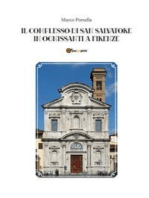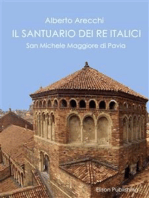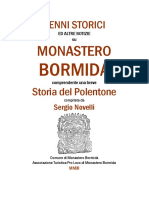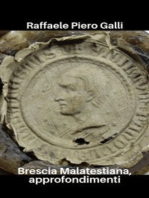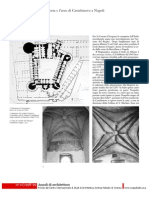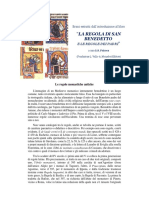Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Progetti Di Francesco Di Giorgio Per Il Monastero Di Santa Chiara in Urbino
Caricato da
demeros0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
531 visualizzazioni21 pagineCopyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
531 visualizzazioni21 pagineProgetti Di Francesco Di Giorgio Per Il Monastero Di Santa Chiara in Urbino
Caricato da
demerosCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 21
22
La personalit di Francesco di Giorgio, artista e
autore, si delineata recentemente e rimane in
parte indefinita. Anche la sua attivit di architetto
poco documentata. Tre soli suoi edifici sono ac-
certati come autentici
1
. Altri tre si conservano, del
gruppo di sette che lo stesso Francesco di Giorgio
si attribu nel secondo Trattato
2
. La trattatistica
dellartista senese la principale fonte sulla sua
opera di architetto e ingegnere, anche per il pio-
nieristico uso che egli fece dei moltissimi disegni
che commentano i testi. Tuttavia, i numerosissimi
disegni di architettura dei Trattati sono solamen-
te indiziari della poetica e dei metodi progettuali
martiniani, perch essi vennero sottoposti a una
semplificazione geometrica in funzione didattica.
Anche i pochi disegni di architettura autografi di
Francesco di Giorgio sono scarsamente significa-
tivi, sotto laspetto progettuale
3
. I pi importanti
sono tre piante di conventi, che sono raccolte nel
codice Ashburnham 1828 Appendice della Biblio-
teca Medicea Laurenziana di Firenze
4
. Due ff.
63v-64r; f. 159r sono state riferite a unarchitet-
tura martiniana in Urbino (ill. 6)
5
. La terza ff.
66v-67r stata valutata in modi diversi (ill. 1).
Gustina Scaglia lha identificata come un proget-
to di Francesco di Giorgio per il convento dei ge-
suati di San Girolamo in Siena
6
. Howard Burns
lha identificata come un rilievo martiniano di un
originario monastero di Santa Chiara in Urbino,
costruito su un possibile progetto di Luciano
Laurana e poi abbattuto e sostituito da Francesco
di Giorgio con lodierno edificio
7
.
Il disegno va certamente riferito a un edificio
che era costruito, o doveva essere costruito, sul si-
to dellodierno ex monastero di Santa Chiara in
Urbino (ill. 2). Lassetto e lubicazione delle mura
urbiche (ill. 8), della strada rettilinea in basso (ill.
3) e della chiesa di San Girolamo (ill. 4) si ap-
prossimano fin quasi a coincidere con lassetto e
lubicazione dei corrispondenti elementi urbani
di Urbino alla fine del secolo XV
8
. Lipotesi
del progetto per il convento senese va scartata.
Ma laltra ipotesi non appare pienamente convin-
cente, perch limpianto planimetrico del disegno
molto affine a quello dellodierno ex monastero
urbinate, tanto da legittimare il sospetto che la
pianta sia un progetto per quelledificio, che at-
tribuito a Francesco di Giorgio. I modi e i tempi
che Burns ipotizza per la fabbrica martiniana del
monastero di Santa Chiara in Urbino rafforzano
il sospetto. Alla distruzione di un monastero re-
centissimo e di magnifico impianto sarebbe se-
guita la costruzione, sul medesimo sito, di un edi-
ficio molto affine allipotetico monastero origina-
rio. In modo diverso e pi economico, Federico
di Montefeltro fece ampliare i suoi edifici inglo-
bandovi tutti i corpi di fabbrica riutilizzabili.
Lattribuzione
I dati certi nella vicenda edilizia del monastero di
Santa Chiara in Urbino sono due: Federico di
Montefeltro fece costruire sul nostro sito un mo-
nastero femminile osservante
9
; Elisabetta di
Montefeltro, figlia di Federico, spese la sua do-
te nella fabbrica dellodierno ex monastero
10
. Si
ritiene inoltre fondata unattribuzione ottocente-
sca di questultimo edificio a Francesco di Gior-
gio e Baccio Pontelli
11
. A questo punto si pone un
dilemma. O Federico di Montefeltro fece co-
struire un monastero prima dellarrivo in Urbino
di Francesco di Giorgio e poi, dopo la morte del
duca di Urbino, larchitetto senese lo demol e
sostitu con lodierno edificio, su incarico di Eli-
sabetta Feltria. Oppure Federico di Montefeltro
fece iniziare su progetto di Francesco di Giorgio
la costruzione dellodierno edificio, e poi Elisa-
betta Feltria prosegu quella fabbrica. Se il nostro
disegno risale al primo corno del dilemma esso
va preferibilmente datato dopo il 1482 anno
della morte di Federico di Montefeltro e pu
essere, in alternativa, o un rilievo martiniano di
un originario monastero fatto costruire dal duca
di Urbino, o un progetto martiniano ordinato da
Elisabetta Feltria per lodierno edificio. Se il no-
stro disegno risale al secondo corno del dilemma
esso va datato tra larrivo di Francesco di Giorgio
in Urbino che avvenne al pi tardi nel 1477 e
la morte di Federico di Montefeltro, ed esso un
progetto martiniano ordinato dal duca di Urbino
per lodierno edificio.
Sul nostro sito (ill. 2) il beato gerolimino Pie-
tro da Pisa fond nel 1420 un Conservatorio di
Donne Nobili Vedove
12
. Due anni dopo lo stes-
so eremita gerolimino fond, l vicino, il conven-
to di San Girolamo
13
. Un nuovo documento del
1431 attesta una vendita al beato Pietro da Pisa di
una casa con un orto, confinanti con il conserva-
torio
14
. Un altro documento inedito del 1445 at-
testa che Federico di Montefeltro pens in quel-
lanno di costruire, sul sito del conservatorio, un
Enrico Ferdinando Londei Progetti di Francesco di Giorgio
per il monastero di Santa Chiara in Urbino
10-11|1998-99 Annali di architettura
Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org
23
nuovo monastero da edificarsi subito. A questo
scopo egli don un terreno ortivo adiacente al
conservatorio e confinante (ill. 2): a ovest, con la
via del cortile; a sud, con un terreno ortivo; a
nord, con loratorio della fraternita di SantAnto-
nio; e a est, con le mura urbiche medievali
15
. Nel
1456 il conservatorio venne istituito in monastero
delle clarisse osservanti di Urbino, e lanno dopo
Gentile Brancaleoni prima moglie di Federico di
Montefeltro vi si ritir e vi mor, poco dopo, e
verosimilmente l fu sepolta. Anche Battista Sfor-
za seconda moglie di Federico di Montefeltro
fu sepolta nel 1472 nel monastero di Santa Chia-
ra
16
. Alcuni ritengono che a quella data gi esistes-
se il nuovo monastero ordinato da Federico di
Montefeltro. Ma lunica testimonianza attesta so-
lo che quelledificio venne costruito, patrocinato e
frequentato dal signore di Urbino
17
. invece insi-
gnificante il rapido cenno che la beata Battista da
Varano dette del suo soggiorno nel monastero ur-
binate, negli anni 1481-83
18
. Un nuovo importan-
te documento del 1481 conferma la testimonianza
di Vespasiano da Bisticci. Esso attesta la costruzio-
ne del monastero prima di quella data e accenna a
una dislocazione della chiesa annessa al mona-
stero che concordante con quella della chiesa
odierna. Latto del 1481 registr una precedente
vendita di alcune propriet del monastero, la cui
somma ricavata era stata gi impiegata, converti-
ta nella fabbrica del detto monastero
19
. Il docu-
mento lascia il dubbio se il reimpiego della somma
avvenne prima o dopo larrivo di Francesco di
Giorgio in Urbino. Ma altri documenti inediti
sciolgono il dubbio. Il primo attesta che Elisabet-
ta Feltria entr nel monastero di Santa Chiara il
26 gennaio 1494 con alcuni anni di ritardo, ri-
spetto a ci che si supposto finora e che dispo-
se allora di spendere integralmente la sua dote
per la fabbrica di quel monastero
20
. Gli altri docu-
menti testimoniano le reiterate richieste indirizza-
te negli anni 1495-96 da Elisabetta Feltria al
duca di Ferrara Ercole dEste per ritirare quanto
doveva avere da lui
21
. Poich si ritiene che lo-
dierno ex monastero delle clarisse urbinati venne
disegnato e diretto da Francesco di Giorgio e
Baccio Pontelli, ci accadde prima degli anni
1494-96, perch a quella data: Baccio Pontelli era
probabilmente gi morto
22
, e nei rapporti tra la
corte di Urbino e Francesco di Giorgio che ri-
siedeva nuovamente in Siena da alcuni anni si
era gi registrata una grave crisi
23
. Ci dimostra
che lodierno edificio venne progettato e iniziato a
costruire da Francesco di Giorgio con il proba-
bile aiuto di Baccio Pontelli su incarico di Fede-
rico di Montefeltro. Probabilmente i lavori si in-
terruppero alla morte del duca di Urbino, quando
le fabbriche federiciane vennero interrotte o co-
munque ridimensionate. Ma se la fabbrica prose-
gu, alla continuazione di quei lavori non parte-
cip Baccio Pontelli, che lasci Urbino subito do-
po la morte di Federico di Montefeltro. Poi Elisa-
betta Feltria ordin la seconda campagna di lavo-
ri, sullo scorcio del secolo XV.
La soluzione del dilemma ci consente di va-
lutare la testimonianza e le attribuzioni sulla
committenza della fabbrica. Vespasiano da Bi-
sticci complet la sua Vita di Federico da Urbino
prima del 1493, e pot attestare solamente la
campagna di lavori federiciana
24
. Poco dopo la
met del secolo XVI Gian Carlo Galli attribu
invece la committenza della fabbrica a Elisabet-
ta di Montefeltro
25
. Alla fine del secolo XVI Ber-
nardino Baldi dette due indicazioni contraddito-
rie sulla fabbrica
26
, ma negli stessi anni Fuschinio
Brancaleoni rifer che tanto la Chiesa che lan-
nesso Monastero [...] devesi alla munificenza del
Duca Federico e dellIll.ma Signora Elisabetta
sua Figlia
27
. Un giudizio significativo su queste
attribuzioni venne espresso allinizio dellOtto-
cento dallabate Andrea Lazzari. Egli conobbe e
pubblic la lettera di Gian Carlo Galli, e tuttavia
scrisse che il monastero di Santa Chiara Fede-
rico incominci ad edificarlo ed Elisabetta sua
Figlia[...] vimpieg la sua dote
28
.
Il progetto e i primi lavori del monastero di
Santa Chiara vanno collocati agli esordi dellat-
tivit architettonica di Francesco di Giorgio, al-
linizio del suo soggiorno urbinate. Una sua pre-
cedente esperienza come architetto in Siena, se
mai avvenne, fu modesta e di essa ci rimangono
comunque debolissime tracce. Una prima ri-
guarda la chiesa della Santissima Annunziata
nello spedale di Santa Maria della Scala dove, se-
condo uninterpretazione di vecchie trascrizioni
di un documento oggi perduto, Francesco di
Giorgio costru il soffitto e la tribuna
29
. Una se-
conda si riferisce alla basilica di San Bernardino
allOsservanza la cui fabbrica, iniziata nel 1475,
fu affidata lanno dopo a un maestro
30
. Alcuni
lo identificano con Francesco di Giorgio che
avrebbe poi seguito la fabbrica durante la sua
permanenza in Urbino mediante linvio di col-
laboratori e direttamente in occasione dei suoi
numerosi ritorni a Siena. Manfredo Tafuri ha
ipotizzato un legame tra le committenze dei due
conventi osservanti e ha proposto che larrivo di
Francesco di Giorgio in Urbino, per la costru-
zione del convento e della chiesa di San Bernar-
dino, avvenisse nel 1476, prima di divenire ar-
chitetto di Federico di Montefeltro e di Ottavia-
no Ubaldini
31
. Francesco Paolo Fiore ha antici-
pato quellarrivo al 1475 e ha ipotizzato che la
committenza urbinate avesse preceduto e occa-
sionato quella senese
32
. Lipotesi di un precoce
coinvolgimento di Francesco di Giorgio nel cir-
cuito delle committenze edilizie francescane in
Siena si allarga a unaltra attribuzione. Il Della
Valle assegn a Francesco di Giorgio i due chio-
stri del convento di San Francesco in Siena
33
. Poi
il Romagnoli indic il 1475 come anno dinizio
10-11|1998-99 Annali di architettura
Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org
24
della loro costruzione
34
. Lattribuzione stata ac-
quisita alla letteratura artistica senese ed
rafforzata dalla documentata costruzione ad
opera di Francesco di Giorgio nel 1482 del
tetto della chiesa annessa a quel convento
35
.
La ristrutturazione del convento di San Fran-
cesco in Siena fu commissionata dal ministro ge-
nerale dellordine conventuale Francesco Nani,
detto Sanson. Originario di Brescia, egli risiedet-
te a lungo in Siena dove percorse una brillante
carriera di religioso e docente universitario
con il consenso delle istituzioni cittadine
36
. Egli fu
eletto ministro generale in Urbino, il 15 maggio
1475
37
, in un capitolo che si tenne nel convento
osservante di San Donato. Federico di Montefel-
tro patrocin quel capitolo per consolidare la sua
alleanza politica con Sisto IV papa conventuale
che era stata suggellata lanno prima col fidan-
zamento tra Giovanna di Montefeltro figlia di
Federico e Giovanni della Rovere nipote del
papa
38
. Il capitolo di Urbino elesse un candida-
to certamente gradito a Francesco della Rovere,
perch Francesco Nani aveva appena assunto il
suo nuovo cognome da Raffaele Sansoni, proni-
pote di Sisto IV. Con lacquisizione di quella pa-
rentela Francesco Sanson contrasse una spiritualis
cognatio con lo stesso papa. E il comune rapporto
di familiarit, seppure di grado diverso, che Fede-
rico di Montefeltro e Francesco Sanson ebbero
con Sisto IV, dovette favorire il legame tra il ge-
nerale francescano e il duca di Urbino. Il consi-
derevole prestito di denaro che Francesco Sanson
effettu poi a favore di Guidubaldo di Montefel-
tro figlio di Federico costituisce un indizio
concordante circa il legame precedentemente
stretto dal Sanson con Federico di Montefelto
39
.
Il rapporto stabilito con la corte urbinate nel
1475 dal Sanson, la lunga residenza conventuale
senese del generale francescano e la sua commit-
tenza per il convento di San Francesco in Siena lo
indicano come il possibile intermediario tra Fede-
rico di Montefeltro e Francesco di Giorgio. Cer-
chiamo i possibili legami tra lartista senese e il fra-
te conventuale. Francesco Sanson fu un vero me-
cenate artistico: committente di opere darte e di
architetture, in contatto con numerosi artisti, tra
cui Leonardo. Proprio la sua presenza in Urbino,
nel 1475, stata posta in rapporto col trasferi-
mento del Bramante in Lombardia. Ma il suo pos-
sibile mecenatismo artistico prima del 1475 non
mai stato indagato e non risulta documentato
40
.
Tuttavia, si individuano facilmente gli ambiti in
1. Francesco di Giorgio. Progetto per
il monastero di Santa Chiara in Urbino,
pianta. Firenze, Biblioteca Medicea
Laurenziana, codice Ashburnham 1828
App. ff.66v-67r. Penna e inchiostro con uso
di riga su carta, 26,8x27,2 cm 1475-76.
Scritte: via; mura di comuno; via;
via; San gj/rolamo; via; giardino;
tolesi da questa linea (in)la / p(iedi) 60;
via; logia; via; giardino dove stano
e fratj; Confes(s)io/ne; sachrestia delle /
done; chapitolo; Rifetorjo; cano/veto;
lava/manj; chucina; chiesa delle /
done; guarda chu/cina; cami/no dove /
si schalda; chortile; chiesa degli omi/nj;
par/latorj; parlato/rio delle / done;
dove tenga/no e panj; cacato/ri
(Foto Biblioteca Medicea Laurenziana
di Firenze).
10-11|1998-99 Annali di architettura
Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org
25
2. Ricostruzione del sito dellex monastero
di Santa Chiara in Urbino, nel secolo XV,
e contestuale sovrapposizione della pianta ai
ff. 66v-67r del cod. Ashburnham 1828.
App. sullodierna planimetria urbana.
1. area delloratorio di SantAntonio, oggi
demolito; 2. area del Conservatorio delle
Donne Nobili Vedove, dal 1420 al 1459,
poi delloriginario monastero fino al 1475 e
infine delledificio odierno; 3. oratorio della
Santa Croce; 4. area di terreni ortivi, di
propriet della famiglia Catani alla met
del secolo XV; 5. area a valle delle mura
urbiche medievali demolite verso la met
del secolo XV, poi terreno di confine tra il
monastero di Santa Chiara e il convento di
San Girolamo e infine, dopo il 1475, luogo
del giardino pensile del monastero di Santa
Chiara; 6. area del convento di San
Girolamo; 7. area dellappartamento del
guardiano.
A puntinato: le aree delloratorio
di SantAntonio e dellappartamento del
guardiano, oggi distrutti.
A tratto continuo: le mura urbiche
medievali parzialmente residue.
A tratteggio: le mura urbiche medievali
demolite verso la met del secolo XV
(ricostruzione e disegno dellautore).
cui pot avvenire in Siena la conoscenza tra il San-
son e Francesco di Giorgio. Per primo lordine
francescano senese, dove il frate visse dal 1459 al
1475, percorrendo tutti in gradi della gerarchia
conventuale fino a ricoprire la carica di provincia-
le della Toscana, dal 1470 al 1475. Lordine fran-
cescano commission in seguito degli incarichi ar-
tistici e di architetture a Francesco di Giorgio, in
Siena e in Urbino. Per secondo, ma non minore,
lUniversit di Siena dove Francesco Sanson inse-
gn dal 1470 al 1475. La vita culturale senese del
Quattrocento si identific con lo Studio, nel cui
ambito si mosse anche Francesco di Giorgio. Fin
dai primi anni sessanta egli studi le opere del
Taccola che erano probabilmente conservate pres-
so lUniversit
41
. Inoltre, in quel decennio France-
sco di Giorgio lavor per Alessandro Sermoneta
42
,
e forse per la famiglia di Mariano Sozzini
43
, en-
trambi autorevoli cittadini e docenti universitari
senesi. La verosimile conoscenza tra lartista sene-
se e il frate conventuale legittima il sospetto del-
lesistenza di un nesso, tra la presenza del Sanson
in Urbino, nel 1475, e il successivo trasferimento
di Francesco di Giorgio presso la corte urbinate.
La presenza dellartista senese nel ducato di
Urbino, alle dipendenze di Federico di Montefel-
tro, documentata per la prima volta il 17 mag-
gio 1477
44
. Tuttavia alcuni lavori martiniani urbi-
nati vengono datati a partire dal 1475
45
. La seria
ipotesi di una precoce attivit di Francesco di
Giorgio per Urbino concorda con la scarsa docu-
mentazione sulla sua presenza in Siena, tra lesta-
te del 1475 e la primavera del 1477. Il 6 luglio
1475 Francesco di Giorgio e Neroccio di Barto-
lomeo scelsero i rispettivi arbitri per dirimere lo
scioglimento della loro societ fra pittori
46
. Il 26
maggio 1476 Francesco di Giorgio era in Siena,
dove comparve come perito di parte avversa in
una stima di lavori di Neroccio
47
. Infine, un docu-
mento del 25 luglio 1476, dal quale emerge che la
Signoria di Siena incaric due maestri di andare a
verificare i lavori della diga sulla Bruna, risulta-
to di recente dubbio circa lassegnazione di quel-
lincarico a Francesco di Giorgio
48
.
La presenza documentata in patria dellartista
senese tra lestate 1475 e la primavera 1477
talmente saltuaria, e la successione temporale tra
la presenza del Sanson in Urbino e la risoluzione
della controversia tra Neroccio e Francesco di
Giorgio nel maggio e nel luglio 1475, rispetti-
vamente tanto ravvicinata, che i due fatti co-
stituiscono indizi concordanti nellindividuare un
nesso di causalit: tra lo svolgimento del capitolo
conventuale in Urbino e lo scioglimento della so-
ciet fra Neroccio e Francesco di Giorgio. Proba-
bilmente Francesco Sanson segnal lartista sene-
se al duca di Urbino, nel maggio 1475. Certa-
mente Francesco di Giorgio chiuse la sua bottega
senese nellestate di quellanno e, quasi certamen-
te, si trasfer subito dopo in Urbino
49
.
10-11|1998-99 Annali di architettura
Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org
26
Qui lartista senese svolse subito unattivit
multiforme, nel cui contesto larchitettura pre-
valse ben presto. Nel maggio 1477 alcuni docu-
menti attestano per la prima volta la costru-
zione di un edificio di Francesco di Giorgio e la
sua qualifica di architetto
50
. Sappiamo che nel
1445 Federico di Montefeltro don, per la co-
struzione di un monastero delle clarisse urbinati,
un terreno ubicato nel sito dellodierno ex mona-
stero di Santa Chiara e che, nel 1472, Battista
Sforza venne sepolta nel monastero delle clarisse
osservanti di Urbino. In quellanno Federico for-
se pensava ancora di costruire nel contesto del
suo nuovo palazzo il mausoleo dei Montefeltro
secondo il progetto di tempio rotondo redatto
dal Laurana
51
. Pochi anni dopo quellidea pare gi
accantonata, a vantaggio di un mausoleo perso-
nale da edificare nel contesto del nuovo conven-
to dei francescani osservanti. La nuova determi-
nazione adottata forse in occasione del capitolo
generale conventuale del 1475
52
prevedeva la
abbinata costruzione di una chiesa-mausoleo di
Battista Sforza, da edificare prioritariamente nel
contesto di un nuovo monastero delle clarisse os-
servanti. Il monastero e la chiesa di Santa Chiara
vennero costruiti dopo il 1475. Il convento e la
chiesa di San Bernardino vennero costruiti dopo
il 1482, in esecuzione di una volont testamenta-
ria del duca di Urbino
53
. La prima campagna di
lavori nel monastero di Santa Chiara fu contem-
poranea alle altre iniziali fabbriche di Francesco
di Giorgio nei palazzi Ducali di Urbino e Gub-
bio, principalmente e di poco precedente la co-
struzione del nuovo duomo urbinate, che gli at-
tribuita
54
. Nel 1475 gli osservanti urbinati ebbero
modo di conoscere larchitetto senese, quale pro-
gettista del loro monastero-sorella, e forse lo se-
gnalarono ai loro confratelli senesi
55
.
I progetti
La pianta ai ff. 66v-67r del codice Ashburnham
1828 App. va datata allinizio del soggiorno urbi-
nate di Francesco di Giorgio, negli anni 1475-
76
56
. Sovrapponiamola alla planimetria dellex
monastero di Santa Chiara (ill. 2), facendo coin-
cidere il bordo in basso del progetto sul lato ove-
st del rilievo. La corrispondenza tra i due allinea-
menti garantita dalla permanenza della medie-
vale via del cortile nellodierna via Santa Chia-
ra (ill. 3). Poi collimiamo il bordo sinistro della
pianta sullantico confine tra il monastero di San-
ta Chiara e loratorio di SantAntonio. Francesco
di Giorgio rilev il sito abbastanza esattamente
verso sud, nella parte destra della pianta, dove
occorreva spartire larea di confine tra gerolimi-
ni e clarisse, e pi sommariamente verso nord,
nella parte sinistra della pianta, dove larchitetto
senese progett degli spazi aperti e facilmente
adattabili al sito
57
. Sulla pianta sono vergate nu-
merose scritte, che sono riferite a elementi del si-
to e del progetto. La pi significativa apposta
lungo lallineamento della chiesa di san Girola-
mo: tolesi da questa linea (in) la p(iedi) 60. Es-
sa stata diversamente interpretata. Burns lha
ritenuta una documentazione dellampliamento
progettato da Francesco di Giorgio per la costru-
zione del nuovo monastero, rispetto a questo di-
segno che lo studioso britannico considera il ri-
lievo di un monastero esistente. In sostanza, con
quelle parole si sarebbe indicata la larghezza del
rettangolo di terreno da togliere ai gerolimini e
da assegnare alle clarisse per il loro nuovo mona-
stero, che Francesco di Giorgio avrebbe costrui-
to subito dopo labbattimento delledificio appe-
na rilevato. Larea individuata da due linee de-
bolmente tracciate ed composta dalla via a for-
ma di L e dalladiacente rettangolo, di 10060
3. Via Santa Chiara in Urbino, anticamente
via del cortile. A sinistra lex monastero
di Santa Chiara, a destra loratorio
della Santa Croce (foto Guido Cecere).
4. Langolo sud-est dellex monastero
di Santa Chiara in Urbino. Al centro
la rientranza delledificio, a destra
lex convento di San Girolamo
(foto Guido Cecere).
10-11|1998-99 Annali di architettura
Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org
27
piedi
58
. Ma il settore delledificio corrispondente
a quella parte del sito presenta una rientranza
analoga a quella che disegnata, solo un po pi
grande, nella pianta ai ff. 66v-67r (ill. 2, 4 e 9).
Linterpretazione autentica della frase di signi-
ficato opposto, secondo la lettura che ne ha dato
la Scaglia: si toglie da questa linea in l unarea
della larghezza di 60 piedi
59
. Le due linee debol-
mente tracciate individuarono larea che nella
pianta veniva allora sottratta alle clarisse, ma che
a loro era stata assegnata in un precedente pro-
getto. Il compromesso finale su quel controverso
terreno di confine fu ancora leggermente diver-
so. Esso registrato nellimpianto delledificio.
Liniziale forma rettangolare dellarea prece-
dente il progetto ai ff. 66v-67r porta a identifi-
care un elaborato di quella fase progettuale inizia-
le nella pianta al f. 65r del Codice Ashburnham
1828 App. (ill. 5). In quel foglio si ridisegn, da
un probabile disegno autografo di Francesco di
Giorgio, la pianta di un progetto per il monaste-
ro di Santa Chiara in Urbino. Alcune scritte iden-
tificative degli ambienti dormitorio
c(hi)ostro coro ecc. individuano il disegno
come un progetto per un convento. Le notevoli
affinit di forma e disposizione tra le sequenze
corrispondenti di ingresso, chiesa circolare e coro
rettangolare, che sono luna disegnata nel f. 65r e
laltra costruita nelledificio costituiscono un se-
rio indizio a favore della nostra ipotesi (ill. 9). Le
misure indicate in piedi da fabbrica di Urbino e le
affinit tra le due piante sono ulteriori indizi
precisi e concordanti che valgono come mezzo
di prova per la nostra identificazione
60
. Lulteriore
ricerca porta a individuare un possibile altro pro-
getto per il monastero di Santa Chiara in Urbino
nella pianta autografa ai ff. 63v-64r del codice
Ashburnham 1828 App. (ill. 6)
61
. In questo codice
essa precede la pianta al f. 65r e con questultima
e con la pianta ai ff. 66v-67r costituisce una serie,
che intervallata da un altro disegno il n. 96 al
f. 66r che contiene disegni di palazzi desunti dal
repertorio di Francesco di Giorgio. una pianta
di convento, che stata prevalentemente identifi-
cata come un progetto per il convento di San Ber-
nardino in Urbino. Essa stata riferita al conven-
to rinascimentale degli osservanti urbinati sulla
base della pianta della annessa chiesa, che affine
alla planimetria del San Bernardino di Urbino
62
.
Una conferma per questa identificazione stata
indicata in un progetto per linterno di questulti-
ma chiesa, che anchesso nel codice Ash-
burnham 1828 App. e viene attribuito alla botte-
ga di Francesco di Giorgio
63
. Ma la pianta ai ff.
63v-64r un progetto per un monastero femmi-
nile. Lappartamento dei frati nettamente sepa-
rato dalledificio, e il parlatorio e il confessorio
delle suore denominate donne secondo una con-
suetudine lessicale del secolo XV, che ritroviamo
usata anche nella pianta ai ff. 66v-67r sono di-
rettamente comunicanti col primo chiostro. Gli
elementi e le scritte del progetto non contraddi-
cono questa identificazione. Neppure la scritta
stanzia p(er) lo exercitio che viene riferita al-
lindicazione martiniana di ambienti per attivit
manuali nei conventi osservanti
64
perch essa
applicabile anche ai monasteri femminili. Poich
le misure sono indicate in piedi da fabbrica di Ur-
bino la pianta va verosimilmente riferita al mona-
stero urbinate di Santa Chiara. Inoltre, le dimen-
sioni delledificio sono congruenti col sito e con le
altre due piante. Le tre piante sono riferite ai pia-
ni terra e le due autografe sono disegnate a filo
di ferro, secondo una convenzione grafica abi-
tualmente adottata da Francesco di Giorgio nella
progettazione esecuzione e illustrazione di edifici.
Il filo di ferro denota la prevalente attenzione
posta da Francesco di Giorgio verso la geometria
dei muri, rispetto al loro volume, e questa con-
venzione grafica conforme allappiattimento e
alla stiratura dei muri in piani astratti, che carat-
terizzano le sezioni prospettiche martiniane
65
.
La pianta al f. 65r priva di riferimenti al si-
to (ill. 5). Essa presenta una simmetria speculare
a cui fanno capo le due parti affiancate alla chie-
sa. Il monastero ha dimensioni modeste ed evi-
denzia unanalisi e una disposizione delle funzio-
ni imperfette e una scarsa variet nei tagli dei va-
ni. Ledificio risulta inadeguato a ospitare in mo-
do confortevole una comunit numerosa. Lele-
mento centrale, che separa le due parti laterali
del monastero, il pi significativo. Esso costi-
tuito da un breve portico dingresso, una chiesa
circolare e un coro rettangolare. La successione
ripetuta nella costruzione (ill. 9), ma con due va-
rianti. Il portico venne semplificato in una rien-
tranza del fronte edilizio (ill. 3) e il coro venne al-
lungato. La stessa successione presente, con va-
rianti distributive, in alcune piante di palazzi dei
Trattati. Il disegno pare desunto da modelli anti-
chi e ricorda il rilievo martiniano del tempio di
Romolo sulla via Sacra a Roma
66
. Nella parte si-
nistra, intorno al primo chiostro, erano dislo-
cate le attivit comunitarie. Sul fronte stradale in
basso individuato dalle scritte stal(l)a e ca-
mera era probabilmente sistemato lapparta-
mento del confessore. Sui lati a sinistra e in alto
erano probabilmente dislocate le officine: la
cucina, lanticucina, la dispensa, la cantina, il re-
fettorio ecc. L accanto, il coro fungeva forse an-
che da capitolo. Mentre i quattro vani ricavati
esternamente allo spazio cilindrico della chiesa
dovevano avere funzioni diverse. Probabilmente
i due vani in alto erano adibiti a sacrestia e a par-
latorio-confessorio, come i due corrispondenti
vani delledificio (ill. 9). La parte destra del mo-
nastero dislocata intorno al secondo chiostro.
Il dormitorio era previsto nel primo piano, per-
ch al piano terra sono disposti dieci apparta-
menti costituiti di camera, saletta e cappellina
10-11|1998-99 Annali di architettura
Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org
28
che erano forse destinati alle discrete. Lappar-
tamento a sinistra il pi ampio e lunico con un
accesso diretto al chiostro era probabilmente
riservato alla badessa
67
. Il monastero ha una lar-
ghezza modesta, ma raggiunge lantico allinea-
mento delle mura urbiche medievali, da poco de-
molite. possibile che Francesco di Giorgio
avesse previsto un piano seminterrato nel corpo
di fabbrica in alto, perch la scala allineata sul
bordo in alto delledificio lungo il ciglio tattico
del poggio di Urbino, dove fino a pochi anni pri-
ma erano innalzate le mura urbiche medievali
di modo che attraverso essa si sarebbe potuto su-
perare il forte dislivello attestato lungo quel trac-
ciato. Anche il giardino presenta una simmetria
speculare e ricorda quello del palazzo del re,
che illustrato nel primo Trattato. Alti muri rac-
chiudono prati e viali alberati, che fanno capo a
una loggia e forse a una cappella, addossata al
muro di fondo
68
. Il giardino invade larea che era
a valle delle demolite mura medievali ed era de-
limitata dalle nuove mura urbiche e dal convento
dei gerolimini. Il possesso di quel terreno, che
era reclamato dalle due comunit religiose confi-
nanti, in buona parte assegnato alle clarisse. La
pianta del monastero pare disegnata sul riferi-
mento di una trama geometrica. Il reticolo indi-
vidua il corpo di fabbrica di ampiezza costante
che perimetra ledificio. Allinterno sono traccia-
ti i corridoi che racchiudono, a loro volta, i due
chiostri coi vani adiacenti. Anche lelemento cen-
trale allineato al reticolo. Il disegno abbastan-
za impreciso, sia per lapposizione di alcune arbi-
trarie misure sia per lincerto tracciamento a ma-
no libera delle linee. Risulta impossibile rintrac-
ciare tutti i rapporti numerici che vennero utiliz-
zati. Ma appare evidente luso di rapporti tra nu-
meri razionali
69
. Inoltre, il dimensionamento dei
vani della parte destra avvenne secondo labitua-
le raddoppio di un modulo quadrato di base.
La pianta autografa ai ff. 63v-64r parzial-
mente mancante della parte sinistra (ill. 6). Ma
facile completarla in base alle due misure che vi
sono apposte
70
. Limpianto planimetrico presenta
una simmetria speculare, cui fanno capo le due
parti affiancate alla chiesa. Il dispositivo analo-
go a quello del precedente progetto, ma esso pre-
senta due importanti migliorie. Ledificio pi
vasto, e lanalisi e la disposizione delle funzioni
sono pi sapienti. Il monastero pu ospitare co-
modamente una comunit numerosa. Anche que-
sto disegno privo di riferimenti al sito, ma pos-
sibile verificarne la compatibilit con il nostro.
Ledificio lungo 230 piedi solamente dieci pie-
di pi delledificio ai ff. 66v-67r ed largo 105
piedi solamente dieci piedi meno del settore in
basso delledificio ai ff. 66v-67r . La pianta ai ff.
63v-64r si adatterebbe facilmente al settore in
basso della pianta ai ff. 66v-67r, se il monastero
sconfinasse brevemente nei terreni ortivi sulla de-
stra (ill. 2). Inoltre, le due scale delledificio si al-
lineerebbero al ciglio tattico della collina del pog-
gio. Lunico inconveniente funzionale derivereb-
be dalla mancanza di un giardino, a cui ovviereb-
be in parte il chortile e horto. Ma anche pos-
sibile che si dovesse contestualizzare la pianta del-
ledificio in una planimetria pi ampia comples-
siva dellintera area del monastero e forse com-
5. Anonimo. Progetto per il monastero
di Santa Chiara in Urbino, pianta. (Co-
pia da Francesco di Giorgio?).
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana,
codice Ashburnham 1828 App. f. 65r.
Penna e inchiostro su carta, 20,2x24,3 cm.
Secolo XVI? (Da un originale del 1475-
76). Scritte: coro; c(hi)ostro; c(h)iesa;
dormitorio; stal(l)a; camera
(foto Biblioteca Medicea Laurenziana
di Firenze).
10-11|1998-99 Annali di architettura
Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org
29
6. Francesco di Giorgio. Progetto per il
monastero di Santa Chiara in Urbino,
pianta. Firenze, Biblioteca Medicea Lau-
renziana, codice Ashburnham 1828 App.
ff. 63v-64r. Penna e inchiostro su carta, su
traccia preparatoria a gessetto,
con uso di riga e compasso, 17,8x26,3 cm.
1475-76. Scritte: qui di sopra p(er) tuto
el dormetor(i)o longo p(iedi) 230 largo
p(iedi) 25; stanzia p(er) lo / exercitio;
lavatio/ne p(er) lo co/rpo; infermarja;
cano/veto e dj/spensa soto; piaza; pia-
za; chortile e horto; lavam/anj; ca-
me/ra; chucin/na; sachrestja; rife-
torjo; camera; piaza; salotto; loco
p(er) lo / confesa/ria; loco p(er) /
le done / dove si con/fesano; lavama(n)j;
po/zo; orato/rj; vestibolo / p(er) lj
fratj; vestibolo; p(er) lo parla/torjo;
grata; guarda /chucina; chucina
(foto Biblioteca Medicea Laurenziana
di Firenze).
prendente un giardino . Ledificio conserverebbe
comunque unampia visione sul paesaggio dallu-
nico fronte finestrato, che posto in alto. Ci ri-
sulterebbe coerente con lassetto del nostro sito
(ill. 10), che scosceso e ancor oggi inedificato
solamente verso quel lato, di modo che il mona-
stero avrebbe conservato la sua separatezza istitu-
zionale acustica e visiva dalla citt. Rispetto al-
la precedente, questa pianta presenta una miglio-
re disposizione delle funzioni. Ledificio pi va-
sto e presenta un impianto planimetrico pi arti-
colato, bench conservi una simmetria speculare.
Francesco di Giorgio us due larghezze diverse
per i corpi di fabbrica e vi ricav allinterno una
pi ampia gamma di tagli dei vani. possibile che
Francesco di Giorgio avesse seguito questo pro-
cedimento progettuale. Egli accost dapprima i
due moduli di 3030 piedi della chiesa, poi fis-
s in 20 piedi la larghezza del vestibolo e in 25
piedi la larghezza del corpo di fabbrica in alto.
Ottenuta cos la larghezza del monastero, egli ne
determin la lunghezza: accost ai fianchi della
chiesa due corpi di fabbrica di 20 piedi poi fis-
s la profondit dei portici e cos ottenne i due
chiostri quadrati. Infine egli fiss la larghezza di
20 piedi dei due corpi di fabbrica di testata. Poi
larchitetto senese tagli i vani allinterno dei cor-
pi di fabbrica, ad iniziare dalla chiesa che lele-
mento pi significativo del progetto. Essa ha
chiare connotazioni funerarie e presenta delle af-
finit cos evidenti con la chiesa di San Bernardi-
no in Urbino, da far ipotizzare la rielaborazione
di quella pianta per la costruzione della chiesa-
mausoleo di Federico di Montefeltro
71
.
A sinistra della navata il vestibolo p(er) lj
fratj, che introduce allappartamento dei fran-
cescani osservanti di Urbino, tra i quali si sce-
glieva il confessore delle clarisse. Lappartamen-
to composto di un salotto, due camere, una cu-
cina e un gabinetto. Tutti i vani accedono a un
piccolo chiostro o a un cavedio. Lappartamento
nettamente separato dal monastero, al quale i
frati avrebbero avuto accesso solo per ammini-
strare i sacramenti. A destra del vestibolo della
chiesa il parlatorio, con la ruota e la grata per i
colloqui. A destra della navata sono i due con-
fessor: quello pubblico e quello delle suore, che
avrebbero raggiunto il loro direttamente dal
chiostro. Accanto ai due confessor si trova la sa-
crestia, che d su un piccolo chiostro e ha un la-
vamani di servizio. Lambito della clausura inizia
col parlatorio a cui seguono due ambienti non
identificati e prosegue con la serie delle offi-
cine: lanticucina; la cucina che in angolo e
perci lunico vano illuminato da finestre che
danno verso lesterno, ma verosimilmente rica-
vate in alto; il lavamani, lungo dieci piedi e col
pozzo retrostante; il refettorio e, infine, un am-
biente soppalcato e adibito a cantina e dispensa,
a cui si accede anche dallinfermeria. Questulti-
ma posta in alto ed costituita di undici came-
re, un obitorio indicato dalla scritta lavatione
p(er) lo corpo e una latrina. Il chiostro rit-
mato da colonne, ma ha negli angoli dei pilastri
piegati a libro. la soluzione dangolo del corti-
le del palazzo Ducale di Urbino, che impres-
sion Francesco di Giorgio perch ricorre spes-
so nei Trattati e in disegni desunti dal repertorio
10-11|1998-99 Annali di architettura
Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org
30
martiniano
72
. Dietro la chiesa si trova un labora-
torio per attivit manuali indicato dalla scritta
stanzia (per) lo exercitio ed probabile che
anche altri vani vicini avessero la stessa destina-
zione duso. A sinistra della chiesa il secondo
chiostro, intorno al quale sono disposte tre di-
verse serie di abitazioni. In basso una camera
composta di camera, saletta e oratorio che ha
una disposizione analoga a quella gi vista nella
pianta al f. 65r (ill. 5). Essa individua una fore-
steria o pi probabilmente il dormitorio delle
discrete. Allaltro lato del cortile sono le celle,
separate con un corridoio dal dormitorio comu-
ne. Le tre diverse serie di abitazioni dovevano
raggiungere la testata del monastero, dove era
forse ubicato il capitolo in una posizione simme-
trica al refettorio. Le funzioni che non sono
menzionate nel disegno erano previste nel pri-
mo piano. Nella nostra ipotesi sarebbe inoltre
previsto un piano seminterrato per i servizi, li-
mitato al corpo di fabbrica in alto.
La pianta autografa ai ff. 66v-67r inserita nel
contesto del sito (ill. 1, 2)
73
. Vi sono disegnati: il
tratto delle mura urbiche, con un torrione semi-
circolare e un bastione quadrato, la chiesa di San
Girolamo, la rettificata via del cortile e il circui-
to delle vie pubbliche, esistenti e progettate
74
. Gli
elementi delle mura urbiche allora esistenti sono
tutti puntualmente presenti, ma le loro dimensio-
ni e dislocazioni sono imprecisi. La distanza tra la
chiesa di San Girolamo e la via del cortile ven-
ne invece misurata con buona approssimazione
75
.
Dopo aver delimitato larea del monastero in ba-
se ai vincoli del sito e al compromesso raggiunto
sullarea da spartire fra gerolimini e clarisse
Francesco di Giorgio vi articol allinterno una
pianta di notevole libert formale. Egli sostitu al-
la simmetria speculare dei precedenti progetti il li-
bero accostamento di tre rettangoli destinati a
funzioni diverse: il giardino dei frati, il monastero
e il giardino del monastero. Larea vasta ma de-
stinata in gran parte a spazi aperti, e il monastero
risulta ancora insufficiente a ospitare una comu-
nit numerosa. Tuttavia, la sapiente dislocazione
degli spazi aperti garantisce una maggiore variet
formale e una migliore disposizione funzionale del
monastero, che pure dislocato intorno ad un so-
lo chiostro. Lelemento risolutivo della pianta la
figura a T, che la loggia compone con un portico
del chiostro. La loggia-asta trasversale si affaccia
sul giardino, mentre il portico-asta longitudinale
si incastra nel monastero e indica un potenziale as-
se di simmetria del complesso edilizio. Intorno al
chiostro sono disposti quattro corpi di fabbrica di
ampiezze diverse, che permettono di raggruppare
i vani secondo le funzioni e le dimensioni simili.
Le funzioni sono inoltre distinte verticalmente nei
tre piani delledificio. Nel piano terra sono rag-
gruppati gli ambienti del primo chiostro: il par-
latorio, la chiesa coi vani di servizio, il capitolo, le
officine e forse dei laboratori. Al primo piano
dovevano essere previsti gli ambienti del secondo
chiostro: i dormitori, la foresteria, linfermeria,
ecc. Nel piano seminterrato del corpo di fabbrica
in alto, in comunicazione col giardino, dovevano
essere previsti i locali di servizio: la lavanderia, lo
stenditoio, i depositi ecc. Bench il progetto sia
ancora nella sua fase di elaborazione iniziale, la
pianta presenta una disposizione articolata. A sini-
stra il giardino dei frati osservanti. Accanto nel
corpo di fabbrica di sinistra che ha unampiezza di
30 piedi sono disposti in successione: la chiesa, il
coro e, accoppiati, il confessorio e la sacrestia del-
le suore. La chiesa-mausoleo era prevista ad uso
pubblico e venne separata dal monastero. Il tratto
a penna che indica il muro comune al coro e alla
chiesa presenta due brevi interruzioni e un picco-
lo cerchio. Questo simbolo segnala probabilmen-
te la ruota. Esso anche indicato: nel muro co-
mune al giardino dei frati e al confessorio delle
suore, e nel muro comune ai due parlator. Proba-
bilmente lapertura nella mezzeria del muro co-
mune al coro e alla chiesa indica la grata attraver-
so cui le suore avrebbero seguito, in incognito, la
messa officiata nella chiesa. La seconda apertura
in quel muro indica forse una grata per i colloqui.
E una grata certamente indicata nella mezzeria
del muro comune ai due parlator. Questi ultimi
sono i primi due vani del corpo di fabbrica in bas-
so, che ha una larghezza di 20 piedi. Segue il de-
posito dei panni, da scambiare con lesterno attra-
verso la ruota del parlatorio. La collocazione di
questo vano fa ritenere che la prevalente attivit
manuale svolta dalle clarisse urbinati fosse la con-
fezione di tessuti e/o indumenti. Seguono due am-
bienti non identificati, forse dei laboratori per
quelle attivit manuali. In angolo una batteria di
tre latrine, ognuna fornita di due condotti retro-
stanti. Uno il discendente, certamente prove-
niente dalla latrina superiore del primo piano, lal-
tro il camino di aerazione, innalzato fino al col-
mo del tetto
76
. Dietro i sei condotti ricavato un
ripostiglio, a cui si accede dal pianerottolo dellat-
tigua scala. Probabilmente Francesco di Giorgio
disegn questo stretto spazio dopo aver constata-
to leccessiva lunghezza delle latrine: accorci i
tramezzi di queste ultime sono ancora visibili
delle raschiature di tratti di inchiostro spost la
batteria dei condotti e segn con due brevi tratti la
piccola porta di accesso al ripostiglio, cos ricava-
to. Il cortile presenta la nota sequenza di colonne
e pilastri aperti a libro e posti in angolo. Il portico
a sinistra fiancheggia la chiesa, il coro e la sacrestia
delle suore fino a incastrarsi nella loggia a colon-
ne. Questultima domina il giardino e ricorda la
loggia sul giardino del palazzo Piccolomini in
Pienza. Nella testata sinistra della loggia posta
laltra scala delledificio. Tra la loggia, il portico in
alto e la prosecuzione del portico di sinistra in-
cernierato il capitolo che ha una larghezza di 25
10-11|1998-99 Annali di architettura
Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org
31
piedi ed affiancato al refettorio a cui seguono
le officine. Qui Francesco di Giorgio disegn
una sequenza quasi identica a quella corrispon-
dente, che disegnata nella pianta ai ff. 63v-64r
(ill. 6). Essa composta dal refettorio, il lavamani
con la retrostante cantina al posto del pozzo, la
cucina disposta in angolo e lanticucina che di-
slocata nel corpo di fabbrica a destra, della lar-
ghezza di 22 piedi.
Il successivo vano un quadrato con due cer-
chi inscritti e concentrici, allinterno del minore
dei quali apposta la scritta camino dove si
schalda. La figura geometrica e la scritta iden-
tificano il vano come un laconico desunto da Vi-
truvio (ill. 7). Il cerchio esterno individua il va-
no cilindrico e cupolato nella cui sommit
ricavato un oculo. Uno schermo di bronzo in-
nalzabile fino a ostruire loculo funge da val-
vola per regolare nellambiente la temperatura
ed eventualmente lumidit alle gradazioni volu-
7. Anonimo (copista della prima stesura
del primo Trattato di Francesco di Giorgio).
Illustrazioni di bagni e stufe. Firenze,
Biblioteca Medicea Laurenziana di Firen-
ze, codice Ashburnham 361 f.23r. Penna e
inchiostro su pergamena, 38,5x26,5 cm.
1480 circa. Scritte: stufa sichondo / li an-
tichi; chamino del fuocho p(er) / lo quale
la stufa ri/schalda; cappello di bronzo (
per la) temperanza; profurnio della stu-
fa; profurnio delle chaldaie; profurnio
delle chaldaie; frigidario; stufa; pro-
furnio della stufa; Bangnio; frigida-
rio; profurnio; fondo de la stufa; va-
chuit fra lluno e llaltro muro / dovel
chalore chorendo rischalda; profurnio
(foto Biblioteca Medicea Laurenziana
di Firenze).
te. Il cerchio interno indica unarbitraria buca-
tura del pavimento, attraverso cui Francesco di
Giorgio credeva, erroneamente, che laria calda
e le fiamme propagatesi nellipocausto penetras-
sero nellambiente del camino
77
. Il disegno illu-
strativo del laconico vitruviano in entrambi i
codici in cui si copi le due stesure del primo
Trattato. Ma solo in uno di essi il codice Ash-
burnham 361 della Biblioteca Medicea Lauren-
ziana di Firenze, convenzionalmente definito L
appare lannotazione da cui si abbrevi la scrit-
ta camino dove si schalda (ill. 7)
78
. In quel co-
dice si ritiene che venne versata la prima stesura
a cui segu la seconda, riveduta e ampliata, che
venne trascritta in un secondo codice il Saluz-
ziano 148 della Biblioteca Reale di Torino, con-
venzionalmente definito T . La nostra scritta
abbreviata dimostra che il capitolo sugli am-
bienti termali di Vitruvio era gi stato tradotto e
il corrispondente disegno annotato di L era gi
stato approntato, negli anni 1475-76. Inoltre, la
collocazione del camino nel contesto di un mo-
nastero conferma la precedenza di L su T, per-
ch in quel secondo codice venne aggiunto il ca-
pitolo sui conventi, proprio in seguito alla so-
praggiunta esperienza progettuale martiniana di
quel tipo edilizio, che quasi certamente inizi
col progetto e la fabbrica del monastero di San-
ta Chiara in Urbino
79
. Lartista senese compil il
primo Trattato facendo costante riferimento alla
autorit di Vitruvio
80
. Anche in questo caso, in
cui egli utilizz la descrizione vitruviana di un
antico ambiente termale per adattarla alle esi-
genze igieniche e mediche del suo tempo mo-
derno
81
. Anche per quel brano Francesco di
Giorgio perfezion la concordanza del signifi-
cato col segno, mediante la ripetuta elaborazio-
ne della illustrazione del testo di base. Le copie
dei probabili primi disegni martiniani di bagni e
stufe sono nel codice Zichy, che si ritiene con-
tenga tra laltro una trascrizione delliniziale
tentativo di elaborazione del primo Trattato. A
quei disegni seguirono quelli di L, e poi quelli di
T
82
. Nella pianta ai ff. 66v-67r lanticucina sepa-
ra il camino dalla cucina. Lubicazione dellanti-
cucina non fu casuale, perch certamente Fran-
cesco di Giorgio previde di collocarvi il forno
delle caldaie e il prefurnio dellipocausto, che
sono indispensabili per il funzionamento dellat-
tiguo camino. Nei disegni corrispondenti del
primo Trattato, il camino-stufa e il forno-pro-
furnio delle chaldaie sono accostati al bagno.
Ma questultima destinazione duso appare diffi-
cilmente associabile allambiente che, nella
pianta ai ff. 66v-67r, segue il camino. Appare in-
vece evidente laffinit del camino ai ff. 66v-67r
coi bagni del palazzo Ducale di Urbino
83
e della
rocca di Ostia
84
. Queste affinit fanno ipotizzare
che lesercitazione condotta da Francesco di
Giorgio sugli ambienti termali vitruviani ebbe
10-11|1998-99 Annali di architettura
Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org
32
poi un concreto esito nel bagno del palazzo di
Urbino e, per opera di Baccio Pontelli, nel ba-
gno della rocca di Ostia.
Il capitolo sugli ambienti termali del De ar-
chitectura ancora oggi di difficile comprensio-
ne, ma Francesco di Giorgio la raggiunse quasi
pienamente quando la lingua vitruviana era
pressoch sconosciuta e la sua lettura era parti-
colarmente ostica
85
. Ci conforta la tesi che la
complessiva opera di traduzione da Vitruvio
venne svolta da qualche dotto umanista, perch
alcuni segni alcuni grossolani errori nella
scrittura di parole latine
86
, le incerte traduzioni
del latino elementare del Taccola ecc. sono ri-
velatori di una, almeno inizialmente, rudimen-
tale conoscenza della lingua latina da parte di
Francesco di Giorgio. Ci concorda con lap-
partenenza di Francesco di Giorgio allo strato
culturale intermedio. Del modo di esprimersi di
quello strato culturale Francesco di Giorgio
presenta sia gli elementi peculiari luso del vol-
gare e della scrittura mercantesca, la preminen-
za del disegno e luso di procedimenti analogici
sia il possesso di tecniche specifiche la pro-
spettiva, la cartografia, lingegneria idraulica, la
fusione dei metalli ecc.
La pianta ai ff. 66v-67r un progetto inizia-
le, gi impostato brillantemente nel suo disegno
generale ma il cui perfezionamento ancora in-
compiuto. Tuttavia essa dettagliata con le mi-
sure delle parti e degli ambienti delledificio.
Ci permette di individuare e analizzare i rap-
porti numerici e i sistemi proporzionali even-
tualmente impiegati da Francesco di Giorgio. Il
disegno a filo di ferro annulla lo spessore di
muri e di strutture portanti, dai quali nel Rina-
scimento si traevano talora le unit di misura de-
gli edifici. Ma non pare che Francesco di Gior-
gio ne avesse fissate. Appare invece evidente la
ricerca di rapporti numerici musicali, o co-
munque di numeri razionali, nella ordenazio-
ne delledificio. Ci emerge gi nelle tre aree
su cui Francesco di Giorgio impost il dispositi-
vo funzionale del monastero
87
. possibile che
Francesco di Giorgio avesse seguito questo pro-
cedimento progettuale. Sulla distanza tra la via
del cortile e la chiesa di San Girolamo di
124,5 piedi egli stacc la larghezza del mona-
stero di 115 piedi e la residua larghezza di
9,5 piedi della via di separazione tra il mona-
stero e il convento dei gerolimini. Poi sulla lar-
ghezza del monastero egli stacc nel corpo di
fabbrica di sinistra le lunghezze della chiesa,
del coro, e della sacrestia e del confessorio acco-
stati, che mise in rapporto con la larghezza di
30 piedi di quel corpo di fabbrica. Egli riusc a
ottenere dei rapporti numerici musicali tra
le due dimensioni di ogni singolo vano e a por-
re in rapporto fra loro le dimensioni degli am-
bienti vicini. La chiesa rettangolare di 4030
piedi divisa dalla sua diagonale di 50 piedi
in due triangoli pitagorici
88
. La lunghezza del-
la diagonale pari alla lunghezza del coro di
50x30 piedi . Inoltre, le dimensioni della sacre-
stia e del confessorio di 2515 piedi sono di-
mezzate da quelle del coro, in modo che si sta-
bilisce una unit organica fra questi tre rettan-
goli simili. Sulla lunghezza della sacrestia e del
confessorio accostati di 25 piedi Francesco di
Giorgio fiss la larghezza del corpo di fabbrica
in alto, la cui lunghezza egli lasci inizialmente
indeterminata. Poi larchitetto senese fiss la
profondit dei portici di sette piedi e dimen-
sion il cortile di 8050 piedi . Cos egli ot-
tenne la lunghezza del corpo di fabbrica in alto
e, contemporaneamente, la lunghezza e la lar-
ghezza del corpo di fabbrica in basso. Infine egli
collim la larghezza del corpo di fabbrica di de-
stra sulla larghezza di 60 piedi dellarea da
assegnare ai gerolimini. Una conferma di questo
procedimento progettuale viene dalla verifica
dei rapporti numerici usati nei vani dei corpi di
fabbrica in alto e in basso. Essi sono poco signi-
ficativi, perch gli ambienti vennero tagliati al-
linterno di corpi di fabbrica gi dimensionati.
Ma i due vani identici dei parlator fanno ecce-
zione, perch il rapporto fra i lati 14:20 piedi
esprime il rapporto 1:2. Esso era certamente
noto a Francesco di Giorgio, sia dalla pratica di
bottega sia dal Vitruvio, dal quale ultimo egli
trasse lunica indicazione di quel rapporto nu-
merico irrazionale che nel primo Trattato
89
. Il
testo di Vitruvio anche una fonte per i rappor-
ti di numeri razionali che sono indicati nei Trat-
tati. Ma quei rapporti numerici, che larchitetto
senese traeva anche dalla sua esperienza di co-
8. Il sito a nord dellex monastero di Santa
Chiara in Urbino ripreso dalla rampa eli-
coidale di quelledificio. Lungo lasse centra-
le della illustrazione si notano le mura ur-
biche medievali parzialmente residue, indi-
viduate dalle puntellature di sostegno e dal
filare degli alberi (foto Guido Cecere).
9. Ricostruzione delle planimetrie e delle
destinazioni duso del monastero di Santa
Chiara in Urbino allinizio del secolo XVI
(da L. Fraternale, Il monastero di Santa
Chiara a Urbino, in Larchitettura, cro-
nache e storia, X, 1964, pp.268-75).
Pianta a quota 9,75 m: 1. rampa elicoida-
le; 2. deposito; 3. stenditoio;
4. camino; 5. cantina; 6. scala di servizio;
7. corridoio; 8. lavanderia; 9. pozzo;
10. ingresso carraio; 11. fondo;
12. cavedio dello spulciatoio; 13. giardino
pensile; 14. cappella ducale; 15. cappelle se-
polcrali.
Pianta a quota 3,15 m: 1. rampa elicoi-
dale; 2. loggia; 3. cantina; 4. refettorio;
5. ripostiglio; 6. corridoio; 7. cucina;
8. pozzo; 9. camino; 10. laboratorio;
11. camera dei telai; 12. cavedio dello spul-
ciatoio; 13. magazzino; 14. dispensa; 15.
portico; 16. legnaia; 17. foresteria.
Pianta alle quote 0,00/+3,15 m:
1. rampa elioidale; 2. noviziato; 3. celle;
4. corridoio; 5. dormitorio; 6. camera di
passaggio; 7. coretto delle converse; 8. coro
delle coriste; 9. refettorio dellinfermeria;
10. infermeria; 11. corridoio; 12. balcone
dello spulciatoio; 13. laboratorio;
14. magazzino; 15. abitazione del guar-
diano; 16. abitazione del confessore; 17. sa-
crestia; 18. confessorio delle monache; 19.
sacrestia delle monache; 20. paneria;
21. chiesa; 22. foresteria
(rielaborazione grafica dellautore).
10-11|1998-99 Annali di architettura
Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org
33
struttore, gli erano soprattutto noti dai testi da-
baco e in particolare dalle volgarizzazioni dei
trattati di geometria. Ci confermato anche
dalla Praticha di gieometria martiniana, in cui
conflu un corpo di conoscenze molto noto,
scritto in volgare e di facile accesso
90
. In sostan-
za, il sistema proporzionale usato nelle tre pian-
te elementare. Francesco di Giorgio us dei
rapporti di numeri razionali e musicali, ma
non elabor un uso ragionato di rapporti pro-
porzionali. La sua esecuzione, ad esempio, appa-
re molto lontana da quella di un virtuoso della
matematica quale fu Leon Battista Alberti
91
.
La fabbrica
Ledificazione conclude il processo progettuale.
In essa si rende ledificio conforme alle aspirazio-
ni del committente e se ne perfeziona ladatta-
mento al contesto del sito. Proprio nel capitolo
sui conventi, che in T, Francesco di Giorgio
sottoline pi volte la necessit di adattare ledi-
ficio al sito. In un passaggio di quel capitolo egli
afferm che gli adattamenti del tipo ideale non
andavano progettati sulla carta, bens operati di-
rettamente sulledificio, quando esso era calato
nello spazio reale
92
. probabile che Francesco di
Giorgio avesse determinato quella sua raccoman-
dazione anche in base allesperienza della fabbri-
ca del monastero di Santa Chiara, la cui esecuzio-
ne avvenne anche in base a decisioni prese diret-
tamente sul cantiere. La fabbrica dovette iniziare
al pi tardi nel 1477. La fiducia che Federico di
Montefeltro e Ottaviano Ubaldini dimostrarono
di accordare a Francesco di Giorgio nei tre con-
tratti del maggio 1477 che riguardarono anche
la direzione dei lavori di opere di architettura
progettate dallo stesso architetto senese
93
legit-
tima lipotesi di una sua precedente attivit per la
corte urbinate, esplicata anche nellambito della
progettazione e costruzione di edifici, tra i quali
vi fu certamente il monastero di Santa Chiara in
Urbino. Ma ben presto la presenza di Francesco
di Giorgio in Urbino divenne saltuaria tra le-
state del 1478 e la primavera del 1480 durante
la guerra tra Sisto IV e Firenze, che egli segu co-
me architetto militare del duca di Urbino
94
. Allo-
ra Baccio Pontelli collabor con Francesco di
Giorgio nella costruzione del monastero di Santa
Chiara in Urbino. La collaborazione continu fi-
no a poco dopo la morte di Federico di Monte-
feltro del 10 settembre 1482 a causa della qua-
le molto probabilmente si interruppe la fabbrica
e certamente il Pontelli lasci Urbino
95
. impos-
sibile individuare cosa venne costruito in quella
prima campagna di lavori, a parte forse la chiesa
che pare identificabile in base alla sua descrizione
nel documento del 1481
96
. I lavori intrapresi per
volont di Elisabetta Feltria a cavallo tra i seco-
li XV e XVI proseguirono sulla base del pro-
getto martiniano. Alla fine di quella seconda cam-
10-11|1998-99 Annali di architettura
Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org
34
pagna di lavori restavano da costruire, o forse so-
lo da completare, i corpi di fabbrica a sud e a ove-
st del chiostro. Ma nulla si sa di questi ultimi la-
vori. invece noto che la chiesa venne rimaneg-
giata in almeno tre occasioni
97
. Allinizio del seco-
lo XX il monastero venne ristrutturato, con dan-
neggiamenti anche gravi, e solamente da ventan-
ni ne iniziata una lenta opera di manutenzione
98
.
Larchitettura autentica martiniana costitui-
sce la maggior parte delledificio. In essa il sito,
i vincoli preesistenti, le necessit funzionali, le
emergenze di cantiere e le interpretazioni di col-
laboratori ed esecutori intervennero come acci-
denti della fortuna sul modello ideale. Lo stes-
so uso martiniano della composizione a filo di
ferro facilitava il prodursi di deformazioni mu-
rarie nelle sue architetture, che si verificarono
anche nel monastero di Santa Chiara. Francesco
di Giorgio sottopose le tre piante a una sempli-
ficazione geometrica meno rigida, ma analoga, a
quella adottata nei disegni dei suoi Trattati. Inol-
tre egli contestualizz in modo approssimativo
nel sito quelle piante geometrizzate. Solamente
sul cantiere egli deform il regolare impianto
planimetrico del progetto finale. In quel fran-
gente, alcune linee parallele e perpendicolari su-
birono deviazioni e deformazioni e certi elemen-
ti e parti del progetto si adattarono esattamente
a dei vincoli preesistenti. Si sono gi indicati gli
inconvenienti pi gravi del progetto ai ff. 66v-
67r: nella ridotta dimensione delledificio e nel-
la indicazione di un circuito di vie pubbliche,
che avrebbero intaccato la clausura del monaste-
ro. Questi due inconvenienti non pregiudicano
ledificio. Il monastero fu ampliato e separato
dalla citt. Larea si estese a nord, fino alle mura
urbiche ed al torrione semicircolare, a quelle
contestuale, sul quale si innalz la rampa elicoi-
dale (ill. 2 e 8). Inoltre, si ridusse a un impasse la
strada a L tra il monastero e il convento di San
Girolamo
99
. La sovrapposizione della pianta ai ff.
66v-67r sul rilievo dellex monastero rende evi-
denti le trasformazioni intervenute con la co-
struzione delledificio (ill. 2). Il fronte edilizio
assecond la curva dolce della via del cortile e
registr tre cesure murarie (ill. 3), che individua-
rono delle separazioni funzionali nelledificio. A
partire da quella linea spezzata la pianta del cor-
po di fabbrica ovest assume una forma a venta-
glio, che si interrompe contro il regolare corpo
di fabbrica est (ill. 9).
Una attendibile ricostruzione delledificio e
dei suoi usi alla data del primo Cinquecento
stata pubblicata pi di trentanni fa (ill. 9)
100
. Le
abitazioni del confessore e del guardiano separa-
rono verso ovest il giardino dei frati dalla via del
cortile. Labitazione del guardiano era accostata
alloratorio di SantAntonio ed entrambi i corpi
di fabbrica vennero abbattuti. Per primo lorato-
rio
101
, e successivamente allinizio del secolo XX
labitazione del guardiano. Dopo la prima ca-
mera dellabitazione del confessore, che fungeva
anche da primo ingresso al monastero cerano: la
sacrestia, il parlatorio, il confessorio, la sacrestia
delle suore, e il deposito dei panni. Lubicazione
della paneria, che analoga a quella della pian-
ta ai ff. 66v-67r (ill. 1), conferma che la confezio-
ne dei panni fosse la prevalente attivit manuale
delle clarisse urbinati. A sud cerano la chiesa e il
coro, dal quale le suore seguivano attraverso una
grata, in incognito, la messa celebrata nella chie-
sa. Anche la finestra di ferro del parlatorio era af-
facciata sulla chiesa, che fungeva inoltre da parla-
torio pubblico
102
. Dal loro parlatorio le suore ac-
cedevano al confessorio. Lingresso alla chiesa
posto su una breve rientranza del fronte edilizio,
che ritaglia un esiguo slargo sulla via del corti-
le. Nei brevi fronti laterali dellesiguo slargo
erano collocati i due ingressi del monastero. La
sequenza di ingresso, chiesa e coro venne desun-
ta dal progetto al f. 65r. E da esso venne forse ri-
presa anche la disposizione dellappartamento
10. Il fronte orientale dellex monastero
di Santa Chiara in Urbino
(foto Guido Cecere)
10-11|1998-99 Annali di architettura
Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org
35
11. Loriginario dormitorio
nellex monastero di Santa Chiara in
Urbino (foto Guido Cecere).
del confessore. Il corpo di fabbrica a valle venne
edificato su tre piani. Nel primo piano cerano il
dormitorio e le celle, affiancati e separati da un
corridoio, secondo una soluzione distributiva
che disegnata nella pianta ai ff. 63v-64r (ill. 6).
La lunga serie delle celle, oggi in gran parte de-
molite, risvoltata a 90 in due ali di testata.
Quella nord incernierata al dormitorio me-
diante la rampa elicoidale. La disposizione plani-
metrica di quel corpo di fabbrica affine a quel-
la del corpo di fabbrica sud del palazzo Ducale di
Gubbio, che venne costruito, quasi certamente
con il concorso di Francesco di Giorgio, con-
temporaneamente al monastero di Santa Chiara
in Urbino
103
. A sud della testata sud delle celle e
del dormitorio cerano linfermeria e lo spulcia-
toio. Francesco di Giorgio afferm lutilit di
questultimo ambiente nel contesto dei con-
venti proprio nello specifico capitolo sui con-
venti di T
104
. Lo spulciatoio assolveva sia a una
funzione igienica sia al precetto religioso di pre-
servare anche la pi piccola creatura di Dio. Dal
balcone quadrilatero dello spulciatoio del loro
monastero le clarisse urbinati si scrollavano di
dosso i parassiti, che cadevano nel fondo del ca-
vedio, da dove venivano convogliati nella fogna e
di qui espulsi. Le logge vicine al dormitorio era-
no usate come laboratorio, e il tratto incompiu-
to delle logge nord era forse adibito a magazzi-
no. La foresteria era nel corpo di fabbrica ovest,
lungo la via del cortile. Essa venne costruita a
partire dal secolo XVI, nella terza campagna di
lavori. Ancora nel corpo di fabbrica est, al piano
terra cerano: il refettorio, la cucina con la di-
spensa e, intorno al cavedio dello spulciatoio, al-
cuni magazzini e laboratori che immettevano
nella lunga loggia a U; e nel seminterrato cera-
no: il lavatoio, lo stenditoio e i vari depositi.
Questi ambienti fanno capo al portico, che im-
mette nel giardino dove originariamente erano
collocate, addossate al muro orientale, le cappel-
le sepolcrali. Una collocazione affine di una cap-
pella nel giardino del palazzo del re, nel pri-
mo Trattato
105
. E poich il giardino del palazzo
del re affine a quello della pianta al f. 65r (ill.
5), possibile che fin da quelliniziale progetto
Francesco di Giorgio prevedesse la collocazione
di cappelle nel giardino. Il recupero delle solu-
zioni approntate nei progetti iniziali avvenne se-
condo un procedimento non lineare, mediante il
loro reimpianto nel progetto definitivo, che
documentato in una sua fase di elaborazione ini-
ziale nella pianta ai ff. 66v-67r. Le tre aree fun-
zionali che in essa sono chiaramente distinte il
giardino dei frati, il monastero e il giardino del
monastero vennero eseguite con gli adatta-
menti gi detti. Il giardino dei frati venne sepa-
rato dalla strada con un corpo di fabbrica ad uso
degli stessi osservanti. La chiesa e il coro venne-
ro trasformati secondo il precedente progetto al
f. 65r. La rampa elicoidale sostitu la scala nella
testata sinistra della loggia. Labile incastro a T
fra la loggia e il portico venne fratturato con lin-
serimento del refettorio. La via di separazione
dal convento di San Girolamo venne ridotta a un
impasse
106
. Infine si spost il confine tra le due co-
munit religiose confinanti, ampliando larea de-
stinata alle clarisse.
Dal rilievo metrico si ricavano altre informa-
zioni sulla geometria delledificio e sui procedi-
menti adottati nella fabbrica
107
. Pare che France-
sco di Giorgio avesse fissato le misure massime
dellarea e le dimensioni delledificio e del giar-
dino approssimando dei rapporti di numeri ra-
zionali
108
. Su quella sommaria geometria di rife-
rimento egli sovrappose e accost dei fasci di
volte a botte e a padiglione le cui ampiezze
vennero adattate dai precedenti progetti
109
fino
a ottenere larticolata disposizione del Mona-
stero. Ma larchitetto senese ottenne anche la
giusta ordenazione degli ambienti, mediante
un ampio uso di rapporti di numeri razionali
110
.
Si registra inoltre, nel regolare corpo di fabbrica
est, la presenza di alcune misure esatte di dieci
e venti piedi che derivarono forse dalluso del-
la canna di misurazione
111
. Il raccordo tra i due
impianti planimetrici quello regolare del corpo
di fabbrica est e quello irregolare del corpo di
fabbrica ovest avvenne mediante la modellazio-
ne a pianta trapezoidale di alcuni vani.
Limmagine delledificio stabilita dallimpo-
nente apparato murario del suo fronte orientale
(ill. 10). Esso caratterizzato dalla doppia loggia
su pilastri, che protesa verso il paesaggio con le
testate svoltate a U e che, originariamente, era
completata con lattico delle celle. Quel fronte
connota il paesaggio urbano orientale di Urbino
e fronteggia il paesaggio agrario che fa capo alla
chiesa di San Bernardino. I tre originari piani so-
vrapposti con le doppie arcate dal ritmo serra-
to rimandano a esempi di teatri e acquedotti
10-11|1998-99 Annali di architettura
Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org
36
romani antichi
112
. In quellimpaginato inserito
il tipico motivo medievale senese dellarco ribas-
sato. Linnovazione tipologica delle testate svol-
tate a U rimanda al castellare e alla torre quadra-
ta, nel palazzo Ducale di Urbino. Le costruzioni
ad archi su pilastri, che sorreggono il giardino
pensile dellex monastero, rimandano ai grandi
contrafforti della spianata pensile del mercatale
di Urbino. Infine, Francesco di Giorgio ottenne
un forte effetto di contrasto applicando sul po-
deroso apparato murario la sua sintetica abbre-
viazione dellordine classico. Lintero dispositivo
formale presenta una marcata affinit col fronte
nord del palazzo del Belvedere di Innocenzo
VIII, in Vaticano, e la somiglianza costituisce un
solido indizio per lattribuzione delledificio vati-
cano a Baccio Pontelli
113
.
Limpianto regolare del corpo di fabbrica
orientale appena deformato dalla modesta de-
viazione del muro di testata nord, che prosegue
rettilineo nel muro del giardino pensile. Il lungo
allineamento murario complessivo tangente al
cilindro della rampa elicoidale. Questa una si-
gla martiniana che congiuntamente rimanda: al-
la coclea e alle competenze meccaniche di Fran-
cesco di Giorgio ingegnere
114
e alla predilezione
figurativa verso le forme circolari e rotanti di
Francesco di Giorgio artista
115
. La lunga devia-
zione muraria si accorda alla poetica martiniana
di deformazione del modello ideale, attraverso
ladozione del principio di flessibilit nellorga-
nismo reale
116
. Il modo col quale Francesco di
Giorgio risolveva il tema delle scelte compositi-
ve nei siti irregolari o comunque gravati da
vincoli che potessero compromettere la regola-
rit degli edifici era consono alla sua poetica di
deformazione espressionistica delle masse mura-
rie. Essa dichiarata apertamente anche nel trat-
tamento degli spazi interni voltati, che si esten-
dono dalla vastit di navate basilicali alla contra-
zione di cunicoli ipogei. Qui Francesco di Gior-
gio dette fondo alla sua vena fantastica (ill. 11).
La deformazione materica dei blocchi murari
plasmati, scavati e incisi e la illuminazione mi-
steriosa e intensa raggiungono esiti in genere
espressionistici, talvolta ermetici e astratti. Que-
ste scelte linguistiche accomunano le poetiche
dellarchitettura e della scultura martiniane. Ad
esempio, la modellazione delle masse murarie
sulle funzioni nei suoi edifici affine alla mo-
dellazione delle forme plastiche sui gesti delle fi-
gure nei suoi bassorilievi . Questo saldo lega-
me ha una replica indebolita nel suo simmetrico
speculare allacciato tra larchitettura e la pittu-
ra martiniane soprattutto perch gli esiti della
sua pittura vennero molto attenuati dalla medio-
cre interpretazione degli esecutori. Ma questa
via delle ipotesi critiche allargate ai settori disci-
plinari contigui va comunque percorsa, nella
prospettiva di estendere lunitariet della mul-
tiforme opera martiniana, dalla prassi quotidiana
alle poetiche artistiche.
1. La fortificazione di Costacciaro, il cui
contratto di allogagione dei lavori venne
stipulato il 17 maggio 1477 (pubblicato in
P.L. Menichetti, Castelli, palazzi fortificati,
fortilizi, torri di Gubbio dal sec. XI al XIV,
Citt di Castello 1979, p. 141). La chiesa
di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio
presso Cortona, la cui cerimonia di fon-
dazione avvenne il 6 giugno 1485 (pub-
blicato in G. Pinucci, Memorie istoriche
della sacra immagine [] del Calcinajo, Fi-
renze 1792, pp. 44, 53-54, 57-61). Il pa-
lazzo Comunale di Jesi, il cui contratto di
allogagione dei lavori venne stipulato il
27 maggio 1486. Pubblicato in A. Gia-
nandrea, Il Palazzo del Comune di Jesi, Je-
si 1887, p. 16.
2. I sette edifici sono: le rocche di Sasso-
feltrio, Serra SantAbbondio, Tavoleto e
Cagli, e la scuderia ducale con lannessa
rampa elicoidale di Urbino, edifici co-
struiti per Federico di Montefeltro; e le
rocche di Mondolfo e Mondavio, costrui-
te per Giovanni della Rovere signore di
Senigallia. (Francesco di Giorgio Marti-
ni, Trattati darchitettura militare e civile, a
cura di C. Maltese, Milano 1967, 2 voll.,
II, pp. 339-40, 459-65, tavv. 274-79). La
rocca di Mondavio integra. La rocca di
Cagli e la rampa-scuderia di Urbino sono
parzialmente conservate. Gli altri quattro
edifici sono andati completamente di-
strutti.
3. La definizione del corpus dei disegni di
architettura autografi di Francesco di
Giorgio un problema controverso (cfr.
M. Mussini, La trattatistica di Francesco di
Giorgio: un problema critico aperto, in F.P.
Fiore, M. Tafuri (a cura di), Francesco di
Giorgio architetto, Milano 1993, pp. 358-
79). Tralasciando i moltissimi disegni del
Codicetto, codice Urb. Lat. 1757 della Bi-
blioteca Apostolica Vaticana, e i numero-
si dellOpusculum de architectura, codice
197.B.21 del British Museum di Londra,
che hanno uno scarso riferimento alla
progettazione architettonica. Alcuni di-
segni rapidamente schizzati e annotati,
che riguardano soprattutto macchine e
meccanismi, sono postillati nel De inge-
neeis I-II del Taccola, ms. Lat. 197.II del-
la Bayerische Staatsbibliothek di Mona-
co di Baviera, ff. 57r, 65r, 66r, 68r, 87r,
88v, 95v, 103r, 106r, 115v, 120r, 121r,
128r, 129r, 130v (cfr. L. Michelini Tocci,
Disegni e appunti autografi di Francesco di
Giorgio in un codice del Taccola, in Scritti di
storia dellarte in onore di Mario Salmi, Ro-
ma 1962, II, pp. 203-12). Vedi nota 41.
Otto disegni sono apposti a margine del-
la Traduzione da Vitruvio, allegata al codi-
ce Magliabechiano II.I.141 della Biblio-
teca Nazionale di Firenze, convenzional-
mente definito M, ai ff. 103r-187r, ma
anchessi sono annotazioni grafiche di
scarso rilievo (cfr. F.P. Fiore, La traduzio-
ne da Vitruvio di Francesco di Giorgio. No-
te ad una parziale trascrizione, in Archi-
tettura, storia e documenti, 1, 1985, pp.
5-30). Un progetto per la casa della Sa-
pienza di Siena e alcune rapide idee pro-
gettuali sono nel Quaderno di schizzi ar-
cheologici di Francesco di Giorgio, Museo
degli Uffizi di Firenze, ff. U 318 Ar/U
337 Av. Cfr. H. Burns, I disegni di France-
sco di Giorgio agli Uffizi di Firenze, in Fio-
re, Tafuri (a cura di), Francesco di Gior-
gio..., cit. [cfr. nota 3], pp. 330-57.
4. Il codice Ashburnham 1828 App. della
Biblioteca Medicea Laurenziana di Fi-
renze risulta prezioso per lo studio del-
larchitettura del Quattrocento. Esso
contiene quello che ritenuto lunico di-
segno autografo di Leon Battista Alberti
(cfr. H. Burns, A drawing by Leon Battista
Alberti, in Architectural Design, 49, 5-
6 1979, pp. 45-56; id., Un disegno architet-
tonico di Alberti e la questione del rapporto
tra Brunelleschi e Alberti, in Filippo Brunel-
leschi. La sua opera e il suo tempo, Firenze
1980, 2 voll., I, pp. 105-23) e i tre disegni
autografi di Francesco di Giorgio ff.
63v-64r, 66v-67r, 159r . Il codice racco-
glie 333 disegni di architettura, databili
tra la seconda met del secolo XV e lini-
zio del secolo XVII. La collezione fu pro-
babilmente composta nel secolo XVII
dallarchitetto urbinate Muzio Oddi
(1569-1639), del quale sono ravvisabili
nel codice numerosi disegni e brani di
scrittura. Dal suo testamento risulta che
egli possedette una considerevole raccol-
ta di Istrumenti Matematici, Libri,
Scritture, statuette, disegni (cfr. Biblio-
teca Universitaria di Urbino, Fondo del
Comune, b. 22, f. 327v,). inoltre noto
che i Vincenzi, suoi eredi, a poco a poco
si disfecero di molti libri, di tutti gli stru-
menti matematici e di alcuni manoscritti
appartenuti al loro antenato (cfr. L. Ser-
volini, Muzio Oddi, architetto urbinate del
Seicento, in Urbinum, VI, 6, 1932, pp.
7-27; p. 22). significativo che nella Bi-
blioteca Medicea Laurenziana sia anche
conservata una raccolta autografa di Mu-
zio Oddi, con disegni di orologeria idrau-
lica e di tecnica varia (codice Ash-
burnham 1357), di provenienza identica a
quella del codice qui preso in esame. Ol-
tre ai disegni di Leon Battista Alberti,
Francesco di Giorgio e Muzio Oddi, si
individuano nel codice diversi gruppi di
disegni che denunciano singole paternit
(cfr. P. Ruschi, Scheda n.155..., in F. Gur-
rieri (a cura di), Disegni dei manoscritti lau-
renziani, secoli X-XVI, Firenze 1979, pp.
214-18; p. 218). Questi raggruppamenti
sono pi caratterizzati fra i disegni pi
antichi, e in particolare tra quelli di alcu-
ni collaboratori di Francesco di Giorgio.
Gustina Scaglia ha riferito questi rag-
gruppamenti a due precise personalit e
ha proposto di identificarne una, ma con
scarse adesioni (G. Scaglia, Architectural
drawings by Giovanbattista Alberto in the
circle of Francesco di Giorgio, in Architec-
tura, VIII, 2, 1978, pp. 104-24). I tre di-
segni martiniani vennero identificati e
pubblicati da Howard Burns (H. Burns,
Progetti di Francesco di Giorgio per i conven-
ti di San Bernardino e Santa Chiara di Ur-
10-11|1998-99 Annali di architettura
Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org
37
bino, in Studi bramanteschi, Roma 1974,
pp. 293-311, tavv. CXXXIII-CXXXVI), e
subito dopo commentati dalla Scaglia (G.
Scaglia, Newly discovered drawings of Mo-
nasteires of Francesco di Giorgio Martini, in
Architectura, IV, 2, 1974, pp. 112-24).
Va infine segnalata la presenza nel codice
di un disegno, n. 110 al f. 77r, che rap-
presenta un edificio sacro allantica, che
rimanda in modo quasi testuale al tempio
della Veduta di citt ideale, oggi alla
Galleria Nazionale di Urbino. Cfr. Ru-
schi, Scheda..., cit. [cfr. nota 4], p. 218).
5. La pianta ai ff. 63v-64r e la pianta al f.
159r, di cui Burns ha proposto lidentifi-
cazione quali progetti per il convento di
San Bernardino in Urbino. Burns, Proget-
ti..., cit.[cfr.nota 4], pp.298-99.
6. Scaglia, Newly..., cit. [cfr. nota 4], pp.
114-18.
7. Burns, Progetti..., cit. [cfr. nota 4], pp.
296-98.
8. La strada rettilinea in basso lantica
via del cortile. Il suo tracciato permane
inalterato nellodierna via Santa Chiara,
sulla quale prospetta ancora oggi il tre-
centesco oratorio della Santa Croce (ill.
3). La rinascimentale chiesa di San Giro-
lamo consacrata nel 1474 venne ab-
battuta per riedificare quasi sullo stesso
luogo lodierna chiesa tardo settecentesca
(ill. 4) (cfr. B. Ligi, Memorie ecclesiastiche di
Urbino, Urbino 1938, p. 399). Inoltre,
lassetto delle mura coincide quasi esatta-
mente con quello registrato da Leonardo
nel suo rilievo delle mura urbiche di Ur-
bino del 1502. Il rilievo leonardesco do-
cumenta che a quella data il fronte nord
del monastero era gi stato costruito, per-
ch in esso non compaiono n il torrione
semicircolare (ill.1 e 2), sul quale era gi
stata innalzata la rampa elicoidale, n il
primo tratto rettilineo delle mura urbiche
che era a est del torrione semicircolare e
che, a sua volta, era gi stato inglobato
nel nuovo lunghissimo muro nord del
giardino del monastero. Vedi nota 116 e
cfr. N. De Toni, I rilievi cartografici per
Cesena e Urbino nel Ms.L dellIstituto di
Francia, in Letture vinciane I-XII, Firenze
1974, pp. 133-48 e ill. 30-39.
9. Fece (Federico di Montefeltro) edifi-
care in Urbino uno monistero di Santa
Chiara, [] e ci spese molti danari. Ve-
spasiano da Bisticci, Vita di Federico da
Urbino, in id., Vite di uomini illustri del se-
colo XV, a cura di P. DAncona, E. Aesch-
limann, Milano 1951, p. 225.
10. Elisabetta (di Montefeltro) riducen-
dosi a fare vita religiosa e Santa in quel
bel Monistero di S. Chiara di Urbino,
chella fabbric a sue spese. G.C. Galli,
Lettera a Guidubaldo II della Rovere. 1566
gen. 23, in G. Colucci (a cura di), Anti-
chit Picene, Fermo 1795, t. XXI, p. 81.
11. Lattribuzione contenuta in uni-
stanza che il conte Giacomo Ubaldini ed
alcuni altri cittadini urbinati indirizzaro-
no al governo del Regno dItalia, il 29
giugno 1862, al fine di tutelare lappena
disciolto monastero di Santa Chiara da
possibili manomissioni. In essa il conte
Ubaldini, basandosi quasi certamente su
documenti in suo possesso, abbandon le
tradizionali attribuzioni delledificio agli
architetti urbinati Bramante e Girolamo
Genga (cfr. A. Lazzari, Delle chiese di Ur-
bino e delle pitture in esse esistenti, Urbino
1801, p. 81), e cit due nomi allora quasi
completamente dimenticati, dichiarando
che lex monastero di Santa Chiara era
stato disegnato e diretto da Francesco
Martini senese e Baccio Pintelli fiorenti-
no. Archivio Comunale di Urbino, Car-
tella VIII, 11, convento di Santa Chiara,
1862-65; cit. in P. Rotondi, Contributi ur-
binati a Francesco di Giorgio, in Studi arti-
stici urbinati, Urbino 1949, pp. 87-135;
pp. 117-18 e nota 49 a p. 128.
12. Il conservatorio venne eretto dal
Beato Pietro da Pisa [] e da Cattarina
Vedova di Ser Pietro Foschi da Rimino, e
sua figlia, Vedova ancora essa del quon-
dam Antonio di S.Arcangelo (cfr. Lazza-
ri, Delle chiese..., cit. [cfr. nota 11], p. 78).
Un rogito per un successivo acquisto di
terreni, effettuato dai tre fondatori per
lampliamento del conservatorio, in Ar-
chivio di Stato di Urbino, Quadra di Po-
sterula, 1430, c. 138, 1421 ago. 16, notaio
Nicola di Giovanni da Urbino. Cit. in
ibid., pp. 78-79.
13. Cfr. Ligi, Memorie..., cit. [cfr. nota 8],
p. 396. Un successivo rogito del 15 otto-
bre 1422, per la vendita al beato Pietro da
Pisa di una casa con un orto in loco
Sportelli sive Spineti, in Archivio Ca-
pitolare di Urbino, Pergamena del conven-
to di san Girolamo, 1422 ott. 15, notaio
Tarquinio da Urbino. Cit. in ibid., p. 396.
14. Ringrazio vivamente lemerito stu-
dioso urbinate monsignor Franco Negro-
ni per avermi cortesemente segnalato i
sette documenti inediti qui pubblicati,
che egli ha rinvenuto e trascritto. Su que-
sti indispensabili documenti si basato il
mio lavoro. (ill. 2) Vendita da parte del-
legregio ser Tommaso Catani di Urbino
di una casa con suolo, tetto, pareti e lor-
to contiguo alla stessa casa, posta nella
citt di Urbino nella quadra di Santa
Croce presso le vie da ogni parte al vene-
rabile uomo Fra Pietro da Pisa e a donna
Caterina moglie del fu Pietro di Fosco da
Rimini e sua figlia donna Simona [] al
prezzo di cinquecento ducati. (Archivio
di Stato di Urbino, Quadra di Posterula, n.
23, 1430-31, c. 138v, 1431 ago. 31, notaio
Nicola di Giovanni da Urbino). Lubica-
zione del terreno nella quadra di Santa
Croce e la sua vendita a Fra Pietro da
Pisa e a donna Caterina [] e a sua figlia
Simona garantiscono che quel terreno
fosse confinante con il Conservatorio e
servisse per lampliamento della sua area.
Vedi nota 12.
15. (Ill. 2) Il 30 marzo 1445 in Urbino
nel portico delle case dellillustrissimo si-
gnore Federico. Lillustre e magnifico
conte Federico [] successore della sem-
pre ricordevole memoria dellillustre fu
Guidantonio conte di Montefeltro [] o
[] liberamente e per certa scienza mos-
so da carit e zelo divino e amor di Dio
nonch a titolo e causa di donazione tra
vivi per aiuto del divino favore e per la
costruzione dellinfrascritto monastero di
monache che, povere serve di Dio, pura-
mente, liberamente, semplicemente e ir-
revocabilmente [] don allegregio uo-
mo Bartolomeo di Simone di Pietro []
mercante in Urbino e a maestro Benedet-
to da Coldazzo, muratore ovvero inge-
gnere, domiciliato in Urbino, sindaci,
procuratori, negoziatori, gestori delle de-
vote donne (cors. agg.; vedi nota 17, ill. 1
e ill. 6) povere, ossia monache del nuovo
monastero da edificarsi subito e costruir-
si in detta citt di Urbino [] un pezzo di
terreno ortivo, ossia tutto il tenimento e
terreno ortivo dello stesso illustre signo-
re, posto nella citt di Urbino, nella qua-
dra di Santa Croce, nella localit del cor-
tile, ossia del poggio, ossia in quanto e
per quanto vasto incominciando e com-
prendendo dallorto, ossia il terreno orti-
vo dellegregio dottore in legge signor
Matteo de Catani, escluso, fino al muro
della chiesa della Fraternita di SantAnto-
nio, esclusa, il quale terreno donato, dal
primo lato, superiore, confina con la stra-
da ossia via pubblica detta la via del corti-
le, dal secondo lato, la detta chiesa e i be-
ni della detta Fraternita di SantAntonio,
dal terzo il terreno ortivo predetto del
detto signor Matteo e dal quarto, di sot-
to, la via ossia la via e la cerchia del co-
mune. (Archivio di Stato di Urbino,
Quadra di Santa Croce, n. 41, 1449, cc. 6r-
6v, 1445 mar. 30, notaio Bartolomeo di
Brugaldino di Martino Antaldi da Urbi-
no). Fino al 1445 il conservatorio rimase
allinterno delle mura urbiche medievali
la cerchia del comune . Liniziale in-
sediamento del conservatorio dovette es-
sere posto verso sud, perch il terreno ac-
quisito nel 1431 venne ceduto dalla fami-
glia Catani. A valle delle mura medievali
era posto in loco Sportelli sive Spineti
(vedi nota 13) il convento di San Girola-
mo. Fu dopo labbattimento delle mura
medievali, particolarmente col progetto
del nuovo monastero nel 1475, che le cla-
risse accamparono delle pretese su quel-
larea contigua al convento di San Girola-
mo e posta a valle del loro monastero.
16. Battista Sforza mor il 6 luglio 1472 in
Gubbio. Il suo funerale venne celebrato
in Urbino, nella chiesa di San Francesco,
il 17 agosto 1472 (cfr. G. Santi, La vita e
le gesta di Federico di Montefeltro Duca
dUrbino, a cura di L. Michelini Tocci,
Citt del Vaticano 1985, 2 voll.; I, p. 412;
Gaugello Gaugelli, De vita et Morte illu-
strissimae Baptistae Sfortiae, a cura di A.
Cinquini, Roma 1905, p. 55). Secondo
lunica testimonianza, la salma di Battista
Sforza fu sepolta nel monastero de sanc-
ta Clara de Urbino in li propri sepulchri
de le sancte monache, come havea lei
(Battista Sforza) devotamente ordinato
ne la sua infermitade (cfr. Joanne Sabati-
no de li Arienti, Gynevera de le clare donne,
a cura di C. Ricci, A. Bucchi Della Lega,
Bologna 1888, p. 304). Tuttavia, la storio-
grafia urbinate accredit per lunghissimo
tempo laffermazione del Baldi che Batti-
sta Sforza fosse stata sepolta nella Chie-
sa de Zoccolanti, cio nella chiesa di
San Donato (B. Baldi, Vita e fatti di Fede-
rico da Montefeltro duca di Urbino, Roma
1824, 3 voll.; III, p. 230). Sulla sepoltura
di Battista Sforza cfr. F. Madiai, Battista
Montefeltro sepolta in Santa Chiara, in
Urbinum, IX, 1-6, 1935, pp. 12-16.
17. Oltre a inserire il monastero tra gli
edifici fatti costruire da Federico di
Montefeltro (vedi nota 9), Vespasiano da
Bisticci parl altre volte delledificio e
dellistituzione regolare: Era in Urbino
uno luogo di sanctissime donne (cors.
agg.) rinchiuse, doverano circa donne
(cors. agg.) sessanta, murate; e il moniste-
ro fece fare la sua Signoria, per confor-
tarle nel buono proposito loro. Ogni set-
timana, una volta, andava a questo moni-
stero, e lui solo entrava nella chiesa, e non
voleva che ventrasse altri, e andava a se-
dere a una grata che vera. Qui vi veniva
solo la maggior donna (cors. agg.) (Ve-
spasiano da Bisticci, Vita..., cit. [cfr. nota
9], p. 215). Va rilevato che sia in questo
sia negli altri brani dedicati ai monasteri
femminili, Vespasiano da Bisticci deno-
mina le suore come donne, secondo una
consuetudine lessicale del secolo XV. Ci
concorda sia con le corrispondenti anno-
tazioni nelle due piante autografe marti-
niane in cui anche Francesco di Giorgio
denomina le suore come donne sia col
documento del 1445. Vedi nota 15.
18. In quelli due anni, che stetti (Battista
da Varano) in quel sacro e benedetto Mo-
nastero di Urbino. Battista Varano, Vita
della Veneranda Madre suora Battista Varani,
a cura di D. Passini, Macerata 1624, p. 55.
19. Nella detta chiesa e presso la grata di
ferro di clausura delle dette monache, al-
la cui chiesa, da un lato la strada pubbli-
ca, da tutti gli altri le propriet e il detto
convento. Le monache di Santa Chiara
che avevano venduto al nobile Guido
Brancaleoni dei mulini e provvidenze in
Piobbico in ragione di 200 fiorini compu-
tati a 40 bolognini luno. Somma gi im-
piegata e convertita nella fabbrica del
detto monastero, poich non era stato
steso listrumento papa Sisto IV concede
ai frati dellOsservanza di San Donato di
Urbino, curatori del detto monastero, di
poter legalizzare latto. Latto steso.
Archivio di Stato di Urbino, Notaio Anto-
nio Vanni, n. 44, divisione I, casella 2,
1469-83, cc. 403r-404r, 1481 lug. 31.
20. Suor Chiara (Elisabetta di Monte-
feltro) allatto di prendere i voti nel con-
vento di Santa Chiara dispone dei suoi
beni, presenti e futuri, lasciando erede
universale il fratello Guidubaldo, duca di
Urbino, con lobbligo di spendere inte-
gralmente detti beni per la fabbrica del
detto monastero di Santa Chiara rego-
landosi sulle informazioni che daranno il
padre Domenico da Leonessa, frate mi-
nore dellOsservanza, e la veneranda ma-
dre suor Elisabetta Varano (Battista da
Varano) professa nel detto monastero di
Santa Chiara [] presso la finestra di
ferro e che d nella chiesa del detto mo-
nastero, presente me notaio e i testimoni
presenti anchessi nella detta chiesa,
presso la detta finestra. Archivio di Sta-
to di Urbino, Notaio Antonio Vanni, n. 55,
divisione I, casella IV, 1464-1528, c.s.n.,
1494 gen. 26.
21. La suora Elisabetta da Varano (Bat-
tista da Varano) e suor Chiara Feltria
(Elisabetta di Montefeltro) monache del-
la strettissima regola di Santa Chiara. La
detta suor Chiara col consiglio e consen-
so della predetta suor Elisabetta costitui-
sce il signor Agapito di Pietrantonio di
Urbino suo procuratore per ritirare dal
duca Ercole di Ferrara quanto di sua
spettanza. Nel convento. (Archivio di
Stato di Urbino, Notaio Antonio Vanni, n.
47, divisione I, casella III, 1493-95, c.s.n.,
1495 gen. 12). Suor Elisabetta da Vara-
no (Battista da Varano) e suor Chiara Fel-
tria (Elisabetta di Montefeltro) [] suor
Chiara Feltria d mandato alla illustre si-
gnora Emilia (Emilia Pio) consorte del
magnifico e potente Antonio di Monte-
feltro di ritirare dal duca di Ferrara quan-
to deve avere. Fatto nel convento. (Ar-
10-11|1998-99 Annali di architettura
Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org
38
chivio di Stato di Urbino, Notaio Antonio
Vanni, n. 47, divisione I, casella III, 1493-
95, c.s.n., 1495 dic. 10). Nel monastero
di Santa Chiara. Suor Elisabetta da Vara-
no (Battista da Varano) e suor Chiara Fel-
tria (Elisabetta di Montefeltro) [] costi-
tuiscono il signor Agapito di Pietrantonio
di Urbino [] suo procuratore per ritira-
re dal duca Ercole di Ferrara quanto di
sua spettanza. Fatto alla grata di ferro.
Archivio di Stato di Urbino, Notaio Anto-
nio Vanni, n. 47, divisione I, casella III,
1493-95, c.s.n., 1496 gen. 24.
22. Pochissime sono le notizie documen-
tate su Baccio Pontelli. Anche la data
della sua morte ignota, ma il decesso
avvenne certamente in Urbino, perch la
tomba dellarchitetto fiorentino nella
chiesa di San Domenico di Urbino (cfr.
G. De Fiore, Baccio Pontelli architetto fio-
rentino, Roma 1963, p. 31). Le ultime
notizie che lo riguardano sono del 1492,
e in quello o negli anni immediatamente
seguenti viene datata la sua morte. Ma va
segnalato che un breve di Alessandro
VI, del 24 marzo 1494, ordin il seque-
stro di un terreno gi donato dalla Ca-
mera Apostolica a Baccio Pontelli. Tut-
tavia, dal documento non si desume lesi-
stenza in vita dellarchitetto fiorentino
(cfr. ibid., e p. 107). La critica colloca il
primo soggiorno urbinate di Baccio Pon-
telli tra il 1479 e il 1482. La presenza
dellarchitetto fiorentino in Urbino in
quel periodo attestata nel 1481 dal-
la sua lettera di accompagnamento al ri-
lievo del palazzo Ducale di Urbino, che
egli effettu per Lorenzo de Medici (cfr.
J.W. Gaye, Carteggio inedito dartisti dei
secoli XIV, XV e XVI, Firenze 1839-40, 3
voll.; I, pp. 274-75). Il ritorno in Urbino
di Baccio Pontelli avvenne poco prima
del 1492 o in quello stesso anno, perch
esso viene posto in rapporto con la mor-
te di Innocenzo VIII. Tuttavia, Baccio
Pontelli pot visitare Urbino, tra il 1482
e il 1492, perch in quegli anni egli la-
vor a lungo nelle Marche, soprattutto
come commissario alle rocche pontificie
nella Marca di Ancona. Vedi anche note
84, 95 e 113.
23. Francesco di Giorgio si distacc gra-
dualmente da Urbino nel 1486-89. Gia-
como Cozzarelli il principale collabora-
tore dellarchitetto senese risultava an-
cora residente in Urbino nel 1488 e la
Bala di Siena intimava a Francesco di
Giorgio di tornare a risiedere in Siena
con la famiglia ancora nel gennaio 1489.
Tuttavia, gi dal 1486 Francesco di Gior-
gio aveva diviso la sua presenza tra Urbi-
no e Siena, e progressivamente aveva in-
tensificato i periodi di soggiorno nella sua
citt natale (cfr. L. Cavazzini, A. Galli (a
cura di), Biografia di Francesco di Giorgio
ricavata dai documenti, in L. Bellosi (a cu-
ra di), Francesco di Giorgio e il Rinascimen-
to a Siena. 1450-1500, Milano 1993, pp.
512-17; pp. 514-15). In occasione del de-
finitivo distacco di Francesco di Giorgio
da Urbino, o poco dopo, intervenne una
grave crisi nei rapporti tra larchitetto se-
nese e la corte dei Montefeltro, perch
solo un evento traumatico pot indurre
Giovanni Santi a cancellare dalla sua Cro-
nica il nome di Francesco di Giorgio.
Nella prima stesura del poema - versata
prima del 1488 la personalit e lattivit
di Francesco di Giorgio, col quale Gio-
vanni Santi era entrato in familiarit,
vennero trattate ampiamente e in modo
preciso e affettuoso. Ma con la revisione
della Cronica avvenuta tra il 1488 e il
1494 il lungo brano dedicato allarchi-
tetto senese venne coperto con otto versi
insignificanti. Inoltre, gi nel testo origi-
nario il nome di Francesco di Giorgio era
stato storpiato in Francesco Nori. Cfr.
Giovanni Santi, La vita..., cit. [cfr. nota
16], pp. XLVIII-XLIX, 418-19.
24. Vespasiano da Bisticci (1421-98)
scrisse le sue biografie nel 1480-95 circa. Il
proemio della Vita di Federico da Urbino,
con la dedica a Guidubaldo di Montefel-
tro, porta la data del 1493 (cfr. P. Rajna,
Vespasiano da Bisticci Libraio fiorentino del
secolo decimoquinto, in Rivista bolognese,
vol. I, pp. 604-15, vol. II, pp. 52-64; I, p.
614). Vespasiano da Bisticci pot vedere
personalmente il monastero di Santa
Chiara perch testimoni che fu in Urbi-
no nel 1482 (Vespasiano da Bisticci, Vi-
ta..., cit. [cfr. nota 9], pp. 213, 224).
25. Vedi nota 10.
26. Lo storiografo urbinate attribu dap-
prima la committenza delledificio a Eli-
sabetta di Montefeltro Il Monastero di
S.Chiara dentro la citt, edificato da Eli-
sabetta figliuola di Federico, la quale []
rimasta vedova vi spese la sua dote (B.
Baldi, Encomio della patria, Urbino 1706;
ripubblicato in id., Memorie concernenti la
citt di Urbino, a cura di F. Bianchini, Ro-
ma 1724, p. 26). Ma successivamente il
Baldi parl della fabbrica con unespres-
sione che soggetta a uninterpretazione
controversa fecesi monaca (Elisabetta di
Montefeltro) e co danari della sua dote
fabbric in Urbino, imitando la magnifi-
cenza paterna, il Monastero sontuosissi-
mo di santa Chiara (Baldi, Vita..., cit.
[cfr. nota 16], III, nota M a p. 277). Dal
brano non emerge chiaramente se imi-
tando la magnificenza paterna Elisabet-
ta Feltria avesse genericamente prosegui-
to il mecenatismo paterno o, specificata-
mente, la fabbrica del monastero di San-
ta Chiara in Urbino.
27. Archivio Capitolare di Urbino, Rela-
zione della citt e diocesi di Urbino di Fuschi-
nio Brancaleone, 1597. Cit. in Ligi, Memo-
rie..., cit. [cfr. nota 8], pp. 402-03.
28. In verit labate urbinate afferm ini-
zialmente che Il Convento di S. Chiara
dUrbino fu fabbricato da Elisabetta Fel-
tria (Lazzari, Delle chiese..., cit. [cfr. nota
11], p. 78). Ma il Lazzari distinse poi la
fabbrica delledificio in due campagne di
lavori e spieg perch Elisabetta Feltria
fosse ritenuta fondatrice del monastero:
il magnifico Convento di S. Chiara []
che Federico incominci ad edificarlo, ed
Elisabetta sua Figlia circa lanno 1483 e
1484, dopo essere rimasta Vedova di Ro-
berto Malatesta, vimpieg la sua dote,
vestendo ancor essa lAbito, ed ivi mona-
candosi, per cui il detto Monistero, con-
servandone il Ritratto, chiamolla sempre
sua Fondatrice. A. Lazzari, De Vescovi
dUrbino, Urbino 1806, p. 82.
29. Nel 1471 Francesco di Giorgio fu pa-
gato perch dipense la choronazione
della Madonna [] e fece la nobil tribu-
na, e soffitta. Cfr. C. Zarrilli (a cura di),
Francesco di Giorgio pittore e scultore nelle
fonti archivistiche senesi, in Bellosi (a cura
di), Francesco..., cit. [cfr. nota 23], pp. 530-
38; p. 530.
30. La ricostruzione della chiesa dellOs-
servanza di Siena che fu realizzata se-
condo alcuni da Francesco di Giorgio e
Giacomo Cozzarelli venne decisa il 20
luglio 1474. Nel luglio 1475 dovevano
gi essere iniziate le opere di fondazione.
In proposito si richiese il parere di alcuni
tecnici, che suggerirono delle rettifiche.
Nellagosto 1476 vennero approvate le
rettifiche come parr di fare al maestro
el quale decto edifitio condurr (cfr. M.
Bertagna, La basilica di San Bernardino
dellOsservanza di Siena. Note storico-arti-
stiche, in Archivum Franciscanum Histo-
ricum, LVI, 1963, pp. 284-331, 390-
438; pp. 285-89).
31. M. Tafuri, Le chiese di Francesco di
Giorgio Martini, in Fiore,Tafuri (a cura
di), Francesco di Giorgio..., cit. [cfr. nota 3],
pp. 21-73; p. 26.
32. F.P. Fiore, Larchitettura civile di Fran-
cesco di Giorgio, in Fiore,Tafuri (a cura di),
Francesco di Giorgio...,cit. [cfr. nota 3], pp.
74-125; p. 75.
33. G. Della Valle, Lettere sanesi di un so-
cio dellAccademia di Fossano, sopra le Belle
Arti, Venezia-Roma 1782-86, 3 voll., II,
p.105. Cit. in Scaglia, Newly..., cit. [cfr.
nota 4], nota 3 a p. 112.
34. E. Romagnoli. Biografia Cronologica
de Bellartisti Senesi dal secolo XII a tutto il
XVIII, Firenze 1976, 13 voll.; II, c. 766.
Ripr. anast. dei mss. L.II.1/13 della Bi-
blioteca Comunale di Siena [ante 1835].
Cit. in Scaglia, Newly..., cit. [cfr. nota 4],
p. 112.
35. A. Allegretti, Diarii [] delle cose sene-
si del suo tempo [ante 1497], in Rerum Itali-
carum Scriptores, Milano 1783, t. XXIII,
pp. 767-866; p. 776. Cit. in S. Borghesi,
L. Banchi, Nuovi documenti per la storia
dellarte senese, Siena 1898, p. 258.
36. Su Francesco Sanson cfr. A. Zanelli,
Maestro Francesco Sanson, in Bullettino
Senese di Storia Patria, IV, 1897, pp.
83-100; G. Abate, Francisci Sansonis mini-
stri generalis ordinis fratrum minorum Re-
gestum, in Miscellanea francescana,
XXII, 1921, pp. 147-74, XXII, 1922, pp.
42-60, XXXVII, 1938, pp. 525-56; G.
Parisciani (a cura di), Regesta Ordinis Fra-
trum Minorum, Padova 1989, pp. XIV-
XXII, XLII-XLVI. Per un rapido cenno
sullattivit di insegnante del Sanson cfr.
G. Fioravanti, Le arti liberali nei secoli
XIII-XV, in LUniversit di Siena. 750 an-
ni di Storia, Milano 1991, pp. 255-71.
Per alcune notizie sul mecenatismo arti-
stico del Sanson cfr. G. Agosti, Su Siena
nellItalia artistica del secondo Quattrocento
(desiderata scherzi cartoline), in Bellosi (a
cura di), Francesco..., cit. [cfr. nota 23],
pp. 488-509; pp. 493-94, note 38-46 alle
pp. 505-06.
37. L. Wadding, Annales Minorum, Roma
1731-98, 20 voll.; XIV 1472-91, p. 124.
38. Francesco della Rovere, poi papa Si-
sto IV negli anni 1471-84, e Federico di
Montefeltro ebbero rapporti di amicizia
fino alla rottura tra loro intervenuta nel
1481. Francesco della Rovere frequent
dagli anni cinquanta la corte di Urbino, al
seguito del cardinal Bessarione, stringen-
do una solida amicizia con Federico di
Montefeltro e Ottaviano Ubaldini (cfr. L.
Michelini Tocci, Federico di Montefeltro e
Ottaviano Ubaldini della Carda, in Federico
di Montefeltro. Lo Stato. Le Arti. La Cultu-
ra, Roma 1986, 3 voll., vol. Lo Stato, pp.
297-344; pp. 320, 332). Lamicizia si tra-
mut in alleanza politica dopo la nomina
a pontefice del della Rovere.
39. Nel lungo elenco testamentario dei
beni mobili posseduti dal Sanson si regi-
str una cassa, conservata nel convento
di San Francesco di Brescia, et in eadem
capsa sunt centum parulae orientales il-
lustrissimi d.ni Ducis Urbini super qui-
bus praestiti ducatos aureos quingentos.
Una settimana dopo la morte del Sanson
il 4 novembre 1499 si stil linventa-
rio dei beni del defunto conservati in
quel convento e vi si annot la registra-
zione di quel prestito: Uno scritto de
mano de dinari imprestati allo Ill.mo Du:
DUrbino de Ducatti cinquecento (cfr.
R. Prestini, Devozioni in San Francesco, in
Musica e devozione nella chiesa di S.France-
sco dAssisi a Brescia, Brescia 1983, pp.
224, 227).
40. Cfr. Agosti, Su Siena..., cit. [cfr. nota
36], p. 494 e nota 38 a p. 505; Parisciani
(a cura di), Regesta..., cit. [cfr. nota 36],
pp. XX-XXI.
41. La postillatura martiniana al De inge-
neis I-II del Taccola testimonia lo studio
e forse il temporaneo possesso di quel
codice da parte di Francesco di Giorgio
(vedi anche nota 3). Ma lartista senese
conobbe e studi precocemente anche il
De ingeneis III-IV ms. Palatino 766 del-
la Biblioteca Nazionale di Firenze . In-
fatti liconografia della Santa Dorotea e il
Bambin Ges di Francesco di Giorgio,
oggi alla National Gallery di Londra,
venne molto probabilmente desunta da
un disegno, di identico soggetto, che al
f. 42r del De ingeneis III-IV del Taccola.
La datazione ai primissimi anni sessanta
della tavoletta martiniana fa ipotizzare
che Francesco di Giorgio si fosse dedica-
to precocemente allo studio di opere di
architettura e ingegneria, prevalente-
mente consultate presso lUniversit di
Siena, dove si ritiene che fosse conserva-
to il De ingeneis del Taccola. Cfr. L. Bel-
losi, Scheda n. 5..., in Bellosi (a cura di),
Francesco..., cit. [cfr. nota 23], pp. 120-21.
42. Per Alessandro Sermoneta, medico
senese e docente presso lUniversit di
Siena, nato nel 1424, Francesco di Gior-
gio mini il frontespizio del De Animali-
bus di Alberto Magno, che viene datato al
1463 circa. Va segnalato che il Sermone-
ta ospit Federico di Montefeltro nella
propria residenza di Siena, nel 1478, du-
rante la guerra tra Sisto IV e Firenze, (cfr.
Allegretti, Diarii..., cit. [cfr. nota 35], p.
780). Ci ha fatto ipotizzare che il Ser-
moneta potesse essere stato il tramite tra
Federico di Montefeltro e Francesco di
Giorgio. Cfr. A. Angelini, Scheda n. 10...,
in Bellosi (a cura di), Francesco..., cit. [cfr.
nota 23], pp. 142-45.
43. Luciano Bellosi ha di recente attri-
buito a Francesco di Giorgio il Gisant
di Mariano Sozzini il Vecchio, del 1467 cir-
ca, oggi al Museo del Bargello di Firenze
(cfr. L. Bellosi, Scheda n. 26..., in Bellosi
(a cura di), Francesco..., cit. [cfr. nota 23],
pp. 198-99).
44. Vedi nota 1.
10-11|1998-99 Annali di architettura
Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org
39
45. Pasquale Rotondi si addirittura
spinto a una datazione pi alta, perch ha
ipotizzato che Francesco di Giorgio dette
dei disegni per delle decorazioni del pa-
lazzo Ducale di Urbino ancor prima del
1474 (cfr. P. Rotondi, Il Palazzo Ducale di
Urbino, Urbino 1950-51, 2 voll., I, pp.
267, 287, nota 147 a p. 439, nota 218 a
pp. 463-65). La prima opera autografa
urbinate di Francesco di Giorgio rite-
nuta il bassorilievo bronzeo della Deposi-
zione oggi nella chiesa del Carmine di
Venezia ma proveniente dalloratorio del-
la Santa Croce di Urbino che viene da-
tato al 1475 circa. Cfr. A.S. Weller, Fran-
cesco di Giorgio, 1439-1501, Chicago 1943,
p. 135; F. Fumi Cambi Gado, Scheda n.
68..., in Bellosi (a cura di), Francesco..., cit.
[cfr. nota 23], pp. 350-353.
46. La vertenza sorta tra Francesco di
Giorgio e Neroccio, in occasione dello
scioglimento della societ quam simul
habuerunt in arte pictorum, venne risol-
ta con un compromesso. Furono eletti
laudatori il Vecchietta e Sano di Pietro,
rispettivamente per Francesco di Giorgio
e Neroccio. Cit. in Zarrilli (a cura di),
Francesco..., cit. [cfr. nota 29], p. 531.
47. Cit. in ibid., pp. 531-32.
48. Si tratta di una lettera, inviata dalla
Signoria di Siena al commissario per il la-
go sulla Bruna, in cui lo si informava che
sarebbero stati inviati i maestri Francius
et Sanus per verificare lesecuzione dei
lavori della diga sulla Bruna. Una vecchia
trascrizione ottocentesca del documento
aveva alterato Francius in Franciscus.
Cfr. G. Chironi, Repertorio dei documenti
riguardanti Mariano di Iacopo detto il Tacco-
la e Francesco di Giorgio Martini, in P. Gal-
luzzi (a cura di), Prima di Leonardo. Cultu-
ra delle macchine a Siena nel Rinascimento,
Milano 1991, pp. 471-82; p. 474 e nota
17 a p. 482.
49. Alcuni studiosi hanno gi ipotizzato
che Francesco di Giorgio avesse sciolto la
societ con Neroccio, in vista del suo tra-
sferimento in Urbino. Ad esempio cfr.
Weller, Francesco..., cit. [cfr. nota 45], p.
134; Fiore, Larchitettura..., cit. [cfr. nota
32], p. 75.
50. Il 25 maggio 1477 lo Spectabilis vir
et ingegnosus architector Franciscus
Georgii de Senis don, per conto di Ot-
taviano Ubaldini, un terreno sito in Gub-
bio (cit. in P.L. Menichetti, Le corporazio-
ni delle Arti e Mestieri Medievali a Gubbio,
Citt di Castello 1980, pp. 239-40).
Quella funzione di fiduciario Francesco
di Giorgio la svolse anche per Federico di
Montefeltro, in due altre contemporanee
occasioni. Nellallogagione di una pittura
nella camera ducale del palazzo di
Gubbio (cit. in ibid.) e nellallogagione
dei lavori per la fortificazione di Costac-
ciaro (vedi nota 1). I tre documenti sono
riportati in Chironi, Repertorio..., cit .[cfr.
nota 48], pp. 402-03.
51. Giovanni Santi testimoni che Fede-
rico di Montefeltro anco havea ordina-
to/ nel suo pallazzo, a lultimo riposo/ un
tempio (cfr. Giovanni Santi, La vita...,
cit. [cfr. nota 16], p. 420, vv. 139-47). Un
secolo dopo il Baldi scrisse che si sarebbe
dovuto costruire il tempio nel cortile
del Pasquino e aggiunse che nella guar-
darobba de Duchi se ne conserva ancora
il modello (B. Baldi, Descrittione del Pa-
lazzo Ducale di Urbino, in id., Versi e prose,
Venezia 1590; ripubblicato in id., Memo-
rie..., cit. [cfr. nota 26], p. 63).
52. Durante il capitolo generale conven-
tuale del 1475 Federico di Montefeltro si
pose certamente il problema di ricostrui-
re la chiesa e il convento degli osservanti
urbinati. Il duca di Urbino verific in
quelloccasione la modestia del convento
di San Donato, per cui si scus con un
frate che aveva partecipato a quel capito-
lo (Federico di Montefeltro, Lettere di
Stato e dArte (1470-80), a cura di P. Ala-
tri, Roma 1949, pp. 77-78). Inoltre, an-
che in quelloccasione egli ebbe modo di
riflettere sugli aspetti pagani di una se-
poltura in un mausoleo e sulla soluzione
molto migliore, sotto laspetto religioso,
di una sepoltura in una chiesa necessaria-
mente francescana, perch i Montefeltro
erano legati da secoli a quellordine rego-
lare e i signori di Urbino venivano tradi-
zionalmente sepolti nelle chiese france-
scane di Urbino. Cfr. G. Franceschini, I
Montefeltro, Milano 1970, nota 3 a p. 362,
nota 24 a p. 409, nota 31 a p. 430.
53. Vespasiano da Bisticci lo testimoni
pi volte. In una di quelle occasioni scris-
se: Lasci in ultimo suo testamento (Fe-
derico di Montefeltro) che fusse rifatta la
chiesa e il convento di Santo Donato,
luogo di frati minori fuori dUrbino, do-
ve, in vita sua, aveva disegnato dessere
poi sepulto (Vespasiano da Bisticci, Vi-
ta..., cit. [cfr. nota 9], p. 225; cfr. inoltre
pp. 224, 225). Giovanni Santi conferma
la testimonianza di Vespasiano da Bistic-
ci: Distante da Urbin ben mille passi/ fu
sepelito (Federico di Montefeltro) l, nel
tempio sancto/ di San Donato [] e l
suo fratello, (Ottaviano Ubaldini)/ pien
de alto amore e caritade e zelo,/ aedificar
fa uno tempio richo e bello/ ai poveri
Observanti di Francesco,/ cum un sepul-
cro qual conviense a quello/ (Giovanni
Santi, La vita..., cit. [cfr. nota 16], II, p.
743). La chiesa e il convento di San Ber-
nardino, nel cui contesto venne ingloba-
ta la vecchia chiesa osservante di San Do-
nato, vennero costruiti tra la met degli
anni ottanta e linizio degli anni novanta
del sec. XV.
54. La fabbrica del duomo di Urbino co-
minci tra la fine del 1480 e linizio del
1481. Il 30 giugno 1481 un maestro co-
struttore stipul una convenzione con al-
cuni maestri luganesi perch edificassero
al suo posto e alle stesse condizioni da
lui precedentemente pattuite coi fabbri-
ceri del duomo le opere edilizie di cui
era stato incaricato. Cfr. F. Negroni, Il
Duomo di Urbino, Urbino 1993, p. 57 sgg.
55. Vedi nota 32.
56. (Ill. 1). Il disegno a penna e inchio-
stro bruno con uso di riga su carta. Le
misure sono indicate in piedi da fabbrica
di Urbino. Quella unit di misura era pa-
ri a 35,372 cm ed era divisa in 12 once
(cfr. A. Martini, Manuale di metrologia,
Torino 1883, p. 807, rist. anast., Roma
1976). La misura di unoncia nel disegno
corrisponde a 30 piedi nella costruzione,
secondo il rapporto di 1:360. Lattribu-
zione a Francesco di Giorgio stata avan-
zata da Burns (Progetti..., cit. [cfr. nota 4],
pp. 296-98), basandola sulla scrittura e
sullaspetto a filo di ferro del disegno.
Alcune misure apposte sulla pianta sono
errate. La lunghezza del giardino ve-
rosimilmente di 100 piedi, invece che
110. La lunghezza del Rifetorio di 41
piedi, invece che 43. Inoltre, per ottenere
la larghezza di sei piedi per ciascuno dei
tre cacatori occorre sottrarre dallam-
piezza di 20 piedi del vano lo spessore di
un piede per ciascuno dei due tramezzi.
Infine, anche le misure del chortile,
8050 piedi, risultano sbagliate e vanno
corrette in 7956. Larea totale del mona-
stero misura 4526 mq. Il giardino dei fra-
ti 1079 mq, il giardino 1226 mq, il
cortile 457 mq, ledificio 1764 mq.
57. Lipotesi che Francesco di Giorgio
avesse previsto di accostare il monastero
alloratorio di SantAntonio si basa sulla
documentata propriet delle clarisse, che
a nord giungeva fino al muro della chie-
sa della Fraternita di SantAntonio, esclu-
sa (vedi nota 15) (ill. 2). Il confine tra le
due propriet venne individuato dal mu-
ro nord dellabitazione del guardiano e la
posizione di quel muro, oggi demolito,
rintracciata nella ricostruzione di Frater-
nale (ill. 9) e nelle piante topografiche di
Urbino di inizio Ottocento (cfr. G. Cuc-
co, Urbino percorso iconografico dal XV al
XIX secolo, Urbino 1994, pp. 252-53, 275-
81). Il posizionamento del bordo in basso
della pianta ai ff. 66v-67r sul rilievo pla-
nimetrico dellex monastero avvenuto
adattando la linea retta che nel proget-
to martiniano sulla linea leggermente
curva di via Santa Chiara (ill. 3). La lar-
ghezza delledificio costruito in media
di 123 piedi, a cui vanno aggiunti i 5,5
piedi di larghezza dellimpasse che separa
il monastero dal convento di San Girola-
mo, per un totale di 128,5 piedi. Quella
misura di quattro piedi maggiore della
corrispondente, di 124,5 piedi, che Fran-
cesco di Giorgio segn sulla pianta. Las-
setto dei luoghi disegnati nel lato sinistro
della pianta rilevato in modo impreciso
e geometrizzato (ill. 2). In particolare
rilevante la distanza che separa il torrione
semicircolare, disegnato nella pianta
martiniana, dalla rampa elicoidale del
monastero che venne innalzata, con tutta
evidenza, su quel torrione semicircolare
delle mura urbiche (ill. 8).
58. Burns, Progetti..., cit. [cfr. nota 4], p.
298.
59. Scaglia, Newly..., cit. [cfr. nota 4], p.
114.
60. (Ill. 5). Il disegno a penna e inchio-
stro nero su carta senza uso di riga. Le
misure sono indicate in piedi da fabbrica
di Urbino. La misura di unoncia nel di-
segno corrisponde a 20 piedi nella costru-
zione, secondo il rapporto di 1:240. La
pianta appare copiata da un probabile
progetto di Francesco di Giorgio e come
tale venne segnalata e posta in rapporto
col monastero di Santa Chiara in Urbino
da Burns, insieme ad unaltra analoga
pianta al f. 54r dello stesso codice Ash-
burnham 1828 app. (Progetti..., cit. [cfr.
nota 4], nota 52 a pp. 305-06). Questul-
timo disegno presenta delle varianti mar-
ginali, rispetto al disegno al f. 65r, e va ri-
composto col disegno al f. 60r dov di-
segnato il giardino che venne tagliato e
separato dal disegno al f. 54r. Alcune mi-
sure sono palesemente errate, forse per-
ch le corrispondenti non erano indicate
nelloriginale. Gli elementi di affinit col
progetto ai ff. 66v-67r appaiono evidenti.
Le scritte sono riferite certamente ad un
progetto di convento e lelemento centra-
le della pianta, composto di portico din-
gresso, chiesa e coro, ha una larghezza di
30 piedi come il corrispondente corpo di
fabbrica della pianta ai ff. 66v-67r. Anche
la disposizione del monastero e del giar-
dino affine nei due progetti. Un ulterio-
re indizio concordante per il riferimen-
to dei due progetti allo stesso edificio
dato dalla lunghezza della pianta al f. 65r.
Essa risulta verosimilmete pari a 168 pie-
di e pari alla lunghezza della pianta del-
ledificio ai ff. 66v-67r, se ai 145 piedi del
fronte edilizio sulla via si aggiunge i 23
piedi della scala nella testata sinistra della
loggia. Francesco di Giorgio dovette ini-
zialmente individuare sulla via del corti-
le un fronte edilizio di 168 piedi. Questo
fronte costituiva il lato di un rettangolo
che si inseriva, a est e in alto nella pianta,
tra le nuove mura urbiche del secolo XV
e il convento di San Girolamo (ill. 2). Il
monastero e il giardino accostati misura-
no 134 piedi circa, ma il foglio pare ta-
gliato sul bordo in alto e, se cos fosse, la-
rea del monastero avrebbe invaso per una
maggior profondit il terreno a nord del
convento di San Girolamo. Larea totale
del monastero misura 2690 mq. Il giardi-
no 1345 mq, i chiostri sono 475 mq cir-
ca, ledificio 1170 mq circa.
61. (Ill. 6). Il disegno a penna e inchio-
stro bruno su carta, su di una traccia pre-
paratoria a gessetto, con uso di riga e
compasso. Le misure sono indicate in
piedi da fabbrica di Urbino. La misura di
unoncia nel disegno corrisponde a 20
piedi nella costruzione, secondo il rap-
porto di 1:240. Lattribuzione a France-
sco di Giorgio stata avanzata da Burns
(Progetti..., cit. [cfr. nota 4], pp. 296, 298-
99) ed basata sulla scrittura e sullaspet-
to a filo di ferro del disegno. Il foglio
stato ritagliato attorno al disegno e il di-
segno stesso stato tagliato nella parte
sinistra. tuttavia evidente che lattuale
disegno residuo facesse parte di una
pianta a simmetria speculare. Ci trova
conferma in due misure apposte sul fo-
glio qui di sopra p(er) tuto el dormen-
tor(i)o longo p(iedi) 230 largo p(iedi) 25
che permettono di verificare lasse di
simmetria delledificio nella mezzeria
della chiesa. Larea del monastero misura
3026 mq. I chiostri sono 442 mq e ledi-
ficio 2584 mq.
62. Burns ha proposto di identificare il
disegno ai ff. 63v-64r come un progetto
per la chiesa e il convento di San Bernar-
dino in Urbino (ibid.). Subito dopo la
Scaglia ha invece suggerito che lidentifi-
cazione del progetto andasse condotta su
other monasteries of the Osservanti,
perhaps in the Marche. Cfr. Scaglia,
Newly..., cit. [cfr. nota 4], p. 122.
63. il disegno n. 124 al f. 87r, che da-
tabile alla seconda met del secolo XV. Si
tratta di una sezione prospettica per il
progetto dellinterno della chiesa di San
Bernardino, che presenta alcune margi-
nali differenze con la chiesa urbinate.
Proprio queste differenze autorizzano a
ritenere che si tratti di uno studio prepa-
ratorio, disegnato da un ignoto collabora-
tore di Francesco di Giorgio. Questa ipo-
tesi trova conferma nelle due misure ap-
poste al disegno, forse autografe dellar-
chitetto senese, che non trovano riscon-
10-11|1998-99 Annali di architettura
Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org
40
tro nella chiesa degli osservanti di Urbi-
no. Cfr. Burns, Progetti..., cit. [cfr. nota 4],
p. 299; id., San Bernardino a Urbino..., in
Fiore, Tafuri (a cura di), Francesco di Gior-
gio..., cit. [cfr. nota 3], pp. 230-43; p. 238.
64. Francesco di Giorgio Martini, Tratta-
ti..., cit. [cfr. nota 2], I, p. 238.
65. Francesco di Giorgio usava delle se-
zioni prospettiche, oltre a dei modelli,
per la progettazione e la rappresentazio-
ne degli interni degli edifici. Egli adott
in modo pionieristico le vedute prospetti-
che ed assonometriche anche nella pro-
gettazione e rappresentazione degli
esterni degli edifici. Larchitetto senese fu
tra i primi a mettere a punto quegli stru-
menti grafici, ma certamente egli usava
anche delle proiezioni ortogonali (cfr.
op.cit., I, pp. 87-91, tavv. 36 e 37). Sulla
rappresentazione degli interni di archi-
tettura nel Rinascimento cfr. W. Lotz,
Das Raumbild in der Architekturzeichnung
der italienischen Renaissance, in Mitteilun-
gen des Kunsthistorischen Instituts in
Florenz, 7, 1956, pp. 193-226, trad. it. in
id., Larchitettura del Rinascimento, Milano
1997, pp. 89-119.
66. Cfr. Burns, I disegni ..., cit. [cfr. nota
3], p. 345.
67. Nel capitolo sui conventi in T, Fran-
cesco di Giorgio accenn due volte alle
camere de frati sistemate ad apparta-
mento con saletta, oratorio, camera.
Francesco di Giorgio Martini, Trattati...,
cit. [cfr. nota 2], I, pp. 237-38. Inoltre cfr.
Parisciani (a cura di), Regesta..., cit. [cfr.
nota 36], pp. LXXXV-LXXXVI.
68. Nel primo Trattato Francesco di
Giorgio descrisse alcuni giardini inseriti
nel contesto di edifici diversi, tra cui dei
conventi. Francesco di Giorgio Martini,
Trattati..., cit. [cfr. nota 2], I, pp. 71-72,
238-39, 245-46, tavv. 29, 121 e 122.
69. La ricostruzione delle misure dei va-
ni della parte destra della pianta abba-
stanza sicura. Fissati i probabili spessori
murari: tre piedi per la chiesa, il coro e il
muro esterno; due piedi per gli altri mu-
ri; un piede per i tramezzi delle came-
re, la misura della parte destra della
pianta risulta pari a 84 piedi, per un tota-
le di 168 piedi delledificio. Da questul-
tima misura si ricava le larghezze delle-
dificio e del giardino, che sono entrambe
pari a 67 piedi, per un totale di 134 (vedi
anche nota 60). Nella parte destra della
pianta i vani delle camere hanno di-
mensioni di 55, 105, 1010 piedi.
Nella parte sinistra della pianta i vani si-
curamente identificabili hanno dimen-
sioni di 105, 1010, 1710, 2510,
3010 piedi. I due chiostri quadrati han-
no il lato di 25 piedi e la chiesa ha il dia-
metro di 30 piedi.
70. Le due misure apposte sulla pianta
(ill. 6) sono relative alla lunghezza totale
delledificio e alla larghezza del dormito-
rio (vedi nota 61). Esse consentono di in-
dividuare nellinfermeria una serie di cel-
le accostate di 1010 piedi e divise da un
corridoio di 5 piedi. Di qui parte la misu-
razione degli altri ambienti. In particola-
re dei vani quadrati di 2020 piedi del
parlatorjo e del vestibolo p(er) lj fratj
e dei due moduli quadrati di 3030 piedi
che formano la chiesa.
71. La marcata affinit tra le due piante fa
riferimento alloriginaria presenza di
unabside a pianta semicircolare nella
chiesa degli osservanti urbinati (cfr.
Burns, San Bernardino..., cit. [cfr. nota
63], pp. 232, 240-42; A. Terzaghi, Nuovi
elementi per il problema di Urbino, in Il
mondo antico nel Rinascimento, atti del V
Convegno internazionale di studi sul Ri-
nascimento, (Firenze, Palazzo Strozzi, 2-
6 sett. 1956, Firenze 1958, pp. 279-83).
Tuttavia, tra le due piante esistono due
differenze. La prima relativa al vano
triabsidato della chiesa urbinate, dove so-
no presenti quattro colonne angolari, as-
senti nel disegno, che sorreggono gli ar-
chi delle crociere su cui sono impostati i
pennacchi della cupola. La seconda re-
lativa ai due setti murari in aggetto, dise-
gnati nella pianta ai ff. 63v-64r e assenti
nel San Bernardino, che dividono la na-
vata dal presbiterio della chiesa. Va infine
segnalato che nel codice Ashburnham
1828 App. si trovano alcune copie e va-
rianti del disegno ai ff. 63v-64r e diversi
altri disegni comunque riferibili a proget-
ti martiniani di conventi. Tra essi spicca il
terzo disegno autografo di Francesco di
Giorgio, al f. 159r.
72. Francesco di Giorgio Martini, Tratta-
ti..., cit. [cfr. nota 2], I, tavv. 35, 43-44, II,
tavv. 197-202, 206, 208. La soluzione
compare numerose volte anche nei dise-
gni del codice Ashburnham 1828 App.
Sul retro del disegno n. 291 di quel codi-
ce, al f. 201v, lunico disegno quattro-
centesco rimasto del palazzo Ducale di
Urbino. una veduta dello scalone do-
nore, attribuita a un ignoto collaboratore
di Francesco di Giorgio. Cfr. Burns, Un
disegno..., cit. [cfr. nota 4], p. 105.
73. Lesistenza di due diversi tipi di pian-
te nella progettazione del monastero di
Santa Chiara in Urbino luna inserita
nel contesto del sito e disegnata secondo
un rapporto con denominatore pi gran-
de (1:360), laltra priva di ogni riferimen-
to al sito e disegnata secondo un rappor-
to con denominatore pi piccolo (1:240)
forse da mettere in rapporto con un
ovvio procedimento progettuale. Larchi-
tetto senese probabilmente dettagliava i
progetti a scala pi grande, dopo aver
controllato linserimento delledificio nel
sito a scala pi piccola.
74. Vedi note 8 e 15.
75. Vedi nota 57.
76. Nel secondo Trattato Francesco di
Giorgio descrisse brevemente le latrine.
Egli sottoline la necessit di dotarle di
condotti di aerazione (Francesco di
Giorgio Martini, Trattati..., cit. [cfr. nota
2], II, pp. 335-37, tav. 191). Analoghe in-
dicazioni si ritrovano nel Trattato del Fi-
larete (Filarete, Trattato di architettura, a
cura di A.M. Finoli, L. Grassi, Milano
1972, 2 voll.; I, pp. 303-04). Opere
conformi a quelle indicazioni si rintrac-
ciano sia nellOspedale Maggiore di Mi-
lano del Filarete (cfr. op.cit., ill. 27 e 28)
sia nel palazzo Ducale di Urbino. Cfr. V.
Guidi, Gli impianti tecnologici, in M.L.
Polichetti (a cura di), Il Palazzo di Federi-
co da Montefeltro. Restauri e ricerche, Urbi-
no 1985, pp. 627-40; p. 640 e tav. n. 18
dei rilievi f.t.
77. Vedi nota 85.
78. Il testo del paragrafo sui bagni e le
stufe identico in L e T (Francesco di
Giorgio, Il Codice Ashburnham 361 della
Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze,
a cura di P.C. Marani, Firenze 1979, 2
voll.; I, p. 47 sgg. e note, II, f. 23r; Fran-
cesco di Giorgio Martini, Trattati..., cit.
[cfr. nota 2], I, pp. 99-101 e note, tav.
42). Anche i quattro disegni sono quasi
identici ma le didascalie sono diverse (ill.
7) (Francesco di Giorgio, Il Codice..., cit.
[cfr. nota 78], I, p. 131; Francesco di
Giorgio Martini, Trattati..., cit. [cfr. nota
2], I, p. 261). La diversit si accentua
molto nelle scritte apposte ai due spacca-
ti assonometrici che illustrano il laconi-
co. Le due scritte in T: Stufa, cappel-
lo di bronzo; sono pi esplicative in L:
stufa sichondo li antichi, cappello di
bronzo( per la) temperanza. Inoltre,
in L sono descritti il profurnio della
stufa, e lo spazio cilindrico che con-
giunge il foro praticato nel pavimento
col clipeo di bronzo ed il foro nella som-
mit della stufa. In questo spazio appo-
sta la scritta chamino del fuocho p(er) lo
quale la stufa rischalda che, nella pianta
ai ff. 66v-67r, venne abbreviata in cami-
no dove si schalda.
79. La trattatistica di Francesco di Gior-
gio un problema critico aperto. Al suo
arrivo in Urbino nel 1475 lartista senese
aveva gi compilato gran parte del Codi-
cetto e completato lOpusculum de architec-
tura, questultimo preparato forse espres-
samente per farne dono a Federico di
Montefeltro. Entrambi i codici sono au-
tografi e presentano un materiale omoge-
neo, prevalentemente riferito agli argo-
menti di una enciclopedia tecnologica.
Col soggiorno urbinate inizi la vera atti-
vit di autore di Francesco di Giorgio. La
trascrizione di un primo abbozzo del pri-
mo Trattato e di una iniziale traduzione
da Vitruvio viene identificata nel codice
Zichy (ms. 09.2690 della Biblioteca Mu-
nicipale Szb Ervin di Budapest). Subi-
to dopo, la critica colloca il primo Tratta-
to, il cui testo sarebbe stato compilato fra
il 1478 e il 1481. Le due stesure del pri-
mo Trattato sarebbero state copiate sepa-
ratamente: L tra il 1480 e il 1482, T fra il
1482 e il 1486. Il nesso che viene ora al-
lacciato tra il disegno ai ff. 66v-67r degli
anni 1475-76 e il materiale copiato al f.
23r di L consente di anticipare di qualche
anno la compilazione di almeno alcuni
passi del primo Trattato e la preparazione,
se non la copiatura nel codice, di almeno
alcuni disegni annotati di L. Cfr. C. Mal-
tese (introduzione), in Francesco di
Giorgio Martini, Trattati..., cit. [cfr. nota
2], pp. XI-LXIV; G. Scaglia. Francesco di
Giorgio autore, in Galluzzi (a cura di), Pri-
ma di..., cit. [cfr. nota 48], pp. 57-80; id.,
Francesco di Giorgio Checklist and History of
Manuscripts and Drawings..., London
1992; Mussini, La trattatistica..., cit. [cfr.
nota 3], pp. 358-379.
80. Francesco di Giorgio testimoni che
i maggiori sforzi da lui coordinati nella
comprensione del De architectura avven-
nero in Urbino, tra il 1475 e il 1482, da
parte di dotti umanisti sollecitati in que-
sto compito da lui stesso e da Federico di
Montefeltro (Francesco di Giorgio Mar-
tini, Trattati..., cit. [cfr. nota 2], II, p.
295). I risultati di quegli sforzi appaiono
evidenti nella Traduzione da Vitruvio, che
autografa e viene prevalentemente da-
tata nel nono decennio del secolo XV. Da
essa risulta la migliore comprensione rag-
giunta da Francesco di Giorgio del testo
di Vitruvio, rispetto al primo Trattato e ai
suoi abbozzi intermedi, dove Francesco
di Giorgio fece un uso molto ampio del
De architectura. Il preciso riferimento ad
un passo del testo vitruviano, che si evi-
denzia nella pianta ai ff. 66v-67r, testimo-
nia che la Traduzione da Vitruvio era in at-
to subito dopo larrivo di Francesco di
Giorgio in Urbino (cfr. Fiore, La tradu-
zione..., cit. [cfr. nota 3], pp. 7-30). Con
qualche ragione, la Scaglia anticipa linte-
resse martiniano per Vitruvio a prima del
suo soggiorno in Urbino, e lo pone in re-
lazione con lambiente umanistico sene-
se. Cfr. Marco Vitruvio Pollione, Il Vitru-
vio Magliabechiano di Francesco di Giorgio
Martini, a cura di G. Scaglia, Firenze
1985, pp. 13-71.
81. Luso di una stufa in un monastero
pu apparire un comfort fuori luogo, ma
esso concorda con le rinnovate esigenze
igieniche e mediche del tardo Medioevo
e con la tradizione di innovazioni tecno-
logiche e costruttive e messa in opera da-
gli ordini regolari. Il calefactorium e il
chauffoir delle abbazie cistercensi transal-
pine prefigurano la nostra stufa. Alcuni
indizi sulla esistentenza di tali attrezzatu-
re anche nei conventi italiani si ricavano
da regesti conventuali contemporanei,
dove si citano ambienti con camino e
stufette per il bagno caldo (cfr. Pariscia-
ni (a cura di), Regesta..., cit. [cfr. nota 36],
pp. LXXXV-LXXXVI). Allatto della co-
struzione del monastero, Francesco di
Giorgio sostitu la stufa con uno spulcia-
toio, che rivestiva anchesso unimpor-
tante funzione igienica. Cfr. G. Scaglia,
Stanze-stufe e stanze-camini nei tratta-
ti di Francesco di Giorgio da Siena, in
Bollettino dArte, 39-40, 1986, pp.
161-84.
82. Lanalisi comparata delle tre serie di
illustrazioni sui bagni e le stufe porta ad
alcune considerazioni. Il f. 164r del codi-
ce Zichy (riprodotto in ibid., p. 166) pre-
senta tre disegni: lo spaccato assonome-
trico di un bagno, lo spaccato assonome-
trico di un bagno e una stufa accostati, la
pianta dellipocausto di una stufa. Essi
corrispondono puntualmente al testo di
base (Francesco di Giorgio Martini, Trat-
tati..., cit. [cfr. nota 2], I, p. 100, righe 12-
30, p. 101, righe 1-34). Tutti gli elemen-
ti, anche le caldaie e gli sfiatatoi della stu-
fa, vi sono indicati. Tuttavia in quel foglio
del codice Zichy manca il disegno del la-
conico, che invece si aggiunge in L e in T.
In sostanza, nei due codici del primo
Trattato venne illustrata anche la prima
parte del paragrafo martiniano (ibid., p.
99, righe 23-26), tranne lesordio che
dedicato al bagno degli antichi (ibid., p.
99, righe 14-22). Le due terne di disegni
corrispondenti di Zichy e di L sono
simili, ma in L mancano le indicazioni
della caldaia e degli sfiatatoi della stufa. Si
rileva inoltre una svista nel disegno in al-
to a destra di L, dove la stufa definita
frigidario. I disegni di T sono quasi
identici ma meno dettagliati di quelli di
L. Anche le didascalie sono abbreviate ri-
spetto a L, in modo conforme alla note-
vole semplificazione dellannotazione del
laconico, di cui si gi detto (vedi nota
78). Va rilevato infine che lerrata annota-
zione di una stufa come frigidario in L
venne cancellata nel corrispondente dise-
gno di T.
10-11|1998-99 Annali di architettura
Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org
41
83. Il bagno del palazzo Ducale di Urbi-
no, datato al 1477-82, il primo esempio
rimasto di bagno rinascimentale allanti-
ca. Le soluzioni strutturali, limpianto
distributivo e gli stilemi decorativi ne
fanno assegnare la costruzione a France-
sco di Giorgio. Particolarmente signifi-
cativa la corrispondenza tra la chiusura
del paragrafo sui bagni e le stufe del pri-
mo Trattato martiniano (ibid., p. 101, ri-
ghe 31-34) e limpianto distributivo dei
quattro piccoli ambienti del bagno urbi-
nate. Lambiente del grande camino, cor-
rispondente al forno delle caldaie e al
prefurnio dellipocausto vitruviani, re-
trostante i vani accostati della vasca e
della stufa. Dallambiente del camino si
versava lacqua nella vasca e si ponevano
le braci, invece di alimentare il fuoco,
nellipocausto della stufa. La vasca del
bagno di forma quadrilatera e ha un co-
modo accesso a gradini, che servivano
anche da sedili. La stufa era riscaldata so-
lamente dal pavimento, bench in alcune
illustrazioni di stufe del primo Trattato e
del codice Zichy Francesco di Giorgio
disegni anche le intercapedini per la cir-
colazione dellaria calda lungo i muri (ill.
7). Accanto alla stufa ci sono due piccoli
ambienti di servizio sovrapposti e colle-
gati da una doppia rampa. Cfr. Rotondi,
Il Palazzo..., cit. [cfr. nota 45], I, p. 330;
M.L. Polichetti, Nuovi elementi per la sto-
ria del Palazzo: restauri e ricerche, in Poli-
chetti (a cura di), Il Palazzo..., cit. [cfr.
nota 76], pp. 137-79; pp. 159-61; P. Del
Poggetto, Nuova lettura di ambienti fede-
riciani: il bagno cosiddetto della duchessa e
la biblioteca del duca Federico, in Federico...,
Le Arti., cit. [cfr. nota 38], pp. 105-17;
pp. 105-108; F.P. Fiore, Il palazzo Ducale
di Urbino..., in Fiore,Tafuri (a cura di),
Francesco di Giorgio..., cit. [cfr. nota 3],
pp. 164-73; pp. 169-72.
84. La rocca di Ostia, datata al 1483-86,
viene generalmente attribuita a Baccio
Pontelli (cfr. M.G. Aurigemma. La rocca
non un labirinto, in S. Danesi-Squarzina,
G. Borghini, Il Borgo di Ostia da Sisto IV a
Giulio II, Roma 1980, pp. 69-87). Il ba-
gno cupolato e a pianta circolare, e con
la vasca a tre anelli di gradini-sedili. Lim-
pianto per il riscaldamento, ladduzione e
il deflusso dellacqua oggi scomparso.
Ma loriginario ambiente per la produ-
zione dellacqua calda viene tradizional-
mente indicato in un piccolo vano, vicino
la vasca (cfr. Scaglia, Stanze-stufe..., cit.
[cfr. nota 81], pp. 172-73). Anche in que-
sto caso appare evidente laffinit col te-
sto e i disegni del primo Trattato. France-
sco di Giorgio parl di bagni tondi o
quadri con le vasche a gradini (France-
sco di Giorgio Martini, Trattati..., cit.
[cfr. nota 2], I, p. 100) e disegn il laconi-
co, cupolato e a pianta circolare (ill. 7).
85. Il confronto del capitolo di Vitruvio
sugli ambienti termali (Vitruvio, De archi-
tectura, a cura di P. Gros, traduzione e
commento di A. Corso e E. Romano, To-
rino 1997, 2 voll.; I, pp. 580-85, [V, X, 1-
5], e note alle pp. 755-75) col passo mar-
tiniano sui bagni e le stufe (Francesco di
Giorgio, Il Codice..., cit. [cfr. nota 78], I,
pp. 47-48, 113, II, ff. 23r-23v; Francesco
di Giorgio Martini, Trattati..., cit. [cfr.
nota 2], I, pp. 99-101, 261, tav. 42) dimo-
stra che il testo del Trattato venne in buo-
na parte parafrasato da Vitruvio, e sola-
mente intarsiato con le moderne cono-
scenze tecnologiche dellautore. In so-
stanza, Francesco di Giorgio dimostr
anche in questo caso di voler fare del te-
sto vitruviano un uso concreto. Va inoltre
rilevata la piena comprensione raggiunta
dallarchitetto senese del passo di Vitru-
vio. Lunico errore, in quella lettura,
Francesco di Giorgio lo commise proprio
nella ricostruzione del laconico. Vitruvio
identific il laconicum come lambiente
adibito al bagno secco. Egli pensava ad un
laconico con un fuoco posto al centro
della stanza, in unapposita fossa, perch
solo in et postvitruviana si impose anche
per quellambiente termale il riscalda-
mento a ipocausto. Nel laconico era inol-
tre possibile ottenere il bagno a vapore
versando acqua su delle pietre calde, di-
sposte nella fossa centrale. Invece, Fran-
cesco di Giorgio applic al laconico il ri-
scaldamento a ipocausto, che Vitruvio de-
scrisse solamente nel caso del calidarium.
E poich - a proposito del laconico - Vi-
truvio parla di una diffusione a medio
flammae vaporisque vis, larchitetto senese
ipotizz nel centro del pavimento un fo-
ro dal quale entravano nellambiente la-
ria calda e le fiamme propagatesi nellipo-
causto (ill. 7). In questa ricostruzione
Francesco di Giorgio non pot render
conto della vaporisque vis, che era riferita
alluso del laconico come bagno a vapore.
Nei Disegni di monumenti antichi, nel se-
condo Trattato e nel Quaderno di schizzi
archeologici Francesco di Giorgio illustr
alcuni camini antichi, che la critica ritie-
ne ricostruiti da resti di antichi ambienti
termali (Francesco di Giorgio Martini,
Trattati..., cit. [cfr. nota 2], I, tav. 149, II,
pp. 331-33, tav. 188; Burns, I disegni...,
cit. [cfr. nota 3], U 322 Av, pp. 336-37). A
questo proposito, va segnalato che in uno
dei camini antichi del secondo Trattato il
fuoco acceso al centro del pavimento.
Cfr. Francesco di Giorgio Martini, Trat-
tati..., cit. [cfr. nota 2], II, tav. 188.
86. Un grossolano errore di scrittura in
latino nella didascalia apposta alla pian-
ta della basilica di Massenzio nel Quader-
no di schizzi archeologici . Lantico edificio
era allora ritenuto il Templum Pacis ma
nellannotazione martiniana esso divenne
tenpium pacis (cfr. Burns, I disegni..., cit.
[cfr. nota 3], pp. 343-45). La scrittura del
nome venne corretta quasi esattamente
nei Disegni di monumenti antichi. Cfr.
Francesco di Giorgio Martini, Trattati...,
cit. [cfr. nota 2], II, tav. 139.
87. noto che i rapporti numerici mu-
sicali del Medioevo corrispondevano al-
le consonanze dellantica scala musicale
greca. probabile che Francesco di
Giorgio basasse la sua conoscenza dellar-
gomento sul Vitruvio (Vitruvio, De..., cit.
[cfr. nota 85], I, pp. 560-65, [V, IV, 1-9], e
note a pp. 673-86). Nel Medioevo si sol-
lev inoltre il dibattito sul riconoscimen-
to delle terze e delle seste naturali, come
consonanze, e dei relativi rapporti nume-
rici non pitagorici, come musicali.
Considerando anche questi ultimi, nel
nostro progetto Francesco di Giorgio us
in sette casi quattro rapporti musicali
1:1, 4:3, 5:3, 8:5 e in altri dieci casi si av-
vicin a sei rapporti musicali 1:1, 2:1,
3:1, 3:2, 5:4, 9:8 . Tre di questi ultimi ca-
si sono riferiti al giardino dei frati (115:75
piedi, circa 3:2), al monastero (145:115
piedi, circa 5:4) e al giardino del mona-
stero (100:98 piedi, circa 1:1). Il rilevante
uso che Francesco di Giorgio fece di rap-
porti numerici musicali non deriv,
quasi certamente, dalla conoscenza delle
teorie musicali classiche e medievali, ma
dalla consuetudine che egli ebbe di quei
rapporti attraverso la pratica di bottega e
la prassi costruttiva. Essi erano citati nei
trattati dabaco e venivano insegnati nelle
scuole dabaco. Inoltre, Francesco di
Giorgio ritrov ampiamente il loro uso in
Vitruvio. Cfr. Francesco di Giorgio Mar-
tini, Trattati..., cit. [cfr. nota 2], I, pp. 46-
50, 75-79, 82, 86-89.
88. La costruzione del triangolo pitagori-
co riportata nel Vitruvio (Vitruvio,
De..., cit. [cfr. nota 85], II, pp. 1200-03,
[IX, pref., 6-8], e note a pp. 1249-51).
89. La citazione martiniana (Francesco
di Giorgio Martini, Trattati..., cit. [cfr.
nota 2], I, p. 82) tratta dal paragrafo su-
gli atri delle case del Vitruvio (Vitruvio,
De..., cit. [cfr. nota 85], II, pp. 838-39
[VI,III,3] e nota 103 a pp.914-15). La co-
noscenza e luso martiniani del rapporto
1:2 fanno ipotizzare anche la sua cono-
scenza e il suo uso del procedimento ad
quadratum, che dal rapporto 1:2 deriva.
Luso di questo procedimento, nellambi-
to della costruzione, risale al basso Me-
dioevo. Esso documentato, ad esempio,
da alcune postille del magister 2 al ce-
leberrimo Taccuino di Villard de Honne-
court (R. Pernoud [a cura di], Carnet de
Villard de Honnecourt, Paris 1986; trad it.
Villard de Honnecourt. Disegni, Milano
1988, tav. 39 k.o.p, p. 132). Il procedi-
mento fu adottato fino al tardo Gotico
nelle botteghe artistiche e soprattutto dai
maestri costruttori del centro Europa,
per i quali costituiva un segreto del me-
stiere. Lutilizzazione del procedimento
in questo ambito testimoniata in alcuni
manuali di maestri costruttori tedeschi
dei secoli XV e XVI. I pi noti sono
quelli di Roriczer [1486], Schmutter-
mayer [fine secolo XV] e Lechler [1516]
(cfr. P. Frankl, The secret of the medieval
masons, in The Art Bulletin, 27, 1945,
pp.46-60; R. Schelby, The geometrical
knowledge of medieval master masons, in
Speculum, 1972, pp. 395-421. Luso
del procedimento geometrico ad quadra-
tum era in Italia meno generalizzato, ri-
spetto al centro Europa. Nel caso di
Francesco di Giorgio, alcuni studiosi
hanno accennato rapidamente alluso del
rapporto 1:2 e ad una sua possibile evo-
luzione nel procedimento ad quadratum
(cfr. H. Millon, The architectural theory
and practice in Antonio Filaretes Trattato
di architettura, in The Art Bulletin,
XLI, 1959, pp. 89-106; nota 9 a p. 92,
nota 28 a p. 99). Poi Hellmann ha pro-
posto lindividuazione in Francesco di
Giorgio di un ampio uso del procedi-
mento geometrico ad quadratum, che ha
accostato a quello dei contemporanei
maestri costruttori tedeschi (G. Hell-
mann, Proportionsverfahren des Francesco
di Giorgio Martini, in Miscellanea Bi-
bliothecae Hertzianae zu Ehren von Leo
Bruhns, Mnich 1961, pp. 157-66). Li-
potesi di Hellmann ha trovato consensi
(cfr. ad esempio J. Eisler, Remarks on some
aspects of Francesco di Giorgios trattato,
in Acta historiae artium academiae
scientiarum hungaricae, 18, 1972, pp.
193-231; pp. 202, 207 e note 24, 25 e 26
a p. 226), ma anche posizioni contrarie
(cfr. ad esempio L. Lowic, Francesco di
Giorgio on the Design of Churches: the Use
and Significance of Mathematics in the
Trattato, in Architectura, XII, 2,
1982, pp. 151-63; p. 159 e nota 49 a p.
159). Nei Trattati, Francesco di Giorgio
pare avere adottato il procedimento geo-
metrico ad quadratum una sola volta, nel
tracciamento di una trama geometrica
per una pianta di chiesa. Francesco di
Giorgio Martini, Trattati..., cit. [cfr. nota
2], II, p. 402, tav. 235.
90. La Praticha di giometria il nono capi-
tolo del primo Trattato (cfr. G. Arrighi,
Francesco di Giorgio. La praticha di giome-
tria del codice Ashburnham 361 della Biblio-
teca Medicea Laurenziana di Firenze, Fi-
renze 1970; Francesco di Giorgio Marti-
ni, Trattati..., cit. [cfr. nota 2], I, pp. 117-
40, tavv. 50-61). Le pratiche di geometria
del secolo XV erano volgarizzazioni del
testo originario di Leonardo Fibonacci.
Una delle pi importanti rimaste venne
compilata da un misuratore fiorentino
ed conservata in Siena codice L.IV.18
della Biblioteca Comunale . Il confron-
to della Praticha martiniana con una coe-
va fiorentina del 1442 evidenzia le affinit
tra i due testi e lidentica formulazione di
una serie di esercizi di misurazione. Cfr.
Leonardo Fibonacci, La pratica di geome-
tria. Volgarizzata da Cristofano di Gherardo
di Dino cittadino pisano. Dal Codice 2186
della Biblioteca Riccardiana di Firenze, a cu-
ra di G. Arrighi, Pisa 1966.
91. Ad esempio, il sistema proporzionale
elaborato da Leon Battista Alberti nel
progetto ai ff. 56v-57r del codice Ash-
burnham 1828 App. estremamente
complesso. LAlberti lo bas sul lato di
cinque braccia di un vano quadrato, da
cui deriv una serie ad quadratum che
estese ad alcuni vani. A quella egli af-
fianc una seconda serie, costituita di
rapporti di numeri razionali e musicali.
Inoltre egli intrecci le due serie median-
te luso di medi geometrici e aritmetici
(cfr. Burns, A drawing..., cit. [cfr. nota 4];
id., Un disegno..., cit. [cfr. nota 4]). Poich
il disegno albertiano di provenienza ur-
binate, possibile che originariamente
fosse conservato in Urbino e che l lo
avesse potuto consultare Francesco di
Giorgio.
92. Francesco di Giorgio Martini, Tratta-
ti..., cit. [cfr. nota 2], I, p. 239.
93. Vedi note 1 e 50.
94. La presenza di Francesco di Giorgio
sul teatro delle operazioni di guerra do-
cumentata da due lettere di Federico di
Montefeltro alla Signoria di Siena. Le
lettere vennero inviate nel luglio 1478 da
due accampamenti nel Chianti da Ren-
cine il giorno 25 e da Castellina il giorno
28 e vennero affidate a Francesco di
Giorgio vostro citadino e mio architec-
to (cfr. Romagnoli, Biografia..., cit. [cfr.
nota 34], IV, ff. 771-72). Inoltre, Sigi-
smondo Tizio document che il 6 set-
tembre 1478 Francesco di Giorgio parte-
cip allassedio di Brolio, fornendo opere
di artiglieria (cfr. S. Tizio, Historiarum
Senensium ab initio urbis Senorum usque ad
annum MDXXVIII [1506-1528], mss. B
III.5-12 della Biblioteca Comunale di
Siena). Tuttavia, va segnalato che nellas-
sedio condotto da Federico di Montefel-
tro contro Colle Val dElsa, conclusosi
vittoriosamente il 13 novembre 1479, gli
architetti militari del duca di Urbino ven-
nero guidati da Scirro Scirri (cfr. W.
Tommasoli, La vita di Federico da Monte-
10-11|1998-99 Annali di architettura
Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org
42
feltro, 1422/1482, Urbino 1978, p. 306).
95. La collaborazione di Baccio Pontelli
alla fabbrica del monastero di Santa
Chiara in Urbino solleva il controverso
aspetto della sua precedente attivit di ar-
chitetto. Il Vasari attribu al Pontelli nu-
merosi edifici fatti costruire in Roma da
Sisto IV, fin dallinizio del suo pontificato
(1471-84) (cfr. Giorgio Vasari, Le vite de
pi eccellenti pittori scultori ed architettori,
[ed. del 1568], a cura di G. Milanesi, Fi-
renze 1878-85, 9 voll.; II, pp. 652-54; ri-
st. anast., Firenze 1973). La vasta attribu-
zione vasariana venne poi sfrondata, ad
iniziare dal Milanesi (ibid. e pp. 659-64),
ma negli ultimi decenni essa ha trovato
nuove adesioni (cfr. De Fiore, Baccio...,
cit. [cfr. nota 22]), in particolare per la
fabbrica della cappella Sistina (cfr. R. Sal-
vini, The Sistine Chapel. Ideology and archi-
tecture, in Art History, III, 2, 1980, pp.
144-57; id., La Cappella Sistina in Vaticano,
Milano 1965, 2 voll.; I, pp. 15-18). Vedi
anche note 22, 84 e 113.
96. Vedi nota 19.
97. Dopo il 1538, per collocarvi la tom-
ba di Francesco Maria I della Rovere,
che venne disegnata da Girolamo Genga
ed eseguita da Bartolomeo Ammannati
(cfr. Vasari, Le vite..., cit. [cfr. nota 95],
VI, p. 321). Nel 1627-29, quando il duca
Francesco Maria II della Rovere ne fece
trasformare la decorazione per riadattar-
la a mausoleo roveresco (cfr. L. Pungi-
leoni, Elogio storico di Giovanni Santi, Ur-
bino 1822, pp. 102-03; L. Serra, Chiesa di
S. Chiara in Urbino, in O.T. Locchi (a cu-
ra di), La provincia di Pesaro-Urbino, Ro-
ma 1934, p. 385). Nel 1716, quando il
cardinale Annibale Albani fece sistemare
nella cupola dei bozzetti dipinti di Pietro
da Cortona.
98. Dopo la soppressione delle corpora-
zioni religiose del 1861 lex monastero
venne ceduto il 19 settembre 1864 al Co-
mune di Urbino, che lo adib a sede di un
istituto di educazione femminile retto
dalle clarisse. Nel 1904 il Comune di Ur-
bino adib ledificio a sede dellOspedale
Civile e lo cedette alla Congregazione di
Carit di Urbino (cfr. Archivio Comuna-
le di Urbino, Cartella Nuovo Ospedale Ci-
vile, busta n.15, fasc.1, archiviazione
1903-14; cit. in Rotondi, Contributi..., cit.
[cfr. nota 11], nota 47 a pp. 127-28). La
pesante ristrutturazione delledificio ini-
zi nel 1907. Circa 25 anni fa lOspedale
Civile di Urbino venne trasferito in un
nuovo edificio, e lex monastero di Santa
Chiara divenne la sede dellI.S.I.A. di Ur-
bino. Da allora iniziata una lenta opera
di manutenzione delledificio.
99. Vedi nota 57.
100. Cfr. L. Fraternale, Il monastero di
Santa Chiara a Urbino, in Larchitettura,
cronache e storia, X, 1964, pp. 268-75.
La ricostruzione di Fraternale altamen-
te attendibile, perch venne basata sulle
testimonianze di alcune clarisse urbinati,
che avevano abitato nellex monastero di
Santa Chiara fino al 1907 e solo allora si
erano trasferite nel loro nuovo monaste-
ro urbinate, costruito appena fuori le mu-
ra urbiche, a sud.
101. Ci avvenne prima del 1810, perch
nella planimetria catastale di Urbino di
quellanno il terreno, gi appartenuto al-
la fraternita di SantAntonio, accorpato
al monastero di Santa Chiara e loratorio
di SantAntonio, che insisteva su quel ter-
reno, risulta abbattuto. Vedi nota 57.
102. Vedi note 17, 19, 20 e 21.
103. La costruzione del palazzo Ducale di
Gubbio viene datata fra la met degli an-
ni settanta e i primi anni ottanta del sec.
XV. Nel primo piano, due corpi di fab-
brica sono disposti ad angolo retto e sono
incernierati nella rampa elicoidale. Cfr.
F.P. Fiore, Il palazzo Ducale di Gubbio..., in
Fiore, Tafuri (a cura di), Francesco di Gior-
gio..., cit. [cfr. nota 3], pp. 180-85.
104. Francesco di Giorgio Martini, Trat-
tati..., cit. [cfr. nota 2], I, p. 237.
105. Vedi nota 68. Secondo le testimo-
nianze rese dalle clarisse a Fraternale, le
cappelle erano del tipo a tomba e recava-
no incisi i misteri del rosario, che veni-
vano l recitati (ill. 9).
106. Vedi nota 57.
107. La Soprintendenza per i Beni Am-
bientali e Architettonici delle Marche ha
di recente fatto redigere il rilievo metri-
co delledificio. Ringrazio il soprinten-
dente dottor architetto Renzo Mancini
per avermi permesso di consultare il ma-
teriale grafico del rilievo, che conserva-
to in Ancona presso lArchivio della So-
printendenza.
108. Larea del monastero era di forma
irregolare. La sua lunghezza massima
lungo la via del cortile era di 222 piedi
e la sua larghezza dal bordo di quella via
fino al lato orientale del giardino in
media di 215 piedi. Ledificio, dalla ram-
pa al fronte sud, lungo 179 piedi ed
largo in media 123 piedi. Il giardino
lungo 140 piedi e largo 90. I rapporti nu-
merici tra i lati dei rispettivi rettangoli si
avvicinano a: 1:1, 3:2 e 3:2.
109. Il rilievo metrico delledificio con-
ferma che la pianta ai ff. 66v-67r (ill. 1)
un elaborato iniziale della fase proget-
tuale finale del monastero. In questo
progetto la lunghezza di 220 piedi della-
rea e la larghezza di 126 piedi delledifi-
cio, fino alla loggia compresa, sono pros-
sime alle corrispondenti misure, di 222 e
123 piedi, delledificio costruito (ill. 2,
9). Anche le larghezze dei vani nel corpo
di fabbrica est delledificio corrispondo-
no alle larghezze dei corrispondenti vani
del progetto. Nelledificio, la profondit
della loggia e la larghezza del refettorio
sono di 10,5 e 23,7 piedi, misure quasi
pari alle larghezze di 11 e 25 piedi dei
corrispondenti ambienti del progetto.
Invece, nel corpo di fabbrica nord le mi-
sure a filo di ferro del progetto venne-
ro tradotte in misure comprendenti an-
che lo spessore di uno o di entrambi i
muri. Ad esempio, il coro e la sottostan-
te legnaia delledificio misurano 24,7
piedi di larghezza, per i 30 piedi di lar-
ghezza del coro nel progetto. Analoga-
mente, la chiesa misura 30,8 piedi al filo
esterno dei muri, per i 30 piedi di lar-
ghezza della chiesa nei tre diversi proget-
ti. Nei corpi di fabbrica sud e ovest, che
vennero costruiti durante la terza campa-
gna di lavori, non si verificano delle affi-
nit col progetto. Va infine segnalato che
le celle del monastero (ill. 9) avevano le
stesse dimensioni 85 piedi di quelle
disegnate nella pianta ai ff. 63v-64r.
110. Anche nelledificio Francesco di
Giorgio ricerc un ampio uso di rappor-
ti stabiliti tra i primi cinque numeri inte-
ri (ill. 9). Si rilevano le seguenti misure in
piedi: 32,324,5 (4:3) per la legnaia;
24,4 16,1 (5:3) per la cantina; 34,913,8
(5:2) per il noviziato; 121,524,3 (5:1)
per il dormitorio; 4124.6 (5:3) per il co-
ro, questultimo misurato secondo la ri-
costruzione di Fraternale (ill. 9). Inoltre,
la larghezza e le lunghezze parziale e to-
tale delle due testate della loggia di 11,
22 e 33 piedi rispettivamente formano
una progressione aritmetica. Analoghi
rapporti si verificano anche tra le lar-
ghezze e le altezze massime di alcuni am-
bienti. Ad esempio, si rilevano le seguen-
ti misure in piedi: 23,3517,5 (4:3) per lo
stenditoio; 23,616,2 (3:2) per il refetto-
rio; 24,7418,2 (4:3) per il dormitorio.
Ulteriori elementi e indicazioni potran-
no venire da uno studio approfondito del
rilievo, che non rientrava nelle finalit di
questo studio.
111. Nel primo piano delledificio (ill. 9)
la larghezza dellinfermeria di circa die-
ci piedi. La successiva lunghezza dei due
corridoi laterali allo spulciatoio, che sono
vicini allinfermeria, di 20 piedi.
112. Nel primo Trattato Francesco di
Giorgio dedic un brevissimo passo ai
teatri con alcuni disegni di scarso inte-
resse (Francesco di Giorgio Martini,
Trattati..., cit. [cfr. nota 2], I, pp. 54-55,
tavv. 23, 37). Pi interessanti sono i dise-
gni di circhi, anfiteatri e teatri, che sono
inseriti nei Disegni di monumenti antichi
(op.cit., I, tavv. 129-31). Tra essi assume
un particolare valore il disegno del teatro
di Gubbio, perch Francesco di Giorgio
certamente vide quel monumento nel
1477. Ci d certezza che egli conosces-
se almeno un modello per il fronte
orientale del monastero di Santa Chiara
in Urbino. inoltre significativo che
quel disegno presenti la tipica rielabora-
zione martiniana dellordine, che venne
adottata anche nel fronte orientale del
monastero di Santa Chiara in Urbino.
Essa esemplificata due volte nel Qua-
derno di schizzi archeologici, U 327 Ar, U
337 Ar. Cfr. Burns., I disegni..., cit. [cfr.
nota 3], pp. 340-41, 354-55.
113. Non esistono documenti per lattri-
buzione del palazzo del Belvedere di In-
nocenzo VIII (1485-90 circa). Il Vasari
scrisse che ai suoi tempi il disegno delle-
dificio veniva attribuito ad Antonio del
Pollaiolo (cfr. Vasari, Le vite..., cit. [cfr.
nota 95], III, p. 296). Loriginario assetto
formale delledificio raffigurato in una
serie di disegni e di dipinti dei secoli XVI
e XVII. Verso nord, ledificio era costi-
tuito da un loggiato a nove campate in-
nalzato su sostruzioni a scarpa e ad archi
chiuso da due logge di testata protese
verso il paesaggio. Probabilmente il pia-
no superiore era anchesso ad archi e ter-
minava con una fila di beccatelli e di
merli. Il prospetto era ritmato da paraste
continue, che erano interrotte da una
trabeazione. Nelle intersezioni fra la tra-
beazione e le paraste si disegnavano dei
capitelli a forma di trabeazione, analoghi
a quelli martiniani. Il dispositivo formale
di questo prospetto puntualmente affi-
ne a quello del prospetto orientale del
monastero di Santa Chiara in Urbino, e
la marcata affinit costituisce un indizio
per lattribuzione delledificio vaticano a
Baccio Pontelli (cfr. M.Tafuri, Veduta del
Belvedere di Innocenzo VIII..., in Fiore,Ta-
furi (a cura di), Francesco di Giorgio..., cit.
[cfr. nota 3], p. 272). Larchitetto fioren-
tino si trasfer a Roma dopo la morte di
Federico di Montefeltro, forse gi alla fi-
ne del 1482. A Roma e nel Lazio egli la-
vor inizialmente per Sisto IV e per Giu-
liano della Rovere, ma il Pontelli si mos-
se nellambito della curia pontificia an-
che durante il pontificato di Innocenzo
VIII (1484-92). Lattribuzione del Belve-
dere innocenziano a Baccio Pontelli ac-
quista ora maggiore forza, con la docu-
mentata precedenza della fabbrica del
monastero urbinate di Santa Chiara ri-
spetto alla fabbrica vaticana del Belvede-
re innocenziano.
114. Lelevatore dacqua a vite compare
pi volte tra i disegni di Francesco di
Giorgio. Nel Codicetto f. 146r, in L f. 42r
e in T f. 47r (cfr. Francesco di Giorgio
Martini, Trattati..., cit. [cfr. nota 2], I, tav.
85). La coclea inoltre raffigurata in una
formella del fregio dellarte della guer-
ra del palazzo Ducale di Urbino, che
viene classificata nel gruppo di sicura
ispirazione martiniana (cfr. G. Bernini-
Pezzini, Il fregio dellarte della guerra del
Palazzo Ducale di Urbino, Roma 1985, pp.
53-55).
115. Alcune invenzioni figurative nella
Incoronazione della Vergine di Monteolive-
to Maggiore (1472-74) esemplificano la
predilezione figurativa martiniana per le
forme circolari e rotanti (cfr. A. De Mar-
chi, Scheda n. 56..., in Bellosi (a cura di),
Francesco..., cit. [cfr. nota 23], pp. 300-05).
Altrettanto significativa, a questo propo-
sito, lidea figurativa della vorticosa tor-
sione dei corpi, che appare ripetutamente
nellopera artistica martiniana.
116. Il lungo muro che dallo spigolo
nord-est del giardino pensile raggiunge
la rampa elicoidale (ill. 9) leggermente
deviato rispetto ai muri ortogonali del-
ledificio. Questa deviazione venne de-
terminata dallinnalzamento della rampa
elicoidale sul torrione semicircolare, che
era situato allincrocio tra le vecchie mu-
ra urbiche medievali e il nuovo tratto
delle mura urbiche rinascimentali (ill. 2).
Ci si evidenzia dal confronto tra lo
schematico rilievo martiniano delle mura
urbiche, che precedente la costruzione
del monastero, e il rilievo leonardesco di
quel tratto di mura, che successivo alla
costruzione delledificio (cfr. De Toni, I
rilievi..., cit. [cfr. nota 8], ill. 33). France-
sco di Giorgio registr fra il torrione se-
micircolare e il bastione quadrato due
deviazioni murarie. Nel rilievo leonarde-
sco non appaiono pi n il torrione se-
micircolare n la prima deviazione mura-
ria, perch il muro nord del monastero
era gi stato innalzato lungo la tangente,
alla rampa elicoidale costruita sul torrio-
ne, che si allineava al tratto di muro
compreso tra le due deviazioni murarie
registrate da Francesco di Giorgio.
10-11|1998-99 Annali di architettura
Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di Vicenza www.cisapalladio.org
Potrebbero piacerti anche
- Il Complesso Di San Salvatore In Ognissanti A FirenzeDa EverandIl Complesso Di San Salvatore In Ognissanti A FirenzeNessuna valutazione finora
- Il santuario dei Re Italici: San Michele Maggiore di PaviaDa EverandIl santuario dei Re Italici: San Michele Maggiore di PaviaNessuna valutazione finora
- Scheda AnconaDocumento6 pagineScheda AnconaFrancesco ChiacchieraNessuna valutazione finora
- La Storia Della Costruzione Del Convento e Della Chiesa Di Santa Maria Delle Grazie A Senigallia, Da Baccio Pontelli A Gerolamo GengaDocumento16 pagineLa Storia Della Costruzione Del Convento e Della Chiesa Di Santa Maria Delle Grazie A Senigallia, Da Baccio Pontelli A Gerolamo GengademerosNessuna valutazione finora
- Tesei - Le Basiliche MaggioriDocumento27 pagineTesei - Le Basiliche MaggioriRoncaglia Fabio100% (1)
- Restauro 3Documento25 pagineRestauro 3haring84Nessuna valutazione finora
- El Monte Santo Spirito, 2Documento22 pagineEl Monte Santo Spirito, 2Wenceslao Soto ArtuñedoNessuna valutazione finora
- Pietre Che ParlanoDocumento31 paginePietre Che Parlanostopconsumo_argentaNessuna valutazione finora
- Bsilica Di San Freancesco D AssisiDocumento19 pagineBsilica Di San Freancesco D AssisiPietro BattagliaNessuna valutazione finora
- Pietre Che ParlanoDocumento27 paginePietre Che Parlanostopconsumo_argentaNessuna valutazione finora
- Il Portale Della Cattedrale Di AltamuraDocumento21 pagineIl Portale Della Cattedrale Di AltamuraLeonardo RennaNessuna valutazione finora
- Jacopo Torni Detto L'indaco (1476-1526) e La Cappella Funebre A La Antigua Di Don Gil Rodríguez de Junterón Nella Cattedrale Di MurciaDocumento0 pagineJacopo Torni Detto L'indaco (1476-1526) e La Cappella Funebre A La Antigua Di Don Gil Rodríguez de Junterón Nella Cattedrale Di MurciademerosNessuna valutazione finora
- Gian Lorenzo BerniniDocumento22 pagineGian Lorenzo BerninipsilveNessuna valutazione finora
- Francesco Del BorgoDocumento5 pagineFrancesco Del BorgoElisNessuna valutazione finora
- Basilica Di San Pietro in Vaticano - Storia, Descrizione Ed Informazioni PDFDocumento14 pagineBasilica Di San Pietro in Vaticano - Storia, Descrizione Ed Informazioni PDFDongWha ∞ SeoNessuna valutazione finora
- Sotto Il Tiburio. Ricerche Sulle Origini Della Tribuna Di Santa Maria Della Passione A MilanoDocumento28 pagineSotto Il Tiburio. Ricerche Sulle Origini Della Tribuna Di Santa Maria Della Passione A MilanodemerosNessuna valutazione finora
- Identificazione Dei Resti Del Monastero Di Paolino Di NolaDocumento33 pagineIdentificazione Dei Resti Del Monastero Di Paolino Di NolaSabato ScalaNessuna valutazione finora
- Storia ArteDocumento4 pagineStoria ArtemiriNessuna valutazione finora
- Arte BrunelleschiDocumento11 pagineArte BrunelleschiAmuchinaNessuna valutazione finora
- Chiamare Le Chiese ... 3Documento25 pagineChiamare Le Chiese ... 3stopconsumo_argentaNessuna valutazione finora
- Chiesa Dell'Incoronata (Napoli)Documento194 pagineChiesa Dell'Incoronata (Napoli)mariascheNessuna valutazione finora
- Architettura Urbino TesiDocumento64 pagineArchitettura Urbino TesiMario FundaroNessuna valutazione finora
- Via Toledo, I Quartieri Spagnoli e Piazza DanteDocumento39 pagineVia Toledo, I Quartieri Spagnoli e Piazza DanteLuca BalestrinoNessuna valutazione finora
- Trionfo Della Divina ProvvidenzaDocumento15 pagineTrionfo Della Divina ProvvidenzaCatalina RosaceNessuna valutazione finora
- Chiesa Di Santa Maria Presso San SatiroDocumento10 pagineChiesa Di Santa Maria Presso San SatiroFrancesco TarantinoNessuna valutazione finora
- Abbazia Montescaglioso PDFDocumento27 pagineAbbazia Montescaglioso PDFMarco PignataNessuna valutazione finora
- I Templari e Gli Altri Ordini Militari e PDFDocumento20 pagineI Templari e Gli Altri Ordini Militari e PDFRichardo BaciuNessuna valutazione finora
- ChiaravalleDocumento3 pagineChiaravalleRiccardo TrabattoniNessuna valutazione finora
- Architettura Resiliente. Palazzo Medici Clarelli PDFDocumento9 pagineArchitettura Resiliente. Palazzo Medici Clarelli PDFGianluca VecchioNessuna valutazione finora
- La Residenza Milanese Di Pio IV - Il Palazzo Medici in Via BreraDocumento0 pagineLa Residenza Milanese Di Pio IV - Il Palazzo Medici in Via BrerademerosNessuna valutazione finora
- Leon Battista AlbertiDocumento4 pagineLeon Battista Albertif9fbv59n67Nessuna valutazione finora
- Giovan Battista Bertani. L'Inventario Dei Beni Di Un Architetto e Imprenditore MantovanoDocumento6 pagineGiovan Battista Bertani. L'Inventario Dei Beni Di Un Architetto e Imprenditore MantovanodemerosNessuna valutazione finora
- Presenze Francescane e Statuaria Sacra Nella Chiesa Della SS. Annunziata Di OstuniDocumento9 paginePresenze Francescane e Statuaria Sacra Nella Chiesa Della SS. Annunziata Di OstuniSalvatore Polito100% (1)
- Schede BibliograficheDocumento160 pagineSchede BibliograficheCosetta BaroniNessuna valutazione finora
- Mausoleo Di Elena e La Basilica S Marcellino e Pietro Di Gabriella Cetorelli SchivoDocumento15 pagineMausoleo Di Elena e La Basilica S Marcellino e Pietro Di Gabriella Cetorelli SchivoStefano FedeleNessuna valutazione finora
- La Cupola Del BrunelleschiDocumento7 pagineLa Cupola Del BrunelleschiVarapodio Archilovers ArtNessuna valutazione finora
- La Crociera e La Facciata Di Santa Maria Di Loreto, Problemi Di RidefinizioneDocumento0 pagineLa Crociera e La Facciata Di Santa Maria Di Loreto, Problemi Di RidefinizionedemerosNessuna valutazione finora
- Arcana UrbisDocumento5 pagineArcana UrbisjoxtaleNessuna valutazione finora
- Il duca e la città. Appunti dal II convegno internazionale di studi su Vespasiano GonzagaDa EverandIl duca e la città. Appunti dal II convegno internazionale di studi su Vespasiano GonzagaNessuna valutazione finora
- Sant'AndreaDocumento5 pagineSant'AndreaCLIZIA CAROLINessuna valutazione finora
- Federico Zuccari e La Sua Scuola in UmbrDocumento33 pagineFederico Zuccari e La Sua Scuola in UmbrPedro AlvezNessuna valutazione finora
- Mini Storia PDFDocumento16 pagineMini Storia PDFSergio NovelliNessuna valutazione finora
- La Biblioteca Vaticana Nelle Sue Architetture Un Disegno StoricoDocumento54 pagineLa Biblioteca Vaticana Nelle Sue Architetture Un Disegno StoricoAna Paula GurgelNessuna valutazione finora
- Leon Battista Alberti A Mantova Proposte PDFDocumento30 pagineLeon Battista Alberti A Mantova Proposte PDFPaolo BianchiNessuna valutazione finora
- Presentazione Chiesa Del Gesu RomaDocumento19 paginePresentazione Chiesa Del Gesu RomaFrancesco TarrarrallaNessuna valutazione finora
- Annuario Della Accademia Nazionale Di San LucaDocumento194 pagineAnnuario Della Accademia Nazionale Di San Lucagianpics100% (1)
- 35 Pievi Diocesi LuniDocumento6 pagine35 Pievi Diocesi LunimbNessuna valutazione finora
- Cap15 Urbanistica Architettura 1Documento13 pagineCap15 Urbanistica Architettura 1Luana CelettaNessuna valutazione finora
- Cardinali Vescovi e Governatori Di Ostia e VelletriDocumento97 pagineCardinali Vescovi e Governatori Di Ostia e Velletripedroguterrez0% (1)
- Brescia Malatestiana, approfondimentiDa EverandBrescia Malatestiana, approfondimentiValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- La Storia Della Costruzione Del Duomo Di FirenzeDocumento13 pagineLa Storia Della Costruzione Del Duomo Di FirenzeSilvia CardiaNessuna valutazione finora
- BRAMANTEDocumento2 pagineBRAMANTERex TrattorinoNessuna valutazione finora
- BrunelleschiDocumento12 pagineBrunelleschiGiulia CappelliniNessuna valutazione finora
- Storia Dell'Arte-pala MontefeltroDocumento3 pagineStoria Dell'Arte-pala Montefeltrobarcato18Nessuna valutazione finora
- Dizionario Di Scultura ContemporaneaDocumento92 pagineDizionario Di Scultura Contemporanea_fiacoNessuna valutazione finora
- Palazzo BarbieriniDocumento21 paginePalazzo Barbieriniludovico cassinaNessuna valutazione finora
- Chiesa Di Saint-SulpiceDocumento36 pagineChiesa Di Saint-SulpiceMauro LondrilloNessuna valutazione finora
- ArticoloDocumento5 pagineArticoloLalla LalliNessuna valutazione finora
- Notizie Storiche Parrocchia Matrice CasaranoDocumento3 pagineNotizie Storiche Parrocchia Matrice CasaranoFabio CavalloNessuna valutazione finora
- Ca' Loredan-Vendramin-Calergi A Venezia - Mauro Codussi e Il Palazzo Di Andrea Loredan PDFDocumento19 pagineCa' Loredan-Vendramin-Calergi A Venezia - Mauro Codussi e Il Palazzo Di Andrea Loredan PDFdemerosNessuna valutazione finora
- San Sebastiano - Un'Architettura Di Pellegrino Tibaldi Nella Milano BorromaicaDocumento17 pagineSan Sebastiano - Un'Architettura Di Pellegrino Tibaldi Nella Milano BorromaicademerosNessuna valutazione finora
- Verso Brunelleschi o Della "Scomparsa" Dei Maestri. Progetti Per La Facciata Di San Lorenzo A Firenze (1900-1905)Documento8 pagineVerso Brunelleschi o Della "Scomparsa" Dei Maestri. Progetti Per La Facciata Di San Lorenzo A Firenze (1900-1905)demerosNessuna valutazione finora
- La Residenza Milanese Di Pio IV - Il Palazzo Medici in Via Brera PDFDocumento16 pagineLa Residenza Milanese Di Pio IV - Il Palazzo Medici in Via Brera PDFdemerosNessuna valutazione finora
- Foligno, Chiesa Di Fuksas Al Gelo, Messa SpostataDocumento2 pagineFoligno, Chiesa Di Fuksas Al Gelo, Messa SpostatademerosNessuna valutazione finora
- Francesco Algarotti, Andrea Palladio e Un Frammento Di Marmo Di PolaDocumento8 pagineFrancesco Algarotti, Andrea Palladio e Un Frammento Di Marmo Di PolademerosNessuna valutazione finora
- Su Alcuni Esempi Di Scultura e Architettura Antiche Nel Parallèle (1650) Di Roland Fréart de Chambray e Charles ErrardDocumento10 pagineSu Alcuni Esempi Di Scultura e Architettura Antiche Nel Parallèle (1650) Di Roland Fréart de Chambray e Charles ErrarddemerosNessuna valutazione finora
- La Crociera e La Facciata Di Santa Maria Di Loreto, Problemi Di Ridefinizione PDFDocumento18 pagineLa Crociera e La Facciata Di Santa Maria Di Loreto, Problemi Di Ridefinizione PDFdemerosNessuna valutazione finora
- La Porta e L'arco Di Castelnuovo A Napoli.Documento15 pagineLa Porta e L'arco Di Castelnuovo A Napoli.demerosNessuna valutazione finora
- La Porta e L'arco Di Castelnuovo A Napoli.Documento15 pagineLa Porta e L'arco Di Castelnuovo A Napoli.demerosNessuna valutazione finora
- Tutte Le Barriere Alla Risalita Dell'umidità.Documento5 pagineTutte Le Barriere Alla Risalita Dell'umidità.demerosNessuna valutazione finora
- Progetti Di Francesco Di Giorgio Per Il Monastero Di Santa Chiara in UrbinoDocumento21 pagineProgetti Di Francesco Di Giorgio Per Il Monastero Di Santa Chiara in UrbinodemerosNessuna valutazione finora
- La Tomba Di Lavinia Thiene - Un'opera Mantovana A Vicenza PDFDocumento5 pagineLa Tomba Di Lavinia Thiene - Un'opera Mantovana A Vicenza PDFdemerosNessuna valutazione finora
- Vitruvio, Piero Della Francesca, Raffaello, Note Sulla Teoria Del Disegno Di Architettura Nel RinascimentoDocumento20 pagineVitruvio, Piero Della Francesca, Raffaello, Note Sulla Teoria Del Disegno Di Architettura Nel Rinascimentodemeros100% (1)
- Gli Envois de Rome Di Eugène Beaudouin - Lo Studio Dell'Antichità Come Lettura Della Composizione UrbanaDocumento12 pagineGli Envois de Rome Di Eugène Beaudouin - Lo Studio Dell'Antichità Come Lettura Della Composizione UrbanademerosNessuna valutazione finora
- Sebastiano Serlio e Il Palazzo Zen A VeneziaDocumento18 pagineSebastiano Serlio e Il Palazzo Zen A VeneziademerosNessuna valutazione finora
- Sotto Il Tiburio. Ricerche Sulle Origini Della Tribuna Di Santa Maria Della Passione A MilanoDocumento28 pagineSotto Il Tiburio. Ricerche Sulle Origini Della Tribuna Di Santa Maria Della Passione A MilanodemerosNessuna valutazione finora
- Francesco Algarotti, Andrea Palladio e Un Frammento Di Marmo Di PolaDocumento8 pagineFrancesco Algarotti, Andrea Palladio e Un Frammento Di Marmo Di PolademerosNessuna valutazione finora
- Porta San Martino A Legnago e Porta Nuova A Verona. Nuovi Documenti Sul Sanmicheli Architecto Nella Fabbrica MilitareDocumento10 paginePorta San Martino A Legnago e Porta Nuova A Verona. Nuovi Documenti Sul Sanmicheli Architecto Nella Fabbrica MilitaredemerosNessuna valutazione finora
- La Tomba Di Lavinia Thiene - Un'Opera Mantovana A VicenzaDocumento5 pagineLa Tomba Di Lavinia Thiene - Un'Opera Mantovana A VicenzademerosNessuna valutazione finora
- Palladio Costruttore 7 Il Convento Della Carità - Materiali, Tecniche, StruttureDocumento12 paginePalladio Costruttore 7 Il Convento Della Carità - Materiali, Tecniche, StrutturedemerosNessuna valutazione finora
- La Fabbrica Di Santa Maria Dell'Anima e La Sua FacciataDocumento20 pagineLa Fabbrica Di Santa Maria Dell'Anima e La Sua FacciatademerosNessuna valutazione finora
- Giovan Battista Bertani. L'Inventario Dei Beni Di Un Architetto e Imprenditore MantovanoDocumento6 pagineGiovan Battista Bertani. L'Inventario Dei Beni Di Un Architetto e Imprenditore MantovanodemerosNessuna valutazione finora
- Porta San Martino A Legnago e Porta Nuova A Verona. Nuovi Documenti Sul Sanmicheli Architecto Nella Fabbrica MilitareDocumento10 paginePorta San Martino A Legnago e Porta Nuova A Verona. Nuovi Documenti Sul Sanmicheli Architecto Nella Fabbrica MilitaredemerosNessuna valutazione finora
- Palladio Costruttore 4 All'Ombra Della Cupola - Tradizione e Innovazione Nei Cantieri Fiorentini Quattro e CinquecenteschiDocumento12 paginePalladio Costruttore 4 All'Ombra Della Cupola - Tradizione e Innovazione Nei Cantieri Fiorentini Quattro e CinquecenteschidemerosNessuna valutazione finora
- Palladio Costruttore 5 Architetture Del Cinquecento A Roma. Una Lettura Dei Rivestimenti OriginariDocumento11 paginePalladio Costruttore 5 Architetture Del Cinquecento A Roma. Una Lettura Dei Rivestimenti OriginaridemerosNessuna valutazione finora
- Palladio Costruttore 8 Eredità Cinquecentesca e Apertura Al Nuovo Nella Costruzione Di Palazzo Mattei Di Giove A RomaDocumento13 paginePalladio Costruttore 8 Eredità Cinquecentesca e Apertura Al Nuovo Nella Costruzione Di Palazzo Mattei Di Giove A RomademerosNessuna valutazione finora
- Palladio Costruttore 6 Tecnologia Edilizia e Organizzazione Del Cantiere Nella Milano Del Secondo CinquecentoDocumento11 paginePalladio Costruttore 6 Tecnologia Edilizia e Organizzazione Del Cantiere Nella Milano Del Secondo CinquecentodemerosNessuna valutazione finora
- Il Popolo Del Segreto - Ernest ScottDocumento145 pagineIl Popolo Del Segreto - Ernest Scottalexgeppo100% (5)
- Aelredo Di RievaulxDocumento6 pagineAelredo Di RievaulxEsonet.orgNessuna valutazione finora
- Luang Por Sumedho, Il Mio Maestro-Ajahn SucittoDocumento25 pagineLuang Por Sumedho, Il Mio Maestro-Ajahn SucittonicheloroNessuna valutazione finora
- Riassunto Archeologia MedievaleDocumento32 pagineRiassunto Archeologia MedievaleJoia_88100% (1)
- Archivio 88Documento155 pagineArchivio 88Gaetano RussoNessuna valutazione finora
- López-Tello 2014 - 1Documento9 pagineLópez-Tello 2014 - 1Fray JuanNessuna valutazione finora
- Novena A SConoDocumento3 pagineNovena A SConoLuis GarciaNessuna valutazione finora
- Nicola Severino - Gli Orologi Inediti Di Montecassino e SubiacoDocumento13 pagineNicola Severino - Gli Orologi Inediti Di Montecassino e SubiacoNicola SeverinoNessuna valutazione finora
- 19 Boccaccio EroticoDocumento10 pagine19 Boccaccio EroticoVirginia S.Nessuna valutazione finora
- Sobre A Regra de São Basílio PDFDocumento171 pagineSobre A Regra de São Basílio PDFrenan larentiNessuna valutazione finora
- San Carlo e I BarnabitiDocumento88 pagineSan Carlo e I BarnabitiBarnabite PublicationsNessuna valutazione finora
- FollieriE. ISantiDell'ItaliaGrecaDocumento32 pagineFollieriE. ISantiDell'ItaliaGrecaAN100% (1)
- La Storia Della Spiritualità FrancescanaDocumento8 pagineLa Storia Della Spiritualità Francescanagel anNessuna valutazione finora
- Documento Da Parte Di Alexsandro ITALIADocumento158 pagineDocumento Da Parte Di Alexsandro ITALIAAlexsandroNessuna valutazione finora
- Settimo Tema. I RitualiDocumento22 pagineSettimo Tema. I RitualiPablo RizoNessuna valutazione finora
- 03-La Regola Di San Benedetto e Le Regole Dei Padri PDFDocumento6 pagine03-La Regola Di San Benedetto e Le Regole Dei Padri PDFRodica GheorghiuNessuna valutazione finora
- Alcuni Aneddoti Zen...Documento22 pagineAlcuni Aneddoti Zen...gionnigioNessuna valutazione finora
- Verifica MonachesimoDocumento3 pagineVerifica MonachesimoLiliana Dominici100% (2)
- Atlante CamaldoleseDocumento354 pagineAtlante CamaldoleseFrancesco Spallino100% (3)
- Breve Storia BenedettinaDocumento26 pagineBreve Storia BenedettinaGiacomo CantiNessuna valutazione finora
- Rogo Al Monastero Di S.Giovanni Bigorski in Macedonia.Documento2 pagineRogo Al Monastero Di S.Giovanni Bigorski in Macedonia.BrunildaTernovaNessuna valutazione finora
- Immagini Di Chiara in Santa Chiara Da Mo PDFDocumento29 pagineImmagini Di Chiara in Santa Chiara Da Mo PDFGabrielNessuna valutazione finora
- Il Diario Di Sigerico e La Via Dei Sasso PDFDocumento5 pagineIl Diario Di Sigerico e La Via Dei Sasso PDFEP Profilo PrivatoNessuna valutazione finora
- Libro MestieriDocumento76 pagineLibro MestieriLuoana EremiaNessuna valutazione finora
- Giovanni Lorenzoni Venezia Medievale Tra Oriente e OccidenteDocumento88 pagineGiovanni Lorenzoni Venezia Medievale Tra Oriente e OccidenteΞενώνας ΝάματαNessuna valutazione finora
- Riassunto Le Goff MedievaleDocumento17 pagineRiassunto Le Goff Medievaleginocervi50% (2)
- Tesi Magistrale Definitiva PDFDocumento295 pagineTesi Magistrale Definitiva PDFsimone vettoneNessuna valutazione finora
- Fra Mauros World Map PDFDocumento256 pagineFra Mauros World Map PDFbookfreakNessuna valutazione finora
- Colpo D'occhio Su Le Condizioni Del Reame Dalle Due Sicilie Nel Corso Dell'anno 1862Documento270 pagineColpo D'occhio Su Le Condizioni Del Reame Dalle Due Sicilie Nel Corso Dell'anno 1862Vincenzo RussoNessuna valutazione finora
- 95 VTDocumento33 pagine95 VTMarco BattagliaNessuna valutazione finora