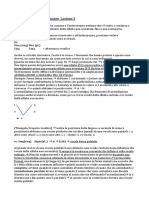Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
163 visualizzazioni54 pagineFonologia Germanica
Il documento tratta di alcuni fenomeni fonetici intervenuti nel passaggio dal protogermanico alle lingue germaniche come l'innalzamento vocalico, l'abbassamento vocalico e l'allungamento vocalico. Vengono forniti esempi per illustrare questi mutamenti con le corrispondenze nelle lingue germaniche antiche.
Caricato da
Hannah Laxis-TamCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
163 visualizzazioni54 pagineFonologia Germanica
Il documento tratta di alcuni fenomeni fonetici intervenuti nel passaggio dal protogermanico alle lingue germaniche come l'innalzamento vocalico, l'abbassamento vocalico e l'allungamento vocalico. Vengono forniti esempi per illustrare questi mutamenti con le corrispondenze nelle lingue germaniche antiche.
Caricato da
Hannah Laxis-TamCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd