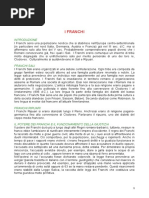Filologia Germanica II
Caricato da
Hannah Laxis-TamFilologia Germanica II
Caricato da
Hannah Laxis-TamlOMoARcPSD|9956491
Filologia II parte - Fondamenti teorici e strumenti operativi utili
a comprendere la cultura germanica
antica
Filologia germanica (Università degli Studi di Napoli L'Orientale)
StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
IL GOTICO
I GOTI E WULFILA
Nel gruppo cosiddetto germanico orientale l'unica popolazione di cui ci è documentata la lingua è quella dei Goti.
Di tale lingua abbiamo tuttavia una conoscenza molto limitata, poiché sono giunti a noi solo alcuni frammenti della traduzione
della Bibbia effettuata nel IV sec. dal vescovo visigoto Wulfila.
Il gotico è la lingua dei Visigoti e degli Ostrogoti. Il gotico è una lingua morta e nessuna lingua gm moderna discende dal
ramo orientale delle lingue gm antiche.
Da Procopio (VI secolo): Vandali e Burgundi parlavano sostanzialmente la stessa lingua dei Goti.
LA STORIA DEI GOTI
I Goti cominciarono ad entrare in contatto con l'Impero romano agli inizi del III sec d.C. in seguito al loro stanziamento sul mar
Nero, dopo che ebbero lasciato, per una lunga migrazione verso su, le antiche sedi sulla bassa Vistola, dove sono segnalati da
Tacito (La Germania, cap.43).
I Burgundi giunsero sulle rive del Reno intorno al 407 e si stanziarono a Worms (attuale Germania centrale), dove fondarono il
primo regno burgundo, poi annientato da un'incursione degli Unni. Circa trent'anni dopo fondarono un nuovo regno, tra
Francia e Svizzera attuali, la Burgundia (Borgogna). Il regno dei Burgundi ebbe vita breve: nel 534 il regno venne inglobato dai
Franchi. Dei Burgundi si parla nel poema tedesco dei Nibelunghi, ambientato a Worms.
I Vandali dall'area nord scendono verso sud-est, vanno in Spagna e poi si stanziano a Cartagine. Nel 455 arrivano a Roma e la
saccheggiano. I Vandali furono un popolo belligerante e bellico. In poco tempo diventano i padroni del Mediterraneo (“il mare
dei Vandali”). Tra il 433-34 termina il loro regno.
I Visigoti varcano più volte il Danubio, devastando le regioni balcaniche e si stanziano nell'attuale Bulgaria-Romania, fino a
giungere con Alarico in Italia dove saccheggiano Roma nel 410 (primo sacco di Roma).
Nel IV secolo si convertono alla versione 'ariana' del Cristianesimo e si avvicinano alla scrittura. L'arianesimo era una dottrina
eretica. Nel 419 fondano in Gallia il regno di Tolosa ed estendono il loro dominio fino a gran parte della penisola iberica, dove
però sono sconfitti dai Franchi. I Visigoti sono il gruppo che ci lascerà la documentazione linguistica.
Anche il regno degli Ostrogoti, sulla pianura sarmatica, viene travolto dall'invasione degli Unni. Alcuni di essi si rifugiarono in
zone appartate come la penisola di Crimea, la maggior parte però seguì le sorti degli Unni e del loro re Attila (got. Atta
“padre”, Attila è un diminutivo “paparino”).
Dopo la morte di Attila, gli Ostrogoti riacquistano l'indipendenza ed invadono l'Italia sotto la guida di Teodorico. Teodorico
compie il primo tentativo di conciliare in uno stesso stato le esigenze giuridiche, religiose e culturali dei Germani e dei Latini. Il
regno ostrogoto in Italia (Teodorico si insedia a Ravenna) dura 60 anni. Dopo la morte di Teodorico, l'imperatore d'Oriente
Giustiniano mette fine al regno ostrogoto.
I due momenti più importanti per l'evoluzione culturale dei Goti sono:
• l'impatto con il mondo greco-bizantino e la conversione al Cristianesimo, soprattutto i Visigoti;
• il regno in Italia di Teodorico, il contatto con la civiltà latina, in un periodo di relativa stabilità che sembra consolidare
e rivitalizzare la cultura gotica.
WULFILA
La figura del vescovo Wulfila ed il prestigio della sua traduzione furono determinanti per l'acquisizione e la diffusione del
Cristianesimo da parte dei Goti, anche se probabilmente essi conobbero la religione cristiana già nel corso del III sec.
Wulfila era bilingue, di madre cappadoce e padre goto, istruito al latino e greco.
Fu elevato al vescovato da Eusebio di Nicodemia, seguace dell'arianesimo, nel 341 a Costantinopoli. Poi tornato in patria si
fece promotore della diffusione del Cristianesimo tra i Visigoti.
L'impresa di Wulfila fu quella di avvicinare i Goti al cristianesimo traducendo in Gotico il testo sacro della Bibbia.
Della Bibbia di Wulfila ci sono giunti tre quarti del Nuovo Testamento, tre capitoli del libro di Neemia e parte delle lettere di S.
Paolo. La Bibbia di Wulfila è il primo testo in una lingua gm antica e la prima traduzione della Bibbia in volgare. La lingua
gotica che viene fuori da tale traduzione ha un carattere estremamente dotto, è molto influenzata dal modello greco e
finalizzata a precise necessità liturgiche (e quindi probabilmente molto diversa dai dialetti effettivamente parlati dai Goti).
Tuttavia, il documento assume enorme importanza dal punto di vista linguistico e culturale. Ci troviamo di fronte al primo
testo di notevole estensione in una lingua germanica.
Inoltre, il documento di Wulfila documenta il primo contatto diretto dei Germani con il mondo mediterraneo colto e letterato.
L'impianto grammaticale germanico non sembra quasi mai compromesso dall'influenza del greco; quest'ultima si manifesta
soprattutto nel lessico, nella sintassi e nell'ordine delle parole.
Per la stesura della sua traduzione, Wulfila inventò un alfabeto che utilizza sostanzialmente l'onciale (onciale: tipo preciso di
grafia maiuscola) greco integrato con l'onciale latino e con l'alfabeto runico. Sembra accertato infatti che anche i Goti, come
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
gli altri Germani, abbiano conosciuto ed usato la scrittura runica, ma Wulfila l'ha ritenuta inadeguata per la stesura delle
Bibbia, per il suo valore magico-sacrale.
L'alfabeto gotico è essenzialmente fonologico (ogni segno grafico corrisponde ad un fonema. Ci sono però delle eccezioni
(vedere dopo caratteristiche della lingua gotica).
L'alfabeto in questione utilizza lettere maiuscole (sistema bilineare).
LE ISCRIZIONI RUNICHE
alcune delle Iscrizioni runiche più antiche possono essere attribuite ai germani dell'est. Si possono considerare senza difficoltà
come scritte in gotico o in qualche dialetto affine.
Tra le più famose ricordiamo:
• l'iscrizione sulla punta di lancia di Kowel (in Ucraina) che recita: tilarids 'veloce verso il bersaglio'-nominativo maschile;
• l'iscrizione sul collare di Pietroasa (in Romania) che recita: gutaniowihailag, con gutani che può essere il genitivo
plurale del nome dei Goti.
I Goti conoscevano le rune ma probabilmente le hanno ritenute poco adatte alla redazione di un testo sacro, dato il loro uso
magico-sacrale.
I MANOSCRITTI DELLA TRADIZIONE GOTICA
• Bibbia
- “Codex Argnteus”, conservato alla biblioteca universitaria di Uppsala, in pergamena purpurea con scrittura in
argento e oro (fine V-inizio VI sec), testimone più importante della lingua gotica, 187 fogli;
- frammento di Spira, noto come “foglio di Spira”, scoperto a Spira, in Germania, nel 1970; è il 188esimo foglio del
codex argenteus;
- “Codex Carolinus” è il ms più antico che ci è rimasto della Bibbia gotica, V sec; contiene l'epistola ai Romani;
- “Codices Ambrosiani A,B,C,D; sono palinsesti, cioè riscritti;
- “Codex Gissensis” proveniente dall'Egitto
• Skeireins
('spiegazione') commento prziale ai primi 7 capitoli del Vangelo di [Link]. Non è certo che si tratti di un originale
gotico ma piuttosta una traduzione di un'opera ignota. Il testo è comunque molto interessante perchè testimonia
l'utilizzo della lingua di Wulfila anche per opere di carattere esegetico, oltre che liturgico.
• Il documento di Napoli
Il “Papiro di Napoli”, conservato alla Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III; è un atto di compravendita di un
terreno in gotico. Esisteva anche un Papiro di Arezzo, ma è andato perduto.
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
LA LINGUA GOTICA
- La lingua dei Goti è la lingua gm con la più antica attestazione manoscritta, ci testimonia uno stadio del gm molto indietro
nel tempo.
- E' una lingua però sostanzialmente compatta e monotematica: i testi sono quasi tutti di carattere religioso.
- Wulfila operò nel IV sec d.C., invece i manoscritti della lingua gotica sono tutti datati tra V e VI sec: abbiamo un arco
cronologico di due secoli e la lingua got deve essersi evoluta per forza di cose! Da qui il dubbio sull'effettiva compattezza
della lingua.
- Alfabeto gotico: è essenzialmente un alfabeto fonologico (ogni segno grafico corrisponde ad un fonema). Ci sono però delle
eccezioni. E' una sorta di mix tra alfabeto greco, latino e sequenza runica; la scrittura è maiuscola (sistema bilineare).
Come per l'alfabeto greco, inoltre, ogni lettera equivale ad un numero.
VOCALISMO
- Il vocalismo del got ripete il vocalismo gm (il gm è ricostruito infatti a partire dal got).
- I segni per la e e la o indicano vocali lunghe, come in lētan “lasciare” e in brōthar “fratello”.
- i ed il digrafo ei indicano rispettivamente [ i ] ed [ i: ], che restano distinti nella grafia, come in fisks “pesce” e leik “corpo”.
- In gotico la presenza del doppio segno indica sia la quantità che la qualità vocalica.
- I digrammi ai ed au sono un caso particolare e problematico. Le opinioni degli studiosi sono contrastanti: probabilmente i
digrammi sono soluzioni per rappresentare un unico fonema, rispettivamente e ed o aperte ,quando tali digrammi si trovano
davanti a r, h, hv.
wair “uomo” (letto weir)
saihs “sei” (letto sehs)
baurgs “città” (letto borgs)
Altri studiosi, invece, attribuiscono a questi due digrammi il valore di dittongo (vanno lette cioè come dittonghi). Essi hanno
preso in esame parole che, su base etimologica, presentano dei dittonghi (quindi tornando indietro nel tempo all'originale
germanico o addirittura indoeuropeo) oppure basandosi su trascrizioni di nomi stranieri (es. Audericus).
Altri studiosi ancora ritengono che i digrammi abbiano sempre indicato dei monottonghi, delle vocali singole.
Infine, lo studioso D'Alquen ha ipotizzato che la problematicità dei digrammi derivi dall'evoluzione della lingua gotica. In
origine i digrammi rappresentavano dei dittonghi e solo successivamente dei fonemi singoli.
Altre trasformazioni del vocalismo_
- ai ed au potrebbero essere considerati anche come particolari esiti di frattura in gotico, dato che ricorrono nello stesso
contesto (l, r, h).
- abbassamento/apertura delle vocali lunghe e ed o davanti ad a (pronuncia molto aperta).
- affermazione dell'accento protosillabico che in gotico non provoca fenomeni come metafonia e indebolimento vocalico ma
essenzialmente riduzione delle vocali lunghe in brevi e scomparsa delle vocali brevi, a fine parola e davanti a -s e -m.
CONSONANTISMO
Il sistema consonantico del got corrisponde essenzialmente a quello del gm, tranne per quanto riguarda:
- i segni b, d, g che in got indicano fricative sonore, tranne a inizio parola e dopo nasale (in gm sono occlusive).
- resa grafica delle nasali velari ɳk e ɳg con i digrammi gk e gg , secondo il modello greco.
CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
Il got è la lingua gm più conservativa.
- in got abbiamo più flessioni nominali rispetto alle altre lingue gm;
- distinzione dei vari casi per tutte le classi tematiche: desinenze diverse per ogni caso;
- forma del passivo sintetica e non analitica (una sola parola per esprimere il passivo);
- il got conserva tracce di duale più di tutte le altre lingue gm;
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
- VII classe dei verbi forti: preterito per raddoppiamento;
- IV classe dei verbi deboli; classe produttiva solo in got:
- innovazione morfologica: creazione del pronome relativo ampliando il pronome dimostrativo (so sa tod), aggiungendo la
particella -ei.
CARATTERISTICHE SINTATTICHE
Il got risente delle strutture sintattiche del greco e del latino, lingue di partenza del testo biblico.
Ci sono però tratti caratteristici propri del gotico:
- il got conserva costrutti sintetici, si conservano i casi, si usa poco l'articolo;
- prefissi per esprimere l'aspetto del verbo: ga- → funzione aspettuale del verbo rispetto al verbo semplice;
- uso di wisan “essere”, con participio presente per esprimere l'azione durativa.
IL LESSICO
La Bibbia gotica di Wulfila:
- utilizzo di calchi semantici, ossia ampliare il significato di parole gotiche per avere nuovi significati.
Es. Spirito Santo: ahma weihs, Paradiso: waggs (“prateria”);
- imitazione della struttura dei composti stranieri, calchi strutturali;
- prestiti dal greco e dal latino.
Poco documentati sono i campi lessicali non religiosi: quello militare, quello relativo all'arte e alla scienza.
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
L'ANGLOSASSONE
L'espressione Inglese Antico fa riferimento alla lingua inglese del periodo Anglosassone.
(ingl.a. è la lingua; ags. è il periodo storico)
Il periodo anglosassone va dal V sec., cioè dall'emigrazione di Angli, Sassoni e Juti (popolazioni germaniche continentali
provenienti dalla Danimarca e dalla Germania settentrionale) in Gran Bretagna al 1066, anno della conquista normanna.
A darci queste informazioni è lo storico Beda, nella sua opera Historia Ecclesiastica gentis Anglorum.
Lo storico Beda ci informa che i Germani sarebbero giunti sull'isola inizialmente perchè chiamati in aiuto come mercenari da
alcune popolazioni celtiche. Poi, dopo una lunga guerra di conquista, si sarebbero impadroniti di gran parte dell'isola (non
sappiamo quanto ciò possa essere veritiero!).
Fatto sta che nel V sec. Angli, Sassoni e Juti si insediano in territorio britannico, portando con sé la propria lingua germanica. In
base alle aree geografiche in cui queste popolazioni si stanziano, distinguiamo 4 dialetti dell'inglese antico:
• northumbrico, usato dagli Angli che si stabilirono al centro-nord dell'Inghilterra;
• merciano, usato dagli Angli che si stabilirono nell'Inghilterra centrale;
• sassone occidentale, usato dai Sassoni che si stabilirono a sud del Tamigi;
• kentico, usato dagli Juti, che si stabilirono nel Kent.
Molti scritti in prosa della documentazione che abbiamo sono redatti in sassone occidentale (testi religiosi, testi ad uso
scolastico, testi scientifici, la regola benedettina, formule magiche..)
Molti scritti in versi sono redatti originariamente in merciano o northumbrico e poi ricopiati in sassone antico.
LA CONVERSIONE AL CRISTIANESIMO
Nel V sec i Germani arrivano in Bretagna. Nel corso del VI sec, queste popolazioni dividono l'Inghilterra in 7 regni, dando vita
alla cosiddetta eptarchia:
il regno del Kent in cui c'erano gli Juti,
i tre regni Sassoni del Sussex, Essex e Wessex,
e, a nord del Tamigi, la Mercia, l'Anglia orientale e la Northumbria.
Nello stesso periodo, nei territori rimasti celtici e nella vicina Irlanda si diffonde il cristianesimo ed un particolare monachesimo,
detto appunto Monachesimo Irlandese, caratterizzato da:
1. rigide pratiche ascetiche e penitenziali, quindi una riflessione spirituale molto forte e sentita;
2. una forte motivazione di tipo missionario, che stimolerà la diffusione del monachesimo irlandese nell'Inghilterra
settentrionale e poi nei regni barbarici del continente.
L'Inghilterra anglosassone conosce il Cristianesimo attraverso due correnti diverse:
1. da Nord, attraverso il Monachesimo Irlandese, che si diffonderà nell'area settentrionale dell'Inghilterra anglosassone;
2. da Sud, attraverso il monachesimo benedettino legato a Roma, che si diffonderà nella parte meridionale dell'Inghilterra
anglosassone.
IL MONACHESIMO IRLANDESE
E' un monachesimo di tipo ascetico-eremitico che caratterizza le popolazioni celtiche ed irlandesi. E' introdotto in Irlanda dai
cristiani gallo-romani. La Gallia diede un fondamentale apporto al movimento monastico celtico e irlandese, perchè assicurò la
diffusione del cristianesimo e della cultura romana.
L'Irlanda, una volta convertitasi al cristianesimo grazie all'opera di San Patrizio, divenne il principale baluardo della romanità in
Occidente.
Gli irlandesi avevano una forte motivazione di tipo missionario e nel VII sec si spostarono verso l'Inghilterra e il continente per
convertirli (peregrinatio penitenzaria) e fondarono numerosi monasteri in Inghilterra, Germania ed Italia settentrionale.
La diffusione del cristianesimo non è importante solo da un punto di vista culturale. La diffusione del cristianesimo si basa
molto sull'uso di testi di fede cristiana.
Il monaco Columba fonda nel 563 il monastero di Iona, in Scozia, ed il monaco Aidan di Iona fonda nel 565 il monastero di
Lindisfarne (Holy Island oggi).
In questi monasteri, i monaci irlandesi trascrivevano e ricopiavano testi sacri (Bibbia, Vangeli) ed introdussero importanti
innovazioni grafiche nella scrittura: la separazione delle parole e una scrittura mista maiuscola e minuscola. Scrivevano anche
vite dei santi, grammatiche latine e decoravano riccamente i manoscritti. I monasteri irlandesi sono piccoli edifici, poco più che
capanne d'argilla con tetti di paglia.
Un noto manoscritto di questi monaci irlandesi è il London, British Library, Cotton Nero [Link]
IL MONACHESIMO BENEDETTINO
Il monachesimo di impostazione benedettina arriva in Inghilterra da Sud. Nel 597 il monaco Agostino giunge in Inghilterra da
Roma, per cristianizzarla.
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
Incontra re Ethelbert del Kent che accoglie la nuova fede (anche perchè il re aveva già sposato una principessa cattolica).
Quindi predica presso il popolo del Kent, che si converte, e viene nominato da Papa Gregorio Magno del titolo Arcivescovo di
Cantebury. La conversione degli anglosassoni fu caratterizzata da grande moderazione ed avvenne nel rispetto delle tradizioni
precedenti, non annullando del tutto le precedenti credenze pagane (divinità germaniche). Molte festività cristiane sono
legate, infatti, a festività pagane (es. solstizio d'inverno).
REAZIONE DELL'INGHILTERRA ANGLOSASSONE
Il Cristianesimo fu accolto di buon grado e senza reazioni violente (come avvenne invece in Germania), perchè:
1. Il Cristianesimo non rappresentava una minaccia straniera politicamente temibile;
2. ci si avvicinava alla cultura latina, il Cristianesimo era cioè un elemento di prestigio culturale;
3. la cultura e la lingua latina non erano completamente sconosciute a tali popolazioni.
CONTRASTO TRA ROMA E MONACHESIMO IRLANDESE
Contrasto sull'impostazione del monachesimo:
Il monachesimo irlandese non riconosceva le indicazioni e l'autorità di Roma, era caratterizzato da ascetismo ed individualità: il
monaco autonomamente decideva di fondare un nuovo monastero.
Il monachesimo benedettino si reggeva invece sul principio della stabilitas loci e su un'organizzazione gerarchica: il monaco
viveva nel monastero e svolgeva attività residenziali continuative, e vigeva la regola benedettina (silenzio assoluto nel
monastero; ora et labora: falso storico!).
Contrasti liturgici:
metodo per stabilire la data della Pasqua.
PACIFICAZIONE DEL CONTRASTO
Nel 644, col Sinodo di Whitby, viene dichiarata valida la data romana della Pasqua. Dopo il Sinodo, tutti i monasteri
d'Inghilterra optarono per la regola benedettina.
VIII SECOLO
La pacificazione porta ad una notevole vivacità culturale.
Nei centri monastici si rafforza una letteratura latina di carattere omiletico ed agiografico, legata ai testi sacri, ma fiorisce
anche la poesia di tradizione germanica. L'alfabeto latino viene quindi ampliato per tradurre alcuni suoni specifici che
appartenevano alle lingue gm, vengono introdotti nuovi simboli grafici, tra cui il simbolo per il thorn ϸ.
Furono molto fecondi i monasteri settentrionali di Jarrow, York e Lindisfarne, dove operarono monaci che influirono sulla vita
culturale di tutta Europa.
Le personalità più importanti, da un punto di vista culturale, di questa tradizione latina promossa da monaci nati in Inghilterra
sono:
• Beda il Venerabile (V, VI sec)
Scrisse Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, opere grammaticali e scientifiche, i “Commenti” alle Scritture;
• Alcuino
Monaco anglosassone educato nel convento di York, scrisse in latino opere grammaticali, di carattere filosofico e
didattico che ebbero grande diffusione nell'alto Medioevo.
Nel 781 Alcuino fu chiamato alla corte di Carlo Magno per realizzare il suo progetto della scuola Palatina (chiamare a corte un
monaco equivaleva ad introdurre una mini-biblioteca). Notevoli erano i contatti culturali tra continente e mondo
anglosassone. Questo passaggio di persone, di eruditi, tra isola e continente porta alla diffusione di tutto il sapere medievale
(sapere scientifico, filosofico, enciclopedico, tutto ovviamente in latino).
Ad un certo punto, in Inghilterra, alcuni concetti cristiani cominciano ad essere espressi non più solo in latino, ma anche in
inglese antico, in forma poetica.
L'EPOCA DI ALFREDO (fine VIII-inizio IX sec)
Tra fine VIII-inizio IX sec arriva re Alfredo. Re Alfredo il grande compare sulla scena inglese in un periodo di incursioni
vichinghe, un periodo molto travagliato:
- Norvegesi, occupano il nord della Scozia, le Shetland e la costa occidentale dell'Inghilterra;
- Danesi, occupano le regioni orientali dell'Inghilterra.
Queste popolazioni vichinghe distruggono Lindisfarne ad altri monasteri settentrionali. Forse è questo il motivo per cui la
maggior parte dei mss anglosassoni ci sono pervenuti solo in un dialetto meridionale. Si tratta di copie da probabili originali
anglici.
Nell'886, re Alfredo riesce a porre fine alle invasioni danesi, scendendo con essi a patti e concedendogli dei territori. York
diviene il centro del regno danese. Nei territori occupati dai Danesi è in vigore la legge danese.
Solo nel 1016 il re danese Canuto il Grande riunisce sotto la sua corona l'Inghilterra, la Norvegia e la Danimarca ma il suo
regno finisce con la sua morte nel 1036 e l'Inghilterra torna ad una dinastia inglese.
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
Con re Alfredo l'Inghilterra conosce un periodo di relativa tranquillità, di notevole attività letteraria e culturale stimolata ed
attuata dal sovrano stesso.
In campo giuridico: re Alfredo riorganizza il regno e promuove un nuovo codice di leggi.
In campo letterario: re Alfredo elabora un fitto programma di traduzione di opere dal latino all'ingl.a., in particolare in Sassone
antico. Con tale spirito, promosse la redazione della Cronaca Sassone. Nel portare avanti questo programma di traduzioni,
Alfredo invitò tutti ad usare l'inglese nella vita culturale e civile. Tra le opere tradotte abbiamo anche la Historia Ecclesiastica
gentis Anglorum di Beda.
LA RINASCITA BENEDETTINA
Il regno di Alfredo è seguito da un nuovo periodo di incertezza civile e culturale a causa della ripresa delle guerre contro i
danesi.
Si diffonde però lo spirito della Rinascita Benedettina, partita dai monasteri riformati secondo il modello di Fleury. Si riporta in
Inghilterra la norma della regola benedettina (prima ogni monastero sembrava seguire una propria regola) e il nuovo fervore
religioso favorì la ripresa degli studi.
LA SCUOLA DI WINCHESTER
Questo processo di rinascita culturale legato alla riaffermazione della regola di San Benedetto parte dalla scuola di Winchester
(sud dell'Inghilterra) e dall'attività del vescovo di Ӕthelwold, monaco di grande rilievo perchè ha tradotto in ingl.a. la regola di
San Benedetto, rendendola comprensibile a tutti. Ӕthelwold era un arcivescovo in stretto contatto con i re Sassoni
Fra gli allievi di Ӕthelwold spicca il monaco Ӕlfric, studioso ad ampio raggio, come Beda, e autore di manuali di vario genere.
Ad Ӕlfric si deve la traduzione in ingl.a delle Istitutiones grammaticae di Prisciano (primo manuale di grammatica in ingl.a) e
dei primi libri del Vecchio Testamento (versione volutamente parziale). Ӕlfric fu autore di molte omelie. Con l'omelia, grazie ad
Ӕlfric, la prosa inglese entra nell'uso letterario sostituendo quella latina, raffinandosi e perfezionandosi.
1066, BATTAGLIA DI HASTINGS, GUGLIELMO IL CONQUISTATORE
Nel 1066 avvenne la famosa battaglia di Hastings in cui Guglielmo il Conquistatore porta la casata normanna, di lingua
francese, su territorio anglosassone.
Ne conseguono trasformazioni culturali e linguistiche importanti.
L'inglese viene quasi totalmente soppresso nei testi letterari e nei documenti ufficiali, redatti in latino o francese. La nuova
classe dotta non comprendeva e non aveva interesse a ricopiare o conservare gli antichi mss in inglese. La produzione
letteraria anglosassone fu in gran parte dimenticata e dispersa. Ci resta solo una piccola percentuale di quanto fu
effettivamente scritto in epoca anglosassone.
La tradizione inglese fu conservata solo ad ovest dell'isola. Ad esempio, a Peterborough si continuò a compilare la “Cronaca”
in anglosassone fino al 1154.
Di una fusione tra le due culture, quella inglese e quella francese, si potrà parlare solo attorno al 1200, quando nasce una
lingua inglese del tutto ristrutturata (da Goeffrey Chaucer in poi). L'inglese in questione non è più “inglese antico” ma un
“inglese medio”.
LA LETTERATURA ANGLOSASSONE
Nonostante per molti anni prevale l'uso del latino rispetto a quello dell'inglese (Beda, Alcuino scrivevano in latino), si osserva
che l'inglese antico entra nell'uso scritto piuttosto precocemente rispetto alle altre lingue gm.
La letteratura anglosassone è fortemente legata alla produzione cristiana, si fa uso infatti dell'alfabeto latino. Tuttavia, c'è
rispetto per la tradizione germanica e un'armonia tra questa e la civiltà cristiana di nuova acquisizione.
Abbiamo due brevi inni, che sono i più antichi documenti di poesia epica in inglese antico:
• il primo è un inno attribuito da Beda a Caedmon e canta in nove versi la gloria del creatore, originariamente in
dialetto northumbrico
• il secondo inno è il canto di morte dello stesso Beda, in 5 versi, conservato in 29 mss, molti dei quali in northumbrico.
Tra i primi documenti in inglese antico vi è anche l'iscrizione runica incisa sul cofanetto Franks, del 700 circa (“la marea
scaraventò il pesce sugli scogli”).
I QUATTRO CODICI
La maggior parte della produzione poetica in inglese antico è conservata in quattro codici, tutti scritti intorno all'anno 1000 in
sassone occidentale tardo:
1. ms London, British Library, Cotton Vitellius [Link]
è il ms di Beowulf, di tre testi in prosa e di un frammento in versi che riprende la vicenda biblica di Giuditta;
2. ms Oxford, Bodleian Library, Junius 11,
116 fogli, contiene i poemetti caedmoniani ispirati all'Antico Testamento;
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
3. ms Exeter, Cathedral Library, 3501
113 fogli, regalo del primo arcivescovo leofric alla cattedrale di Exeter, contenuti religiosi e in parte profani;
4. ms Vercelli, Biblioteca Capitolare, cod 117
contiene omelie in prosa anonimi e componimenti poetici.
TEMI
La maggior parte della produzione poetica è ispirata a temi cristiani, che influenzano anche l'epica e la mitologia tipici della
tradizione germanica.
Beowulf [beoulf]: è il maggior rappresentante della poesia eroica: combatte e sconfigge il male. Il poema risente di
un'impostazione morale cristiana.
I poemetti caedmoniani: la materia biblica entra a far parte della poesia anglosassone e viene espressa con schemi stilistici e
narrativi tipici della poesia germanica (nell'Esodo, ad esempio, Mosè è come un condottiero germanico e ricorrono espressioni
poetiche legate al mondo germanico).
CARATTERISTICHE DELLA POESIA ANGLOSASSONE
1. Verso lungo allitterante
Verso lungo diviso in due emistichi, legati da allitterazione, ciascun verso lungo è costituito da due tempi forti e due deboli
(sillabe accentate e non accentate). L'allitterazione è dettata dal primo tempo forte del secondo emistichio.
es. iscrizione sul corno di Galleheus o inizio di Beowulf.
2. Kenningar
Kennigar (plur. di kenning) è un termine norreno che indica una costruzione a base prevalentemente metaforica/perifrastica,
tipica dell'antica poesia germanica, utilizzata per riferirsi ad un oggetto già menzionato nel discorso ed evitare ripetizioni. Tale
strategia arricchisce anche il verso poetico.
Es. “oltre la via delle balene”=oltre il mare
“il gioiello del cielo”=il sole
“donatore d'anelli”=il princeps del comitatus
3. Variazione
Uno stesso oggetto viene espresso con parole diverse, con vari sinonimi. Sono molto numerosi, ad esempio, i termini per
“mare”, “signore”, “guerra”.
L'INFLUSSO LATINO NELLA POESIA ANGLOSASSONE
Rispetto alla poesia anglosassone, il latino ne influenza in particolar modo i contenuti e la sintassi (evoluzioni di frasi semplici
in frasi complesse e di frasi coordinate in frasi subordinate, per imitare le strutture classiche).
LA PROSA IN INGLESE ANTICO
Gran parte della prosa in inglese antico è costituita da tradizioni di testi nati originariamente i latino. I suo scopo era funzionale
più che artistico. La prosa anglosassone raggiunge una dimensione letteraria vera e propria solo nel periodo tardo.
Dal momento che la filologia studia tutti i testi a prescindere dalla loro bellezza letteraria, occorre precisare che le leggi, le
carte, le glosse, pur essendo fuori dalla sfera della letteratura, costituiscono i primi passi che hanno portato allo sviluppo della
prosa.
Le leggi di re Alfredo costituiscono l'unico esempio di leggi in volgare precedenti la conquista normanna. Si tratta delle leggi
all'interno della Cronaca Anglosassone. Tali leggi sono precedute dal prologo di re Alfredo. Molte leggi mostrano tracce di
allitterazioni, assonanze, caratteristiche che ne facilitano senza dubbio la recitazione e la declamazione.
Le prime leggi sono essenziali e asciutte, poi man mano si arricchiscono (presenza di un prologo e sintassi più complessa).
L'INFLUSSO LATINO NELLA PROSA ANGLOSASSONE
Il lessico:
- molte parole latine entrano nel lessico inglese mediante i romani, che giungono sul suolo inglese prima dei germani.
Es. stræt “strada”; win “vino”.
- molte parole latine sono legate alla tradizione cristiana
Es. cirice “chiesa”; preost “prete”.
- molte parole latine sono calchi per riprodurre termini cristiani
Es. Þriness “trinità”, temini astratti in -dom, -scip, -nes.
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
LA TRADIZIONE GLOSSOGRAFICA
Il lessico latino entra a far parte del lessico anglosassone con le glosse. Le glosse sono dei termini che compaiono nei testi
antichi affiancati da una spiegazione del loro significato, ad opera degli autori stessi o di commentatori successivi (glossatori).
La traduzione glossografica è una traduzione molto letterale. Attraverso questa strategia si arricchisce il lessico.
L'INFLUSSO SCANDINAVO
Nel periodo anglosassone cominciano ad entrare nel lessico inglese anche termini scandinavi. Questo a causa delle invasioni
vichinghe. Tali termini stranieri sono stati accolti forse anche per l'affinità di lingua e cultura tra i due popoli e per le comuni
origini germaniche.
Es. sister è più simile all'isl.a syster che all'ingl.a sweostor;
sostituzione di parole : to take a danno dell'ingl.a niman;
molto diffusi sono anche i toponimi scandinavi;
per quanto riguarda la morfologia: sono di origine scandinava il pronome “they” e le forme “both” e “same”.
L'influenza scandinava sarà registrata nella documentazione a partire dall'inglese medio.
L'INGLESE ANTICO – OLD ENGLISH
- è una lingua ingevone
- l'ingl.a comincia ad avere una struttura estesa quando sul suolo anglosassone compare l'alfabeto latino
- l'alfabeto è fonologico (tendenzialmente ad un segno corrisponde un suono)-ingresso nella sequenza alfabetica latina di
nuovi simboli grafici per esprimere nuovi suoni ( þ , ð ).
Il grafema <g> rende sia /j/ , /ʤ/ , /g/ in base alla lettera che segue.
GRAFEMI VOCALICI
- La vocale a si nasalizza in o, se seguita da nasale (isoglossa ingevone). La stessa parola a volte è scritta con a, altre volte è
scritta con o. Questo si può vedere nella documentazione manoscritta fino al X sec. (hand/hond , and/ond).
- Il grafema œ rende l'esito metafonizzato di una o (es. œle “olio”).
- il grafema y rende l'esito metafonizzato di una u. Nel corso del tempo la y indicherà semplicemente una i.
- i digrammi ea, eo, ie possono indicare sia dittonghi che vocali semplici.
GRAFEMI CONSONANTICI
- c, g, h hanno valore palatale se sono seguite da vocali palatali;
Es. cirice vs corn.
- f è una spirante sorda ma in posizione intervocalica va letta come una spirante sonora;
Es. ofer (over) vs folc (folk)
- s è una spirante sorda ma in posizione intervocalica va letta come una spirante sonora (come una z);
- þ e ð sono usati più o meno indifferentemente. Se in posizione intervocalica vanno lette con pronuncia sonora.
Es. broþor (brodhor)
EVOLUZIONE FONOLOGICA DAL GERMANICO ALL'INGL.A.
Vocali brevi:
gm. *a > ingl.a. *æ per un processo di palatizzazione (dæg “giorno”)
gm. *e, *i, *u rimangono inalterate in ingl.a.
Vocali lunghe:
gm. *ē¹ > ingl.a. ǣ
gm. *ā > ingl.a. ǣ (ingl.a strǣt vs ata. strāta)
gm. *ē² > ingl.a. ē
le altre vocali lunghe rimangono inalterate
Dittonghi:
gm * ai > ingl.a *ā (ingl.a *ān vs got *ains, “uno”)
gm * au > ingl.a *æo, *æa e *ea (ingl.a *read vs got *rauþ, “rosso”)
gm *eu, *io > ingl.a eo (ingl.a *deop vs ata *tiuf “profondo”)
Morfologia:
In inglese antico si osserva, rispetto ad esempio al gotico, una semplificazione del sistema morfologico. Molte desinenze non
sono visibili e talvolta è difficile individuare il tema di appartenenza di un sostantivo.
Inoltre, cii sono casi particolari dell'inglese in cui si conserva il duale.
Un tratto conservativo dell'ie è il pronome dimostrativo rafforzato che svolge la funzione di articolo.
Il sistema pronominale vede l'introduzione del pronome relativo che nasce dal dimostrativo
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
Flessione verbale:
Per quanto riguarda il sistema verbale, l'ingl.a tende ad uniformare le desinenze. Le tre persone del singolare hanno desinenze
diverse, le tre persone del plurale hanno la stessa desinenza.
Sintassi:
La frase, come già detto, va incontro ad un arricchimento. Forte è l'influsso del latino.
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
ANALISI DEL PRIMO TESTO
da “HISTORIA ECCLESIASTICA GENTIS ANGLORUM” di BEDA
LIBRO 1, CAP.15 “The founding of England”
L'opera è scritta da Beda intorno al 731. E' un'opera estesa, che ha avuto una grandissima diffusione in tutto l'occidente
europeo. Della versione latina esistono ben 160 mss.
L'opera è costituita da 5 libri. In ogni libro Beda affronta un argomento della storia anglosassone.
Nel primo libro si parla dell'arrivo di Angli, Sassoni e Juti su territorio anglosassone e del cristianesimo in Inghilterra. Il primo
libro si chiude più o meno con l'arrivo di Agostino a Cantebury.
Il secondo libro continua con la diffusione del cristianesimo e si sofferma sull'operato di Papa Gregorio Magno.
Nel terzo libro si parla della diffusione del cristianesimo grazie all'operato dei monaci irlandesi e della disputa con il
monachesimo benedettino.
Nel IV libro Beda torna nuovamente sull'operato di Papa Gregorio Magno e narra dell'arrivo in Inghilterra del monaco
Teodoro, che riuscirà a diventare l'unico arcivescovo di tutta la Chiesa inglese.
Nel V libro si parla dei miracoli dei santi indigeni anglosassoni.
Tra questi 160 mss ne sono stati utilizzati 6 per costituire l'edizione critica del testo in latino.
La versione in inglese antico rispetta grosso modo il contenuto della Historia latina, però i traduttori hanno apportato una
serie di modifiche al testo. Possiamo dire che si tratta della versione sintetica del testo originale di Beda. Altre differenze
riguardano la disposizione dei capitoli, che non sempre corrispondono.
La versione in ingl.a è frutto di 6 mss (4 interi e 2 frammentari) di varia provenienza. Il ms principale, quello più autorevole ed
antico è l'Oxford, Bodleian Library, Tanner 10 sebbene privo di alcune parti del I libro.
• Đa Angelþēod ond Seaxna wæs gelađod fram þām foresprecenan cyninge ond on Breotone com on þrim myclum
scypum.
In quel tempo, il popolo degli Angli e dei Sassoni fu chiamato dal su menzionato re e giunse in Britannia su tre grandi
navi.
parola analisi traduzione
Đa avv. di tempo Allora, in quel tempo
(potrebbe avere anche valore di cong. e
significare “quando”. In questo caso è un
avv. di tempo).
Angelþēod È un sostantivo composto da Angel e Il popolo/la nazione degli Angli
þēod.
Angel è la foma base per 'Angli' (la
desinenza non è visibile ma è da rendere
con un genitivo);
þēod è un sostantivo femminile forte al
nominativo sing (tema in -o) che deriva
da una rad ie *teutā.
ond Congiunzione e
(oscillazione o/a davanti a nasale)
Seaxna Genitivo plur del nome Seaxe, dei Sassoni
sost. masch ft, tema in -i;
gm* sahsa:
gm *a> ingl.a *æ> ingl.a *ea per frattura
(segue la fricativa velare h).
La -i del tema avrebbe dovuto dare esito
di metafonia palatale (la vocale ea si
sarebbe dovuta presentare come ie) ma
ciò non avviene, probabilmente per
analogia.
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
wæs gelađod gelađod è un indicativo preterito passivo fu invitato/chiamato
formato dal pret sing di waesan, vb ft di V
classe, + il participio pret di gelađian, vb
db di II classe (-o nella desinenza e
suffisso in dentale).
fram preposizione che regge il dativo da
(from in [Link]: sempre alternanza a/o
in presenza di nasale)
þām dat. sing masch del dimostartivo/articolo il (da+il=dal)
se seo þæt
foresprecenan dat. sing di un participio preterito, su menzionato
utilizzato con valore di aggettivo.
fore è un avverbio (“prima”);
sprecan è un vb ft di V classe
(“menzionare, parlare”).
cyninge dat. sing di cyning, [Link] ft, tema in Re (si riprende Vortigern, re dei
-a. Britanni)
deriva dal gm* kunningaz (si nota l'esito
della metafonia palatale).
ond on ond è una congiunzione; e in
on è una preposizione che regge dat,acc,
strum: in questo caso regge l'accusativo.
Breotone [Link] di Bryten, nome proprio Britannia
femminile, tema in -jo.
La -j del tema può aver determinato
metafonia su eo (eo>ie).
cōm [Link] di cuman, vb ft di IV classe. giunse/arrivo
on Preposizione che regge il dat.. su, con
þrim dat. dell'[Link] “tre”. tre
myclum dat. dell'agg. micel. grandi
L'agg deriva dal gm *mekila (e>i per
metafonia palatale).
scypum [Link] di scip, sost neutro, tema in -a. Navi.
• ˥ on ēastdǣle þyses ēalondes eardungstōwe onfēng þurh đæs ylcan cyninges bebod þe hī hider gelađode þæt hī
sceoldan for heora eđle compian ond feohtan.
E sulla parte orientale dell'isola ricevettero un luogo di insediamento per ordine del re in persona che li invitò quaggiù
affinchè combattessero per la loro patria.
parola analisi traduzione
˥ Nel manoscritti spesso si trova il simbolo E
grafico ˥ come abbreviazione di 'ond'.
on Preposizione che regge vari casi: acc, dat su
o strumentale.
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
ēastdǣle Nome composto: la parte orientale
east fa pensare all'est, all'oriente;
dǣle è un [Link] (il genere del composto
è definito da secondo termine del
composto). Deriva dal latino pars-parti.
þyses dimostrativo rafforzato al genitivo, di questa
neutro.
ēalondes Ealand/ealond è un sost composto ft isola
neutro (nome composto: ea=acqua,
land= terra, neutro), tema in-a.
eardungstōwe Sostantivo composto forte femm. un luogo di insediamento
(desinenza -e = [Link]), caso accusativo:
eard: terra, insediamento;
ung: suffisso per formare sost femminili
stowe: place (femm, tema in -o)
onfēng Vb ft, preterito sing, VII classe (ē² al ricevette
preterito sing).
Verbo composto: on/fon-feng-fangen;
Perchè fon? Originariamente: fanhan,
nasalizzazione della a in o e poi caduta
della nasale.
þurh Preposizione che regge più di un caso, attraverso/per mezzo
fenomeno della metatesi (due lettere
che cambiano di posto): originariamente
era þruh ([Link] through).
Regge 'bebod'.
đæs del
ylcan Agg debole (individualizzante); lo stesso/in persona
ilca: lo stesso.
cyninges re
bebod Sost ft, caso accusativo, neutro ordine
(tema in -a);
rad gm* bibeudan “comandare”.
þe Pronome relativo indeclinabile che/il quale
hī [Link] 3^pers plur (acc) loro
hider Avverbio di luogo, movimento verso chi qui/quaggiù
parla
gelađode Preterito plur debole (suff in dentale) I invitò
classe.
þæt Congiunzione con valore finale affinchè
hī [Link] 3^pers plur essi
sceoldan Verbo preterito-presente plur, debole dovevano
(seguito dall'infinito come oggi i modali
moderni).
Regge: compian ond feohtan.
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
for preposizione per
heora Possessivo che deriva dal genitivo la loro
eđle Sostantivo ft sing al dat, tema in -a. terra natìa, patria
gm* oþila: mtafonia palatale, la o prima
si centralizza e poi diventa a.
compian Vb debole II classe all'infinito battersi
ond congiunzione e
feohtan. Vb forte II classe all'infinito (la dentale fa combattere.
parte della radice e non del suffisso);
(antenato del vb “fight”).
La coppia “compian ond feohtan” è una
doublet, tipica della poesia.
• Ond hi sōna compedon wiđ heora gewinnan þe hi oft ǣr norđan onhergedon ond Seaxan þa sige geslōgan.
Ed essi subito si batterono contro i loro nemici, i quali spesso devastarono da nord, e i Sassoni ottennero le vittorie.
Ond hi Congiunzione e pron personale Ed essi
sōna avverbio di tempo subito
([Link] soon)
compedon Vb debole di II classe si batterono
wiđ Preposizione che regge il dat. contro
(influenza dell'isla.a., può significare
anche 'con')
heora [Link] di hi i loro/propri
gewinnan sost debole masch. nemici
þe hi Pronome relativo indeclinabile e i quali essi (si riferisce ai nemici, i
pronome personale di 3^persona britanni)
oft avverbio spesso
ǣr avverbio, non ha equivalente in [Link] in precedenza
norđan Avverbio; la componente -an indica la da nord
provenienza
onhergedon Vb debole di II classe composto da on e molestarono/devastarono
hergian (deriva dal gm* harjon:
metafonia palatale in ingl.a)
ond congiunzione e
Seaxan nom plur. E' un nome di popolo e non i Sassoni
segue le declinazioni.
þa Articolo all'[Link]. le
sige Sostantivo masch, acc. vittorie
geslōgan Vb forte VI classe, pret plur di geslean. ottennero.
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
• Þa sendan hī hām ærenddracan ond hēton secgan þysses lande swæstmbærnysse ond Brytta yrgþo.
Poi mandarono in patria i messaggeri e gli ordinarono di narrare la fertilità di questa terra e la codardia dei Britanni.
parola analisi traduzione
þa avverbio Allora, poi
sendan Vb debole di I classe (got. *sandjan: inviarono/mandarono
metafonia palatale in ingl.a).
Verbo problematico per la struttura.
hī Pron. personale essi
hām Sost ft masch, tema in -a ma perde la a casa/in patria
desinenza, come accade spesso per
sostantivi monosillabici.
In [Link]. home; non richiede la
preposizione to.
ærenddracan sostantivo composto (i portatori del i messaggeri
messaggio) da ærendd, sost ft masch
(tema in -ja) 'messaggio' e reccan, vb
debole di I classe
ond congiunzione e
hēton Vb ft VII classe, preterito di hatan ordinarono
secgan Vb debole di III classe, 'dire'; dire
gm* sagjan
þysses Gen sing del dimostrativo rafforzato di questa
landes Gen sing di land, sost neutro, tema in -a. terra
wæstmbærnysse Sostantivo all'acc. fertilità
Sost femm ft, tema in -jo, composto da:
wæstm, sost masch nt ft, tema in -a
“frutto”;
bærian, vb deb di I classe, ricavato dal
vb ft di IV, beran “portare”;
suff. nys che indica sost astratti
(precursore di -ness moderno).
ond congiunzione e
Brytta Gen plur di Bryttas, nome di popolo, dei Britanni
'Britanni', sost ft, tema in -a.
yrgþo. Sostall'acc, ft, femm, tema in -jo. codardìa.
Ed essi, allora, subito laggiù mandarono una flotta più grande di uomini più forti e vi fu (si formò) un esercito invincibile
quando essi furono uniti.
parola analisi traduzione
Ond hi congiunzione e pronome personale. Ed essi
þa Avv. allora, poi
sona Avv. subito
hider Avv. laggiù
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
sendon [Link] di sendan, vb deb di I classe mandarono
māran Comparativo irregolare di mycel 'grande' una più grande
(antenato di more);
la flessione è debole perchè il
comparativo è individualizzante.
sciphere Sost. composto: flotta
scip sta per 'nave';
here sta per 'esercito'
strengran Gen plur db del comparativo di strang: il di più forti
compar si forma con il suffisso gm *-ero
o -iro (che produce metafonia).
wighena Sost debole (desinenza nasale -na) uomini/guerrieri
masch plur.
ond wæs Congiunzione + [Link] di wæsan, rad e vi fu
utilizzata per esprimere il passato di
essere.
unoferswiðendlic Agg. ft composto (ft perchè ha funzione invincibile
predicativa)
weorud, Sost. sing ft neutro, tema in -a. un esercito
þa hi Congiunzione subordinante + quando essi
pronome personale
togædere Avv. insieme
geþeodde [Link] di geþeodan, vb deb di I classe uniti
(presenta la doppia dentale)
wæron. Preterito plur di wæsan, rad utilizzata furono.
per esprimere il passato di essere.
• Ond him Bryttas sealdan ond geafan eardungstowe betwih him,þæt hi for sibbe ond hǣlo heora eđles campodon ond
wunnon wiđ heora feondum ond hi him andlyfne ond āre forgeafen forr heora gewinne.
E i Britanni gli diedero e assegnarono un luogo di insediamento, affinchè essi combattessero e vincessero contro i loro
nemici per la pace e la salvezza della loro patria e gli fornirono cibo/denaro e proprietà per il loro lavoro.
parola analisi traduzione
Ond congiunzione E
him Dat plur di 'essi', pron di III pers plur. a loro
Bryttas [Link], nome di popolo i Britanni
sealdan Vb debole, pret plur di sellan. diedero
Deriva dal gm *saljan (metafonia
palatale e geminazione consonantica,
isoglossa del gm occidentale).
Al pret abbiamo sealdan: frattura.
Sealdan e geafan: altra doublet, coppia
sinonimica, tratto poetico.
ond congiunzione e
geafan Vb ft di V classe, [Link]. di giefan assegnarono
([Link] *give)
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
eardungstowe Sostantivo composto forte femm. un luogo di insediamento
(desinenza -e = [Link]), caso accusativo:
eard: terra, insediamento;
ung: suffisso per formare sost femminili
stowe: place (femm, tema in -o)
betwih Preposizione che regge vari casi tra
(antenato del mod. between);
be (tra)+twih (due)
him, [Link] del pron di III pers. loro (Britanni),
þæt Congiunzione con valore finale affinchè
hi [Link] del pron di III pers. essi (gli Angli e Sassoni)
for Preposizione che regge il dat. per
sibbe Dat sing di sibb, sost femm ft (tema in la pace
-jo);
gm* sebjo (geminazione consonantica
occidentale e metafonia pal)
Tale sostantivo fa pensare alla Sippe,
luogo di pace.
ond congiunzione e
hǣlo Dat sing, sost femm db, tema in -in; la salvezza/sicurezza
gm* hailin (metafonia pal)
heora Gen plur del pronome di III pers con della loro
valore possessivo
eđles Gen sing di eđel, sost masch ft, tema in patria
-a.
gm* oþila: mtafonia palatale, la o prima
si centralizza e poi diventa a.
campodon Pret plur di compian, vb deb di II classe. combattessero
ond wunnon Pret plur di winnan, vb ft di III classe. e vincessero
wiđ Preposizione che regge il dativo contro
(influenza dell'isl.a: può significare anche
'con').
heora Gen plur, possessivo i loro
feondum Dat plur di feond, sost. m deb, nemici
tema in -n
ond hi Nom plur del pron di III pers ed essi
him Dat plur del pron di III pers. a loro (A. e S)
andlyfne [Link] di andleofen, sost femm ft, tema cibo/denaro
in -o, composto dal prefisso and e lifen
(amore, vita, sostentamento).
ond āre [Link] di ār, sost femm ft, tema in -o e proprietà (onore)
forgeafen [Link] di forgiefan, vb ft di V classe diedero/fornirono
composto da for e giefan.
for Preposizione che regge il dat per
heora Gen plur, possessivo il loro
gewinne. Dat sing di gewinn, [Link] ft, tema lavoro/guerra
in -a.
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
ANALISI DEL SECONDO TESTO
da “HISTORIA ECCLESIASTICA GENTIS ANGLORUM” di BEDA
LIBRO 4, CAP.24 “Il miracolo di Cædmon”.
Cædmon è uno dei pochi poeti della tradizione anglosassone di cui conosciamo il nome, vissuto più o meno nello stesso
periodo di Beda (prima metà VIII sec).
Cædmon è un “pastore ignorante”, che non aveva mai studiato latino o la poesia. Viene accolto come monaco nella stessa
abbazia dove risiedeva anche Beda. A lui è attribuito un miracolo: a questo pastore Dio avrebbe donato la capacità di
comporre versi, versi legati alla cristianità (fatti del primo testamento: Esodo, Genesi..). Cædmon riceveva questi versi da Dio
durante il sonno. Quando una badessa viene a sapere di questa cose, vuole a tutti i costi che Cædmon diventi un confratello
del suo convento.
Il brano introduttivo in analisi parla proprio di come Cædmon riesce a comporre versi in seguito a questo miracolo. Nel
convento, durante i banchetti e i momenti di gioia, a turno, ognuno doveva cantare qualcosa. Al turno di Cædmon, egli inizia
a comporre versi e compone l'inno sulla creazione. Il brano è interessante perchè contiene discorsi diretti.
…..vi fu un uomo che aveva vissuto nel mondo delle persone laiche, per un certo tempo della sua vita, fino alla vecchiaia,
e mai aveva imparato qualcosa di latino..
• Ond he forþon oft in gebēorscipe,þonne þǣr wæs blisse intinga gedemed þæt heo ealle scolden þurh endebyrronesse be
hearpan singan,þonne he geseah þa hearpan him nealecan þonne ārās he for scome from þæm symble ond ham eode
to his huse.
Poiché spesso, alla festa conviviale, quando vi era occasione di gioia, era stabilito che tutti dovessero cantare con l'arpa
(per ordine), quando egli vide l'arpa avvicinarsi a lui, per vergogna, si alzò dal banchetto ed andò verso casa sua.
parola analisi traduzione
Ond he Nom sing del pron di III pers Ed egli
forþon Congiunzione con valore causale poichè
oft Avv. spesso
in Preposizione che regge il dat nella
gebēorscipe, Dat. sing, sost mach ft, tema in -i, festa conviviale
composto da:
gebeor, sost masch ft (convitato, oppure
birra);
scipe, suff utilizzato per nomi astratti.
þonne Congiunzione temporale quando
þǣr wæs Antenato di “there was”; avv+verbo vi era
essere
blisse Gen sing di blis, sost femm di gioia
gm * bleitisjo (metafonia palatale)
intinga Nom sing, sost masch deb (tema in occasione
nasale).
In+ tinga (cosa, causa, occasione9
gedemed Vb deb, [Link] di demian era stabilito/deciso
gm *domjan (metafonia palatale, la o
prima si centralizza e poi diventa e).
þæt Congiunzione subordinante che
heo [Link] del pronome di III persone essi
(forma coeva all'epoca di Alfredo,
[Link] iniziale)
ealle Antenato di 'all', agg indefinito: flessione tutti
ft, [Link]
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
scolden Vb preterito presente plur dovevano
þurh Prep che regge l'accusativo attraverso/per
endebyrronesse Sost composto: ordine
endebyrd: sost femm ft, tema in -i
(ordine,turno);
ness: suff per formare nomi astratti
be Preposizione che regge vari casi con
hearpan Dat sing di hearpe, sost femm db, tema l'arpa
in -n:
gm *harpo (frattura, il sost
originariamente era un ft, tema in-ō)
singan, Infinito retto da scolden; cantare
vb ft di III classe
þonne Congiunzione temporale quando
he [Link] del pron di III pers egli
geseah [Link] di seon, vb ft di V classe; vide
è un verbo contratto
þa hearpan [Link] l'arpa
him [Link] del pronome di III pers a lui
nealēcan Inf di un vb deb di I classe avvicinarsi
(oggi [Link] near) composto da:
neah “vicino”;
læcan “muovere”
þonne Avv. allora
ārās [Link] di arasan, vb ft di I classe si alzò
he [Link] del pron di III pers egli
for Preposizione che regge vari casi per
scome Dat del sost ft femm scamu, tema in -o. vergogna
scamu>scome nasalizzazione
from þæm Preposizione + [Link] dal
symble [Link] di symbel (sincope vocalica) banchetto
ond ham Ham in questo caso non indica il sost e verso casa
'casa' ma ha valore avverbiale
eode [Link], vb deb II classe. andò
Il verbo andare, in gm, come il verbo
essere, è un vb a suppletismo radicale.
to preposizione a
his Gen di heo con valore possessivo sua
huse. Sost ft neutro, tema in -a. casa.
gm* husa<ie *keus “casa”
• Þa he þæt þā sumre tide dyde, þæt he forlēt þæt hus þæs gebeorscipes ond ut wæs gongende to nēata scipene,para
heord him wæs þære neahte beboden,þa he đa þær in gelimplice tide his leomu on reste gesette ond onslepte,þa stod
him summon æt þurh swefn ond hine halette ond grette ond hine be his noman nemnde:
Poichè egli fece questo in una certa occasione, che egli lasciò la casa della festa ed era uscito fuori verso la dimora del
bestiame, la cui custodia quella notte fu a lui assegnata, quando ad un certo punto egli le sue membra pose a riposo
e si addormentò,sllora apprve davanti a lui durante il sogno un certo uomo e lo salutò e lo chiamò per nome:
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
parola analisi traduzione
Þa Avv. o congiunzione causale Allora/poichè
he [Link] del pron di III persona. egli
þæt Acc. di se/þæt/seo neutro. ciò/questo
þā Avv. (eccessivo) . allora
sumre [Link] di sum, [Link] (flessione ft) in una certa
([Link] some)
gm* suma (-re è una desinenza dei
dativi).
tide [Link] di tid, [Link] ft, tema in -i, occasione
si tartta di un dativo di tempo.
dyde, [Link] di dōn, vb anomalo/atematico fece,
in -mi.
þæt Congiunzione esplicativa, spiega cosa che
ha fatto Cædmon
he [Link] del pronome di III pers egli
forlēt [Link] di forlætan, vb ft di VII classe lasciò
þæt Dimostratico/articolo la/quella
hus [Link] si hus, sost neutro, tema in -a. casa
gm* husa<ie *keus “casa”
þæs [Link] del dimostrativo/articolo della
gebeorscipes gen. sing, sost mach ft, tema in -i, festa
composto da:
gebeor, sost masch ft (convitato, oppure
birra);
scipe, suff utilizzato per nomi astratti.
ond ut cong+avv. di luogo (out) e fuori
wæs gongende Vb essere+ [Link] di gan (vb a era uscito
suppletismo radicale)
(in [Link] è un past perfect)
to prep+dat verso/per
nēata [Link] di neat, sost femm ft, del bestiame
tema in -a;
gm *nauta (au>ea sviluppo spontaneo
del dittongo gm)
scipene, Sost al nom la dimora
þara [Link] di se/þæt/seo della cui
heord [Link] tema in -o; custodia
gm *herdo (frattura)
([Link] ward)
him [Link] del pron di III pers a lui
wæs wæs beboden: costruzione passiva
wæs ha funzione di ausiliare.
þære Dat. sing femm di se/þæt/seo, funzione quella
dimostrativa
neahte Dat di niht, sost femm ft, tema in notte
consonante (metafonia e frattura)
gm *naht (frattura)
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
beboden, [Link] di beodan, vb ft di II classe fu assegnata
þa Congiunzione temporale quando
he [Link] del pron di III pers egli
đa avv allora
þær avv lì
In gelimplice tide avv al momento opportuno
his [Link] ricavato dal genitivo le sue
leomu [Link] ft membra
gm* limu (metafionia velare)
On reste On regge il dativo: A riposo
reste, sost ft (metafonia palatale)
gesette [Link] di satjan, vb deb pose
(il pret sarebbe dovuto essere gesettete)
ond onslepte, Vb composto, slepan: vb ft di VII classe e si addormentò
þa Avv. allora
stod stod regge æt stava in piedi
vb ft VI classe, standan (la nasale al pret
scompare)
him Dat sing del pron di III pers. a lui
sum [Link] (flessione ft); un certo
[Link] 'some'
mon Sost ft che non ha suffisso tematico uomo
(a/o alternanza data dalla nasale)
æt preposizione davanti
þurh preposizione durante
swefn Termine tipicamente poetico; il sogno
sost ft neutro, tema in -a.
ond hine [Link] del pron di iII pers e lo
halette halette ond grette: coppia sinonimica chiamò
[Link] di halettan, vb deb di I classe.
ond grette [Link] di gretan, vb deb di I classe. e salutò
ond hine [Link] del pron di iII pers e lo
be his Be regge il dat. e con il suo
noman [Link], tema in nasale il suo nome
nemnde: Pret di nemnan, vb debole lo chiamò:
• “Cedmonsing meHwæthwugu”. Þa ondswarede he ond cwæđ: “Ne con ic noht singan ond ic forþon of þeossum
gebeorscipe ut eode ond hider gewat, forþon ic naht singan ne cuđe.”
“Cedmon cantami qualcosa”. Allora egli rispose e disse: “Io non so cantare nulla e per questo io sono uscito da quel
banchetto, perchè non sapevo cantare nulla.
parola analisi traduzione
“Cedmon vocativo “Cædmon
sing Imperativo di singan, vb ft di III classe. canta
me [Link] del pron di I pers. a me
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
Hwæthwugu”. [Link] qualcosa”
Þa Avv. allora
ondswarede Antenato di 'answered' rispose
vb deb di II classe;
swarjan: rispondere solennemente,
giurare
he [Link] del pron di III pers lui
ond congiunzione e
cwæđ: Pret. di cwæđan, vb ft di V classe disse:
(alternanza grammaticale)
“Ne Abbondanza di negazioni in ingl.a; Non
con [Link] *can so
La n nasalizza la a in o,
verbo preterito presente cunnan
ic Nom sing del pron di I pers io
noht Altra negazione niente/affatto
singan Vb ft di III classe all'infinito cantare
ond congiunzione e
ic Nom sing del pron di I pers io
forþon Congiunzione causale perciò
of Prep che regge il dat. da
þeossum quel
gebeorscipe .. banchetto
ut Avv. di luogo fuori
eode [Link], vb deb II classe. sono venuto
Il verbo andare, in gm, come il verbo
essere, è un vb a suppletismo radicale.
ond congiunzione e
hider Avv. quaggiù
gewat, Pret vb ft di I classe sono venuto,
forþon Congiunzione causale perchè
ic Nom sing del pron di III pers sing io
naht negazione non
singan Vb ft di III classe all'infinito cantare
ne negazione niente
cuđe.” Pret del verbo preterito-presente sapevo
cunnan (cade la nasale davanti alla
spirale con allungamento di compenso).
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
TEDESCO ANTICO
“Tedesco antico” è una definizione d’insieme di tutti i dialetti germanici dell’area continentale (centrale), che abbraccia un
periodo di tempo che va dal 700 circa al 1000 circa e che include, oltre a varie aree dell’Europa centrale, parte del territorio
dell’attuale Germania.
Tale periodo antico della storia della lingua tedesca è inaugurato dalla realizzazione della Seconda Mutazione Consonantica
(700), nota anche come Mutazione Consonantica alto tedesca antica.
Quali sono questi popoli del “tedesco-antico”, dell'europa centrale? Sono:
• Sono i Germani del Reno-Weser [veza], ossia i Franchi. I Franchi si dividono in due grandi gruppi:
-Franchi Salii, vivevano lungo il basso Reno poi abbandonano la zona per spostarsi verso l'atuale Belgio. In quella
zona, Childerico, il primo sovrano di questo gruppo di Franchi, costituì il suo regno. Il regno è poi portato
all'espansione oltre il reno da Clodoveo, che si converte al cristianesimo e riesce ad avvicinare il suo popolo al mondo
politico e culturale romano-cristiano.
-Franchi Ripuari, stanziati sul corso del Reno centrale.
• Sono i Germani dell'Elba: Svevi, Alemanni e Bavaresi. Si stanziano nell'area della Germania meridionale.
Franchi, Svevi, Alemanni e Bavaresi sono i 4 gruppi dell'area della Germania. Li differenziamo da un punto di vista storico e
geografico e da un punto di vista linguistico (testimonianze). Tenere bene a mente che la Germania NON è un'unità politica
ma quel territorio dell'Europa centrale in cui si parlavano dialetti germanici occidentali. Tali dialetti si suddividono
principalmente in alto e basso tedeschi.
LA PAROLA “TEDESCO”.
Nella documentazione antica l'aggettivo “theodisk” significava “volgare”, lingua parlata dal popolo, l'equivalente del latino
“vulgaris”.
A partire dal IX sec, Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico firmano i Giuramenti di Strasburgo (842) che sanciscono la fine del
Sacro Romano Impero di Carlo Magno. I due sovrani si giurano fedeltà e alleanza ed ognuno esprime il giuramento nella
lingua dell'altro (seppur la sottoscrizione è in latino). Carlo si esprime in Theudiska lingua (tedesco) e Ludovico si esprime in
Germanica lingua (francese).
Quindi, a partire dal IX sec cambia il significato di tedesco.
CRONOLOGIA DELLA LINGUA TEDESCA-4 PERIODI PRINCIPALI:
1. Proto-alto tedesco, scarsa documentazione (perlopiù onomastica). Dal 600 all'800. Già visibile qualche traccia di SMC;
2. Periodo ATA. 700-800. Presenti tutti gli esiti della mutazione consonantica. Inizio della documentazione in volgare.
3. Alto-tedesco medio. Dal 1000 al 1400 circa. Si afferma una lingua letteraria e sopradialettale. Periodo delle opere cortesi.
4. Periodo moderno. Dal 1500 a oggi. (dal 1350 al 1650 fase del tedesco protomoderno).
I TESTI e LE GLOSSE
Testi di un certo rilievo sono documentati a partire dal IX sec, soprattutto nella Germania centro-meridionale, ma già nel
secolo precedente sono presenti le gosse in manoscritti latini di varia provenienza, sia come citazioni di denominazioni
germaniche relative ad oggetti e usi caratteristici, sia come aiuto per la traduzione e comprensione del testo latino.
Tali glosse rappresentano anche la documentazione relativa a popolazioni germaniche che non risiedevano nell'area
dell'odierna Germania: i Longobardi in Italia, i Franchi in Gallia, popoli che per le loro caratteristiche fonologiche possiamo
definire “tedeschi”.
CRONOLOGIA
1. Inizio della documentazione: VIII sec – IX sec: periodo antico.
Frammentarietà di dialetti e tradizioni grafiche; i principali criteri linguistici per distinguere questo periodo sono:
- SMC
- modificazione del vocalismo tramite:
la monottongazione di gm *ai/au in ē e ō;
la dittongazione di gm *ē² e ō in ia, uo, ua;
Inizio degli effetti della metafonia;
- graduale indebolimento delle vocali delle sillabe secondarie (atone)
- influsso del latino sul lessico e quindi ampliamento del patrimonio lessicale
- sopravvivenza dei vari dialetti, senza unità linguistica scritta.
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
2. XII sec – XV sec: periodo medio.
Con la letteratura e la civiltà cortese-cavalleresca si afferma una lingua letterari omogenea; i principali criteri linguistici per
distinguere questo periodo sono:
- aumento di fonemi vocalici per effetto di ulteriori metafonie;
- passaggio ad e della maggior parte delle vocali atone di sillabe secondarie;
- inizio della dittongazione di: i>ei ; u>au ; iu>au;
- forte influenza del francese antico sul lessico;
- costituzione di una lingua letteraria tedesco superiore e di una lingua di cancelleria (burocrazia).
STORIA E TRADIZIONE LETTERARIA
• La potenza del regno franco si deve alla politica di re Clodoveo che riuscì a imporsi su Burgundi, Visigoti ed Alemanni,
che consolidò tutto il potere nelle sue mani e che opportunamente convertì il suo regno al cattolicesimo. In questo
modo il popolo franco si inserì nel mondo politico e culturale romano-cristiano, di cui divenne difensore di fronte a
paganesimo ed eresia.
• Le popolazione al di là del Reno entrano nel mondo politico e culturale romano-cristiano solo con l'avvento al potere
dei Carolingi.
• Il legame con la Chiesa rappresentava uno strumento di consolidamento ed espansione politica. Vennero quindi
incoraggiati i missionari in Germania e la fondazione di monasteri.
• Figura fondamentale della cristianizzazione della Germania fu [Link] (prima metà dell'VIII sec). Autorizzato da
Roma, egli attuò una cristianizzazione completa, tenendo conto delle esigenze politiche dei regnanti della zona.
• Con la morte di Carlo Martello, Carlomanno il figlio si impossessò delle regioni orientali e sostenne l'attività di
Bonifacio. Con tale appoggio politico, Bonifacio riorganizzò tutta la chiesa franca.
• Il clero era legato più all'autorità politica che a quella del Papa, diventando spesso strumento diretto di dominio
politico.
• Arriva poi Carlo Magno e porta a termine la riorganizzazione politica e religiosa nella Sassonia settentrionale. Vennero
imposte pene severe a chi si rifiutava di praticare il nuovo culto e di abbandonare gli usi pagani.
• La politica autoritaria di Carlo Magno contribuì al risveglio culturale dell'Europa. Carlo Magno promosse gli studi,
l'attività letteraria e la valorizzazione del mondo classico.
• Carlo Magno crea un'accademia: Alcuino di York è chiamato alla sua corte per formare la scuola palatina e porta con
se manoscritti antichi e importanti per la riscoperta del mondo classico.
NASCITA DELLA CULTURA SCRITTA IN LINGUA TEDESCA
Negli ultimi anni del suo regno, Carlo Magno portò la sua attenzione alla tradizione germanica e promosse la traduzione in
tedesco antico di testi fondamentali della fede cristiana: Padre Nostro, regola benedettina, formula battesimale, Credo..
Inoltre sostenne la raccolta di carmi eroici germanici e la redazione di una grammatica del francone. Tale rivalutazione del
volgare continua anche dopo la morte di Carlo Magno.
A Fulda, direttamente in sassone e secondo lo stile della poesia germanica, viene composto lo Heliand: narrazione in versi
allitteranti della vicenda di Cristo;
nella Germania meridionale poi, nella prima metà del IX sec, viene composto il poemetto mutilo Muspilli, in versi allitteranti sul
giudizio universale, e il poema in rima sulla vita di Cristo di Otfrid di Weissenburg (prima opera di cui abbiamo il nome
dell'autore).
Carlo Magno e i carolingi fecero della classe ecclesiastica una classe potentissima, che ha monopolizzato tutta la cultura e la
vita letteraria.
Dopo Carlo Magno, la struttura politica da lui creata crolla e rimangono solo la classe ecclesiastica e monastica a supporto
della cultura.
LA RINASCITA OTTONIANA
Dopo la decadenza dei carolingi, il potere in Germania è nelle mani dell'alta nobiltà. Nacquero grandi ducati indipendenti
(ducato di Sassonia, di Baviera..). Nel 919, poi, re Enrico di Sassonia assume la corona e successivamente suo figlio Ottone I
restaura il Sacro Romano Impero.
La casa di Sassonia quindi restaura il concetto di impero e si interessa alle vicende d'Italia e della Roma dei Papi. La casa di
Sassonia legò il mondo tedesco a quello romano e tale operazione si riflette anche nella letteratura dell'epoca.
Nella metà del X sec, il poema Waltharius, esprime argomenti tipici germanici in esametri latini.
Fino all'XI sec, la poesia si esprime quasi esclusivamente in latino, mentre il tedesco è utilizzato per fini didattici.
Man mano però l'uso della lingua volgare tedesca si ampli, attraverso traduzioni di complesse opere filosofiche importanti del
mondo medievale.
Personaggio di rilievo di questo periodo è Nokter, autore di una vasta opera in volgare e traduttore. A lui si deve anche una
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
riflessione accurata sulla lingua tedesca. Il suo scopo è quello di rendere il testo accessibile ad allievi e lettori. Nokter fa
traduzioni molto precise e accurate, soprattutto per quello che riguarda traduzioni di difficili concetti teologici. Nokter traduce
solo quando è sicuro di riuscire a rendere bene il significato.
LA TRADIZIONE SCRITTA
La tradizione scritta comincia con le iscrizioni runiche (VI-VIII sec). Si tratta ovviamente di iscrizioni su oggetti che avevano uno
scopo pratico
POESIA IN VERSI ALLITTERANTI
Esiste anche in area tedesca una produzione in versi allitteranti, non ricca però quanto la tradizione anglosassone. L'unico
rappresentante è il Carme di Ildebrando, “Hìldebrandslied”, contenuto nel ms Kassel, un componimento poetico in alto
tedesco antico in versi allitteranti. Tema del componimento è lo scontro fra il vincolo di sangue e il vincolo d'onore:
Hildebrand e Hadubrand sono padre e figlio e parte di due eserciti nemici e si trovano costretti allo scontro in duello.
Altri esempi di poesia in versi allitteranti, non di tradizione germanica nei contenuti però, sono:
- la preghiera di Wssobrunn (ambito del tedesco superiore, molte tracce di SMC, soluzioni grafiche che rimandano all'area
anglosassone), contenuta nel ms Wien, sul tema della creazione. Il componimento è diviso in due parti: la prima in versi
allitteranti, la seconda in prosa ritmica allitterata.
- il Mùspilli (termine che probabilmente ha a che fare col giudizio finale), conservato nel ms che si trova a Monaco, IX sec. E'
un componimento di carattere religioso in versi allitteranti, diviso in due parti: la prima in cui si parla della lotta tra angeli e
demoni, la seconda in cui si parla della lotta di Elia con l'anticristo.
- Heliand, in sassone antico (variante nordica dell'attuale Germania), legato alla vicenda di Cristo sulla terra, che mostra
notevoli influenze lessicali e grafiche del mondo anglosassone; tra le fonti dello Heliand ci sono testi in anglosassone. L'origine
del testo è ancora controversa. Tra i mss che trasmettono il testo abbiamo: il ms London, British Library che trasmette quasi
l'intero componimento e il ms di Monaco, testimone più autorevole del poema (ð sia come fricativa interdentale sorda che
sonora).
- frammento della Genesi in volgare sassone antico, confrontabile con la Genesi in anglosassone
- formule magiche e benedizioni (Formule di Merseburgo); struttura bipartita: fatto storico+invocazione; testi molto brevi; si
invocano Odino e le Idisi.
- glossario (Vocabolario di [Link]).
- versione in alemanno della regola benedettina.
LA LINGUA ATA
- L'elemento che distingue il tedesco e i vari dialetti è l'attuazione della SMC. Sulla base degli esiti della SMC distinguiamo
innanzitutto due macro-aree: alto e basso tedesco e poi nell'area dell'alto tedesco, in base alle consonanti coinvolte nella
mutazione distinguiamo francone renano, orientale, alemanno, bavarese ecc. secondo delle linee che disegnano il Ventaglio
Renano.
- Da un punto di vista linguistico, il tedesco non presenta grosse difficoltà, neanche nel vocalismo. Le mutazioni del vocalismo
sono poche. (ē e ō dittongano in eu e ou, le vocali brevi tendono a scomparire, le lunghe tendono ad abbreviarsi..).
- Da un punto di vista morfologico, possiamo dire che i verbi ft mostrano desinenze distinguibili per i vari casi.
- Sintatticamente, l'ata, come quasi tutte le lingue gm, quando parliamo di poesia allitterante mantiene strutture sintattiche
germaniche, quando si parla di prosa (come avviene per l'ingl e il got) risente molto delle strutture sintattiche del testo latino
di partenza (forme verbali analitiche e non sintetiche)
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
ISLANDESE ANTICO – ANTICO NORDICO
La conoscenza del mondo nordico è fondamentale nello studio delle lingue germaniche, in quanto i testi nordici sono quelli
che più ci tramandano le tradizioni e la cultura germanica. L'inizio della tradizione manoscritta nel mondo nordico è piuttosto
tarda (Islanda e Norvegia XII sec – Svezia e Danimarca XIII sec), così come tardo è l'avvento del Cristianesimo e quindi
l'avvicinamento alla cultura romano-cristiana. Di conseguenza, il mondo nordico è rimasto non influenzato più a lungo e i
motivi dei suoi testi sono più germanici, più puri.
Tuttavia, i motivi germanici e quelli cristiani religiosi si amalgamano in maniera piuttosto armonica.
Oggi, l'islandese moderno è la lingua nordica che meno fa uso di prestiti linguistici ed è ancora conservativa, come lo fu in
passato.
PRODUZIONE LETTERARIA
- La maggior parte dei testi proviene dall'Islanda;
- la lingua letteraria per eccellenza è l'islandese antico, che in fase antica coincide con norvegese antico (il termine 'Norreno' fa
riferimento sia all'isl. che al norvegese);
- la tradizione letteraria è suddivisibile in 3 periodi:
1. periodo runico, dal V al IX sec, periodo caratterizzato da documenti in futhark antico (iscrizione epigrafiche);
2. periodo vichingo, dal IX all'XI sec, periodo in cui la serie runica va incontro ad una semplificazione; futhark recente (16
segni); in questo periodo fioriscono i generi di origine orale (poesia eddica e saghe);
3. periodo classico o norreno, dall'XI al XIV sec, periodo al quale risale tutta la documentazione manoscritta e durante il
quale l'islandese coincide con il norvegese. A partire dal XIV sec poi in Norvegia diventa lingua ufficiale il Danese
(lingua del potere). Le lingue nordiche sud-orientale sono Svedese e Danese.
STORIA
La storia del mondo nordico è collegata ai Vichinghi. La presenza di questo popolo è significativa perchè i Vichinghi sono
coloro che hanno messo in contatto il mondo scandinavo col resto d'Europa, grazie ai loro movimenti.
Altro elemento storico fondamentale è la colonizzazione dell'Islanda. Il sovrano norvegese Haraldr Harfagr ('Aroldo della
Chioma') a un certo punto decide di imporre la propria sovranità a tutta la Norvegia, non tenendo conto dell'originaria
organizzazione tribale delle popolazioni germaniche. I norvegesi si oppongono a questa volontà unificatrice e quindi
abbandonano la Norvegia e vanno a colonizzare l'Islanda. Si stanziano in Islanda e con loro portano lingua e tradizioni sociali.
L'ambiente islandese darà vita ad una straordinaria attività letteraria.
La più importante trasformazione nel mondo nordico si ebbe poi con l'avvento del Cristianesimo, che non introdusse
semplicemente un nuovo culto, ma una civiltà del tutto nuova ed estranea.
La conversione ufficiale avvenne intorno all'anno 1000, per decisione di un'istituzione germanica, un'assemblea che riuniva
tutte le tribù, la alþingi (þingus: assemblea) e per l'attività di Olafr il Santo, sovrano norvegese.
Gli islandesi non si convertono per un contatto diretto, con Roma o con i monaci della Chiesa, ma si convertono tramite
persone già convertite.
LA TRADIZIONE LETTERARIA
La tradizione scritta il lingua norrena si sviluppò con l'introduzione della lingua latina in Islanda e Norvegia, cioè a partire dal
XII sec.
I testi nordici sono per lo più traduzioni e testi di ispirazione pagana. Tale corpus è composto essenzialmente dalla poesia
eddica, dalla poesia scaldica e da una prosa di carattere storico, scientifico e soprattutto narrativo (che vede la sua espressione
migliore nelle saghe).
POESIA EDDICA
La poesia eroico-mitologica è contenuta in gran parte in un manoscritto del 1270 circa, detto Codex Regius, e denominato dal
suo scopritore 'Edda'. (Edda è anche il titolo dell'omonima opera in prosa di Snorri Sturluson, che ha anch'essa contenuto
mitologico).
L'Edda poetica e l'Edda di Snorri costituiscono le più importanti fonti di informazione che abbiamo sulla mitologia norrena.
Il nome 'Edda' forse fa rifermento al centro monastico di Oddi, in Islanda, dove i testi sono stati ricopiati per la prima volta,
oppure alla parola islandese 'odr' (poesia).
L'Edda è comunque una raccolta di 29 canti: 10 carmi mitologici (protagonisti sono le divinità germaniche) e 19 carmi eroici,
tutti anonimi.
Ad aprire la raccolta è un carme profetico-escatologico, dalla creazione della terra fino alla previsione apocalittica del
ragnarok. Seguono poi alcuni canti legati alle vicende di Odino e Thor, tra cui emerge l'Havamal.
L'Edda poetica è in versi allitteranti, il linguaggio è generalmente semplice e disadorno.
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
LA POESIA SCALDICA
I versi scaldici, a differenza di quelli eddici, sono complessi sia dal punto di vista della metrica che dei contenuti. Spesso erano
composti per omaggiare un particolare sire.
La poesia scaldica obbedisce a schemi rigidi, ad uno stile descrittivo, al virtuosismo metrico ed all'originalità di sinonimi e
metafore (kenningar).
Sempre a differenza dei canti eddici, i componimenti scaldici sono attribuiti a particolari autori.
LA PROSA
La letteratura norrena in prosa è particolarmente ricca.
Abbiamo opere storiche e soprattutto narrative. Il nucleo più importante è costituito dalle cosiddette Saghe Islandesi, saghe
che comunque narrano avvenimenti storici.
LA LINGUA NORRENA
In norreno le vocali avevano opposizione di quantità e per questo le vocali si possono considerare a coppie, ogni coppia
formata da una vocale breve e dalla vocale lunga corrispondente. Nell'ortografia si usa distinguere le vocali lunghe con un
accento acuto. Il fonema /æ/ è sempre lungo, il corrispondente lungo di /ɔ/ è ā.
Per quanto riguarda l'ortografia, la fricativa dentale sorda è diversa da quella sonora.
Metafonie palatali e velari avvengono, mentre la frattura in nordico interessa solo la vocale e che appare come ia o io.
Per quanto riguarda la morfologia, in nordico le desinenze tendono ad uniformarsi, persistono forme del duale, nel sistema
pronominale abbiamo delle innovazioni.
Per quanto riguarda la sintassi, si sviluppano forme analitiche. La sintassi norrena privilegia generalmente strutture molto
semplici (frasi coordinate > frasi subordinate). Molto frequente nello stile narrativo è il discorso diretto.
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
IL FRISONE
La lingua frisone è una lingua germanica appartenente al ramo germanico occidentale. I parlanti frisoni oggi rappresentano
una minoranza linguistica di fronte alle lingue nazionali tedesca e nederlandese, ma nei secoli passati essa aveva un'estensione
molto più ampia.
Oggi, la maggior parte dei parlanti vive nei Paesi Bassi, nella regione della Frisia.
STORIA
La storia dei frisoni fu segnata dalle lotte contro i Franchi, i quali introdussero il Cristianesimo. Lo stesso Bonifacio predicò nei
Paesi Bassi dove trovò il martirio proprio per mano dei Frisoni. La conversione si concluse poi con Carlo Magno, che incorporò
le popolazioni frisoni nel suo Impero. Con la fine dell'Impero carolingio, i Frisoni videro assottigliarsi i loro territori ma
acquistarono, tuttavia, una più solida individualità ed indipendenza. L'autonomia dei frisoni si basava orevalentemente sulla
solida tradizione giuridica, basata sull'antico diritto germanico. Nel XVI sec poi le potenze vicine, in particolare i Sassoni,
intralciano quest'indipendenza e introducono nella regione frisone i modelli del diritto romano, su cui si eggevano tutti gli altri
stati europei.
TRADIZIONE LETTERARIA
Le più antiche testimonianze in lingua frisone risalgono al XIII secolo e sono soprattutto testi giuridici in cui si documentano gli
usi, la vita e le istituzioni del popolo frisone. Ricordiamo le “17 disposizioni” e le “24 leggi della regione”, che non sono semplici
codici di leggi ma più che altro manuali ad uso dei magistrati.
La prosa giuridica talvolta contiene elementi tipici della poesia germanica, ad esempio l'allitterazione.
LA LINGUA FRISONE
Alcuni elementi della lingua frisone, come la caduta della nasale e l'allungamento di compenso della vocale precedente e la
forma unica per le persone plurali del presente, fanno si che il frisone sia linguisticamente più vicino all'anglosassone e al
sassone, che al tedesco (il frisone rientra nel gruppo delle lingue ingevoni).
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
I GERMANI IN ITALIA
Il periodo che riguarda la presenza dei Germani in Italia interessa più di quattro secoli, dal loro graduale inserimento nella vita
dell'Impero fino all'epoca delle vere e proprie invasioni e successivi insediamenti.
Si può affermare che gli invasori d'Italia, cioè soprattutto Goti e Longobardi, inserendosi in un ambiente profondamente
letterizzato, hanno usufruito di una situazione favorevole rispetto ad altri conquistatori germanici.
Il germanesimo in Italia non ha prevalso dal punto di vista culturale, né tanto meno linguistico, ma ha agito da superstrato.
Le uniche tracce linguistiche dei germani in Italia sono costituite da:
1. glosse contenute in testi storici o giuridici in lingua latina o in glossari bilingui;
2. elementi lessicali e morfologici penetrati nella lingua e nei dialetti italiani.
I PRIMI INSEDIAMENTI
La penetrazione dei Germani in Italia iniziò molto prima della caduta dell'Impero. Pensiamo ai Visigoti: invadono due volte
l'Italia agli inizi del V sec, minacciano la penisola ed impongono tributi, per poi tornare pochi anni più tardi al servizio
dell'Impero.
ODOACRE
NEL 476, il re degli Eruli, Odoacre (gli Eruli erano la componente principale di tribù germaniche entrate a servizio dell'Impero
romano in qualità di mercenari), depose l'ultimo imperatore romano d'Occidente, Romolo Augusto, si nominò Rex Italiae e
assunse il controllo dell'Italia. Il regno degli Eruli fu però di breve durata, scalzato nel 493 dagli Ostrogoti di Teodorico.
GLI OSTROGOTI
Gli ostrogoti penetrarono in Italia e si scontrarono più volte con Odoacre, sconfiggendolo definitivamente nel 493. Teodorico
ottenne il titolo di patricius da parte dell'Imperatore d'Oriente e governò in suo nome il regno degli Ostrogoti. Il regno di
Teodorico rappresentò per l'Italia un lungo periodo di pace e fioritura economica. Alla sua morte seguì un'era di decadenza ed
imbarbarimento dell'Italia. Per più di 20anni l'Italia fu devastata dalla guerra tra Goti e Bizantini, e alla fine Giustiniano sconfisse
i Goti.
I LONGOBARDI
Nel 568 i Longobardi, guidati da Alboino, mossero verso l'Italia, indebolita dalla recente Guerra gotica che aveva abbattuto il
regno ostrogoto e restaurata l'autorità imperiale. Le deboli difese bizantine in Italia caddero rapidamente, e i Longobardi
fondarono un proprio regno.
L'Italia si trovò divisa tra Longobardi e i Bizantini. I Longobardi si insediarono soprattutto in 3 zone della penisola: l'Italia
settentrionale dove Pavia assunse in ruolo di capitale, la Toscana e i territori centro-meridionali di Fermo, Spoleto e Benevento.
L'esercito bizantino aveva come fulcro Ravenna.
Tra i vari sovrani longobardi, Liutprando fu quello che regnò più a lungo. La sua politica accentratrice ridosse i possedimenti
bizantini. Dopo di lui, suo fratello Astolfo conquistò Ravenna, le sue campagne portarono i Longobardi a un dominio quasi
completo dell'Italia.
Nel frattempo, il Papa si alleò con i Franchi che discesero in Italia. Nel 754 i Franchi sconfissero i Longobardi, che dovettero
cedere dei territori. La guerra col papa riprese due anni dopo, il Papa di nuovo chiamò i Franchi in suo aiuto. Sconfitto di
nuovo, Astolfo dovette accettare patti molto più duri: Ravenna passò al papa, incrementando il nucleo territoriale del vaticano
e il re dovette accettare una sorta di protettorato.
Nel 771 la morte del fratello Carlomanno lasciò mano libera a Carlo Magno. Carlo Magno venne in aiuto del papa, scese in
Italia e conquistò la capitale del regno, Pavia. Carlo Magno riunì il regno franco e quello longobardo sotto la sua corona,
mantenendo le leggi dei longobardi ma riorganizzando il regno sul modello franco.
I Longobardi furono un popolo militare, con un re guerriero, non dinastico ma elettivo.
TRACCE LINGUISTICHE DEL GERMANESIMO IN ITALIA
LA LINGUA DEI GOTI
I Goti hanno certamente lasciato qualche traccia della loro lingua nell'onomastica italiana e nel lessico, anche se di minor
rilievo rispetto all'apporto linguistico dei longobardi.
Potrebbero essere di origine ostrogota alcuni termini quali: bega (lite), nastro, stecca, albergo (da hari-bergo: alloggio
dell'esercito). Si può notare che si tratta di tutti termini del linguaggio quotidiano, mentre mancano completamente etrmini di
ambio giuridico e amministrativo.
LA LINGUA DEI LONGOBARDI
Non abbiamo testimonianze scritte di questa lingua, poichè essa era affidata alla trasmissione orale.
Solo occasionalmente, in testi storici come l'Historia Langobardorum di paolo Diacono, o giuridici, come l'Editto di Rotari,
compaiono alcune parole longobarde che non hanno corrispettivo latino. L'uso di questa lingua in Italia è soppiantato dal
latino ma ancora oggi sia nell'italiano che nei dialetti regionali sopravvivono numerose tracce linguistiche della lingua dei
Longobardi.
Come per la lingua dei Goti, tali tarcce sono relative quasi esclusivamente al lessico. A differenza del gotico, però, questi
termini lessicali abbracciano vari campi semantici: campo giuridico e diritto germanico (es. faida: vendetta), sociale (dote),
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
lOMoARcPSD|9956491
politico (es. arimannus: uomo libero), quotidiano (bara, panca, schiena, stinco).
Tale situazione ha dato origine ad una vivace attività lessicografica, documentata dalla presenza di glosse e dalla
conservazione di tre glossari longobardi-latini.
Altra testimonianza importante della presenza linguistica dei longobardi in Italia è costituita dai nomi di persona (Aldo, Guido)
Numerosi sono anche i toponimi (pianura, sala).
Scaricato da Barbara Vardaro (barby99v@[Link])
Potrebbero piacerti anche
- Riassunto Di Filologia Germanica Di Molinari100% (2)Riassunto Di Filologia Germanica Di Molinari22 pagine
- PANIERE APERTE - Filologia Germanica (FINALE A Parte Le Traduzioni)Nessuna valutazione finoraPANIERE APERTE - Filologia Germanica (FINALE A Parte Le Traduzioni)73 pagine
- 09 de Bonis - Metafonia - Frattura 2015 PDFNessuna valutazione finora09 de Bonis - Metafonia - Frattura 2015 PDF18 pagine
- Elementi Di Linguistica Germanica DispensaNessuna valutazione finoraElementi Di Linguistica Germanica Dispensa191 pagine
- Docsity Riassunto Storia Romana Geraci Marcone 14Nessuna valutazione finoraDocsity Riassunto Storia Romana Geraci Marcone 14111 pagine
- Filol. Romanza Libro Profilo Delle LetteratureNessuna valutazione finoraFilol. Romanza Libro Profilo Delle Letterature21 pagine
- 05 de Bonis - L'Apofonia, Caratteristiche Generali PDFNessuna valutazione finora05 de Bonis - L'Apofonia, Caratteristiche Generali PDF5 pagine
- Riassunto Il Biondo Eckbert - Il Monte Delle RuneNessuna valutazione finoraRiassunto Il Biondo Eckbert - Il Monte Delle Rune6 pagine
- Riassunto Filologia Della Letteratura ItalianaNessuna valutazione finoraRiassunto Filologia Della Letteratura Italiana45 pagine
- RIASSUNTO "LE ORIGINI DELLE LETTERATURE MEDIEVALI ROMANZE" - Documenti GoogleNessuna valutazione finoraRIASSUNTO "LE ORIGINI DELLE LETTERATURE MEDIEVALI ROMANZE" - Documenti Google30 pagine
- Riassunto Manuale Di Filologia RomanzaNessuna valutazione finoraRiassunto Manuale Di Filologia Romanza39 pagine
- Propedeutica Al Latino UniversitarioNessuna valutazione finoraPropedeutica Al Latino Universitario12 pagine
- Alberto Varvaro - Avviamento Alla Filologia Francese Medievale100% (1)Alberto Varvaro - Avviamento Alla Filologia Francese Medievale22 pagine
- Quaderni Del Centro Mediterraneo Preclassico - Studi e Ricerche III (1) N. Bolatti Guzzo - S. Festuccia - M. Marazzi Edd. Naples 2013Nessuna valutazione finoraQuaderni Del Centro Mediterraneo Preclassico - Studi e Ricerche III (1) N. Bolatti Guzzo - S. Festuccia - M. Marazzi Edd. Naples 2013410 pagine
- 10 de Bonis - Isoglosse Parziali Tra Le Lingue Germaniche 2015 PDFNessuna valutazione finora10 de Bonis - Isoglosse Parziali Tra Le Lingue Germaniche 2015 PDF25 pagine
- Letteratura Latina. Storia e Antologia Di Testi, Giovanni Cipriani PDFNessuna valutazione finoraLetteratura Latina. Storia e Antologia Di Testi, Giovanni Cipriani PDF91 pagine
- Docsity Dispensa La Filologia Italiana Di Bausi FrancescoNessuna valutazione finoraDocsity Dispensa La Filologia Italiana Di Bausi Francesco39 pagine
- Estratto Di Conte Letteratura LatinaNessuna valutazione finoraEstratto Di Conte Letteratura Latina11 pagine
- Profilo Delle Letterature RomanzeNessuna valutazione finoraProfilo Delle Letterature Romanze4 pagine
- Storia Della Letteratura Inglese Dalle Origini Alla RestaurazioneNessuna valutazione finoraStoria Della Letteratura Inglese Dalle Origini Alla Restaurazione15 pagine
- Szemerényi, Introduzione Alla Linguistica Indoeuropea Parte 1100% (1)Szemerényi, Introduzione Alla Linguistica Indoeuropea Parte 149 pagine
- Risposte Domande Aperte Filologia GermanicaNessuna valutazione finoraRisposte Domande Aperte Filologia Germanica56 pagine
- DOMANDE APERTE - Filologia GermanicaNessuna valutazione finoraDOMANDE APERTE - Filologia Germanica37 pagine
- Latino e Gotico Nell'italia Del VI° SecoloNessuna valutazione finoraLatino e Gotico Nell'italia Del VI° Secolo10 pagine
- Filologia Germanica - Tradizione Letteraria Gotica e Inglese AnticoNessuna valutazione finoraFilologia Germanica - Tradizione Letteraria Gotica e Inglese Antico3 pagine
- Introduzione Al Gotico Atta UnsarNessuna valutazione finoraIntroduzione Al Gotico Atta Unsar4 pagine
- La Linguistica Testuale Dell'italianoNessuna valutazione finoraLa Linguistica Testuale Dell'italiano40 pagine
- W. Croft e A. Cruse - Linguistica Cognitiva (Riassunto)0% (1)W. Croft e A. Cruse - Linguistica Cognitiva (Riassunto)13 pagine
- Boitani e Di Rocco, Guida Allo Studio Delle Letterature ComparateNessuna valutazione finoraBoitani e Di Rocco, Guida Allo Studio Delle Letterature Comparate13 pagine
- Gnisci, La Letteratura Comparata 2Nessuna valutazione finoraGnisci, La Letteratura Comparata 229 pagine
- Fadda, Tradizioni Manoscritte e Critica Del Testo Nel Medioevo (Riassunto)Nessuna valutazione finoraFadda, Tradizioni Manoscritte e Critica Del Testo Nel Medioevo (Riassunto)75 pagine
- Breve Prontuario Di Prosodia e Di Metrica GrecaNessuna valutazione finoraBreve Prontuario Di Prosodia e Di Metrica Greca2 pagine
- Viaggi Di Ritorno, Itinerari Antropologici Nella Grecia AnticaNessuna valutazione finoraViaggi Di Ritorno, Itinerari Antropologici Nella Grecia Antica4 pagine
- Antonio Di Tuccio Manetti - La Novella Del Grasso LegniauoloNessuna valutazione finoraAntonio Di Tuccio Manetti - La Novella Del Grasso Legniauolo8 pagine
- Calvino - Sentiero Dei Nidi Di RagnoNessuna valutazione finoraCalvino - Sentiero Dei Nidi Di Ragno11 pagine
- Equipaggiamento Per Lo Storico Della Quarta DimensioneNessuna valutazione finoraEquipaggiamento Per Lo Storico Della Quarta Dimensione23 pagine
- 50 Misteri Da Risolvere PR Z LibraryNessuna valutazione finora50 Misteri Da Risolvere PR Z Library131 pagine
- O Testi Scritti e Testi Orali. Differenze Interazioni Intersezi Oni PDFNessuna valutazione finoraO Testi Scritti e Testi Orali. Differenze Interazioni Intersezi Oni PDF4 pagine
- KANT Critica Della Ragion PraticaNessuna valutazione finoraKANT Critica Della Ragion Pratica2 pagine
- La Storia Della Letteratura Di CordelNessuna valutazione finoraLa Storia Della Letteratura Di Cordel2 pagine
- Biancaneve. Fiabe Tradizionali in Inglese Per BambiniNessuna valutazione finoraBiancaneve. Fiabe Tradizionali in Inglese Per Bambini4 pagine