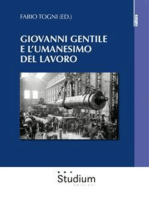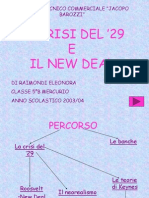Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Alienazione
Caricato da
pstrlTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Alienazione
Caricato da
pstrlCopyright:
Formati disponibili
www.matura.
it - la matura non ci fa paura
LALIENAZIONE
Il concetto varia a seconda del tempo e del contesto: nel Medioevo, Riccardo di San Vittore identific l'alienazione con il terzo grado dell'itinerario mistico della mente verso Dio, corrispondente alla dimenticanza delle cose finite e alla contemplazione del soprannaturale; affatto diverso l'uso che ne fece Rousseau, che vide nell'alienazione l'unica e sovrana clausola del contratto sociale, per cui l'individuo cede i propri diritti naturali alla comunit dando cos luogo alla formazione di una volont generale legislatrice. Hegel lo us nuovamente in un senso metafisico come un momento del processo che va dalla coscienza all'autocoscienza, e pi precisamente il momento in cui la coscienza si estrania da s e si considera una cosa. Tale momento per viene superato quando la coscienza scopre che gli oggetti fuori di s sono una sua creazione ed esprimono la sua stessa realt. Questo perdersi per ritrovarsi ha il suo epilogo (tutto positivo) nella consapevolezza totale. Altro filosofo che riflette sul concetto di alienazione Feuerbach. Questi vede nellalienazione un momento di perdita ed estraneazione da se. Per Feuerbach la causa dellalienazione delluomo da ricercarsi nella religione. Infatti nel fenomeno religioso luomo prende coscienza della propria essenza infinita e non di se in quanto individuo limitato.La religione nasce dallo squilibrio ontologico interno alluomo e piu precisamente tra lindividuo che radicalmente finito e lessenza che invece infinita.E proprio la consapevolezza di questa finitezza che spinge luomo a separarsi dalla propria essenza e a proiettarla fuori di se come unentita distinta e indipendente nella quale non riesce piu a riconoscersi. Un'interpretazione critica e uno sviluppo del concetto hegeliano di alienazione sono presenti in Marx. Questi rimprovera a Hegel di aver confuso L'obiettivazione, cio il farsi cosa dell'uomo attraverso il lavoro, e l'alienazione, cio lo smarrimento di s, la perdita di ci che proprio dell'uomo perch uomo. L'obiettivazione , in altre parole, momento positivo del processo che conduce alla realizzazione dell'unit dell'uomo e della natura; l'a. invece nello stesso processo un momento negativo, in quanto scinde tale unit (cos p. es. la religione e qui Marx ricorda Feuerbach scinde il rapporto tra l'uomo e i prodotti della sua volont). Al concetto di alienazione come perdita di s si rifanno molte correnti della filosofia contemporanea, in particolare l' esistenzialismo e il personalismo. II termine comunemente associato alla riflessione di Marx, che si serve della categoria di alienazione negli scritti filosofici giovanili in riferimento critico all'accezione propostane da Hegel. Se per questi, infatti, con alienazione sintende la separazione fra coscienza e realt empirica (oggettivazione dello spirito assoluto nella natura e nella storia), per Marx l'alienazione esprime la posizione dei soggetti sociali nella societ capitalistica divisa in classi. In particolare , in questo significato materialistico, lalienazione si applica alla condizione operaia. Nell'industria, il lavoratore
www.matura.it - la matura non ci fa paura
privato dei mezzi di produzione e di scambio e impossibilitato a controllare il ciclo produttivo di cui egli stesso diviene parte cedendo la propria forza lavoro in cambio del salario esprime in maniera esemplare la condizione alienata dell'intera umanit. Si tratta, perci, di un aspetto centrale e nevralgico della filosofia materialistica, le cui potenzialit critiche risultano peraltro ridimensionate dagli sviluppi maturi della produzione marxiana pi lontana dalla sua matrice filosofica e meno impegnata nella polemica antiidealistica delle opere giovanili e negli stessi contributi dei pensatori marxisti del Novecento. .
Caratteri della societ di massa
La maggior parte dei cittadini vive in grandi e medi agglomerati urbani: gli uomini entrano in rapporto tra loro con maggior frequenza. Il grosso della popolazione entrato nel circolo delleconomia di mercato come produttore o come consumatore di beni e di servizi. In questo periodo lindice della produzione industriale e quello del commercio mondiale raddoppiarono. Crebbe in misura ancor pi consistente anche il livello medio dei salari dei paesi industrializzati nonostante il cospicuo aumento della popolazione. Di conseguenza si determin lallargamento del mercato. Cominciarono i prodotti pi richiesti ad essere prodotti in serie ed essere venduti attraverso una rete commerciale sempre pi estesa e ramificata (nel 1913 Ford a Detroit la prima catena di montaggio). Tutto ci rendeva il lavoro ripetitivo e spersonalizzato. La categoria dei dipendenti pubblici si allargava di pari passo con laumento delle competenze dello stato e ancora pi rapidamente cresceva la massa degli addetti al settore privato che svolgevano mansioni non manuali (colletti bianchi). Un ruolo fondamentale nel plasmare i lineamenti della nuova societ fu svolto dalla scuola che costituiva in quel tempo unopportunit da cui nessuno doveva essere escluso, un servizio reso alla collettivit. Vi fu in quasi tutta Europa, in forme e in risultati diversi per paese, obbligo scolastico e calo dellanalfabetismo. Legato ai progressi dellistruzione ci fu lincremento della diffusione della stampa. Vi furono riforme degli ordinamenti militari: servizio militare obbligatorio, creazione di eserciti di massa (imposta dallevoluzione delle strategie delle tecniche militari, e la produzione in serie di armi). Nonostante esso portasse ad addestrare masse che sarebbero potute diventare rivoluzionarie e che le risorse finanziarie degli stati non erano sufficienti a mantenere tutti gli uomini giudicati abili sotto la leva, essi si crearono poich gli eserciti di massa servivano anche ad estendere la capacit di controllo dei poteri statali sulla societ civile e i grandi industriali interessati alle forniture militari fecero grandi pressioni sui governi. Il cammino verso la societ di massa si accompagn alla tendenza costante verso una pi larga partecipazione alla vita politica. Questo deriva
www.matura.it - la matura non ci fa paura
dal fatto che in vari paesi in diversi momenti vi fu unestensione del diritto di voto. Di conseguenza si afferm un nuovo modello di partito, proposto dai socialisti, basato sullinquadramento di larghi strati della popolazione attraverso una struttura permanente ed articolata in organizzazioni locali (sezioni e federazioni) e facente capo ad un unico centro diligente. In Europa occidentale quindi la vita politica non era pi considerata un terreno riservato a un gruppo ristretto di notabili in forza della loro posizione sociale. Ci fu anche una rapida crescita dellorganizzazione sindacali alle quali vi fu grande adesione.. Per quanto riguarda la legislazione sociale furono istituiti sistemi di assicurazione contro gli infortuni e di previdenza per la vecchiaia e anche sussidi per i disoccupati. Alla fine dell800 sorsero nei principali paesi europei dei partiti socialisti, che si inspiravano per lo pi al modello della socialdemocrazia tedesca e facevano capo alla Seconda Internazionale fondata nel 1889 nella quale fu fissato come obiettivo la giornata lavorativa di otto ore e il 1 maggio. Essa non era altro che una federazione di partiti nazionali autonomi e sovrani. Nella maggioranza di questi partiti il marxismo fu assunto come dottrina ufficiale. Si affacciarono presto tuttavia contrasti tra il revisionismo riformista di Berstein, gli esponenti dellortodossia marxista e le nuove correnti rivoluzionarie, tra le quali va ricordata quella "sindacalista rivoluzionaria" che aveva il suo maggiore ispiratore in Sorel. Col Lione XIII la chiesa favor limpegno dei cattolici in campo sociale stimolato soprattutto dallenciclica rerum novarum.
LUIGI PIRANDELLO: PROBLEMATICA SOCIALE ED ESISTENZIALE
Luigi Pirandello nacque a Girgenti, oggi Agrigento, il 28 giugno 1867 e fu tra gli scrittori italiani uno dei massimi drammaturghi del Novecento. Lesordio come poeta di Pirandello risale al 1889, con la pubblicazione di Mal Giocondo, nello stesso anno si laurea alluniversit di Bonn in filologia romanza. In seguito si dedico allinsegnamento della letteratura italiana, pubblicando nel 1894 le prime novelle, Amori senza amore. Nel 1901 pubblico il suo primo romanzoLesclusa che segna il passaggio dal modello narrativo verista allo stile umoristico, in altre parole ad una mescolanza fra tragico e comico, che da quel momento avrebbe caratterizzato la produzione pirandelliana. Nel 1903 lo scrittore si trovo improvvisamente in rovina e con la moglie in preda alla pazzia; risale a questo periodo la stesura del suo capolavoro Il fu Mattia Pascal. A questo romanzo seguirono altre opere, tra le quali spiccano: I vecchi e i giovani, Uno, nessuno, centomila, che rappresenta per molti aspetti una specie di consuntivo ideologico finale.
www.matura.it - la matura non ci fa paura
Pirandello nelle sue opere affronto come tema principale quello della problematica sociale ed esistenziale e nella prefazione al dramma Sei personaggi in cerca dautore ha cosi sintetizzato i punti principali della sua visione di questa tematica: linganno della comprensione reciproca fondato irrimediabilmente sulla vuota astrazione delle parole La molteplice personalita dognuno secondo tutte possibilita dessere che si trovano in ciascuno di noi. il tragico conflitto immanente tra la vita che di continuo si muove e cambia e la forma che la fissa immutabile Provando ad esplicare in altri termini il pensiero di Pirandello si puo asserire che egli evidenzia lincomunicabilit, la natura disgregata e molteplice del soggetto umano, la condanna della maschera che impedisce il libero fluire della vita.La concezione pirandelliana, si puo riportare ad una forma di relativismo, in altre parole, luomo coinvolto completamente in un sistema di convenzioni sociali che ne condizionano lespansione vitale. Ciascuno costretto, suo malgrado, ad assumere tante forme o maschere quanti sono i ruoli che gli sono imposti dagli altri.Ne deriva una condizione esistenziale perennemente alienata e in autentica, il dramma di unidentita infinitamente mutevole in quanto dipende da un giudizio estraneo e relativo. E conseguentemente, unaspirazione frustrata ad appropriarsi di unidentita diversa. Vista la mancanza di qualsiasi criterio razionale che possa dare un senso alla vita, luomo puo solo prendere atto della propria natura alienata ed estraniata e, come in uno specchio, guardarsi vivere, spiare il proprio doppio che agisce come una creatura senzanima, come un automa. Oppure sperimentare la tormentosa attivita dellautocoscienza, del sentirsi vivere, cercando di attribuire allinforme una forma mentale plausibile. In questo tentativo consiste per Pirandello la logica, che pero non puo inquadrare o dotare di senso le assurdita della vita.Le assurdit della vita-ricordera il padre nei Sei personaggi-non hanno bisogno di parer verosimili, perch sono vere. E significativamente Pirandello mostra nelle sue opere una particolare predilezione per il paradosso, per la soluzione il cui verificarsi risulta al limite dellimprobabile o sul punto di sconfinare nellassurdo. Il paradosso la forma piu espressiva per rendere la costituzionale inverosimiglianza della realta. In questo contesto diventa labile e precaria la distinzione tra ragione e follia. Se lesercizio della ragione si risolve in un farneticante sforzo di dare forma logica allassurdo, la follia la coerente ostentazione dellanomalia come norma del vivere. La rappresentazione pirandelliana dellassurdo non si caratterizza solamente sul piano esistenziale e metafisico. Esprime anche la fondamentale negativita della condizione sociale; il disagio del rapporto con le istituzioni e con le convenzioni, la penosa necessita di misurarsi con un sistema codificato di Forme artificiose, di falsita, dipocrisie. Questo sistema identificato nel modello della vita borghese.
www.matura.it - la matura non ci fa paura
Luniverso borghese ha offerto a Pirandello uno scenario esemplare in cui collocare i conflitti tra Forma e Vita. Ricorrente nelle sue opere la vicenda del personaggio borghese desideroso di cambiare identita e di rompere clamorosamente gli schemi, o intento a contestare il ruolo che gli stato imposto.
Potrebbero piacerti anche
- Singolarità e istituzione: Antropologia e politica oltre l'individuo e lo statoDa EverandSingolarità e istituzione: Antropologia e politica oltre l'individuo e lo statoNessuna valutazione finora
- Modernità e Metafisica - Leussein Rivista di studi umanistici anno III, n. 2Da EverandModernità e Metafisica - Leussein Rivista di studi umanistici anno III, n. 2Nessuna valutazione finora
- Karl Marx SintesiDocumento3 pagineKarl Marx SintesitotimaggyNessuna valutazione finora
- Marx SintesiDocumento9 pagineMarx SintesiMichela MaroniNessuna valutazione finora
- Althusser e LideologiaDocumento10 pagineAlthusser e LideologiaSalento E DintorniNessuna valutazione finora
- Marx AlienazioneDocumento2 pagineMarx AlienazioneElettra RizzottiNessuna valutazione finora
- Alienazione Religiosa in Hegel Feuerbach e MarxDocumento3 pagineAlienazione Religiosa in Hegel Feuerbach e MarxPierluigiPriscoNessuna valutazione finora
- Tesina Di Maturita Sull AlienazioneDocumento4 pagineTesina Di Maturita Sull AlienazioneamiiNessuna valutazione finora
- "Critica" Tra Hegel e MarxDocumento13 pagine"Critica" Tra Hegel e Marxmarx_dialectical_studies100% (1)
- Il Primo e Il Secondo WittgensteinDocumento2 pagineIl Primo e Il Secondo WittgensteinMarisa OmbraNessuna valutazione finora
- Bauman - PensieroDocumento5 pagineBauman - PensieroWilliamMorigiNessuna valutazione finora
- NietzscheDocumento7 pagineNietzscheEinstein TuveriNessuna valutazione finora
- Jean Jacques Rousseau - Schema Riassuntivo PDFDocumento2 pagineJean Jacques Rousseau - Schema Riassuntivo PDFBrandon CrossNessuna valutazione finora
- Marx Sul Lavoro (Commento A Una Pagina Dai Grundrisse)Documento6 pagineMarx Sul Lavoro (Commento A Una Pagina Dai Grundrisse)SalvatoreMurgiaNessuna valutazione finora
- Zygmunt BaumanDocumento6 pagineZygmunt BaumanGiorgio Matta100% (1)
- BergsonDocumento3 pagineBergsonMario LeoneNessuna valutazione finora
- Ludwig FeuerbachDocumento4 pagineLudwig FeuerbachGaia RoccoNessuna valutazione finora
- Marx (Abbagnano) Prima ParteDocumento9 pagineMarx (Abbagnano) Prima ParteSalvatoreMuroloNessuna valutazione finora
- Soren KierkegaardDocumento4 pagineSoren Kierkegaardykcul95Nessuna valutazione finora
- Feuerbach e MarxDocumento17 pagineFeuerbach e MarxCarlo MunariNessuna valutazione finora
- Riassunto - Corso Di Diritto PubblicoDocumento49 pagineRiassunto - Corso Di Diritto PubblicoDanNessuna valutazione finora
- Riassunto Marxismo PDFDocumento6 pagineRiassunto Marxismo PDFSimone MaucciNessuna valutazione finora
- SartreDocumento5 pagineSartreClaudio NWave100% (1)
- Parini e AlfieriDocumento4 pagineParini e AlfieriAngelica RussoNessuna valutazione finora
- ComteDocumento3 pagineComtenicolasgueraNessuna valutazione finora
- Globalizzazione Eurocentrismo e Storia Della LetteraturaDocumento10 pagineGlobalizzazione Eurocentrismo e Storia Della LetteraturaPier Paolo FrassinelliNessuna valutazione finora
- La Crisi Del 29 RiassuntoDocumento42 pagineLa Crisi Del 29 Riassuntolol_loleNessuna valutazione finora
- Conseguenze Politiche Della Seconda Rivoluzione IndustrialeDocumento4 pagineConseguenze Politiche Della Seconda Rivoluzione IndustrialeLuca ToralboNessuna valutazione finora
- Appunti Su FICHTEDocumento4 pagineAppunti Su FICHTEHayleyNessuna valutazione finora
- L'Evoluzione Del Pensiero Di LeopardiDocumento3 pagineL'Evoluzione Del Pensiero Di LeopardiChiara SantoroNessuna valutazione finora
- Io So PasoliniDocumento4 pagineIo So PasoliniEric VargasNessuna valutazione finora
- FichteDocumento2 pagineFichteAndreaCintiNessuna valutazione finora
- Critica Della Ragion PuraDocumento6 pagineCritica Della Ragion PuravaffansucaNessuna valutazione finora
- I Totalitarismi Del Novecento - Fascismo, Nazismo, StalinismoDocumento21 pagineI Totalitarismi Del Novecento - Fascismo, Nazismo, StalinismoCaruso GiovanniNessuna valutazione finora
- Società e Cultura Nell'età EllenisticaDocumento4 pagineSocietà e Cultura Nell'età EllenisticailarfNessuna valutazione finora
- Salvo Mastellone - Storia Della Democrazia in EuropaDocumento70 pagineSalvo Mastellone - Storia Della Democrazia in EuropaThomas TosiNessuna valutazione finora
- Zygmunt BaumanDocumento6 pagineZygmunt Baumanalfonso_belfioreNessuna valutazione finora
- SartreDocumento2 pagineSartreluiNessuna valutazione finora
- Kant (Schema)Documento9 pagineKant (Schema)nicolasgueraNessuna valutazione finora
- Colonialismo e ImperialismoDocumento29 pagineColonialismo e ImperialismoClaudia MarracciniNessuna valutazione finora
- Teorie Comunicazioni Di MassaDocumento20 pagineTeorie Comunicazioni Di MassaDaniela CoriNessuna valutazione finora
- Simposio (Dialogo) - WikipediaDocumento8 pagineSimposio (Dialogo) - WikipediafabromNessuna valutazione finora
- EspositoDocumento24 pagineEspositolvanzago100% (1)
- Tesina Storia 3Documento7 pagineTesina Storia 3poipear100% (1)
- La Filosofia Di Cartesio.Documento4 pagineLa Filosofia Di Cartesio.Anonymous FeqCyVNessuna valutazione finora
- Mappa Concettuale NietzscheDocumento5 pagineMappa Concettuale NietzscheMarco StefanelliNessuna valutazione finora
- Il Pensiero Abissale Dell'eterno Ritorno Vuole Liberare Le Cose Da Una Tragicità Senza RedenzioneDocumento8 pagineIl Pensiero Abissale Dell'eterno Ritorno Vuole Liberare Le Cose Da Una Tragicità Senza Redenzionemcc43100% (1)
- MarxDocumento7 pagineMarxDaniela CampoliNessuna valutazione finora
- La Fenomenologia Dello SpiritoDocumento7 pagineLa Fenomenologia Dello SpiritoBeatriceNessuna valutazione finora
- Derecin Lezioni Di Filosofia PDFDocumento484 pagineDerecin Lezioni Di Filosofia PDFCaruso Giovanni100% (1)
- MarxDocumento10 pagineMarxnicolasgueraNessuna valutazione finora
- Seneca Letteratura LatinaDocumento2 pagineSeneca Letteratura LatinaGiosinigaNessuna valutazione finora
- Storia - Europa e Mondo Inizio 900Documento1 paginaStoria - Europa e Mondo Inizio 900LucaHero93Nessuna valutazione finora
- SpinozaDocumento2 pagineSpinozaMarta BrunelloNessuna valutazione finora
- VERGADocumento6 pagineVERGABenedetta PiliaNessuna valutazione finora
- Appunti CartesioDocumento2 pagineAppunti Cartesiobla blaNessuna valutazione finora
- Storia Della CinaDocumento64 pagineStoria Della CinapstrlNessuna valutazione finora
- 8K45INV800RESPDocumento103 pagine8K45INV800RESPpstrlNessuna valutazione finora
- I DinosauriDocumento61 pagineI DinosauripstrlNessuna valutazione finora
- Coomaraswamy BuddhadottrinabuddhismoDocumento157 pagineCoomaraswamy Buddhadottrinabuddhismopstrl100% (1)
- ARETINODocumento103 pagineARETINOpstrlNessuna valutazione finora
- SantiDocumento163 pagineSantipstrlNessuna valutazione finora
- ElettraDocumento31 pagineElettrapstrlNessuna valutazione finora
- Le Parole Dei Dalai LamaDocumento85 pagineLe Parole Dei Dalai LamapstrlNessuna valutazione finora
- Guru Baba NanakDocumento65 pagineGuru Baba NanakpstrlNessuna valutazione finora
- Il Sonno e Il SognoDocumento42 pagineIl Sonno e Il SognopstrlNessuna valutazione finora
- I Novantanove Nomi Di DioDocumento89 pagineI Novantanove Nomi Di DiopstrlNessuna valutazione finora
- Microsoft AccessDocumento64 pagineMicrosoft AccesspstrlNessuna valutazione finora
- Lucrezia BorgiaDocumento40 pagineLucrezia BorgiapstrlNessuna valutazione finora
- ProtomartiriDocumento102 pagineProtomartiripstrlNessuna valutazione finora
- 02.pirandello (Sintesi)Documento7 pagine02.pirandello (Sintesi)nicolasgueraNessuna valutazione finora
- Teoria Del Dramma Moderno - SzondiDocumento8 pagineTeoria Del Dramma Moderno - SzondimarcoNessuna valutazione finora
- Regimi TotalitariDocumento10 pagineRegimi TotalitarimarcoartiacoNessuna valutazione finora
- Pirandello Mai Giocondo PDFDocumento20 paginePirandello Mai Giocondo PDFTommaso JacchiaNessuna valutazione finora
- Cotticelli EduardoDocumento12 pagineCotticelli EduardogiudisNessuna valutazione finora
- Ripasso Italiano Per La MaturitàDocumento5 pagineRipasso Italiano Per La MaturitàSofia Padova100% (1)
- FONTI Su Pirandello e Il Cinema A Cura Di Paola PopulinDocumento5 pagineFONTI Su Pirandello e Il Cinema A Cura Di Paola PopulinEleniRoumeliotouNessuna valutazione finora
- Luigi PirandelloDocumento4 pagineLuigi PirandelloDonatella Di GiulioNessuna valutazione finora
- ArabeschiDocumento196 pagineArabeschineobarroco71Nessuna valutazione finora
- Soluzione Tipologia A, Il Fu Mattia Pascal, Luigi PirandelloDocumento4 pagineSoluzione Tipologia A, Il Fu Mattia Pascal, Luigi PirandelloSkuola.net33% (3)
- Il Realismo Magico Oggi Sguardi IncrociaDocumento36 pagineIl Realismo Magico Oggi Sguardi IncrociaLuca PiccoloNessuna valutazione finora
- ITALIANODocumento39 pagineITALIANOSimone MihailovNessuna valutazione finora
- ITALIANO ESAME MaturitàDocumento5 pagineITALIANO ESAME Maturitàpaora paoraNessuna valutazione finora
- Interstellar e Il Vuoto CosmicoDocumento65 pagineInterstellar e Il Vuoto CosmicoAlessandra Arvonio JonasNessuna valutazione finora
- Pirandello e SvevoDocumento7 paginePirandello e SvevoFrancescaNessuna valutazione finora
- Shalom DPL 2017 TestiDocumento19 pagineShalom DPL 2017 TestiRedazione gonews.itNessuna valutazione finora
- Decadentismo e SimbolismoDocumento6 pagineDecadentismo e SimbolismopatriziaNessuna valutazione finora
- Pirandello Riassunto ConvertitoDocumento5 paginePirandello Riassunto ConvertitoeziaNessuna valutazione finora
- Le Caratteristiche Del Testo TeatraleDocumento14 pagineLe Caratteristiche Del Testo TeatraleTommaso De santisNessuna valutazione finora
- Luigi PirandelloDocumento4 pagineLuigi PirandelloDanieleCalìNessuna valutazione finora
- TesinaDocumento84 pagineTesinagabriele_pecchioliNessuna valutazione finora
- Ugo Foscolo Alessandro Manzoni Giacomo Leopardi Italo Svevo Luigi Lo Giovanni Verga Giosue Carducci Giovanni Pascoli Gabriele DAnnunzDocumento11 pagineUgo Foscolo Alessandro Manzoni Giacomo Leopardi Italo Svevo Luigi Lo Giovanni Verga Giosue Carducci Giovanni Pascoli Gabriele DAnnunzDarkMelpomene100% (1)
- QUADRO STORICO E CULTURALE Di PirandelloDocumento4 pagineQUADRO STORICO E CULTURALE Di PirandellokkNessuna valutazione finora
- Il Paesaggio Siciliano Topos LetterarioDocumento19 pagineIl Paesaggio Siciliano Topos LetterarioRiccardo PaceNessuna valutazione finora
- 2003 - L. Pirandello, Il Piacere Dell'onestàDocumento3 pagine2003 - L. Pirandello, Il Piacere Dell'onestàAlvise ZanardoNessuna valutazione finora
- Teatro PirandellianoDocumento13 pagineTeatro PirandellianoGiuseppe Prete100% (1)
- Italy - Docenti - Folio - 2017 A04 04 - Pattini Letture Allegato 1 PDFDocumento4 pagineItaly - Docenti - Folio - 2017 A04 04 - Pattini Letture Allegato 1 PDFLuca TeseoNessuna valutazione finora
- Tesina - La Crisi Delle Certezze - Nietzche, Pirandello, Paradossi MatematiciDocumento24 pagineTesina - La Crisi Delle Certezze - Nietzche, Pirandello, Paradossi MatematiciLory Caro67% (3)