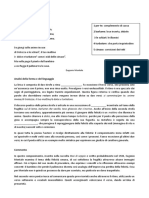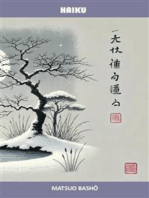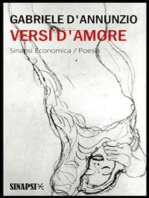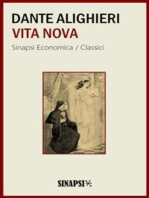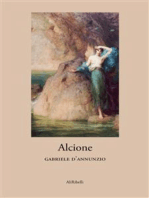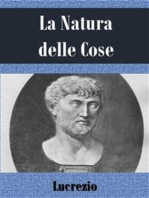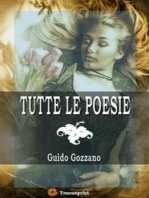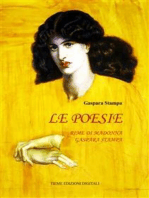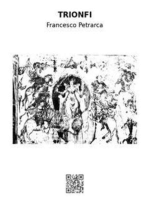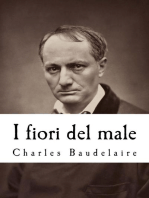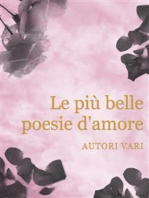Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
X Agosto
Caricato da
ANITA ZAULI0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
34 visualizzazioni2 pagineTitolo originale
X AGOSTO
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
TXT, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato TXT, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
34 visualizzazioni2 pagineX Agosto
Caricato da
ANITA ZAULICopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato TXT, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 2
X Agosto, Giovanni Pascoli.
PARAFRASI: San Lorenzo, io lo so perch� un cos� gran numero di stelle bruciano e
cadono, inondando il cielo in un pianto. Una rondine stava tornando al suo nido,
l�uccisero, cadde tra spini e nel becco aveva un insetto per i suoi rondinini. La
rondine ha le ali aperte posta come in una croce con il verme in bocca, e i
rondinini che pigolano nel nido, aspettando il cibo. Anche un uomo stava tornando a
casa, venne ucciso e perdon� il suo assassinatore e con gli occhi aperti portava
due bambole in dono. E nella casa abbandonata lo aspettano in vano, e lui fermo e
attonito con gli occhi aperti e due bambole in mano. Tu Cielo che sei infinito,
immortale da una condizione di felicit�, tu inondi questo atomo opaco del Male con
un pianto di stelle.
ANALISI DEL TESTO: La poesia � formata da 6 strofe, i versi sono raggruppati in
quartine formata ognuna da due endecasillabi e due novenari, i versi sono in rima
alternata con uno schema metrico abab. Ci sono varie figure metriche di significato
come ad esempio abbiamo una similitudine tra la rondine e l�uomo, entrambi colpiti
da un fatto catastrofico, la morte. Un�altra similitudine un po� pi� nascosta �
quella tra Pascoli e Ges�, ci sono molti riferimenti come ad esempio nel titolo la
X ricorda la croce, oppure cadde tra spini nel secondo verso della seconda strofa,
il suo nido � nell�ombra e come in croce nella terza strofa primo e terzo verso.
Infine nella quinta strofa e terzo e quarto verso abbiamo un enjambement con addita
le bambole. Poi nella prima strofa abbiamo proprio nel primo verso un�apostrofe con
San Lorenzo. La lirica fa parte della raccolta Myricae ed il titolo �X Agosto� non
vuole rievocare i fenomeni della notte di San Lorenzo, ma in particolare quel
giorno rievoca in Pascoli la morte del padre, ucciso il 10 agosto 1867 in
circostanze mai ben chiare. Presenta un anda mento circolare infatti il tema del
pianto viene proposto all�inizio del componimento ed anche al termine di esso.
Ritroviamo frequenti le figure retoriche tipiche di Pascoli (personificazioni,
metafore, allitterazioni, similitudini), l�uso di una sintassi spezzata e
l�ambientazione in un quadretto naturalistico. Particolare invece sono la seconda e
quarta strofa dove l�autore crea uno scambio tra termini usati in ambito animale e
termini usati per gli uomini. Si nota anche una forte differenza tra i linguaggi
usati: �rondinini� termine usato dai bambini invece �romita� termine pi� elaborato
e poco conosciuto.
TEMI: La figura della morte viene rievocato pi� volte nel testo, ma in particolare:
nella terza strofa �come in croce� che rimanda alla morte di Cristo anch�esso morto
innocente sia come la rondine, ma soprattutto come il padre di Pascoli
nell�ultimo verso �quest'atomo opaco del Male� che rende questo componimento molto
pi� tragico con un termine quasi di memoria leopardiana e trasmette un senso di
lontananza, indifferenza e di un paesaggio non ben definito (Impressionismo
pascoliano).
RIASSUNTO: La poesia si apre descrivendo l�ambientazione temporale: � il 10 agosto
cio� la notte di San Lorenzo, giornata in cui in genere si manifesta la quantit�
massima di caduta delle stelle. In questo suggestivo paesaggio c�� una rondine che
sta tornando nel suo nido per dare da mangiare ai suoi piccoli; d�un tratto � stata
uccisa ed � caduta a terra con ancora il verme in bocca e i suoi figlioli
pigoleranno sempre pi� a piano fino a morire di fame. Anche un uomo per� stava
tornando a casa e come la rondine d�un tratto viene ucciso; anche lui portava con
s� un regalo per le sue figlie. E� riverso a terra, e nella loro casa lo stanno
aspettando inutilmente. Intanto la caduta delle stelle continua, senza fermarsi
davanti a nulla, ad inondare la Terra oscurata dal Male.
SINTASSI: Pascoli fa un uso molto abbondante della punteggiatura che gli permette
di avere una coordinazione fra i versi e un ritmo pi� sostenuto e pi� veloce, come
possiamo vedere nella quarta strofa della poesia.
COMMENTO: Ecco un esempio di trasfigurazione della realt� in "simbolo": le stelle
cadenti non sono viste nella loro realt� scientifica di meteore che s'infiammano a
contatto con l'atmosfera, ma come pianto del cielo. Il dieci agosto, giorno di San
Lorenzo, per Pascoli � una data dolorosa perch� gli ricorda la morte del padre
Ruggero, assassinato mentre tornava dal mercato di Cesena. � questo il motivo
centrale della lirica. Nella notte di San Lorenzo una strana pioggia cade dal
cielo: una pioggia di stelle. Il poeta, quasi rispondendo alla sorpresa di chi non
sa spiegarsi il meraviglioso fenomeno, afferma con sicurezza: �Io lo so perch�; ma
prima di rivelarlo, racconta una favola allegorica (apologo), quello della rondine
innocente uccisa da un malvagio, e l'assassinio di un uomo. Chi conosce il fatto
luttuoso che grav� sull'adolescenza, anzi su tutta la vita del Pascoli, comprende
subito a che cosa vuole alludere; anzi, a questo punto, il riferimento � tanto
evidente che quasi si potrebbe considerare superflua la rievocazione della morte
tragica del padre; ma per il poeta il fatto � troppo grave per non ritornarvi con
precisione di minuti e toccanti particolari. Egli, ora che ha rivelato la malvagit�
degli uomini, pu� spiegare apertamente il significato del pianto di stelle, che fin
dall'inizio della lirica ha detto di conoscere: piange, il Cielo, sul male che
rende buia la terra, e piange con lacrime di luce perch� si uccidono gli innocenti:
una rondine che aveva nel becco un insetto la cena dei suoi rondinini e un padre
che portava alle sue bambine due bambole in dono.Vi sono anche riferimenti
religiosi: la rondine che muore con le braccia aperte come in una croce � il padre
che perdona coloro che lo hanno ucciso, la croce � presente anche nella lettera "X"
nel titolo della poesia. Il fenomeno naturale che si verifica nella tranquilla sera
estiva finisce per denunciare la legge di sofferenza e d'ingiustizia che sconvolge
l'umanit�.
FIGURE RETOTICHE: Apostrofe: San Lorenzo (v. 1) = il poeta si rivolge al santo
celebrato il 10 agosto, anniversario dell'assassinio del padre. Enjambement: -
tanto/di stelle (v. 1-2) - tende/quel verme (vv. 9-10) - addita/le bambole (vv. 19-
20) - mondi/sereni (vv. 21-22) - inondi/quest'atomo (vv. 23-24). Sineddoche: al
tetto (v. 5) = invece di dire al suo nido. Allitterazioni: - vv. 1-2, v. 5, v. 12,
v. 19, v. 24. Personificazioni: - Cielo e Male (vv. 21; 24). Anastrofe: ritornava
una rondine al tetto = il soggetto inserito dopo il verbo (v. 5). Similitudini: -
come in croce. Metonimia - il suo nido che pigola (v. 11) - al suo nido (v. 13)
Metafore: - perch� si gran pianto = le stelle che cadono diventano il simbolo del
pianto (v. 3) - d'un pianto di stelle (v. 23) - quest'atomo opaco del Male (v.24) =
indica la Terra. Consonanza: - 1� e 2� Strofa consonanza della lettera L - 2�
Strofa consonanza della lettera R. Sinestesie: - rest� negli aperti occhi un
grido (v. 15). Assonanza: arde e cade. Anafora: - Ora � l� (vv. 9 e 17) =
evidenziano il parallelo tra le due morti, quella della rondine e quella del padre.
Anadiplosi: lo aspettano, aspettano in vano (v. 18) = la ripetizione del verbo
indica l'angoscia dell'attesa.
Potrebbero piacerti anche
- X AgostoDocumento4 pagineX AgostoPasquale VinoNessuna valutazione finora
- Giovanni Pascoli - X AgostoDocumento3 pagineGiovanni Pascoli - X AgostoeziaNessuna valutazione finora
- X AgostoDocumento7 pagineX AgostoItz.Noi.RofelicoviNessuna valutazione finora
- Nuova Nota 2023-01-09 17-23-56Documento5 pagineNuova Nota 2023-01-09 17-23-56Elettra Di NoceraNessuna valutazione finora
- PascoliDocumento1 paginaPascoliSimone CagnazzoNessuna valutazione finora
- LE POESIE Interrogazione Di ItalianoDocumento7 pagineLE POESIE Interrogazione Di ItalianoGiuseppe ListaNessuna valutazione finora
- Testi Pascoli e D'AnnunzioDocumento3 pagineTesti Pascoli e D'Annunziofederica0505Nessuna valutazione finora
- RIASSUNTO Principali Poesie Di PascoliDocumento2 pagineRIASSUNTO Principali Poesie Di PascoliFab ioNessuna valutazione finora
- Pascoli Tre Poesie 3Documento9 paginePascoli Tre Poesie 3maria rossiNessuna valutazione finora
- PoesiaDocumento5 paginePoesiaEsterNessuna valutazione finora
- Analisi e Commento Della Poesia "Temporale"Documento3 pagineAnalisi e Commento Della Poesia "Temporale"Anna CivaleNessuna valutazione finora
- Leopardi CantiDocumento6 pagineLeopardi CantilucioNessuna valutazione finora
- Tesina Cavalli Elia AfeltraDocumento30 pagineTesina Cavalli Elia AfeltraANNA GALLONessuna valutazione finora
- Petrarca 2Documento5 paginePetrarca 2Beatrix KovácsNessuna valutazione finora
- A ZacintoDocumento2 pagineA ZacintoIlaria NotaristefanoNessuna valutazione finora
- Poesie Parte DueDocumento2 paginePoesie Parte DueMartina BortolottiNessuna valutazione finora
- X Agosto Di PascoliDocumento2 pagineX Agosto Di PascoliMauroNessuna valutazione finora
- Appunti Su Pascoli e La Sua PoeticaDocumento2 pagineAppunti Su Pascoli e La Sua PoeticaVincenzo CannoneNessuna valutazione finora
- Il LampoDocumento3 pagineIl LampoGiorgio ButtittaNessuna valutazione finora
- Il Linguaggio Di PascoliDocumento6 pagineIl Linguaggio Di Pascoliapi-285399009Nessuna valutazione finora
- Giovanni PascoliDocumento8 pagineGiovanni PascolivalentinaNessuna valutazione finora
- PoesiaDocumento46 paginePoesiaAnonymous hA5GhBNessuna valutazione finora
- Testi D'annunzioDocumento6 pagineTesti D'annunzioChiara RizzoNessuna valutazione finora
- Pascoli LassiuoloDocumento4 paginePascoli LassiuoloMarco CannavacciuoloNessuna valutazione finora
- Breve Storia Opera LiricaDocumento6 pagineBreve Storia Opera LiricabesciamellaNessuna valutazione finora
- Pascoli e Roba Varia Ed EventualeDocumento4 paginePascoli e Roba Varia Ed EventualeGiulianoNessuna valutazione finora
- Arano - PascoliDocumento5 pagineArano - PascoliAlessandra RacugnoNessuna valutazione finora
- Alessandro MartinisiDocumento6 pagineAlessandro MartinisiEsonet.orgNessuna valutazione finora
- Trucheck - It A Zacinto (Ugo Foscolo)Documento3 pagineTrucheck - It A Zacinto (Ugo Foscolo)Mlle FrancaiseNessuna valutazione finora
- Letteratura IngleseDocumento7 pagineLetteratura IngleseAnnamaria DuranteNessuna valutazione finora
- Commento Sonetto FoscoloDocumento3 pagineCommento Sonetto FoscoloDelViva RicoNessuna valutazione finora
- QuadritticoDocumento3 pagineQuadritticosesso nudoNessuna valutazione finora
- A ZacintoDocumento11 pagineA ZacintoBeatrice SanavioNessuna valutazione finora
- Svevo e LeopardiDocumento8 pagineSvevo e Leopardis9fqcbmmypNessuna valutazione finora
- Il TuonoDocumento5 pagineIl TuonogiaiselNessuna valutazione finora
- Il TemporaleDocumento7 pagineIl TemporaleGiorgio ButtittaNessuna valutazione finora
- Analisi Del Testo, Il Lampo, Pascoli.Documento4 pagineAnalisi Del Testo, Il Lampo, Pascoli.angycassy10Nessuna valutazione finora
- Pascoli - ItalianoDocumento5 paginePascoli - ItalianoMatteo GiordaniNessuna valutazione finora
- AlcyoneDocumento9 pagineAlcyoneLudixNessuna valutazione finora
- Pianto Antico (Commento)Documento2 paginePianto Antico (Commento)Carlotta ValenteNessuna valutazione finora
- X Agosto QuestionarioDocumento1 paginaX Agosto QuestionarioMauro0% (1)
- Pianto Antico - CarducciDocumento3 paginePianto Antico - CarducciAlessandra RacugnoNessuna valutazione finora
- Analisi DellassiuoloDocumento5 pagineAnalisi Dellassiuoloamalia de biaseNessuna valutazione finora
- X AgostoDocumento1 paginaX AgostoNicolaNipolinoNessuna valutazione finora
- BARRAUD Henry - Rake Progress - Avant Scene Opera - 1992 n.145Documento36 pagineBARRAUD Henry - Rake Progress - Avant Scene Opera - 1992 n.145ju15loNessuna valutazione finora
- Foscolo SonettiDocumento21 pagineFoscolo SonettiEnricoZampaNessuna valutazione finora
- PETRARCADocumento6 paginePETRARCAYllka KosumiNessuna valutazione finora
- Marchese - Analisi Di A ZacintoDocumento12 pagineMarchese - Analisi Di A ZacintoFrancesco TucciNessuna valutazione finora
- Appunti 10b OK Sinfonia Fantastica ProgrammaDocumento2 pagineAppunti 10b OK Sinfonia Fantastica ProgrammaEuridice PezzottaNessuna valutazione finora
- Autori Letteratura ItalianaDocumento6 pagineAutori Letteratura ItalianaFedericaNessuna valutazione finora
- La Poesia "X Agosto" Di Pascoli È Parte Della Raccolta Della MirmicaeDocumento1 paginaLa Poesia "X Agosto" Di Pascoli È Parte Della Raccolta Della MirmicaeLucia LoivissaNessuna valutazione finora
- NOSSIDE DI LOCRI Epigrammi Testo Greco ADocumento43 pagineNOSSIDE DI LOCRI Epigrammi Testo Greco AMariaNessuna valutazione finora
- BaudelaireDocumento8 pagineBaudelaireLAURA LUDOVICA DIANANessuna valutazione finora
- Il Mito Di Arianna e Il Melodramma BaroccoDocumento6 pagineIl Mito Di Arianna e Il Melodramma BaroccoValeria La GrottaNessuna valutazione finora
- Histoire Du Soldat, Una Favola in MusicaDocumento7 pagineHistoire Du Soldat, Una Favola in MusicaLuigi Lillo CipolloneNessuna valutazione finora
- Jacopo SannazaroDocumento11 pagineJacopo SannazaroNatalia DangeloNessuna valutazione finora
- Analisi Testuale Da StampareDocumento2 pagineAnalisi Testuale Da StampareAmal YamaroNessuna valutazione finora
- P. Gibellini, L'Impaziente Odisseo. Ulisse Nella Poesia Del '900Documento3 pagineP. Gibellini, L'Impaziente Odisseo. Ulisse Nella Poesia Del '900rabidusutventusNessuna valutazione finora
- Felicità RaggiuntaDocumento1 paginaFelicità RaggiuntaMarco CosentinoNessuna valutazione finora
- Paola Manni La Lingua Di Dante PDFDocumento19 paginePaola Manni La Lingua Di Dante PDFLaura RamosNessuna valutazione finora
- Ilport 49Documento52 pagineIlport 49disconnessoNessuna valutazione finora
- Riassunto Il Modernismo ItalianoDocumento7 pagineRiassunto Il Modernismo ItalianoMarikaNessuna valutazione finora
- (Ivan Bunin) Opere. Campagna, Valsecca, Una Bella PDFDocumento731 pagine(Ivan Bunin) Opere. Campagna, Valsecca, Una Bella PDFLuis O. Brea Franco100% (1)
- PLAUTODocumento8 paginePLAUTOJessica JohnsonNessuna valutazione finora
- Il NovecentoDocumento19 pagineIl NovecentoMichela AnnoniNessuna valutazione finora
- Coro Atto III AdelchiDocumento4 pagineCoro Atto III AdelchiFilippo FirenzuoliNessuna valutazione finora
- Chiarini Ombre e FigureDocumento474 pagineChiarini Ombre e FigurealdosciNessuna valutazione finora
- Dispensa Letteratura Araba PDFDocumento12 pagineDispensa Letteratura Araba PDFWei WeiNessuna valutazione finora
- Lucilla Spetia - Alle Origini Della Pastorella, Un Genere PopolareDocumento15 pagineLucilla Spetia - Alle Origini Della Pastorella, Un Genere PopolareEnzo Jesus Santilli0% (1)
- Il TuonoDocumento5 pagineIl TuonoGiorgio ButtittaNessuna valutazione finora
- LAVANDAR1Documento3 pagineLAVANDAR1ebexuti-5047Nessuna valutazione finora
- I Colori Dell'amore - Racconti Del NovecentoDocumento35 pagineI Colori Dell'amore - Racconti Del NovecentoPatricia Hartman BonocielliNessuna valutazione finora
- Solo e PensosoDocumento2 pagineSolo e Pensosodavis2aNessuna valutazione finora
- Le Odi OrazioDocumento4 pagineLe Odi OrazioArcangelo FiordellisiNessuna valutazione finora
- Francesco RoncenDocumento37 pagineFrancesco RoncenL Gio GraciaNessuna valutazione finora
- AUTORITRATTO ManzoniDocumento7 pagineAUTORITRATTO ManzonisoniaNessuna valutazione finora
- 12 AnceschiDocumento2 pagine12 AnceschiPasquale AielloNessuna valutazione finora
- La Lirica BaroccaDocumento26 pagineLa Lirica BaroccaAnonymous a49Xzs7Nessuna valutazione finora
- Il Medioevo - A Cura Di Emilio Piccolo PDFDocumento219 pagineIl Medioevo - A Cura Di Emilio Piccolo PDFprofeta1955Nessuna valutazione finora
- MAZZONIDocumento15 pagineMAZZONIGiovanna CobinoNessuna valutazione finora
- Marziale Appunti e Testi ImportantiDocumento26 pagineMarziale Appunti e Testi ImportantiAndreaFabrisNessuna valutazione finora
- Storia Della Letteratura Greca RiassuntoDocumento89 pagineStoria Della Letteratura Greca RiassuntoAlvaro75% (4)
- Iii.b-D.a.d. Italiano G.ungaretti-Analisi - TestiDocumento8 pagineIii.b-D.a.d. Italiano G.ungaretti-Analisi - TestiArcangelo FiordellisiNessuna valutazione finora
- Dan Octavian Cepraga, Eteroglossia e imitazione sperimentale: la poesia italiana di Gheorghe Asachi, in Scrittori stranieri in lingua italiana dal Cinquecento ad oggi, a cura di Furio Brugnolo, Unipress, Padova, 2009, pp. 215-31.Documento17 pagineDan Octavian Cepraga, Eteroglossia e imitazione sperimentale: la poesia italiana di Gheorghe Asachi, in Scrittori stranieri in lingua italiana dal Cinquecento ad oggi, a cura di Furio Brugnolo, Unipress, Padova, 2009, pp. 215-31.danoctavian.cepraga7220% (1)
- Cromatismi Nella Lirica TrobadoricaDocumento26 pagineCromatismi Nella Lirica TrobadoricaMarco Di CaprioNessuna valutazione finora
- Poesie e Canzoni-I Einaudi - Brecht BertoltDocumento136 paginePoesie e Canzoni-I Einaudi - Brecht BertoltRosso MalpeloNessuna valutazione finora
- Luciano Formisano - La Lirica (Pp. 01-256)Documento53 pagineLuciano Formisano - La Lirica (Pp. 01-256)Enzo Jesus Santilli100% (2)
- The Inferno of Dante: A New Verse Translation, Bilingual EditionDa EverandThe Inferno of Dante: A New Verse Translation, Bilingual EditionValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (65)
- Versi d'amore: Canto novo, Intermezzo di rime, Isaotta Guttadauro, Elegie romane, Poema paradisiacoDa EverandVersi d'amore: Canto novo, Intermezzo di rime, Isaotta Guttadauro, Elegie romane, Poema paradisiacoNessuna valutazione finora
- Tutte le poesie (La via del rifugio, I colloqui, Le farfalle, Poesie sparse)Da EverandTutte le poesie (La via del rifugio, I colloqui, Le farfalle, Poesie sparse)Nessuna valutazione finora
- I fiori del male: Con la prefazione di T. Gautier e l'aggiunta di studi critici di Saint-Beuve, c. Asselinéau, b. D'aurevilly, e. Deschamps, eccDa EverandI fiori del male: Con la prefazione di T. Gautier e l'aggiunta di studi critici di Saint-Beuve, c. Asselinéau, b. D'aurevilly, e. Deschamps, eccNessuna valutazione finora
- Pascoliana: 11 capolavori poetici e Il fanciullinoDa EverandPascoliana: 11 capolavori poetici e Il fanciullinoNessuna valutazione finora