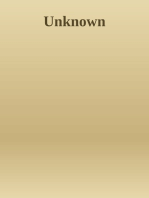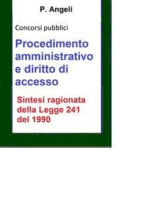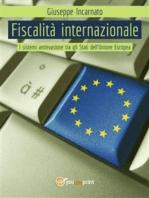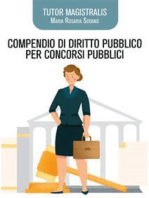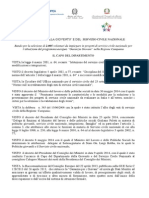Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Strozzi PG 32 Pag
Strozzi PG 32 Pag
Caricato da
Salvatore CascellaCopyright:
Formati disponibili
Potrebbero piacerti anche
- Riassunto Diritto Unione Europea Adam Tizzano PDFDocumento58 pagineRiassunto Diritto Unione Europea Adam Tizzano PDFRoccotanosiff100% (3)
- Riassunto Diritto Unione Europea Adam Tizzano PDFDocumento58 pagineRiassunto Diritto Unione Europea Adam Tizzano PDFRoccotanosiff100% (3)
- Riassunto Unione Europea StrozziDocumento45 pagineRiassunto Unione Europea StrozziEleonora MattioliNessuna valutazione finora
- Costituzionale - Barbera-FusaroDocumento20 pagineCostituzionale - Barbera-Fusarothementalist90Nessuna valutazione finora
- Diritto Amministrativo SimoneDocumento31 pagineDiritto Amministrativo SimoneAndrea SpadoniNessuna valutazione finora
- Riassunto Diritto Internazionale PrivatoDocumento30 pagineRiassunto Diritto Internazionale PrivatoLilith993100% (1)
- Dispense Di Istituzioni Di Diritto PubblicoDocumento72 pagineDispense Di Istituzioni Di Diritto Pubblicorafgraz90Nessuna valutazione finora
- Riassunto Libro Corso Di Diritto Pubblico Scienze PoliticheDocumento58 pagineRiassunto Libro Corso Di Diritto Pubblico Scienze PoliticheDavid Del Valli86% (14)
- Riassunto Manuale Di Diritto Civile Di Pietro Perlingieri PDFDocumento210 pagineRiassunto Manuale Di Diritto Civile Di Pietro Perlingieri PDFRaffaellaBaccariNessuna valutazione finora
- Mandrioli RiassuntoDocumento73 pagineMandrioli Riassuntoalteriuris100% (10)
- DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA - Parte Istituzionale G Strozzi R MastroianniDocumento50 pagineDIRITTO DELL UNIONE EUROPEA - Parte Istituzionale G Strozzi R MastroianniFabrizio RomanoNessuna valutazione finora
- Domande Svolte Di Diritto Processuale Civile (Verde, Volumi 1, 2, 3 e 4)Documento71 pagineDomande Svolte Di Diritto Processuale Civile (Verde, Volumi 1, 2, 3 e 4)Carrie1989bq100% (2)
- Adam Tizzano-Lineamenti Di Diritto Dell Unione EuropeaDocumento49 pagineAdam Tizzano-Lineamenti Di Diritto Dell Unione EuropeamanueconomistNessuna valutazione finora
- Manuale Di Diritto Amministrativo, Marcello ClarichDocumento194 pagineManuale Di Diritto Amministrativo, Marcello ClarichAndrea BondiniNessuna valutazione finora
- Capire il diritto amministrativo: attraverso schemi, mappe concettuali e schedeDa EverandCapire il diritto amministrativo: attraverso schemi, mappe concettuali e schedeNessuna valutazione finora
- Riassunto Di Istituzioni Di Diritto Dell'Unione Europea VillaniDocumento29 pagineRiassunto Di Istituzioni Di Diritto Dell'Unione Europea VillaniEdy RoxanaNessuna valutazione finora
- Diritto Regionale Bin FalconDocumento52 pagineDiritto Regionale Bin Falcongioeleaurora100% (1)
- La tutela della Privacy - Sintesi aggiornata per concorsi pubblici: Il Codice di protezione dei dati personali, il diritto di accesso e la trasparenzaDa EverandLa tutela della Privacy - Sintesi aggiornata per concorsi pubblici: Il Codice di protezione dei dati personali, il diritto di accesso e la trasparenzaValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (1)
- Belloni-Le Organizzazioni InternazionaliDocumento44 pagineBelloni-Le Organizzazioni InternazionaliDana ArghirNessuna valutazione finora
- Diritto Dell' Unione EuropeaDocumento34 pagineDiritto Dell' Unione EuropeaWafaaDounaim100% (2)
- Il diritto amministrativo in tasca: 25 schede sintetiche per concorsi ed esamiDa EverandIl diritto amministrativo in tasca: 25 schede sintetiche per concorsi ed esamiValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Riassunto-Strozzi-Estratto-Ed.-2014 2Documento57 pagineRiassunto-Strozzi-Estratto-Ed.-2014 2Chiara CiottiNessuna valutazione finora
- Le Obbligazioni BiancaDocumento110 pagineLe Obbligazioni BiancaCarrie1989bq50% (2)
- Diritto Tributario - Riassunto TESAURO 2014 - Parte SpecialeDocumento62 pagineDiritto Tributario - Riassunto TESAURO 2014 - Parte SpecialeIlaria TranquilloNessuna valutazione finora
- Riassunto Manuale Diritto Internazionale - GioiaDocumento49 pagineRiassunto Manuale Diritto Internazionale - GioiaSpirited AwayNessuna valutazione finora
- Gaja - Adinolfi Introduzione Al Diritto Dell Unione EuropeaDocumento36 pagineGaja - Adinolfi Introduzione Al Diritto Dell Unione EuropeaLista Shine100% (2)
- Diritto AmministrativoDocumento159 pagineDiritto Amministrativo19avantasia87100% (1)
- Riassunti Lezioni Di Diritto Processuale Civile Su Il Processo Civile Manuale PicardiDocumento240 pagineRiassunti Lezioni Di Diritto Processuale Civile Su Il Processo Civile Manuale PicardiCarmela Chiariello100% (1)
- Riassunto Diritto Processuale Civile Parte GeneraleDocumento41 pagineRiassunto Diritto Processuale Civile Parte GeneraleGianmarco BrunoNessuna valutazione finora
- Dispensa Conforti Diritto InternazionaleDocumento99 pagineDispensa Conforti Diritto InternazionaleFabio Agovino100% (1)
- Diritto InternazionaleDocumento71 pagineDiritto Internazionaleappuntigratis_unicam100% (1)
- Procedimento amministrativo e diritto di accesso: Sintesi aggiornata della Legge 241 del 1990 per concorsi pubbliciDa EverandProcedimento amministrativo e diritto di accesso: Sintesi aggiornata della Legge 241 del 1990 per concorsi pubbliciValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (3)
- Gaja - Adinolfi Introduzione Al Diritto Dell Unione EuropeaDocumento36 pagineGaja - Adinolfi Introduzione Al Diritto Dell Unione EuropeaLista Shine100% (2)
- Diritto Dell' Unione EuropeaDocumento34 pagineDiritto Dell' Unione EuropeaWafaaDounaim100% (2)
- Diritto Dell'Unione DanieleDocumento64 pagineDiritto Dell'Unione DanieleWalter Romano100% (2)
- Riassunto Villani 2016Documento93 pagineRiassunto Villani 2016Umberto_Aprior_4254Nessuna valutazione finora
- VillaniDocumento40 pagineVillanirobella1992Nessuna valutazione finora
- Istituzioni Di Diritto Unione Europea Riassunto VillaniDocumento121 pagineIstituzioni Di Diritto Unione Europea Riassunto VillaniAngela ArgentoNessuna valutazione finora
- Adam Tizzano-Lineamenti Di Diritto Dell Unione Europea PDFDocumento49 pagineAdam Tizzano-Lineamenti Di Diritto Dell Unione Europea PDFGiada SollaiNessuna valutazione finora
- Fiscalità Internazionale - I sistemi antievasione tra gli Stati dell’Unione EuropeaDa EverandFiscalità Internazionale - I sistemi antievasione tra gli Stati dell’Unione EuropeaNessuna valutazione finora
- Tutor Magistralis. Compendio di diritto pubblico per concorsi pubblici: Per concorsi pubblici nel settore GiustiziaDa EverandTutor Magistralis. Compendio di diritto pubblico per concorsi pubblici: Per concorsi pubblici nel settore GiustiziaNessuna valutazione finora
- L'Europa dei Popoli o degli Stati?: L'integrazione spiegata attraverso il diritto dell'Unione europeaDa EverandL'Europa dei Popoli o degli Stati?: L'integrazione spiegata attraverso il diritto dell'Unione europeaNessuna valutazione finora
- Riassunto Ronzitti Dir. InternazDocumento66 pagineRiassunto Ronzitti Dir. InternazMarcoLeopizziNessuna valutazione finora
- DIRITTO TRIBUTARIO AppuntiDocumento106 pagineDIRITTO TRIBUTARIO AppuntiMatteo CeredaNessuna valutazione finora
- AmministrativoDocumento92 pagineAmministrativoFabiana NobertiNessuna valutazione finora
- Riassunto - Manuale Diritto PrivatoDocumento366 pagineRiassunto - Manuale Diritto Privatotwixt100% (2)
- Riassunto Diritto Del Lavoro E. Ghera 2010Documento162 pagineRiassunto Diritto Del Lavoro E. Ghera 2010Francesco BenedettoNessuna valutazione finora
- Diritto EcclesiasticoDocumento27 pagineDiritto Ecclesiasticoappuntigratis_unicamNessuna valutazione finora
- Riassunto Istituzioni Di Diritto Processuale Civile Balena Vol IDocumento76 pagineRiassunto Istituzioni Di Diritto Processuale Civile Balena Vol IFederica Di ChioNessuna valutazione finora
- Compendio Di Procedura Penale, A Cura Di G. CONSO, V. GREVI, M. BARGIS, Cedam, Padova, 2014Documento109 pagineCompendio Di Procedura Penale, A Cura Di G. CONSO, V. GREVI, M. BARGIS, Cedam, Padova, 2014Corrado Maria PetrucciNessuna valutazione finora
- Diritto PubblicoDocumento22 pagineDiritto PubblicoPaolo De Laurentis100% (1)
- Riassunto Libro Di Diritto Internazionale Di Conforti - Parte 1Documento26 pagineRiassunto Libro Di Diritto Internazionale Di Conforti - Parte 1Simone PianeselliNessuna valutazione finora
- Compendio Diritto Amministrativo - Elio Casetta FinaleDocumento36 pagineCompendio Diritto Amministrativo - Elio Casetta FinaleShirley QuattrocchiNessuna valutazione finora
- Diritto TributarioDocumento157 pagineDiritto TributarioMarcoNessuna valutazione finora
- Diritto Processuale CivileDocumento72 pagineDiritto Processuale CivileChiara Ruby Tuesday ScarcelloNessuna valutazione finora
- Lezioni Di Diritto AmministrativoDocumento30 pagineLezioni Di Diritto AmministrativoViorel.s0% (1)
- DIRITTO INTERNAZIONALE RiassuntiDocumento5 pagineDIRITTO INTERNAZIONALE Riassuntialteriuris100% (4)
- Diritto Amministrativo CasettaDocumento236 pagineDiritto Amministrativo CasettaFedericaGennaro60% (5)
- Riassunto Libro Compendio Di Diritto TributarioDocumento80 pagineRiassunto Libro Compendio Di Diritto TributarioMattia ZuccaNessuna valutazione finora
- PERLINGIERI DocxDocumento143 paginePERLINGIERI DocxMaria Antonia Adesso100% (1)
- 40 Funzionari Amministrativi Scolastici - Le norme anticorruzione, gli obblighi di trasparenza e pubblicitàDa Everand40 Funzionari Amministrativi Scolastici - Le norme anticorruzione, gli obblighi di trasparenza e pubblicitàNessuna valutazione finora
- Concorso Istruttore Enti Locali - Servizi pubblici locali: Sintesi ragionata per concorsi pubbliciDa EverandConcorso Istruttore Enti Locali - Servizi pubblici locali: Sintesi ragionata per concorsi pubbliciNessuna valutazione finora
- APERTE Diritto Unione Europea EcampusDocumento23 pagineAPERTE Diritto Unione Europea EcampusRaffaele MondoNessuna valutazione finora
- Dispensa - Diritto Dell'Unione Europea (Compendio)Documento93 pagineDispensa - Diritto Dell'Unione Europea (Compendio)Bruno MercurioNessuna valutazione finora
- MULTIPLE Diritto Unione Europea EcampusDocumento15 pagineMULTIPLE Diritto Unione Europea EcampusRaffaele MondoNessuna valutazione finora
- Corso-Di-Diritto-Pubblico-Augusto-Barbera-E-Carlo-Fusaro X EdizioneDocumento94 pagineCorso-Di-Diritto-Pubblico-Augusto-Barbera-E-Carlo-Fusaro X Edizionecamilla pomponioNessuna valutazione finora
- Diritto Dell Unione Europea Tesauro 6 EdizioneDocumento194 pagineDiritto Dell Unione Europea Tesauro 6 EdizionecescozNessuna valutazione finora
- Diritto Dell - Unione Europea - Strozzi Parte Istituzionale - 1-2.sbloccatoDocumento22 pagineDiritto Dell - Unione Europea - Strozzi Parte Istituzionale - 1-2.sbloccatocescozNessuna valutazione finora
- Bando Garanzia Giovani Regione CampaniaDocumento36 pagineBando Garanzia Giovani Regione CampaniapaolinoNessuna valutazione finora
- Unione EuropeaDocumento19 pagineUnione EuropeaNico PandaNessuna valutazione finora
- StrategiDalla Strategia Di Lisbona A Europa 2020a Di LisbonaDocumento498 pagineStrategiDalla Strategia Di Lisbona A Europa 2020a Di LisbonaNinoVassalloNessuna valutazione finora
- Diritto Dell'unione EuropeaDocumento5 pagineDiritto Dell'unione EuropeaAshley HughesNessuna valutazione finora
- Ue - File UnicoDocumento174 pagineUe - File UnicoSilvia DchNessuna valutazione finora
- Unione EuropeaDocumento13 pagineUnione EuropeaAnnarita IaiaNessuna valutazione finora
- Barbera FusaroDocumento20 pagineBarbera Fusaro0000Nessuna valutazione finora
- Appunti Di Geografia Le Regioni EuropeeDocumento162 pagineAppunti Di Geografia Le Regioni EuropeeA MNessuna valutazione finora
- RelazioneDocumento1.672 pagineRelazioneacoohayNessuna valutazione finora
- Docsity Riassunto Completo Elementi Di Diritto Dell Unione Europea Draetta Bestagno Santini 2018Documento96 pagineDocsity Riassunto Completo Elementi Di Diritto Dell Unione Europea Draetta Bestagno Santini 2018mahashakerNessuna valutazione finora
- Diritto Unione EuropeaDocumento31 pagineDiritto Unione EuropeaLucrezia PuerariNessuna valutazione finora
- Diritto UeDocumento57 pagineDiritto UemahashakerNessuna valutazione finora
- Adam Tizzano-Lineamenti Di Diritto Dell Unione Europea PDFDocumento49 pagineAdam Tizzano-Lineamenti Di Diritto Dell Unione Europea PDFGiada SollaiNessuna valutazione finora
- 5) Unione Europea. Fatti e CifreDocumento82 pagine5) Unione Europea. Fatti e CifreFrancesca Della BiancaNessuna valutazione finora
Strozzi PG 32 Pag
Strozzi PG 32 Pag
Caricato da
Salvatore CascellaTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Strozzi PG 32 Pag
Strozzi PG 32 Pag
Caricato da
Salvatore CascellaCopyright:
Formati disponibili
lOMoARcPSD|8844004
Riassunto DIRITTO DELL ’UNIONE EUROPEA Parte
Istituzionale"
Istituzioni di diritto dell'Unione Europea (Università degli Studi di Trento)
Studocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
DIRITTO
DELL’UNIONE
EUROPEA
Parte Istituzionale
G. Strozzi – R. Mastroianni
Riassunto concettuale ad opera di P. Geremia
&
SENTENZE DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA
EUROPEA ED
ITALIANA
Riassunto concettuale ad opera di A. Lamagna
~1~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Parte Istituzionale
G. Strozzi – R. Mastroianni
Riassunto concettuale ad opera di P. Geremia
Origini e sviluppo dell’integrazione europea
Le prime esperienze di organismi istituzionalizzati a livello internazionale si ebbero dopo la
Seconda Guerra Mondiale in vari campi:
Economico OECE (oggi OCSE);
Militare NATO;
Politico Consiglio d’Europa (prima organizzazione internazionale che prevede una
Assemblea parlamentare) che ha dato vita alla CEDU (Convenzione Europea per la
salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali del 1950).
Nel 1950 il ministro degli esteri francese Schuman propose di mettere in comune la produzione
franco-tedesca del carbone e dell’acciaio in una organizzazione internazionale aperta anche ad
altri Stati europei; l’obiettivo immediato era quello di evitare le rivalità tra Francia e Germania,
ancorando quest’ultima all’Europa, agendo su aree tradizionalmente oggetto di conflitto tra i
due paesi.
Trattato di Parigi (1951)
CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio) firmato da Francia e Germania e Italia e
Olanda e Lussemburgo e Belgio. Istituzione con poteri sovranazionali formata da:
Alta Autorità (poteri decisionali);
Consiglio dei Ministri (poteri di controllo);
Assemblea parlamentare;
Corte di giustizia.
Fallì il progetto di una armata europea con la CED (Comunità Europea di Difesa).
Trattato di Roma (1957)
CEE (Comunità Economia Europea) ed EURATOM (comunità europea per l’energia atomica), è
una estensione dell'integrazione europea alla cooperazione economica generale. Vennero
definite le tappe per la realizzazione del mercato unico:
Integrazione negativa: zona di libero scambio in cui eliminare gli ostacoli;
Unione doganale: unica barriera tariffaria nei confronti dei paesi terzi;
Integrazione positiva: armonizzare le legislazioni degli Stati membri;
Libera circolazione:
Merci;
Persone (lavoratori dipendenti e stabilimento dei lavoratori autonomi);
Prestazione di servizi (prestazione temporanea retribuita);
Capitali (libertà dei pagamenti correnti, da Maastricht libertà di movimenti di
capitali anche senza transazioni commerciali o prestazioni di servizi).
~2~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
Le tre comunità (CECA, CEE ed EURATOM) avevano in comune Corte di giustizia e Assemblea
parlamentare, mentre ogni comunità aveva Commissione (CECA Alta Autorità) e Consiglio
autonomi.
Trattato di Bruxelles (1965)
Fusione degli esecutivi (abrogato dal trattato di Amsterdam):
Una sola Commissione;
Un solo Consiglio;
Un solo bilancio.
Grazie al generale francese De Gaulle, ostile a ogni aspetto di sovranazionalità nel
funzionamento delle istituzioni europee, attraverso la “politica della sedia vuota”, culminata nel
1965 con l’opposizione della Francia ad usare il voto a maggioranza in seno al Consiglio, si arrivò
al compromesso di Lussemburgo, secondo cui se per una questione è prevista la maggioranza ed
uno Stato membro si oppone, allora si passa al voto all’unanimità.
Con la presidenza di Pompidou si ha il passaggio dal sistema dei contributi finanziari al sistema
delle risorse proprie delle comunità. Nel 1972 viene introdotto il “serpente monetario” al fine di
limitare i margini di fluttuazione tra le monete nazionali. Nel 1978 viene istituito il Sistema
Monetario Europeo (SME).
Atto unico europeo
(firma 1987 - entrata in vigore 1987):
Votazione a maggioranza qualificata nel Consiglio;
Creazione delle procedure di cooperazione e di parere conforme, che accrescono
l'influenza del Parlamento;
Tribunale di 1° alla Corte di Giustizia.
Trattato di Maastricht
(firma 1992 - entrata in vigore 1993) Trattato dell’Unione Europea:
Procedura di Codecisione, che conferisce al Parlamento maggiori poteri nel processo
decisionale;
Cittadinanza europea (i cui diritti fondamentali sono: circolazione e soggiorno nel
territorio dell’UE, elettorato attivo e passivo al Parlamento europeo, petizione,
possibilità di ricorso al Mediatore europeo, protezione diplomatica e consolare all’estero);
Unione economica in tre fasi:
BCE (Banca Centrale Europea);
Politica monetaria riservata all’UE per quei paesi che rispettano i criteri di
convergenza.
UE si basa su tre pilastri:
CE (Comunità Europea);
PESC (Politica Estera e Sicurezza Comune);
GAI (Giustizia Affari Interi).
Troika La Presidenza è assistita dallo Stato membro che ha esercitato la precedente
presidenza e da quello che eserciterà la successiva.
Trattato di Amsterdam
(firma 1997 – entrata in vigore 1997):
Cooperazione rafforzata tra alcuni Stati, ma non in materia di PESC;
Entro 5 anni eliminazione delle frontiere interne;
~3~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
Politica per asilo e immigrazione (vota il Consiglio all’unanimità su proposte della
Commissione o di uno Stato membro, previa consultazione del Parlamento);
Numero massimo di 700 per i membri del Parlamento europeo (attualmente 766 da
riportare a 751 nel 2019).
Trattato di Nizza
(firma 2001 - entrata in vigore 2003):
estensione del voto a maggioranza qualificata e della procedura di codecisione;
politica commerciale comune;
disposizioni sociali;
PESC Consiglio:
Azioni comuni;
Posizioni comuni;
Alto Rappresentante = Segretario Regionale del Consiglio
GAI:
Europol per le operazioni investigative (1995);
Eurojust per la cooperazione penale (2002) per prevenire il conflitto di giurisdizione;
Posizioni comuni:
Decisioni-quadro;
Decisioni e misure di attuazione a maggioranza qualificata;
Convenzioni.
Il Consiglio delibera normalmente all’unanimità e a maggioranza dei suoi membri per
questioni procedurali. Il Parlamento deve rilasciare il suo parere (entro un termine non
inferiore a tre mesi). L’iniziativa appartiene agli Stati membri ed alla Commissione. La
Corte ha competenza pregiudiziale.
Convocazione Convenzione sul futuro dell’Europa (2001).
Firma del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (2004):
Abolisce la divisione dei tre pilastri e il dualismo Unione-Comunità;
Viene incorporata la Carta dei diritti fondamentali di Nizza 2000;
Riordino delle fonti comunitarie:
Legge europee (regolamenti);
Leggi quadro (direttive);
Regolamento europeo (portata generale con risultato obbligatorio);
Decisione europea obbligatoria;
Raccomandazioni e pareri.
La codecisione diventa la procedura legislativa ordinaria: si elimina quella di
cooperazione, rimane quella di consultazione e parere conforme (ora detto “previa
approvazione del Parlamento europeo”);
La presidenza del Consiglio europeo dura due anni e mezzo;
Alto rappresentante PESC è eletto dal Ministro degli Affari esteri e dal Consiglio
Europeo a maggioranza qualificata con l’accordo del Presidente di Commissione (di cui è
vice Presidente).
La convenzione viene respinta da un referendum in Francia e Paesi Bassi nel 2005, poi si
eliminano i riferimenti a “Costituzione” e viene approvata, ma non in Irlanda.
Trattato di Lisbona
(firma 2007 – entrata in vigore 2009) TUE e TFUE con identico valore giuridico:
Rafforzato il ruolo del Parlamento catalogo competenze UE;
Eliminate le leggi e le leggi quadro europee, si fa riferimento alle leggi nazionali;
~4~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
Diritto UE prevale sui diritti nazionali;
Cooperazione rafforzata: aperta a tutti gli Stati, è trasmessa alla Commissione, che può
presentare al Consiglio una proposta in merito, l’autorizzazione è concessa dal Consiglio,
che delibera a maggioranza qualificata, previa autorizzazione del Parlamento europeo.
In ambito PESC la richiesta viene presentata al Consiglio che l’autorizza all’unanimità,
previo parere dell’Alto Rappresentante e con il parere della Commissione. Si attua in
alcune materie e rispetta alcune caratteristiche:
In materia di integrazione;
Rispetta i Trattati;
Opera nei limiti delle competenze UE;
Non reca pregiudizio economico;
Interessa almeno nove Stati;
Aperta a tutti previa verifica della Commissione.
In generale è concesso ad uno Stato di sottrarsi all’applicazione di una decisione se si astiene
dal voto con dichiarazione motivata; se lo fanno un terzo degli Stati membri, che rappresentano
un terzo del popolo, allora non si adotta.
In deroga al principio generale dell’unanimità, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata
per l’adozione di decisioni, sulla base di una decisione del Consiglio o proposta dall’Alto
rappresentante, per l’attuazione di una decisione e per la nomina di un rappresentante speciale.
Vota a maggioranza semplice per le questioni procedurali e vota con una cooperazione
strutturata permanente per gli Stati con elevati criteri in termini di capacità militare.
Freno d’emergenza lo Stato blocca la procedura legislativa ordinaria e incarica il
Consiglio europeo se la decisione incide sul proprio ordinamento (penale); si esprime
entro quattro mesi o rimanda al Consiglio (fine sospensione) o chiede un nuovo progetto.
Se non decide in quattro mesi o entro dodici non c’è un nuovo progetto, si può creare una
cooperazione rafforzata tra Stati per attuarlo.
Ingresso di un membro UE il Consiglio vota all’unanimità e previa consultazione (non
vincolante) della Commissione e previa approvazione del Parlamento a maggioranza dei
membri, l’accordo di adesione viene poi ratificato dagli Stati membri previa approvazione
del testo dal Parlamento:
Requisito oggettivo geografico;
Valutazione di conformità (criteri storici, economici …).
Sospensione su proposta motivata di 1/3 degli Stati o del Parlamento o della
Commissione, il Consiglio a maggioranza di 4/5 può constatare l’esistenza di una
eventuale violazione grave (dell’art.2 TUE) ed attivare una procedura sanzionatoria il
Consiglio può decidere di sospendere alcuni diritti dello Stato membro, ma esso non si
sottrae comunque dal rispetto dei propri obblighi;
Recesso l’Unione negozia con lo Stato un accordo, dove si definiscono le modalità di
recesso, che viene concluso dal Consiglio a maggioranza qualificata previa approvazione
del Parlamento. I Trattati cessano di essere applicati dopo due anni dalla notifica.
Competenze dell’Unione Europea
Principio di attribuzione (art. 5 TUE):
Esclusiva (art. 3 TFUE);
Concorrente (art. 4 TFUE) il campo di applicazione copre solo gli elementi disciplinati;
Azioni di sostegno o coordinamento o completamento.
~5~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
La sicurezza nazionale è espressamente riservata in via esclusiva alla competenza di ciascuno
Stato membro.
Clausola di flessibilità (art. 352 TFUE) consente all’Unione, a seguito di una deliberazione
unanime del Consiglio su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento
europeo, di adottare le disposizioni necessarie per realizzare uno degli scopi istituzionali,
quando il Trattato non abbia previsto poteri d’azione, o anche quando quelli previsti siano
insufficienti (senza così ricorrere alla procedura di revisione dei Trattati).
Principio di sussidiarietà (sul cui rispetto vigilano gli Stati) ogni progetto legislativo è
trasmesso anche ai Parlamenti nazionali che, entro otto settimane, possono muovere
opposizione, con parere motivato, ai presidenti del Parlamento e del Consiglio e della
Commissione. Se i pareri motivati sono almeno 1/3 dell’insieme dei voti attribuiti ai parlamenti
nazionali, il progetto viene riesaminato. Se si ha la maggioranza semplice, la Commissione deve
riesaminare la proposta e può mantenere il progetto con parere motivato trasmesso al
legislatore dell’Unione insieme ai pareri dei nazionali.
Principio di proporzionalità valutare l’adeguatezza degli atti emanati e controllare la loro
conformità agli obiettivi del trattato.
Principio di prossimità le decisioni devono essere il più possibile vicino ai cittadini.
Istituzioni dell’Unione Europea
Parlamento
Doveva essere un organo consultivo e di controllo. Inizialmente era formato dai delegati
designati dai parlamenti nazionali, poi il Trattato di Maastricht dichiarò che i suoi componenti
sono i rappresentanti dei popoli degli Stati membri eletti tramite suffragio universale diretto
con voto unico ogni 5 anni contemporaneamente in tutti gli Stati (in Italia si vota con un sistema
proporzionale sulla base di cinque circoscrizioni regionali). Vi è incompatibilità tra una carica
parlamentare nazionale e quella dell’Unione.
In base al Trattato di Amsterdam i suoi membri dovevano essere 700, dal Trattato di Lisbona
si definisce che il numero dei seggi può variare da un minimo di 6 ad un massimo di 96 per
Paese e che il numero massimo fosse di 750 con l’aggiunta del presidente (attualmente 766 da
riportare a 751 nel 2019).
Il Presidente è eletto per due anni e mezzo dall’Assemblea a maggioranza qualificata nei primi
tre scrutini, al quarto scrutinio vince il candidato con più voti. È a capo dell’Ufficio di presidenza,
formato da:
Presidente del Parlamento;
14 vicepresidenti;
5 questori, i quali hanno funzioni consultive.
La Conferenza dei presidenti è composta dal presidente del Parlamento e dai presidenti dei
gruppi politici e stabilisce l’ordine del giorno delle sedute.
La Conferenza dei presidenti di Commissione è formata dai presidenti delle commissioni
parlamentari.
Le commissioni parlamentari possono essere:
Commissioni permanenti, attualmente formate da 20 membri eletti per due anni e
mezzo;
Commissioni temporanee, non possono superare i 12 mesi;
~6~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
Commissioni temporanee d’inchiesta, sono costituite dal Parlamento su richiesta di 1/4
dei suoi membri per esaminare le denunce di infrazione del diritto dell’Unione o di cattiva
amministrazione. Cessano col deposito del rapporto.
I parlamentari sono poi organizzati in gruppi politici, composti da deputati eletti almeno in 1/4
degli Stati; i membri devono essere almeno 25 e non possono appartenere a più di un gruppo. I
deputati che non aderiscono a nessun gruppo risultano non iscritti (attualmente vi sono 8 gruppi
compreso quello dei non iscritti).
Il Parlamento si riunisce a Strasburgo il secondo martedì di marzo, la sessione è annuale divisa
in periodi di sessione di una settimana al mese. Può riunirsi anche in seduta straordinaria su
richiesta della maggioranza dei membri o del Consiglio o della Commissione. La legislatura dura
cinque anni.
Delibera a maggioranza assoluta, il numero legale è 1/3 (2/3 per gravi violazioni) ma, se 40
deputati non lo richiedono al Presidente, non viene verificato il suo raggiungimento e la delibera
risulta comunque valida.
Il voto parlamentare può essere:
Personale per alzata di mano;
Nominale;
Segreto.
Il Parlamento ha diversi poteri:
Potere di iniziativa la proposta normativa spetta solo alla Commissione, ma il
Parlamento può fare delle proposte alla Commissione, votando a maggioranza assoluta
(può inoltre apporre un termine alla sua proposta, sebbene ciò non sia previsto dai
Trattati);
Potere di controllo:
La Commissione è tenuta a presentare una relazione annuale sulle attività
dell’Unione almeno un mese prima dell’apertura della sessione del Parlamento e deve
presentare entro ottobre un progetto di lavoro per l’anno successivo;
Il Consiglio è tenuto a presentare ogni sei mesi un programma di lavoro all’inizio di
ogni presidenza;
Il Consiglio europeo è tenuto a presentare una relazione annuale e una dopo ogni
seduta;
Può censurare la Commissione su proposta presentata al Presidente da 1/10 dei
deputati, se si raggiunge la maggioranza di 2/3 dei voti espressi e a maggioranza dei
membri che lo compongono, il Parlamento provoca la dimissione collettiva di tutta la
Commissione, anche se a causa dell’operato di un solo commissario (si può tuttavia,
per consuetudine, procedere alle dimissioni del singolo commissario se ciò viene
chiesto dal Parlamento con l’accordo del presidente della Commissione);
Riceve le petizioni dal Presidente (le petizioni devono avere ricevibilità formale ossia
essere non anonima, redatta in una lingua ufficiale e contenente nazionalità e
domicilio del firmatario) che vengono poi inviate alla commissione permanente delle
petizioni;
Può esperire il ricorso in annullamento (dal 1990) alla Corte senza dover più
dimostrare l’interesse d’agire (solo la Commissione invece può esperire il ricorso per
inadempimento contro uno Stato membro).
Potere di bilancio ora si esplica nella procedura di concertazione con l’approvazione
delle tre istituzioni;
Potere di consultazione generalmente obbligatoria.
~7~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
Mediatore/Difensore civico
È eletto dal Parlamento, con voto segreto a maggioranza semplice, ad ogni inizio legislatura, ed
è rieleggibile.
Il suo compito è quello di ricevere le denunce dei cittadini dell’Unione sui casi di cattiva
amministrazione di organi comunitari con esclusione della Corte di giustizia.
La sua attività è preclusa quando sia pendente un procedimento giudiziario interno.
La denuncia deve essere presentata entro due anni tramite un parlamentare europeo.
Il Mediatore informa l’istituzione interessata che ha tre mesi di tempo per presentare
osservazioni utili a conciliare il fatto, se non vi è successo allora la questione viene presentata
al Parlamento.
Il suo rapporto non crea vincoli per l’istituzione contro cui viene redatto.
Anche il Mediatore europeo è tenuto a presentare annualmente una relazione al Parlamento.
Consiglio europeo
Il Consiglio europeo non può esercitare funzioni di tipo legislativo e le sue funzioni si svolgono
prevalentemente in materia di PESC.
Oltre al proprio presidente, comprende capi di Stato o di governo degli Stati membri e il
presidente della Commissione; partecipa inoltre ai lavori anche l’Alto rappresentante.
Si riunisce due volte a semestre su convocazione del suo presidente, il quale viene eletto dai capi
di Stato e di governo a maggioranza qualificata per un periodo di due anni e mezzo (rinnovabile
una sola volta).
In generale il Consiglio europeo vota a maggioranza qualificata (con l’astensione del presidente
del Consiglio europeo e del presidente della Commissione):
Il presidente del Consiglio europeo;
Il presidente della Commissione;
La nomina della Commissione stessa previa approvazione del Parlamento;
L’Alto rappresentante.
Gli atti che il Consiglio europeo adotta aventi effetti giuridici verso terzi, sono sottoposti al
controllo della Corte di giustizia.
Consiglio
Il Consiglio è composto da un rappresentante di rango ministeriale per ogni Stato membro ed è
a formazione variabile a seconda delle materie trattate. I suoi lavori sono supervisionati dal suo
Segretario generale.
La presidenza è esercitata a turno da ciascuno Stato membro per sei mesi ed è determinata dal
Consiglio europeo con votazione a maggioranza qualificata secondo un sistema di rotazione
paritaria. La presidenza è inoltre organizzata attraverso il sistema della troika, secondo cui la
presidenza attuale è assistita dallo Stato membro che ha esercitato la precedente ed anche da
quello che eserciterà la successiva (sono già state definite tutte le terne fino al 2020).
Si riunisce dietro convocazione del presidente su iniziativa sua o di uno Stato o della
Commissione; le sedute sono pubbliche quando si delibera su un progetto di atto legislativo. Il
presidente stabilisce l’ordine del giorno, che comunica almeno 14 giorni prima dell’inizio della
seduta ai membri del Consiglio e della Commissione.
~8~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
L’ordine del giorno è diviso in due parti, una A e una B:
A. Sono iscritti i punti di approvazione che non necessitano di un dibattito;
B. Sono iscritti i punti che invece necessitano di un dibattito e possono essere rinviati al
COREPER.
Ogni votazione è aperta dal presidente su proposta di un membro del Consiglio o della
Commissione. Per affari urgenti si ha una votazione scritta (procedura scritta normale), se il
Consiglio o il COREPER decidono all’unanimità in tale senso. Esiste inoltre una “procedura di
approvazione tacita”. Il voto è considerato valido se è presente la maggioranza degli aventi
diritto al voto (50% +1).
Il Consiglio dispone di tre sistemi di votazione:
Maggioranza semplice, calcolata non sui presenti, ma su tutti i membri che compongono
il Consiglio;
L’unanimità dei votanti (l’astensione dei presenti non costituisce un ostacolo), molto
utilizzata in ambito PESC;
Maggioranza qualificata.
~9~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
COREPER
Il COREPER (Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri) è un organo
intergovernativo presieduto da un rappresentante permanente dello Stato che ottiene la
presidenza al Consiglio.
Si riunisce a due livelli:
COREPER 2 ambasciatori rappresentanti permanenti (per affari di rilievo politico e
economico e finanziario e per relazioni estere);
COREPER 1 rappresentanti permanenti (per affari di tipo tecnico).
La proposta della Commissione viene trasmessa al Consiglio direttamente dal COREPER per il
suo esame:
Se si raggiunge l’unanimità, la questione viene iscritta al punto A dell’ordine del giorno
del Consiglio, il quale approva la decisione, ma, se qualche membro del Consiglio o la
stessa Commissione chiede di riaprire la discussione, essa viene rinviata al COREPER.
Se invece la questione non raggiunge l’unanimità e quindi viene iscritta al punto B
dell’ordine del giorno del Consiglio, il COREPER prepara un rapporto per il Consiglio
con tutti gli elementi utili alla discussione.
Commissione
L’organo della Commissione ha le funzioni di esprimere il principio di sovranazionalità e di
promuovere l’interesse dell’Unione.
Fino al 31 ottobre 2014 era formata da un rappresentante per Stato membro, tra cui il
Presidente e il vicepresidente/Alto rappresentante (28 membri). Dal 1 novembre 2104 invece (a
causa di una riduzione operata dal Trattato di Lisbona), non avendo carattere rappresentativo,
è formata da membri dei 2/3 degli Stati, compresi Presidente e Alto rappresentante, per un
numero complessivo di 19 unità, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità,
decida di cambiare tale numero.
I componenti sono scelti in base ad un sistema di rotazione rispettando due criteri:
Il numero totale dei mandati di cittadini di uno Stato non deve mai superare di una unità
il numero dei mandati di cittadini di un altro Stato;
Ogni Commissione deve riflettere la molteplicità demografica e geografica degli Stati
membri.
Il Presidente è proposto a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo e viene approvato a
maggioranza assoluta dal Parlamento (se non viene approvato, bisogna presentare una nuova
proposta in un mese). Il resto della Commissione è adottato dal Consiglio europeo in accordo col
presidente. Tutto il collegio è poi nuovamente approvato dal Parlamento e formalmente
nominato dal Consiglio europeo per 5 anni (un membro dimissionario o deceduto può essere
sostituito da un membro della stessa nazione, per la restante durata del mandato, mediante
nomina del Consiglio in accordo col presidente della Commissione previa consultazione del
Parlamento).
L’Alto rappresentante è nominato sempre dal Consiglio europeo con votazione a maggioranza
qualificata, in accordo col presidente della Commissione, e rimane di diritto uno dei 24
vicepresidenti della Commissione.
La Commissione si riunisce una volta a settimana e ogni qualvolta sia necessario e le delibere
delle sedute sono adottate a maggioranza assoluta.
~ 10 ~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
La Commissione ha diversi poteri:
Potere di iniziativa l’art. 293 TFUE attribuisce particolare valore alla proposta della
Commissione, stabilendo che il Consiglio non possa emendarla se non all’unanimità. I
cittadini, almeno 1 milione ed appartenenti ad un numero significativo di Stati, possono
avanzare una proposta alla Commissione, la quale può rifiutare motivando oppure si
concede un anno di tempo per la raccolta dei firmatari e si esamina entro tre mesi. La
Commissione può inoltre appoggiare le questioni di politica estera che l’Alto
rappresentante propone al Consiglio, sebbene non possa operare in ambito PESC e BEI;
Potere consultivo ha facoltà consultiva nei confronti del Consiglio per la cooperazione
rafforzata in politica estera;
Potere decisionale in politica di concorrenza, la Commissione può adottare atti di
portata generale su delega di un atto legislativo, per integrare o modificare determinati
elementi non essenziali dell’atto stesso;
Potere esecutivo solo su delega precisa del Consiglio, affiancata tramite la procedura
dei comitati. Si hanno tre procedure principali:
Procedura consultiva, operata da un comitato di rappresentanti degli Stati membri a
carattere puramente consultivo;
Procedura di gestione, una volta emanato il parere a maggioranza qualificata, o
qualora il comitato non si pronunci nel termine stabilito, le misure previste dalla
Commissione sono immediatamente applicabili ma, nel caso non si sia conformata al
parere del comitato, le comunica al Consiglio e ne differisce l’esecuzione (per massimo
tre mesi): se il Consiglio non prende una decisione diversa o non si pronuncia, la
Commissione adotta definitivamente le misure in questione;
Procedura di regolamentazione, in caso di parere negativo del comitato, o se non si
ha la maggioranza richiesta, o in assenza di parere, la Commissione sottopone al
Consiglio una proposta e ne informa il Parlamento. Il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata entro tre mesi e, se si oppone, la Commissione la riesamina,
e, se non si oppone o non si pronuncia, la Commissione adotta l’atto. Dal 2006 esiste
la procedura di regolamentazione con controllo, mediante cui sia il Consiglio che il
Parlamento possono bloccare la Commissione qualora ecceda dalle sue competenze.
Dal 2011 sono previste solo due procedure:
o Procedura consultiva;
o Procedura d’esame, con un controllo da parte degli Stati membri per impedire
l’adozione di misure non conformi al parere del comitato, il quale lo formula a
maggioranza qualificata.
Potere di gestione alla Commissione spetta la gestione amministrativa dei
programmi e strumenti finanziari europei e degli stanziamenti destinati agli interventi
pubblici dell'Unione, in collaborazione con le autorità interessate dei Fondi a finalità
strutturale;
Potere di controllo la Commissione (guardiana dei Trattati) ha il compito di vigilare
sull'applicazione delle norme dei Trattati:
Orienta l'operato degli Stati membri e dei privati in modo conforme alle norme
dell'Unione, inoltre si impone agli Stati il dovere di comunicare le misure che
intendono adottare in certi campi, di notificare i provvedimenti che hanno preso
per uniformarsi alle direttive. La mancata osservanza da parte di uno Stato alla
richiesta della Commissione comporta la violazione dell'obbligo di cooperazione,
essa può esercitare il suo potere di accertamento e di verifica negli ordinamenti
statali e nei confronti di privati o imprese e può procedere ad inchieste e sanzioni.
Ha il potere di perseguire nei confronti degli Stati ogni violazione degli obblighi
~ 11 ~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
derivanti dal diritto comunitario per assicurarne l'osservanza; quindi può
promuovere la procedura per infrazione davanti alla Corte di propria iniziativa o
su richiesta di un altro Stato. È prevista una deroga: la Commissione può adire
direttamente la Corte se lo Stato non si è conformato alla decisione della
Commissione che ne verifichi l'incompatibilità di un aiuto di Stato; la Commissione
può adire la Corte se ritiene che uno Stato ha abusato della clausola di
salvaguardia.
Nei confronti di altre istituzioni, la Commissione non deve dimostrare il suo interesse ad
agire. Mentre in determinati settori come politica di concorrenza può emanare sanzioni
pecuniarie ad imprese o privati che hanno violato gli obbligi imposti dalle norme
comunitarie. Tuttavia le decisioni della Commissione possono essere impugnate davanti
alla Corte;
Relazioni esterne. La Commissione deve garantire la coerenza tra i vari settori
dell'azione esterna dell'UE e tra queste e le altre politiche. Negozia gli accordi tra UE e
Stati terzi o organizzazioni internazionali in ambito di direttive stabilite dal Consiglio.
Corte dei conti
Creata col Trattato di Bruxelles del 1975 ed operativa dal 1977, opera il controllo contabile
esterno alle singole istituzioni e l’esame del bilancio.
È formata da un cittadino per Stato membro e la carica dura sei anni ed è rinnovabile; il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, sentito il parere del Parlamento, adotta
l’elenco dei membri.
Il presidente viene letto dai membri e rimane in carica tre anni.
Nonostante sia un organo collegiale, la Corte di giustizia può destituire alcuni membri dalle loro
funzioni.
Redige dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario una relazione da trasmettere entro il 30
novembre al Consiglio e al Parlamento per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea.
Corte di giustizia
Ha sede a Strasburgo e dal Trattato di Lisbona è configurata come una istituzione unica
articolata in più organismi quali:
Corte di giustizia;
Tribunale;
Tribunali specializzati.
Corte di giustizia
La Corte di giustizia dispone di diversi tipi di azioni articolate su due livelli:
Primo livello:
Azione di annullamento;
Azione in carenza, ossia accerta l’illegittima inerzia delle istituzioni dell’Unione;
Eccezione incidentale di invalidità, per i procedimenti pendenti dinanzi la Corte;
Procedura di infrazione, da parte degli Stati contro il diritto dell’Unione;
Per responsabilità extra contrattuale.
~ 12 ~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
Secondo livello:
Controllo sulla interpretazione e sulla validità degli atti dell’Unione (dal Trattato di
Maastricht no in materia di PESC e GAI, poi dal Tratto di Amsterdam no solo in
materia di PESC);
Funzione consultiva.
Non è competente a valutare validità e proporzionalità delle operazioni di polizia per il
mantenimento dell’ordine pubblico e di sicurezza interna.
È composta di sette giudici, uno per Stato, in carica per sei anni rinnovabili (un rinnovo parziale
avviene ogni tre anni). Questi giudici sono poi assistiti da otto avvocati generali, in carica per
sei anni anche se ne vengono cambiati quattro ogni tre anni: uno di essi è indicato dai grandi
Stati (Francia e Germania e Italia e Regno Unito e Spagna), mentre gli altri a rotazione; tra di
essi la Corte nomina il primo avvocato generale che distribuisce le cause tra gli avvocati
generali.
Il presidente è eletto per tre anni a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei voti espressi
ed è rinnovabile. È affiancato da un vicepresidente eletto dai giudici per tre anni.
Nella disciplina precedente la Corte si riuniva di regola in formazione plenaria (grande plenum
e piccolo plenum di 11 giudici), ma si potevano creare sezioni di tre o cinque o sette giudici.
Secondo la nuova disciplina la seduta plenaria si ha solo per pronunciarsi su determinate
questioni quali le dimissioni del Mediatore, o di un membro della Commissione, o della Corte
dei conti. Normalmente si riunisce in sezioni di tre o cinque giudici che eleggono i propri
presidenti in base ad una rotazione triennale; le loro deliberazioni sono valide a maggioranza di
tre giudici. La Corte può inoltre riunirsi in una grande sezione, quando lo richiede un’istituzione
o uno Stato membro, che comprende tredici giudici, tra cui i presidenti delle sezioni di cinque
giudici, ed è presieduta dal presidente della Corte.
Secondo la procedura le parti devono farsi rappresentare, le istituzioni e gli Stati nominano un
agente per ogni causa, le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato abilitato. Le
procedure pregiudiziali comportano delle fasi:
Fase scritta si apre con un istanza trasmessa al cancelliere e prosegue con lo scambio
di memorie e contro-memorie. Il presidente nomina il giudice relatore e il primo avvocato
generale nomina l'avvocato generale incaricato della causa; al termine di questa parte il
giudice relatore presenta alla Corte una relazione preliminare che riassume la causa e
le posizioni delle parti e contiene l'eventuale richiesta di misure istruttorie.
Fase orale si opera l’audizione delle parti e l'avvocato generale presenta le conclusioni
e alle parti non è consentito replicare. La causa è posta in deliberazione e la decisione
assunta dalla Corte con votazione a maggioranza è pronunciata in seduta pubblica.
La sentenza ha carattere definitivo, tuttavia può essere oggetto di mezzi di impugnazione
straordinaria:
Opposizione di terzo può essere presentata a cura di uno Stato, di un'istituzione o di
ogni persona fisica/giuridica contro le sentenze che pregiudicano i loro diritti;
Revocazione delle sentenze può essere chiesta se sussiste un fatto nuovo che modifica
la soluzione della controversia (entro dieci anni);
Interpretazione le parti dimostrano di avere un interesse e possono chiedere alla Corte
l'interpretazione della sentenza.
~ 13 ~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
Tribunale
È composto da almeno un giudice per Stato, i componenti sono scelti e nominati secondo criteri
simili a quelli della Corte. Il loro mandato dura sei anni con un rinnovo parziale ogni tre anni, i
giudici designano il presidente per tre anni.
L’impugnazione può essere presentata entro due mesi dalla notifica della decisione.
Tribunali specializzati
Sono incaricati di conoscere in primo grado certe categorie di ricorsi in materie specifiche.
Le decisioni dei tribunali specializzati possono essere oggetto d’impugnazione per i soli motivi
di diritto davanti alla Corte o anche per motivi di fatto dinanzi al Tribunale.
I membri sono nominati dal Consiglio all’unanimità.
Nel 2004 il Consiglio ha istituito il Tribunalle della funzione pubblica, composto da sette giudici,
per le controversie tra l’Unione e i suoi agenti.
Comitato economico sociale
Questo Comitato è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro,
lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile.
Attualmente ci sono 353 membri, ripartiti in maniera ponderata tra gli Stati membri, nominati
a titolo personale per 5 anni dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata previa
consultazione della Commissione.
Il Comitato designa il proprio presidente che rimane in carica per due anni e mezzo.
Ha una funzione consultiva obbligatoria da parte di Parlamento e Consiglio e Commissione, il
parere deve essere presentato entro un certo limite che non può comunque essere inferiore a un
mese di tempo.
Comitato delle regioni
È un organo a carattere consultivo che affianca il Comitato economico e sociale per assistere il
Parlamento, Consiglio e Commissione; esso è stato istituito dal Trattato di Maastricht.
È composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali nominati per 5 anni, rinnovabili
dal Consiglio.
I membri, in egual numero a quelli del Comitato economico sociale, non devono essere vincolati
da alcun mandato al fine di assicurare la loro indipendenza.
Il Comitato designa il proprio presidente che rimane in carica per due anni e mezzo.
È consultato obbligatoriamente dal Parlamento, Consiglio o Commissione nei casi previsti, con
termini simili a quelli del Comitato economico sociale.
Banca Europea degli Investimenti (BEI)
Ha personalità giuridica e autonomia finanziaria, agisce in modo indipendente sui mercati
finanziari senza scopo di lucro e nei limiti del perseguimento degli obiettivi dell'UE.
~ 14 ~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
Ogni Stato è membro della BEI, essa è amministrata e gestita da un Consiglio di governatori
composto dai ministri degli Stati, da un Consiglio di amministrazione che gestisce l'ordinaria
amministrazione e da un Comitato direttivo con funzioni esecutive.
Il suo capitale è dato dagli Stati secondo quote che si basano sulla ponderazione dei voti a ogni
Stato attribuita.
Le deliberazioni del Consiglio dei governatori sono adottate a maggioranza dei membri che
rappresenta almeno il 50% del capitale.
L'Unione Economica Monetaria (UEM)
Le banche centrali nazionali sono integrate nel sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e
devono eseguire le istruzioni degli organi della Banca centrale europea (BCE).
Il SEBC si configura come indipendente sia dagli Stati che dalle istituzioni dell’Unione.
Nel 2011 è stato adottato un “Patto di stabilità e crescita” per le modalità di sorveglianza
preventiva e di controllo e di sanzioni.
Nel 2013 25 Stati membri hanno sottoscritto il Fiscal Compact, per la stabilità e il
coordinamento e la governance nella UEM.
La politica monetaria viene decisa dalla BCE, la realizzazione dell'Unione monetaria è prevista
in 3 fasi:
Prima fase Trattato di Maastricht con oggetto la totale liberalizzazione della
circolazione dei capitali;
Seconda fase 1 gennaio 1994 per adeguare le situazioni economiche degli Stati sulla
base di parametri di convergenza. La sorveglianza di questi parametri era affidata
all'Istituto monetario europeo (IME. Con la BCE, l'IME non ha più esercitato queste
funzioni);
Terza fase 1 gennaio 1999, sostituzione dell'€ alle monete nazionali sulla base di tassi
di cambio predefiniti e trasferimento delle competenze in materia di politica monetaria
dagli Stati all'UE. Solo 18 Stati hanno aderito all’ euro zona, altri infatti hanno scelto di
avvalersi della clausola di “opting out” (Regno Unito e Danimarca), ovvero, non
soddisfacendo alcuni criteri di convergenza, usufruiscono dello status di “Stati membri
con deroga”.
Banca Centrale Europea (BCE)
Ha carattere indipendente, è l'organo centrale dell'Unione economica e monetaria. Il suo statuto
è definito dal protocollo allegato al Trattato.
I suoi organi sono:
Consiglio direttivo composto dai membri del Comitato esecutivo e dai governatori delle
banche centrali degli Stati la cui moneta è l'€, ogni membro ha un voto e le decisioni sono
prese a maggioranza semplice. Il quorum è dei 2/3 dei membri;
Comitato esecutivo è responsabile della preparazione delle riunioni del Consiglio
direttivo. Il presidente e il vicepresidente e altri quattro membri sono nominati dal
Consiglio europeo a maggioranza qualificata su raccomandazione del Consiglio e previa
consultazione del Parlamento e del Consiglio direttivo BCE, la durata del loro mandato
è di otto anni e non sono rinnovabili. Delibera a maggioranza semplice, in caso di parità
prevale il voto del presidente;
Consiglio generale è composto dal presidente e dal vicepresidente della BCE e i
governatori delle banche centrali nazionali. Partecipa alla funzione consultiva della BCE
e contribuisce a fissare i tassi di cambio delle monete degli Stati, può presentare
osservazioni prima che il Consiglio direttivo adotti gli atti di sua competenza.
~ 15 ~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
La BCE non è soggetta a controlli. È previsto che il presidente trasmetta al Consiglio,
Commissione, Consiglio europeo e Parlamento una relazione annuale.
La BCE dispone di un autonomo potere normativo e può ricorrere alla Corte di giustizia, inoltre
divide con la Commissione il potere di iniziativa.
Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC)
L'obiettivo principale del sistema è mantenere la stabilità dei prezzi e sostenere le politiche
economiche generali nell'Unione; esso agisce in conformità del principio di un'economia di
mercato aperta e in libera concorrenza.
Il SEBC è retto dagli organi decisionali della Banca centrale europea, che opera per
l'assolvimento dei suoi compiti.
Procedimenti interistituzionali
I Trattati istitutivi codificano le procedure necessarie per l’adozione degli atti dell’Unione:
Procedura consultiva l’atto del Consiglio viene adottato su proposta della
Commissione, previo parere del Parlamento obbligatorio ma non vincolante. Se il
Parlamento non si esprime in un termine ragionevole, l’atto può essere validamente
adottato. Secondo la Corte è obbligatoria una nuova consultazione del Parlamento
quando la proposta iniziale è modificata dalla Commissione, o quando le modifiche
sostanziali sono apportate dal Consiglio al testo proposto dalla Commissione.
(procedura legislativa speciale);
Procedure di cooperazione la posizione comune, adottata dal Consiglio su proposta
della Commissione, veniva trasmessa al Parlamento che poteva proporre emendamenti,
sui quali si pronunciava la Commissione. Questi venivano riesaminati in seconda lettura
dal Consiglio, che poteva decidere in via definitiva. Questa procedura è stata
abbandonata col Trattato di Lisbona;
Procedura di codecisione introdotta dal Trattato di Maastricht. L’iniziativa è della
Commissione, che la propone sia al Consiglio che al Parlamento. Il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata. Se il Parlamento respinge l’atto a maggioranza assoluta, o se
una delle due istituzioni non approva il progetto comune elaborato dal comitato, o se
questo non elabora un progetto di accordo condiviso, l’atto non si adotta.
(procedura legislativa ordinaria);
Procedura del parere conforme richiede il parere conforme del Parlamento per l’esame
delle domande di adesione di altri Stati europei e per la stipulazione degli accordi di
associazione. Confermata dal Trattato di Maastricht. (procedura legislativa speciale).
In alcuni casi limitati, il Consiglio può decidere anche senza consultazione del Parlamento
europeo, o previa consultazione di altri organi consultivi; ciò avviene per esempio in materia di
unione doganale o mercato interno.
La possibilità di adottare atti legislativi è invece esclusa per il Consiglio europeo, e non è
prevista nella materia della PESC, nel cui contesto il potere decisionale è appannaggio del
Consiglio e del Consiglio europeo, mentre Commissione e Parlamento svolgono un ruolo solo
marginale. Gli atti normativi della BCE seguono una procedura di adozione diversa.
In alcuni casi specifici l’iniziativa normativa può provenire anche da un gruppo di Stati o dal
Parlamento, o su raccomandazione della BCE o su richiesta della Corte di giustizia o dela BEI.
L’iniziativa della Commissione inoltre può essere sollecitata dal Parlamento o dal Consiglio o
da 1 milione di cittadini dell’Unione apartenenti a più Stati membri (“iniziativa dei cittadini”),
e in alcuni casi limite anche da un singolo Stato membro.
~ 16 ~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
Finchè il Consiglio non abbia deliberato, la Commissione può modificare o anche ritirare la
propria proposta.
La Commissione non ha potere d’iniziativa in materia di PESC e con riguardo agli atti adottati
dalla Banca europea.
Procedura legislativa ordinaria
Procedura legislativa speciale
La procedura legislativa speciale si ha in alcuni casi in alternativa a quella ordinaria, quando
l’adozione di un regolamento o di una direttiva o di una decisione avviene da parte del
Parlamento con la partecipazione del Consiglio o viceversa. Ciò crea un disequilibrio a favore di
uno o dell’altro a seconda dei casi.
In queste procedure inoltre, spesso il Consiglio delibera all’unanimità, mentre nella procedura
ordinaria lo fa a maggioranza qualificata.
Si torna perciò in sostanza alla procedura consultiva quando il parere del Parlamento (da fornire
in termini ragionevoli) deve essere obbligatoriamente chiesto dal Consiglio, pena l’illegittimità.
Questa procedura è utilizzata per la lotta alle discriminazioni e per la sicurezza sociale e per
decisioni in materia di voto.
Si fa inoltre riferimento anche alla procedura del parere conforme (ora denominata “previa
approvazione del Parlamento europeo”), utilizzata per la lotta alla discriminazione e attivazione
della clausola di flessibilità e per la sospensione dei diritti e per la cooperazione rafforzata e per
l’ammissione di nuovi membri e per il recesso.
~ 17 ~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
Le procedure legislative speciali possono sostituire quella ordinaria a seguito di una decisione
unanime del Consiglio europeo.
Procedura di conclusione degli accordi internazionali
La Commissione (o l’Alto rappresentante se in materia di PESC) rivolge al Consiglio una
raccomandazione con cui chiede l’autorizzazione ad aprire i negoziati. Il Consiglio adotta a
maggioranza qualificata, ma può anche designare un comitato speciale.
Concordato il progetto, il negoziatore lo sottopone al Consiglio, il quale adotta una decisione.
Il Consiglio adotta la decisione e notifica alla controparte.
La conclusione definitiva si ha con lo scambio o il deposito dell’atto di approvazione (procedura
solenne).
È prevista una procedura semplificata: il Consiglio può abilitare il negoziatore a concludere
l’accordo con la semplice firma.
La decisione di conclusione viene adottata previa consultazione del Parlamento (tranne in
materia di PESC).
Il Parlamento può chiedere al Consiglio di non autorizzare l’apertura dei negoziati prima di un
parere parlamentare.
A negoziati conclusi, ma prima della firma dell’accordo, il progetto è sottoposto al Parlamento
per il parere o l’approvazione. In caso di parere negativo, il Presidente del Parlamento può
chiedere al Consiglio di non concludere l’accordo. Il Parlamento si esprime a maggioranza dei
voti espressi.
Quando l’accordo verte su materie rientranti nelle competenze sia dell’Unione che degli Stati
membri, si hanno gli accordi misti o in forma mista: conclusi congiuntamente sia dal Consiglio
sia dagli Stati membri, i quali dovranno provvedere alla loro ratifica secondo le procedure
costituzionali interne: l’Unione può concludere l’accordo solo dopo la ratifica di tutti gli Stati
membri.
Se l’accordo comporta emendamenti dei Trattati, la Corte di giustizia può essere consultata da
uno Stato membro in via preventiva. Il parere della Corte ha dunque carattere vincolante.
Adozione del bilancio
Il bilancio annuale dell’Unione si colloca e deve rispettare il quadro finanziario pluriennale,
stabilito per almeno cinque anni, e tratta “risorse proprie”. Spetta formalmente al Presidente
del Parlamento constatare l’adozione del bilancio.
Procedura di adozione del bilancio:
La Commissione redige un progetto che presenta al Parlamento e al Consiglio entro il 1°
settembre dell’anno precedente;
Il Consiglio adotta la sua decisione e la comunica al Parlamento entro il 1° ottobre;
Il Parlamento ha a disposizione 42 giorni per pronunciarsi:
Se approva, o non delibera bilancio adottato;
Oppure apporta emendamenti.
Il progetto viene trasmesso al Consiglio e alla Commissione:
Se il Consiglio approva bilancio adottato;
Se il Consiglio entro dieci giorni non approva comitato di conciliazione.
Il comitato di conciliazione ha 21 giorni per trovare un progetto comune a maggioranza
qualificata dei membri del Consiglio e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento:
Se l’accordo viene raggiunto Parlamento e Consiglio hanno 14 giorni per
approvare;
~ 18 ~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
Se l’accordo non viene raggiunto la Commissione deve presentare un nuovo
progetto di bilancio.
Se le due istituzioni approvano il progetto comune bilancio adottato;
Se il Parlamento approva il progetto comune a maggioranza dei suoi membri e dei 3/5
dei voti espressi, mentre il Consiglio lo respinge bilancio adottato.
In attesa dell’adozione del bilancio, si applica il regime dei dodicesimi provvisori, cioè le spese
effettuate non possono superare 1/12 dei crediti aperti nel bilancio dell’esercizio precedente.
Il Parlamento, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione dell’esecuzione del
bilancio (decisione di “discarico” o di “scarico”).
Il rifiuto di concedere l’atto di discarico alla Commissione comporta una richiesta formale di
chiusura dei conti per l’esercizio in questione con l’invito alla Commissione di rilasciare una
dichiarazione: si tratta di un provvedimento politico grave, che deve essere deciso a maggioranza
assoluta dei membri del Parlamento, paragonabile per certi versi alla mozione di censura.
Sistema normativo
Secondo il sistema delle fonti al vertice dell’ordinamento dell’Unione si pongono le norme dei
Trattati e atti aventi forza di Trattati su cui essa si fonda:
Trattato sull’Unione europea (TUE);
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
I Trattati prevedono inoltre un sistema di fonti di “diritto derivato”, costituite dagli atti
normativi con carattere vincolante.
Le modifiche ai trattati istitutivi possono esserci solo nel rispetto dei Trattati stessi (TUE e
TFUE). Si definiscono diverse procedure come la procedura formale di revisione (ordinaria o
semplificata)
Procedura di revisione ordinaria
L’iniziativa può provenire dagli Stati membri, o dal Parlamento, o dalla Commissione che
sottopongono i progetti al Consiglio, il quale li trasmette al Consiglio europeo e li notifica ai
parlamenti nazionali.
Se il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento e della Commissione, si pronuncia
a maggioranza semplice a favore, il suo presidente convoca una Convenzione del Parlamento e
della Commissione (se verte in materia monetaria si richiede anche il parere della BCE),
formata da rappresentanti dei parlamenti nazionali e capi di Stato o di governo.
La Convenzione adotta “per consenso” una raccomandazione, trasmessa ad una apposita
Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, la quale stabilisce le modifiche
da apportare ai Trattati.
L’atto finale entra in vigore dopo la ratifica da parte di ogni Stato membro.
Se, decorsi due anni dalla firma di un trattato di revisione, i 4/5 degli stati hanno ratificato ed
uno o più altri no, si rimanda al Consiglio europeo.
Procedura di revisione semplificata
Si divide in due procedure:
Relativa alla modifica totale o parziale della parte terza del TFUE l’iniziativa proviene
dagli Stati membri, o dal Parlamento, o dalla Commissione, e il Consiglio europeo
deliberando all’unanimità, previa consultazione di Parlamento e Commissione, adotta
~ 19 ~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
una decisione che modifica le disposizioni in materia, la decisione entra in vigore dopo
l’approvazione degli Stati membri;
Per un settore in cui decide il Consiglio all’unanimità oppure per casi in cui il Consiglio
può adottare la procedura ordinaria in luogo di quella speciale prevista dal TFUE le
decisioni sono assunte dal Consiglio all’unanimità, previa approvazione del Parlamento
che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. La proposta di modifica
viene poi trasmessa ai parlamenti nazionali e, se entro sei mesi, un parlamento nazionale
si oppone, allora non si adotta. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può
procedere all’adozione senza la necessità di ratifica da parte degli Stati membri.
Senza modificare propriamente i Trattati si può però giungere ad un ampliamento o
integrazione delle loro disposizioni grazie alla clausola di flessibilità (art. 352 TFUE) che
consente alle istituzioni l’esercizio delle competenze sussidiarie quando risultino necessarie
per raggiungere uno degli obiettivi dell’Unione.
Principi dell’ordinamento dell’Unione europea
Si tratta per lo più di principi frutto dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia
e sono fonte non scritta del diritto dell’Unione. Gerarchicamente o principi generali hanno un
rango superiori agli atti normativi.
Possono distinguersi grosso modo:
Princìpi generali di diritto relativi ad ogni sistema giuridico (principio di legalità con i
concetti di processo equo e contradditorio, diritto alla riservatezza, certezza del diritto,
non retroattività, rispetto dei diritti quesiti, legittimo affidamento, ne bis in idem, nulla
poena sine lege, buona fede, arricchimento senza causa, forza maggiore ed equità);
Princìpi generali propri del diritto dell’Unione (solidarietà, leale cooperazione,
responsabilità, preferenza comunitaria, equilibrio istituzionale, mutuo riconoscimento,
effetto utile, proporzionalità, sussidiarietà, uguaglianza, libera circolazione, libertà di
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione in ragione del sesso e
dell’orientamento sessuale o dell’età);
Il Consiglio delibera all’unanimità, previa approvazione del Parlamento per l’accordo
dell’adesione dell’Unione alla CEDU e che l’entrata in vigore di tale decisione sia
subordinata all’approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme
costituzionali. L’accordo entra in vigore dopo tre mesi dalla data in cui tutti gli Stati
membri della CEDU l’abbiano ratificato e sia approvato con decisione unanime del
Consiglio.
Carta dei diritti fondamentali
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione viene proclamata il 7 dicembre 2000 in occasione
del Consiglio europeo di Nizza da parte del Parlamento, Consiglio e Commissione e
successivamente modificata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo.
La Carta costituisce un insieme dei princìpi e delle libertà fondamentali ritenuti valori comuni
agli Stati dell'Unione, ricavati dei vari strumenti internazionali in materia di tutela dei diritti
dell'uomo, dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati, dai trattati comunitari ed agli atti
delle istituzioni tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea
dei diritti dell'uomo.
I sei capi sono intitolati:
Dignità;
Liberta;
Uguaglianza;
Solidarietà;
~ 20 ~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
Cittadinanza;
Giustizia.
Inizialmente, fino al Trattato di Lisbona, la Carta aveva valore solo di un solenne impegno
assunto dalle istituzioni. Tuttavia, ha subito contribuito a conferire maggiore peso ai diritti
fondamentali che trovano tutela nell'ordinamento dell'Unione con una loro precisazione e un
loro ampliamento oltre quelli tradizionalmente affermati e già rappresentati per la Corte di
giustizia. L'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea elimina i dubbi sull'efficacia giuridica
della Carta:
Maggiore caratterizzazione costituzionale al Trattato di Lisbona;
Tutela dei diritti dell'uomo non più solo affidata al giudice dell’Unione, ma anche alle
altre isitutzioni anche a livello nazionale;
Rende visibili e certi tali diritti e conferisce maggiore efficacia alla loro tutela;
Realizza un sistema integrato di tutela dei diritti fondamentali affidato alle Corti
costituzionali interne e alla Corte di giustizia in un ambito europeo ampio, anche alla
Corte europea dei diritti dell'uomo per cui il cittadino europeo può usufruire di un triplice
sistema di tutela;
Sancisce nuovi diritti rispetto a quelli classici e a quelli della CEDU;
Introduce nuovi diritti nella terza generazione sotto forma di princìpi;
Vi sono tuttavia degli interrogativi:
Una sovrapposizione di diritti che può sollevare conflitti sostanziali e incertezze per la
prevalenza e la compatibilità degli uni rispetto agli altri;
La mancanza di coordinamento tra la disciplina sostanziale e quella procedurale; non è
prevista la possibilità di ricorsi diretti alla Corte di giustizia da parte degli individui per
violazione di un diritto fondamentale;
L'assenza di una gerarchia formale tra le forme che tutelano i diritti fondamentali
dell'uomo e le altre norme dei Trattati;
Ci possono essere dei conflitti di competenza e contrasti giurisprudenziali tra la Corte di
giustizia e la Corte di Strasburgo sull'interpretazione e la portata di determinati diritti.
Accordi internazionali
Si tratta degli accordi conclusi dall’Unione con gli Stati terzi e si pongono ad un livello superiore
rispetto alla norme derivate, ma comunque inferiore ai Trattati.
Possono produrre effetti diretti negli ordinamenti nazionali anche qualora la stessa efficacia
non venga riconosciuta nell’ordinamento giuridico degli Stati contraenti.
Gli Stati membri non possono concluderli in materie esclusive dell’Unione.
Diritto derivato
La produzione normativa dell'Unione si applica attraverso l'emanazione di atti da parte delle
istituzioni nei limiti delle competenze attribuite secondo l'articolo 288 del TFUE. Tali atti non
hanno gerarchia e il contrasto tra di essi si risolve con criteri di specialità e successione nel
tempo, inoltre sono caratterizzati dalla motivazione, che è considerata un elemento sostanziale,
la cui mancanza comporta l’invalidità dell’atto. Essa deve evidenziare l’iter logico seguito
dall’istituzione che promana l’atto. Si distinguono tra:
Atti vincolanti:
Regolamenti sono atti di portata generale e validi erga omnes. Sono inoltre
direttamente applicabili, anzi qualsiasi misura di recepimento è considerata
illegittima. Si distingue tra regolamenti di base, adottati dal legislatore dell’Unione,
e regolamenti di esecuzione, emanati per l’attuazione dei primi, solitamente adottati
~ 21 ~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
dalla Commissione o dal Consiglio previo conferimento dei poteri necessari. Devono
essere conformi al regolamento base, pena l’invalidità. I regolamenti sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella sezione L (dedicata alla
Legislazione) ed entrano in vigore dal ventesimo giorno; l’entrata in vigore è
immediata per motivi d’urgenza. L’efficacia retroattiva è esclusa;
Direttive sono vincolanti per gli Stati a cui sono rivolte (non hanno quindi portata
generale), con efficacia dal momento della comunicazione, e richiedono un intervento
di attuazione e recepimento da parte degli Stati membri, i quali sono liberi nei mezzi
e nella forma necessari al compimento della direttiva entro il termine previsto dalla
stessa. Se la direttiva implica un obbligo di non fare e, allo scadere del termine, non
sono state attuate le norme di recepimento, in caso di direttiva precisa e chiara, che
crei a favore dei singoli diritti chiaramente individuabili nel loro contenuto, essa
diviene direttamete applicabile nello Stato ed i singoli sono tutelabili in caso di nesso
causale tra il danno sofferto e l‘inerzia dello Stato nel recepimento. La direttiva ha
dunque soli effetti verticali in quanto il singolo può rifarsi solo contro l’inadempenza
dello Stato e non può far valere le disposizioni della direttiva anche nei confronti di
altri soggetti privati (effetto orizzontale);
Decisioni sono atti vincolanti prevalentemente di portata individuale. Ha effetti
diretti quando rivolta a soggetti privati. Le decisioni che designano i destinatari
devono essere a questi notificate e prendono effetto dalla data di notifica, mentre
quelle che non designano i destinatari vegono pubblicate nella GUUE ed entrano in
vigore nella data fissata o al ventesimo giorno dalla pubblicazione.
Atti non vincolanti:
Pareri sono atti rivolti da una istituzione al destinatario per esternare e far
conoscere il proprio punto di vista su una determinata questione;
Raccomandazioni sono atti che esprimono un invito o un‘esortazione a tenere un
certo comportamento.
Atti atipici:
Regolamenti interni di ciascuna istituzione, non invocabili dal singolo davanti ai
giudici nazionali poichè non rivolti alla tutela dei singoli;
Direttive o pareri o raccomandazioni di una istituzione per un’unaltra.
Atti non previsti:
Comunicazioni;
Conclusioni e risoluzioni;
Programmi d’azione, dichiarazioni, deliberazioni, codici di condotta;
Dichiarazioni comini e accordi interistituzionali.
Funzione giudiziaria
Le competenze del Tribunale sono state modificate dal Trattato di Nizza. Ora viene attribuito
ruolo di giurisdizione di primo grado e competenza generale compresa quella di occuparsi delle
questioni pregiudiziali. I ricorsi di competenza in primo grado del Tribunale sono:
Ricorsi di annullamento degli atti delle istituzioni;
Ricorsi in carenza;
Azione di risarcimento dei danni contro l'Unione;
Controversie tra l'Unione i suoi agenti, sono attribuiti in primo grado al Tribunale della
funzione pubblica a partire dal novembre 2004;
~ 22 ~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
Competenze attribuite in virtù di una clausola compromissoria contenuta nel contratto
di diritto pubblico di diritto privato stipulato dall'Unione.
Tuttavia lo statuto della Corte riserva alla Corte di giustizia i ricorsi presentati da uno Stato in
annullamento in carenza contro un atto od un'omissione del Parlamento, Consiglio, Parlamento
e Consiglio tranne che si tratti di:
Decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea, ovvero gli aiuti di Stato;
Atti del Consiglio in forza di un regolamento riguardante misure di difesa commerciale;
Atti del Consiglio con cui questo esercita competenze di esecuzione.
Spetta al primo avvocato generale dare inizio alla procedura di riesame, secondo queste
condizioni:
La proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia del
Tribunale che si intende sottoporre a riesame;
È fissato ad un mese il termine assegnato alla Corte per decidere se dare seguito alla
richiesta;
Le decisioni sulle questioni oggetto di riesame perciò:
Sono prese secondo una procedura di urgenza;
Le parti della causa davanti al Tribunale o in quella principale possono depositare
memorie ed osservazioni scritte;
Quali sono gli effetti dell' eventuale accoglimento della richiesta di riesame.
Per le tipologie di ricorsi proponibili davanti alle corti dell'Unione, il sistema di tutela
giurisdizionale si articola su due livelli per controllo diretto da parte della Corte e del Tribunale,
sollecitato dai soggetti dell'ordinamento dell'Unione, e il controllo indiretto fondato sulla
cooperazione tra giudice dell'Unione e giudici nazionali.
Procedimenti contenziosi:
Ricorso per infrazione;
Azione di annullamento;
Ricorso in carenza;
Eccezione di validità;
Responsabilità extracontrattuale e contrattuale;
Ricorso contro le sanzioni;
Contenzioso del personale.
La cooperazione giudiziaria si opera invece attraverso il rinvio pregiudiziale.
Procedimenti contenziosi
Ricorso per infrazione
Il ricorso per infrazione ha lo scopo di consentire al giudice dell'Unione di esercitare un controllo
sul rispetto, da parte degli Stati, degli obblighi loro derivanti dalle regole dell'ordinamento
dell'UE.
La funzione è di ristabilire la legalità, più che sanzionare lo Stato membro e non può essere
operara in ambito PESC; la competenza della Corte si attivava solo qualora la controversia tra
Stati membri relativa all’interpretazione o applicazione di atti adottati in tale settore non
potesse esser risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data in cui esso era stato adito da uno dei
suoi membri. Non ha rilevanza la qualità dell’organo che abbia commesso la violazione.
L'oggetto dell'infrazione può essere la mancata comunicazione alla Commissione delle
informazioni richieste in merito all'attuazione degli obblighi imposti da una direttiva.
~ 23 ~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
Lo Stato non può addurre a giustificazione del suo comportamento norme, prassi o situazioni
peculiari del proprio ordinamento interno.
Ci sono due procedure previste, entrambe divise in una fase precontenziosa e in una contenziosa:
Iniziativa della Commissione:
Fase precontenziosa quando la Commissione ritiene che uno Stato ha mancato uno
degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione, per conoscenza diretta o dietro
richiesta di un altro Stato, o sollecitata da un privato, può d’ufficio iniziare la
procedura per inadempimento. La Commissione raccogliere tutti gli elementi di
informazione e di valutazione e può chiedere spiegazioni allo Stato coinvolto che è
tenuto a fornirle nel termine fissato. La mancata risposta può configurare una
violazione del principio di leale collaborazione.
Il primo atto ufficiale della procedura è la lettera di messa in mora o di intimidazione
dove la Commissione comunica allo Stato i motivi del suo intervento, contesta gli
addebiti e invita lo Stato per fare le sue osservazioni entro un termine generalmente
di due mesi.
Dopo le spiegazioni dello Stato, la Commissione può decidere di archiviare il caso;
altrimenti può emanare un parere motivato, che chiude la fase precontenziosa, nella
quale si intima lo Stato nel porre fine alla violazione entro un termine in base alla
gravità del caso;
Fase contenziosa presentazione del ricorso alla Corte, qualora lo Stato in causa
non si sia conformato al parere della Commissione nel tempo fissato. Incombe alla
Commissione l’onere di provare l’esistenza di una violazione.
Iniziativa di uno Stato agli Stati è riconosciuta la possibilità di adire la Corte quando
siano o meno parti lese; tuttavia, prima di far ricorso alla Corte, si prevede che debbano
rivolgersi alla Commissione, la quale, dopo aver richiesto agli Stati di presentare in
contraddittorio le loro osservazioni, emette un parere motivato. La Commissione è tenuta
a formulare un parere entro tre mesi dalla domanda: è poi lo Stato reclamante che dovrà
decidere di adire o meno la Corte, la mancata emanazione del parere non impedisce di
ricorrere lo stesso alla Corte.
Procedura abbreviata alcune disposizioni dei Trattati consentono alla Commissione (e a
ciascuno degli Stati membri) di adire direttamente la Corte saltando la fase della procedura
precontenziosa. La Commissione decide entro sei mesi dalla notifica e la sua mancata risposta
si considera come silenzio assenso. Se la Commissione ritiene che uno Stato faccia abuso di tali
facoltà, può adire la Corte in deroga. Infine la Commissione può adire direttamente la Corte nel
caso di abuso di poteri.
Sentenza della Corte la sentenza ha natura dichiarativa quindi verifica l'eventuale
sussistenza della lamentata violazione e non può prescrivere allo Stato che comportamenti
tenere per porre rimedio. Vi è la possibilità che la Corte infligga allo Stato inadempiente una
condanna pecuniaria che può consistere nel pagamento di una somma forfettaria e/o una
penalità di mora, la Corte può decidere senza essere vincolata dalla richiesta della Commissione.
La Commission può adire la Corte dopo la lettera di intimidazione e l’eventuale replica dello
Stato membro interessato, non essendo più necessaria l’adozione del parere motivato.
Azione di annullamento
Il controllo di legittimità degli atti delle istituzioni dell'Unione per ottenere l'annullamento, è
affidato alla competenza esclusiva della Corte di giustizia.
Atti impugnabili l'impugnazione ha per oggetto gli atti vincolanti adottati congiuntamente
dal Parlamento e dal Consiglio (atti legislativi), nonchè gli atti del Consiglio e della
Commissione e della BCE che non sono raccomandazioni o pareri.
~ 24 ~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
Possono essere oggetto di impugnazione anche atti del Parlamento destinati a produrre effetti
giuridici nei confronti dei terzi.
Gli atti della Corte dei Conti tuttora non figurano tra quelli indicati come suscettibili di
impugnazione.
Non sono soggetti a impugnazione i ricorsi diretti contro atti degli Stati membri adottati in
esecuzione degli atti dell’Unione ed anche gli atti produttivi di effetti solo nella sfera interna
delle istituzioni e gli atti che costituiscono fasi intermedie di un procedimento o meramente
preparatori di un atto definitivo.
L’azione di annullamento può insomma essere promossa solo contro il diritto derivato, nonchè
ogni atto che produca effetti giuridici nei confronti dei destinatari.
La Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti dai privati riguardanti il controllo
della legittimità delle decisioni del Consiglio che prevedono misure restrittive nei confronti di
persone fisiche o giuridiche.
Soggetti legittimati a presentare il ricorso in annullamento possono proporre il ricorso:
Ricorrenti privilegiati, ovvero gli Stati e il Consiglio e la Commissione e il Parlamento,
possono impugnare qualsiasi atto senza dover dimostrare che questo incida sulla
posizione giuridica del ricorrente;
Ricorrenti semi-privilegiati, ossia BCE e Corte dei conti, solo se agiscono per la
salvaguardia delle loro prerogative. Può anche il Comitato delle Regioni;
Persone fisiche e giuridiche, a condizioni più restrittive dovendo dimostrare un interesse
ad agire personale, effettivo ed attuale derivante dal prodotto di un pregiudizio. Il ricorso
di annullamento può essere proposto dalle persone fisiche e giuridiche contro la decisione
di cui siano destinatari e contro gli atti che le riguardano individualmente o direttamente
o contro gli atti regolamentari che le riguardano direttamente non richiedono misure di
esecuzione.
Nel decidere sulla ricevibilità del ricorso, la Corte prende in considerazione anche il margine di
apprezzamento lasciato allo Stato: un ricorrente non potrà considerarsi direttamente
interessato quando l’atto dell’Unione lascia un potere discrezionale agli Stati membri per la sua
attuazione, interrompendo così il nesso di cusalità.
Una persona fisica o giuridica può impugnare atti adottati nei suoi confronti ed è legittimato a
ricorrere contro atti che la riguardano direttamente e individualmente ma anche contro atti
regolamentari.
Trascorso il termine per l'impugnazione di due mesi dalla pubblicazione dell'atto o dalla notifica,
l'atto dell'Unione non contestato diventa definitivo.
Motivi di impugnazione, termini dopo due mesi dalla notifica dell'atto o dalla sua
pubblicazione sulla GUUE, i ricorsi possono essere proposti per incompetenza o per violazione
delle forme sostanziali o per violazione dei Trattati o per sviamento di potere. Questi motivi
possono essere sollevati anche d'ufficio. Se si tratta di atti interessati ad altri soggetti, il termine
per la presentazione del ricorso può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato è a
conoscenza del contenuto della motivazione dell'atto. Un eventuale ricorso in annullamento è
ricevibile per:
Incompetenza derivante dall'assenza di un potere dell'Unione o delle istituzioni ad
emanare l'atto. Può configurarsi in una delle ipotesi classiche:
Ratione materiae, l'atto non rientra nella sfera di competenza dell'organo;
Ratione loci, l'atto ha effetti al di fuori del territorio sul quale si esercita la
competenza dell'organo;
Ratione temporis, l'atto è adottato oltre i termini di tempo fissati.
~ 25 ~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
Violazione delle forme sostanziali si rileva sotto tre aspetti:
Garanzia di procedure, relative al formare gli atti con modalità di votazione in seno
alle istituzioni ed al rispetto delle consultazioni obbligatorie;
Rispetto delle forme essenziali, a garanzia degli interessati nella procedura di
adozione degli atti delle procedure non contenziose;
Obbligo di motivazione, che consente agli interessati di comprendere la portata
dall'atto.
Violazione dei trattati o regole di diritto relative alla loro applicazione;
Sviamento di potere l'istituzione utilizza l'atto per perseguire un obiettivo diverso da
quello per il quale i poteri sono stati conferiti.
Effetti della sentenza la sentenza di annullamento ha efficacia erga omnes e ha l'autorità di
cosa giudicata quindi sarà irricevibile un nuovo ricorso contro l'atto già annullato, mentre se
l'atto è stato dichiarato legittimo, un nuovo ricorso è possibile se si fondi su nuovi motivi.
L'istituzione, l'organo che ha emanato l'atto annullato dovrà trarre le conseguenze e adottare
provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta entro un termine ragionevole.
Ricorso in carenza
Offre la possibilità di rivolgersi alla Corte per far constatare il comportamento omissivo delle
situazioni che si astengono dal pronunciarsi in violazione dei Trattati.
Il ricorso è proponibile sono nei confronti del Consiglio e della Commissione e del Parlamento e
della BCE e del Consiglio europeo.
Sono legittimati a proporre ricorso gli Stati membri, tutte le istituzioni dell'Unione diverse dal
responsabile dell'omissione.
Anche ogni persona fisica o giuridica può dire la Corte di giustizia per contestare ad una delle
istituzioni di aver omesso di emanare nei suoi confronti un atto con efficacia vincolante.
Presupposto del ricorso è l'esistenza di un obbligo di agire delle istituzioni in virtù di una regola
di diritto dell'Unione: dunque occorre la mancata adozione di un comportamento dovuto.
Affinché il ricorso sia ricevibile occorre che all'istituzione in causa sia stato preventivamente
richiesto di agire (messa in mora) con una domanda in cui sono indicate con precisione il
contenuto dell'obbligo che si pretende violato e le misure richieste per far cessare l'inerzia.
Se trascorsi due mesi da questa richiesta, l'istituzione diffidata non ha preso posizione, il ricorso
può essere introdotto nei due mesi successivi; se invece ha preso posizione, il ricorso non è più
proponibile anche se non ha reso soddisfazione al richiedente.
La legittimità della posizione può essere contetata con il ricorso in annullamento.
Il ricorso in carenza non è consentito in ambito PESC.
Effetti della sentenza la sentenza del giudice ha carattere dichiarativo, limitandosi ad
accertare l'illiceità del comportamento.
Eccezione di invalidità
Consente anche dopo la scadenza del termine di due mesi, di far valere l'illegittimità di una
portata generale, per invocare la sua inapplicabilità nel corso di una controversia pendente
davanti alla Corte e non avente ad oggetto un regolamento.
L'eccezione invalidità, che non è soggetta ad alcun limite temporale, rappresenta la sola
possibilità per i privati di tutelarsi contro l'applicazione di un regolamento illegittimo contro cui
non hanno potuto proporre azione di annullamento; Dunque non si tratta di una azione
autonoma, in quanto può essere esercitata solo in via incidentale.
~ 26 ~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
L'eccezione non può essere utilizzata durante un procedimento davanti ai giudici nazionali, in
tal caso si deve utilizzare il rinvio pregiudiziale di validità.
Nè uno Stato nè un privato possono sollevare l'eccezione contro una decisione individuale di cui
sono destinatari dovendo in questo caso, ricorrere all'impugnazione diretta.
L'eccezione deve essere sollevata espressamente, non può essere rilavata d’ufficio dal giudice.
La natura incidentale del rimedio comporta che l'atto dichiarato illegittimo dal giudice
dell'Unione non sarà annullato, ma dichiarato non applicabile al caso di specie.
Azione di responsabilità extracontrattuale e contrattuale
L'articolo 268 del TFUE attribuisce al giudice dell'Unione la competenza a conoscere delle
controversie relative al risarcimento dei danni di cui all’art. 340 TFUE.
L'azione di risarcimento può essere presentata contro l'Unione da qualsiasi persona fisica o
giuridica o da parte degli Stati quando ritengono di aver subito un pregiudizio; oppure anche
dal Consiglio o dal Parlamento se il danno è imputato a un atto adottato a seguito della
procedura legislativa ordinaria.
Condizioni di ricevibilità l'azione deve essere proposta entro cinque anni dal momento in cui
avviene il fatto che dà origine al danno. La prescrizione è interrotta dalla domanda presentata
alla Corte o dalla richiesta preliminare che il danneggiato può rivolgere alle istituzioni. La
responsabilità dell’Unione può essere coinvolta se il comportamento delle autorità nazionali è
collegato a un difetto di controllo da parte delle isitituzioni dell’Unione, in particolare della
Commissione, ma comunque solo in caso di colpa grave. La Corte ha introdotto il principio che:
l'azione di risarcimento ha carattere sussidiario rispetto ai ricorsi nazionali.
Condizioni per il sorgere della responsabilità per l'accertamento della responsabilità
extracontrattuale dell'Unione viene attribuito alla Corte di giustizia il compito di rilevare i
princìpi generali e applicarne nel suo apprezzamento discrezionale. Quando il danno è causato
da un agente al di fuori delle sue funzioni istituzionali, non sussiste alcun legame funzionale e
quindi non può venire in rilievo la responsabilità dell'Unione. Il risarcimento dovrà essere
direttamente personale contro l'agente. La Corte ha precisato che la responsabilità dell'Unione
si configura solo per gli atti degli agenti che, in virtù di un rapporto interno, costituiscono il
prolungamento necessario dei compiti affidati alle istituzioni.
Danno risarcibile una volta ritenuta responsabile l'Unione è tenuta ad indennizzare la
vittima del pregiudizio arrecato. Il ricorrente deve provare la sussistenza, l'attualità e
l'effettività del danno. La determinazione dell'ammontare deve tener conto sia delle perdite
subite (damnum emergens) che nel mancato guadagno (lucro cessans) ed eventualmente del
danno morale, oltre che degli interessi.
Responsabilità contrattuale dell'Unione può derivare dai contrasti, regolati dal diritto privato
stipulati con soggetti terzi. La Corte di giustizia dell'Unione è competente a decidere in virtù di
una clausola compromissoria, inserita in un contratto di diritto pubblico o diritto privato
stipulato dall'Unione, o per conto di essa.
Ricorso contro le sanzioni
Ulteriore competenza giurisdizionale della Corte riguarda il controllo sulle sanzioni adottate
dalle istituzioni dell’Unione europea, disciplinata entro gli stessi termini del ricorso in
annullamento.
Contenzioso del personale
La competenza della Corte a conoscere delle controversie tra l'Unione e i suoi agenti, nei limiti
e alle condizioni determinate dallo Statuto del personale riguardante qualsiasi condizione e
~ 27 ~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
modalità nel rapporto di impiego.
Deve essere un atto suscettibile di toccare direttamente una situazione giuridica determinata:
dunque atti individuali, o generali su cui si fonda l'atto individuale impegnato, con l'esclusione
degli atti preparatori. Il ricorrente deve avere un interesse personale ad agire certo ed attuale.
La procedura prevede due fasi:
Prima fase un procedimento amministrativo preliminare, ove il ricorrente si rivolge
all'istituzione chiedendo di adottare una decisione o formulare un reclamo contro l'atto o
l'omissione lamentata, se entro 4 mesi l'istituzione non risponde il silenzio equivale alla
decisione di rigetto;
Seconda fase l'interessato può dire al Tribunale della funzione pubblica: il ricorso
contro atti od omissione delle istituzioni, o contro decisioni implicite di rigetto deve essere
formulato entro tre mesi a partire dalla notifica della decisione o dalla data in cui scade
il termine dei quattro mesi previsti per la pronuncia delle istituzioni.
Cooperazione giudiziaria
Rinvio pregiudiziale
È una procedura che esalta il principio di cooperazione giudiziaria tra giudici dell'Unione e
giudici nazionali attraverso un fattore essenziale di coesione.
La Corte può solo intervenire per fornire ai giudici nazionali le indicazioni utili per l'applicazione
del diritto dell'Unione. La procedura ha due diverse funzioni:
Rinvio pregiudiziale di interpretazione assicurare l'applicazione corretta, uniforme
nel diritto dell'Unione; la Corte ha il compito di fornire criteri per evitare divergenze
nell'applicazione concreta nel diritto dell'Unione nei vari Stati;
Rinvio pregiudiziale di validità garantire il rispetto del principio di legalità evitando
soluzioni difformi.
La procedura pregiudiziale avviata dalla decisione di un giudice interno di adire la Corte quando
reputa che si ponga un problema di interpretazione nel diritto dell'Unione o di validità di un
atto di derivato nel corso di un procedimento pendente dinanzi ad esso.
La disciplina del rinvio pregiudiziale è gestita attraverso due procedure speciali:
L’accesso alla Corte è consentito esclusivamente alle giurisdizioni nazionali avverso le
cui decisioni non può porsi un ricorso giurisidizionale di diritto interno;
La competenza pregiudiziale a pronunciarsi sulla validità e sull'interpretazione delle
decisioni quadro e delle decisioni, sull‘interpretazione delle convenzioni e sulla validità
e l'interpretazione delle misure di applicazione di esse, ma subordinandola ad una
esplicita accettazione della giurisdizione della Corte da parte degli Stati la cui mancanza
determina l'irricevibilità della domanda.
Con il Trattato di Lisbona vi sono due regole particolari che concernono lo sviluppo e lo
svolgimento della procedura pregiudiziale nel settore della competenza giudiziaria e di polizia
in materia penale:
La Corte non è competente ad esaminare la validità e la proporzionalità di operazioni
condotte dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione di una legge di uno
Stato o l'esercizio della responsabilità incombenti agli Stati per il mantenimento
dell'ordine pubblico;
Quando una questione di interpretazione di invalidità si pone in un giudizio pendente
davanti al giudice nazionale, riguardante una persona in detenzione, la Corte statuisce
il più rapidamente possibile.
Rinvio pregiudiziale di interpretazione la competenza pregiudiziale della Corte si estende
anche agli accordi conclusi dagli Stati con Stati terzi ma vincolanti l'Unione. La competenza
~ 28 ~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
della Corte esclusa in ambito PESC e per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati anche se rispetto
a materie di interesse dell'Unione.
Rinvio pregiudiziale di validità consente alla Corte di esercitare un controllo di legittimità
sugli atti delle istituzioni, organi e organismi aventi valore vincolante anche se sprovvisti di
efficacia diretta. Le giurisdizioni nazionali non hanno il potere di dichiarare invalidi gli atti
dell'Unione dovendo adire la Corte se hanno un dubbio sulla loro validità.
Facoltà ed obbligo di rinvio, procedura
Quando davanti ad una giurisdizione nazionale si pone un problema di interpretazione del
diritto dell'Unione di validità di un atto delle istituzioni la cui risoluzione si ritiene necessario
per decidere la controversia, questa deciderà e chiederà alla Corte di pronunciarsi sulla
questione:
Se è un giudice le cui decisioni possono essere sottoposti ad un ulteriore grado di giudizio
e ha la facoltà di rinviare alla Corte, può pronunciarsi esso stesso sull'interpretazione
del diritto dell'Unione e sulla validità di un atto;
Quando si tratta di un giudice avverso le cui decisioni non possono proporsi in un ricorso
in via pregiudiziale, come è il caso, in Italia, esso deve rivolgersi alla Corte.
L'inosservanza di questo dovere può condurre un procedimento di infrazione nei confronti dello
Stato membro cui appartiene l'organo giudiziario per violazione del Trattato.
L'iniziativa di operare il rinvio spetta al giudice interno, può essere sollecitato dalle parti ma
non è tenuto a seguire la loro richiesta di rivolgersi alla Corte nè ad accettare il testo di questi
che propone mentre può decidere di sollevare d’ufficio la questione anche contro il consenso delle
parti.
La questione può essere sollevata in qualsiasi stato del procedimento interno. Per operare il
rinvio ma deve chiarire, gli elementi di fatto e di diritto pertinenti e motivare la sua richiesta di
interpretazione in modo da consentire alla Corte di poter valutare adeguatamente il quesito
posto. Se il giudizio davanti al giudice a quo si è ormai conclusa, la Corte non si ritiene più
competente a conoscere del rinvio.
Tutti hanno la possibilità di presentare memorie ed osservazioni scritte entro due mesi dalla
notifica.
Nozione di "organo giurisdizionale nazionale"
Ci sono alcuni requisiti che gli organi interni devono rispettare per potersi ritenere giurisdizione
e quindi essere abilitate a rivolgere requisiti pregiudiziali:
Obbligatorietà della giurisdizione;
Compito di applicare il diritto;
Carattere permanente dell'organo;
Costituzione per legge;
Indipendenza
Terzietà.
Secondo la teoria della doppia pregiudizialità, spetta al giudice comune proporre quesiti
pregiudiziale alla Corte per poi rivolgersi alla Corte Costituzionale solo quando il dubbio di
costituzionalità della norma interna non può essere superato grazie alla pronuncia della prima.
La Corte costituzionale si ritiene legittimata a sollevare davanti alla Corte di giustizia questioni
pregiudiziali.
~ 29 ~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
Limiti dell'obbligo di rinvio
Vi sono alcune situazioni in cui l'obbligo del rinvio può non sussistere:
Quando la Corte si è già pronunciata in relazione ad analoga fattispecie su una questione
identica e ugualmente anche in presenza di una giurisprudenza costante della Corte che
risolve il quesito anche in assenza di una stretta identità fra le materie del contendere;
L'applicazione del principio dell'atto chiaro accolto dalla Corte di giustizia nella sua
giurisprudenza.
Ricevibilità delle questioni pregiudiziali
La Corte ha ribadito che il suo dovere di pronunciarsi non opera quando risulta il carattere
fittizio della controversia, o sia manifesto che la disposizione del diritto dell'Unione sottoposta
ad interpretazione non può essere applicata nel caso di specie; il carattere fittizio della
controversia deve risultare in modo manifesto dagli elementi di fatto indicati.
La Corte, si è dichiarata comunque competente a fornire al giudice interno gli elementi di
interpretazione del diritto dell'Unione che consentono di accertare la compatibilità per risolvere
la controversia
Natura ed effetti delle sentenze pregiudiziali
Le sentenze pregiudiziali della Corte hanno carattere dichiarativo senza parti e di natura non
contenziosa. Il giudice interno può operare un nuovo rinvio pregiudiziale.
Le sentenze pregiudiziali di interpretazione vincolano il giudiche che ha operato il rinvio ad
applicare la norma dell'Unione come interpretato dalla Corte.
Effetti temporali le sentenze pregiudiziali di interpretazione o dichiarative di invalidità,
hanno effetto retroattivo e si applicano anche a situazioni pregresse sorte prima della sentenza
purché non esaurite. Gli effetti ex nunc della sentenza possono essere decisi.
~ 30 ~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
lOMoARcPSD|8844004
~ 31 ~
Scaricato da salvatore cascella (copystudentbook@gmail.com)
Potrebbero piacerti anche
- Riassunto Diritto Unione Europea Adam Tizzano PDFDocumento58 pagineRiassunto Diritto Unione Europea Adam Tizzano PDFRoccotanosiff100% (3)
- Riassunto Diritto Unione Europea Adam Tizzano PDFDocumento58 pagineRiassunto Diritto Unione Europea Adam Tizzano PDFRoccotanosiff100% (3)
- Riassunto Unione Europea StrozziDocumento45 pagineRiassunto Unione Europea StrozziEleonora MattioliNessuna valutazione finora
- Costituzionale - Barbera-FusaroDocumento20 pagineCostituzionale - Barbera-Fusarothementalist90Nessuna valutazione finora
- Diritto Amministrativo SimoneDocumento31 pagineDiritto Amministrativo SimoneAndrea SpadoniNessuna valutazione finora
- Riassunto Diritto Internazionale PrivatoDocumento30 pagineRiassunto Diritto Internazionale PrivatoLilith993100% (1)
- Dispense Di Istituzioni Di Diritto PubblicoDocumento72 pagineDispense Di Istituzioni Di Diritto Pubblicorafgraz90Nessuna valutazione finora
- Riassunto Libro Corso Di Diritto Pubblico Scienze PoliticheDocumento58 pagineRiassunto Libro Corso Di Diritto Pubblico Scienze PoliticheDavid Del Valli86% (14)
- Riassunto Manuale Di Diritto Civile Di Pietro Perlingieri PDFDocumento210 pagineRiassunto Manuale Di Diritto Civile Di Pietro Perlingieri PDFRaffaellaBaccariNessuna valutazione finora
- Mandrioli RiassuntoDocumento73 pagineMandrioli Riassuntoalteriuris100% (10)
- DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA - Parte Istituzionale G Strozzi R MastroianniDocumento50 pagineDIRITTO DELL UNIONE EUROPEA - Parte Istituzionale G Strozzi R MastroianniFabrizio RomanoNessuna valutazione finora
- Domande Svolte Di Diritto Processuale Civile (Verde, Volumi 1, 2, 3 e 4)Documento71 pagineDomande Svolte Di Diritto Processuale Civile (Verde, Volumi 1, 2, 3 e 4)Carrie1989bq100% (2)
- Adam Tizzano-Lineamenti Di Diritto Dell Unione EuropeaDocumento49 pagineAdam Tizzano-Lineamenti Di Diritto Dell Unione EuropeamanueconomistNessuna valutazione finora
- Manuale Di Diritto Amministrativo, Marcello ClarichDocumento194 pagineManuale Di Diritto Amministrativo, Marcello ClarichAndrea BondiniNessuna valutazione finora
- Capire il diritto amministrativo: attraverso schemi, mappe concettuali e schedeDa EverandCapire il diritto amministrativo: attraverso schemi, mappe concettuali e schedeNessuna valutazione finora
- Riassunto Di Istituzioni Di Diritto Dell'Unione Europea VillaniDocumento29 pagineRiassunto Di Istituzioni Di Diritto Dell'Unione Europea VillaniEdy RoxanaNessuna valutazione finora
- Diritto Regionale Bin FalconDocumento52 pagineDiritto Regionale Bin Falcongioeleaurora100% (1)
- La tutela della Privacy - Sintesi aggiornata per concorsi pubblici: Il Codice di protezione dei dati personali, il diritto di accesso e la trasparenzaDa EverandLa tutela della Privacy - Sintesi aggiornata per concorsi pubblici: Il Codice di protezione dei dati personali, il diritto di accesso e la trasparenzaValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (1)
- Belloni-Le Organizzazioni InternazionaliDocumento44 pagineBelloni-Le Organizzazioni InternazionaliDana ArghirNessuna valutazione finora
- Diritto Dell' Unione EuropeaDocumento34 pagineDiritto Dell' Unione EuropeaWafaaDounaim100% (2)
- Il diritto amministrativo in tasca: 25 schede sintetiche per concorsi ed esamiDa EverandIl diritto amministrativo in tasca: 25 schede sintetiche per concorsi ed esamiValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Riassunto-Strozzi-Estratto-Ed.-2014 2Documento57 pagineRiassunto-Strozzi-Estratto-Ed.-2014 2Chiara CiottiNessuna valutazione finora
- Le Obbligazioni BiancaDocumento110 pagineLe Obbligazioni BiancaCarrie1989bq50% (2)
- Diritto Tributario - Riassunto TESAURO 2014 - Parte SpecialeDocumento62 pagineDiritto Tributario - Riassunto TESAURO 2014 - Parte SpecialeIlaria TranquilloNessuna valutazione finora
- Riassunto Manuale Diritto Internazionale - GioiaDocumento49 pagineRiassunto Manuale Diritto Internazionale - GioiaSpirited AwayNessuna valutazione finora
- Gaja - Adinolfi Introduzione Al Diritto Dell Unione EuropeaDocumento36 pagineGaja - Adinolfi Introduzione Al Diritto Dell Unione EuropeaLista Shine100% (2)
- Diritto AmministrativoDocumento159 pagineDiritto Amministrativo19avantasia87100% (1)
- Riassunti Lezioni Di Diritto Processuale Civile Su Il Processo Civile Manuale PicardiDocumento240 pagineRiassunti Lezioni Di Diritto Processuale Civile Su Il Processo Civile Manuale PicardiCarmela Chiariello100% (1)
- Riassunto Diritto Processuale Civile Parte GeneraleDocumento41 pagineRiassunto Diritto Processuale Civile Parte GeneraleGianmarco BrunoNessuna valutazione finora
- Dispensa Conforti Diritto InternazionaleDocumento99 pagineDispensa Conforti Diritto InternazionaleFabio Agovino100% (1)
- Diritto InternazionaleDocumento71 pagineDiritto Internazionaleappuntigratis_unicam100% (1)
- Procedimento amministrativo e diritto di accesso: Sintesi aggiornata della Legge 241 del 1990 per concorsi pubbliciDa EverandProcedimento amministrativo e diritto di accesso: Sintesi aggiornata della Legge 241 del 1990 per concorsi pubbliciValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (3)
- Gaja - Adinolfi Introduzione Al Diritto Dell Unione EuropeaDocumento36 pagineGaja - Adinolfi Introduzione Al Diritto Dell Unione EuropeaLista Shine100% (2)
- Diritto Dell' Unione EuropeaDocumento34 pagineDiritto Dell' Unione EuropeaWafaaDounaim100% (2)
- Diritto Dell'Unione DanieleDocumento64 pagineDiritto Dell'Unione DanieleWalter Romano100% (2)
- Riassunto Villani 2016Documento93 pagineRiassunto Villani 2016Umberto_Aprior_4254Nessuna valutazione finora
- VillaniDocumento40 pagineVillanirobella1992Nessuna valutazione finora
- Istituzioni Di Diritto Unione Europea Riassunto VillaniDocumento121 pagineIstituzioni Di Diritto Unione Europea Riassunto VillaniAngela ArgentoNessuna valutazione finora
- Adam Tizzano-Lineamenti Di Diritto Dell Unione Europea PDFDocumento49 pagineAdam Tizzano-Lineamenti Di Diritto Dell Unione Europea PDFGiada SollaiNessuna valutazione finora
- Fiscalità Internazionale - I sistemi antievasione tra gli Stati dell’Unione EuropeaDa EverandFiscalità Internazionale - I sistemi antievasione tra gli Stati dell’Unione EuropeaNessuna valutazione finora
- Tutor Magistralis. Compendio di diritto pubblico per concorsi pubblici: Per concorsi pubblici nel settore GiustiziaDa EverandTutor Magistralis. Compendio di diritto pubblico per concorsi pubblici: Per concorsi pubblici nel settore GiustiziaNessuna valutazione finora
- L'Europa dei Popoli o degli Stati?: L'integrazione spiegata attraverso il diritto dell'Unione europeaDa EverandL'Europa dei Popoli o degli Stati?: L'integrazione spiegata attraverso il diritto dell'Unione europeaNessuna valutazione finora
- Riassunto Ronzitti Dir. InternazDocumento66 pagineRiassunto Ronzitti Dir. InternazMarcoLeopizziNessuna valutazione finora
- DIRITTO TRIBUTARIO AppuntiDocumento106 pagineDIRITTO TRIBUTARIO AppuntiMatteo CeredaNessuna valutazione finora
- AmministrativoDocumento92 pagineAmministrativoFabiana NobertiNessuna valutazione finora
- Riassunto - Manuale Diritto PrivatoDocumento366 pagineRiassunto - Manuale Diritto Privatotwixt100% (2)
- Riassunto Diritto Del Lavoro E. Ghera 2010Documento162 pagineRiassunto Diritto Del Lavoro E. Ghera 2010Francesco BenedettoNessuna valutazione finora
- Diritto EcclesiasticoDocumento27 pagineDiritto Ecclesiasticoappuntigratis_unicamNessuna valutazione finora
- Riassunto Istituzioni Di Diritto Processuale Civile Balena Vol IDocumento76 pagineRiassunto Istituzioni Di Diritto Processuale Civile Balena Vol IFederica Di ChioNessuna valutazione finora
- Compendio Di Procedura Penale, A Cura Di G. CONSO, V. GREVI, M. BARGIS, Cedam, Padova, 2014Documento109 pagineCompendio Di Procedura Penale, A Cura Di G. CONSO, V. GREVI, M. BARGIS, Cedam, Padova, 2014Corrado Maria PetrucciNessuna valutazione finora
- Diritto PubblicoDocumento22 pagineDiritto PubblicoPaolo De Laurentis100% (1)
- Riassunto Libro Di Diritto Internazionale Di Conforti - Parte 1Documento26 pagineRiassunto Libro Di Diritto Internazionale Di Conforti - Parte 1Simone PianeselliNessuna valutazione finora
- Compendio Diritto Amministrativo - Elio Casetta FinaleDocumento36 pagineCompendio Diritto Amministrativo - Elio Casetta FinaleShirley QuattrocchiNessuna valutazione finora
- Diritto TributarioDocumento157 pagineDiritto TributarioMarcoNessuna valutazione finora
- Diritto Processuale CivileDocumento72 pagineDiritto Processuale CivileChiara Ruby Tuesday ScarcelloNessuna valutazione finora
- Lezioni Di Diritto AmministrativoDocumento30 pagineLezioni Di Diritto AmministrativoViorel.s0% (1)
- DIRITTO INTERNAZIONALE RiassuntiDocumento5 pagineDIRITTO INTERNAZIONALE Riassuntialteriuris100% (4)
- Diritto Amministrativo CasettaDocumento236 pagineDiritto Amministrativo CasettaFedericaGennaro60% (5)
- Riassunto Libro Compendio Di Diritto TributarioDocumento80 pagineRiassunto Libro Compendio Di Diritto TributarioMattia ZuccaNessuna valutazione finora
- PERLINGIERI DocxDocumento143 paginePERLINGIERI DocxMaria Antonia Adesso100% (1)
- 40 Funzionari Amministrativi Scolastici - Le norme anticorruzione, gli obblighi di trasparenza e pubblicitàDa Everand40 Funzionari Amministrativi Scolastici - Le norme anticorruzione, gli obblighi di trasparenza e pubblicitàNessuna valutazione finora
- Concorso Istruttore Enti Locali - Servizi pubblici locali: Sintesi ragionata per concorsi pubbliciDa EverandConcorso Istruttore Enti Locali - Servizi pubblici locali: Sintesi ragionata per concorsi pubbliciNessuna valutazione finora
- APERTE Diritto Unione Europea EcampusDocumento23 pagineAPERTE Diritto Unione Europea EcampusRaffaele MondoNessuna valutazione finora
- Dispensa - Diritto Dell'Unione Europea (Compendio)Documento93 pagineDispensa - Diritto Dell'Unione Europea (Compendio)Bruno MercurioNessuna valutazione finora
- MULTIPLE Diritto Unione Europea EcampusDocumento15 pagineMULTIPLE Diritto Unione Europea EcampusRaffaele MondoNessuna valutazione finora
- Corso-Di-Diritto-Pubblico-Augusto-Barbera-E-Carlo-Fusaro X EdizioneDocumento94 pagineCorso-Di-Diritto-Pubblico-Augusto-Barbera-E-Carlo-Fusaro X Edizionecamilla pomponioNessuna valutazione finora
- Diritto Dell Unione Europea Tesauro 6 EdizioneDocumento194 pagineDiritto Dell Unione Europea Tesauro 6 EdizionecescozNessuna valutazione finora
- Diritto Dell - Unione Europea - Strozzi Parte Istituzionale - 1-2.sbloccatoDocumento22 pagineDiritto Dell - Unione Europea - Strozzi Parte Istituzionale - 1-2.sbloccatocescozNessuna valutazione finora
- Bando Garanzia Giovani Regione CampaniaDocumento36 pagineBando Garanzia Giovani Regione CampaniapaolinoNessuna valutazione finora
- Unione EuropeaDocumento19 pagineUnione EuropeaNico PandaNessuna valutazione finora
- StrategiDalla Strategia Di Lisbona A Europa 2020a Di LisbonaDocumento498 pagineStrategiDalla Strategia Di Lisbona A Europa 2020a Di LisbonaNinoVassalloNessuna valutazione finora
- Diritto Dell'unione EuropeaDocumento5 pagineDiritto Dell'unione EuropeaAshley HughesNessuna valutazione finora
- Ue - File UnicoDocumento174 pagineUe - File UnicoSilvia DchNessuna valutazione finora
- Unione EuropeaDocumento13 pagineUnione EuropeaAnnarita IaiaNessuna valutazione finora
- Barbera FusaroDocumento20 pagineBarbera Fusaro0000Nessuna valutazione finora
- Appunti Di Geografia Le Regioni EuropeeDocumento162 pagineAppunti Di Geografia Le Regioni EuropeeA MNessuna valutazione finora
- RelazioneDocumento1.672 pagineRelazioneacoohayNessuna valutazione finora
- Docsity Riassunto Completo Elementi Di Diritto Dell Unione Europea Draetta Bestagno Santini 2018Documento96 pagineDocsity Riassunto Completo Elementi Di Diritto Dell Unione Europea Draetta Bestagno Santini 2018mahashakerNessuna valutazione finora
- Diritto Unione EuropeaDocumento31 pagineDiritto Unione EuropeaLucrezia PuerariNessuna valutazione finora
- Diritto UeDocumento57 pagineDiritto UemahashakerNessuna valutazione finora
- Adam Tizzano-Lineamenti Di Diritto Dell Unione Europea PDFDocumento49 pagineAdam Tizzano-Lineamenti Di Diritto Dell Unione Europea PDFGiada SollaiNessuna valutazione finora
- 5) Unione Europea. Fatti e CifreDocumento82 pagine5) Unione Europea. Fatti e CifreFrancesca Della BiancaNessuna valutazione finora