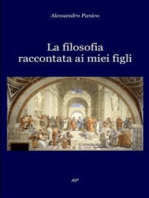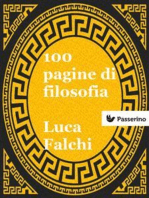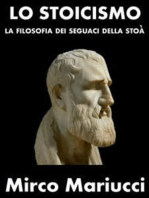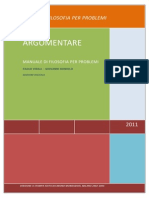Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Storia Della Filosofia Antica
Caricato da
Aldo ChellaTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Storia Della Filosofia Antica
Caricato da
Aldo ChellaCopyright:
Formati disponibili
lOMoARcPSD|5511223
Storia della Filosofia Antica
Filosofia (Università degli Studi di Napoli Federico II)
StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
Prima Ora
Sulle fonti antiche e sul modo antico e moderno di leggerle, su Talete.
Opere e frammenti Le fonti antiche presentano molti problemi di approccio.
Il primo problema è quello della Frammentarietà delle opere, soprattutto per i preplatonici di cui
non possediamo direttamente le opere, dunque ricostruiamo il loro pensiero sulla base di citazioni
di queste opere da posteriori. Le principali Fonti sono Platone (IV sec. a.C) Simplicio (VI sec. a.C.),
Aristotele, Plutarco.
Diels e Kranz distinsero le fonti in frammenti e testimonianze.
I frammenti costituiscono le citazioni, le testimonianze racconti sulla vita e sulle dottrine dei
presocratici.
Nel libro si parlerà di preplatonici più che di presocratici, pure per sottolineare il fatto che è stato
proprio Platone il primo a riflettere sulle dottrine.
La nascita della filosofia Un problema dello studioso moderno è quello della nascita della filosofia.
Una vecchia tesi è quella che interpretava la nascita della filosofia come il passaggio dal Mythos al
Logos, ossia il passaggio da una mentalità che si era espressa in racconti su dei e cosmogonie ad una
mentalità più razionali. Tuttavia mito e filosofia non possono considerarsi totalmente distinte.
Il primo riconosciuto come filosofo tradizionalmente è Talete di Mileto (VII – VI sec. a.C.), che si
interesava di matematica, geometria e scienze naturali. Il titolo gli è riconosciuto poiché è stato il
primo ad osservare la natura e a cercare cause oltre il divino. Secondo Aristotele egli è stato il primo
a porsi il problema dell’Archè, cioè del principio di tutte le cose.
Il pensiero di Talete Egli coniugava osservazione esperienza e ragionamento, andando oltre
l’aspetto scientifico, per esempio ipotizzando che l’acqua fosse il principio di tutte le cose dà
dimostrazione di come la filosofia sia un insieme di astrazione e fantasia che permetto di offridre
una spiegazione unitaria del mondo.
Secondo Snell la filosofia ha origine in Grecia proprio perché i Greci disponevano di un linguaggio
adatto alla formazione di concetti astratti. In particolare disponevano dell’articolo determinativo
che permetteva loro di fissare concetti universali utilizzando aggettivi o verbi preceduti dall’articolo
determinativo.
Secondo Havelock un punto fondamentale è stata l’invenzione dell’Alfabeto greco, che ha permesso
di passare dall’oralità alla scrittura.
Seconda Ora (VII-VI sec a.C.)
Su Anassimandro e Anassimene; sulle storie della filosofia antiche e moderne.
Anassimandro e l’àperion Il primo filosofo greco di cui possediamo un frammento è
Anassimandro (VII-VI sec a.C)
Dai frammenti rinvenuti per Anassimandro il principio di tutte le cose è indefinito (àperion), privo
cioè di que i limiti (pèirata) che caratterizzano le cose che cadono sotto i nostri sensi. Prima e dopo
le singole realtà c’è l’indeterminato e la determinazione viene vista come una colpa morale che
l’ordine del tempo si incarica di punire.
Bisogna sottolineare che nei preplatonici nessuno riconosce debiti intelletuali nei confronti dei
predecessori.
Anassimene e il pnèuma Contemporaneo di Anassimandro è Anassimene di Mileto (VI sec a.C),
secondo cui la sostanze unica ed infinita che fa da sostrato a tutte le cose non è indeterminata, ma
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
ben determinata e si chiama PNèUMA, aria. Essa si trasforma attraverso rarefazione e
condensazione.
La rarefazione massima è il Fuoco, poi condensandosi diventa vento, poi nuvola, poi acqua, poi
terra e poi pietra. Il pneuma può essere considerato come il respiro dell’universo per analogia con
il corpo umano.
A partire dall’antichità le teorie dei preplatonici sono state interpretate pensandole comeuna
sorta di dialogo tra pensatori avvenuto su problemi astratti, inoltre dagli autori ellenistici in poi c’è
stata l’idea di uno sviluppo progressivo in termini di una successione tra maestro e discepolo.
Questi due “miti storiografici” hanno portato ad alcune forzature nello studio della filosofia:
- che ha dato poca importanza alla biografia ed al contesto culturale di ciascun autore
- che sentiva il bisogno di una necessita storica nello sviluppo del pensiero filosofico con la
successione da un filosofo all’altro e nell’opposizione dialettica tra maestro e presunti
discepoli
Terza Ora (VI sec a.C)
Sui Pitagorici
La prima scuola filosofica fu quella Pitagorica e la sua figura divenne ben presto leggendaria e si
consolidò sia nell’Accademia (la scuola di Platone), sia nel Peripato (la scuola di Aristotele).
Pitagora tra scienza, filosofia e religione Nella figura di Pitagora (Vi sec a.C.) confluiscono idealità
scientifiche e filosofiche, etiche e religiose. A rendere difficile la ricostruzione dell’antico
pitagorismo è, più che la mancanza di materiale, la sua sovrabbondanza.
Pitagora a 40 anni si trasferisce da Samo a Crotone e comincia in Italia a tenere una serie di discorsi
pubblici su temi educativi tanto da convincere, secondo alcune fonti, tanti italioti ad abbandonare
il lusso per rivolgersi alla virtù. Sulla base di questi discorsi si fonda pure la tesi secondo la quale
sono i pitagorici ad aver inventato la Retorica. Pitagora è descritto sia come politico, legislatore,
aristocratico, che come sciamano e indovino.
C’è chi fa di Pitagora soprattutto il sostenitore della metempsicosi, la trasmigrazione delle anime,
ma sono teorie che si rifanno più all’orfismo che al pitagorismo.
Aristotele afferma che per i pitagorici l’anima è composta da quel pulviscolo (insieme di particelle)
atmosferico che entra nel corpo mediante la respirazione e gli dà vita, tuttavia secondo altre
testimonianze, per i pitagorici l’anima è l’armonia di elementi contrari.
Gli akoùsmata ( i precetti che caratterizzano la vita pitagorica) si dividono in 3 gruppi: ti esti (che
cos’è), ti màlista (che cosa in sommo grado) e ti pràttein (cosa si deve fare). Sono rappresentate da
concetti, frasi di poche parole allusive ed enigmatiche.
“Quali sono le isole dei beati? Sole e Luna” Qual è la cosa più giusta? Il sacrificare”
Musica ed armonia Un discorso particolare merita l’armonia. L’armonia che i pitagorici riscontrano
nei fenomeni musicali è per essi riflesso terreno dell’armonia cosmica. Le distanze tra i pianeti
rispettano proporzioni che sono le stesse delle consonanze musicali; quelli più lontani ruotano più
velocemente e fanno suono più acuti.
Molte testimonianze parlano di una scuola pitagorica in cui per essere ammessi bisognava superare
prove difficili, rispettare regole di comportamento e praticare la comunione dei beni. Nella scuola si
distinguevano Acusmatici (ammessi all’ascolto delle lezioni ed all’applicazione dei principi) e
matematici (che erano quelli che approfondivano la dottrina e tenevano il degreto su di essa).
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
Pare che anche la scoperta degli accordi musicali fu una scoperta pitagorica con prove con vasi pieni,
mezzi pieni e vuoi
La natura dei numeri: l’aritmogiometria Secondo Aristotele, per i pitagorici il numero va concepito
come materia e al contempo forma di tutte le cose, tale concezione è detta aritmogeometria.
Le opposizioni che si incontrano nella realtà sono simili a quelle che si incontrano tra numeri pari e
numeri dispari, ciò che separa le varie unità numeriche nella realtà è costituito dal vuoto.
Pensare significa cogliere le relazioni che esistono tra le cose, calcolarle, ordinarle, catalogarle,
misurarle. Il numero rende comprensibile il mondo e la natura delle cose in quanto ne rivela la
struttura quantitativa, geometrica.
• L’unico numero che sfugge alla distinzione pari e dispari è l’1, infatti esso viene definito
parimpari. I numeri dispari sono finiti delimitati, compiuti e perfetti poiché quando vengono
divisi in due parti uguali rendono interposta tra loro una parte che pine un limite,
diversamente dai numeri pari che invece vengono lasciati aperti dalla divisione.
• Il 10 è il numero perfetto, formato da 4 numeri pari e 4 dispari non composti e i primi 4
numeri. 10 sono i corpi celesti e le coppie di contrari con cui si misurano tutte le cose (che
non elencheremo).
Quarta Ora (VI sec a.C)
Su Alcmeone, Senofane e Parmenide
Alcmenone: malattia e pensiero Alcmeone di Crotone (VI sec a.C.) fu un pensatore vicino agli
ambienti del primo pitagorismo. Medico, pensò la salute e la malattia dell’uomo in termini di
equilibrio e squilibrio tra coppie di elementi opposti. Egli chiamò ISONOMIA lo stato di salute e
MONARCHIA quello della ricerca.
Sulla conoscenza egli afferma che la conoscenza non è solo il raggiungimento dell’obiettivo, ma lo
stesso formulare ipotesi e verificarle, esercitare il pensiero rappresenta conoscenza e distingue
l’uomo dall’animale.
Senofane ed il divino relativo Altro filosofo del periodo è Senofane di Colofone (VI sec a.C.), che
pensò il cosmo come un tutto unitario eterno ed immobile all’interno dei quali è possibile
riscontrare i fenomeni particolari..
Polemico nei confronti della politica che attribuisce onori agli atleti piuttosto che ai saggi, affida alla
filosofia soprattutto il compito di individuare la natura della divinità. La divinità è una figura delle
città, le sue rappresentazioni infatti cambiano in base alla città in cui esse sono disegnate.
Tutto ciò dimostra da un lato la relatività di tali rappresentazioni del divino, dall’altro il bisogno che
gli uomini hanno del divino. A proposito di questo il simposio deve essere lo spazio per la creazione
di una nuova cultura della divinità, che sappia rispondere al bisogno umano del divino nel nuovo
contesto politico.
Parmenide tra verità ed esperienza Parmenide (VI sec a.C.) è il primo preplatonico considerato da
platone e aristotele come un vero filosofo. Anche lui considera la realtà come tutto un omogeneo,
ma inserisce tutto in un diverso piano conoscitivo: l’uomo deve cercare di conoscere sia il campo di
to eòn (di ciò che è), cioè il campo conoscitivo il cui oggetto è la realtà pensata nella sua totalità,
pensabile, sia quello di ta eònta (delle cose che sono) cioè il campo conoscitivo il cui oggetto è la
realtà pensata come luogo di fenomeni particolari e delle esperienze umane, i sensi.
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
Questa distinzione tra piano della verità e piano delle esperienza dà l’unica strada di ricerca
percorribile, essa ha infatti in sé tutto ciò che esiste, l’universo tutto nella sua astrazione logica e le
singole esperienze concrete.
Per conoscere la realtà dobbiamo cogliere i sèmata, i segni, che sono distinti tra campo della verità
e dell’esperienza.
Quinta Ora (V sec a.C.)
Su Zenone e Melisso; su Eraclito di Efeso.
Zenone, Parmenide e i Paradossi Le teorie di Parmenide, soprattutto quelle in cui affermava
l’immobilità e l’immutabilità dell’essere andavano contro il senso comun poiché se ci guardiamo
attorno, però, vediamo una moltitudine di esseri che nascono, crescono, mutano e si muovono.
Zenone, per difendere Parmenide, elabora una serie di argomenti e tesi contro la molteplicità degli
enti, il movimento e l’infinito. Gli argomenti contro l’infinità di tempo e spazio sono 4:
1. Si pretende che, quindi, contro Parmenide, un corpo possa, muovendo da un punto di
partenza, giungere ad un termine stabilito. “E invece non è possibile – dice Zenone – perché
tale corpo (A), prima di raggiungere la meta (B), dovrebbe percorrere la metà della strada
che deve percorrere (AC) e, prima ancora, la metà di quella metà (AD), fino all’infinito non
pervenendo mai allo zero. E’ impossibile in un tempo finito percorrere uno spazio infinito,
dunque il corpo non raggiungerà ami la meta B.
2. Lo stesso vale per Achille e la tartaruga
3. Una freccia scoccata, occupando sempre uno spazio uguale alle sue dimensioni nel corso del
tempo, sarà come ferma.
4. Rispetto ad un punto A, due oggetti che si trovano in punti opposti di uno stadio, percorrono
uno spazio che è nello stesso tempo Uguale (rispetto al punto A) e doppio (Rispetto all’altro
oggetto in movimento)
Melisso e la ragione universale Melisso (V sec a.C), allievo di Parmenide, pensò al tutto non come
finito, ma infinito.
Eraclito di Efeso visse nel V sec a.C. Secondo la sua visione il mondo è governato da una legge
fondamentale che governa l’accadere degli eventi. Questa legge universale è il Logos ed è comune
a tutti, poiché essa si identifica con la razionalità stessa. Pure essedo il logos comune a tutti, poco
sono quelli che ne hanno consapevolezza e che si comportano secondo essa. La maggior parte degli
uomini infatti si muove a partire da punti di vista individuali senza seguire il Logos che è ragione
universale.
Il mondo comune de logos rivela la sua natura unitaria di armonia che nasce dagli opposti; solo
contendendosi a vicenda i contrari danno l’uno all’altro un senso specifico. Conoscere la realtà
significa quindi superare quel livello di falsa conoscenza che vede gli opposti come “irrelati”(la pace
senza la guerra) e vederli invece come collegati.
- Per Platone, Eraclito è il “FILOSOFO DEL DIVENIRE”, capo stirpe di una pericolosa stirpe di
pensatori che ritenendo la realtà in perpetuo movimento teorizzarono l’impossibilità di ogni
forma di sapere stabile.
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
- Per Aristotele, Eraclito è il “FILOSOFO DELLA CONTRADDIZIONE”, l’inventore di una stile di
pensiero teso a negare il principio di identità: di ogni cosa è possibile affermare tutto ed il
contrario di tutto.
Sesta Ora (V sec a.C.)
Su Empedocle ed Anassagora
Le 4 radici di empedocle e i 4 momenti Secondo Empedolce (V sec a.C.), tutto ciò che esiste è il
risultato della mescolanza e della separazione di 4 radici: aria – acqua – terra e fuoco. Queste si
aggregano e si disgregano grazie all’azione di due forze: PHILIA (amicizia, amore, forza aggregante)
e NEIKOS (contesa,odio, forza disgregante). L’universo ha una storia distinta in 4 periodi: un
periodo in cui prevale Philia ed uno in cui prevale Neikos; tra i due periodi vi sono due cicli
intermedi: Uno che va da dominio dell’amore a quello dell’odio e l’altro che va dal dominio
dell’odio a quello dell’amore. In questi due momenti, essendo le due forze compresenti, nascono
tutte le cose, e tra tutte le cose, gli uomini.
Orfismo e demoni Alcuni frammenti ritrovati testimoniano un collegamento di Empledocle con
l’orfismo: Ogni uomo è abitato da un demone che, spinto dall’odio, commette colpe ed è costretto
a compiere un lungo viaggio che dura millenni e porta il demone a trasmigrare attraverso vari tipi
di corpi viventi. Questa concezione conduce al vegetarianismo: ogni animale abita un’anima che
compie un suo ciclo di reincarnazioni per giungere alla sua condizione divina; mangiarlo è un atto
di cannibalismo.
Scienza e cosmo Accanto all’Empledocle orafo c’è l’immagine di Empedocle più scientifica. Egli
afferma che cosmo ed uomo sono fatti della stessa materia ed è in base a questa omogeneità che
per l’uomo è possibile conoscere il mondo. Questa materia è di fatto la mescolanza delle 4 radici
ed anche l’anima, riporta Aristotele, per Empedocle, è data proprio dalla “proporzione per la
mescolanza”.
Anassagora: semi, omeomerie e noùs Secondo Anassagora (V sec a.C.), le 4 radici sono ben lungi
dallo spiegare le innumerevoli qualità che si manifestano nei fenomeni. Lui propone, quindi, i semi
(spermata). I semi sono gli elementi di cui sono composte le cose ed hanno “forme, colore, gusti di
ogni genere”, cioè sono infinitamente vari e di tutte le qualità = originario qualitativo.
Inoltre anche se presi singolarmente e divisi in parti sempre più piccole, queste saranno sempre
della stessa qualità e vengono chiamate OMEOMERIE.
Dapprima, queste omeomerie costituivano una massa in cui tutto era mescolato “insieme” in modo
che “nessuna” si distingueva.
E’ qui che Anassagora introduce il noùs: è un intelligenza cosmica che dalla caotica mescolanza, con
un determinato movimento, produsse ordinata mescolanza da cui scaturirono tutte le cose. Ogni
cosa ha in sé tutti i semi, ma la prevalenza di questo o quell’altro seme che la qualifica, la individua.
“Tutto è in tutto”; o anche: “in ogni cosa c’è parte di ogni cosa”.
Settima Ora (V sec a.C.)
Su Ippocrate, sugli sviluppi del pitagorismo, sugli atomisti
Nei testi della medicina ippocratica, il divino viene considerato riparo dell’ignoranza poiché “intorno
alla cosiddetta malattia sacra (…) gli uomini la considerano un fatto divino per mancanza di risorse
e per il suo carattere sorprendente in quanto in niente rassomiglia ad altri morbi.
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
Ippocrate come dialettica tra leggi ed empirismo Ippocrate si oppone alla scuola italica ed alla
scuola di Cnido. La prima poiché generalizzava le leggi del cosmo alle leggi dell’uomo, la seconda
poiché si configurava come eccessivamente empirista, troppo legata a casi particolari.
Il metodo ippocratico si configura come una sintesi di esperienza e ragione: il punto di partenza è la
sensazione (sia del paziente che descrive il suo dolore che del medico) che, interpretata attraverso
un ragionamento, conduce ad un segno che rinvia alla realtà nascosta: la causa. A partire dal segno,
il medico congettura una spiegazione:
1. Ricostruisce il passato della malattia (anàmnesis)
2. Ricostruisce il suo presente (diàgnosis)
3. Ricostruisce la sua evoluzione (prognosi)
Ippocrate sostiene che le malattie dipendono dalle condizioni climatiche, geografiche, idriche e
dietetiche di una regione.
Pitagotisti ed armonie Si sviluppa in questo periodo ulteriormente la matematica, soprattutto con
i pitagoristi, secondo cui rapporti tra numeri sono armonie. Il moto degli astri è armonia, i suoni
prodotti dagli astri nel loro movimento corrispondono alle consonanze musicali, e noi non sentiamo
questi suoni perché li abbiamo sempre sentiti.
Gli atomisti, l’alfabeto e le sensazioni Leucippo e Democrito per spiegare la molteplicità dei
fenomeni della natura introducono la figura dell’atomo. Gli atomi sono eterni ingenerati e
soprattutto indivisibili poiché indistruttibili.
Gli atomi sono privi di qualità sensibili: colori, odori, sapori sono solo apparenze. Le uniche qualità
che possono essere loro attribuite sono quelle necessarie all’intelletto per pensarli
geometricamente e quantitativamente.
Le qualità degli atomi sono:
1. Forma: Le forme geometriche dell’atomo, percepibili solo dalla mente (noi comuni mortali
del 21esimo secolo riusciamo a vedere gli atomi senza l’uso del microscopio? Pensa un po’ i
greci allora...), sono infinite (rotonde,triangolari, quadrate, ecc. ecc.).
2. Grandezza (volume): Gli atomi più grandi hanno massa maggiore, quelli più piccoli massa
minore.
3. Posizione: L’atomo A non poteva certo occupare la posizione dell’atomo B.
(Es alfabeto A diverso da N per forma, AN da NA per ordine, Z da N per posizione).
Le cose sono combinazioni di atomi: si formano quando gli atomi si aggregano e si dissolvono
quando si separano. Caratteristica dell’atomo è quindi il movimento, poiché è esso che, appunto,
permette il suo aggregarsi. In particolare, questa aggregazione è causata da un moto vorticoso che
unisce gli atomi più grandi che si dispongono al centro per la maggiore resistenza al vortice e gli
atomi più piccoli che si dispongono all’esterno. Così prendono vita le cose, l’uomo ed i diversi mondi.
Ma come può, l’atomo, muoversi? Per muoversi ha bisogno di uno spazio: questo spazio è il vuoto
(lo spazio vuoto di Democrito è lo spazio astratto della geometria).
1. Qualità oggettive – dunque primarie: sono di ordine geometrico-meccanico e sono
intrinseche ai corpi stessi (prendiamo una sedia, per esempio, per Democrito essa era
formata da 27 atomi cubici di grandezza tot che si trovavano disposti in un determinato
modo)
2. Qualità soggettive – dunque secondarie: sono le impressioni prodotte dall’azione delle cose
sui nostri organi di senso, vale a dire le proprietà sensibili, quali i colori, i suoni, i sapori, le
temperature.
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
Per Democrito, LA SCIENZA ha il compito di ricondurre le qualità secondarie a quelle primarie.
Come conosce l’uomo? L’uomo conosce attraverso le sensazioni. Come avviene, però, la
sensazione? Ogni oggetto, come sappiamo, è composto da atomi grandi e piccoli. E’ anche composto
da atomi molto minuti, leggerissimi che, essendo situati all’estrema superficie di un oggetto, si
staccano dall’oggetto stesso di cui conservano però la configurazione esteriore e che, producendo
delle "emissioni atomiche", ossia degli "idoli" (o simulacri), attraversando l'aria, colpiscono gli organi
sensoriali degli animali e degli uomini.
Ottava Ora (V sec a.C.)
Un’introduzione ai sofisti, Protagora
I “falsi pensatori” come antitesi per Hegel Nell’antichità c’è stata una forte ostilità nei confronti dei
sofisti che venivano definiti come imitazioni dei filosofi. Inoltre venivano dipinti come falsi pensatori
e con insegnamenti immorali.
Con Hegel si ha il recupero dei sofisti dalla storia della filosofia. La storia, per Hegel, è storia dello
spirito e, con movimento dialettico, procede per TESI-ANTITESI-SINTESI.
La filosofia ionica, greca in generale rappresenterebbe la TESI. Quella dei sofisti e socratici
l’ANTITESI, cioè il momento critico imperniato sul principio della soggettività. Platone ed Aristotele
la SINTESI.
I sofisti, afferma Nestle, a differenza dei filosofi che si sono interessati alla conoscenza per sé stessa,
inseguono la conoscenza per scopi pratici e per la costruzione di un sapere sociale.
Platone critica la filosofia dei sofisti per il suo relativismo, tuttavia diventa l’esempio più illustre della
loro essenza metodologica e delle strategie persuasive (da lui stesso criticate).
Maestri di persuasione La democrazia Periclea affida, escluse le cariche militari, le magistrature
pubbliche per sorteggio. In un contesto politico che vede ogni qualsiasi cittadino al potere, i sofisti
si configurano come figure professionali specializzate nell’arte dell’educazione. Offrivano una
selettiva istruzione secondaria che doveva seguire l’istruzione di base che finiva a 14 anni. Tale
educazione era orientata in funzione della carriera politica; Parte essenziale dell’apprendimento era
infatti l’esercizio della persuasione oratoria = acquisizione, padronanza del vocabolario, arte
dell’argomentazione.
Ad un certo punto, quindi, i sofisti divennero una professione: cominciarono a percepire per la loro
attività di insegnanti, un onorario. L’immoralità non stava nel percepire un onorario (tutti i tecnici
lo percepivano), stava nel vendere la propria sapienza, a chiunque, senza discriminazione. Il fatto di
chiedere del denaro, impediva loro di avere degli allievi.
“Falsari e prostituti della cultura” questa fu l’accusa mossa contro di loro da Senofonte.
Homo Mensura e Relativismo La tesi Protagorea dell’HOMO MENSURA è la più famosa: “l’uomo è
misura (cioè norma di giudizio) di tutte le cose (cioè di tutti i fatti e le esperienze in generale) di
quelle che sono per ciò che sono, di quelle che non sono per ciò che non sono”.
Questo assioma è considerato la magna carta del relativismo occidentale.
Criterio è solamente l’uomo, il singolo uomo: “quali le singole cose appaiono a me, tali sono per me,
quali a te, tali per te”. Questo vento che soffia è caldo o è freddo? La risposta è: “è caldo per chi ha
caldo e freddo per chi ha freddo”.
Per Protagora, dunque, tutto è relativo: non esiste un “vero” assoluto o valori morali tali. Esiste,
tuttavia, qualcosa che è più utile, più conveniente, e perciò più opportuno. Il sapiente è colui che lo
riconosce e sa convincere anche gli altri a riconoscerlo ed attuarlo.
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
Prometeo e le definizioni di giustizia Il mito di Prometeo (p72), attribuito a Protagora nel Protagora
platonico, è una delle più antiche teorie sulla nascita della città.
Prometeo deve distribuire qualità, ruba da Efesto ed Atena abilità tecniche e fuoco. L’uomo può
cacciare ma è senza politica. Ermes porta allora rispetto reciproco e giustizia sulla terra. La giustizia
è qualcosa quindi che è venuta dopo, non riflessiva ma TRA GLI UOMINI. Prometeo narra dell’arrivo
della giustizia tra gli uomini. Ci sono 3 teorie greche sulla giustizia:
1. Una è sostenuta da Democrito ed è fondata sul paradigma del bisogno e della tecnica per
la difesa contro le fiere. Ma in questo scenario nasce solo l’homo tecnologicus, non quello
politucus.
2. Una seconda è sostenuta in Tucidide ed è fondata sulla pleonixia (avidità, cupidigia).
Tucidide non parla della genesi della città ma vede parte della società già formata. In questa
società la natura umana è mostrata nella sua essenza attraverso il celebre dialogo tra gli
ateniesi ed i Meli: “per bisogno della natura chi ha il potere lo esercita”. L’uomo desidera
sopraffare
3. Una terza è sostenuta nel Protagora ed è un compromesso tra le prime due: all’inizio si ha
la paura delle fiere, poi si abbraccia la Pleonixia, poi quest’ultima, grazie ad paradigma del
bisogno e della tecnica per la difesa contro le fiere, viene canalizzata secondo le forme della
legge.
Nona Ora (V sec a.C.)
Ancora sui sofisti: Gorgia di Leontini, Prodico di Ceo
Gorgia e il “nulla esiste” Gorgia giunge ad Atene nel 427. La sua dottrine dell’esperienza e del
relativismo della conoscenza non fu dissimile da quella di Protagora. Egli mette in crisi la
connessione parmenidea tra essere, pensare e dire.
• Nulla esiste: Ecco come Gorgia dimostra che nulla esiste: Se qualcosa esiste o è
1. Essere
2. Non essere
3. Essere e non essere assieme
Innanzitutto il non essere (punto 2.) non esiste: se il non essere esistesse, esso sarà e non sarà allo
stesso tempo. Ciò è assurdo. Quindi il non essere non esiste. Neanche l'essere esiste (punto 1).
Perché, se esiste, o sarebbe A) Eterno B) Generato C) Eterno e Generato assieme Ma l'essere non è
eterno (A), perché se è eterno non ha alcuna origine dato che tutto ciò che ha un origine dev'essere
nato da qualcosa che prima non era. Siccome l'essere non ha origine, significa che è illimitato,
indeterminato, cioè non si può determinare; se è indeterminato, nessun luogo lo può contenere,
cioè determinare appunto, quindi l'essere non è in nessun luogo. Se l'essere non è in nessun luogo
allora non esiste. L'essere non può nemmeno essere Generato (B) perché se fosse generato o è
generato dall'essere o dal non essere. Non può essere generato dal non essere in quanto il non
essere non è. Non può essere generato dall'essere in quanto già sarebbe. L'essere non è nemmeno
eterno e generato assieme (C) perché le due parole eterno e generato escludono l'una, l'altra: ciò
che è eterno non è generato e ciò che è generato non è eterno, al massimo lo è per metà. Dimostrato
che il non essere non è e che l'essere non è sarebbe assurdo dire che l'essere è e non è allo stesso
tempo.
• Posto anche che l’essere esistesse, esso “non potrebbe essere conoscibile (cioè pensato)”:
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
Gorgia inficia sul principio Parmenideo secondo cui il pensiero è solo e sempre pensiero
dell’essere ed il non essere è impensabile. Ci sono dei pensati (come dei cocci che corrono
sul mare) che non esistono e ci sono non esistenti (Scilla, la chimera) che sono pensati. Fra
essere e pensiero c’è dunque rottura. Se fra essere e pensiero c’è quindi rottura, anche se
questo (l’essere) esistesse, non potrebbe essere conosciuto.
• Posto anche che l’essere fosse pensabile, esso “sarebbe inesprimibile (incomunicabile)”:
La parola non può comunicare altro da sé in maniera veritativa. “Quello che uno vede, come
mai potrebbe esprimerlo con la parola? O come mai questo potrebbe venir manifesto a chi
lo ascolta, senza averlo veduto? L’udito ode i colori, ma i suoni; e certo dice, chi dice, ma non
dice né un colore né un’ esperienza”. (Intesa come suono, la parola è oggetto dell’udito; non
si può comunicare l’oggetto di un’esperienza, per esempio visiva, con un veicolo sonoro).
L’inesistenza della verità assoluta e l’esempio di Elena di Troia Se non esiste una verità assoluta e tutto è
falso, la parola viene ad acquisire una sua autonomia, quasi sconfinata, perché non legata dai vincoli
dell’essere, dell’esistenza.
Famoso di Gorgia è infatti l’encomio di Elena: nell’Encomio, Gorgia difende Elena dall'accusa di essere stata
causa della guerra di Troia con la sua decisione di tradire il marito Menelao e seguire Paride. Gorgia dimostra,
con la dialettica, l’innocenza di Elena con le seguenti 4 tesi:
1) Elena tradì Menelao perché mossa da un principio a lei superiore (come gli dèi per esempio)
2) Elena tradì Menelao perché fu rapita con la forza da Paride
3) Elena tradì Menelao perché fu persuasa dai discorsi di Paride (logoi)
4) Elena tradì Menelao perché fu vinta dall'amore.
Gorgia dimostra che, così, in ogni caso, il movente rimane esterno alla sua responsabilità.
1) Nel primo caso Elena è una vittima, poiché Afrodite promise a Paride che in cambio della Mela d'Oro
avrebbe fatto innamorare di lui la donna più bella al mondo, appunto Elena.
2) Nel secondo caso Elena viene rapita, quindi è nuovamente una vittima e la colpa è da assegnare a Paride.
3) Nel terzo caso Elena è ancora una volta vittima perché la sua mente è stata persuasa dalle parole di Paride:
quando una mente è persuasa non c’è più nulla da fare.
4) Nel quarto caso Elena si è innamorata spontaneamente di Paride: quando uno è colpito dalla meraviglia
dell’amore è pervaso dalla sua divina potenza.
Podico e la sinominica Prodico di Ceo è ricordato per le ricerche che condusse sulla sinonimica, ovvero lo
studio delle differenze di significato tra termini aventi significati simili e sull’etimologia, lo studio dell’origine
dei nomi (per esempio ricordare e rammentare: in latino cor, cordis significa cuore. Re-cordare significa
“ritornare al cuore”. Ben diverso dal termine ‘rammentare’ che significa “ritornare alla mente”).
Prodico pensò che esistesse un legame naturale tra struttura della parola e la cosa che essa esprime, e che
poi, le successive differenziazioni fossero causate dalla lingua della storia delle varie civiltà,
Decima Ora (V sec a.C.)
Ancora sui sofisti; su Socrate
Altre importanti figure dei sofisti furono Ippia, Crinzia, Antifonte
Ippia è noto per aver proposto una forma di conoscenza enciclopedica e per aver insegnato l’arte della
memoria.
Ippia e la legge che crea conflitto Secondo Ippia, la natura unisce gli uomini, la legge li divide. Secondo il
filosofo, in pratica, la natura non crea quella gerarchia, quella divisione interna alle città e tra città che si crea
col diritto positivo, il quale è fittizio, artificiale. Le discriminazioni che si vengono a creare tra le persone,
dunque, di per sé non esistono perché in natura abbiamo tutti gli stessi diritti.
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
Crizia e la legge e la religione contro l’istinto bestiale Crizia, uomo di cultura ed intelligenza acuta,
ammiratore della costituzione spartana, sostenne che la legge è l’unica garanzia per l’uomo di uscire dallo
stato di ferinità (istinto bestiale) naturale ed iniziare una vita civile.
La religione è un’invenzione degli uomini tesa a garantire l’ordine laddove non arriva la legge: nell’interiorità
dell’uomo.
Antifonte e l’amore per la legge della natura Antifonte radicalizza l’antitesi fra “natura” e la legge già vista
in Ippia di Elide giungendo a dire che si deve seguire la legge di natura e, quando lo si possa fare
impunemente, trasgredire quella degli uomini.
Qui si evidenziano anche le concezioni egualitarie e cosmopolite riscontrate in Ippia di Elide: Antifonte giunge
ad affermare addirittura la parità di tutti gli uomini senza distinzione delle loro origini, “poiché di natura
siamo tutti assolutamente uguali, sia greci che barbari”.
Socrate, un filosofo ateniese senza scuola e senza scritti Socrate nacque ad Atene nel 470 a.C. e morì nel
399 in seguito ad una condanna per “empietà” (fu accusato di non credere agli déi della città e di corrompere
i giovani verso l’ostilità e contro i vsloti della partia).
Fu figlio di uno scultore ed un’ostetrica. Non fondò una scuola, come gli altri filosofi, ma tenne il suo
insegnamento in luoghi pubblici esercitando un fascino non solo sui giovani, ma anche su uomini di tutte le
età, e questo gli procurò avversioni ed inimicizie.
Nella vita di Socrate vanno distinte due fasi, di cui la prima è quella in cui frequentò i fisici di Archelao ed
entrò in contatto con i sofisti, rimanendone in parte influenzato. Se così è, infatti, non risulta strano la critica
fattagli da Aristofane
Socrate non scrisse nulla, eppure mai nessun uomo ha ispirato tanti scritti quanti ne ha ispirati lui. Dopo la
sua morte si accesero violenti polemiche sull’interpretazione della sua figura.
Socrate e le influenze sofiste Probabilmente, fino ai 45 anni, Socrate risentì degli influssi della sofistica pur
criticandone alcune cose.
Aristofane, infatti, mette in caricatura un Socrate che è assai diverso dal Socrate della maturità che ci
presentano Platone e Senofonte.
Nelle Nuvole, infatti, Aristofane ci presenta Socrate come un sofista che dà lezioni a pagamento per “vincere
cause buone e perse con la chiacchiera”.
Senofonte scrisse di Socrate in 4 opere: l’Apologia di Socrate, I Memorabili, l’Economico ed il Convito. La
figura che emerge da Senofonte che fu suo allievo è quella di un Socrate che non solo non si faceva pagare
per le sue lezioni, ma che considerava i sofisti dei veri e propri ”prostituti della cultura”.
Il Socrate di Aristotele, fondatore dell’etica e del ragionamento Aristotele, nella metafisica, scrive che, prima
di Socrate la filosofia si occupava di questioni naturali ed invece, con Socrate, cominciò ad interessarsi di
etica, cioè di scienza della morale. Secondo Aristotele, Socrate fu l’inventore del ragionamento
1) Induttivo (particolare à universale)
2) Deduttivo (universale à particolare)
Platone è colui che, più di tutti, ha scritto di Socrate, suo maestro. Negli scritti di Platone, questi espone tutta
intera la sua visione del mondo ed è quindi difficile usare la sua opera per scoprire la visione del maestro. E’
quasi impossibile distinguere ciò che, nei dialoghi è attribuibile al Socrate storico da ciò che è frutto della
riflessione squisitamente platonica
Il metodo, il dialogo, l’ironia, la maieutica Sulla base di attenti studi, è stato possibile individuare alcuni
aspetti che caratterizzano il metodo del filosofare socratico:
1) Il DIALOGO: Socrate prediligeva il dialogare breve ed efficace, penetrante, detto brachilogico, rifiutando il
dialogare macrologico. Praticò la sua filosofia intendendola come un dialogo fatto di domande e risposte.
2) L’IRONIA: Socrate finge di accettare la tesi dell’interlocutore e poi la decostruisce mostrandone tutta
l’inconsistenza. Professa di “non sapere”, ma il suo “non sapere” è un non sapere consapevole, e dunque, in
un certo senso, la sua è la più alta forma di conoscenza.
3) La MAIEUTICA: La madre faceva partorire le donne senza regalare loro nulla di suo, ma aiutando ciascuna
donna gravida a partorire un proprio figlio, così Socrate faceva partorire gli uomini, senza insegnare loro nulla
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
che tragga da un suo proprio sapere e aiutando gli uomini a far emergere quanto, inconsapevolmente, essi
si portano dentro.
Undicesima Ora (Tra V sec a.C. e IV sec a.C.))
Sulle scuole socratiche minori
Si è soliti definire con l’espressione “scuole socratiche minori” quelle correnti che, pur prendendo spunto
dall’insegnamento socratico, non si inseriscono nella “via regia” della filosofia che conduce a Platone e
Aristotele. Queste scuole sono tre: la cinica, la cirenaica e la megarica.
Antistene e la sola corrispondenza tra Pragmata e Onomata La filosofia cinica di Antistene sviluppa fino alle
estreme conseguenze il tema dell’ignoranza socratica. Ricollegandosi alla dottrina sofistica, Antistene
sostiene che di ogni affermazione si può dimostrare tanto la sua verità quanto la sua falsità, senza la
possibilità di individuare un criterio di verità certo.
A differenza di Platone, per Antistene vale solo il principio dei pragmata (cose), interpretato come referenti
degli onomata (nomi), vale quindi il principio dell’equazione tra parola e cosa e non tra cosa ed idea.
Egli nega dunque la possibilità di conoscere la realtà attraverso il linguaggio e afferma, di conseguenza,
l’impossibilità della comunicazione. Da qui prende le mosse la critica nei confronti di Platone, a cui Antistene
obietta che, se è possibile vedere un cavallo, non è possibile vedere e poi comunicare l’idea universale e
astratta della cavallinità.
Antistene si spinge oltre: sostiene che tutto quello che il linguaggio può fare è affermare che una tale cosa è
quella che è; per esempio che un cavallo è un cavallo, che un tavolo è un tavolo. Non si può quindi connettere,
ad un nome, un altro nome che lo definisca: come animale al nome cavallo.
Diogene e l’impossibilità della conoscenza Diogene nella sua scuola riprende le tematiche di Antistene
evidenziando che la virtù non può essere ricercata nella conoscenza: impossibile per definizione. Ciò che può
fare il saggio è solo raccogliersi in se stesso, liberarsi dai bisogni che lo rendono schiavo e offrire un concreto
esempio di moralità. Solo l’esercizio e la fatica consentono di raggiungere la vera sapienza.
La scuola megarica e i paradossi La scuola megarica, fondata da Euclide di Megara ha formato alcuni filosofi
che hanno elaborato i cosiddetti paradossi, per mostrare come pur partendo da premesse plausibili, esistono
diversi livelli di linguaggio che vietano ad una frase di pronunciarsi su se stessa. Un’altra tesi sostenuta dai
megarici fu l’impossibilità dei giudizi predicatici, cioè dei giudizi in cui il predicato è diverso dal soggetto.
L’edonismo della scuola a scuola cirenaica I cirenaici erano edonisti e ritenevano che il piacere, specialmente
quello fisico, fosse il bene supremo della vita. Considerarono la tipologia fisica del piacere più intensa e
desiderabile dei piaceri mentali. Il piacere era per i cirenaici l'unico bene della vita (“ciò che è da cercare”) e
il dolore l'unico male (“ciò che è da fuggire”).
Per i cirenaici, quindi, tutta la conoscenza è fondata sulla sensazione immediata, la quale, essendo soggettiva,
non permette, però, la conoscenza oggettiva delle cose.
Il piacere passato ed il piacere futuro non hanno effettività in quanto ciò che conta è il piacere presente.
Dodicesima Ora (Tra V sec a.C. e IV sec a.C.))
Introduzione a Platone
Platone, una vita tra Atene e Siracusa Platone nacque ad Atene nel 428, la sua famiglia era tra le più
aristocratiche di Atene e quindi ricevette un’educazione con ginnastica e musica. Nel 408 conobbe Socrate e
ne diventò l’allievo.
399 a.C. Socrate morì ed il disgusto per i metodi della politica praticata in Atene raggiunsero ormai, per lui,
il culmine e comincio una serie di viaggi di cui i più importanti sono i 3 viaggi a Siracusa.
Nel 388. a.C. Platone partì alla volta dell’Italia per conoscere la comunità dei Pitagorici ma, durante il viaggio,
fu invitato a Siracusa, in Sicilia, dal tiranno Dionigi I. Ben presto, però, Platone venne in urto col tiranno (quasi
certamente Platone cercò di fare il lavaggio del cervello a Dionigi con la questione del re-filosofo che aveva
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
già esposto nel Gorgia, opera che precedeva il viaggio stesso) e fu probabilmente venduto come schiavo,
fortunatamente riscattato da un amico. Sebbene si inimicò il Tiranno, lì a Siracusa aveva stretto amicizia con
Dione, parente del sovrano, in cui Platone credette di trovare un discepolo capace di diventare re filosofo.
Nel 367 a.C. Dionigi I morì e gli succedette Dionigi II che, a dire di Dione, ben più del padre avrebbe potuto
favorire i disegni del filosofo Ma Dionigi si rivelò identico al padre ed esiliato Dione perché accusato di
tradimento, trattenne Platone come prigioniero fino a quando non fu costretto a liberarlo per apprestarsi
all’inizio di una guerra.
Nel 361 a.C. Platone si reca nuovamente in Sicilia su pressante richiesta di Dione, il quale spera che Dionigi II
lo riammetta a Siracusa. Nel frattempo si era rifugiato proprio ad Atene. Prima di partire per la terza volta,
Platone era riuscito ad unire Archita (E’ un filosofo ed amico di Platone dal 388 a.C.) ed i tarantini in buoni
rapporti col tiranno; infatti è grazie a loro intervento che Platone riuscì a salvare la propria vita dopo nuovi
contrasti con Dionigi II
360 a.C. Platone ritornò ad Atene e vi rimase alla direzione dell’Accademia, fino alla morte, avvenuta nel 347.
Socrate è il protagonista dei dialoghi di Platone, soprattutto di quelli dell’età giovanile. Egli discuterà con uno
o più interlocutori … (Accanto a questi, altrettanto importante sarà il ruolo del lettore che verrà chiamato in
causa per trarre maieuticamente la soluzione di molti problemi discussi)
Socrate come voce di Platone? Socrate, oltre ad essere protagonista delle opere di Platone, è anche una
sorta di sua creazione. E’ colui al quale, spesso, affida le sue idee e gli interrogativi da porre (Per questo
motivo diventa a volte difficile capire dove finisca il Socrate storico e dove invece Platone si stia servendo
della figura del filosofo per esprimere le proprie teorie).
Socrate è il simbolo di tutto ciò che si contrappone al tradizionale, a ciò che è esteriore; come scrive Vigetti,
rappresenta la figura dell’interiorità.
Il filosofo della Buonafede Tutte le famose tesi difese dal Socrate di Platone sono riconducibili all’idea
dirompente della dimensione interiore su quella esteriore:
- È meglio subire ingiustizia che commetterla, perché nel primo caso si è danneggiati nel corpo, nel
secondo caso ci si danneggia nell’anima che è il vero danno che l’uomo può procurarsi.
- Nessun commette il male volontariamente, perché ognuno desidera ciò che è bene;
- Il malvagio è colui che, per mancanza di sapere, non sa comprendere ciò che è davvero bene.
Questa sua concezione pone Socrate in contraddizione con i Sofisti, secondo cui i retori fanno quello che
vogliono.
Secondo Socrate invece, i retori e i tiranni fanno ciò che ad essi sembra il meglio, tuttavia sono privi di
intelletto non sanno giudicare ciò che è meglio per loro e non si procurano in realtà nessun vantaggio.
L’originalità della filosofia platonica consiste nel pensare il sapere come quel movimento in cui il
domandare ed il rispondere si trasformano l’uno nell’altro, che poi in realtà è una caratteristica del suo
maestro.
Tredicesima Ora (Tra V sec a.C. e IV sec a.C.))
Su Platone e i sofisti
Nel Gorgia di Platone, Socrate afferma che la retorica è un EMPERìA (esperienza intesa come legata
all’apparenza) e che non è una tecnica che cura l’anima, anche se, all’apparenza, può sembrarlo, ma solo una
pratica in grado di produrre gioia e piacere; è una forma di adulazione.
Il Gorgia e le tecniche di cura del corpo e dell’anima Esistono, spiega Socrate tecniche di cura del corpo e
tecniche di cura dell’anima. Esistono poi, nascoste sotto di esse le loro immagini, che fingono di essere il
loro corrispettivo reale.
La tecnica di cura per l’anima, quella per eccellenza, è la politica nelle sue due parti: legislazione e giustizia.
Anche per il corpo esiste una tecnica di cura; seppur non si conosca il nome si divide anch’essa in due parti:
ginnastica e medicina.
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
Esistono, però, tecniche che, attraverso l’adulazione, fingono di prendersi cura dell’anima, cioè la sofistica e
la retorica, e fingono di prendersi cura del corpo, cioè la culinaria e la cosmetica.
La differenza fondamentale tra le tecniche per eccellenza e quelle false sta nel fatto che le prime agiscono in
vista di ciò che è meglio, avendo anche una spiegazione per ogni proposta terapeutica, le seconde agiscono
solo in vista di ciò che è piacevole, mancando anche di validi criteri.
Inganni e Saggezza Solo l’uomo saggio, essendo queste tecniche simili tra loro ma distinte per natura, riesce
a distinguere e a non confondere, come fanno gli uomini privi di intelletto, le tecniche vere con quelle
apparenti.
Socrate sentenzia che la retorica è per l’anima ciò che la culinaria è per il corpo in quanto il cuoco, nel curare
il corpo, si sostituisce al medico che è l’unico a conoscerlo veramente (il corpo). Come quindi il cuoco inganna
gli uomini, così i sofisti, nella cura dell’anima, si sostituiscono al filosofo propinando agli ascoltatori un falso
sapere, propinando loro non la verità ma ciò che vogliono sentire. L’inganno del Sofista, dunque, intessuto di
capacità adulatoria, appare come un arte vera e propria quando è, invece, solamente una sua volgare
immagine. In Platone nasceva quindi la volontà di costruire una forma di sapere che potesse sottrarre ai
sofisti la gestione della prassi politica.
Protagora e Gorgia, diventati i sostenitori dell’impossibilità di un sapere universalmente valido, lanciano a
Platone una formidabile sfida intellettuale che Platone raccolse, costruendo un’immagine del mondo
antigorgiana ed antiprotagorea, per portare nuovamente la filosofia al gradino di unica scienza esistente per
la conoscenza della verità.
Platone, l’isufficienza del testo e il dialofo socratico Il testo scritto, secondo Platone, come il discorso
retorico, è incapace di aprirsi un varco nella verità perché resta inevitabilmente legato a quella destinazione
pragmatica, a quella rigidità argomentativa, alle quali si sottrae solo il discorso orale, scrittura dell’anima.
Per questo Platone ci ha “consegnato” la forma filosofica del dialogo socratico: forma di filosofia aperta,
come spazio intermedio, scrive Vigetti, tra il privilegio della parola, cifra del socratismo, ed il primato del
testo, cifra dell’aristotelismo.
Quttordicesima Ora (Tra V sec a.C. e IV sec a.C.)
Sulla cronologia e l’esogenesi dei dialoghi di Platone
Tentativi di Cronologia: Citazioni interne e stolometrici Siccome dei dialoghi di Platone non si conosce una
cronologia, per cercare vagamente di ricostruirne una che si avvicini alla realtà sono state tentate due strade:
1) Quella delle citazioni interne: di solito, in un dialogo si trovano riferimenti espliciti a trattazioni contenute
in un altro dialogo; si può quindi stabilire facilmente la successione dell’uno rispetto all’altro. 2) Quella del
metodo stilometrico: a partire dalle “Leggi”, l’ultima opera che Platone scrisse (E’ l’unica notizia sicura), e
individuati in essa determinati stilemi (sono quei tratti distintivi propri ad ogni autore), si cerca di individuare
le opere che hanno:
a) Gli stessi stilemi, o comunque in misura massiccia, delle “Leggi” (Stesso stilema, stesso periodo à Periodo
tardo = DIALOGHI VECCHIAIA-DIALETTICI).
b) Quasi gli stessi stilemi delle “Leggi”(Periodo intermedio = DIALOGHI DELLA MATURITA’-COSTRUTTIVI )
c) Quasi per niente gli stessi stilemi (DIALOGHI GIOVANILI-SOCRATICI)
36 scritti (34 dialoghi – 1 discorso – 1 corpo di lettere)
PRIMO PERIODO
1. Eutifrone (sulla nozione di santità)
2. Apologia di Socrate (sul processo che decretò la condanna di Socrate)
3. Critone (su Critone che, recatosi in prigione da Socrate, cerca di convincerlo a fuggire senza però
riuscire nell’intendo: il filosofo evidenzia l’importanza della superiorità dell’anima sul corpo e del
valore della coerenza)
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
4. Ione (sull’arte della poesia)
5. Ippia maggiore (Sulla nozione di bellezza)
6. Ippia minore (sull’identità tra virtù e scienza)
7. Lachete (sulla nozione di coraggio)
8. Liside (Sulla nozione di amicizia)
9. Carmide (sulla nozione di sophrosyne = saggezza)
10. Alcibiade primo (sulla conoscenza dell’utile e del giusto, sulla consapevolezza)
11. Alcibiade secondo (sul senno e sulla stoltezza, sull’ignoranza, sulla preghiera)
Tra il primo ed il secondo periodo
12. Menesseno (Sulla retorica – Si suppone fosse un introduzione al Gorgia)
13. Protagora e Gorgia (sulla retorica)
14. Menone (sull’insegnabilità della virtù e sulla teoria della reminiscenza)
15. Eutidemo (sulle confutazioni contro le tesi degli eristi, i peggiori tra i sofisti)
SECONDO PERIODO
16. Cratilo (sul problema dell’origine dei nomi)
17. Simposio (Sull’eros)
18. Fedone (Sull’ultimo giorno di Socrate – Egli discute con gli amici sul valore della filosofia e
sull’immortalità dell’anima)
19. Repubblica (sulla Kallìpolis, la bella città governata dai filosofi ed alla loro educazione che è
educazione dell’anima)
20. Fedro (sul problema della retorica e della scrittura – qui si narra del celebre mito della biga alata che
rappresenta l’anima tripartita)
TERZO PERIODO
21. Teeteto (sull’epistème, cioè sul sapere saldo e sulle sue condizioni di possibilità)
22. Parmenide (sull’auto-criticità di Platone nei confronti della sua teoria delle idee)
23. Sofista (sull’essere ed il non essere, sulla distinzione tra realtà e apparenza, sul criterio della
distinzione del vero dal falso) Politico (sulle varie forme di costituzione)
24. Filebo (sulla natura della vita migliore)
25. Timeo (sulla struttura dell’anima del mondo e su quella umana)
26. Crizia (sul mito di Atlantide)
27. Leggi (su di un codice legislativo volto all’educazione dei cittadini alla virtù).
La lettera VII, la scrittura e le interpretazioni Del corpo di lettere rinvenuto ad opera di Platone, solamente
una, la critica, la attribuisce con certezza al filosofo in questione: la lettera VII.
La stesura di questa lettera è successiva alla morte di Dione, suo discepolo ed amico. E’ una lettera molto
importante perché ha attirato l’interesse di moltissimi interpreti contemporanei che hanno finito per non
essere tutti d’accordo l’uno con altro (non l’avreste mai detto èh?). Sostanzialmente, in questa lettera,
Platone critica la scrittura ribadendo una sua tesi (già esposta nel Fedro) secondo la quale un filosofo non
può mettere per iscritto le “cose di maggior valore”.
« Questo tuttavia io posso dire di tutti quelli che hanno scritto e scriveranno dicendo di conoscere ciò di cui
io mi occupo per averlo sentito esporre o da me o da altri o per averlo scoperto essi stessi, che non capiscon
nulla, a mio giudizio, di queste cose. Su di esse non c'è, né vi sarà, alcun mio scritto. » Platone - Epistola VII
• La scuola platonica di Tubinga, alla critica di Platone nei confronti della scrittura, propone un
interpretazione che Vigetti chiama “oralistico-esoterica” secondo cui Platone, appunto, non avrebbe
riportato, nei suoi dialoghi, i vertici metafisici della sua filosofia per l’inadeguatezza sia della scrittura
ad esprimere le cose di maggior valore sia degli interlocutori ad accoglierle; avrebbe quindi esposto,
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
questi “vertici metafisici” solo oralmente. In sostanza, com’è scritto nella stessa epistola, la
conoscenza di questa scienza (la filosofia) non è affatto comunicabile come le altre conoscenze
perché essa richiede una lunga serie di discussioni fatte insieme ed in stretta comunione fra chi
insegna e chi impara (quindi in una comunanza di vita, cioè una vita di gruppo) finché non nasce,
nell’anima stessa di chi impara, la luce che illumina la verità.
• Una seconda interpretazione critica quella “oralistico-esoterica” collocandosi al vertice opposto.
Questa vede la filosofia esposta oralmente solo come una via parallela a quella esposta nei dialoghi
(una sorta di insegnamento orale di quello che c'era scritto, nulla di più).
• Una terza interpretazione, anch’essa criticante la scrittura ma lontana dall’avvicinarsi a quella
“oralistico-esoterica” della scuola di Tubinga, evidenzia come la critica platonica non vada vista come
una rinuncia a scrivere “le cose di maggior valore” che solo oralmente dovrebbero essere diffuse,
ma solo un invito a valorizzare la forma dell’oralità e del dialogo continuo perché è l’unico a
permettere l’indagine interiore.
Lo scopo generale del filosofare di Platone, infatti, non è quello di offrire teoremi definitivi, ma quello di
definire metodi e problemi che conducono all’indagine interiore e che la permettono.
Diciannovesima ora (IV sec a.C)
Su Aristotele: la vita, le opere, un’introduzione alla logica
Aristotele tra Atene, l’accademia e Peripato 384 a.C. Aristotele nacque a Stagira. Il padre, Nicomaco, era
valente medico e fu al servizio del re Aminta di Macedonia (padre di Filippo il Macedone). E’ quindi da
presumere che Aristotele possa anche avere frequentato la corte.
366 a.C. A 18 anni, rimasto orfano, si recò ad Atene ed entrò quasi subito nell’Accademia platonica dove
rimase per ben vent’anni, ossia fino a che Platone rimase in vita.
347 a.C. Alla morte di Platone, Aristotele non sentì di rimanere nell’Accademia perché la direzione della
scuola era stata presa da Speusippo; si recò, pertanto, in Asia Minore.
343 a.C. Inizia un nuovo periodo nella vita di Aristotele: Filippo il Macedone lo chiama a corte e gli affida
l’educazione del figlio Alessandro, destinato a rivoluzionare la storia greca. Aristotele restò a corte fino a
quando Alessandro salì sul trono.
335 a.C. Aristotele torna ad Atene e prende in affitto alcuni edifici vicino ad un tempietto sacro di Apollo
Licio, donde venne il nome di “liceo” dato alla Scuola. Poiché Aristotele impartiva i suoi insegnamenti
passeggiando nei viottoli del giardino annesso agli edifici, la Scuola fu detta anche “Peripato” (dal greco
peritato = passeggiata). Il Peripato si contrappose così all’Accademia, e, per un certo periodo di tempo, la
eclissò interamente. Furono questi gli anni più fecondi per la vita di Aristotele.
Nel peripato, a differenza dell’accademia, dove uno leggeva per tutti, la lettura è solitaria, come da esempio
di Aristotele.
323 a.C. Morto Alessandro, ci fu in Atene una forte reazione antimacedone, nella quale fu coinvolto anche
Aristotele, reo di essere stato maestro del grande sovrano. Aristotele quindi fuggì e morì nel 322 a.C. Il
Peripato fu lasciato al suo amico Teofrasto.
Le idee Platoniche avevano lasciato aperto il dibattito sulla dialettica e quindi sulla relazione di idee e quindi
tra soggetto e predicato; per stabilire quando un predicato appartiene ad un soggetto, Aristotele introduce
e distingue, nei Topici, quattro diversi tipi di predicabili (modi di predicare):
• Definizione (risponde alla domanda “Che cos’è”)
E’ composta dalla definizione di un genere (vedremo dopo) e la specificazione di una differenza
L’uomo è un animale razionale
Genere: animale - Differenza specifica: razionale.
• Genere
E’ quel predicato in cui il soggetto rientra pienamente ma che è più ampio del soggetto stesso.
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
L’uomo è un animale
Animale è un genere poiché tutti gli uomini sono animali, ma non viceversa.
• Proprietà
Si riferisce a un predicato che non esprime la definizione ma è comunque predicato solo di quel
soggetto
L’uomo è capace di parlare
Il saper parlare non esaurisce la definizione di uomo, ma è comunque tipico solo dell’uomo.
• Accidente
L’accidente è un predicato che può o meno appartenere ad un soggetto. E’ un predicato che al
soggetto può “accadere”.
L’uomo è bianco
L’uomo può non essere bianco.
Le categorie Aristoteliche Quindi i predicabili sono tutti i modi in cui si può predicare una determinata
sostanza.
Nelle Categorie, Aristotele affronta per la prima volta quello che apparirà come il concetto fondamentale sia
della logica sia della metafisica: la nozione di sostanza.
Aristotele divide la sostanza in:
1. Sostanza prima (funge solo da soggetto): le realtà fondamentali che sussistono autonomamente e
che, senza le quali, nient’altro esisterebbe: gli individui. Es Socrate.
2. Sostanza seconda (può fungere sia da soggetto che da predicato): le realtà di minore entità che si
aggiungono alle Sostanze prime: specie e genere. Es Socrate (sostanza prima) è un uomo (specie) –
Socrate (sostanza prima) è un animale (Genere).
In parole povere, mentre Socrate (sostanza prima) è un individuo concreto, tangibile con i nostri sensi, uomo
(specie) e animale (genere) sono “sostanze seconde”, parole - definizioni mentali che noi attribuiamo a
Socrate mediante l’astrazione logica.
Tutti i termini delle predicazioni, siano essi specie, genere, o accidenti, sono riconducibili a dieci generi
supremi detti “categorie” e che sono:
1. Sostanza (seconda) o essenza “Uomo”, “Cavallo”
2. Qualità “Bianco” “aureo”
3. Quantità “due metri” “tre metri”
4. Relazione “Doppio” “maggiore”
5. Azione “bruciare”
6. Patire “ Venir tagliato, venir bruciato”
7. Luogo “In piazza, nel liveo”
8. Tempo “Ieri, l’anno scorso”
9. Avere “Porta le scarpe”
10. Essere in una sitazione “E’ coricato è in piedi”
Ventesima ora
Su Aristotele: le parole e le cose
La critica della separazione del mondo e la teoria del terzo uomo Aristotele critica la dottrina platonica delle
idee. In particolare, il suo bersaglio è il chrorismòs, cioè la separazione, posta dai platonici, tra il mondo
intellegibile (cioè quello delle idee) e quello sensibile.
Infatti il fatto di aver posto per ogni genere o specie un riferimento ideale nell’iper-uranio, complica di molto
le cose ed il loro studio aumentando il numero degli enti. Bisogna distinguere sì l’individuale dal particoloare,
ma non dividerlo (per esempio distinguere Socrate dal concetto di uomo in generale e non separare entrambi
come se Socrate fosse una realtà a sé e l’uomo ne fosse un’altra).
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
Uno degli argomenti utilizzati da Socrate per criticare la teoria del chorismòs, ed in particolare per criticare
l’ipotesi della mimesi (il rapporto di imitazione che le cose hanno con le idee) è quello del terzo uomo:
Aristotele suppose che, per essere certi che l’uomo sensibile sia la copia dell’uomo ideale, c’è bisogno di un
elemento che entrambi abbiano in comune. Questo elemento è il TERZO UOMO, cioè un uomo che ha
qualcosa in comune sia con l’uomo ideale sia con quello sensibile. Ma come si può dire che il terzo uomo
abbia qualcosa in comune con l ’ Uomo ideale e quello sensibile? C'è bisogno di un altro elemento che
debbano tutti e 3 avere in comune e che sarebbe un quarto uomo.. e così fino all’infinito.
Le idee acquistano quindi, per Aristotele, lo stesso significato che noi attribuiamo alle idee: esse sono realtà
universali, nozioni mentali e linguisticamente parlando, realtà esprimibili semplici parole, semplici termini.
Nel De interpretazione, allora, Aristotele spiega le relazioni che esistono tra il livello del linguaggio, del
pensiero e della realtà (riflessione che sarà poi ripresa dai filosofi medievali).
Relazione tra realtà, pensiero e linguaggio Queste relazioni, la prof, a mio avviso, le pone in modo di difficile
comprensione. Ma, posso assicurarvi che non è nulla di così complicato come vi mostrerò: Di un sinolo, il
composto di materia e forma (una sedia, una statua, un pallone), noi percepiamo e facciamo diventare
concetto solamente la forma (poiché la scissione tra materia e forma la facciamo solamente in astratto, cioè
mentalmente: l’oggetto si presenta alla nostra vista solo per la forma che ha).
(Per esempio, se adesso guardate la vostra mano, ciò che vedete è la sua forma. Scindere la vostra mano nei
suoi vari elementi, cioè la materia di cui è composta, quali la pelle, le vene e le ossa cui sono al suo interno,
è un’operazione che voi fate con la mente)
Diventato un oggetto (REALTA’), concetto nella mente (PENSIERO), si può trasformarlo e trasmetterlo
verbalmente agli altri (LINGUAGGIO). La scrittura ha il ruolo di trasportare le espressioni verbali dalla fonicità
(verbalmente) alla graficità (per iscritto).
Per riassumere: Ciò che è universale ha due modi esistere. A) Uno ce l’ha nella mente, in astratto, e solo lì
sono possibili tutte le differenze particolari, solo lì, cioè, si può scindere l’universale dal particolare, la forma
e la materia dal composto. B) Un altro ce l’ha nella stessa realtà, in quanto materia e forma sono unite e non
si possono scindere, scorporare l’una dall’altra.
Per quanto riguarda il linguaggio nel De Interpretazione Aristotele afferma da un lato la simbolicità delle
parole, cioè la genesi dell’articolazione vocale e del linguaggio mentale e dall’altro la natura della relazione
che lega tra loro linguaggio umano e mondo: l’uomo può pensare il mondo e parlarne perché le operazioni
logico-cognitive della sua anima e i fatti/cose (pragmata) di cui è intessuto il mondo hanno conformazioni
simili.
Ventunesima ora
Su Aristotele: le parole e le cose
La logica è stata fondata da Aristotele. Mentre noi, però, la chiamiamo logica, lui la chiamava analitica, cioè
l’arte di scomporre il pensiero nei suoi elementi.
I 6 libri che costituiscono l’organon sono: Categorie – De interpretazione – Analitici primi – Analitici secondi
– Topici – Confutazioni sofistiche
Le Categorie trattano dell’“estensione”, cioè l’ampiezza, e la “comprensione”, cioè la determinatezza, dei
termini – parole – concetti: La specie (la parola uomo per esempio) ha una maggiore “comprensione” ed una
minore estensione rispetto al genere a cui appartiene (cioè animale in questo caso); il genere ha una minore
comprensione ed una maggiore estensione rispetto alla specie.
In sostanza, ma questo era ovvio già dal paragrafo precedente, quanto è maggiore l’estensione di un
concetto, tanto minore è la sua comprensione. (Ex. Se io voglio studiare e quindi conoscere un “animale”
dovrei mettermi a studiarli tutti perché la parola “animale” comprende l’uomo, lo struzzo, il cavallo ecc. ecc.
Se decido, però, di studiare un cane, mi è molto più facile perché mi basta conoscere i vari tipi differenti di
cane esistenti… Molta meno fatica e quindi di più facile studio e comprensione!).
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
Il De Interpretazione invece si occupa di definire le relazioni tra termini, cioè giudizi, proposizioni.. I rapporti
tra soggetto e predicato.
Il De interpretazione tratta delle relazioni che intercorrono tra le/i proposizioni/giudizi.
Le proposizioni possono essere divise sotto tre aspetti:
1. Quantità; le proposizioni possono essere universali, particolari o indefinite. Se dico "tutti gli uomini
sono mortali" è universale, “alcuni uomini sono mortali è indefinito.
2. Qualità; le proposizioni possono essere affermative o negative: sia le universali che le particolari
possono essere sia negative che affermative. Tutti gli uomoni sono mortali, nessun uomo è immortale
3. Modalità, una proposizione può essere Possibile (non è ma può essere) Impossibile (non è e non può
essere) Contingente (è ma può non essere) Necessario (è e non può non essere)
Le proposizioni possono inoltre essere:
• CONTRARIE (differiscono per qualità) hanno la prerogativa di non poter essere entrambe vere ma di
poter essere entrambe false: "tutti gli uomini sono bianchi" e "nessun uomo è bianco" sono tutte e
due false , in quanto qualche uomo è bianco e qualche altro non lo è!
• CONTRADDITTORIE (differiscono per qualità e quantità) invece hanno la prerogativa di essere
necessariamente una vera e l'altra falsa: "tutti gli uomini sono bianchi" , "qualche uomo non è
bianco": se la seconda è vera, la prima non lo è.
Gli analitici primi introducono il metodo sillogistico. Il sillogismo è così definito da Aristotele:
““Un sillogismo è un discorso in cui, posti alcuni oggetti (date delle premesse), qualcosa di diverso dagli
oggetti stabiliti (qualcosa di nuovo dalle premesse fatte) risulta necessariamente (deve essere un
obbligatorio risultato), per il fatto che questi oggetti sussistono (per il fatto che sono poste quelle
determinate premesse)”.
In un sillogismo, o anche ragionamento perfetto, vi sono tre proposizioni, due delle quali sono dette
premesse e si distinguono in premessa maggiore (la prima) e premessa minore (la seconda), l’ultima è detta
conclusione perché scaturisce appunto dalle premesse fatte.
(premessa maggiore) Tutti gli uomini sono mortali
(premessa minore) Tutti i greci sono uomini (conclusione)
Dunque tutti i greci sono mortali
Perché si dia il sillogismo le premesse devono avere in comune un termine, detto “termine medio” sia perché
le unisce, sia perché permette il passaggio, da esse, alla conclusione.
Si distinguono tre figure di sillogismo a seconda del ruolo svolto dal termine medio:
1) Prima figura: il termine medio è soggetto nella prima premessa e predicato nella seconda (es precedente)
2) Seconda figura: il termine medio è predicato in entrambe le premesse (Birba ha 4 zampe – il cane ha 4
zampe = Birba è un cane)
3) Terza figura: il termine medio è soggetto in entrambe le premesse (Il cavallo ha i muscoli – Il cavallo si
muove = I muscoli permettono il movimento)
Nel medioevo provvidero a schematizzare tutta la sillogistica:
Lettera a: prop universali positive Lettera e: prop universali negative Lettera i prop particolari positive Lettera
o: prop particolari negative.
Quindi Il silloggismo bArbArA è formato da 3 universali positive, fErIO da un.neg pa.pos e pa.neg..
Gli analitici secondi trattano dei sillogismi scientifici o dimostrativi. Mentre negli analitici prima si parla del
sillogismo in generale, cioè di quei sillogismi che prescindono dal contenuto veritiero delle premesse e quindi
delle conclusioni, negli analitici secondi il sillogismo scientifico “guarda” al valore di verità delle premesse
(premesse vere, altrettanto vere le conclusioni).
Secondo Aristotele, perché si possa fondare la scienza, bisogna capire che né tutte le cose sono dimostrabili,
né tutte indimostrabili. Alcune di esse, però, devono essere dimostrate sulla base di alcuni principi
indimostrabili che vengono chiamati principi primi.
I principi primi sono di due tipi:
a) Quelli comuni a più scienze chiamati assiomi come il principio di non contraddizione e del terzo escluso.
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
b) Quelli propri di ciascuna scienza come i numeri nella matematica.
Da dove vengono, però, questi principi primi? Aristotele risponde che vengono mediante:
A) L’induzione B) L’intuizione
1. L’INDUZIONE è procedimento attraverso cui dal particolare si ricava l’universale. Aristotele
riconosce che l’induzione non è un ragionamento, ma un “essere condotto” dal particolare
all’universale da una sorta di visione immediata o di intuizione che l’esperienza rende possibile.
L’induzione è, in sostanza, un processo astrattivo.
2. L’INTUIZIONE è invece il coglimento puro da parte dell’intelletto dei principi primi. (Dunque,
anche Aristotele, come già Platone, ammette un’intuizione intellettiva
Nei Topici, Il sillogismo dialettico parte da premesse che non sono dimostrate (non per forza false) e ciò a cui
arriva, seppur giusto, non è per forza la verità: se le premesse sono errate, lo è anche la conclusione.
Mentre il sillogismo scientifico dimostra la verità, il sillogismo dialettico, però, può scoprirla. Ed il modo con
cui il sillogismo dialettico può scoprire la verità, è attraverso, se si pensa fondamentalmente alla matematica,
le dimostrazioni per assurdo.
Gli elenchi sofistici trattano del sillogismo eristico. L’opera indaga i tipi di confutazione che il sillogismo
eristico adotta per far credere veri, con tanto di dimostrazione, i propri discorsi.
Ventiduesima ora
Su Aristotele: la fisica
Quando c’è mutamento, c’è sempre movimento Il movimento (Aristotele intende al movimento più come
un “mutamento” che come movimento in sé e per sé) si esplica attraverso tre fasi:
1) La cosa che muta (sostrato o materia)
2) La mancanza in esso di un certo carattere (privazione)
3) Il carattere che viene acquisito (forma).
Ex. Un uomo ed il suo divenire musicista sono un tipo di divenire in cui l’uomo è il sostrato, la sua mancanza
di cultura musicale la privazione, la sua acquisita cultura musicale che lo fa un musicista la forma.
Potenza e forma Se vediamo questo fenomeno dinamicamente, non staticamente, noteremo che la cosa che
muta, cioè la materia, ha in sé la capacità (cioè potenza, potenzialità) di assumere o di ricevere una
determinata forma (cioè di attuarsi, divenire atto). il bronzo è potenza della statua; il legno è potenza di vari
oggetti che col legno si possono fare perché è concreta capacità di assumere le forme dei vari oggetti
Il composto che si sarà formato, conosciuto come sinolo di materia e forma (in questo caso la statua), sarà:
a) Se lo si considera come sinolo di materia e forma, come composto, prevalentemente atto (perché è
prevalentemente forma)
b) Se lo si considera nella sua forma sarà senz’altro atto o enteléchia (perché e solo forma, il legno e le sue
potenzialità sono escluse).
c) Se lo si considera nella sua materialità, sarà invece misto di potenza e atto
Infine possiamo dedurre che l’atto sta alla forma come la potenza alla materia.
Non bastano solo atto e potenza per spiegare il movimento/mutamento, poiché per far sì che una potenza
passi all’atto è necessaria una causa motrice o efficiente ed una causa finale.
Nel caso di una statua la causa efficiente è lo scultore che l’ha realizzata, la causa finale, cioè il fine per cui è
stata costruita, può essere, per esempio, il suo adornare una casa.
Teoria sul cambiamento Partendo dalla categorie, Aristotele espone la sua teoria del movimento intesa come
cambiamento (già ve lo avevo anticipato :P).
Esistono diversi modi del divenire:
1) Sostanziale (generazione e corruzione)
2) Qualitativo (alterazione)
3) Quantitativo (aumento e diminuzione)
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
4) Locale (spostamento, traslazione di un essere da un posto ad un altro) Si distingue in circolare e rettilineo
Le cause del movimento possono essere accidentali o volute.
L’infinito in potenza, numeri, spazio e tempo L’infinito, per Aristotele, esiste solo in potenza. Per capire il
motivo per cui esiste solo in potenza, bisogna precisare che Aristotele non vede l’infinito come qualcosa di
immateriale, lo vede quantitativamente: lo fa rientrare nella categoria della quantità, la quale vale solo per il
sensibile.
Infinito in potenza, per Aristotele è il numero, perché è possibile aggiungere a qualsivoglia numero un
ulteriore numero senza che si arrivi ad un limite estremo al di là del quale non si possa più andare.
Infinito in potenza, per Aristotele, è lo spazio in quanto, potenzialmente, può essere diviso all’infinito in
quanto il risultato è una grandezza ulteriormente divisibile.
Infinito in potenza, per Aristotele, è il tempo, poiché non può esistere tutt’insieme attualmente e si svolge e
si accresce senza fine.
Anche il movimento è infinito ed eterno, perché non può esistere un inizio del movimento che non sia già un
movimento.
Inoltre il tempo è movimento ed il movimento è nel tempo, quindi siccome il tempo è eterno ed il tempo non
è altro che una determinazione del movimento, l’eternità del primo, postula l’eternità del secondo.
Il Motore immobile, principio primo che ama Ma a quale condizione può sussistere un movimento eterno?
Aristotele risponde che può sussistere solo se sussiste un Principio primo che sia causa di esso.
Questo Principio primo dev’essere:
• Eterno : se eterno è il movimento, eterna dev’essere anche la sua causa.
• Immobile: tutto ciò che è mosso, dev’essere mosso da qualcos’altro (una pietra, ad esempio, è mossa
da un bastone, il bastone dalla mano e la mano dall’uomo). Questo è anche il principio della
cinematica. Ora, se è così, dev’esserci un Principio assolutamente primo ed assolutamente immobile
cui fa capo tutto il moto dell’universo.
• Atto puro, scevro di potenzialità: se questo principio che tutto muove fosse in potenza, potrebbe
anche non muovere in atto. Ma ciò è assurdo perché, in tal caso, se fosse in potenza, non ci sarebbe
un movimento eterno dei cieli che è sempre in atto.
E’ questo il MOTORE IMMOBILE. Nella Metafisica si dirà che il motore immobile muove senza muoversi
perché muove come l’amato muove l’amante.
Nel De Caelo si indaga il cosmo e i movimenti terrestri:
1- Mondo terrestre (mondo sublunare): comprende la terra e lo spazio che più prossimamente lo
circonda. Spazio che è costituito dai 4 elementi che Aristotele, contro Empedocle, considera
trasformabili l’uno nell’altro. I 4 elementi si muovono di moto rettilineo (dal basso verso l’alto gli
elementi leggeri come il fuoco e l’aria - dall’alto verso il basso gli elementi pesanti come l’acqua e la
terra)
2- Cielo (mondo sopralunare): comprende tutto ciò che è esterno al mondo terrestre: pianeti, astri, ecc.
Il cielo è il luogo naturale del quinto elemento, cioè L’etere, eterno ed incorruttibile, dotato,
naturalmente, di moto circolare uniforme
Ventitreesima ora
Su Aristotele: l’anima
L’anima in funzione del corpo, il corpo in funzione dell’anima Gli esseri animati differiscono da quelli
inanimati perché posseggono un principio che dà loro la vita: l’anima.
Il rapporto tra corpo e anima è da intendersi nei termini del rapporto tra un organo -strumento (corpo) e lo
scopo per cui quello strumento esiste (anima). Insomma, l’anima, per Aristotele, dà vita al corpo ed il corpo
è in funzione dell’anima. Senza l’anima saremmo solo un mucchietto di ossa senza senso, senza uno scopo:
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
saremmo essere inanimati privi, appunto, di vita. Es: “Non è il segare ad esistere in funzione della sega, ma è
la sega ad esistere in funzione del segare”.
L’anima vegetativa, sensitiva, intellettiva Aristotele parla dell’anima nel De Anima
Poiché i vari fenomeni della vita suppongono determinate operazioni costanti nettamente differenziati e che
sono
a. di carattere vegetativo come la nascita e la nutrizione. ANIMA VEGETATIVA.
L’anima vegetativa ha un livello psichico basso ed è il principio più elementare della vita, cioè quello
che regola le attività biologiche come la crescita,nutrizione e riproduzione.
b. di carattere sensitivo-motorio come sensazione e movimento. ANIMA SENSITIVA. L’anima sensitiva
ha un livello psichico medio. L’anima sensitiva regola le sensazioni, l’appetito ed il movimento. La
sensazione è la “funzione” più importante che svolge l’anima sensitiva.
c. di carattere intellettivo, come conoscenza, deliberazione (discorso) e scelta (volontà). ANIMA
INTELLETTIVA. L’anima intellettiva ha un livello psichico alto e regola il processo gnoseologico
(conoscitivo) dell’uomo, oltre che le facoltà di scelta, di astrazione, di memoria e di linguaggio –
discorso.
La sensibilità è la capacità di provare percezioni; queste avvengono per opera dei cinque sensi, ciascuno dei
quali ha per oggetto un “sensibile proprio”: la vista ha per oggetto i colori, l’udito i suoni ecc. ecc. Esistono
anche “sensibili comuni”, cioè qui sensibili che sono percepiti da più sensi come il movimento, la grandezza
ecc. ecc e dei “sensibili per accidente”, cioè errori (vedo una macchia da lontano e credo che sia qualcuno).
La sensazione è il passaggio di un senso, per esempio la vista, dalla potenza – la mera possibilità di vedere
– all’atto, ossia l’attuale visione di un oggetto. Ciò che il senso percepisce, dice Aristotele, si chiama forma
o immagine sensibile (aspetto, colore).
E’ fantasìa La phàntasia (immaginazione) è la rappresentazione mentale dell’immagine sensibile percepita.
Per questo motivo si colloca a cavallo tra la sensazione e l’intellezione (per intellezione si intende il processo
conoscitivo dell’intelletto).
Nel De anima Aristotele distingue due tipi di phàntasia
1) la phantasìa sensibile che l’uomo ha in comune con gli altri animali e che consiste nel semplice richiamare
una sensazione
2) la phàntasia linguistica che è esclusivamente umana e che consiste nel connettere più rappresentazioni
in vista di un discorso.
Quest’ultimo tipo di phàntasia è legata alla memoria. La memoria è strettamente connessa all’immaginazione
perché tutte le cose che possono essere oggetto di rappresentazione mentale possono essere ricordate: non
potrei immaginarmi Pegaso se non ricordassi l’immagine sensibile di un cavallo e di un volatile (ringrazio il
collega Paolo Leardi per questo fantastico esempio che mi ha aiuto a capire bene la questione e che vi
riporto).
Con la phàntasia, scrive Franco Lopiparo, professore di filosofia all’università di Palermo, i confini del mondo
vengono estesi oltre il mondo percepito.
Ventiquattresima ora
Su Aristotele: fisica e metafisica
Intelletto attivo e passivo L’intelletto opera sulle immagini sensibili e ne astrae la forma intellegibile presente
in esse potenzialmente, cioè la loro essenza. Perché si possa cogliere la forma intellegibile c’è bisogno di:
1) Intelletto passivo, che rappresenta la pura potenzialità dello stesso intelletto di apprendere le forme
intellegibili, è quindi in potenza ogni forma intellegibile: è come un foglio bianco che può essere
utilizzato per scrivere qualsiasi cosa. Affinché l’intelletto potenziale si attui nella conoscenza, è
indispensabile che esista un intelletto già in atto che lo muova a conoscere:
2) L’intelletto attivo agisce sull’intelletto passivo illuminandolo ad attuarsi nella conoscenza. In questo
modo (cioè con l’intelletto attivo che fa da motore immobile) l’intellezione è possibile poiché
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
l’intelletto passivo si attua conoscendo la forma intellegibile – allo stesso tempo, la forma
intellegibile, che è presente in potenza nell’immagine sensibile, si attua divenendo conosciuta
dall’intelletto.
Metafisica e sostanza Non si capisce, nel De anima, se Aristotele vedesse intelletto attivo ed intelletto passivo
come uniti o separati.
Aristotele dà varie definizioni alla metafisica:
a) la metafisica “indaga le cause ed principi primi e supremi” –
b) la metafisica “indaga l’essere in quanto essere” –
c) la metafisica “indaga la sostanza” –
d) la metafisica “indaga Dio e la sostanza.
L’essere si dice in molti sensi e si predica in modi diversi, secondo le 10 categorie. Seppur l’essere si dice in
molti sensi, tutti conducono all’unità che è la sostanza (se infatti dico “alto” o “affezionato” senza che ci sia
un soggetto come “Piero” o “Maria” o una “sedia”, cioè una sostanza che è alta o che si affeziona, quell’
“alto” e quell’ “affezionato” non valgono nulla).
Per questo motivo l’essere non è univoco (contro Parmenide) e, allo stesso tempo, non è equivoco (non rinvia
a realtà completamente diverse perché si riporta alla sostanza).
All’indagine dell’ “essere in quanto essere” (prote philosophìa), appartiene lo studio degli assiomi perché essi
sono implicati in qualunque forma di sapere.
I principali assiomi sono tre:
1) Il PRINCIPIO Di IDENTITA’ o DELL’ESSERE vuole che, dato A, esso sia = A. Una cosa è uguale a se stessa
EX. Mario è Mario
2) Il PRINCIPIO Di NON CONTRADDIZIONE afferma che “È impossibile che il medesimo attributo (un
predicato), nel medesimo tempo, appartenga (si possa affermare) e non appartenga (e negare) al
medesimo oggetto (al soggetto di cui è predicato) e nella medesima relazione”.
EX. La proposizione “Mario è alto e allo stesso tempo non è alto” è errata
3) Il PRINCIPIO DEL TERZO ESCLUSO (E’ un corollario del principio di non contraddizione) afferma che “Non è
neppure possibile che ci sia qualcosa tra due proposizioni, ma è necessario affermare o negare una cosa di
un’altra, quali che esse siano”.
In pratica esso stabilisce che date due proposizioni contraddittorie (dati un giudizio affermativo e un giudizio
negativo di ugual soggetto e di ugual predicato), non solo essi non possono essere né contemporaneamente
veri né contemporaneamente falsi (cosa già stabilito dal principio di contraddizione), ma è necessario che
uno di essi sia vero e l’altro falso, e che la falsità dell’uno implichi la verità dell’altro e viceversa, senza una
«terza» possibilità.
EX. Le due proposizioni “Mario è alto” e “Mario non è alto” implicano la falsità di una e la veridicità di un'altra
perché, come afferma il principio di non contraddizione, non possono essere entrambe vere nel medesimo
tempo
L’atto precedente alla potenza? Aristotele passa a parlare di sostanza prima, definendola come un sinolo
(unione di materia e forma).
Vi ricordate il famoso indovinello che recita “E’ nato prima l’uovo o la gallina?” ? Bene. Se lo ricordate e state
tentando nuovamente di rispondere, la soluzione di questo dilemma è data da Aristotele (E’ proprio lui che
ha posto per la prima volta il quesito) proprio partendo dal atto e potenza.
Vediamo dunque che significa che l’atto è anteriore alla potenza: Cronologicamente c'è una precedenza della
potenza sull'atto, in pratica prima c'è l'uovo (potenza) e poi da esso può esserci la gallina (atto). Ma,
logicamente ed ontologicamente, Aristotele dice che c'è una precedenza dell'atto sulla potenza perché tu sai
che quell'uovo di gallina è un uovo che non può far schiudere uno struzzo o un coccodrillo, ma solo una
gallina: l'orientamento all'atto precede la potenza stessa, la specie precede l'individuo.
Se, però, la specie precede l'individuo, non c'è evoluzione tra le specie in quanto esse sono eterne e sono
fisse, cioè sono sempre esistite e sono sempre le stesse.
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
Il Primo Motore Immobile si fa amare In quale modo può, il primo motore, muovere restando assolutamente
immobile? C’è, nell’ambito delle cose che conosciamo, un qualcosa che sappia muoversi senza muoversi esso
stesso? Aristotele risponde affermativamente, è ”L’oggetto del desiderio e dell’intelligenza”.
L’oggetto del desiderio è ciò che è bello e ciò che è buono: il bello ed il buono attraggono la volontà dell’uomo
senza muoversi essi stessi in alcun modo. Analogamente, il primo motore muove come “l’oggetto di amore
attrae l’amante”. E’ quindi evidente che, la causa che tutto muove restando immobile (cioè il motore
immobile), non è una causa di tipo efficiente (tipo la mano che lancia il sasso), ma è una causa finale e che
Aristotele arriva a chiamare Dio.
ATTENZIONE: il Dio Aristotelico non va confuso con il Dio della creazione. Il Dio Aristotelico non ha creato
nulla, è semplicemente la causa finale di tutti i movimenti: in pratica il mondo tenderebbe ad assomigliare a
Dio perché è attratto dalla perfezione che è appunto Dio.
Inoltre, per Aristotele, Dio non pensa alla realtà del mondo ed ai singoli uomini che sono cose imperfette e
mutevoli. Dio pensa a “ciò che è più divino e più degno di onore”, quindi pensa se stesso: è attività
contemplativa di se stesso, “è pensiero di pensiero”.
Venticinquesima ora
Su Aristotele: l’etica
Aristotele ha distinto le scienze in tre grandi branche
A) Scienze teoretiche: quelle che ricercano il sapere per sé medesimo (Logica – Fisica – Metafisica).
B) Scienze pratiche: quelle che ricercano il sapere per raggiungere, attraverso esso, alla perfezione morale
(Etica – Politica).
C) Scienze poietiche o produttive: quelle che ricercano il sapere in vista del fare, cioè allo scopo di produrre
determinate cose (Retorica – Poetica).
B e C sono scienze che dipendono dagli uomini, A non dipendono dagli uomini e non possono essere diverse
da come sono.
Le opere etiche di Aristotele sono l’Etica Nicomachea e l’Etica Eudemia, e, se autentiche, i Magna Moralia.
Secondo Aristotele il mondo della Prassi, delle scienze pratiche ha una sua autonomia, una sua collocazione,
con metodi di indagine che hanno più a che fare con credenze diffuse e condivise che con il mondo astratto
della teoria. Ecco perché nel sapere pratico, sarà sufficiente mostrare il fatto.
I destinatari dell’Etica Nicomachea sono i cittadini già moralmente formati secondo il valore della polis, che
saranno in grado di capire l’importanza dell’educazione morale e quindi di trasmetterla.
Esistono vari tipi di beni (fini), alcuni sono ricercati in fine di altri, altri per se stessi. Il più importante di tutti,
quello in vista del qualche ricerchiamo tutti gli altri, è la felicità.
La felicità per ogni ente consiste nella propria compiutezza, visto che ogni ente tende ad essa.
Il bene supremo realizzabile dall’uomo consiste nel perfezionarsi in quanto uomo (cioè compiersi), ossia in
quella attività che differenzia l’uomo da tutte le altre cose: la ragione.
Visto che l’essenza dell’uomo è l’essere un animale dotato di linguaggio, la sua perfezione sarà nell’attività
della sua razionalità linguistica, un’attività che sarà perfetta de svolta secondo virtù,cioè secondo
“eccellenza”.
Un’altra distinzione dell’anima, il linguaggio La felicità oltre agli agi del corpo tipici, per essere spiegata
richiede una descrizione degli scenari dell’anima: dell’anima una parte è senza linguaggio, un’altra invece ha
il linguaggio.
La parte senza linguaggio è a sua volta duplice:
• Aspetto vegetativo, che è quella di nutrizione e crescita, in comune con le piante e che non partecipa
affatto al linguaggio.
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
• Dimensione appetitiva ed in generale desiderativa, che partecipa al linguaggio, perché è in ascolto di
esso e gli obbedisce.
La dimensione linguistica e quella desiderativa sono strettamente connesse all’anima, visto che ciò che rende
i comportamenti umani eticamente valutabili è il fatto che essi siano volontari ed oggetto di scelta perché
ragionati.
La scelta è quel particolare tipo di volontà che, in seguito ad una valutazione argomentativa di ciò che è
possibile fare per raggiungere un determinato fine, orienta il comportamento in una direzione o in un’altra.
Non è il semplice volere o desiderare e può essere praticata solo dagli animali dotati di linguaggio. Quindi il
linguaggio si pone come necessario per l’eticità per due ragioni:
1. Vizi e virtù sono tipi di scelte e le scelte richiedono linguaggio
2. La scelta etica è guidata dal “discorso corretto” ossia l’enunciazione della norma che definisce in
ciascuna circostanza il comportamento virtuoso (ogni situazione ha un discorso corretto”.
Anche l’anima linguistica inoltre si distingue in una parte che si occupa di ciò che è necessario e immutabile
e un’altra che si occupa di ciò che è variabile e mutaibile.
La virtù, dice Aristotele, non è innata, la si può, quindi, solo acquisire. La virtù etica dev’essere una
“disposizione permanente”: non possiamo definirci virtuoso se ci comportiamo bene solo in qualche
occasione. Per questo motivo, la disposizione virtuoso si fonda sull’abitudine: le virtù devono diventare “modi
d’essere” che noi stessi costruiamo attraverso il ripetuto esercizio di azioni virtuose che rendono virtuoso il
carattere di chi le compie.
Ventiseiesima ora
Su Aristotele: la politica
L’uomo come essere politico e i vari tipi di aggregati Per Aristotele l’uomo è per natura un essere politico,
poiché è per natura un animale linguistico, il linguaggio ha infatti una destinazione essenzialmente politica.
Per Aristotele la vita del filosofo, dedita alla pura teoria ha come fine la Sapienza e consiste nel conoscere le
realtà che sono al di sopra dell’uomo. E’ la scienza teoretica, in special modo la metafisica.
Nell’esercizio di quest’ultima virtù, dice Aristotele, che è perfezione dell’attività contemplativa, l’uomo
raggiunge la massima felicità.
Nella Politica, Aristotele descrive le modalità naturali dell’aggregazione sociale (E’ evidente l’analogia con lo
sviluppo di un organismo vivente:
• La famiglia con la sua casa: essa risponde ai bisogni quotidiani del mangiare, del dormire, del
ripararsi. (GHIANDA)
• Il villaggio: esso risponde ai bisogni di aver lavoro (un lavoro primitivo) e della difesa da animali e
nemici. (PIANTICELLA)
• Polis: esso risponde al bisogno della vita politica e della cultura, in quanto all’uomo non deve bastare
vivere, ma vivere bene. Per vivere bene ha bisogno di esprimere la propria “umanità” che è il logos,
cioè il linguaggio, proprio della vita politica. (QUERCIA FRONDOSA)
I rapporti in famiglia come sono? Lo studio dell’òikos, ossia del “governo della casa” rileva l’esistenza di tre
tipi di rapporti familiari:
1) Rapporto tra uguali liberi (marito e moglie) nel quale però, per natura, il marito è atto a comandare
2) Rapporto tra disuguali liberi (Genitore e figlio), nel quale il comando del superiore è nell’interesse
dell’inferiore
3) Rapporto tra disuguali di cui uno non è libero (padrone e schiavo), dove il comando del superiore è
esercitato nel proprio interesse. La schiavitù è necessaria, ed è giusta, quando è fondata sulla natura, quando
cioè ad essere schiavi sono coloro che non sanno governarsi da sé.
Aristotele afferma che la crematistica, cioè l’arte di procurarsi i mezzi per vivere, è giusta e va distinta dall’arte
di accumulare i guadagni, che è ingiusta.
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
Aristotele contro il comunismo Aristotele, inoltre, critica il “comunismo” Platonico atto ad abolire la
proprietà privata e la famiglia. Infatti, Aristotele considera queste istituzioni come naturali e necessarie,
designando come forma ottima di governo quella che sia in grado di garantire pace e tempo libero.
Il governo è da pensarsi come servizio prestato agli altri e l’educazione deve essere rivolta a tutti. Per questo
Aristotele è sostenitore dell’assunzione delle cariche a turno che permette anche di alternare gli affari
pubblici con il tempo libero.
Ventisetteesima ora
Su Aristotele: la retorica e la poetica
La retorica come persuasione Lo scopo della retorica è quello di “persuadere” o, più esattamente, quello di
scoprire quali siano i modo ed i mezzi per persuadere.
La retorica è dunque una sorta di “metodologia del persuadere”, un arte che analizza e definisce i
procedimenti con cui l’uomo cerca di convincere gli altri uomini, i mezzi per rendere persuasivi i discorsi.
Questi mezzi riguardano 3 cose: il carattere morale di chi parla, i sentimenti di coloro che ascoltano e la
validità intrinseca delle argomentazioni.
Tre sono i generi di discorso persuasivo:
1) Il genere deliberativo: si usa nelle assemblee
2) Il genere giudiziario: si usa nei processi
3) Il genere epidittico: si usa nel caso di elogi pubblici
Infine, c’è una parte della retorica che è dedicata alla teoria dell’elocuzione, cioè agli stili del discorso orale e
scritto
Qual è la natura del discorso poetico? E a che cosa esso mira.
L’Arte e la poetica in chiave positiva: la Mimesi Platone aveva fortemente biasimato l’arte, appunto perché
la mimesi, cioè imitazione di cose fenomeniche, le quali, per lui, sono a loro volta imitazione degli eterni
paradigmi delle Idee, sì che l’arte diventa copia di copia, parvenza di parvenza, che estenua il vero fino a farlo
scomparire.
Aristotele si oppone nettamente a questo modo di concepire l’arte, e interpreta la “mimesi artistica”
secondo un’opposta prospettiva:
Afferma che tutte le forme di poesia sono una forma di imitazione, di MIMESI. Il significato del termine oscilla
tra “simulazione e rappresentazione”.
- In quanto rappresentazione, la poesia non è la semplice riproduzione di un’immagine che riproduca
accuratamente un modello, ma è la riproduzione dell’universale (il verosimile) di quel modello.
- In quanto simulazione (inganno), la poesia drammatica per eccellenza è la tragedia e ciò che essa è
in grado di simulare è un’identificazione tra il personaggio e lo spettatore. La fallibilità del
personaggio lo avvicina a noi e in questo fenomeno è insito il piacere della tragedia.
La Catarsi Mentre la natura dell’arte consiste nella imitazione del reale secondo la dimensione del possibile,
la finalità di essa consiste nella “purificazione delle passione”. Questo Aristotele dice facendo esplicito
riferimento alla tragedia “la quale per mezzo della pietà e del terrore finisce col l’effettuare la purificazione
di siffatte passioni” LA CATARSI.
Sempre nella Poetica Aristotele costruisce tre classificazioni delle forme poetiche elencando 3 tratti
differenziali per discriminarle.
1. Gli strumenti dell’imitazione sono il ritmo, le parole e le note e possono essere usate insieme,
disgiuntamente o parzialmente
2. Gli oggetti dell’imitazione possono essere persone migliori o peggiori ed oggetto di lode o biasimo
3. La poesia può essere più drammatica (mimetica) e più diegematica (narrativa).
Ventottesima ora
Un’introduzione alle filosofie ellenistiche: lo scetticismo
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
L’età ellenistica è un periodo storico che va dalla morte di Alessandro Magno (323 a.C.) alla vittoria di
Ottaviano contro Marc’Antonio nella battaglia di Azio (31 a.C.).
La crisi della polis e l’individualismo privato Uno degli aspetti che caratterizza l'Ellenismo è quello che
riguarda i suoi rapporti con la polis: la cultura classica greca differisce infatti dall'Ellenismo in quanto è
incentrata nella polis, fenomeno non solo politico sociale ma anche etico, spirituale e perfino religioso: la
polis rappresenta quel felice connubio fra stato (tutto) e singoli cittadini (parti) che risponde a quel concetto
di sana democrazia a cui guardano sia Platone che Aristotele nei loro differenti progetti di "sane" costituzioni.
Si tratta di una concezione in cui individuo e stato non sono considerati fini a se stessi, ma l'uno in funzione
dell'altro. La polis per l'individuo rappresenta la vita stessa, la somma di tutti quei valori in cui egli si riconosce
e crede (gli dei non sono qualcosa di universale o privato, ma sono gli dei della polis).
Con la fine della polis, invece, passiamo da un individualismo politico ad un individualismo privato, generato
dal nuovo universalismo.
Primato della vita spirituale e del mondo terrestre Vi sono anche alcuni elementi positivi, come il recupero
dell'indagine interiore (il "conosci te stesso" socratico) e l'intensificazione della vita spirituale intesa come
azione interna anziché esterna.
In età ellenistica viene negata la superiorità del mondo celeste rispetto al mondo terreste ed assume corpo
la credenza di un ordine terrestre non meno rigoroso di quello astrale. Si ricostruisce inoltre l’unità dell’io
messa in crisi dalla divisione platonica dell’anima e dalla distinzione aristotelica dei diversi livelli psichici.
Le filosofie ellenistiche più importanti furono lo scetticismo, lo stoicismo e l’epicureismo.
Pirrone e lo scetticismo Pirrone è colui che dà inizia allo scetticismo affermando che, come sottolinea
Timone, suo principale discepolo, tutte le cose sono ugualmente “senza differenza, senza misura e senza
discriminazione: per questo né le nostre sensazioni, né le nostre opinioni sono vere o false. La natura è
ontologicamente vacua e saggio è colui che adegua il proprio comportamento a tale mancanza di senso,
non c’è alcuna realtà oltre l’apparenza e bisogna esercitarsi perché delle sensazioni possano dar vita a
credenze.”
Il problema non è più quello platonico della conoscenza, ma come vivere indifferenti in un mondo a sua volta
indifferente.
Se le cose sono “indifferenti”, “immurabili” e “indiscernibili”, come si può vivere indifferenti in un mondo a
sua volta indifferente? L’unico modo è quello di non dare alcuna fiducia ad i sensi ed alla ragione. Lo scettico
deve quindi rimanere:
1) “senza opinione”, astenersi dal giudizio (l’opinare è sempre in giudicare)
2) “senza alcuna inclinazione” verso una cosa o un'altra
3) “senza agitazione” cioè “restare indifferenti”: non lasciarsi scuotere da alcuna cosa.
L’atarassia L’astensione dal giudizio viene successivamente espressa con il termine epoché di derivazione
stoica. Questo atteggiamento, denominato Afasia (mancanza di parola), conduce all’atarassia, cioè
l’imperturbabilità = mancanza di turbamento e quiete interiore.
Pirrone fu famoso per aver dato prova in molti casi di tale mancanza di turbamento e di totale indifferenza,
anche se, quando fu assalito da dei cani, provando paura, a chi lo incolpò di esser stato turbato lui rispose:
“è difficile spogliare completamente l’uomo”.
Arcesilao e la conoscenza impossibile, ma ragionevole Arcesilao faceva parte dell’accademia Platonica, il so
stoicismo fu diverso da quello di Pirrone, poiché non si fondò sull’idea di assoluta indifferenza del mondo,
ma sulla convinzione che né la mente né i sensi possono percepire nulla di certo. Non c’è al mondo nessuna
rappresentazione vera che sia tale da non poter essere falsa, non esiste alcun criterio per poter distinguere
il vero dal falso.
Ma Arcesilao è un passo in avanti a Pirrone: “colui il quale sospende il giudizio su tutte le cose regolerà le
proprie azioni in base a ciò che è ragionevole”. In pratica ogni persona può regolarsi ragionevolmente intorno
ai giudizi, alla conoscenza delle cose. Alla base, però, il saggio scettico deve sempre sapere dell’impossibilità
della conoscenza.
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
Carneade e la probabilità Carneade diede un nuovo impulso all’accademia: non esistendo un criterio
assoluto di verità generale, non può scomparire anche l’azione. E’ per questo motivo che Carneade risolve il
problema della vita con la dottrina del probabile.
E’ possibile, cioè probabile, che qualche rappresentazione sensibile avuta sia vera, anche se non possiamo
accertarlo. Possiamo quindi scegliere due strade: A) sospendere il giudizio – B) dare l’assenso alle
rappresentazioni che sembrano più vere di altre.
Secondo Sesto Empirico l’uomo non conosce le cose, ma ciò che appare delle cose (il fenomeno). Inoltre alle
critiche per il fatto che lo scetticismo cade in affermazioni dogmatiche tanto quanto quelle che intende
confutare, risponde affermando che lo scetticismo ha un intento antidogmatico ancehe contro se stesso.
Per sesto la ricerca di un criterio al quale conformare la propria condotta è la vera ragione dell’infelicità
umana.
Ventinovesima ora
Sull’epicureismo
Come tutte le filosofie ellenistiche del periodo anche l’Epicureismo è diviso in Logica Etica e Fisica.
L’interesse principale è quello di giungere alla felicità attraverso la comprensione della realtà, diciamo di dare
delle prescrizioni, poiché la felicità non è altro che il risultato di un metodo.
Il mondo come totalità e atomi L’epicureismo vede, come Democrito, gli atomi come costituenti primari
dell’universo; tuttavia il loro numero totale resta costante. Quindi come totalità esso è immobile,
eternamente stabile.
Gli atomi si muovono nel vuoto e come proprietà posseggono figura, peso e grandezza. Tutte le cose hanno
delle proprietà che le caratterizzano: la proprietà dei sassi è il peso, del fuoco il calore..
Movimento e Clinamen Il movimento ha delle cause: esse sono il peso e la non resistenza al vuoto. Tutti gli
atomi, anche di peso diverso si muovono allo stesso modo. Ma se gli atomi cadono nel vuoto lungo rette
parallele e ad uguale velocità come possono avvenire gli incontri – scontri che danno luogo agli aggregati ed
ai fenomeni naturali? Epicuro risponde a questo difficoltà introducendo la possibilità di una declinazione
(clinamen), cioè di una deviazione della retta perpendicolare. Il clinamen non figura nelle opere di Epicuro
pervenuteci ma è attestato con sicurezza e da fonti attendibili (Lucrezio, Cicerone).
Il clinamen consente, nel passaggio dal piano fisico a quello morale, di fon darne la possibilità di libertà e di
autonomia. Il clinamen, infatti, non ha causa; esso può darsi in qualsiasi momento e luogo: rappresenta
quindi un elemento di contingenza, di “rottura delle leggi di natura” (per usare un termine moderno).
Dei ed Anima Epicuro non nega l’esistenza degli Dei; l’afferma sulla base della sua concezione gnoseologica:
gli dei di Epicuro non sono composti di atomi, quindi aggregati corporei, abitano gli spazi vuoti fra mondo e
mondo, gli intermundia. Anche l’anima, come tutti i corpi, è costituita di atomi, particolarmente sottili e
mobili: l’individuo è dunque un composto di anima e di “carne” (il corpo). Omogenea al corpo, l’anima, vive
in stretta connessione con questo: “quando il corpo si distrugge, l’anima si disperde e perde la facoltà di
sentire”. L’anima, in altri termini, è mortale. L’individuo non può avere esperienza della propria morte, perché
ciò presupporrebbe una sopravvivenza dell’anima al corpo.
Nel momento in cui dimostra la vanità della paura della morte, Epicuro, in realtà, propone un approccio
positivo al problema della vita fondato sul concetto del limite. Dal punto di vista fisico – gnoseologico, la
morte è esclusa come esperienza possibile. La vita è un bene, ma la morte non è un male, perché in essa non
vi è dolore, né sensazione, né esperienza.
Ongi sensazione è contatto Se la morte è assenza di sensazione, la vita è tutta sensazione. Ogni sensazione
è contatto: i corpi emettono, a causa del movimento vibratorio degli atomi che li costituiscono, delle
immagini o simulacri, composte di atomi sottili e velocissimi che colpiscono i nostri organi di senso. La
rappresentazione di un oggetto è dunque la “registrazione” da parte degli organi di senso del simulacro di
quell’oggetto.
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
Nell’epicureismo è fondamentale la ricerca del piacere, ma non si tratta di un volgare edonismo. I piaceri
dissoluti sono da fuggire, poiché in nessun modo da essi nasce la felicità. Il vero piacere per Epicuro è il piacere
“Catastematico”, quello della pace assoluta, caratterizzato dalla totale assenza di dolore. Le componenti del
piacere Catastematico sono “Aponia” es Ataraxia.
Trentesima ora
Un’introduzione allo stoicismo
Il fondatore dello stoicismo, Zenone, nacque a Cinzio.
Lo Stoicismo è diviso on fisica, logica ed etica. La fisica è il fondamento dell’etica, poiché è dalla conoscenza
delle leggi del mondo che nasce la norma etica, i concetti di bene e male assumono una prospettiva cosmica.
Viene a definirsi una razionalità universale ed il saggio è colui che agisce sempre in accordo con questa
razionalità unversale.
La fisica è collegata anche con la logica: per poter vivere in accordo con la natura, l’uomo deve sapere quali
sono i fatti veri e che cos’è la verità. La natura è fatta di eventi naturali concatenati tra loro dal principio di
casualità. L’ordine delle cause corrisponde all’ordine delle proposizioni vere, la conoscenza di quest’ordine
permette all’uomo di progettare la sua vita in accordo con la natura e la ragione.
Gli stoici eliminano la divisione in razionale ed irrazionale dell’anima. E’ naturale solo la razionalità,
l’irrazionalità se esistesse giustificherebbe la malvagità, che non sarebbe nemmeno più considerabile tale.
Quindi l’anima, così come l’intera natura dell’universo è una questione di ragione (lògos), di razionalità.
La passione è uno stravolgimento del logos, il logos che va contro se stesso.
Il saggio stoico distingue il bene, i mali e l’indifferente:
I bene è la virtù, l’accordo con il logos e l’accettazione del destino
Il male è il vizio, l’errore della passione
L’indifferente è la salute o la malattia, la vita o la morte, la ricchezza o la povertà.
Trentunesima ora
Sulla logica e sulla fisica degli stoici
Per Zenone e per Crisippo, come per Epicuro, fonte di ogni conoscenza è la sensazione. L’anima è in origine
come una carta “ben disposta alla scrittura” sulla quale gli oggetti esterni, colti dai sensi, lasciano le loro
“impronte”. A tali impronte gli stoici danno il nome di rappresentazione che vengono fissate per mezzo della
memoria. L’insieme delle rappresentazioni costituisce l’esperienza.
Il criterio che garantisce la corrispondenza tra gli oggetti e le loro rappresentazioni è individuato dagli stoici
nell’assenso. Solo l’assenso, da parte del soggetto, infatti, trasforma la rappresentazione in rappresentazione
comprensiva o “catalettica”, cioè in rappresentazione vera. L’errore nasce dall’assenso accordato ad una
rappresentazione in modo precipitoso e scorretto. Mentre alla rappresentazione non ci si può sottrarre,
l’assenso è un atto libero e si dà solo alla rappresentazioni evidenti.
Sesto Empirico testimonia la differenza posta dagli stoici tra il vero e la verità, una differenza su tre punti
VERO: incorporeo, semplice, può essere posseduto anche dall’insensato
VERITA’: corporea, sistema totale, soltanto del saggio.
Vero è qualsiasi cosa enunci lo stato delle cose, verità e l’intero stato delle cose, è passato presente e futura.
La distinzione tra corporeo ed incorporeo è una distinzione basilare per gli stoici: condizione per l’esisitenza
di una cosa è la capacità di agire e di patire e tale condizione è solo dei corpi.
L’aria e la voce sono corporei, il significato non risponde a tale requisito. Non esistono significati senza
qualcuno li pensi, quindi essi non hanno esistenza indipendente, non agiscono, né patiscono.
Gli stoici riconobbero diversi tipi di asserzioni, tra di essi inclusero domande, preghiere, giuramenti.. ma il più
importante di tutti i tipi di asserzione è l’Axioma. In esso risiedono il vero ed il falso, può essere negato ed
affermato in se e per se. Secondo sesto Empirico, gli stoici giudicavano la validità delle asserzioni composte
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
secondo il principio di coesione: un ragionamento ipotetico è valido quando la contraddittoria della principale
entra in conflitto con la condizione:
Es.Se piove, allora ci bagnamo. Non ci bagnamo, allora non piove.
Questo viene definito indimostrabile, poiché non c’è bisogno di dimostrarlo, è autoevidente. Secondo
Diogene gli stoici distinguevano due principi: un principio attivo, cioè la Natura e Dio ed un principio passivo,
identificato con la “materia” o sostanza senza determinazione quantitativa.
La relazione tra i due principi è la mescolanza. Dio si mescola alla materia, la rende le dà la forma e la rende
capace di agire e patire.
Lo stoicismo non è materialismo, poiché non distingue nettamente mente e corpo, ma la mente è necessaria
per il corpo, un costituente di essa.
La concezione stoica del mondo fisico si riallaccia al naturalismo pre-socratico. Gli stoici percepiscono il
cosmo come un immenso organismo vitale e pulsante in ogni sua parte, la cui vita è organizzazione sono
governate da un principio unitario, il logos, o pnéuma o fuoco. Il logos è immanente alla realtà ed inseparabile
da essa. Gli stoici spiegano il mondo nei termini di un rigoroso immanentismo. Tutto ciò che esiste è corpo,
anche le divinità sono corpi, anche l’anima. Reale è infatti solo ciò che agisce o subisce un azione. La materia,
sostanza priva di qualità, riceve forma ad opera del pnéuma: soffio caldo che pervade e anima tutte le cose.
Gli stoici individuano 4 categorie per descrivere la realtà e sono astratte.
1. Sostanza che corrisponde alla materia
2. Qualificazione, una sorta di identità data dal pnèuma
3. L’essere in un certo stato, in un certo momento
4. Disposizione relativa, cioè le cose che una cosa possiede in relazione a qualcos’altro.
Trentaduesima ora
Un’introduzione al neo platonismo
I Neoplatonici chiamavano se stessi semplicemente platonici. Nella scuola e nella tradizione platonica si
determinò subito il problema di comprendere Platone. Di scoprire il vero significato al di là della metafora
letteraria di risolvere le apparenti contraddizioni.
La teoria delle idee era stata letta dai primi platonici in modi molto diversi. La storia del platonismo è in un
certo senso la storia delle diverse interpretazioni dello status “logico” ed “ontologico”. delle idee. Secondo
la teoria dei principi le idee non erano più considerate principo ma derivate esse stesse da due principi ad
esse superiori: L’ UNO fonte della razionalità e la DIADE fonte di molteplicità, disuguaglianza. Nella metafisica
Aristotele parla di una serie di posizioni accademiche riferibili ad una teoria dualistica di tipo pitagorizzante:
da un lato l’unità, dall’altro la dispersione: una sorta di ripreda del binomio pitagorico LIMITE-ILLIMITATO.
Anima unificatrice ed Uno La vera e propria storia della filosofia neoplatonica comincia con Plotino. Se
volgiamo lo sguardo in noi stessi, scopriamo che ogni atto della vita interiore diviene comprensibile se lo
riconduciamo a quella unità che dirige ed unifica l’intera attività intellegibile: l’anima. Anche l’anima è
tensione verso un ulteriore unità: l’unità dell’intellegibile che richiede a suo fondamento un intelletto
universale. Anche l’intelletto universale rimanda ad una realtà superiore, ad un unità scevra di molteplicità
in cui l’anima possa trovare quiete e riposo. Alla sommità c’è l’uno: tutte le cose sono quelle che sono in virtù
dell’unità, nulla potrebbe essere ciò che non è se non fosse innanzitutto un unità ed ogni unità, per essere
compresa, richiede riferimento ad unità superiore, di grado in grado risalente fino al principio assoluto.
L’anima si genera dall’intelligenza ed è come un pensiero che si stacca dal suo generatore per vivere una vita
autonoma. E’ anche l’estendersi dell’energia vitale dell’intelligenza stessa. La materia è’ mera assenza di luce,
puro non essere, specularmente opposto a quel non essere supremo che è l’uno. La materia non è che
l’ultimo esito del processo di irradiazione dell’uno, ma non è propriamente il male. Il male, infatti, nel sistema
di Plotino, sta nella rinuncia dell’anima a percorrere la strada che riconduce all’uno; il male è la scelta di
rimanere nelle tenebre e l’assenza di misura, l’indeterminatezza, l’instabilità, la passività. Compito dell’uomo,
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
lOMoARcPSD|5511223
infatti, è quello di distaccarsi dalla materia, ripercorrere i vari gradi del processo emanativo e ricongiungersi
all’uno.
L’uomo, per Plotino, è fatto di anima e di corpo. Ma è il corpo a stare nell’anima, e non l’anima a stare nel
corpo. Ci sono cose che si possono fare solo con l’anima. Ma non ci sono cose che il corpo sappia fare senza
anima. Ad ogni uomo, appartengono, per così dire, tre parti dell’anima: 1) la prima è la parte non discesa, la
parte dell’anima che resta sempre presso “l’intelligenza” e mediante l’intelligenza presso l’Uno. 2) Ciò di cui
invece l’uomo è consapevole, è la parte intermedia dell’anima, la sua razionalità umana, incarnata nel corpo.
I conflitti passionali. 3) La terza parte è del tutto corporea, anche di essa si è in un certo modo inconsapevole,
ma essa esercita una grande influenza deleteria. Compito dell’uomo è purificarsi, separarsi da tutto ciò che
è corporeo e diventare pensiero immune da passione. La conversione, la “catarsi”, il distacco dal sensibile,
l’abbandono della dispersione, sono i modi per ricongiungersi all’intellegibile ed all’Uno. Ciò che guida in
questo percorso di purificazione, che è un percorso di salvezza, non è il desiderio del bello estetico, è la brama
di “fusione” propria degli amanti: l’anima desidera ritornare presso di se, ritornare ad essere quello che era
un tempo quando era davvero felice.
L’estasi, la fusione dell’anima con l’uno che Plotino indica come meta del percorso filosofico, è negazione di
ogni individualità. E’ beatitudine, è abbandono.
Scaricato da Pollo Pollo (pollopollo@pollopollo.it)
Potrebbero piacerti anche
- Reale Giovanni Storia Della Filosofia Antica Vol 1 e 2 1987Documento92 pagineReale Giovanni Storia Della Filosofia Antica Vol 1 e 2 1987Vincenzo Lo PaloNessuna valutazione finora
- Filosofia - Storia Della Filosofia AnticaDocumento49 pagineFilosofia - Storia Della Filosofia AnticaelenaNessuna valutazione finora
- 2 - La Ricerca Del PrincipioDocumento4 pagine2 - La Ricerca Del PrincipioCrocetti SimonaNessuna valutazione finora
- Capitolo 1-La Grecia e La Nascita Della FilosofiaDocumento9 pagineCapitolo 1-La Grecia e La Nascita Della FilosofiaCiao Ciao100% (1)
- ARISTOTELEDocumento14 pagineARISTOTELEShika KiaraNessuna valutazione finora
- FilosofiaDocumento9 pagineFilosofiaEdoardo Del CarloNessuna valutazione finora
- I filosofi e le loro idee: Breve introduzione alla filosofiaDa EverandI filosofi e le loro idee: Breve introduzione alla filosofiaNessuna valutazione finora
- Le Origini Della Filosofia Nella IoniaDocumento22 pagineLe Origini Della Filosofia Nella IoniaFILIPPO RAPPARININessuna valutazione finora
- FilosofiaDocumento13 pagineFilosofiavirginiadandrea2008Nessuna valutazione finora
- FILOSOFIADocumento12 pagineFILOSOFIAMaria BellaNessuna valutazione finora
- StoriaDocumento8 pagineStoriaricoNessuna valutazione finora
- PRESOCRATICI AppuntiDocumento8 paginePRESOCRATICI AppuntiCristina CappellaNessuna valutazione finora
- Plat OneDocumento9 paginePlat OneArianna GiordanoNessuna valutazione finora
- Riassunti AristoteleDocumento11 pagineRiassunti AristoteleFedericaPerra0% (1)
- Riassunti AristoteleDocumento10 pagineRiassunti AristoteleFederica Perra67% (3)
- I Primi Filosofi E La Ricerca Dell' ArchéDocumento16 pagineI Primi Filosofi E La Ricerca Dell' ArchéDarioNessuna valutazione finora
- La Nascita Della FilosofiaDocumento11 pagineLa Nascita Della FilosofiaSimo 1223Nessuna valutazione finora
- Filosofia (Pitagora, Anassimene, Talete, Democrito,... )Documento3 pagineFilosofia (Pitagora, Anassimene, Talete, Democrito,... )noemimarini04Nessuna valutazione finora
- Aristo TeleDocumento31 pagineAristo TeleManfredi RandisiNessuna valutazione finora
- 100 pagine di filosofia: Le origini del pensiero occidentaleDa Everand100 pagine di filosofia: Le origini del pensiero occidentaleNessuna valutazione finora
- 2filo MiletoDocumento4 pagine2filo Miletofrancesca.maugeriNessuna valutazione finora
- FilosofiaDocumento59 pagineFilosofiastudentiaristofaneNessuna valutazione finora
- Causalità e determinismo nella filosofia e nella storia della scienzaDa EverandCausalità e determinismo nella filosofia e nella storia della scienzaNessuna valutazione finora
- FILOSOFIADocumento11 pagineFILOSOFIAcristianbovinolegoNessuna valutazione finora
- 1 La Filosofia PresocraticaDocumento9 pagine1 La Filosofia PresocraticaMonica Fernanda Aliaga LopezNessuna valutazione finora
- Platone - Ipertesto MultimedialeDocumento13 paginePlatone - Ipertesto Multimedialemik_spiga100% (1)
- Filosofia - EllenismoDocumento3 pagineFilosofia - EllenismoStefania SimonettiNessuna valutazione finora
- La Scuola Di MiletoDocumento7 pagineLa Scuola Di Miletotfptd7nbt5Nessuna valutazione finora
- I Filosofi PresocraticiDocumento19 pagineI Filosofi PresocraticiElisaNessuna valutazione finora
- PlatoneDocumento4 paginePlatoneIleniaNessuna valutazione finora
- Le Origini Della Filosofia e I MonistiDocumento2 pagineLe Origini Della Filosofia e I MonistiVittorio MaggioNessuna valutazione finora
- Razionalismo EmpirismoDocumento4 pagineRazionalismo EmpirismofabiomalesaNessuna valutazione finora
- Riassunti Filosofia AristoteleDocumento15 pagineRiassunti Filosofia AristoteleMarco Uras73% (11)
- PresocraticiDocumento5 paginePresocraticisonostufodiprovareNessuna valutazione finora
- La Filosofia ScientificaDocumento5 pagineLa Filosofia ScientificaGiuseppe ListaNessuna valutazione finora
- Relazione de AnimaDocumento18 pagineRelazione de AnimaSebastiano TaccolaNessuna valutazione finora
- 2 I Primi Filosofi La Scuola Di MiletoDocumento7 pagine2 I Primi Filosofi La Scuola Di Miletoraffaela.bellabarbaNessuna valutazione finora
- La Filosofia Antica - Talete, Anassimandro e Anassimene.Documento10 pagineLa Filosofia Antica - Talete, Anassimandro e Anassimene.CelesteNessuna valutazione finora
- Filosofia 1Documento7 pagineFilosofia 1Giorgia FornettoNessuna valutazione finora
- Filosofia Int 1Documento8 pagineFilosofia Int 1cristianbovinolegoNessuna valutazione finora
- Analisi del rapporto tra scienza e filosofia: in Schlick e VoltaireDa EverandAnalisi del rapporto tra scienza e filosofia: in Schlick e VoltaireNessuna valutazione finora
- Filosofia Antica PDFDocumento325 pagineFilosofia Antica PDFsoldadonocturno100% (1)
- Lezioni Sui Numeri Figurati (Parte Di Quella Di Sopra) - Bozza1-HDocumento16 pagineLezioni Sui Numeri Figurati (Parte Di Quella Di Sopra) - Bozza1-HRap ItalianoNessuna valutazione finora
- TAROLADocumento7 pagineTAROLAFiamma TarolaNessuna valutazione finora
- Lo StoicismoDocumento4 pagineLo StoicismoDomenico ZucaroNessuna valutazione finora
- Marchini Carlo - Il Problema Degli Universali Da Platone A OggiDocumento23 pagineMarchini Carlo - Il Problema Degli Universali Da Platone A Oggimariobianchi182Nessuna valutazione finora
- Aristotele 1Documento5 pagineAristotele 1davideNessuna valutazione finora
- EllenismoDocumento21 pagineEllenismoAMALIA PANENessuna valutazione finora
- Filosofia SviluppoDocumento12 pagineFilosofia Sviluppogabriel magoNessuna valutazione finora
- Dizionario della filosofia greca: Termini e nozioni, figure storiche e mitologiche, eventi. Edizione 2016.Da EverandDizionario della filosofia greca: Termini e nozioni, figure storiche e mitologiche, eventi. Edizione 2016.Nessuna valutazione finora
- Filosofia Antica PDFDocumento188 pagineFilosofia Antica PDFSamuelEspinalRamirezNessuna valutazione finora
- Dizionario Filosofico (Berti)Documento33 pagineDizionario Filosofico (Berti)BestimmteIndividuenNessuna valutazione finora
- Filosofia - CronologiaDocumento29 pagineFilosofia - CronologiaGiacomo Tresoldi0% (1)
- PlatoneDocumento12 paginePlatoneGianna conteNessuna valutazione finora
- 2 La Filosofia IonicaDocumento3 pagine2 La Filosofia IonicaDamnDamnNessuna valutazione finora
- Filosofia Della NaturaDocumento11 pagineFilosofia Della NaturaCarlo Edoardo CapponiNessuna valutazione finora
- 01 - IntroduzioneDocumento25 pagine01 - IntroduzioneAldo ChellaNessuna valutazione finora
- Linguistica RiassuntoDocumento88 pagineLinguistica RiassuntoAldo ChellaNessuna valutazione finora
- Riassunto Vita e Dottrina Di Kant Con CommentoDocumento35 pagineRiassunto Vita e Dottrina Di Kant Con CommentoAldo ChellaNessuna valutazione finora
- Riassunto Vita e Dottrina Di Kant CassirerDocumento12 pagineRiassunto Vita e Dottrina Di Kant CassirerAldo ChellaNessuna valutazione finora
- Storia Della Filosofia AnticaDocumento31 pagineStoria Della Filosofia AnticaAldo ChellaNessuna valutazione finora
- A02 Come Si Giustifica Una TesiDocumento22 pagineA02 Come Si Giustifica Una TesiAndrea VolonninoNessuna valutazione finora
- Parmenide Sulla Natura. Testo Greco Trad PDFDocumento617 pagineParmenide Sulla Natura. Testo Greco Trad PDFmwahahaa100% (1)
- Sintesi Di Storia Della Filosofia AnticaDocumento34 pagineSintesi Di Storia Della Filosofia AnticaTessy Psibar100% (2)
- (Note) Giorgio Colli - Parmenide PDFDocumento10 pagine(Note) Giorgio Colli - Parmenide PDFCarmen RomeroNessuna valutazione finora
- Presocratici in PDFDocumento15 paginePresocratici in PDFAlessio Tovaglia100% (2)
- Ontologia ParmenideDocumento0 pagineOntologia ParmenidekidmarcoNessuna valutazione finora
- Antígono de Caristo. Edición. Prolegómenos - DORANDI, T. (1995)Documento32 pagineAntígono de Caristo. Edición. Prolegómenos - DORANDI, T. (1995)glorydaysNessuna valutazione finora
- Eraclito, Parmenide E ZenoneDocumento2 pagineEraclito, Parmenide E ZenoneGennaro Jr Di NapoliNessuna valutazione finora
- Capizzi. La Repubblica Cosmica (Epub OCR)Documento594 pagineCapizzi. La Repubblica Cosmica (Epub OCR)Riccardo Rouvigny Rimbaud100% (2)
- Appunti Filosofia 3° Anno Liceo ScientificoDocumento6 pagineAppunti Filosofia 3° Anno Liceo ScientificoNoel Di FrescoNessuna valutazione finora
- Appunti Su ParmenideDocumento19 pagineAppunti Su ParmenideAnonymous 28AYvphsTfNessuna valutazione finora
- Il Metodo Di ZenoneDocumento8 pagineIl Metodo Di ZenonePietro Viviani100% (1)
- FilosofiaDocumento59 pagineFilosofiastudentiaristofaneNessuna valutazione finora
- Eta ArcaicaDocumento6 pagineEta ArcaicakiraNessuna valutazione finora
- # 1.11 Gli EleatiDocumento12 pagine# 1.11 Gli EleatipersonaNessuna valutazione finora
- TesinaDocumento47 pagineTesinaalfierelorNessuna valutazione finora
- FilosofiaDocumento13 pagineFilosofiavirginiadandrea2008Nessuna valutazione finora
- Filosofia Da Talete A DemocritoDocumento10 pagineFilosofia Da Talete A DemocritoGiukyNessuna valutazione finora
- Filosofia Della NaturaDocumento316 pagineFilosofia Della NaturaAdriano Virgili100% (1)
- La Nascita Della FilosofiaDocumento10 pagineLa Nascita Della FilosofiaGaia BorliniNessuna valutazione finora
- Filosofia Milesi, PreSocraticiDocumento6 pagineFilosofia Milesi, PreSocraticiPasquale AielloNessuna valutazione finora
- Il Nulla Che Noi Siamo - Slavoj Zizek e La Difesa Dell'intollerabileDocumento25 pagineIl Nulla Che Noi Siamo - Slavoj Zizek e La Difesa Dell'intollerabileStefano Bellanda100% (3)
- Parmenide, La Via Dell'EssereDocumento60 pagineParmenide, La Via Dell'EsseremrvitaliNessuna valutazione finora
- Maturita ParadossoDocumento42 pagineMaturita ParadossoriccardobrogiNessuna valutazione finora
- Verifica Di FilosofiaDocumento2 pagineVerifica Di FilosofiamattiasNessuna valutazione finora
- Verifica Di Filosofia Mattia SacripantiDocumento2 pagineVerifica Di Filosofia Mattia SacripantimattiasNessuna valutazione finora
- Parmenide Sulla NaturaDocumento41 pagineParmenide Sulla NaturaDavo Lo Schiavo100% (1)
- Tesi Infinito in Matematica PDFDocumento102 pagineTesi Infinito in Matematica PDFcapitankonigNessuna valutazione finora
- Appunti Rivisitati Di Filosofia: I PresocraticiDocumento7 pagineAppunti Rivisitati Di Filosofia: I PresocraticiZacharie PatàNessuna valutazione finora