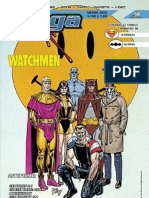Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Il Linguaggio e La Poetica Di Michelangelo Da Firenze A Roma
Caricato da
Jaime Vigliano Girando0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
210 visualizzazioni6 pagineCompendio da appunti scolastici e G. C. Argan, Storia dell'arte italiana, Sansoni, 1970
Titolo originale
06. Il linguaggio e la poetica di Michelangelo da Firenze a Roma
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
ODT, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCompendio da appunti scolastici e G. C. Argan, Storia dell'arte italiana, Sansoni, 1970
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato ODT, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
210 visualizzazioni6 pagineIl Linguaggio e La Poetica Di Michelangelo Da Firenze A Roma
Caricato da
Jaime Vigliano GirandoCompendio da appunti scolastici e G. C. Argan, Storia dell'arte italiana, Sansoni, 1970
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato ODT, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 6
Il linguaggio e la poetica di Michelangelo
Buonarroti da Firenze a Roma
1. La formazione e la Centauromachia
Fin dal 1490 si parlava delle doti eccezionali di un giovanissimo, Michelangelo Buonarroti (1475-
1564); ma, nel 1494, all’avvicinarsi di Carlo VIII, aveva lasciato Firenze, dove torna nel 1495 e, per
rimanervi abbastanza a lungo, nel 1501. Michelangelo è nato a Caprese nel 1475; tredicenne a
Firenze, viene posto a bottega dal Ghirlandaio. Non vi rimane a lungo: vuole diventare scultore, e si
mette a studiare con Bertoldo, un seguace di Donatello, che teneva scuola nel giardino mediceo, in
piazza San Marco. Lo nota subito Lorenzo il Magnifico, che lo prende sotto la sua protezione e lo
introduce nella sua cerchia neoplatonica di filosofi e letterati. Neoplatoniche dunque, le
impostazioni della cultura di Michelangelo e neoplatonica rimarrà fino alla fine la sostanza ideale
della sua opera di artista, ma anche della sua intensa, tormentata vita religiosa. Malgrado gli studî
col Ghirlandaio e col Bertoldo, Michelangelo è un’autodidatta. Concepisce, neoplatonicamente,
l’arte come ispirazione interiore, furor dell’anima; ma la sorgente dell’ispirazione non è, come per
Leonardo, la natura. È la cultura, come storia della spiritualità umana, della lotta per la salvezza.
Studia l’arte classica e certe sue opere vengono addirittura credute antiche: è la prova che non mira
tanto a interpretare il dato storico quanto ad appropriarsene quasi brutalmente, per poi superarlo,
trascenderlo. Le sue esperienze culturali si irradiano in tutte le direzioni: lo attrae soprattutto
Donatello, per il suo sentimento tragico della storia; ma tra i suoi disegni vi sono anche appunti, da
Giotto e da Masaccio. Poco dopo a Bologna, studia Iacopo della Quercia e Niccolò dell’Arca. Non
assume una determinata epoca storica come ideale; nel mutare delle epoche e delle forme cerca il
flusso perenne della spiritualità umana, del sentimento del sacro. Se l’antico rimane un vertice non
più raggiunto, non è per a sua classicità ma, al contrario, perché la mancanza della rivelazione e la
conoscenza esclusiva del mondo fisico costituivano una maggiore “difficoltà”, superata, al
realizzarsi del mondo spirituale. Nella Centauromachia, tra 1490 e 1492, i riferimenti culturali
immediatamente riconoscibili sono quattro: i sarcofagi tardo-romani, Giovanni Pisano, Donatello
(attraverso Bertoldo), Leonardo. Il tema vero del rilievo non è il mito classico, ma il furor e la sua
espressione nel movimento. Come è evidente dalla composizione a vortice, Michelangelo si
richiama all’Epifania di Leonardo (che, a dieci anni di distanza, era pur sempre, a Firenze, l’opera
più “moderna”), e si direbbe anzi che cerchi il confronto. Anche là il tema era il furor, ma il moto
aveva principio nella natura e dalla natura passava agli uomini. Per Michelangelo il moto nasce e si
conclude nelle figure, e la causa che lo suscita è un principio spirituale, il gesto di un Dio, Apollo.
Infatti, non v’è uno spazio, ma una prospettiva che inquadri e ambienti l’azione: i vuoti tra le figure
lasciano scorgere la pietra scabra del fondo. I valori in contrasto non sono il vuoto e il pieno, ma la
materia inerte, quasi passiva sotto la luce che la invade, e la materia animata dal moto, dove la luce
coincide con le tensioni e gli scatti dei gesti. L’artista non dissimula, anzi mette in evidenza il
processo della scultura, l’aspro lavoro dello scalpello: quasi per dire che un’ispirazione
naturalistica, come quella di Leonardo, aveva la sua espressione nella pittura, ma l’ispirazione
spirituale ha sua espressione nella scultura. È infatti persuaso che la scultura (che dirà più tardi, non
si fa come la pittura “ponendo”, ma “levando” la materia) sia la più nobile dunque la più spirituale
delle arti. Perché? Non tanto perché abbia un rilievo reale invece che illusorio, ma perché, appunto,
si fa levando o distruggendo la materia e liberando il concetto o il disegno. Nella Centauromachia
le figure emergono con impeto dalla pietra, che ancora in parte le avvince: proprio in questa lotta fra
materia viva e inerte sta il senso del “non-finito” michelangiolesco.
2. Il primo soggiorno a Roma: la Pietà
La Pietà vuole essere un’opera esemplarmente cristiana, ed infatti riprende audacemente il tema
gotico e nordico della salma di Cristo adagiata in grembo alla Madonna. Al tema del desiderio del
contemporaneo Bacco si contrappone, nella Pietà, il tema complementare del rimpianto, e anche
questo ha due momenti, cioè si realizza in un’oscillazione ansiosa dell’animo. La Madonna tiene in
grembo Cristo morto, come se fosse un bambino dormiente; ed è giovane, come quando Cristo era
bambino (è quasi una Madonna Annunciata). Forse la statua vuol essere proprio questo: una visione
o, piuttosto, la previsione o prefigurazione che la Vergine ha della Passione del figlio. Alla
previsione si lega subito il rimpianto: il gesto dimostrativo della mano della Madonna dice che la
previsione si è purtroppo avverata. È un arco di tempo dal passato al futuro, che esclude il momento
del presente, della realtà del fatto. La composizione è chiusa in una piramide, quasi a indicare che
tutto ciò rientra in un concetto divino, e che trascende il dolore, la pietà umana. Ma lo scopo di
questa lucida geometria (come del cubo in cui si inscrivevano la Madonna della Scala e l’Angelo di
Bologna) è anche di ottenere il movimento senza descriverlo come fatto fisico, deducendolo dallo
scarto, dalla divergenza delle linee rispetto ai lati o all’asse dello schema. Il ritmo, qui, nasce dal
disarticolarsi del corpo di Cristo in una successione di angoli, dalla caduta obliqua del braccio,
dall’inclinazione della testa della Madonna: dal rompersi, cioè, dell’equilibrio “naturale” della
composizione. Per il Bacco e la Pietà dovremmo parlare di troppo-finito. Le immagini sono
concepite in una dimensione che è al di là della realtà naturale, al di là dello spazio: la luce deve
scorrere sulla forma levigata senza penetrarla, l’aria non deve avvolgerla ed offuscarla. Il troppo-
finito michelangiolesco è dunque l’opposto metafisico del fisico sfumato di Leonardo.
Michelangelo vuole andare al di là del reale, Leonardo vuole penetrarvi a fondo. L’uno e l’altro
muovono da un assunto neoplatonico e ne superano il limite umanistico di pensiero antico “rinato”
per assumerlo come premessa di una coscienza attuale: ma Leonardo lo supera nel senso
dell’analisi, avvicinando l’arte alla scienza, Michelangelo nel senso della sintesi, avvicinando l’arte
alla filosofia.
4. Il ritorno nella Firenze repubblicana: il David e la Battaglia di Cascina
La relazione e il contrasto si fanno più stretti quando i due maestri si incontrano a Firenze nel 1501.
Per Leonardo non v’è un arco passato-futuro, v’è soltanto il presente dell’esperienza: le sue figure
non hanno una storia, sono puri fenomeni in un mondo di fenomeni. Altro contrasto: tra il San
Gerolamo che Leonardo aveva lasciato incompiuto a Firenze nel 1482, e il David che Michelangelo
scolpisce tra il 1501 e il 1504 (posto all’ingresso del palazzo della signoria). Doveva rappresentare,
l’Ira e la Fortezza, le due virtù della Repubblica fiorentina: il David è una figura eretta, policletea
quasi non occupa spazio: dall’asse che cade a piombo dalla tesa al piede diverge la gamba obliqua
ed è il principio del succedersi di concisi scatti di moto: la brusca flessione del polso, il sùbito
volgersi della testa, il braccio piegato verso la spalla, il volto “terribile” (Varasri) della giovinezza
spensierata toccata improvvisamente dalla maturità, accentuata da sopracciglia e dal moto dinamico
della capigliatura. Il movimento della figura non si espande nello spazio, si rinchiude negli arti
contrapposti delle membra. Michelangelo si è servito di un blocco in cui, quarant’anni prima,
Agostino di Duccio aveva abbozzato una figura per l’esterno del Duomo, stretta e lunga secondo il
modulo quattrocentesco: era una “difficoltà” da superare, ma anche una condizione che l’artista
accettava volentieri perché gli permetteva di concentrare nell’immagine il massimo d’energia, anzi,
di concepire la figura dell’eroe nel momento della concentrazione della volontà in vista dell’azione
da compiere (infatti, mentre guarda lontano con le sopracciglia aggrottate, come a prendere la mira,
scioglie la fionda che porta avvolta intorno al corpo). L’artista non rappresenta l’azione, ma il suo
movente morale, la tensione interiore che precede lo scatto del gesto. All’opposto, il San Gerolamo
è una figura quasi pronta, emaciata, sofferente: i nervi tesi, i tendini scoperti la rendono
estremamente sensibile allo spazio che la circonda. L’eroe di Michelangelo, giovane e pieno di
forza pronta a scattare, è l’immagine della volontà; l’eroe di Leonardo, vecchio, consumato dalla
lunga “sofferenza” della realtà, è l’immagine dell’esperienza.
Sul tema della storia, si scontrano Leonardo e Michelangelo nel 1504 quando la Signoria li incarica
dipingere, nella sala del consiglio in Palazzo Vecchio, due scene di battaglie vinte dai fiorentini. Il
dipinto di Leonardo, la battaglia di Anghiari, rovinò prima d’essere finito per la tecnica impropria
adottata (come nel Cenacolo di Milano); Michelangelo aveva appena finito il cartone della
battaglia di Cascina, quando fu richiamato a Roma da Giulio II. Dice il Cellini che i due cartoni,
finché si conservarono, furono “la scuola del mondo”: il grande tema della pittura del Cinquecento è
infatti la rappresentazione “di storia”. Conosciamo la parte centrale dei due cartoni da copie e da
stampe. Leonardo concepisce la battaglia come un fenomeno della natura, un ciclone: tra vortici di
fiume e di polvere si vedono episodî di lotta furibonda, cavalli che paiono belve infuriate, smorfie
ferine di combattenti. Lo stesso furore scatenato sconvolge natura, uomini, bestie, annulla ogni
differenza, confonde tutto nel vortice di un ritmo senza principio né fine. È il punto culminante
della battaglia, è la massima dimostrazione della bestialità dell’uomo, che si concretizza nella
guerra: la battaglia è una gigantesca sinestesia, attraverso le sembianze bestiali dei soldati Leonardo
vuol far sentire lo stridore delle armi, il sangue, le urla dei morenti. Alla visione panoramica di
Leonardo, Michelangelo oppone momento preciso: mentre i fiorentini, credendosi al sicuro, si
bagnano in Arno, sono sorpresi dai pisani; la situazione è disperata, ma proprio la disperazione dà
loro la forza di battersi e vincere. La figurazione michelangiolesca ha infatti un doppio significato:
celebra un episodio eroico della storia fiorentina (e per Michelangelo, come già per il Savonarola, la
libertà politica è un’esigenza di fondo della vita morale e religiosa) e allude al momento eroico della
spiritualità cristiana. Per il cristiano, come per il soldato, l’ora della prova estrema giunge quando si
è meno preparati, ma la stessa angoscia può diventare forza di riscatto. Si delinea così, più ancora
che nel David, l’ideale eroico di Michelangelo: eroe non è tanto colui che compie un’azione
coraggiosa quanto colui che, vincendo l’inerzia e il sonno della carne, afferma il proprio essere
spirituale e si salva. La figura dell’eroe è massiccia e muscolosa perché sia evidente il peso della
materia; ma nella massa stessa si suscita un moto che la scuote, la strappa dall’inerzia, le imprime
una spinta che la porta in alto, la riscatta. Né altro che questo trascendere il corpo che lo compie è il
fine del moto o del gesto nell’arte di Michelangelo.
5. Michelangelo a Roma
Quando si dice che Michelangelo è un genio, non si esprime un apprezzamento sulla sua arte, ma si
formula un giudizio storico. Genio, nel pensiero del Cinquecento, è una forza extra-naturale
(angelica o demoniaca) che agisce sull’animo umano; è ciò che in epoca romantica si chiamerebbe
ispirazione. Leonardo è un formidabile “ingegno”, ma non è, in questo senso un “genio” perché
tutta la sua opera insiste sull’area dell’esperienza e della conoscenza; Michelangelo è un “genio”
perché la sua opera è ispirata, animata da una forza che si direbbe soprannaturale e che la fa nascere
dal profondo e tendere al sublime, alla trascendenza pura. Il messaggio che l’artista sente giungergli
da Dio è individuale: per udirlo, deve chiudersi nella solitudine e nella meditazione. Michelangelo,
nella storia dell’arte, è il primo caso di artista isolato, quasi avverso al mondo che lo circonda e a
cui si sente estraneo, ostile. Raffaello a Roma vive come un principe, tra una corte di discepoli e di
ammiratori; il suo studio è un organismo complesso e attivissimo, dove una scelta squadra di
collaboratori variamente specializzati esegue, elabora, sviluppa, applica i disegni del maestro.
Michelangelo vive solo, poveramente malgrado le ricchezze che accumula; superbo con gli altri e
sempre scontento di sé; assillato, specialmente da vecchio, dall’ansia della morte e della salvezza.
“Non ho amici e non ne voglio” scrive al fratello: non ha neppure collaboratori e discepoli, affronta
da solo imprese gigantesche. Un solo grande affetto, per Vittoria Colonna: un rapporto puramente
spirituale, che influisce profondamente sulla sua vita religiosa. Scultore, pittore, architetto (e poeta),
per tutta la vita mira ad un’arte che sia la sintesi delle tecniche particolari e, superandole, realizzi il
puro disegno, l’idea. Benché presenti periodi o cicli ben definiti, tutta l’opera di Michelangelo
appare concatenata: ogni singola opera riprende, rielabora, supera le esperienze delle precedenti.
Per la prima volta l’arte è identificata con l’esistenza stessa dell’artista: come l’esistenza, è
un’esperienza che si compie e non potrà dirsi compiuta che col compiersi dell’esistenza, con la
morte. Perciò il pensiero della morte è presente in tutta la sua opera. Il sentimento, l’inquietudine
del non compiuto hanno anche una causa diretta: l’opera in cui l’artista voleva esprimere tutto sé
stesso, la tomba di Giulio II, non fu mai compiuta. Per trent’anni e più le contrastate vicende della
tomba sono la tragedia della sua vita. L’aveva concepita, nel 1505, come il “monumento” classico
della cristianità: sintesi di architettura e scultura, fusione dello “eroico” antico e dello “spirituale”
cristiano, espressione del potere esercitato sul mondo e della sublimazione dell’anima in Dio, ma
anche del ciclo storico che, aperto da Pietro al tempo dell’impero di Roma, culmina nell’Impero
spirituale, nell’autorità che Giulio II ha assicurato alla Chiesa. Il papa si entusiasmò del progetto
ma, per varî motivi, ne differì l’attuazione (per la “invidia di Bramante et di Raffaele da Urbino”,
scrive Michelangelo); dopo la sua morte, durante le complicate trattative con gli eredi, il progetto fu
più volte modificato e più volte rifatto, finché l’artista stanco, ormai quasi vecchio, volto ad altri
problemi, non si rassegnò alla soluzione minima del sepolcro che si vede in San Pietro in Vincoli: al
cui centro è la statua del Mosè che l’artista aveva ideato e in gran parte eseguito molti anni prima
per il Mausoleo di San Pietro.
Il Mosè (1513-16; 1542) è stato interpretato come la rappresentazione dell’Ira: è colto nel momento
in cui vede il popolo di Israele venerare il Vitello d’oro). Mosè sarebbe dunque colto nell’atto di
alzarsi per scagliare le tavole. Sigmund Freud ha fornito un’interpretazione dell’opera che la rende
coerente alla poetica di Michelangelo e alla sua concezione della condizione umana e dell’azione
dell’uomo: infatti – argomenta Freud – se Mosè è davvero il patriarca cui Dio ha assegnato un
compito così grande (quello di custodire, diffondere e far rispettare le XII tavole), come si potrebbe
conciliare il suo compito divino con questo suo troppo umano momento d’ira? In realtà, secondo
Freud, Mosè ha appena ricevuto le tavole e, fiero di questo compito, sta per sollevarsi, quando
assiste all’abiura del popolo eletto: sta per scagliare le tavole, ma impedisce che gli cadano con il
gomito, mentre con l’altra mano si strattona la barba (atteggiamento letto da Freud come azione
compulsiva masochistica dell’inconscio che scuote la coscienza attraverso il dolore fisico che
riporta l’io alla ragionevolezza: l’inconscio, attraverso questi atti, mette a freno e tutela l’io dalle
passioni più irrazionali). Lo sforzo e la tensione sono ancora più accentuati che nel David: l’opera è
stata realizzata sulla suggestione del Laocoonte, ritrovato pochi anni prima). Attraverso la tecnica
del troppo finito, che trascende e sublima la materia, Michelangelo affida all’opera il messaggio
etico: l’uomo, unicamente attraverso la sua volontà, agisce su se stesso per controllare, anche con
l’inconscio, le proprie emozioni irrazionali, trascendendo così la condizione umana e diventando
messaggero del divino.
Nella seconda metà del Quattrocento, Sisto IV, nel nuovo assetto delle stanze vaticane, fa costruire
la cappella sistina; le decorazioni, alle quali lavorano i più grandi artisti del secolo, si articolano in
tre registri: a. in quello inferiore si fingono tendaggî; b. storie di Mosè e Storie di Cristo; c. attorno
alle finestre una carrellata di papi. Michelangelo accetta contro voglia l’incarico di decorare a fresco
la volta della Sistina, che Giulio II gli affida nel 1508: sarà lui stesso, tuttavia, a sostituire a quello
che gli era stato dato il programma ben più complesso, tematicamente e figurativamente,
dell’attuale decorazione. Per la prima volta la concezione dottrinale è dell’artista; per la prima volta
l’architettura dipinta non è soltanto cornice, ma parte integrante dell’opera, con un proprio
significato; per la prima volta tutti gli elementi figurativi si fondono in una sintesi voluta di
architettura, pittura e scultura. La diversa grandezza delle figure nei riquadri al sommo della volta
dimostra che l’artista non cerca un’unità prospettica e un effetto illusivo: probabilmente, da
principio, non aveva neppure un progetto completo e l’opera è cresciuta col precisarsi del concetto
nel corso del lavoro. Ogni figura ha la propria prospettiva, luce, espressività: il loro sforzo è
sottolineato dalle loro anatomie esasperate e drammaticamente monumentali. L’architettura non è
soltanto riquadratura della superficie: incatena la volta con una successione di archi e, con i
pronunciati sporti delle membrature, stabilisce diversi livelli di profondità per l’inserzione delle
figure. Si ha il senso di una spinta verso l’alto perché la fascia con i profeti e le sibille pare il
prolungamento delle pareti laterali; ma, al di sopra, lo spazio non sfonda, anzi, si contrae nella
stretta degli archi trasversali. Michelangelo si propone di dare una struttura architettonica al vano
della cappella; ma, invece di svilupparla dal basso con un sistema di piedritti, la impone dall’alto,
facendo così della volta, del cielo, la determinazione dello spazio architettonico. E il cielo non è,
qui, lo spazio infinito oltre l’orizzonte terreno, ma è una costruzione dottrinale, il luogo ideale della
genesi delle idee e del principio della storia. È sostenuto dai profeti e dalle sibille, che
rappresentano i momenti dell’intuizione del divino. Le figure incombono dal cielo, fanno sentire il
loro peso morale sui destinatarî della cappella. Gli ignudi sui printi non vedono il cielo, a cui
volgono le spalle, ma nell’agitazione che li anima, ne intuiscono la presenza: sono “genî”, e
probabilmente (come i nudi del Tondo Doni), rappresentano il mondo pagano. Nel dipingere, al
sommo, le storie della Genesi, Michelangelo inverte l’ordine cronologico: comincia con l’ebbrezza
di Noè per giungere all’immagine solitaria dell’essere supremo, ma segue un ordine ideale perché il
divino “appare prima abbozzato nella forma imperfetta dell’uomo imprigionato nel corpo (Noè) per
poi progressivamente assumere una forma sempre più perfetta fino a divenire un essere cosmico”
(Tornay). “Al senso biblico della sua opera – nota sempre Tornay – volle sovrapporre un nuovo
significato, un’interpretazione platonica della Genesi. Neoplatonico è infatti il pensiero dell’ascesa
dell’anima all’intuizione del divino dai due fondamentali dottrinali del pensiero ebraico e del
pensiero cristiano. L’antitesi con gli affreschi che negli stessi anni e per lo stesso pontefice
dipingeva Raffaello è evidente. Per Raffaello umanità e natura riflettono ugualmente la forma
mentis del Dio creatore; per Michelangelo la natura non esiste, o è avversa come nel Diluvio,
insidiosa come nel Peccato: il colore è cangiante, vivo, ma mai naturalistico. L’uomo è sempre solo
con se stesso e con la propria volontà, che lo permette di riscattarsi dalla condizione di inerzia, entro
cui si annida il peccato, e di congiungersi alla grandezza divina, permettendogli di trascendere la
propria finitezza e imperfezione (e dunque, neoplatonicamente, la propria fisicità).
Potrebbero piacerti anche
- Storia Dell'arteDocumento20 pagineStoria Dell'arteAurora RoccuzzoNessuna valutazione finora
- Legni LiuteriaDocumento8 pagineLegni LiuteriashakfeNessuna valutazione finora
- Storia Dell'Arte Contemporanea - Manuale Con ImgsDocumento57 pagineStoria Dell'Arte Contemporanea - Manuale Con Imgsbarba000Nessuna valutazione finora
- Storia Dell'ArteDocumento5 pagineStoria Dell'ArteBabiMENessuna valutazione finora
- Spazi Metafisici Di Giorgio de ChiricoDocumento8 pagineSpazi Metafisici Di Giorgio de ChiricoElisa TrivelliniNessuna valutazione finora
- BOTTICELLI (Collana CorSera - Philippe Daverio) - EstrattoDocumento6 pagineBOTTICELLI (Collana CorSera - Philippe Daverio) - EstrattoBiagio D'AngeloNessuna valutazione finora
- GiottoDocumento24 pagineGiottoYounessNessuna valutazione finora
- Beni Culturali Cagliari - Mappa Cavità SotterraneeDocumento1 paginaBeni Culturali Cagliari - Mappa Cavità Sotterranee11224433Nessuna valutazione finora
- 01 MichelangeloDocumento4 pagine01 MichelangeloRaffaele ZenobjNessuna valutazione finora
- La Poetica Di Sandro Botticelli Fra Pittura e NeoplatonismoDocumento5 pagineLa Poetica Di Sandro Botticelli Fra Pittura e NeoplatonismoJaime Vigliano GirandoNessuna valutazione finora
- L'Umanesimo Nell'italia Meridionale, Antonello Da MessinaDocumento3 pagineL'Umanesimo Nell'italia Meridionale, Antonello Da MessinaJaime Vigliano GirandoNessuna valutazione finora
- Donatello, Il Linguaggio Scultoreo Dell'Umanesimo Fiorentino e La Sua Messa in CrisiDocumento6 pagineDonatello, Il Linguaggio Scultoreo Dell'Umanesimo Fiorentino e La Sua Messa in CrisiJaime Vigliano GirandoNessuna valutazione finora
- Michelangelo Giulia LuciaDocumento14 pagineMichelangelo Giulia LuciavooNessuna valutazione finora
- Caravaggio DeposizioneDocumento2 pagineCaravaggio DeposizioneauroraNessuna valutazione finora
- Lezione 1 RinascimentoDocumento6 pagineLezione 1 RinascimentoLuca HuettenmoserNessuna valutazione finora
- PontormoDocumento5 paginePontormoMarta FornasieroNessuna valutazione finora
- Ricerca Di ArteDocumento23 pagineRicerca Di ArteAlessandro MartiniNessuna valutazione finora
- Terza Maniera, Leonardo-Michelangelo-Raffaello.Documento5 pagineTerza Maniera, Leonardo-Michelangelo-Raffaello.AuroNessuna valutazione finora
- Della guerra e della natura delle cose nelle opere di Leonardo e PicassoDa EverandDella guerra e della natura delle cose nelle opere di Leonardo e PicassoNessuna valutazione finora
- Storia Della Critica D'Arte: Rinascimento Manierismo BaroccoDocumento84 pagineStoria Della Critica D'Arte: Rinascimento Manierismo BaroccoGiulio GalloNessuna valutazione finora
- Ricerca Di ArteDocumento23 pagineRicerca Di ArteAlessandro MartiniNessuna valutazione finora
- Michelangelo Buonarroti: Cricco Di Teodoro, Itinerario Nell'arte Quarta Edizione, © Zanichelli Editore 2017Documento31 pagineMichelangelo Buonarroti: Cricco Di Teodoro, Itinerario Nell'arte Quarta Edizione, © Zanichelli Editore 2017Nicola ValentiniNessuna valutazione finora
- MICHELANGELODocumento45 pagineMICHELANGELOWicked_KnightNessuna valutazione finora
- David e Pietà MichelangeloDocumento5 pagineDavid e Pietà MichelangeloAlessandro MonterisoNessuna valutazione finora
- Michelangelo, Leonardo e RaffaelloDocumento6 pagineMichelangelo, Leonardo e Raffaelloelisa853Nessuna valutazione finora
- Biografia Di CaravaggioDocumento8 pagineBiografia Di CaravaggiofukinagashiNessuna valutazione finora
- Leonardo Da VinciDocumento17 pagineLeonardo Da VinciAntonio FiltroNessuna valutazione finora
- Il CinquecentoDocumento8 pagineIl CinquecentoSandro AncisaNessuna valutazione finora
- Testo Lez. 9Documento10 pagineTesto Lez. 9CarlottaNessuna valutazione finora
- (SCARICA) Michelangelo. La Pietà Vaticana (Saggi Bompiani) PDFDocumento1 pagina(SCARICA) Michelangelo. La Pietà Vaticana (Saggi Bompiani) PDFramziNessuna valutazione finora
- La Menade Sotto La CroceDocumento9 pagineLa Menade Sotto La CroceMaria Laura RomeroNessuna valutazione finora
- Masaccio e La Pittura Dell'Umanesimo FiorentinoDocumento5 pagineMasaccio e La Pittura Dell'Umanesimo FiorentinoJaime Vigliano GirandoNessuna valutazione finora
- Dal Neoclassicismo Fino Ai Giorni NostriDocumento59 pagineDal Neoclassicismo Fino Ai Giorni NostriGiovanni ArenaNessuna valutazione finora
- Storia Dell'Arte: Raffaello Sazio, Michelangelo Buonarroti e Giorgione de CastelfrancoDocumento4 pagineStoria Dell'Arte: Raffaello Sazio, Michelangelo Buonarroti e Giorgione de CastelfrancoGabriele Di CoriNessuna valutazione finora
- Arte WordDocumento5 pagineArte Wordgiorgiocapone2Nessuna valutazione finora
- Deposizione (Caravaggio) - WikipediaDocumento3 pagineDeposizione (Caravaggio) - WikipediafabromNessuna valutazione finora
- MICHELANGELODocumento11 pagineMICHELANGELOMarco NistorNessuna valutazione finora
- Il Non Finito Michelangiolesco - Ilaria PasqualiDocumento1 paginaIl Non Finito Michelangiolesco - Ilaria PasqualiEli HollowayNessuna valutazione finora
- Lezione 3 - Storia Dell'arte ModernaDocumento3 pagineLezione 3 - Storia Dell'arte ModernaAurora StefanelloNessuna valutazione finora
- CATALOGO Dramatis 2016 PDFDocumento258 pagineCATALOGO Dramatis 2016 PDFContro PNessuna valutazione finora
- STORIA DELL'arteDocumento3 pagineSTORIA DELL'arteRex TrattorinoNessuna valutazione finora
- Leonardo e L'anatomia Del CavalloDocumento30 pagineLeonardo e L'anatomia Del Cavalloak_ella50% (2)
- ArteDocumento4 pagineArtedavideNessuna valutazione finora
- Approfondimento ArteDocumento8 pagineApprofondimento ArteMaggie GarelliNessuna valutazione finora
- 12 Michelangelo PDFDocumento39 pagine12 Michelangelo PDFjulua11Nessuna valutazione finora
- Arte 4Documento5 pagineArte 4Andy BenattiNessuna valutazione finora
- Chateaubriand Le Rovine Come Paesaggio AffettivoDocumento15 pagineChateaubriand Le Rovine Come Paesaggio AffettivoGiada DaolioNessuna valutazione finora
- MichelangeloDocumento3 pagineMichelangeloSemira SchiavoneNessuna valutazione finora
- Storia Dell'arteDocumento35 pagineStoria Dell'arteventuramarta.2004Nessuna valutazione finora
- Scipione Pulzone e Il Suo Tempo, Dispense Di Storia Dell'Arte ModernaDocumento15 pagineScipione Pulzone e Il Suo Tempo, Dispense Di Storia Dell'Arte ModernaDavide AgnocchettiNessuna valutazione finora
- La Vita Di LeonardoDocumento22 pagineLa Vita Di LeonardoconstanzaNessuna valutazione finora
- Raffaello e GiorgioneDocumento5 pagineRaffaello e GiorgioneLudovicoNessuna valutazione finora
- Dal Futurismo Al SurrealismoDocumento3 pagineDal Futurismo Al Surrealismoehy chiccaNessuna valutazione finora
- La Maria Maddalena Di DonatelloDocumento2 pagineLa Maria Maddalena Di DonatelloGiovanni PaccosiNessuna valutazione finora
- Michelangelo Pittore C. AcidiniDocumento39 pagineMichelangelo Pittore C. Acidiniilenia fedeleNessuna valutazione finora
- La Poetica Di Paolo Uccello, Il Fiabesco e L'eclettismo Fra Umanesimo e Gotico-InternazionaleDocumento2 pagineLa Poetica Di Paolo Uccello, Il Fiabesco e L'eclettismo Fra Umanesimo e Gotico-InternazionaleJaime Vigliano GirandoNessuna valutazione finora
- Storia Dell'arte, MichelangeloDocumento4 pagineStoria Dell'arte, Michelangelodt7hbvkby9Nessuna valutazione finora
- ARGANDocumento6 pagineARGANMarta CristoforiNessuna valutazione finora
- La Scienza, L'uomo, La Vita. Temi e Problemi Di BioeticaDocumento9 pagineLa Scienza, L'uomo, La Vita. Temi e Problemi Di BioeticaJaime Vigliano GirandoNessuna valutazione finora
- Genesi e Caratteristiche Del Linguaggio Neoclassico EuropeoDocumento3 pagineGenesi e Caratteristiche Del Linguaggio Neoclassico EuropeoJaime Vigliano GirandoNessuna valutazione finora
- Genesi e Caratteristiche Del Linguaggio Neoclassico EuropeoDocumento3 pagineGenesi e Caratteristiche Del Linguaggio Neoclassico EuropeoJaime Vigliano GirandoNessuna valutazione finora
- La Poetica Di Paolo Uccello, Il Fiabesco e L'eclettismo Fra Umanesimo e Gotico-InternazionaleDocumento2 pagineLa Poetica Di Paolo Uccello, Il Fiabesco e L'eclettismo Fra Umanesimo e Gotico-InternazionaleJaime Vigliano GirandoNessuna valutazione finora
- Masaccio e La Pittura Dell'Umanesimo FiorentinoDocumento5 pagineMasaccio e La Pittura Dell'Umanesimo FiorentinoJaime Vigliano GirandoNessuna valutazione finora
- L'Introduzione Del Linguaggio Bizantino in Italia Nel Passaggio Dalla Fase Teodoriciana A Quella GiustinianeaDocumento3 pagineL'Introduzione Del Linguaggio Bizantino in Italia Nel Passaggio Dalla Fase Teodoriciana A Quella GiustinianeaJaime Vigliano GirandoNessuna valutazione finora
- La Rivoluzione Figurale Di GiottoDocumento4 pagineLa Rivoluzione Figurale Di GiottoJaime Vigliano GirandoNessuna valutazione finora
- Filippo Brunelleschi e L'umanesimo FiorentinoDocumento7 pagineFilippo Brunelleschi e L'umanesimo FiorentinoJaime Vigliano GirandoNessuna valutazione finora
- Teoria e Storia Di Leon Battista AlbertiDocumento3 pagineTeoria e Storia Di Leon Battista AlbertiJaime Vigliano GirandoNessuna valutazione finora
- La Visione Unitaria Del Mondo Dell'Arte Del QuattrocentoDocumento3 pagineLa Visione Unitaria Del Mondo Dell'Arte Del QuattrocentoJaime Vigliano GirandoNessuna valutazione finora
- 144501453956212c0b2348b PDFDocumento3 pagine144501453956212c0b2348b PDFjoycerkdxfhsjsjNessuna valutazione finora
- Alfa 147 - Manopole Comandi Climatizzatore A LEDDocumento5 pagineAlfa 147 - Manopole Comandi Climatizzatore A LEDarnold7894Nessuna valutazione finora
- Esercitazioni Lenti Oftalmiche - Materiali e Lavorazioni Lenti PDFDocumento22 pagineEsercitazioni Lenti Oftalmiche - Materiali e Lavorazioni Lenti PDFbassidavide91Nessuna valutazione finora
- S Mercadante Francesca Da Rimini Ed CritDocumento9 pagineS Mercadante Francesca Da Rimini Ed Critmarinka123234Nessuna valutazione finora
- Pellegrini e Forestieri L Itineranza NeDocumento49 paginePellegrini e Forestieri L Itineranza Needvin_guerraNessuna valutazione finora
- Ingredienti Del Testo - ORTOGRAFIADocumento46 pagineIngredienti Del Testo - ORTOGRAFIAGiovanni SbrizziNessuna valutazione finora
- IL MUSEO DEL MONDO 15 - Uomo Vitruviano Di Leonardo Da Vinci - La Repubblica 07.04.2013Documento1 paginaIL MUSEO DEL MONDO 15 - Uomo Vitruviano Di Leonardo Da Vinci - La Repubblica 07.04.2013glisfogliatiNessuna valutazione finora
- Pan Brioche Veloce A ManoDocumento12 paginePan Brioche Veloce A ManozgianpietroNessuna valutazione finora
- Esempio Di Calcolo - Tettoia in LegnoDocumento26 pagineEsempio Di Calcolo - Tettoia in LegnoAle85toNessuna valutazione finora
- Guida PowerpointDocumento14 pagineGuida PowerpointAndrew ScaglioneNessuna valutazione finora
- 1943 Bombe Sul VaticanoDocumento2 pagine1943 Bombe Sul VaticanoMiguel Martinez0% (1)
- Appunti Su Boccaccio LetteraturaDocumento11 pagineAppunti Su Boccaccio LetteraturabesciamellaNessuna valutazione finora
- Guia Italiano B1-B2Documento3 pagineGuia Italiano B1-B2Irmgard Varela MullerNessuna valutazione finora
- Valtorta Don GuidoDocumento26 pagineValtorta Don GuidoSandro Del-VittoNessuna valutazione finora
- Catalogo Mega 180 CompletoDocumento212 pagineCatalogo Mega 180 CompletoAugusto RasoriNessuna valutazione finora
- Pisa CosmatescaDocumento89 paginePisa CosmatescaNicola SeverinoNessuna valutazione finora