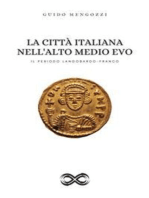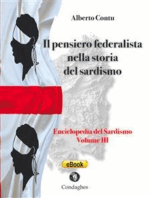Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Storia Del Diritto Italiano 1
Storia Del Diritto Italiano 1
Caricato da
nazzaroaleCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Storia Del Diritto Italiano 1
Storia Del Diritto Italiano 1
Caricato da
nazzaroaleCopyright:
Formati disponibili
lOMoARcPSD|9237083
Storia DEL Diritto Italiano 1
Storia Del Diritto Italiano I (Sapienza - Università di Roma)
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
PARTE PRIMA: L’ALTO MEDIOEVO
CAPITOLO 1 – GLI ORDINAMENTI GIURIDICI NEL PRIMO MEDIOEVO
1. IL DIRITTO DEI POPOLI GERMANICI
Tra gli ultimi anni del secolo IV e i primi del successivo le popolazioni germaniche, che da tempo
premevano ai confini dell’Impero romano d’Occidente, riuscirono a penetrare nelle regioni
imperiali e a stanziarsi stabilmente nelle stesse si ebbe allora l’incontro tra la civiltà romana e
quella germanica.
Nelle popolazioni germaniche non tutti i liberi erano soggetti di diritto: accanto ai liberi, titolari
della piena capacità giuridica, esistevano anche i semiliberi e i servi.
Si ritiene che le attività e gli interessi degli uomini liberi si concentrassero prevalentemente nella
famiglia, la quale costituiva la cellula organizzativa di base delle popolazioni germaniche.
La famiglia era diretta dal paterfamilias, essa comprendeva:
la moglie;
i figli maschi e le figlie femmine;
nonché i semiliberi e i servi che collaboravano alla produzione domestica partecipando ai
lavori a questa necessari.
L’autorità del padre non eliminava la capacità giuridica dei figli: questi ultimi erano soggetti di
diritto e partecipavano:
all’amministrazione dei beni comuni;
alle decisioni sulla loro alienazione;
alla distribuzione del prodotto da essi derivato e del bottino acquisito in guerra dalla famiglia.
L’autorità paterna, quindi, non avrebbe configurato una potestas, ma avrebbe espresso un
potere di guida e di protezione nei riguardi di tutti i componenti il nucleo familiare.
Al padre spettava la difesa del gruppo contro attacchi esterni, la rappresentanza dell’unità
familiare nei rapporti con le altre, la protezione dei beni da cui la famiglia traeva sostentamento.
La famiglia originaria dei popoli germanici viene indicata dagli studiosi come unità di pace,
come organizzazione, cioè, all’interno della quale erano risolti i contrasti tra i componenti e che,
pertanto, si presentava all’esterno come nucleo omogeneo e compatto.
La capacità giuridica dei figli di famiglia viene spiegata dagli studiosi sulla base del carattere
militare della società germanica: si dice che erano soggetti di diritto coloro che partecipavano
alla difesa armata della famiglia alla stessa stregua del padre, condividendone i pericoli e
l’impegno.
È il carattere militare che spiega l’esclusione delle donne dalla capacità giuridica o quanto meno
dalla capacità d’agire.
La loro protezione era affidata completamente al padre, il quale aveva nei loro confronti una
potestà più estesa di quella riconosciutagli per i figli maschi, una potestà che in alcuni popoli
1
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
come i Longobardi si esprimeva nel mundium, potere che comportava l’incapacità d’agire di chi
vi era sottoposto.
Alcuni studiosi hanno poi sostenuto che l’autorità del padre nei confronti della famiglia nel suo
complesso avrebbe incarnato il principio germanico originario di signoria, principio che in epoca
storica (cioè dopo l’occupazione delle regioni occidentali) avrebbe trovato espressione anche
nell’autorità del re e della potestà del signore fondiario.
L’autorità del padre nasceva infatti dalla protezione che egli assicurava ai membri della famiglia,
una protezione che era assoluta per chi non era in grado di tutelarsi da solo, mentre per gli altri
integrava la difesa individuale Quest’interpretazione ha dominato a lungo la storiografia
tedesca, ma oggi risulta abbandonata dagli storici, i quali hanno individuato come il sinallagma
protezione-potestà si presenti in termini diversi a seconda delle condizioni concrete della società
in cui operava e dia vita a forme giuridiche diverse.
Problemi interpretativi rimangono aperti ancora oggi nei riguardi del carattere della famiglia
originaria dei popoli germanici: per un lungo periodo la storiografia tedesca sostenne che il
nucleo essenziale della società germanica era la Sippe, cioè la famiglia agnatizia composta da
tutti i discendenti in linea paterna da un progenitore comune.
La Sippe, guidata da un capo unico o da un gruppo di anziani, avrebbe avuto un significato
uguale a quello di famiglia, nel senso che essa avrebbe garantito ai propri componenti
protezione dall’esterno e pace all’interno, attraverso la tutela dei diritti individuali.
Secondo tale interpretazione l’unità della Sippe sarebbe venuta meno prima dell’invasione delle
regioni occidentali e da essa sarebbero emerse le famiglie, ma i legami agnatizi avrebbero
continuato ad operare anche in epoca successiva: l’antica Sippe avrebbe costituito infatti
un’importante unità di insediamento, nel senso che alle famiglie legate da vincoli agnatizi
sarebbero state assegnate una quota unitaria di terra allo scopo di dar vita ad un insediamento
omogeneo e compatto, e al contempo avrebbe fornito la base sulla quale vennero formate le
unità dell’esercito germanico.
Tale interpretazione è stata rivista dalla prevalente storiografia, la quale pur riconoscendo
significativa efficacia ai vincoli agnatizi, ha sostenuto che essi non dovessero essere tali da
dar vita nella società germanica originaria ad una cellula unitaria.
Di recente è stata avanzata una terza interpretazione secondo la quale esisteva la
contemporanea presenza di vincoli agnatizi cogenti e di rapporti parentali meno rigidi: la
prevalenza della Sippe o della famiglia, sarebbe dipesa dalle concrete esigenze che i diversi
popoli germanici si trovavano ad affrontare.
I vincoli di sangue, comunque, non sono gli unici cui gli studiosi hanno attribuito capacità di dar
vita a momenti unitari rilevanti nella società primitiva germanica: infatti, gli storici tedeschi del
secolo scorso hanno sostenuto l’esistenza di un altro raggruppamento, quello indicato con il
termine latino comitatus corrispondente all’italiano “seguito”.
Sulla base delle testimonianze offerte da Tacito e da alcune fonti scandinave, gli studiosi hanno
ritenuto che i condottieri più valorosi avessero alle loro dipendenze altri liberi, i quali in tempo di
guerra combattevano al loro fianco e ai loro ordini, mentre in tempo di pace operavano al loro
2
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
servizio: del gruppo facevano parte anche i semiliberi e i servi che collaboravano alla difesa e al
funzionamento dell’unità comune.
Il rapporto tra il capo ed i componenti del suo seguito venne proposto dagli storici in termini
sostanzialmente uguali a quelli indicati per il padre e i familiari: il capo avrebbe assicurato ai
liberi del seguito la protezione dall’esterno e la pace all’interno e, in cambio, avrebbe goduto
dell’autorità di guida e di comando, un’autorità che gli sarebbe stata riconosciuta esplicitamente
dall’impegno di fedeltà e dedizione assunto dai suoi seguaci.
Quest’interpretazione, condivisa da una parte importante della storiografia tedesca, portò ad
interessanti approfondimenti: così si sostenne che già nella prima società germanica vigeva una
significativa differenziazione all’interno della comunità dei liberi tra coloro che vantavano un
seguito e gli altri che ne erano privi si sarebbe trattata di una distinzione non solo sul piano
sociale, ma anche su quello giuridico, dato che i primi avrebbero goduto di una sfera di diritti più
ampia di quella riconosciuta agli altri. (TALE TESI NON HA TROVATO UNANIMITA’ DI CONSENSI)
Altri studiosi hanno giudicato il vincolo tra capo e seguaci come manifestazione originaria
di un sentimento di fedeltà connaturato nei popoli germanici, sentimento che poi avrebbe
trovato adeguata espressione nel rapporto feudale.
Allo stesso tempo hanno ritenuto che il seguito fosse presente a tutti i livelli della società
germanica ed hanno immaginato un’articolazione verticale di quest’ultima: i liberi meno
importanti avevano un piccolo seguito, a loro volta facevano parte del seguito dei combattenti
più valorosi, costoro rientravano nel seguito del re; così il re poteva considerare l’intero popolo
come il suo “grande seguito”.
Quest’interpretazione è stata oggi ridimensionata perché gli studiosi ritengono in prevalenza che
il seguito germanico non costituisse un’unità in sé chiusa e compatta, tale da assorbire momenti
associativi diversi: essi ammettono solo che vincoli di fedeltà si aggiungevano a quelli di sangue,
arricchendo la gamma di rapporti giuridici interessanti agli uomini liberi della prima società
germanica tali vincoli di fedeltà avrebbero operato in maniera efficace soprattutto sotto il
profilo militare; nei momenti di pace, comunque, l’autorità morale del capo avrebbe contribuito
a mantenere l’armonia all’interno del gruppo che formava il seguito.
QUINDI, OGGI, L’INTERPRETAZIONE PREVALENTE giudica la famiglia come cellula primaria della
società germanica primitiva, ammette che in alcune popolazioni prevaleva la famiglia agnatizia,
accetta che vincoli di sangue e obblighi di fedeltà si aggiungessero ai doveri derivanti
dall’appartenenza ad un nucleo familiare.
Le comunità germaniche risultano composte da un insieme di famiglie: i rapporti tra queste sono
disciplinati da regole dirette al duplice obiettivo di tutelare interessi di ciascuna di loro e di
conservare l’armonia, la pace e l’equilibrio tra di esse tali regole costituivano il diritto di ogni
popolo germanico ed erano rispettate in quanto parte integrante ed essenziale della tradizione
del popolo stesso, quella tradizione su cui si fondava la coesistenza delle famiglie della stessa
etnia.
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
La fonte primaria del diritto dei popoli germanici era la tradizione, l’uso consolidato nel tempo.
La consuetudine stabiliva quale comportamento dei liberi fosse meritevole di tutela, cioè utile
difendere per conseguire l’armonia tra le famiglie che componevano la società.
Allo stesso tempo la consuetudine era in grado di registrare l’evoluzione della comunità e i
nuovi bisogni da questa avvertiti: quando la vita imponeva nuovi comportamenti ai componenti
della società e detti comportamenti si ripetevano nell’uso prolungato e generalizzato, nuovi
diritti entravano a far parte della tradizione del popolo.
Poteva comunque accadere che in alcune circostanze fosse necessario precisare il significato di
usi o decidere di integrare il patrimonio di consuetudini con regole nuove rese indispensabili da
necessità da poco insorte in tali occasioni i soggetti di diritto si riunivano in assemblea e
concordavano tra loro la soluzione da adottare: quella veniva espressa in una norma che si
aggiungeva dalle altre nate dalla consuetudine.
La delibera della assemblea popolare esprimeva perciò la volontà dei liberi e il loro impegno ad
osservare la nuova norma.
Per tale motivo essa era designata con il termine “pactum”: si trattava dell’impegno
reciprocamente assunto dai comportamenti della comunità a comportarsi da allora in poi
secondo quanto concordato.
Il sistema giudiziario in uso presso i germani è un sistema basato sulla giustizia privata e in
primo luogo sull’istituto della faida.
Tale istituto prevedeva che in caso di omicidio, lesione personale e violazione dei beni di un
libero, la famiglia della persona uccisa o lesa aveva il diritto di recare un danno di pari entità ad
uno qualsiasi dei componenti della famiglia del colpevole.
A lungo gli storici del diritto hanno negato che alla faida potesse essere riconosciuta natura
giuridica, perché erano convinti che il diritto doveva comportare soltanto ordine e pace ed
escludere ogni forma di ricorso alla forza bruta.
Contro quest’interpretazione, Otto Brunner riconobbe la natura giuridica alla faida e nel corso di
una lunga polemica con il Mitteis precisò che la stessa costituiva il mezzo offerto dal diritto
germanico per conseguire in modo rapido ed efficace il ripristino dell’equilibrio tra famiglie che
costituiva il fondamento dell’armonia e della pace interna dei popoli.
Quindi, essa realizzava la forma di giustizia privata protetta e garantita dall’ordinamento
germanico, che non si limitava ad accettarla, ma la disciplinava come legittimo strumento di difesa
dei diritti dei liberi.
L’ordinamento vi poneva, però, dei limiti: infatti, la vendetta non poteva recare all’offensore danni
più gravi di quelli da lui provocati, dato che altrimenti gli equilibri tra famiglie sarebbero risultati
altrettanto alterati.
Al momento delle invasioni delle province romane d’Occidente il meccanismo della faida aveva
conosciuto una sensibile evoluzione, dato che per alcune lesioni si era affermata la
consuetudine di sostituire la vendetta privata con il versamento di una somma di denaro
4
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
(guidrigildo), il cui ammontare variava in relazione non solo all’entità e gravità del danno, ma
anche al rilievo sociale dell’offeso e della sua famiglia tale soluzione viene indicata nelle fonti
romane con il termine di compositio.
Essa consentiva una soluzione meno violenta della vertenza e contribuiva alla conservazione della
pace interna alla comunità; allo stesso tempo non modificava la natura della giustizia germanica,
dato che garantiva la difesa dei nuclei familiari mediante una soluzione privata che ripristinava
l’equilibrio sociale infranto dall’atto violento.
E’ evidente che il meccanismo della faida e delle compositiones rendeva superflua l’esistenza di
un vero e proprio apparato di giustizia.
Quando, comunque, l’intreccio delle relazioni sociali tra nuclei familiari si fece più complesso, più
numerosi divennero i casi in cui la responsabilità del danno veniva messa in discussione e si dava
luogo ad una contestazione: in questa circostanza, il danneggiato si rivolgeva agli altri uomini
liberi del suo popolo chiedendo un loro intervento nella questione.
In una fase primitiva si riuniva l’intera assemblea popolare.
Quando la società divenne più complessa ed articolata delle liti si occupavano anche autorità
popolari.
Obiettivo dell’assemblea che si riuniva o delle autorità popolari era quello di mettere fine
rapidamente alla situazione di lite che alterava gli equilibri sociali e indeboliva la compattezza
della comunità.
Il suo compito era quello di eliminare l’incertezza sull’identità del responsabile dell’offesa; il
giudizio germanico era affidato al giudizio di Dio, sottoponendo l’accusato ad una prova (ordalia) o
imponendo alle due parti in causa di lottare tra di loro (duello giudiziario).
Era infatti convinzione generale che la divinità protettrice del popolo avrebbe indicato il
responsabile facendolo soccombere alla prova o sconfiggere nel duello (diritto non giusto perché
magari l’innocente non era in grado di combattere perché inabile).
L’intervento del giudice germanico, quindi, era di natura esclusivamente dichiarativa, non già
costitutiva: la corte esauriva la sua funzione nel dichiarare il risultato della prova e non assumeva
alcuna responsabilità nel merito della vertenza.
Il meccanismo della giustizia privata aveva quindi l’obiettivo di conservare la pace interna,
eliminando l’apertura di incontrollabili ostilità tra gruppi familiari.
Un ruolo del tutto analogo svolgeva anche il formalismo che informava la disciplina dei rapporti
intersoggettivi: l’assunzione di un obbligo personale, l’acquisizione di una terra nascevano, infatti,
dallo svolgimento di un’azione rituale capace di rendere edotta l’intera comunità della nascita del
nuovo diritto e del correlativo obbligo degli altri liberi a rispettarlo.
Presso i Longobardi il principale contratto obbligatorio era la wadiatio, in virtù della quale il
debitore si impegnava ad una prestazione in favore della controparte mediante un atto solenne,
consistente nella consegna a questa di un’arma, la wadia, che successivamente venne
simboleggiata da un ramo o da un bastone: tale consegna rendeva evidente a tutti i presenti che il
5
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
debitore, cedendo il suo naturale mezzo di difesa, si metteva nelle mani del creditore.
L’acquisto di una terra si realizzava con la cerimonia formale della vestitura, in virtù della quale il
nuovo possessore entrava materialmente in contatto con il bene, cerimonia che in seguito venne
sostituita con la consegna di un simbolo concreto, quale una zolla di terra, un ramo o un arbusto.
Chiunque avesse violato un diritto sorto con questi crismi di formalità e ufficialità avrebbe
procurato un danno del tutto uguale a quello della lesione corporale, poiché avrebbe leso la
disponibilità materiale della famiglia colpita, alterando a suo danno gli equilibri con le altre. Per
questo motivo non si poneva nel mondo germanico la distinzione odierna tra vertenze penali e
quelle civili: tutte derivavano da una violazione della realtà familiare e, di conseguenza, dalla
parità di condizioni di cui i singoli nuclei familiari godevano all’interno della collettività; per lo
stesso motivo il danno subito legittimava la risposta della vendetta privata o della richiesta di
compositio.
Inoltre, la società germanica al momento delle invasioni delle regioni occidentali aveva da tempo
perduto il carattere nomade e conosceva forme diffuse di insediamento territoriale stabile nelle
quali la produzione agricola svolgeva un ruolo significativo.
Si erano, quindi, formate consuetudini che tutelavano la certezza del possesso fondiario e ne
garantivano la titolarità a chi lo deteneva tali consuetudini erano imperniate nella difesa di un
diritto semplice e immediato che le fonti di molti popoli indicano con il termine “Gewere”, che
consisteva nel potere di utilizzare a proprio piacimento e in piena libertà, secondo i bisogni della
famiglia, il bene mobile o immobile, di difenderlo da ogni tentativo di lesione o spoglio, di
tutelarlo mediante i meccanismi della giustizia privata.
La Gewere esprimeva in termini immediati e concreti il rapporto tra l’uomo e il bene, la potestà
del primo di usare del secondo e di goderne i frutti.
Questo rapporto e questa potestà erano i dati riscontrabili da parte dei componenti la comunità,
cioè i dati che denunciavano l’esistenza di un diritto, che doveva essere rispettato da tutti.
L’animus del titolare, non manifestandosi in dati formalmente rilevanti, non veniva preso in
considerazione.
Obiettivo comune della comunità germanica era la difesa comune: tutti gli uomini liberi idonei
alle armi erano tenuti a prendere parte alle lotte della collettività ed erano a tal fine inquadrati
nell’organizzazione militare. In altre parole popolo ed esercito coincidevano.
L’esercito si articolava in varie unità, ciascuna delle quali comprendeva un determinato numero di
uomini, ed era guidata da un capo militare il cui titolo derivava dell’entità del contingente ai suoi
ordini.
Questi capi guidavano in battaglia il loro gruppo e dovevano quindi garantirsi che all’interno di
questo regnasse la massima omogeneità e compattezza.
L’autorità militare del capo, quindi, era congiunta a quella del giudice: il suo intervento era più
semplice e rapido di quello dell’assemblea popolare, tanto da divenire il più frequente.
Capi militari alla guida dei contingenti maggiori erano, i conti, i duchi ed altri ufficiali indicati con
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
vari titoli.
Alla guida unitaria dell’esercito popolare si trovava il capo più autorevole, il rex che aveva anche
compiti da giudice.
Poiché il re era la guida unitaria dell’intero esercito, tutti potevano scegliere di ricorrere
direttamente alla sua corte senza passare per le autorità militari minori.
La corte del re era la principale tra le corti germaniche.
2. DIRITTO UFFICIALE E DIRITTO VOLGARE NEL TARDO IMPERO
Cardine del sistema imperiale era l’imperatore, la cui autorità dalla fine del 3 sec. aveva
conosciuto una sensibile evoluzione.
L’imperatore all’origine era il princeps, cioè primo tra i cittadini e titolare delle più elevate
magistrature individuali della repubblica romana era il maggiore magistrato del popolo
romano e da ciò derivava la sua autorità.
Con Diocleziano l’imperatore divenne il dominus et deus dei cittadini romani, il dio vivente a
cui tutti dovevano obbedienza e venerazione la sua non era più una potestà derivata dal
popolo, ma un’autorità da questo distinta, a lui superiore ed in sé originaria.
A partire dal governo di Costantino la diffusione crescente del Cristianesimo rese impossibile
l’attribuzione della natura divina all’imperatore questo venne considerato come
rappresentante di Dio in terra: una concezione che comunque ribadiva la sostanza del
dominato quale potestà superiore al popolo intrinsecamente connessa con la divinità.
Per conseguire un’efficiente gestione della autorità imperiale, Diocleziano aveva provveduto a
dividerla tra due titolari, i due Augusti, ognuno dei quali si avvale di un vicario, il Cesare, cui
affidava il governo di alcune province e che era il suo legittimo successore.
Il sistema tetrarchico si conservò fino agli inizi del 5 sec., quando, alla morte di Teodosio, il
dualismo imperiale conobbe una più netta distinzione territoriale con la separazione della parte
occidentale da quella orientale quando veniva a mancare il titolare di una delle due parti si
ricostituiva in capo all’altro imperatore l’unicità del potere.
La storiografia ritiene, quindi, che nella visione teorica del dominato il potere imperiale era privo
di limiti ed esente da ogni controllo da parte dei cittadini, nonché fonte a sua volta di diritto e di
potestà.
Nel secolo V la legislazione romana era costituita esclusivamente dalle disposizioni imperiali,
nelle diverse forme di rescritto (valido per i casi concreti), editto (valido per tutti i popoli),
mandato (ordini a funzionari o giudici) e decreto (interventi dell’imperatore in qualità di giudice);
ad esse era attribuito il nome generale di constitutio o di lex ed il significato di espressione della
superiore autorità dell’imperatore, la cui volontà era vincolante per tutti i cittadini.
Accanto alle leges rimanevano, come fonte di diritto, gli iura, cioè il complesso della dottrina
7
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
dei giuristi che avevano esercitato durante il principato lo ius respondendi, il diritto di
formulare per i giudici pareri in merito alle controversie da loro esaminate.
Nella prima metà del secolo l’imperatore Teodosio dispose la raccolta delle costituzioni imperiali
ancora in vigore e la loro organica sistemazione.
L’opera di Teodosio, nota come Codex Theodosianus, raccolse le leggi imperiali a partire da
Costantino che erano ancora da considerare vigenti, eliminando il superfluo (prologhi,
epiloghi…): i compilatori furono autorizzati ad introdurre in esse le modifiche necessarie.
Il codice Teodosiano era diviso in 16 libri, ciascuno dei quali era suddiviso in titoli, venne
approvato nel 438 ed entrò in vigore all’inizio dell’anno successivo.
Per quanto riguarda gli iura, gli imperatori cercarono di intervenire anche in questo settore per
ordinare la molteplicità delle opinioni e garantire la certezza del diritto che poteva essere turbata
dalla contraddittorietà delle interpretazioni.
Nel 426 l’Imperatore d’Occidente Valentiniano III emanò una costituzione, recepita subito
dopo in oriente da Teodosio II, con la quale:
s’imponeva ai giudici l’obbligo di attenersi alle opinioni di 5 giuristi tra i molti che avevano
arricchito la giurisprudenza romana (Papiniano, Ulpiano, Gaio, Paolo, Modestino);
di seguire la tesi di Papiniano in caso di contrasto tra i 5;
di seguire la maggioranza in caso di diverse opinioni;
di scartare ogni altra dottrina salvo nel caso di esplicita citazione da parte di uno dei cinque e
nell’altro di contrasto tra questi non risolvibile con il ricorso a Papiniano per il silenzio di
costui.
La disposizione, nota come legge delle citazioni, non si limitava a mettere ordine alla complessa
materia, ma contribuiva a ribadire la superiorità normativa dell’imperatore, dato che faceva
dipendere dalla sua decisione la validità della fonte giurisprudenziale.
La medesima concezione, che esaltava il ruolo primario dell’imperatore in ordine alla produzione
del diritto, si puo’ cogliere anche nel progetto originario del Codice Teodosiano, progetto che
prevedeva la compilazione di una raccolta di iura da affiancare a quella delle leges.
Il progetto teodosiano, comunque non venne realizzato e successivamente non fu ripreso: le
raccolte di iura diffuse nel mondo romano nel tardo impero sono, pertanto, tutte collezioni
private, che non hanno crisma di ufficialità.
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Fonte primaria di diritto, l’imperatore lo era altrettanto per quanto riguarda il potere: tutta la
numerosa e complessa burocrazia che amministrava l’impero sia al centro sia in provincia, tutte le
cariche da cui dipendeva la guida dell’esercito, tutte le magistrature che assicuravano la gestione
della giustizia erano nominate dell’imperatore, operavano in suo nome, esercitavano un potere di
cui solo l’imperatore era titolare.
Al centro l’imperatore si avvaleva del consiglio e dell’assistenza del consistorium principis,
composto dai principali ministri dell’amministrazione centrale e da altri consiglieri.
I suoi ministri posti al vertice di un settore burocratico formavano anche un organo collegiale a sé
detto comitatus.
Essi erano:
il magister officiorum titolare di una variegata gamma di funzioni che andavano dalla
politica estera all’amministrazione interna e alla direzione delle scholae palatinae, i corpi
militari destinati alla difesa e al servizio di corte;
il quaestor sacrii palatii massimo consigliere dell’imperatore per le materie giuridiche;
il comes sacrarum largitionum responsabile della gestione finanziaria dell’impero;
il comes rerum privatarum, che presiedeva l’amministrazione della res privata, cioè il saltus
et fundi da cui era composto il patrimonio della corona;
il prefetto del pretorio situato presso la corte;
il magister utriusque militiae che nel corso del secolo V unificò nelle sue mani la giuda
dell’esercito di fanti e di cavalieri;
e il praepositus sacri cubicoli responsabile dei servizi di corte e degli addetti alla persona
dell’imperatore.
L’impero era diviso in quattro ampie circoscrizioni, dette prefetture, due per la parte occidentale,
Gallia e Italia, due per la orientale, Illirico e Oriente.
La prefettura era governata da un prefetto del pretorio e divisa in diocesi, affidate ad un vicario; a
loro volta le diocesi si suddividevano in province, al cui vertice erano posti governatori
appartenenti a gradi diversi (proconsules, consulares, correctores, praesides).
Tutti questi funzionari avevano competenze civili, amministrative e giurisdizionali; in particolare si
occupavano della riscossione delle imposte e della gestione finanziaria.
Inoltre, le due città principali dell’Impero godevano di una situazione speciale, Roma e il suo
9
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
distretto (cioè il territorio compreso entro un raggio di 100 miglia) era governata dal praefectus
urbi, direttamente dipendente dell’imperatore quindi non rientrava nella competenza del
prefetto del pretorio d’Italia, né in quella del vicario d’Italia, né in quella del vicarius urbis Romae,
che governava le regioni centro-meridionali.
Dall’imperatore dipendeva poi anche una complessa gerarchia militare, distinta da quella
civile e guidata dai magisrti peditum et equitum, poi magistri utriusque militiae: essi avevano
autorità sui duces e sui comites militares preposti alle truppe stanziate nelle regioni di confine.
In Occidente, nel corso del secolo V, il magister utriusque militiae acquisì ampie competenze in
campo civile, tanto da imporre la propria volontà anche sull’imperatore e risultare decisivo al
momento della deposizione e della nomina degli stessi Augusti.
Di conseguenza ai duces e i comites attivi nelle province finirono per imporre la propria autorità
anche sui funzionari amministrativi.
La rete dei magistrati imperiali si estendeva anche al governo delle città, dove le antiche cariche
municipali, pur continuando a funzionare e ad esprimere l’istanza autonomistica della comunità
urbana, risultano inferiori rispetto a quelle del curator civitatis (nominato direttamente
dall’imperatore) e del defensor plebis (nominato dal prefetto del pretorio), entrambi con
competenze giurisdizionali, tributarie e amministrative.
Continuarono a funzionare i consigli municipali (curie), formati da cittadini titolari di un certo
patrimonio (decurioni), tale organismo sembra rispondere all’esigenza burocratica di inquadrare
la popolazione in ranghi serrati e precisi, al fine di imporre una completa distribuzione di oneri
sociali.
La partecipazione alla curia cittadina era imposta come obbligo ereditario ai principali possidenti
della città.
Compito principale delle curie era, accanto alla designazione dei candidati alla carica di curator e
di defensor, quello di stabilire l’ammontare dei tributi di ciascun cittadino e di nominare i
percettori degli stessi.
Tali agenti (susceptores) scelti tra gli stessi decurioni, erano responsabili della mancata
riscossione; nel caso in cui essi non avessero proceduto all’esenzione, l’onere andava a gravare
sulla curia nel suo complesso la particolare condizione dei decurioni spiega i continui tentativi
compiuti dai cittadini più abbienti per sottrarsi all’inserimento nella curia municipale.
La giustizia era distinta in giudizi in materia civile e quelli in materia criminali.
Per quanto riguarda i giudizi civili si affermò in questo periodo la procedura della cognitio extra
ordinem, nella quale:
da una parte veniva eliminata l’articolazione in 2 fasi (quella in iure e quella in apud
iudicem) del giudizio classico;
dall’altra il giudice privato del processo formulare era sostituito da un giudice nominato
dal funzionario che presiedeva il governo principale, cioè un giudice che esercitava la sua
funzione a nome e per conto dell’autorità superiore dell’imperatore.
10
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
La giurisdizione penale conobbe durante il dominato importanti innovazioni che sottolineavano il
ruolo della superiore autorità imperiale così fu esteso l’ambito della competenza dei giudici a
danno delle forme di autodifesa e di giustizia privata che si erano conservate anche durante i
primi secoli dell’età imperiale e venne ridotta la discrezionalità della pena in virtù di una
legislazione intesa a fissare in maniera definitiva la forma della fattispecie criminosa e allo stesso
tempo la pena da applicare per ogni tipo di reato.
Le leges e gli iura non esaurivano nel tardo Impero le fonti del diritto: accanto a loro rimaneva la
consuetudine, l’uso costantemente ripetuto imposto da coerente necessità della vita sociale e
produttiva e ritenuto legittimo dalla comunità.
A ben vedere era proprio la consuetudine la fonte primaria del diritto, nel senso che in una realtà
territoriale tanto vasta come quella dell’Impero romano le leggi imperiali potevano solo stabilire
alcune regole generali, non potevano pretendere di esaurire l’intera regolamentazione del diritto.
Quindi, la consuetudine era fonte primaria del diritto la sua evoluzione:
In alcuni casi veniva integrata e precisata dalle altre funti giuridiche;
In altri casi non trovava riscontri evidenti nella legislazione imperiale, né adeguata
elaborazione nella dottrina sotto questo profilo deve essere considerato il fenomeno del
cosiddetto diritto volgare, messo in evidenza da Brunner.
Brunner individuò per primo il fenomeno per cui il diritto romano nel tardo impero non era
più applicato secondo iura e leges, cioè non rispettato alla lettera, e che vi era quindi un
diritto volgare che affiancava quello “ufficiale” ovvero un diritto fondato sulle concrete
esigenze.
Matteis diceva invece che questo fenomeno era dovuto all’incontro tra la cultura romana e
la cultura dei paesi sottomessi a Roma.
Oggi il diritto volgare viene considerato come il diritto affermatosi nella pratica delle regioni
occidentali in un periodo di trasformazione sociale e di involuzione economica, quello che fu
il Tardo Impero, diritto basato fondamentalmente sulla prassi.
Leges e iura non potevano rimanere insensibili ai cambiamenti sociali e finivano per registrare,
almeno parzialmente, i più rilevanti.
Secondo alcuni autori, l’ordinamento romano non avrebbe mai conosciuto, nemmeno in epoca
repubblicana, quel principio dell’eguaglianza giuridica dei cittadini, cardine negli ordinamenti
contemporanei tesi fondata per il periodo del dominato quando i cittadini risultano articolati in
categorie, ciascuna delle quali prevedeva un complesso di diritti.
Venne allora confermata una distinzione già introdotta nell’età del principato, quella tra:
Honestiores i cittadini più importanti furono articolati in una rigida gerarchia con al
vertice l’ordo senatorius, formato dai membri del Senato e dai titolari delle più elevate
magistrature dell’Impero, a loro volta suddivisi in illustres, spectabiles e clarissimi.
I senatori godevano di consistenti privilegi sia in campo civile sia nel settore tributario: nel
11
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
corso del 5 sec., comunque, un ulteriore irrigidimento della struttura gerarchica della società
ebbe l’effetto di limitare tale situazione privilegiata ai soli illustres.
L’ordine senatorio era seguito da quello equestre, composto dai funzionari minori, dai
militari dei gradi medio-bassi, da coloro che esercitavano professioni liberali, dai mercanti
etc.
Ciascuna di queste categorie godeva di una particolare condizione giuridica, con privilegi ed
oneri specifici: poiché ogni gruppo svolgeva una funzione essenziale per la società romana e
poiché le condizioni economiche generali non riuscivano ad assicurare una soddisfacente
mobilità, nella legislazione imperiale e nella prassi si affermò la tendenza ad imporre
l’ereditarietà nelle singole cariche.
L’ordine equestre era meno privilegiato rispetto a quello senatorio;
Humiliores erano posti alla fine della piramide sociale, vi appartenevano i piccoli
negozianti, gli artigiani, gli operai e i contadini.
Anche in queste categorie si sviluppò la tendenza all’ereditarietà, soprattutto nei gruppi che
fornivano un servizio di consistente rilievo pubblico e che sin dal 3 sec. erano stati inquadrati
in associazioni professionali di tipo corporativo.
La preminenza sociale del ceto dei senatori, inoltre, non costituiva solo un fatto formale, ma
corrispondeva ad un’effettiva realtà economica: in un sistema produttivo, nel quale l’agricoltura
aveva rafforzato il ruolo principale sempre svolto, la proprietà fondiaria si era accentrata in
maniera crescente nelle mani dell’aristocrazia senatoria.
All’interno dei grandi latifondi da questa tenuti si affermò negli ultimi secoli dell’Impero, sia in
virtù di disposizioni imperiali, sia per effetto della consuetudine, un regime giuridico innovativo: a
partire dal 3 sec. cominciarono ad inaridirsi le fonti che fino ad allora avevano alimentato il
continuo rifornimento della manodopera schiavista, sulla quale si era costantemente basata la
produzione agricola dell’antichità si impose allora la necessità di sopperire alla ridotta presenza
schiavista nelle campagne con il lavoro delle persone libero, alle quali però dovevano essere
imposte limitazioni giuridiche per assicurare alla produzione rurale la loro opera ed evitare
l’abbandono dei campi.
Le esigenze della produzione, quindi, richiedevano la formazione di legami di dipendenza di
uomini liberi da altri uomini liberi tali esigenze si espressero non solo nella necessità di usi
consuetudinari, ma anche in regole formalmente formulate da leggi e da iura che disciplinarono
nuovi istituti giuridici.
E’ il caso del colonato, istituto affermatosi a partire dal periodo di Diocleziano, in virtù del quale
affittuari e contadini dei grandi latifondi erano collegati con la terra, nel senso che non avevano la
libertà di lasciare i campi e di scegliere una diversa attività, e che in caso di alienazione della terra
essi passavano alle dipendenze del nuovo proprietario.
12
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
I rapporti tra il proprietario e i coloni era più complesso: i coloni erano tenuti al pagamento in
denaro o in natura di un canone di affitto (che pagavano in denaro o in natura), non potevano
alienare i loro beni senza l’autorizzazione del dominus e non potevano citarlo in giudizio (quindi
lui era il loro giudice “privato”).
Inoltre, a partire dal periodo di Costantino, fu attribuita ai proprietari la potestà di arrestare i
coloni fuggitivi e di tenere in catene quanti fossero sospettati di tentare la fuga.
Infine, nella seconda metà del secolo IV, venne attribuita ai proprietari una forma di autorità
tributaria sui coloni stessi, poiché fu loro affidata la riscossione dei tributi da quelli dovuti allo
Stato.
L’istituto del colonato, inoltre, non è la sola forma giuridica ufficiale in cui si manifestò la
superiorità economica e sociale del ceto dei grandi latifondisti appartenenti all’ordine senatorio
interessante è l’istituto del patronato, la cui nascita deve essere messa in relazione con il
progressivo aumento della pressione tributaria sulla terra: l’onere fiscale divenne insopportabile
per molti proprietari minori, i quali cercarono di porvi rimedio seguendo 2 vie principali:
1) alcuni cedettero le loro terre ai proprietari maggiori e si misero alle loro dipendenze
continuando a lavorare i campi come contadini liberi o come coloni di costoro;
2) altri invece si rivolsero ai latifondisti circostanti per ottenere la loro protezione contro gli
esattori imperiali, i quali commettevano frequenti abusi di potere nei confronti dei
possessori minori così nacque un altro istituto, il patronato.
In Oriente la funzione di patrono venne assunta sia dai grandi proprietari, sia dai titolari delle più
elevate cariche militare presenti nella regione.
In Occidente invece furono i latifondisti a svolgere in maniera prevalente tale ruolo.
Il patrono acquisiva il compito della difesa del suo protetto e della proprietà di questo una difesa
che veniva esercitata anche in sede giudiziaria.
Quindi, con il patronato la difesa dei diritti del libero, che doveva essere il compito dell’autorità
imperiale, passava in mano ai privati, i quali acquisivano una posizione di concreta e legittima
superiorità rispetto a coloro che proteggevano.
Per questo motivo, mentre il fenomeno risulta comune ad entrambe le parti dell’Impero, diversa
fu in ciascuna di queste la reazione imperiale al diffondersi dell’istituto:
in Oriente (dove l’autorità del governo continuava a svolgere un ruolo significativo)
numerose furono le costituzioni che cercarono di limitare l’affermazione dell’istituto;
in Occidente (dove la potestà imperiale era in decadenza) non risulta attestato alcun
provvedimento del genere.
Questo complesso di innovazioni trovava la sua ragione d’essere nelle immutate condizioni della
vita economica che, dalla fine del 3 sec., conosceva una fase di decadenza nella quale la
13
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
produzione agraria andava progressivamente accentuando il proprio significato e tendeva a
sopperire alle deficienze che si manifestavano nell’attività commerciale.
L’affermazione dei grandi latifondi si spiega sia per il cresciuto interesse dei ceti più abbienti per la
terra, sia per la capacità dei vasti patrimoni di far fronte alla maggior parte dei bisogni della
collettività.
D’altra parte, la stragrande maggioranza dei latifondi, soprattutto nelle regioni occidentali, era in
mano all’ordine senatorio, che, grazie ai privilegi di cui godeva, era gravato da un ridotto onere
fiscale.
Quindi, il potere economico era incentrato nelle famiglie dell’aristocrazia senatoria, le quali,
protette dai magistrati imperiali delle province, godevano di ampia autorità all’interno dei loro
patrimoni.
3. L’ORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA
Il diritto del tardo Impero riconosceva alla Chiesa cristiana ampie libertà di organizzazione e
attribuiva ad essa ed ai chierici diritti diversi da quelli degli altri soggetti di diritto.
L’editto di Milano degli imperatori Costantino e Licinio del 313 concesse ai cristiani liberà di culto
e alla Chiesa piena liceità da quel momento, la Chiesa precisò non solo la propria
organizzazione, ma anche il proprio carattere di ordinamento giuridico diretto a disciplinare la vita
dei fedeli.
Nel corso del 4 e 5 sec. essa maturò un’articolata interpretazione della società: secondo tale
interpretazione, la Chiesa era intesa come composta dalla comunità dei fedeli e costituiva,
pertanto, il corpo mistico di Cristo.
Caratteristica di tale istituzione era la duplice natura dei suoi componenti, i quali erano allo stesso
tempo sudditi dell’impero e fedeli in Cristo.
Secondo la Chiesa, il diritto deve essere distinto in due grandi categorie:
quello divino è composto sia dalla Rivelazione e dalla Tradizione sia dal diritto naturale,
l’ordine cioè del creato;
e quello umano comprende quello ecclesiastico, emanato dalle autorità della Chiesa a ciò
abilitate, e quello secolare prodotto dal sistema temporale.
Il diritto della Chiesa, quindi, non si limita all’organizzazione della gerarchia del clero, ma:
riguarda l’intera comunità dei fedeli;
chiarisce che il diritto divino (si manifesta nell’ordine naturale delle cose) è diritto
immediatamente vincolante e quindi direttamente vigente senza il bisogno di intermediazioni
o di traduzioni in norme positive;
14
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
afferma che tutte le componenti del sistema devono essere tra loro in armonia, in modo tale
che la norma temporale, anche se posta in essere da autorità secolari, non puo’ contrastare
con la norma divina o con quella stabilita dalle istituzioni della Chiesa;
puo’ far ricorso o puo’ rinviare a norme temporali.
Il diritto umano ecclesiastico ha una duplice fonte di derivazione: la consuetudine e la legislazione
conciliare.
I concili erano le assemblee dei vescovi, nel corso delle quali erano adottate decisioni in merito
all’interpretazione della Rivelazione, nonché delibere relative all’organizzazione della comunità
dei fedeli tali decisioni e tali delibere erano indicate con il termine di “canoni”.
I concili si distinguevano, a seconda dell’ampiezza giuridica a cui si riferiscono, in:
ecumenici ai quali partecipavano i vescovi dell’intera cristianità e nel corso dei quali
venivano adottate decisioni in materia di fede e di organizzazione valide per tutto il mondo
cristiano;
locali o provinciali formati dalle riunioni dei soli vescovi di una provincia, che prendevano
delibere valide soltanto per la comunità che vi era rappresentata.
La struttura gerarchica del clero ripeteva articolazioni del sistema amministrativo dell’Impero
romano.
Cardine dell’organizzazione gerarchica del clero era la diocesi, che ricalcava quella della civitas
romana, ed era affidata al vescovo egli era scelto dalla comunità dei fedeli e dal clero e poi
consacrato da un altro vescovo, in genere di diocesi limitrofa.
La sua era la suprema autorità spirituale nella circoscrizione, titolare, insieme con la guida
religiosa dei fedeli:
del potere di ordinare i sacerdoti, i diaconi e il clero inferiore;
della potestà di destituirli in caso di disobbedienza;
del compito di amministrare il patrimonio della diocesi e le offerte a questa presentate.
Al di sopra del vescovo vi era il metropolita, il quale, secondo quanto stabilito dal concilio di
Nicea, era il titolare dell’episcopato che aveva sede nella città capoluogo della provincia imperiale.
Egli interveniva alla nomina dei vescovi attraverso l’assenso alla loro scelta e consacrazione;
inoltre presiedeva l’assemblea dei vescovi della sua provincia, detta concilio o sinodo provinciale.
A tale assemblea erano demandate non solo le decisioni in materia organizzativa, ma anche le
soluzioni delle vertenze tra i vescovi e le loro comunità, nonché di quelle insorte tra le varie
diocesi.
Le delibere del sinodo erano vincolanti per tutta la comunità della provincia ecclesiastica.
L’ambito dell’intervento dell’assemblea era molto esteso, tanto che la sentenza sulle cause
sottoposte al suo esame poteva arrivare alla deposizione del vescovo giudicato colpevole.
15
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Al di sopra dei metropoliti, infine, vi erano i vescovi di alcune tra le città principali dell’impero i
quali assumevano il nome di patriarchi: Alessandria, Antiochia, Costantinopoli e Roma vennero,
infatti, dichiarate sedi patriarcali.
L’organizzazione interna della diocesi è strettamente connessa con la gestione del patrimonio di
cui la stessa era titolare.
Il diritto imperiale riconosceva alla Chiesa un’ampia sfera di privilegi in ordine all’amministrazione
dei suoi beni, sfera che comprendeva immunità fiscali e una vasta libertà organizzativa.
In ordine al primo profilo (immunità fiscali), i possedimenti ecclesiastici erano tenuti:
in un primo tempo, solo al versamento di un tributo, la “canonica inlatio”, ed erano esentati
dagli oneri pubblici;
dopo il 423 tale immunità fu ridotta e le terre della Chiesa vennero gravate dalle
contribuzioni richieste per la manutenzione dei ponti e delle strade pubbliche.
Tra il 4 e il 5 sec. furono frequenti le concessioni alle diocesi di sussidi, detti “annonae”, da parte
dell’autorità imperiale.
Per quanto riguarda il 2 profilo (libertà organizzativa), la Chiesa poteva far fronte alle crescenti
esigenze organizzative, nonché aveva ampia libertà di operare.
All’inizio le strutture istituzionali della diocesi erano estremamente semplici: nella sede
dell’episcopato si trovava una sola chiesa, nella quale il vescovo ed il clero svolgevano il proprio
servizio religioso.
La rapida espansione della fede cristiana impose la fondazione di un numero maggiore di luoghi
di culti: le nuove chiese vennero strutturate come articolazioni di quella principale e di
conseguenza furono:
da una parte affidate al servizio dello stesso clero che operava in quest’ultima;
dall’altro furono mantenute con le rendite del patrimonio spettante alla diocesi.
Successivamente, però, né il clero né le rendite della chiesa principale furono sufficienti a
garantire un’adeguata espansione della rete ecclesiastica.
Alla fine del 5 sec. la fondazione di nuove chiese in Italia è subordinata alla loro titolarità di terre
capaci di assicurare la manutenzione e l’illuminazione dell’edificio, nonché il sostentamento dei
chierici addetti al servizio religioso.
Si affermò allora una distinzione tra le chiese dipendenti da quella che era sede del vescovo:
furono dette “tituli” (in genere si trovavano nelle città) le articolazioni di quest’ultima, servite
dal suo stesso clero e mantenute dalle sue medesime entrate;
si chiamarono invece parochaie (o dioceses), di solito si trovavano in campagna, i luoghi di
16
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
culto dotati di un proprio patrimonio, distinto da quello episcopale, e serviti da chierici che
non facevano parte del clero addetto alla chiesa principale e che operavano sotto la guida di
un presbyter, scelto da loro stessi e dalla comunità dei fedeli che facevano capo alla parochia
e successivamente consacrato dal vescovo.
La gestione del patrimonio episcopale prevedeva la divisione delle sue entrate in 4 parti,
rispettivamente destinate al vescovo, al clero, alla manutenzione ed illuminazione degli edifici
sacri, alle opere caritative in favore dei poveri.
I beni della parochia erano direttamente amministrati dal presbyter, sotto il controllo generale
del vescovo.
L’ordinamento giuridico romano riconosceva ai chierici, ed in particolare ai vescovi una serie di
privilegi come il foro, in virtù del quale il vescovo chiamato in causa sia per una vertenza civile sia
per un’accusa criminale poteva sottrarsi al giudice civile e sottoposto al giudizio di una corte
speciale composta da altri vescovi.
Le costituzioni imperiali, inoltre, avevano attribuito ai titolari delle diocesi un’ampia competenza
giurisdizionale nei confronti delle loro comunità: essi presiedevano l’episcopalis audentia, la corte
che aveva competenza sui chierici, ma che poteva essere adita anche da laici per la soluzione di
vertenze civili.
Infine, la funzione caritatevole ed assistenziale svolta istituzionalmente dal vescovo e la
disponibilità che questo aveva di una parte delle entrate diocesane da destinare alla cura dei
poveri favorirono la progressiva affermazione della dignità ecclesiastica come autorità di guida e
di sostegno dei cittadini romani, residenti nella circoscrizione episcopale, con una conseguente
espansione consuetudinaria delle potestà pubbliche espressamente concesse ai vescovi da
costituzioni imperiali.
La complessa ed articolata organizzazione ecclesiastica operava all’interno di un contesto sociale
ed economico in profonda involuzione: la storiografia ha da tempo messo in evidenza come la
crescente gerarchicizzazione degli ultimi secoli dell’Impero avesse influenza sulle strutture del
clero cattolico.
Le famiglie della ricca aristocrazia, che avevano il controllo dei grandi patrimoni e costituivano il
ceto dominante nelle province, si impadronirono della dignità episcopale, riservandola a chierici
appartenenti ai loro gruppi parentali.
La scelta del titolare della diocesi, che in teoria spettava al clero e al popolo, venne di fatto
assunta dalle famiglie senatoriali della provincia, con la conseguente esclusione dei ceti meno
abbienti e del clero minore.
Inoltre, la gestione del patrimonio episcopale subiva necessariamente la stessa evoluzione che
andavano conoscendo i grandi latifondi laici.
In conclusione, l’ordinamento giuridico ecclesiastico e il sistema istituzionale della Chiesa
17
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
presentavano già, negli ultimi secoli dell’Impero romano, un carattere duplice:
da una parte godevano di un proprio ambito di giurisdizione, del tutto separato da quello
dell’ordinamento temporale;
dall’altra essi estendevano la loro competenza anche ad altri settori rilevanti della vita
sociale.
4. I REGNI ROMANO-BARBARICI IN ITALIA E IN GALLIA
Gli studiosi sono soliti distinguere 2 fasi delle invasioni germaniche dell’Occidente romano:
La prima è considerata opera di popoli giunti nelle regioni imperiali a conclusione di un lungo
periodo di peregrinazione: poco numerosi, essi si stanziarono in zone limitate delle province
occupate, organizzandosi secondo le regole della loro tradizione, lasciando che il restante
territorio di queste rimanesse in mano alla preesistente società romana.
Questa fase riguarda il regno ostrogoto in Italia, quelli visigoto e burgundo nelle Gallie;
La seconda ondata delle invasioni germaniche fu opera di popoli già da tempo stanziati nelle
regioni limitrofe a quelle romane, e si caratterizzarono per il graduale e completo
trasferimento della comunità germanica.
Questa si sparse nell’intero territorio conquistato ed impose le proprie strutture
organizzative alla popolazione romana, eliminando ogni vestigia delle precedenti istituzioni
imperiali.
A questa seconda fase appartengono i regni longobardo in Italia, franco in Gallia,
anglosassone in Britannia.
I regni sorti in seguito alle prime invasioni vengono designati come romano-barbarici per
sottolineare la coesistenza delle due componenti:
Da un lato risente delle suggestioni provenienti dall’impostazione che esalta gli aspetti
statualistici nei regni ostrogoto, visigoto e burgundo;
Dall’altro enfatizza la presenza di forme fondiarie di tipo signorile.
La durata dei regni fondati dai Visigoti, dagli Ostrogoti e dai Burgundi non è omogenea.
Il regno dei Burgundi ebbe inizio intorno alla metà del secolo V con un insediamento che
riguardava il luogo circostante il lago di Ginevra e che successivamente si estese lungo il corso del
Rodano e della Saona: negli ultimi anni del secolo il re burgundo Gundobado fu riconosciuto
dall’imperatore bizantino Anastasio come “rex et patricius”, nel 534, però la vittoria franca ad
Austun pose fine al regno burgundo.
18
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Il dominio ostrogoto in Italia si consumo tra la fine del V secolo e la prima metà del successivo:
nell’agosto del 490 Teodorico conseguì, grazie alla vittoria contro Odoacre presso l’Adda, il
controllo della penisola e tre anni dopo, con la conquista di Pavia e l’uccisione di Odoacre dette
inizio al proprio regno; il dominio godo si protrasse anche dopo la morte di Teodorico e termino
con la conclusione della guerra goto-bizantina nel 533.
Il regno visigoto ebbe una più lunga durata:
In una prima fase (tra l’inizio del 5 sec. e i primi anni del successivo) riguardò l’Aquitania e
le altre regioni occidentali della Gallia, nonché l’area pirenaica ed ebbe come centro
principale la città di Tolosa;
Una seconda dopo la sconfitta subita a Vouillé, i Visigoti persero i loro territori in Gallia e
iniziarono una più estesa penetrazione al di là dei Pirenei, che li portò alla conquista
dell’intera penisola iberica e alla fondazione di un nuovo regno che ebbe in Toledo il suo
centro più importante e che sopravvisse fino alla conquista araba.
Un aspetto degli ordinamenti posti in essere dalle prime invasione è quello della “personalità
del diritto”, in virtù del quale i liberi che appartenevano allo stesso sistema politico osservavano,
nella disciplina dei loro rapporti interpersonali, le norme fissate dall’ordinamento della propria
natio.
Il principio di personalità del diritto costituisce, quindi, l’opposto di quello della territorialità,
secondo il quale tutto l’ordinamento vigente in una regione vincola tutti coloro che in quella
stessa regione si trovano, senza distinzioni di nazionalità.
Il principio della personalità del diritto si fondava sull’idea per cui l’ordinamento giuridico
consuetudinario di ogni popolo germanico era parte integrante del complesso che le divinità
protettrici della natio difendevano e tutelavano insieme con la comunità degli uomini e che, di
conseguenza, non poteva essere esteso ad altre collettività, di origini e usi diversi.
Le invasioni introdussero nell’Occidente europeo tale principio che conobbe un progressivo
sviluppo, quando altre nationes germaniche si stanziarono nelle stesse regioni e più popoli si
trovarono a far parte dello stesso sistema istituzionale si affermò, quindi, l’uso delle
“professiones iuris”, cioè le dichiarazioni con cui le parti di un negozio giuridico indicavano il
diritto nazionale secondo cui vivevano ed in base al quale volevano vincolarsi ed eventualmente
sottoporsi a giudizio.
Sul piano delle fonti giuridiche l’applicazione del principio della personalità del diritto nei primi
regni romano-barbarici dette via via alla formulazione di alcune importanti compilazioni.
Nel REGNO VISIGOTO di Tolosa all’inizio del 6 sec. fu portata a termine la redazione di una
19
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
raccolta di norme valide per la sola componente romana della popazione era la LEX ROMANA
WISIGOTHORUM, approvata nel 506 durante il regno di Alarico II e detta anche Breviarium Alarici
o Alaricinianum.
Essa consisteva in una vasta raccolta di leges del Codice Teodosiano, arricchita da alcune
costituzioni post-teodosiane e da iura tratti soprattutto dal Liber Gai e dalle Sententiae di Paolo.
Obiettivo della raccolta era quello di offrire ai Romani residenti nel regno un quadro esatto del
loro diritto nazionale che ancora poteva essere considerato in vigore: per facilitarne la
comprensione, la maggior parte delle leges e degli iura era accompagnata da una spiegazione
illustrativa (interpretatio visigotica).
Un'altra raccolta destinata ai soli romani era la raccolta compilata nel REGNO BURGUNDO
durante il periodo di re Gundobaldo (465-516), chiamata la LEX ROMANA BURGUNDIONUM:
utilizzava le stesse fonti romane dell’opera visigota, ma è meno elaborata rispetto a quest’ultima.
Dalle due opere si distingue invece L’EDICTUM THEODORICI, che la dottrina tradizionale
attribuisce a Teodorico (re ostrogoto d’Italia), mentre invece il Rasi e il Vismara l’hanno attribuito
al re visigoto Teodorico II.
L’Edictum non è una legge personale: esso risulta diretto a disciplinare alcune questioni che
riguardano entrambe le componenti etniche del regno, al fine di evitare l’insorgere di dissidi tra
loro, e quindi indirizzato sia ai Goti sia ai Romani.
Inoltre, i Visigoti e i Burgundi non si preoccuparono soltanto di raccogliere le norme vigenti per la
popolazione romana, ma vollero anche provvedere alla stesura delle loro antiche consuetudini.
Nel regno visigoto le loro antiche consuetudini furono raccolte nell’opera della CODEX
EURICIANUS, dal nome del re Eurico che ne promosse la redazione facendola approvare
dall’assemblea popolare nel 475.
Nel regno burgundo le consuetudini germaniche furono messe per iscritto tra il 480 e il 501, sotto
il regno di Gundobado, e formarono la raccolta nota come LEX BUGUNDIONUM o LEX
GUNDOBADA.
E’ evidente che l’influenza del mondo romano non era tale da modificare in profondità
l’ordinamento tradizionale del popolo germanico, che continuò a presentare i caratteri del
periodo precedente e conosceva una limitata evoluzione soprattutto per adeguarsi alla nuova
realtà economica e sociale instauratasi in seguito all’insediamento stabile nelle province
occidentali.
Il principio della personalità del diritto, inoltre, non era l’unico aspetto della divisione esistente tra
la popolazione germanica e quella romana all’interno dei regni in esame: secondo le conclusioni
della prevalente storiografia, le strutture organizzative ed amministrative del Tardo Impero
20
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
rimasero immutate nei nuovi regni, con il solo limite di svolgere la loro funzione solo nei
riguardi della comunità romana infatti, i Germani affiancarono a tali istituzioni la propria
organizzazione tradizionale, che li riguardava in modo esclusivo e non poteva essere estesa a
nationes diverse.
Su questo punto sembra esserci accordo tra gli storici che dibattono sul tema della continuità tra
tardo Antico e primo Medioevo; e un accordo si registra anche sulla spiegazione del fenomeno
infatti, secondo gli studiosi, la coesistenza della duplice realtà istituzionale fu resa possibile dal
fatto che il re germanico rivestiva allo stesso tempo la duplice carica di capo del suo popolo e di
magistrato supremo delle autorità romane in quanto rappresentante diretto dell’imperatore.
Il re germanico avrebbe conservato tale qualifica anche dopo la deposizione dell’Imperatore
d’Occidente Romolo Augustolo nel 476, dato che allora, in virtù dell’unicità della “imperialis
majestas”, l’autorità imperiale non si estinse nelle province occidentali, ma passò nelle mani
dell’Augusto d’Oriente tale funzione di rappresentante imperiale sarebbe stata svolta sia dai
primi re visigoti, sia da quelli burgundi, sia in Italia da Teodorico.
E’ certo che i re germanici ebbero modo di ornarsi di titoli romani che li inserivano nella struttura
amministrativa dell’Impero e li rendevano diretti rappresentanti dell’Augusto sia i re burgundi
sia Teodorico ricevettero il titolo di “patricius purpureus”, che corrispondeva alle cariche più
elevate della gerarchia bizantina.
Altrettanto certa è la sopravvivenza di magistrature romane all’invasione barbarica: nel regno
visigoto risulta la magistratura del rector o iudex provinciae, incaricato della guida dei funzionari
minori preposti alla riscossione fiscale e all’amministrazione della giustizia.
Risulta altresì confermata la precedente struttura istituzionale cittadina romana, che continuò a
prevedere la curia municipale e gli uffici di curator e di defensor civitatis quindi durante i regni
romano-barbarici l’organizzazione amministrativa romana sopravvisse.
Dal canto loro, i Germani conservavano il loro ordinamento tradizionale, in particolare, data la
struttura militare che aveva assunto la popolazione, furono stabilite come autorità popolari di
guida quelle cariche che avevano tale ruolo nell’ambito dell’esercito: il decanus, il centenarius, il
quingentenarius, il millenarius, erano a capo di gruppi di guerrieri non soltanto in tempo di guerra
ma anche in periodi di pace.
Nelle città in cui posero la loro residenza gruppi di Germani operava un comes civitatis come loro
guida.
Si ritiene che l’autorità del re germanico conoscesse una profonda trasformazione: il re avrebbe
abbandonato il ruolo marginale svolto nell’ordinamento tradizionale, per divenire il fulcro
dell’intero sistema istituzionale, assumendo la potestà di fonte di diritto e di fonte di autorità
pubblica e ripetendo, in tal modo, il paradigma della imperialis majesta.
Inoltre i capi militari e i conti cittadini germanici sarebbero da considerare rappresentanti della
superiore autorità del re, e pertanto espressione di un potere diverso da quello del popolo; in tal
21
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
modo essi ripeterebbero nei regni romano-barbarici la struttura di potestà affermatasi
nell’Impero romano.
Tuttavia, tale interpretazione non trova nelle fonti alcuna adeguata conferma e risulta in completa
contraddizione con la continuità dell’ordinamento giuridico tradizionale consuetudinario della
natio germanica.
Tale ordinamento era strutturato in maniera tale da escludere la distinzione tra sfera di diritto
pubblico ed una di diritto privato ne consegue che la continuità del sistema tradizionale non
puo’ essere limitata alla disciplina dei rapporti intersoggettivi ed esclusa per l’organizzazione della
società.
D’altro canto le fonti parlano della vitalità delle antiche istituzioni germaniche le assemblee
continuarono ad essere convocate e nel corso delle loro riunioni furono approvate le compilazioni
di norme romane e quelle degli usi germanici.
Il meccanismo di difesa rimane inalterato rispetto al passato: la vendetta legittima (faida), le
compositiones, la funzione dichiarativa della corte giudicante.
Quindi, l’influenza romana non fu tale da sovvertire l’ordine consuetudinario di Goti e
Burgundi.
Secondo Faussner, i re burgundi e ostrogoti alla fine del secolo V si rivolsero con insistenza
all’imperatore d’Oriente per ottenere la concessione del titolo di patricius purpureus per se e per
il proprio erede: tale titolo li faceva entrare nei ranghi della gerarchia burocratica bizantina,
conferiva l’oro l’autorità di principale rappresentante della imperialis majestas nei loro regni e, di
conseguenza , li poneva in una posizione di definitiva superiorità non soltanto nei confronti del
popolo, ma anche dei capi militari minori.
Il patriziato purpureo corrispondeva ad un’alta carica imperiale e il suo titolare era certamente
superiore agli altri magistrati romani attivi nei regni barbarici.
Attraverso il patriziato il re diventava il legittimo vertice della burocrazia romana nel regno.
I periodi durante i quali i re germanici furono privi di questo titolo risultano più lunghi di quelli nei
quali se ne potevano fregiare (onorare) e tra i due tipi di periodi non sembra esserci stata alcuna
significativa differenza in ordine al funzionamento dell’apparato delle magistrature romane.
Nemmeno lo stato di guerra tra l’Impero e il popolo germanico ebbe effetti sulla continuazione
del meccanismo degli uffici romani: nel 468 il re visigoto Eurico ruppe il foedus con l’imperatore e
dette inizio ad un conflitto armato contro di lui, senza che si alterassero né la natura delle
magistrature romane nel regno, né la qualità delle sue relazioni con queste.
Quando nel 475 l’imperatore d’Occidente riconobbe formalmente la nuova situazione creatasi nei
territori visigoti, nessuna conseguenza si verificò nel precedente ordinamento.
Quindi il titolo di patriziato non era indispensabile per il mantenimento dei buoni rapporti tra
Germani e Romani e per il funzionamento del sistema burocratico di origine imperiale in armonia
con quello di tradizione barbarica, ma solamente per motivi di prestigio personale del titolare
della carica.
22
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Quale era allora il motivo per cui i re burgundi e ostrogoti ricercavano con tanta insistenza la
concessione di questo titolo?
1 SPIEGAZIONE) si puo’ trovare sul piano dei rapporti internazionali: concedendo il patriziato,
l’imperatore riconosceva il re come appartenente alla propria burocrazia e di conseguenza si
impegnava a non promuovere alcuna impresa militare contro di lui.
Il titolo aveva riflessi anche sul piano interno, perché poneva il re in una posizione nettamente e
formalmente diversa rispetto a quella dei capi militari minori una volta scartata l’idea della
volontà del re di riproporre nel regno il modello della imperialis majestas, vi erano 2 importanti
novità:
In primo luogo, la funzione di guida di cui in precedenza il popolo aveva avuto bisogno solo in
momenti eccezionali, soprattutto nelle campagne militari, si affermò come necessità stabile
il re divenne il punto di riferimento indispensabile per la difesa della ristretta comunità
germanica stanziatasi nella provincia romana.
La titolarità di tale funzione continua ad essere decisa dal popolo, in modo tale che se la
funzione stessa era diventata insostituibile, i capi famiglia e i capi militari mantenevano il
diritto e il potere di scegliere la persona che la doveva svolgere;
In secondo luogo, bisogna ricordare che, al momento della divisione delle terre conquistate,
il re, cui era spettata la guida dell’esercito, si era impadronito del grande patrimonio che
sotto l’amministrazione romana costituiva la “res privata” dell’imperatore, mentre gli altri
capi famiglia e i militari si erano impossessati di terre do singoli latifondisti il patrimonio in
mano al re era di gran lunga superiore a quello degli altri liberi e spettava a colui che era
liberamente scelto dall’assemblea come re.
E’ legittimo, quindi, pensare che le continue richieste avanzate dai re burgundi e ostrogoti per
ottenere il patriziato fossero motivate da esigenze personali, più che da ragioni istituzionali.
Esso serviva a consolidare la posizione del re e della sua famiglia all’interno del mondo
germanico, poiché affermava che l’impegno imperiale a non muovere guerra e a mantenere
buoni rapporti con la natio germanica passava attraverso la titolarità della funzione regia da parte
di chi era riconosciuto patrizio dall’Augusto.
Cambiando la persona del re o scegliendo alla sua morte persona diversa dall’erede di quello, i
capi germanici avrebbero corso il rischio di rompere i rapporti con l’Impero d’Occidente.
Si respinge, quindi, l’idea di una radicale trasformazione della natura del potere regio
germanico rispetto al periodo precedente.
Si puo’ concludere che il complesso ordinamento istituzionale dei regni romano-barbarici si
23
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
basava su un sostanziale accordo tra la nazione barbarica e quella di origine romana e sul rispetto
reciproco del diritto di ciascuna nazione, che le modifiche intervenute in ognuno di questi
derivarono dalla reciproca influenza e dagli ordinamenti imposti dalle nuove necessità sociali ed
economiche, ma non incisero mai sulle loro basi fondamentali.
La necessità della difesa della comunità germanica e dello stanziamento da questa realizzato
resero stabile la funzione del re, punto di riferimento per tutti i liberi della nazione barbarica.
La stabilità non modificò le funzioni del re egli continuava ad essere il supremo capo militare e
non acquistò nuovi compiti in ordine al mantenimento della pace e della giustizia all’interno del
popolo.
I suoi consiglieri personali erano i membri del suo seguito.
Lo stesso “comes patrimoni” era un consigliere del re che lo aiutava nell’amministrazione del
patrimonio spettante alla funzione regia.
Le decisioni riguardanti la collettività continuarono ad essere prese dall’assemblea dei liberi, la cui
autorità non venne mai assorbita, nemmeno dal re.
All’interno della popolazione romana si conservò la precedente struttura sociale che poneva al
vertice il ristretto ordine senatorio, titolare di vasti latifondi.
L’accordo tra Germani e Romani si fondò sulla garanzia offerta dai primi all’aristocrazia senatoria
di conservare intatto l’ordine sociale affermatosi nel tardo impero.
Nei regni romano-barbarici, quindi, l’incontro tra le due componenti sociali venne disciplinato
dal principio della personalità del diritto, in virtù del quale ciascuna di loro conservava il
proprio ordinamento tale ordinamento, però, si presentava con una pluralità di elementi non
necessariamente tra loro coordinati, di modo che il diritto dei singoli nasceva dall’intreccio dei
vari momenti associativi di cui quelli facevano parte.
Accanto all’ordinamento dei Germani e dei Romani si conservò quello della Chiesa:
I germani erano di religione ariana e introdussero un’organizzazione ecclesiastica;
I romani avevano un’organizzazione distinta dai germani e riservata solo a loro.
I re avevano la funzione di proteggere e di controllare la Chiesa ariana.
L’organizzazione ecclesiastica continuò a funzionare come ordinamento a sé.
Entrambi gli ordinamenti giuridici si adeguavano alle condizioni effettive della società e della
produzione: vi si adeguavano gradualmente e in maniera spontanea fonte primaria del diritto
era la consuetudine, l’uso prolungato e ripetuto nel tempo, imposto dalle concrete necessità
della vita associata.
La consuetudine guidò i rapporti che la vita imponeva ai due ordinamenti, presiedette alla nascita
di regole che disciplinavano le relazioni tra Germani e Romani e assicurò la difesa di nuovi diritti:
Per le popolazioni romane non riuscivano più ad operare le altre fonti del diritto, cioè le
24
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
leggi imperiali e la dottrina dei giuristi;
Per le genti barbariche la tradizione formata nella fase precedente l’insediamento si
arricchì di diverse regole.
Quindi l’ordinamento si arricchì di nuovi elementi: regole imposte dall’evoluzione della società si
affiancarono a quelle che facevano parte della tradizione del popolo germanico o rientravano nel
grande patrimonio giuridico germanico.
Le regole precedenti continuavano ad essere considerate con rispetto e non come regole
esplicitamente abrogate infatti, la caratteristica della consuetudine era la sua estrema
elasticità, nel senso che la sua inosservanza per un tratto di tempo non comporta la sua
abolizione, ma solo la sua quiescenza, dato che essa puo’ sempre essere invocata quando
circostanze oggettive lo consentano.
In tale situazione la certezza del diritto è lontana infatti nei regni visigoto e burgundo si arrivò
alla stesura per iscritto sia delle norme giuridiche in vigore per la comunità romana, sia delle
tradizioni del popolo germanico (obiettivo = fare chiarezza nella molteplicità di regole).
Secondo il Levy, Goti e Burgundi rispettarono nei patrimoni pervenuti nelle loro mani i precedenti
insediamenti contadini della popolazione romana, senza cercare di imporre, come faranno i
Germani della seconda fase delle invasioni, il modello della comunità di marca, costituito da un
villaggio dotato di pascoli e foreste comuni e di un’area destinata all’arativo.
Ai precedenti insediamenti affiancarono i propri, in modo che le forme romane e quelle
germaniche ebbero modo di incontrarsi in maniera diretta, con reciproca influenza.
A detta del Levy, l’influenza germanica sul diritto romana si espresse nell’accentuazione della
prevalenza di elementi possessori su quelli petitori e nel conseguente avvicinamento in sede
processuale della sfera civile e di quella penale.
L’evoluzione del diritto spettò in modo primario ed esclusivo alla consuetudine.
Secondo alcuni storici, i capi militari più importanti si appropriarono di vasti latifondi e su queste
terre insediarono le loro famiglie, dando vita ad unità compatte qui si stanziarono capi militari
minori Levy non è d’accordo capi militari avvantaggiati ma rimane il principio di parità tra le
famiglie, che esclude la formazione di comunità di liberi nei latifondi
Quindi, nei regni romano-barbarici vi è un’evoluzione degli ordinamenti giuridici evoluzione
determinata dalle esigenze quotidiane della vita e quindi nasceva dalla consuetudine.
L’ordinamento germanico che si evolve è quello del popolo-esercito uomini liberi
sostanzialmente uguali.
5 – IL REGNO VISIGOTO DI TOLEDO (dura fino all’VIII sec.)
25
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
In Spagna l’insediamento goto si concretizzò nella regione centro-settentrionale, pur non
mancando presenze militari in altre zone.
Anche qui la divisione delle terre conquistate vide l’assegnazione al re della res privata
dell’imperatore e l’attribuzione ai capi militari di ampi patrimoni.
Anche in Spagna venne rispettato in principio della personalità del diritto e furono conservate
molte magistrature imperiali (come lo iudex) e fu introdotto l’ordinamento visigoto con autorità
militari e conti cittadini, quali erano previsti nel regno di Tolosa.
Anche qui il re amministrò il suo patrimonio con l’ausilio di un comes patrimoni, il quale si
avvaleva di procuratori ed agenti provinciali.
Tuttavia, nel corso del secolo VI e VII nella Spagna visigota ebbe modo di realizzarsi una più
sensibile fusione tra l’elemento romano e quello germanico della popolazione la conversione
del re Recaredo alla fede cattolica e il successivo abbandono della religione ariana da parte dei
capi militari più importanti, è un chiaro indice della raggiunta concordia tra i due popoli.
Concordia che si consolidò di fatto dal momento che nella seconda metà del secolo VII il re goto
Recesvindo poteva predisporre la compilazione di un nuovo testo legislativo, la LEX
WISIGOTHORUM, che era diretto ad entrambi i popoli del suo regno diversa dalla lex romana
wisigothorum che era rivolta solo ai romani.
La conversione visigota al cattolicesimo instaurò nuovi rapporti tra la Chiesa e il mondo
germanico: non più separati tra loro, i due ordinamenti cominciarono ad influenzarsi
reciprocamente.
Secondo l’interpretazione tradizionale, il re goto avrebbe assunto la guida della gerarchia
ecclesiastica e allo stesso tempo avrebbe garantito questa protezione e difesa di privilegi.
Non era solo il monarca ad esercitare influenza sulla Chiesa cattolica: anche i capi militari goti lo
affiancavano in questa funzione.
La maggior fusione tra i nobili romani e i nobili goti ampliò i rapporti tra il mondo ecclesiastico e il
mondo temporale e quindi coinvolse anche i Germani in quella rete di rapporti che sin dal tardo
Impero si erano instaurati tra l’ordine senatorio e la gerarchia cattolica.
Espressione degli stretti vincoli tra le autorità temporali e quelle ecclesiastiche divennero i concili
della Chiesa visigota essi conservavano la loro funzione di assemblee ecclesiastiche, ma
svolsero anche la funzione di riunioni generali delle autorità del regno nel corso delle quali
intervenivano sia il re sia gli altri grandi signori per discutere di questioni di ordine generale.
Secondo la storiografia giuridica, La Lex Wisigothorum aveva natura territoriale e abrogò la legge
personale dei Romani si sarebbe venuto ad affermare un unico ordinamento territoriale, di
prevalente contenuto germanico, ma non privo di influenze romane.
Inoltre, seconda questa corrente interpretativa, durante il regno di Recesvindo sarebbero state
introdotte radicali riforme nel sistema istituzionale del regno, che avrebbero portato alla
26
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
scomparsa della precedente organizzazione delle magistrature romane e alla formazione di un
unico apparato di funzionari, competenti sia per i Romani sia per i Goti e direttamente dipendenti
dal re.
Al vertice del regno, sempre secondo questa ricostruzione, si sarebbe trovato il re, che sin dalla
prima metà del 7 sec. avrebbe ricevuto la sacra unzione e che comunque avrebbe affermato il
carattere teocratico della potestà monarchica, come derivata da Dio per guidare il popolo.
Il re sarebbe stato coadiuvato da un gruppo di fedeli (“i seniores palatii”), che costituivano il
consiglio del monarca e tra i quali avevano una posizione preminenti i “gardingi”, che costituivano
la guida personale del re.
Dal governo regio sarebbe dipeso un articolato sistema burocratico provinciale, dal quale
sarebbero state eliminate sia le magistrature regionali sia la struttura municipale di origine
romana.
Il territorio del regno sarebbe stato diviso in varie province, al vertice delle quali l’autorità regia
sarebbe stata rappresentata dal dux provinciae: in ordine decrescente vi erano il “comes civitatis”,
lo “iudex territorii”, il “millenarius”, il “quingentenatius”, il “centenarius”, il “defensor” e il
“numerarius” questi funzionari avrebbero avuto competenza in ordine all’amministrazione
della giustizia, mentre i vertici della gerarchia (dal “dux provinciae” al “thiufadus”) avrebbero
svolto anche compiti in campo tributario (riscossione tasse).
QUESTO QUADRO ISTITUZIONALE DESCRITTO PRESENTA ELEMENTI DI CONTRADDIZIONE
INTERNA:
Da un lato si afferma la cessazione dell’ordinamento personale dei Romani e la sua
sostituzione con un altro, ossia quello germanico, anche se marginalmente influenzato dalla
disciplina romana;
Dall’altro vi è un sistema radicalmente diverso da quello germanico e caratterizzato sia da
elementi tipici dell’ordinamento bizantino, sia da tratti che sembrano anticipare la monarchia
carolingia.
VI SONO QUINDI CONSIDERAZIONI DUBBIE SULLA VALIDITA’ DELLA RICOSTRUZIONE OFFERTA
DALLA PREVALENTE STORIOGRAFIA:
1) In primo luogo, il testo della Lex Wisigothorum dichiara l’inutilità della raccolta delle leggi
romane, cioè la Lex Romana Wisigothorum che non era stata mai formalmente abrogata
essa forniva il quadro delle norme romane che nel regno di Tolosa erano da considerare
in vigore per la popolazione gallo-romana nei primi anni del VI sec.
Se la Lex Wisigothorum si rivolgeva a Goti e Romani indistintamente, ciò era dovuto al
sensibile avvicinamento tra le due componenti etniche che consentiva la formulazione di
norme valide per entrambe ciò però non escludeva che nei settori non considerati dalla
Lex si conservasse la legge personale di ciascun popolo.
E’ possibile ritenere che i romani entrarono a far parte del popolo-esercito visigoto e
ottennero, di conseguenza, il pieno riconoscimento dei loro diritti personali;
2) Per quanto riguarda la visione teocratica della potestà monarchica, la tesi che ne vede
27
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
l’affermazione nel regno goto nel corso della prima metà del VII sec. non ha tenuto conto
del fatto che proprio in quel periodo la Spagna fu turbata da continue lotte tra grandi
signori, tra loro e il re.
La coincidenza cronologica tra i 2 tipi di avvenimenti non puo’ essere sottovalutata
bisogna ricordare che la monarchia gota continuava ad essere elettiva e, di conseguenza, il
re conservava la natura di autorità popolare e di primus inter pares nei confronti degli altri
capi militari.
Il titolare della carica, quindi, non aveva alcun diritto familiare sul titolo e sul patrimonio.
E’ lecito pensare che i re goti tentassero di sopperire alla debolezza della propria posizione
personale, cercando una legittimazione che rendesse a tutti chiara la differenza tra il re e
gli altri capi.
Una strada del tutto analoga era stata seguita tra il V e il VI sec. dai re burgundi e da quelli
ostrogoti essi si erano rivolti all’imperatore bizantino per ottenere il titolo di patrizio purpureo,
che definiva la loro superiorità rispetto ai minori capi militari del popolo.
I re visigoti, per affermare la loro autorità, non potevano rivolgersi all’imperatore d’oriente con cui
erano in guerra, ma ottennero tale obiettivo attraverso elementi di sacralità.
Un’ultima osservazione deve essere fatta in merito ai consiglieri palatini del re ed ai magistrati che
operavano nelle province operavano nell’ambito della domus regia, della casa del re e
sopraintendevano alle attività necessarie:
- Il comes stabuli si occupava della gestione delle stalle;
- Il comes scanciarum era responsabile dell’approvvigionamento della casa del re;
- Il comes spatariorum era a capo della guardia personale.
Le magistrature in vita dopo la riforma di Recesvindo sono: il dux, il comes, il millenarius, il
quingentenarius, il centenarius.
La riforma non ha quindi modificato la natura popolare delle cariche militari.
Le fonti confermano che le basi del sistema rimasero quelle dell’ordinamento popolare della
tradizione germanica.
Le novità istituzionali del regno visigoto di Spagna risiedono nell’accentuazione delle differenze
sociali tra liberi e nell’emersione di aspetti signorili nella gestione dei grandi patrimoni fondiari.
L’accentuazione dei caratteri signorili del ruolo del grande latifondista non aveva nulla a che
vedere con la funzione unitaria del re, il quale, nel regno visigoto, conservò i compiti di supremo
capo militare, di guida unitaria della comunità germanica il re, però, allo stesso tempo, era il
maggior latifondista del regno.
28
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
6 - L’ITALIA SOTTO IL DOMINIO BIZANTINO
Nella prima metà del secolo VI l’imperatore Giustiniano promosse la riconquista di alcune regioni
occidentali da tempo in mano ai germani.
Il suo programma ebbe successo soprattutto in Italia e portò alla conquista della penisola,
conclusa con la presa di Cuma, che pose fine alla guerra gota.
Il passaggio dell‘Italia sotto i Bizantini comportò la recensione della compilazione giustinianea.
Giustiniano, nell’intento di restaurare l’antico splendore imperiale di Roma, non si era limitato a
progettare la riconquista delle regioni occidentali, ma aveva anche formulato un vasto programma
di riordinamento normativo sul modello di quello pensato da Teodosio.
Nel 529 venne pubblicata un’opera che raccoglieva le costituzioni imperiali promulgate a partire
dal tempo di Adriano tale collezione, nota come CODEX JUSTINIANUS (abbiamo solo un
indice).
Nel 533 furono pubblicati:
le Institutiones, manuale destinato alla scuola e diviso in 4 libri;
i Digestorum seu Pandectarum libri L;
la collezione degli iura nella quale veniva riunita la dottrina dei più noti giuristi dall’età
classica in poi.
Nel 534 fu elaborata un’edizione più elaborata del Codex, cioè il Codex repetitae praelectionis e,
articolato in 12 libri, sostituì la precedente raccolta di costituzioni.
Infine, Giustiniano provvide a raccogliere le leges da lui emanate dopo il 535 in una collezione
nota come Novellae Constitutiones le leggi della raccolta arrivano fino al 565.
La legislazione giustinianea entrò immediatamente in vigore in tutte le regioni dell’impero e
riguardò quindi anche l’Italia sottoposta alla dominazione gota che riconosceva l’alta autorità
dell’imperatore bizantino.
Tuttavia, l’applicazione della nuova disciplina non fu esauriente, perché, dopo la conquista
bizantina della penisola, fu necessario un apposito decreto di Giustiniano per richiamare la
popolazione italiana all’osservanza della legislazione stessa si tratta della “Pragmatica sancito
pro petizione Vigilii” con cui l’imperatore nel 554, su richiesta di papa Virgilio, ribadiva che la sua
legislazione era in vigore nella provincia italiana.
Delle 4 parti che componevano la compilazione (istitutiones, codex, novallae e digesto; in ordine
di importanza) la più conosciuta è il volume delle Istitutiones per il carattere elementare.
Con la conquista bizantina tornarono in vigore in Italia le magistrature dell’ultimo periodo
imperiale.
Giustiniano fisso nel 554 l’assetto amministrativo dell’Italia.
La principale modifica rispetto al tardo impero consisteva nella separazione tra la penisola e le
isole maggiori: la prima continuò ad essere affidata alla competenza del praefectus pretorio e la
sua sede venne posta a Ravenna, mentre il governo di Roma e del suo distretto restava in mano al
29
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
praefectus urbi.
La Sicilia invece venne affidata a un governatore che si fregiava del titolo di pretore e risiedeva a
Siracusa, mentre la Sardegna e la Corsica, dopo la fine del regno vandalico, erano state poste alle
dipendenze dell’amministrazione bizantina che controllava l’Africa settentrionale e aveva sede a
Cartagine.
All’interno della burocrazia bizantina venne ribaltata la distinzione tra magistratura civile e
magistratura militare: responsabile del governo dei distretti territoriali e dell’amministrazione
della giustizia era lo iudex, mentre il dux continuava ad essere un’autorità esclusivamente
militare.
Competenze civili, infine, venivano riconosciute ai vescovi ad essi era attribuita la facoltà di
intervenire nella scelta dei giudici e degli altri ufficiali della burocrazia locale.
La restaurazione dell’autorità imperiale, comunque, non comportò la conferma degli assetti
sociali tradizionali che erano stati turbati nell’ultima fase della dominazione gota infatti, i
Bizantini restituirono ai grandi possessori Romani i patrimoni loro sottratti dai Goti,
concessero ai senatori rifugiatosi a Costantinopoli di tornare in Italia per riprendere possesso
delle loro terre e per riorganizzarvi la produzione recuperando gli antichi diritti su coloni,
contadini e servi.
Ma non restituirono alla stessa aristocrazia senatoria il monopolio del potere in Italia.
Il governo venne assegnato ad una articolata e numerosa burocrazia proveniente dalle province
orientali, mentre le cariche più elevate, con la sola eccezione del praefectus urbi e della
presidenza del Senato erano riservate a funzionari bizantini.
Le necessità finanziarie dell’impero spinsero i Bizantini ad imporre onerosi tributi sui patrimoni
fondiari.
CAPITOLO 2 – I REGNI DEI POPOLI GERMANICI
1. INTRODUZIONE
La seconda ondata di invasioni dei popoli germanici si sviluppò nel corso del VI secolo e modificò
profondamente gli assetti sociali e gli ordinamenti giuridici delle regioni occidentali.
Interi popoli si trasferirono nelle antiche province imperiali e si stanziarono nell’intera area del
territorio conquistato.
I Germani non ebbero bisogno dell’accordo e del consenso delle popolazioni di origine romana
residenti nelle regioni occupate furono abolite le antiche magistrature imperiali, che erano
state rispettate dai regni romano-barbarici, e al loro posto venne introdotta l’organizzazione del
popolo-esercito vincitore.
Gli studiosi hanno dedicato approfondite ricerche agli ordinamenti dei Franche, dei Longobardi e
degli Alglo-Sassoni.
30
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Per i regni dei franchi e dei longobardi l’opinione più diffusa tende a presentare gli ordinamenti
nati dalle medesime invasioni come espressione di un’ideologia che sarebbe composta da
elementi desunti dal modello imperiale bizantino e da altri di ispirazione ecclesiastica.
Si ritiene cioè che gli invasori una volta consolidata la conquista, abbandonarono le forme
organizzative della loro tradizione, per adeguarsi al paradigma istituzionale fornito dal mondo
romano-bizantino tale interpretazione riguarda la struttura del governo.
2.1 INTERPRETAZIONI DELLA STORIOGRAFIA
Il Lemarignier alcuni anni fa rilevava che negli studi sul regno franco erano segnalabili tre correnti
principali:
❖ La prima sosteneva la formazione di un sistema istituzionale di natura uguale a quella
generalmente assegnata dalla storiografia all’impero romano, un sistema caratterizzato
dall’individuazione dell’idea di res publica come sfera di competenza riservata ad
un’autorità superiore ai privati;
❖ La seconda, invece, metteva in evidenzia la continuità del carattere originario del diritto
franco, con la conseguente assenza di ogni idea di autorità pubblica;
❖ La terza, infine, concordava con la prima nel riconoscere l’emersione di una potestà
pubblica assegnata al re, ma ne attribuiva l’origine non già all’imitazione del modello
imperiale, bensì alla concezione teocratica e carismatica dell’autorità del re, concezione
che a questa affidava un ruolo decisivo nella guida della comunità verso la salvezza
eterna.
Oggi la maggior parte degli studiosi sembra ritenere che se nella fase iniziale del loro
stanziamento i Franchi seguirono l’ordinamento tradizionale, ben presto subirono
l’influenza romana e quella ecclesiastica e dettero vita ad un sistema istituzionale profondamente
diverso da quello delle loro origini.
Cardine del nuovo ordinamento, secondo questa corrente interpretativa, fu il re la sua
trasformazione in autorità superiore al popolo sarebbe stata precoce.
Poco tempo dopo la conquista Clodoveo ricevette dall’imperatore d’Oriente il titolo di patrizio che
avrebbe avuto la capacità di legittimare la guida da lui assunta dall’antica provincia della Gallia,
trasformandolo in funzionario imperiale, o meglio inserendolo nella famiglia dell’Augusto come
filius di questo e quindi partecipe della sua autorità.
Con il trattato del 535 Giustiniano riconosceva i Franchi come suoi federati e cedeva loro in
maniera formale il governo delle Gallie.
Subito dopo la conquista Clodoveo aveva deciso di convertirsi all’ortodossia e il suo esempio era
stato seguito dai capi militari minori: era stata superata la frattura religiosa che aveva
caratterizzato i rapporti tra Germani e Romani nei precedenti regni barbarici e il re si era
appropriato di un diritto di protezione sulla gerarchia cattolica che (indicato con il termine di
mundeburdium) stabiliva non soltanto la dipendenza della Chiesa dal re, ma avrebbe anche
enfatizzato in maniera del tutto inedita la funzione e l’autorità di questo nel regno.
31
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Già nella seconda metà del secolo VI sarebbe prevalsa l’idea della derivazione divina del potere
regio e si sarebbe affermata l’attribuzione al re del ruolo preciso di garantire la giustizia interna
attraverso la tutela dei beni e delle persone.
Nel corso del secolo VI si affermò la pratica del giuramento di fedeltà al quale erano tenuti
tutti i liberi nei confronti del re.
Dotato di un ricchissimo ed esteso patrimonio, derivante dall’acquisizione della res privata
imperiale ed articolato in una ampia e diffusa rete di villae o curtes regiae o fisci, il re merovingio
avrebbe assunto ben presto il compito di governare tutti i liberi, romani e germanici del regno e di
proteggerli tutelando le loro persone, i loro beni, i loro diritti.
Per svolgere tale funzione egli si sarebbe avvalso del consiglio e dell’opera di persone a lui
particolarmente fedeli, gli antrustiones, che vivevano presso di lui e formavano la sua corte
giudicante; la competenza di questa si estendeva all’intero territorio del regno, dato che tutti i
liberi, ovunque risiedevano, avevano il diritto di adirla.
Il re comunque, avrebbe delegato la sua autorità ai duchi, ai conti e ad altri ufficiali che in suo
nome operavano nelle varie province del regno.
Il distretto, che si articolava in circoscrizioni minori (dette pagi e dirette da altri rappresentanti del
re), avrebbe conosciuto una netta evoluzione in seguito al progressivo decadimento della vita
cittadina derivato dalla crescente tendenza del sistema economico a privilegiare la campagna
come sede di produzione e a dar vita a forme chiuse di tipo curtense: il centro del distretto
sarebbe allora stato di frequente spostato dalle città e la circoscrizione stessa sarebbe stata
designata non più con il termine di civitas , bensì con l’altro , ben più esatto di comitatus.
Il re avrebbe ereditato dalla precedente autorità imperiale il diritto di riscuotere un tributo sul
commercio (teloneum), per amministrare le vaste terre che formavano il suo patrimonio si
sarebbe avvalso di una schiera di agenti della sua domus, guidati da un majordomus.
Il re avrebbe compensato i servizi a lui resi da propri fedeli con la concessione o donazione di
terre e con l’attribuzione di immunità fiscali e giudiziarie relative alle terre stesse, immunità che
avrebbero legittimato il beneficiario ad esercitare il potere esattivo e giurisdicente del re.
Tuttavia, tale ricostruzione risulta particolarmente inadeguata per il regno merovingio infatti,
essa:
non solo non riesce a conciliare la continuità della tradizione per la disciplina dei rapporti
intersoggettivi;
ma non è neanche in grado di chiarire la natura dell’autorità ducale;
né tantomeno puo’ giustificare il lungo periodo di debolezza della monarchia monarchica.
2.2 LE PRINCIPALI AUTORITA’ MILITARI: DUCA, CONTE, RE
32
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
I Franchi giunti nelle Gallie al seguito di Clodoveo erano organizzati secondo la tradizionale
struttura di popolo-esercito delle genti germaniche che prevedeva l’articolazione in unità militari
sotto la guida di un capo (decano, centenario, ecc..) nonché quella fondata sul seguito, e
prevedeva come autorità centrale il duca introno al quale si riunivano numerose schiere.
La conquista franca si sviluppò su un territorio nel quale erano presenti altre popolazioni
germaniche, le quali vennero inglobate nel sistema sociale stabilito dai conquistatori, oppure ne
rimasero ai margini come alleati.
Le fonti merovinge dei secoli VI e VII presentano la carica ducale come perno della struttura
organizzativa della società.
Secondo il Lewis si possono distinguere tre tipi di duchi:
quelli presenti nelle genti germaniche collegate ai franchi da vincoli di alleanza;
quelli dei popoli sottoposti al domino merovingio;
infine, quelli presenti in territori con prevalente popolazione franca.
In realtà, tale tripartizione sembra riconducibile ad una bipartizione, dato che la principale
differenza risulterebbe quella tra duchi di etnie autonome (Stammesherzoge) e duchi attivi
nell’ambito della comunità dei franchi e delle istituzioni merovinge (Amtsherzoge).
Questi ultimi conobbero un’evoluzione rispetto al periodo della conquista, poiché da autorità
esclusivamente militare divennero titolari di un ufficio ben definito nell’ambito
dell’amministrazione provinciale franca, un ufficio che era posto al vertice del governo di
un’ampia circoscrizione territoriale, che univa alle funzioni militari quelle giurisdizionali e di
comande che era immediatamente dipendente dal re. Il territorio sottoposto all’autorità ducale
acquistò confini più definiti, il duca risulta svolgere anche funzioni di natura giurisdizionale,
soprattutto a partire dall’inizio del secolo VII.
Per i duchi di etnie autonome ed in particolare per quelli che operavano all’interno di popolazioni
autonome dei regni franchi, non si pone certamente il problema della derivazione dei poteri dal
re e risulta evidente la natura popolare di origine germanica.
La bipartizione tra le due categorie di duchi merovingi è stata contestata dal Werner.
A suo parere gli Stammesherzoge, i duchi, cioè delle etnie ai margini del nucleo vero e proprio dei
Franchi, avrebbero conosciuto soprattutto a partire dalla metà del secolo VII, un’interessante
evoluzione, in virtù della quale avrebbero da un canto accentuato la loro indipendenza dal re
franco, dall’altro avrebbero accresciuto i loro compiti e la loro autorità nei riguardi della gente che
guidava, tanto da acquistare una posizione del tutto uguale a quella dei re franchi ed espressa dal
titolo di principes di cui si fregiavano.
Nello stesso tempo anche gli Amtsherzoge, i duchi funzionari del sistema franco, andavano
acquistando una nuova posizione: essi accentuarono fortemente la loro autonomia dal re e
finirono per esercitare come proprie quelle funzioni che in origine avevano svolto nella qualità di
rappresentanti del re.
33
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Nell’ultimo periodo merovingio, allora, sarebbe scomparsa ogni differenza tra i due tipi di duchi:
entrambi avrebbero espresso un’autorità superiore al popolo, titolare del potere di difenderlo,
governarlo, mantenervi l’ordine e la giustizia.
La tesi del Werner ha il merito di mettere in rilievo le affinità esistenti tra le categorie dei duchi,
superando la rigidità della distinzione operata dalla storiografia prevalente.
Per quanto riguarda l’amministrazione della giustizia essi risultano pienamente rispettosi del
sistema tradizionale che affidava loro la guida della corte popolare incaricata di rimuovere gli
ostacoli al funzionamento della giustizia privata e non si trasformarono mai in autorità superiori
abilitate ad imporre ai contendenti la soluzione della vertenza.
Il gradino inferiore a quello dei duchi era occupato dai conti ai quali il re avrebbe affidato la guida
di un distretto ben preciso corrispondente, in origine, alla circoscrizione amministrativa della
civitas romana.
Nelle regioni in cui più forte si conservò la tradizione romana, quelle, cioè, sud-occidentali, quali
la Provenza, l’Aquirania e la Borgogna, il comes di origine imperiale, mantenutosi in vita nel corso
del secolo V, continuò ad operare con funzioni essenzialmente militari.
Il conte veniva nominato dal re e rappresentava il potere di questo.
Il diploma di Childeberto III del 698 o 699, con cui il re riconosceva al vescovo di Le Mans la
possibilità di partecipare all’elezione del conte insieme con i liberi del distretto, non sta ad
attestare il diritto del re alla nomina, ma al contrario, documenta in maniera precisa la scelta
popolare del conte il re infatti, non dichiarava di rinunciare al suo potere di nomina, né si
impegnava a legittimare l’aggiunta del vescovo e del clero al precedente corpo elettorale che era
costituito dai soli libere abitanti del distretto.
L’autorità di duca o di conte conservarono per tutto il periodo merovingio il loro carattere
originario di cariche del popolo-esercito, conoscendo dopo la conquista delle Gallie,
un’evoluzione imposta dalle necessità sociali sopravvenute, non certamente una trasformazione
radicale della loro natura.
La carica regia conservò inalterata la carica militare-popolare.
2 sono gli aspetti dell’autorità regia degni di particolare attenzione:
in primo luogo il potere di “mundeburdium” che i re franchi si arrogarono nei riguardi della
gerarchia ecclesiastica tale potere è stato prevalentemente interpretato come una forma
di mundium, così che il rapporto tra re e Chiesa è stato considerato uguale a quello tra il
capo della famiglia e i membri di questa nell’antico diritto germanico.
Nella storiografia più recente è prevalsa l’idea che il mundeburdio regio sulla chiesa avesse
una forza meno cogente del mundio del padre di famiglia.
E’ rimasta la convinzione che il sovrano godesse di una rilevante autorità nei riguardi della
34
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
gerarchia ecclesiastica, un’autorità in virtù della quale si ingeriva nella scelta di vescovi e
abati, interveniva nei concili e ne influenzava le decisioni, proteggeva, attraverso i propri
agenti, i benefici ecclesiastici.
Tale ampio potere è stato spiegato in base alla precoce conversione dei Franchi, avvenuta sin
dal periodo di Clodoveo nel regno franco la conversione aveva aperto il problema di
armonizzare genti eterogenee in un’unica confessione.
Tale funzione fu assegnata all’autorità germanica che esprimeva l’unità del popolo.
Si spiegano così i numerosi accenni nelle fonti che presentano il re come “minister” della
Chiesa giustificazione del suo ruolo nella gerarchia del mondo franco.
La Chiesa costituiva un ordinamento in grande espansione che i Franchi vollero coordinare
ed integrare con il loro mondo era quindi esaltato il ruolo del re;
il secondo aspetto dell’autorità regia che conobbe un consistente sviluppo durante il periodo
merovingio è collegato con la gestione del vasto patrimonio fondiario di cui il re divenne
titolare dopo la conquista.
In questo periodo si affermò il potere signorile dei grandi latifondisti tale potere implicava
inoltre l’autorità necessaria per garantire la tutela dei diritti delle comunità del fondo e
quindi l’assunzione da parte del signore dell’onore di amministrare la giustizia.
All’evoluzione in senso signorile dell’ordinamento giuridico il re non rimase estraneo: al
contrario egli acquistò una posizione di spicco nella società franca come principale signore
fondiario del regno Nei confronti dei liberi residenti nelle sue terre, allora, il re assunse la
funzione di garante dell’ordine, della pace, della difesa, della giustizia.
Molte delle sue villae sono testimoniate come centri amministrativi di un’ampia regione di
terre regie, il comes da lui inviato ad amministrare i suoi fondi acquisì il compito di formare
una corte e di amministravi la giustizia, mentre il centenarius, posto a capo della centina di
uomini liberi residenti in quelle stesse terre, assumeva stabilmente il ruolo di giudice
nell’ambito di un distretto minore subordinato al conte.
Nelle sue terre il re, inoltre, riscosse, insieme con le rendite, anche diritti di passo e di
commercio, nonché un’imposta fondiaria di origine romana.
I consiglieri domestici che coadiuvavano il re nella gestione delle sue terre erano due
funzionari che si occupavano delle entrate i cameraii sotto la guida di un thesauraruiu o
cubicularius, e da quelle che redigevano gli atti del re, gli scrittori cui era preposto il
referendarius.
Il re non si limitata ad amministrare il suo patrimonio per ricavarne rendite regolari, ma seguiva
anche la prassi di utilizzare i suoi beni come mezzo per ricompensare i fedeli per i servizi da loro
svolti in suo favore.
Continue sono le donazioni effettuate dai re a grandi laici ed ecclesiastici di fondi appartenenti al
suo patrimonio: una prassi, questa, che portò ad una sensibile riduzione dei latifondi regi e
indurrà la dinastia carolingia a ricercare una diversa modalità di ricompensa dei fedeli.
La donazione veniva in genere arricchita dall’impegno del re di astenersi dall’inviare sul fondo
propri agenti per amministrare la giustizia o riscuotere somme.
35
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
In altre parole, il re concedeva al beneficiario della sua donazione l’immunità dal potere signorile
che fino ad allora egli stesso aveva esercitato sulle terre in questione e tale prassi risulta esser
seguita anche per quelle concessioni fondiarie temporanee e precarie che i re merovingi usarono
di tanto in tanto.
L’immunità aveva, accanto all’aspetto negativo costituito dal divieto di azione per gli agenti regi,
quello positivo di legittimare il potere signorile del nuovo titolare del fondo.
L’assunzione effettiva del potere merovingio si esprimeva attraverso il suo viaggio nelle villae regie
che serviva a far conoscere il nuovo signore alla comunità li residenti e dava al re l’opportunità di
prendere il primo contato diretto con i problemi delle sue terre.
L’ambito territoriale del viaggio appare strettamente limitato alle sedi principale del suo
patrimonio, così come risultano essere i successivi viaggi del re, i cui itinerari, sebbene non
sempre facilmente ricostruibili, sembrano snodarsi esclusivamente attraverso le villae e i palatia
del fisco ed escludere in genere contri posti al di fuori del patrimonio regio.
Re signore delle sue terre, allora, e non titolare di un potere di derivazione divina che lo poneva al
di sopra del suo popolo.
2.3 L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO GERMANICO ORIGINARIO
All’inizio del secolo VII, durante il regno di Dagoberto, la lista delle cariche cha alcuni studiosi
hanno interpretato come testimonianza dell’esistenza di una precisa gerarchia di uffici dipendenti
dal re, sembra al contrario denunciare in maniera chiara la natura popolare-militare delle dignità
in questione.
Duchi, conte e altre minori autorità continuavano, quindi, ad essere legati ad un sistema
istituzionale e ad un diritto sostanzialmente immutato rispetto al periodo anteriore alla conquista.
Si tratta di un ordinamento che conservava inalterate le caratteristiche precedenti, come
possiamo vedere nella Lex Alamannorum, la Lex Baiuwariorum, la Lex Ripuaria, il Pactus legis
salicae.
La giustizia continuava nella forma privata con la faida e le compositiones, la natura dichiarativa
della sentenza della sentenza della corte popolare, la forte difesa della famiglia e dei suoi beni
incentrata attorno alla figura del pater.
L’evoluzione del diritto continuò ad essere prodotta dalla consuetudine che si confermò fonte
primaria di diritto.
3.IL REGNO LONGOBARDO
3.1 LE ISTITUZIONI DEL POPOLO-ESERCITO NELL’INTERPRETAZIONE DEGLI STUDIOSI
36
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
L’altra grande dominazione germanica nata dalla seconda ondata di invasioni è quella realizzata
dai Longobardi in Italia.
Secondo una gran parte degli studiosi l’ordinamento longobardo d’Italia presenta numerose
analogie con quello franco del periodo merovingio: anche per esso, infatti è stata immaginata
un’evoluzione in senso statualistico simile a quella sostenuta per quest’ultimo.
La differenza tra i due risiede nel fatto che la conquista longobarda non seguì direttamente la
precedente dominazione germanica tra il regno goto e quello longobardo si colloca, infatti, il
periodo della dominazione bizantina d’Italia.
In Italia i Longobardi dovettero accontentarsi di una parte soltanto della penisola, dato che i
Bizantini continuarono a tenere alcune regioni di questa.
La discesa dei Longobardi in Italia, nel 568 o nel 569, apri una nuova fase nella storia della
penisola questa aveva continuato fino ad allora a far parte dell’Impero direttamente, o
indirettamente attraverso un popolo germanico che governava in nome di Bisanzio.
I Longobardi spezzarono il rapporto con l’impero, occupando la penisola attraverso una dura lotta
contro l’esercito imperiale, rifiutando, a differenza dei Franchi, ogni politica di avvicinamento con
Bisanzio e, tanto più, una legittimazione della conquista da parte di quello, mantenendo per oltre
due secoli uno stato di belligeranza.
L’occupazione longobarda, inoltre dette inizio alla divisione politica della penisola: i Bizantini,
infatti, riuscirono a conservare il controllo della zona ligure (fino al 650) e sull’Adriatico di
un’ampia area intorno a Ravenna che si estendeva a nord fino alla zona lagunare dove sorse
Venezia, nonché delle Pentapoli (Rimini, Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona).
Una striscia che tagliava trasversalmente la penisola univa, poi, il territorio bizantino sull’Adriatico
a Roma, attraversando un’ampia zona delle attuali Marche e Umbria; a sud di Roma rimasero in
mano imperiale una fascia tirrenica che arrivava a Gaeta, la zona intorno a Napoli e la costa
intorno ad Amalfi, e infine, l’attuale Calabria e la penisola salentina, entrambe con confini spesso
mutevoli.
Nelle rimanenti regioni della penisola si insediarono i Longobardi dando vita ad un ordinamento
profondamente diverso da quello dell’età precedente.
L’assetto organizzativo dei Longobardi all’indomani della conquista può essere analizzato sotto
due diversi indirizzi:
il primo sostiene una precoce trasformazione del carattere popolare dell’ordinamento
originario e la rapida affermazione di una sfera di potestà pubblica impersonata dal re, dai
duchi e dai loro funzionari;
il secondo, invece, ritiene che in questa prima fase l’organizzazione longobarda mantenne i
caratteri della tradizione, caratteri che si erano consolidati nel corso del temporaneo
soggiorno in Pannonia, e che, di conseguenza, re duchi, centenari (o sculdasci) decani ecc.
conservavano la loro natura di cariche meramente militari, mentre la giustizia continuava ad
essere privata: e il rispetto della tradizione sarebbe confermato dall’esclusione dei Romani che
37
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
dell’esercito non facevano parte, dalla titolarità di diritti politici o addirittura, dalla privazione
da quelli subita della capacità giuridica.
Il dibattito storiografico non ha riguardato solo l’impostazione generale, ma ha toccato anche la
natura di singole istituzioni ed il significato di alcuni termini rinvenibili nelle fonti si discute sul
termine “fara”, l’unità in cui, secondo le fonti, i Longobardi erano articolati al momento dell’arrivo
nella penisola.
La storiografia più antica la considerava una comunità plurifamiliare corrispondente alla “Sippe”,
mentre l’interpretazione prevalente la vede come un’unità militare, tenuta insieme da vincoli
familiari, la quale, al momento della divisione del territorio conquistato, sarebbe stata la
destinataria delle quote fondiarie in cui era diviso il bottino.
La tesi è stata messa in dubbio dallo Jarnut, che contesta il legame tra “fara” ed esercito e
considera la prima un’unità popolare comprendente non solo uomini in armi, ma anche coloro
che non facevano parte dell’esercito, come le donne, i bambini, i vecchi e gli schiavi il gruppo
aveva il fine di mantenere la pace e l’armonia tra le famiglie che lo componevano e di garantire il
vettovagliamento delle persone e degli animali durante gli spostamenti.
Opposta alla tesi di Jarnut, Murray ha sottolineato come non solo le fonti longobarde, ma anche
quelle franche e burgunde attestino l’esistenza della fara quale raggruppamento di natura
militare, cui sarebbe completamente estraneo ogni carattere familiare.
Qualunque sia il significato della “fara”, è certo che la sede in cui si stanziò, in via temporanea o
definitiva, viene indicata con il termine di “sala”.
Gli storici concordano nel ritenere che il termine “arimanno” designi l’uomo libero:
Secondo alcuni si tratta del libero che faceva parte dell’esercito, l’exercitalis, titolare della
pienezza dei diritti politici e civili;
per altri, invece, il termine indicherebbe una categoria particolare di liberi, quelli che
componevano il seguito e che vennero fatti insediare nelle terre fiscali di cui il re divenne
titolare, di modo che l’altro termine arimannia esprimerebbe la colonia di liberi stanziati
nelle terre regie;
secondo una terza interpretazione il termine arimanno sarebbe apparso per la prima volta
nel corso del secolo VIII per designare l’uomo libero al di là di ogni collegamento con
l’esercito e, di conseguenza, attesterebbe una fase di evoluzione della società longobarda,
una fase in cui la pienezza dei diritti non era più fatta dipendere dalla capacità alle armi;
per altri infine, gli arimanni avrebbero costituito una superiore categoria di liberi che si
sarebbe affermata nel secolo VII in rapporto con l’evoluzione signorile conosciuta dalla
società longobarda in quel periodo.
Altra istituzione longobarda sulla cui natura la storiografia ha a lungo discusso è il ducato.
Il ducato era l’unità principale in cui si articolava la società longobardo in Italia.
38
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
L’istituzione ducale longobarda è stata interpretata in due modi principali:
secondo alcuni autori i ducati nacquero dallo stanziamento dell’unità militare-popolare che si
raccoglieva intorno al duca e quindi sarebbero eredi diretti dell’istituzione germanica;
per altri, invece furono istituiti dai Longobardi sul modello dell’organizzazione imperiale
romano bizantina e costituiscono pertanto una novità per il modello germanico.
Le due interpretazioni vennero sostanzialmente conciliate da Bagnetti, secondo il quale il
modello bizantino si innestò su una tradizione germanica evidente nel ruolo della fara come
componente essenziale dell’unità militare e nel contempo sociale del ducato.
Più di recente la natura popolare di tale autorità è stata negata dal Gasparri, il quale ha
sostenuto che sin dalla sua apparizione il duca longobardo era un Amtsherzog, era cioè il titolare
di un edificio regio ed operava perciò per conto e in nome del re, ed esercitava poteri ed autorità
che solo a quello spettavano.
Il dibattito storico riguarda anche le cariche militari minori, cioè:
quella dello “sculdascio” centenario degli altri popoli germanici;
quella del “decano”.
Maggior accordo tra gli studiosi si rinviene nella fase del dominio longobardo successiva al primo
stanziamento prevale l’opinione per cui a partire dalla fine del VI secolo l’ordinamento avrebbe
conosciuto una sensibile evoluzione verso forme istituzionali analoghe a quelle proposte da
modello romano-bizantino, nelle quali il fulcro del sistema sarebbe stato il re.
L’inizio di tale processo non è fissato con precisione esso comunque presuppone il recupero
delle terre fiscali da parte del re, avvenuto nel 584 contemporaneamente alla restaurazione della
dignità monarchica dopo il decennio di anarchia succeduto alla morte del re Clefi.
Il re allora provvide ad una migliore amministrazione del suo vasto patrimonio, istituendo la
magistratura del gestaldo, che era inviato nelle varie parti del regno per curare la gestione delle
curtes regie.
All’interno dei singoli ducati allora si trovarono ad operare due diverse dignità, quella del gastaldo
che agiva a nome del re, quella dello sculdascio che si andava trasformando in ufficiale del duca.
Il sovrano era titolare del potere di protezione dei minori, degli orfani e delle donne rimaste prive
di un uomo che esercitasse nei loro confronti la tutela del mundio; il re assumeva anche il
compito di difendere la pace sociale e l’ordine interno, nonché l’altro di garantire a tutti i liberi la
tutela dei loro diritti.
L’Editto di Rotari fu la prima compilazione scritta delle consuetudini longobarde (avvenuta nel
643).
Il re, a partire dalla fine del secolo, avrebbe dato vita ad una ramificata rete di magistrature
provinciali che avevano il loro punto principale nel gastaldo: questi infatti, oltre ad amministrare il
39
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
patrimonio regio, avrebbe anche svolto il compito di esercitare in provincia le potestà
giurisdizionale del re, nonché l’altro di rappresentarvi il supremo potere monarchico.
Il gastaldo avrebbe anche avuto la funzione di controllo nei riguardi del duca e delle altre
magistrature da lui dipendenti e, in alcuni casi, avrebbe sostituito completamente l’autorità
ducale esercitando in nome e per conto del re i poteri che spettavano al duca.
Sotto Liutprando il regno sarebbe stato diviso in circoscrizioni territoriali delle iudiciariae,
all’interno delle quali l’amministrazione della giustizia sarebbe stata compito esclusivo di un
giudice regio, circoscrizioni a loro volta suddivise in distretti territoriali minori affidati a giudici di
rango inferiore, gli sculdasci.
Al centro poi il governo regio sarebbe stato incentrato nel palatium di Pavia, sede del supremo
organo giudicante del regno e del consiglio che coadiuvava il monarca nell’amministrazione del
suo popolo: e la stabilità del governo regio, la fissazione della sua sede in una città e in un preciso
palazzo distinguerebbe nettamente la monarchia longobarda da quelle, itineranti, degli altri regni
germanici.
La seconda fase della dominazione longobarda, allora si sarebbe caratterizzata per un profondo
mutamento dell’ordinamento originario.
In analogia con quanto sarebbe avvenuto per il regno franco, il diritto della tradizione popolare-
militare sarebbe stato sostituito da un altro nel quale precisa era la separazione tra la sfera
dell’autorità pubblica, rappresentata da re, duchi e loro funzionari, e quella dei rapporti
intersoggettivi, mentre l’elemento di coesione tra i soggetti dell’ordinamento non era costituito
più dall’appartenenza alla medesima etnia e dalla partecipazione all’organizzazione militare, bensì
dalla soggezione alla medesima potestà pubblica, rappresentata in primo luogo dal re.
Espressione precipua di tale cambiamento sarebbe stato il nuovo significato della legge:
manifestazione della superiore autorità del sovrano, interprete esclusivo della volontà divina.
3.2 LA TESTIMONIANZA DELLE FONTI GIURIDICHE
Le fonti giuridiche concordano nel testimoniare la continuità per l’intero periodo longobardo dei
tradizionali meccanismi della giustizia privata, articolati nella faida, nella compositiones e
nell’intervento dichiarativo delle corti popolari.
Concordano, altresì, nell’indicare l’attività della gairenthix, l’assemblea degli uomini liberi in armi
che decideva su vertenze insorte tra liberi, introduceva nuove norme vincolanti per tutta la
comunità, adottava delibere generali di interesse comune.
Concordano, infine, nel denunciare la vigenza costante degli antichi usi popolari e una loro
significativa evoluzione nel corso del tempo.
Fonte principale per l’analisi delle consuetudini longobarde è L’EDICTUM REGUM
LONGOBARDUM, l’Editto dei re Longobardi.
40
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Esso risulta composto da un nucleo iniziale costituito dall’Editto di Rotari, nel quale vennero per la
prima volta stesi per iscritto gli usi tradizionali fino ad allora tramandati oralmente e osservati
nella prassi.
A questo nucleo si aggiungono altre norme introdotte dall’assemblea popolare durante i regni di
Grimoaldo, Liutprando, Rachi e Astolfo.
Nel suo insieme l’editto longobardo raccoglie norme approvate dalla gairenthix nell’arco di oltre
un secolo.
Nel corso di questo lungo periodo si ebbe una certa evoluzione del diritto longobardo: in
particolare, l’influenza del diritto romano, che al tempo di Rotari era marginale e può essere
riscontrata in poche consuetudini, si accentuò.
Ad esempio sotto Grimoaldo risulta recepito dal diritto longobardo l’istituto romano della
rappresentanza. Liutprando riconobbe formalmente l’uso del diritto romano: nel capitolo 91 de
scribis del 727 dispose, infatti, che i contraenti potevano rivolgersi ad uno scriba per la redazione
di una cartula negoziale, ma precisava che quest’ultima poteva essere compilata soltanto secondo
le due leggi personali prevalenti nel regno, quella longobarda, cioè e quella romana, ed
aggiungeva che ciascuno dei contraenti era legittimato a <subdiscendere de lege sua> accettando
che il negozio fosse disciplinato dal diritto della controparte.
Il capitolo 127 di Liutprando prescrisse che la donna longobarda, sposando un romano, assumeva
la legge personale del marito; il capitolo 153 che il longobardo divenuto chierico prendeva la
legge romana.
Fu significativo l’intervento della Chiesa sulle consuetudini longobarde tale influenza si coglie
nell’ambito del matrimonio e della famiglia.
Nel matrimonio originario la donna longobarda, essendo incapace d’agire, interveniva quasi
come un oggetto il padre, o il fratello, titolare del mundio su di lei, la prometteva ad altro
soggetto e successivamente gliela consegnava con l’atto formale della traditio con cui trasferiva il
mundio al marito.
La Chiesa, che predicava la sacralità del matrimonio germanico, riuscì ad introdurre tra i due
momenti in cui il matrimonio germanico si articolava un terzo atto formale, la subharratio cum
anulo, nel quale la moglie agiva come soggetto di diritto, esprimendo il proprio consenso al
matrimonio attraverso la presa dell’anello, simbolo della fedeltà.
Nell’ambito del diritto di famiglia poi la Chiesa ottenne una decisa tutela dei figli nati dal
matrimonio legittimo: il capitolo 32,33 e 34 di Liutprando, infatti, esclusero dalla successione
paterna i figli frutto di nozze illecite.
Inoltre, la Chiesa riuscì ad infrangere il principio rigoroso della tradizione longobarda che
ammetteva come unica successione quella legittima, escludendo ogni forma di testamento.
Infine, ampio riconoscimento venne offerto da Liutprando ai privilegi del clero.
A fondamento del diritto vigente nel regno rimase il principio della personalità, ovvero quel
principio per cui il soggetto di diritto rispettava le norme dell’ordine o della natio alla quale
41
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
apparteneva lo dimostra la prassi delle professiones iuris con cui le parti sceglievano quale
diritto applicare al “negozio giuridico”.
L’amministrazione della giustizia rimase affidata ai tradizionali meccanismi della faida, delle
compositiones e dell’intervento dichiarativo delle corti popolari i giudici, per l’intero periodo
longobardo, continuarono ad intervenire al solo fine di rimuovere gli ostacoli che si frapponevano
al funzionamento della giustizia privata: il processo, quindi, continuò a fondarsi sull’espletamento
della prova di Dio (ordalia e duello giudiziario), che designava il vincitore e il perdente.
Per quanto riguarda i principali istituti longobardistici, la storiografia è concorde nel sottolineare
la sostanziale continuità della tradizione ordinaria:
il diritto di famiglia si fondò sempre sull’autorità del paterfamilias e il suo potere di mundio;
il matrimonio venne appena toccato dalla formalità della sbharratio cum anulo e conservò
nella traditio della moglie il suo atto costitutivo;
il diritto dell’uomo sulle cose mantenne la forma antica della Gewere che proteggeva il mero
rapporto materiale, senza dar spazio alcuno all’animus con cui i soggetti possedevano il
passaggio di un bene avveniva attraverso la materiale presa di possesso da parte del nuovo
titolare, la cosiddetta investitura.
Per ciò che riguarda le assunzioni di obbligazioni rimase in vigore e trovò ampia diffusione l’atto
contrattuale tipico della tradizione longobarda, la wadiatio, con la quale il debitore cedeva al
creditore le sue armi al fine di rendere a tutti noto ed evidente che nei confronti di quello egli
rinunciava alla propria difesa (in seguito sostituito con la festuca, un bastone di legno).
3.3 LE DUE FASI DEL DOMINIO LONGOBARDO
Per quanto riguarda il modo in cui si realizzò la conquista longobarda della penisola si deve tener
presente che l’esercito germanico non era composto solo da uomini agli ordini diretti di Alboino,
ma anche da altri gruppi che, guidati da capi minori, seguirono itinerari diversi dal grosso delle
truppe.
Dall’altra parte, proprio la fase iniziale del dominio longobardo coincide con una profonda crisi
della guida regia: Alboino, infatti, venne ucciso nel 572 quando ancora era in corso la lotta contro
i Bizantini e il suo successore Clefi, fu assassinato due anni dopo, quando la conquista aveva fatto
pochi progressi.
Per dieci anni a partire da quel momento i Longobardi non procedettero all’elezione del nuovo re:
il che significa che un periodo di grande espansione della conquista coincide con l’assenza di una
guida unitaria dell’esercito e con una divisione delle terre che non prevedeva la quota del re.
42
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
In questa fase l’insediamento dei conquistatori si realizzò attraverso lo stanziamento delle “fare”
in località strategiche dal punto di vista militare ed economico, città, castelli, nodi stradale e
mediante l’assegnazione ai duchi delle terre fiscali.
Il re dunque aveva poteri esclusivamente militari, come era nella tradizione, e tali poteri erano
meno rilevanti di quanto si rinvenga in alti popoli coevi, dato che la sua guida unitaria non rivestì
un ruolo particolarmente significativo ai fini della conquista.
La natura militare della carica regia risulta altresì confermata dalla motivazione in base alla quale
nel 584 i duchi ne decisero la restaurazione: di fronte ai contrasti con i franchi, che si venivano alla
lotta contro i Bizantini, essi videro nella ricostruzione dell’autorità unitaria del re il mezzo più
adeguato per coordinare la difesa delle terre conquistate e promuovere l’espansione.
La restaurazione della dignità regia, peraltro, è interessante anche per un secondo motivo: essa fu
accompagnata dall’assegnazione al re di una quota dei beni fiscali fino ad allora posseduti dai
soli duchi.
Per quanto riguarda gli sculdasci, alcuni storici ritengono che essi sarebbero diventati funzionari
del duca.
Natura pubblica avrebbe avuto anche il gastaldo, il quale, però, non era un funzionario ducale,
bensì un agente del re.
Appare preferibile pensare che il popolo seguisse nello stanziamento i moduli della sua
organizzazione militare, con le singole fare sistemate nell’area circostante i capi dei contingenti e
questi stabiliti in località da cui era facilmente accessibile la località in cui il duca aveva collocato
la sua residenza principale.
Dalle testimonianze in nostro possesso sappiamo che:
i duchi si stabilirono in genere nelle grandi civitates romane;
mentre i capi militari minori (come gli sculdasci) si stanziarono sia in città più piccole e in
castra vicini alla città del duca, sia in centri strategicamente importanti questi sono quindi
autorità della tradizionale organizzazione militare di nomina popolare che continuarono a
svolgere il loro ruolo di coordinamento degli armati che componevano il loro
raggruppamento le loro funzioni sono del tutto estranee alla gestione dei patrimoni di cui
i duchi si erano impossessati.
La fase di assestamento del popolo longobardo in Italia fu seguita dal lungo periodo in cui il suo
dominio si consolidò e divenne definitivo: a questo secondo momento, la storiografia attribuisce,
in maniera pressoché concorde, una profonda trasformazione dell’ordinamento.
L’Editto di Rotari chiarì in maniera precisa gli usi che dovevano essere considerati vigenti presso il
popolo longobardo.
L’Editto di Rotari attesta la continuità dei meccanismi tradizionali della giustizia privata e della
funzione dichiarativa delle corti popolari.
In realtà sulla metà del secolo VII la società longobarda cominciava a vivere un cambiamento
profondo rispetto ai primi anni della conquista italiana, un cambiamento dovuto non solo al
43
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
passaggio da comunità migratoria a società stanziale, ma anche all’evoluzione progressiva della
produzione rurale verso forme di economia chiusa.
L’organizzazione dell’azienda curtense si andava affiancando a quella dell’antico popolo esercito.
I grandi possessori fondiari cominciavano ad imporsi come autorità superiori ai liberi che non
aveva precedenti nella tradizione del popolo germanico ora tra i maggiori possessori fondiari si
trovavano proprio i re e i duchi.
Ed è questa evoluzione, non già la trasformazione dell’ordinamento popolare in ordinamento
regiocentrico, che costituisce la caratteristica saliente della seconda fase del governo longobardo.
Nel corso di questo secondo periodo il re accrebbe la sua personale autorità signorile,
migliorando gli strumenti di gestione patrimoniale e di acquisizione delle rendite.
Lo stesso fecero i duchi nei loro patrimoni, al pari di tutti gli altri grandi possessori fondiari.
Sembra legittimo ritenere che anche nella fase matura del dominio longobardo gli sculdasci
abbiano conservato la loro tradizionale natura di autorità popolari, senza trasformarsi in agenti
ducali: lo stanno a dimostrare sia la loro costante inclusione tra i giudici che componevano le corti
popolari, sia la sopravvivenza della carica nei territori nei quali, tra la fine del secolo VII e il secolo
successivo, venne eliminata l’autorità ducale.
Se ciò è vero, gli sculdasci rappresentavano la forma tradizionale di giustizia e di autorità, quella
che riguardava tutti gli uomini liberi della comunità germanica e le metteva tutti sullo stesso
piano.
La signoria curtense, invece, modificò profondamente la parità giuridica dei soggetti e dette vita
a nuovi diritti e a nuovi meccanismi di giustizia è allora possibile che i liberi residenti nelle
curtes regie vantassero protezione e tutela da parte delle corti popolari degli sculdasci, ma allo
stesso tempo fossero tenuti dai nuovi obblighi assunti nei riguardi del re loro signore curtense a
riconoscere l’autorità dei gastaldi, i quali non si limitavano a gestire il patrimonio del monarca, ma
ne esercitavano anche le potestà di comando e di giustizia.
L’aumento progressivo della potestà signorile regia spiega anche la formazione di un’articolata
organizzazione di palazzo Il re, nella sua duplice natura di capo unitario del popolo esercito e di
titolare di un vasto patrimonio, era coadiuvato sia da fedeli che componevano la sua corte di
giustizia, sia da ufficiali domestici.
La ristrutturazione del palatium di Pavia sembra essere stata sollecitata dalla necessità di
realizzare una forma più funzionale di organizzazione domestica la nuova struttura palatina
consentì un’adeguata guida della giustizia signorile che spettava al re nelle sue terre e che era
localmente esercitata dai suoi agenti patrimoniali; consentì anche al re di far funzionare con
maggior efficienza la corte di giustizia popolare che si riuniva intorno a lui.
Quindi, il palazzo di Pavia fu riorganizzato per rispondere alla necessità della gestione del
patrimonio e si occupò anche di giustizia.
44
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
La crescente importanza del patrimonio fondiario ai fini della posizione sociale e del prestigio
personale spiega, infine, anche la costante azione dei re longobardi diretta ad imporre il principio
dinastico nella successione al trono, eliminando la norma tradizionale della successione elettiva.
E’ preferibile pensare che i titolari della corona cercassero di trasmettere quest’ultima ai loro
eredi soprattutto perché con quella sarebbero passati i numerosi fondi, che costituivano il
patrimonio fiscale.
Anche la persistenza del metodo elettivo nella scelta del re sembra da collocare all’importanza del
patrimonio della corona: la vastità di quest’ultimo poteva essere accettata senza alterare gli
equilibri sociali solo se la sua titolarità era limitata alla durata della vita umana e non era
assegnata, in maniera stabile, ad una delle grandi famiglie.
Una conferma dello stretto legame tra l’importanza della carica regia e il possesso di un ricco
dominio fondiario si puo’ rinvenire nell’assoluta mancanza di significato dell’autorità monarchica
nei ducati di Benevento e di Spoleto qui la principale autorità militare era il duca, titolare
esclusivo del patrimonio fiscale e l’evoluzione signorile ricordata in riferimento al re longobardo si
svolse solo in relazione al duca.
La gestione delle sue curtes venne svolta da gastaldi e da altri agenti ducali, mentre gli sculdasci
(tradizionali autorità popolari) continuavano ad esprimere il sistema consuetudinario germanico.
L’intero sviluppo dell’ordinamento istituzionale si realizzò al di fuori della presenza del re.
Il re longobardo, nella fase matura del dominio in Italia, conobbe una sensibile crescita della
propria potestà signorile fondiaria.
Fino al termine del dominio longobardo, la giustizia conservò il tradizionale carattere privato e le
corti popolari continuarono ad operare trovando come antagonista la nuova giustizia signorile
degli ordinamenti curtensi.
Le attribuzioni nuove acquisite dal re nel campo della giustizia sembrano limitarsi alla tutela di
orfani, minori e vedove.
Le vertenze erano risolte in virtù del duello giudiziario, di modo che, ove fossero rimasti da soli,
orfani, vedove avrebbero finito per soccombere facilmente alle pretese di adulti abili alle armi
il re si assunse, allora, l’onere di assicurare loro un campione che li difendesse nel corso del
giudizio, combattendo in loro vece il duello giudiziario.
L’idea esposta della mancata acquisizione da parte del re di rilevanti potestà unitarie si scontra
con l’opinione, condivisa da molti, secondo la quale sotto Liutprando la monarchia longobarda
sarebbe pervenuta ad un’attenta elaborazione di una concezione teocratica del potere.
Liutprando, primo re cattolico legislatore, proprio nei proemi delle sue leggi proclamò che
l’azione del re era guidata direttamente dalla volontà divina e che egli si accingeva a far
approvare le nuove norme in quanto <divinitus > ispirato.
Non si può affermare che con Liutprando il re si fece legislatore.
45
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Il testo dell’Editto è in proposito chiaro: il re prendeva l’iniziativa di convocare l’assemblea
popolare e di proporre il testo delle nuove norme; ma queste erano approvate dal re < cum
omnibus iudicibus…. cum reliquid fedelibus meis Langobardis et cuncto populo> erano deliberate
dal re <cum inlustribus veris obtimatibus… vel universis nobilibus Langobardis> o <una cum
iudicibus et reliquis Langobardis fidelibus nostris>.
Erano sempre la gairenthix, l’assemblea popolare della tradizione, ad approvare le nuove norme
l’autorità regia, allora non sostituì mai l’assemblea popolare, limitandosi a svolgere quel ruolo
di iniziativa e di coordinamento che aveva avuto anche in passato, come attesta con ogni evidenza
la stesura delle antiche consuetudini sotto Rotari.
Le norme approvate dall’assemblea popolare integravano solo parzialmente il diritto
quest’ultimo continuava ad evolversi essenzialmente attraverso la consuetudine, l’uso continuato
e generalizzato di comportamenti che venivano sollecitati dall’evoluzione della società, dalle
nuove esigenze della vita.
Dobbiamo concludere che anche nella fase più matura del dominio in Italia, l’ordinamento
longobardo conservò la sua natura tradizionale di ordinamento popolare-militare.
3.4 LA POPOLAZIONE ROMANA E LA CHIESA
Per un lungo periodo, tra la seconda metà del secolo VI e la prima metà del successivo, i Romani,
in quanto estranei al popolo-esercito longobardo, non rivestirono mai cariche importanti, come
quelle di duca, sculdascio, giudice o decano.
La mancanza di quelli che alcuni autori definiscono “diritti politici”, tuttavia, non implicò per i
Romani la perdita della capacità giuridica: in virtù del principio della personalità del diritto, essi
continuarono ad avvalersi delle loro norme.
La parità di condizioni giuridica tra i romani e i Longobardi si realizzò solo quando anche i primi
entrarono a far parte dell’esercito.
I Longobardi, a differenza di quanto avevano fatto gli Ostrogoti, non tennero in vita le precedenti
magistrature romane, di modo che l’applicazione del principio di personalità del diritto non si
espresse attraverso un duplice apparato giudiziario, uno per la popolazione, vinta l’altro per i
conquistatori.
Il sistema attraverso cui era garantito il rispetto delle norme di diritto romano che si mantenevano
in vita era assicurato con gli stessi sistemi popolari con cui era garantito quello delle consuetudini
longobarde e quindi attraverso meccanismi basati in larga misura sulla giustizia privata, faida e
composizione e sull’intervento marginale, e comunque dichiarativo, di corti giudicanti guidate da
autorità militari longobarde.
Il diritto romano in tanto rimaneva in vigore in quanto aveva assunto natura di diritto
consuetudinario di una popolazione ed era riuscito ad inserirsi in un sistema giudiziario
completamente diverso da quello in cui era nato.
46
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Quando i romani entrarono a far parte del popolo-esercito e poterono accedere alle magistrature
di questo, più facile dovette diventare l’azione diretta all’applicazione delle consuetudini romane;
ma nel periodo precedente questa azione dovette restare affidata alle strutture istituzionali di un
ordinamento cui i Romani rimanevano estranei e, soprattutto nelle vertenze tra Romani e
Longobardi, non dovette offrire soddisfacente tutela.
Infine, anche nel periodo nel quale non era stata riconosciuta la parità tra i due gruppi etnici, le
condizioni economiche dei Romani non erano per tutti negative lo dimostra la circostanza che
nel periodo successivo non erano poche le famiglie di origine romana che facevano parte del
gruppo socialmente più elevato e dominante.
Per quanto riguarda la situazione della Chiesa cattolica, essa conobbe una profonda crisi in
seguito alla conquista longobarda.
La grave crisi non portò all’abolizione delle strutture istituzionali della Chiesa: dopo i primi difficili
anni il clero cominciò a svolgere un’efficace azione missionaria diretta a convertire al cattolicesimo
le famiglie più importanti della popolazione longobarda.
Un’azione, questa, che dovette dare ben presto frutti consistenti se il re Autari era costretto ad
adottare provvedimenti volti a proibire il battesimo dei bambini longobardi, nel tentativo di
difendere la tradizione ariana del popolo.
L’opposizione degli ariani non riuscì a frenare il processo di conversione al cattolicesimo che
coinvolse non soltanto importanti capi militari e influenti famiglie, ma anche la stessa corte
regia a partire dagli ultimi anni del secolo VI quando Agilulfo sposò la cattolica Teodolinda.
La conversione di personaggi potenti e ricchi favorì da un canto la ricostituzione dei patrimoni
ecclesiastici, grazie alle generose donazioni disposte in favore non solo delle diocesi ma anche dei
monasteri che si andavano diffondendo nelle regioni longobarde, dall’altro accrebbe l’influenza e
il prestigio del clero nel regno.
La conversione ufficiale dei Longobardi, infine, ebbe la conseguenza immediata di dare inizio
alla restaurazione delle strutture gerarchiche cattoliche: nella seconda metà del secolo VII molte
diocesi soppresse tornarono in vita, mentre furono ricoperte da titolari quelle che ne erano
rimaste prive.
Più accentuata si era fatta l’autorità del pontefice romano nel mondo cattolico occidentale e la
sua influenza politica in Italia.
La riorganizzazione ecclesiastica nel regno longobardo, allora, si realizzò in continuo rapporto col
papato, grazie all’interesse congiunto del clero e dei capi longobardi di instaurare buoni rapporti
con quello.
D’altra parte era profondamente mutata la classe dominante rispetto al periodo bizantino la
grande proprietà era nelle mani del nuovo ceto di capi militari longobardi.
La tradizionale simbiosi tra alto clero e ceto dominante si realizzò con le famiglie dei maggiorenti
longobardi.
47
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
4. I REGNI ANGLOSASSONI
Sin dalla metà del secolo V la Britannia venne invasa da popolazioni Sassoni, dando vita ad unità
istituzionali che la storiografia designa correttamente con il termine di regni anglo- sassoni.
Gli storici distinguono due fasi principali nel lungo periodo della dominazione sassone,
individuando nella morte di re Alfredo nel 899 il momento di cesura:
nella prima si formarono ben presto tre diversi regni, quello di Northumbria a nord, quello di
Mercia nella zona centrale e quello di Wessex ad occidente: i rapporti tra queste unità furono
spesso conflittuali e si caratterizzarono per la frequente prevalenza sugli altri del regno di
Wessex.
Nella prima metà del secolo IX l’isola cominciò a subire le invasioni di popoli scandinavi: nella
seconda metà del secolo i Sassoni trovarono nel re del Wessex Alfredo la guida militare
capace di organizzare un’efficace difesa del territorio e di respingere gli invasori.
Alla sua morte venne restaurata la separazione tra i tre regni, ma la prevalenza dei Sassoni
occidentali si conservò e si espresso soprattutto nei momenti di maggior pericolo di
invasione scandinava, quando il re del Wessex unificò sotto la propria guida anche gli eserciti
degli altri regni;
Nel corso del secolo X l’Inghilterra si trovò unificata sotto i discendenti di Alfredo.
Ma ciò non impedì agli Scandinavi di stanziarsi sulle coste inglesi e di tentare la conquista
dell’intero territorio in mano sassone: all’inizio del secolo XI essi conseguirono tale obiettivo
sotto la guida di Canuto che riunì in un solo regno Inghilterra, Danimarca e Norvegia.
Alla morte di Canuto, tuttavia, il regno sassone riacquistò la sua individualità sotto la guida di
Edoardo il Confessore, alla cui morte nel 1066 si aprì la questione ereditaria che spianò la
strada all’invasione normanna dell’isola.
Per quanto riguarda la prima fase della dominazione sassone l’insediamento ebbe luogo
secondo gli schemi dell’articolazione del popolo-esercito.
Unità fondamentale di questo era la contea (shire) composta da un ampio numero di uomini
liberi: costoro si stanziarono nella medesima area, dando vita ad una unità aggregativa che
corrispondeva anche ad un preciso territorio.
La contea era dotata di una corte popolare che interveniva nelle liti con funzione dichiarativa.
Gli uomini liberi godevano di diritti sostanzialmente uguali tuttavia al loro interno si andò
delineando una scala gerarchica che privilegiava i guerrieri più valorosi (gesith), godevano di
rilevante prestigio sociale e si erano impossessati, al momento della conquista, di vasti patrimoni
fondiari, gli ealdormen erano i guerrieri più vicini al re.
Il termine “ehegn” designava gli uomini liberi che erano al servizio di uno dei capi, gesith o
ealdorman che fosse o del re.
48
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
L’assemblea popolare dei sassoni (weitenagemot) si riuniva per le decisioni più importanti
riguardanti l’intera collettività.
Tradizionalmente limitata alla guida militare unitaria del popolo rimase, infine l’autorità del re, cui
spettava anche la presidenza della corte di giustizia popolare competente per tutta la comunità.
Una parte consistente degli usi tradizionali in vigore nel Wessex e in Mercia sono le Leggi di
Alfredo.
Le fonti del secolo X attestano in particolare l’esistenza di una suddivisione della shire,
designata nelle regioni meridionali con il termine di hundred e in quelle settentrionali con l’altro
di wapentake, le cui origini rimangono oscure.
Tale suddivisione svolgeva due funzioni prevalenti:
da un canto costituiva il distretto per l’esazione di tributi generali gravanti sull’intera
popolazione;
dall’altro era la sede di una corte di giustizia che, date le minori dimensioni del distretto,
poteva riunirsi con maggior frequenza rispetto a quella della contea.
A partire dal secolo X si estese a tutto il territorio un’imposta particolare, detta danegeld, che
colpiva tutti i signori fondiari in ragione dell’espansione dei loro domini e serviva a organizzare la
difesa del territorio contro le incursioni scandinave, in particolare danesi.
La cosiddetta hundred ordinance assegnava alle corti di centina la competenza sui reati di furto.
In alcune regioni le hundreds vennero ulteriormente suddivise in circoscrizioni minori, dette
tithing, sulle quali, peraltro, mancano precise notizie.
La stessa corte del re conservò il suo tradizionale carattere popolare.
Anche l’Inghilterra visse in maniera diffusa il fenomeno della signoria fondiaria curtense e l’altro
successivo e complesso della signoria territoriale molti dei principali capi militari, ghesiths e
ealdormen, titolari di vasti patrimoni, si trasformarono in signori fondiari, acquisendo nei
confronti delle comunità delle loro terre autorità di comando e potestà giurisdizionale-signorile.
L’evoluzione in senso signorile coinvolse naturalmente anche il re che era titolare di un
patrimonio esteso e diffuso in tutte le regioni del regno meglio degli altri signori e capi
militari il re sembra esser riuscito a organizzare gli uffici della sua casa (household), mediante i
quali provvedeva alla gestione patrimoniale, dando vita anche ad un primordiale ufficio di
cancelleria.
L’accresciuta autorità unitaria del re sollecitata dal bisogno di una guida omogenea del popolo-
esercito, dovette trovare l’indispensabile supporto concreto nella superiorità economica del re
medesimo rispetto agli altri capi e agli altri signori.
5. LA SIGNORIA FONDIARIA
49
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
La signoria fondiaria nacque da una forma di organizzazione produttiva rurale inedita, nella
quale i rapporti tra signore e i coltivatori della terra erano disciplinati da norme diverse da quelle
che regolavano gli stessi rapporti nei tradizionali sistemi di produzione.
L’azienda curtense prevedeva, infatti, la divisione del fondo in due parti distinte:
la pars domenica posta sotto il diretto ed esclusivo controllo del titolare del fondo;
il massaricium area divisa in varie unità rurali, detti mansi, assegnate a coltivatori, liberi e
non liberi; in genere ogni manso era di dimensioni tali da consentire il mantenimento di un
nucleo familiare.
I contadini che ricevevano il manso lavoravano liberamente la terra, ma avevano il diritto di
appropriarsi solo di una parte del prodotto ottenuto: il resto doveva essere consegnato al
proprietario.
Inoltre essi erano tenuti a prestare la loro opera (corvées) per un certo numero di giorni a
settimana per la coltivazione della pars domenica, il cui prodotto, spettava per intero al
proprietario.
I possessori dei mansi erano tenuti ad utilizzare per la trasformazione del loro prodotto soltanto i
servizi che erano forniti dal loro signore: pertanto il mulino, il frantoio, il forno utilizzabili erano
soltanto quelli del padrone.
Questi ultimi avevano la possibilità di usufruire anche ai fini della produzione del loro
appezzamento fondiario, di pascoli e di foreste che rientravano nella riserva domenicale.
I contadini possessori dei mansi, non solo non potevano appropriarsi dell’intero prodotto dei
loro campi, ma erano anche tenuti a prestare al signore servizi personali senza compenso.
Allo stesso tempo, esso assegnava al dominus tutta l’autorità necessaria per far funzionare il
complesso meccanismo organizzativo sia nella fase della produzione, si in quella della
distribuzione del prodotto.
Tale potestà viene definita con il termine “banno” corrispondente al nostro comando e
collocava il dominus in una posizione di decisa superiorità sugli altri uomini liberi delle sue
terre: costoro, anche se erano liberi, sottostavano alla sua potestà si veniva a delineare in
questo modo quella dipendenza di uomini liberi da altri uomini liberi che il mondo antico aveva
conosciuto solo in via marginale.
La signoria fondiaria comportava la fine della sostanziale parità di condizioni di cui gli uomini
liberi godevano nell’ordinamento popolare della tradizione germanica.
Come è stato ampiamente dimostrato da Otto Brunner, il signore fondiario e le comunità a lui
sottoposte erano legati da un vincolo sinallagmatico: in cambio della soggezione e
dell’acquisizione di gran parte del prodotto, il signore assicurava a tuti gli abitanti della sua terra
protezione da nemici esterni, da pericoli naturali, tutela dei diritti e pace tra di loro le
consistenti entrate del signore erano giustificate anche dal suo onere di apprestare gli strumenti
necessari alla difesa esterna e alla pace interna.
50
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
La signoria fondiaria comportava necessariamente nel suo titolare il compito di amministrare
la giustizia questo compito costituisce la seconda, consistente, novità dell’ordinamento
curtense.
Si deve, in proposito, tenere a mente che amministrare la giustizia significa applicare il diritto
vigente.
Nel caso dell’azienda curtense tale diritto era costituito in primo luogo dalle consuetudini che
regolavano i rapporti di lavoro e poteva anche implicare la tutela dei diritti garantiti ad ogni
libero dagli usi consuetudinari del popolo.
In questo secondo caso, la corte del signore si sostituiva alla corte dell’antico ordinamento del
popolo-esercito e al contempo alterava la natura stessa della giustizia, dato che amministrarla
diveniva compito personale del signore, un compito affidato alla sua responsabilità e una delle
principali ragioni di esistere della sua potestà signorile, cessando di essere affidata alla
collettività.
La giustizia continuò ad essere privata e a basarsi sulla faida, sulle compositiones e
sull’intervento dichiarativo delle corti.
Accanto alle corti della tradizione popolare si posero le curie signorili, soppiantandole o ad esse
affiancandosi a seconda della realtà affermatasi di fatto nelle singole aziende curtensi.
Il signore esercitava la sua autorità avvalendosi in primo luogo dei familiari e dei servi che con lui
vivevano nella sua casa l’amministrazione domestica si articolò allora in vari uffici
corrispondenti ai principali settori della gestione patrimoniale, ciascuno dei quali era affidato,
almeno tendenzialmente ad un responsabile.
In genere poi il signore inviava nelle sue terre agenti che lo rappresentavano presso le comunità
locali.
Gli agenti domestici del signore non si limitavano ad occuparsi delle entrate di questo, ma ne
esercitavano anche i poteri di guida e di giustizia nei riguardi delle comunità della terra.
L’espressione signoria fondiaria non si rinviene nelle fonti, ma è stata coniata dalla storiografia
per indicare in modo sintetico il nuovo atteggiarsi dei rapporti di soggezione tra libero e libero.
Secondo Henri Pirenne, le forme organizzative dell’economia curtense erano nate dalla crisi dei
traffici commerciali nel Mediterraneo, crisi prodotta dall’espansione araba.
A suo parere gli inizi della signoria fondiaria dovevano collocarsi alla fine del secolo VII.
Oggi gli storici preferiscono pensare che l’economia curtense sia stata il prodotto di un lungo
periodo e di molteplici fattori, come la graduale riduzione della mano d’opera servile,
l’attenuarsi della vivacità commerciale, la tendenza della popolazione soprattutto nelle regioni
dell’Europa centrale, ad abbandonare le città e a trovare più sicuro rifugio nelle campagne sotto
la protezione dei grandi latifondisti, cominciato a dare i primi frutti già nel corso del secolo VII, se
non addirittura nel secolo precedente.
Per quanto riguarda, poi, più direttamente il significato giuridico della signoria fondiaria si deve
rilevare che il fenomeno per cui uomini liberi affidavano ad un altro uomo, più potente di loro, la
51
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
difesa della propria vita, la sicurezza della propria esistenza e la tutela dei propri diritti sta a
testimoniare l’inadeguatezza dei meccanismi di difesa e di tutela predisposti nell’ordinamento
giuridico germanico tradizionale in un quadro economico e sociale diverso da quello originario e
caratterizzato dai problemi posti dalla guida di un processo produttivo che andava sempre più
decisamente diventando tendenzialmente autosufficiente e che privilegiava in maniera
crescente la produzione fondiaria.
I piccoli possessori per conseguire risultati più soddisfacenti avevano bisogno dell’intervento
di un altro signore più potente.
Possiamo individuare 2 forme di tale fenomeno:
La prima è costituita dall’intervento, a favore di un dominus fondiario, di altro signore
della medesima zona che era riuscito a dotarsi di strumenti difensivi e di comando sufficienti
ad offrire protezione anche ad altri possedimenti.
Tale forma si rinviene con particolare frequenza a proposito di benefici ecclesiastici, anche se
non manca per le terre possedute da laici.
Il titolare della carica ecclesiastica incontrava spesso difficoltà ad organizzare adeguate forme
di difesa delle terre e delle comunità ivi residenti e si trovava, pertanto, costretto a ricorrere
all’aiuto di vicini laici potenti.
Il termine che designava il signore laico al quale l’ecclesiastico si rivolgeva era quello di
advocatus;
La seconda forma è, poi, quella costituita dalla relazione tra due signori.
È il caso delle donazioni di terra concesse da un latifondista ad un minor possessore, con la
riserva di potestà da esercitare sul fondo donato. Il modello ecclesiastico offre un esempio
chiaro.
Si tratta della cosiddetta chiesa privata, fondata da un signore laico con l’indispensabile
dotazione patrimoniale: le terre della Chiesa erano amministrate e gestite con poteri signorili
dall’ecclesiastico preposto all’esercizio del culto, ma il signore laico si riservava molteplici
poteri di intervento.
In entrambi i casi si venivano ad intrecciare e a sovrapporre due distinte potestà signorili, due
diversi poteri di comando, due differenti sfere giurisdizionali: entrambe avevano diritto di
appropriarsi di parte del prodotto dell’azienda curtense, come corrispettivo della funzione di
protezione e tutela da loro esercitata nei riguardi delle comunità residenti sul fondo interessato.
La signoria fondiaria, quindi, fu frutto della consuetudine.
Sul piano dello sviluppo dell’ordinamento giuridico tale evoluzione, espressa dalla consuetudine,
finiva per affiancare due sistemi diversi e tra loro in contrasto, quello della tradizione germanica
che con i suoi meccanismi di giustizia offriva tutela ai diritti della tradizione e ai rapporti usuali tra
soggetti liberi, quello della organizzazione curtense, che affidava alla superiore autorità del
signore la difesa delle persone e dei loro diritti.
52
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Il secondo non scalzò definitivamente il primo.
La contemporanea presenza di due diversi ordinamenti contiene anche un altro aspetto
significativo: la condizione dell’uomo libero veniva a perdere la sua originaria omogeneità, per
frastagliarsi in una ricca molteplicità di situazioni.
Libero era, infatti, il signore fondiario che era in grado di difendere completamente non solo sé
stesso, la sua famiglia e i suoi bene, ma anche altri uomini e altri beni:
libero era il signore fondiario bisognoso di aiuto per la tutela del proprio patrimonio;
libero era il titolare di allodio che si affidava alla tutela dell’ordinamento tradizionale;
libero, infine era il possessore di manso signorile che era subordinato alle regole di
soggezione imposte da sistema curtense.
Pertanto per alcuni liberi coesistevano due diversi tipi di ordinamento e la loro sfera giuridica si
sostanziava di contenuti di origine e natura diversa.
CAPITOLO 3 – L’ORDINAMENTO CAROLINGIO
1.INTRODUZIONE
L’analisi fin qui condotta consente di dire che nel periodo compreso tra il secolo VI e l’VIII fonte
del diritto era la consuetudine.
Una fonte di diritto, che non necessariamente portava all’abrogazione della regola superata da
nuovi usi, ma questa poteva lasciare quiescente, di modo che alla stessa potessero continuare ad
appellarsi soggetti di diritto interessati ove le condizioni generali lo avessero consentito.
Una fonte che consentiva alla contemporanea presenza di usi vecchi e di usi nuovi in zone vicine,
o addirittura contigue, se non nella medesima comunità, quando soggetti di diritto agli uni e agli
altri affidavano la protezione dei propri comportamenti.
In questo quadro l’amministrazione della giustizia si faceva difficile.
Le difficoltà di funzionamento dell’ordinamento giuridico e delle forme tradizionali di tutela del
diritto appaiono particolarmente evidenti nel periodo carolingio, quando meglio definita e
generalmente diffusa risulta l’organizzazione produttiva della signoria curtense.
A questi problemi Carlo Magno cercò di dare una soluzione stabile, introducendo alcune
interessanti novità nell’ordinamento giuridico.
2.L’INDIRIZZO INTERPRETATIVO PREVALENTE
L’indirizzo dominante nella storiografia giudica l’ordinamento carolingio come il culmine del
processo dell’evoluzione dei diritti germanici verso forme monarcocentriche si preoccupa
53
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
quindi di evidenziare la crescita dell’autorità di governo del re e l’aumento della sua potestà
legislativa, trascurando il suo impegno per la tutela del diritto.
Secondo tale impostazione, Carlo Magno avrebbe dato vita ad un sistema di governo unitario e
sostanzialmente centralizzato nell’ampio territorio sottoposto alla sua autorità e ai numerosi
popoli che era riuscito ad assoggettare.
Tale governo si sarebbe articolato in magistrature stabili istituite sia al centro, sia nelle province.
Al centro il sovrano sarebbe stato coadiuvato da alcuni grandi ufficiali, i più importanti dei quali
erano:
il senescalco cui spettava la sovrintendenza del palazzo regio;
il magister pincernarum posto a capo dei coppieri;
il camerario cui era affidata la cura delle stanze da letto del sovrano e la custodia del suo
tesoro;
il comes stabuli responsabile delle stalle regie e dei trasporti.
Inoltre, sarebbe stato istituito un servizio di cancelleria, formato dai cappellani di corte, i quali
avrebbero svolto il compito della redazione dei diplomi e dei documenti regi sotto la guida di un
cancellarius.
Al vertice dell’amministrazione centrale, infine, sarebbe stato posto da Carlo Magno il conte
palatino, con il compito di sovrintendere alle attività degli altri ufficiali di palazzo e di presiedere la
cancelleria del tribunale palatino.
In provincia il rappresentante stabile del sovrano sarebbe stato il conte, direttamente nominato
dal re alla guida di un distretto territoriale ben definito, detto comitato o contea, nel quale
avrebbe esercitato tutte le potestà spettanti al monarca.
Il conte sarebbe stato coadiuvato da un vicario o vicecomes, mentre il distretto da lui presieduto
si sarebbe articolato in circoscrizioni minori, le centene, affidate ciascuna ad un centenarius,
funzionario dipendente direttamente dal conte.
La divisione amministrativa ora descritta avrebbe riguardato l’intero territorio dell’Impero
carolingio.
I sovrani, inoltre, si sarebbero avvalsi dell’opera di funzionari non stabili, da loro inviati nelle
province.
Si tratta dei missi dominici, dei quali l’interpretazione in esame individua 2 principali categorie:
i missi ad hoc incaricati di una missione speciale
i missi ordinarii incaricati di un mandato generale, in virtù del quale curavano la retta
esecuzione degli ordini regi e amministravano la giustizia, controllando in particolare,
l’attività dei conti e degli altri funzionari territoriali.
L’organizzazione dei missi dominici venne perfezionata da Carlo Magno nell’802, quando affidò
quella carica solo a persone appartenenti ai ceti più elevati della società e precisò l’ambito
54
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
territoriale della loro missione, disponendo che ogni distretto fosse affidato a 2 missi, uno laico e
l’altro ecclesiastico.
Infine, il sovrano avrebbe utilizzato per il suo governo anche i vescovi: i Carolingi, avrebbero
attribuito competenze temporali ai vescovi, utilizzandoli soprattutto nell’amministrazione della
giustizia.
Per quanto riguarda l’amministrazione delle regioni di confine dell’impero, nelle zone in cui
maggiore era il pericolo di infiltrazione da parte di popolazioni limitrofe, i territori avrebbero
ricevuto una struttura unitaria, venendo a costituire una marca, affidata ad un comes marcae,
rappresentante del re e da lui direttamente nominato.
Le marche, comunque, avrebbero conosciuto, al pari dei territori interni, la divisione
amministrativa delle contee.
Il sovrano carolingio, che riceveva da tutti i liberi il giuramento di fedeltà, si sarebbe, infatti,
affermato non soltanto come capo dell’esercito, come titolare di alcuni diritti di esazione sui
commerci, come protettore della Chiesa e dei deboli, ma anche e soprattutto come
responsabile dell’amministrazione della giustizia e del mantenimento dell’ordine pubblico e
della pace.
Egli avrebbe, allora, esercitato tale compito in provincia in primo luogo attraverso i conti, i quali in
suo nome avrebbero presieduto il mallus, la corte, cioè del comitato, ed ivi amministrato in via
ordinaria tutta la giustizia.
Carlo Magno avrebbe modificato la precedente organizzazione delle corti comitali stabilendo, da
un canto che di esse dovevano far parte giudici permanenti, gli scabini e riducendo, dall’altro, la
partecipazione dei liberi non specializzati.
L’attività ordinaria dei conti e della loro corte sarebbe stata poi integrata dalla giurisdizione dei
missi, i quali avrebbero avuto l’autorità di avocare a sé ogni questione giudicata importante.
La competenza giurisdizionale del sovrano sarebbe stata esercitata nel tribunale palatino,
competente non soltanto per le questioni connesse con i diritti particolari spettanti al re e per le
vertenze che concernevano le persone sottoposte alla speciale tutela e protezione del monarca,
ma anche per tutte le cause che quest’ultimo riteneva meritevoli di un proprio diretto intervento.
Il tribunale sarebbe stato composto dai grandi (proceres) del regno che si trovavano presso il
sovrano, nonché dai sui consiglieri più vicini vi avrebbe partecipato anche il conte palatino,
avrebbe curato la cancelleria del tribunale e che, inoltre, avrebbe frequentemente sostituito il
monarca stesso alla presidenza del Tribunale.
Le entrate del sovrano carolingio gli venivano dall’esercizio dei poteri a lui spettanti: innanzi tutto
dall’amministrazione della giustizia, poi dai dazi sul commercio e dai diritti di coniazione delle
monete la fonte principale delle entrate regie, comunque, rimaneva il reddito dei domini
fondiari spettanti alla corona.
Carlo Magno affidò la gestione delle sue terre a propri agenti i quali sono indicati nelle fonti con il
termine di Judices.
55
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Egli, inoltre, avvalse di tale esteso patrimonio per remunerare persone a lui fedeli che gli avevano
reso servizi significativi ma in molte occasioni trasferì ai fedeli che intendeva beneficiare non
già il dominio pieno delle terre, bensì solo un uso temporaneo, revocabile in caso di rottura della
fedeltà e limitato ad un periodo o alla durata della vita del concedente o del concessionario.
Titolare del sommo potere di guida della comunità residenti nel territorio dell’Impero, della difesa
delle stesse, nonché dell’amministrazione della giustizia, il re carolingio avrebbe avuto la
possibilità di consentire ad altri l’esercizio di dette potestà all’interno di una circoscrizione ben
definite.
In questo caso egli avrebbe concesso al beneficiario l’immunità dal potere regio, con la
conseguenza duplice di escludere il territorio immune dalla giurisdizione dei rappresentanti
provinciali regi e di autorizzare l’immunista ad esercitare in quella medesima area i poteri che
spettavano alla competenza sovrana.
Beneficiari della concessione erano per lo più i grandi signori ecclesiastici e i vassalli del monarca.
Il potere monarchico era il perno dell’organizzazione sociale.
La cerimonia dell’incoronazione ed in particolare il sacramento dell’unzione regia, introdotta dai
carolingi, avrebbe avuto il significato di dichiarare che la fonte dell’autorità monarchica non era
più il popolo, bensì Dio.
Espressione di tale nuova funzione del sovrano sarebbe stata, accanto all’amministrazione
diretta della giustizia, la potestà legislativa.
Mentre nell’epoca precedente fonte principale del diritto era la consuetudine, ora il monarca si
sarebbe arrogato il potere di emanare norme, la cui autorità si fondava non già sulla volontà
popolare, bensì sul potere stesso del sovrano si tratta dei capitularia, leggi disposte dal re, le
quali obbligavano i sudditi in quanto espressione della superiore volontà del monarca e che si
distinguono in:
capitularia legibus addenda quelle dirette ad integrare leggi di singoli popoli;
capitularia per se scibenda quelli validi per tutti i sudditi dell’Impero.
Werner sostiene che il sistema carolingio puo’ essere diviso in 3 zone distinte:
una centrale corrispondente al territorio degli antichi regni merovingi;
una intermedia costituita dalle zone in cui si erano stanziati i popoli germanici che sotto
Carlo Magno entrarono a far parte del sistema franco;
una periferica nella quale vennero istituite le marche di confine.
Secondo lui, l’ordinamento ricostruito dalla tesi tradizionale avrebbe funzionato solo nella prima
area solo qui si sarebbe realizzata la precisa divisione in contee e la cooperazione tra conte e
missi dominici.
56
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Da un esame più approfondito delle concezioni teocratiche, la formulazione più completa della
teoria del potere regio risulta collegata al ruolo del sovrano di autorità universale incaricata della
realizzazione dell’agostiniana Civitas Dei nel mondo.
L’impero medievale presenta una natura decisamente spirituale che lo distingue in maniera
decisa ad ogni altro ordinamento infatti non per caso era chiamato il Sacro Romano Impero
Germanico, nato con l’incoronazione di Carlo Magno nella notte di Natale del 800 d.C.
Goetz ha sostenuto che in età carolingia si era già formata l’idea di una potestà di governo del
monarca distinta da quella della sua autorità universale tale potestà è indicata come “regia
potestas”, mentre il termine “regnum” indica l’ambito territoriale in cui la stessa era esercitata.
La tesi del Goetz riconosce che la potestà regia non è nella sostanza diversa dall’imperialis
auctoritas e che i termini regnum e imperium non esprimono delle diverse realtà.
Le lacune e le contraddizioni dell’indirizzo prevalente sono state messe in luce da Waas, il quale
sostenne l’esistenza di 3 tipi di comitati in tale periodo:
distretti amministrativi affidati al re e ad un suo funzionario ;
distretti che riguardavano solo i territori fiscali in questi il conte aveva la funzione di
agente signorile del sovrano;
comitati allodiali i signori fondiari esercitavano funzioni comitali in un preciso territorio,
senza riceverne la legittimazione da parte del monarca.
Baaken afferma la coincidenza tra terre fiscali e comitati.
Mitteis e Bosl hanno ridimensionato la tradizionale interpretazione del potere comitale,
attribuendo a questo funzionario il ruolo di rappresentante degli interessi regi e soprattutto di
amministratore del patrimonio fiscale e di protettore della comunità.
Infine, un ulteriore attacco alla storiografia prevalente è stato dato dalla teoria della “contea
divisa”, secondo la quale il distretto territoriale affidato ad un conte non necessariamente
formava un corpo unitario ed era formato da zone tra loro separate tale tesi evidenziava la
debolezza della visione dell’ordinamento provinciale carolingio.
La storiografia prevalente è convinta dell’esattezza sostanziale del quadro complessivo
dell’ordinamento carolingio elaborato dall’interpretazione tradizionale il comitato è oggi
considerato come l’unità amministrativa ordinaria del governo carolingio.
3. CONTINUITA’ DELL’ORDINAMENTO GERMANICO: LE FUNZIONI DEI CONTI E DEI MISSI
DOMINICI
Il conte carolingio era un’autorità prevista solo nell’ordinamento franco.
Il conte merovingio era un’autorità militare competente su un gruppo di uomini liberi stanziati in
una regione e, come tale, aveva anche il compito di curare la conservazione della pace all’interno
57
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
di tale gruppo, presiedendo la corte di giustizia incaricata di rimuovere gli ostacoli al
funzionamento dei meccanismi della faida e delle compositiones la sua competenza riguardava
una comunità di persone a prescindere dalla zona del loro insediamento.
Quando si andarono formando le prime signorie fondiarie, non si ebbe una riduzione territoriale
della competenza del conte, ma l’autorità di questo continuò a riguardare tutti gli uomini liberi del
suo gruppo.
I capitolari carolingi e le altre fonti concordano nel testimoniare che il conte era titolare di
compiti militari del tutto uguali a quelli esercitati in passato: aveva, infatti:
l’autorità di riunire il gruppo di armati che erano ai suoi ordini;
di formare con loro una delle unità in cui l’esercito popolari si articolava;
di guidarli nella campagna militare;
aveva anche la potestà di adottare le misure necessarie per la difesa di zone strategicamente
importanti o particolarmente esposte agli attacchi dei nemici.
Il diritto alla cui tutela i conti erano impegnati era quello della tradizione (faida e
compositiones) lo dichiarava esplicitamente Carlo Magno nel “Capitulare missorum
generale” dell’802, quando sollecitava tutti i liberi ad osservare le norme delle leggi del loro
popolo.
La corte presieduta dal conte continuava a svolgere per il popolo franco la funzione dichiarativa
del passato, continuava, cioè ad intervenire per rimuovere gli ostacoli che inceppavano lo
spontaneo funzionamento della giustizia privata.
La sua corte era competente nei riguardi di una comunità più ampia di quella che faceva capo alla
corte del centenario nell’esercizio delle sue funzioni il conte si avvaleva della collaborazione di
scabini, nonché di quella di vicari, o vicecomites, cui delegava parte delle sue funzioni.
Al pari del conte merovingio quello carolingio risulta competente non già su un distretto
territoriale chiaramente definito, bensì su un gruppo di persone indipendentemente dalla località
del loro insediamento.
La continuità tra conte merovingio e quello carolingio, comunque non deve portare a
sottovalutare alcune importanti differenze tra le due epoche.
Sotto i carolingi, i conti franchi appaiono autorità di primo piano nell’amministrazione della
giustizia.
Una serie di norme precisarono la loro competenza in alcuni settori, ad es:
il “Capitulare” dell’809 disciplinò la procedura da seguire nel caso in cui un imputato di furto
o di rapina fosse inviato dal conte competente ad altro di comunità vicina;
58
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
varie norme poi stabilirono che le vertenze relative alla titolarità di un fondo o alla libertà di
un uomo potevano essere prese in esame dalla corte popolare (il “mallus”) solo se era il
conte a presiederla;
il “Capitolare aquisgranese” dell’801-803 dispose, inoltre, che i conti dovevano avere a
disposizione un edificio in cui rinchiudere i rei dei delitti più gravi.
Carlo Magno ricordò in varie occasioni che i conti avevano la funzione di proteggere la Chiesa e di
difendere i pupilli, gli orfani, le vedove, ovvero quanti non potevano farlo da soli.
Carlo Magno ed i suoi successori immediati si rivolsero con sorprendente frequenza ai conti
franchi per sollecitarli ad esercitare le loro funzioni giudiziarie in maniera corretta ed efficiente.
Tali richiami del monarca sono molto importanti perché non solo confermano la centralità della
funzione comitale in ordine all’attività delle corti popolari franche, ma anche perché denunciano
i crescenti ostacoli che incontravano i meccanismi tradizionali della giustizia.
Il sovrano, quale superiore autorità unitaria del popolo-esercito, si rivolgeva, allora, alle cariche
che intervenivano correntemente nell’amministrazione della giustizia, per sollecitarle a svolgere in
maniera continua ed efficace il loro compito, senza farsi intimidire da potenti locali.
I missi dominaci erano incaricati di intervenire direttamente per curare il funzionamento dei
meccanismi tradizionali della giustizia popolare ed il rispetto delle norme consuetudinarie essi
esplicavano il loro incarico promuovendo una inquisitio diretta a conseguire, attraverso la
testimonianza dei liberi più affidabili della comunità ivi residente, l’esatta ricostruzione della
materia indagata.
I missi domici, dunque, davano esecuzione all’intervento del monarca in favore del
funzionamento della giustizia tradizionale.
Si deve notare che la natura della carica di missus era profondamente diversa da quella di
conte:
il primo era un agente del sovrano;
il secondo un’autorità dell’ordinamento del popolo-esercito.
La differenza si esprimeva nei contenuti della loro funzione:
Mentre i conti rientravano nell’amministrazione della giustizia tradizionale e presiedevano la
corte popolare che si limitava a dichiarare il risultato della prova di Dio, risultato che era
indispensabile per l’applicazione corretta della consuetudine;
i missi dominaci procedevano mediante un’inquisitio che si proponeva non già la
constatazione del risultato di una prova, bensì la formazione di un giudizio di merito e si
concludeva con una decisione di natura costitutiva, dato che imponeva l’immediato rispetto
dell’obbligo gravante sui liberi di una comunità, oppure sospendeva dal loro incarico giudici
popolari risultanti incapaci e li rinviava al giudizio del sovrano.
59
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
La differenza tra queste 2 cariche ribadisce che il conte franco non era funzionario del monarca.
4. L’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO REGIO
Una parte della storiografia ha sostenuto con il Waas l’esistenza, accanto al conte funzionario
regio, di un secondo tipo di conte, agente patrimoniale del sovrano, e con Baaken ha identificato
l’intero ufficio comitale con la funzione di agente fiscale del re.
La domus regia presenta un chiaro carattere signorile.
Il patrimonio regio era articolato in tante curtes, centri di gestione fondiaria in cui operavano
agenti regi stabili, posti alla guida di apparati domestici che riproducevano la composizione della
domus centrale tali agenti sono indicati dalle fonti con il titolo di Judex.
L’area in cui risiedeva la comunità facente capo al conte comprendeva villae (o cutes) regie, villae
signorili e villae dello steso conte.
Ma la presenza di terre fiscali nell’ambito della giurisdizione territoriale del conte non autorizza a
sostenere una trasformazione della natura della carica quando operava nel patrimonio regio.
Sembra, allora, legittimo affermare che il conte franco del periodo carolingio non mutò in alcuna
direzione la sua natura originaria di autorità dell’ordinamento popolare, incaricata di compiti
militari e giudiziari: non si trasformò né in funzionario pubblico del sovrano, né in agente
patrimoniale di questo.
Secondo Thompson la carica di conte era tenuta in genere da persona titolare di un consistente
patrimonio.
Attesta, altresì, che le terre fiscali erano di due tipi:
quelle amministrate direttamente dal re per il tramite di suoi agenti;
e quelle da lui concesse in via temporanea a propri fedeli, che le fonti cominciano ad indicare
con il termine di vassalli.
Trova, allora, conferma l’idea che nel periodo carolingio presero avvio le prime norme che
avrebbero in seguito dato vita all’ordinamento feudale.
Le prime manifestazioni di dette consuetudini si erano avute durante il periodo merovingio,
quando i sovrani avevano cominciato a retribuire loro fedeli con la concessione, a titolo precario,
di domini fondiari si trattava di persone di stato libero e appartenenti, per lo più agli strati
sociali meno elevati, i quali ricorrevano alla speciale protezione del re per difendere meglio i
propri diritti.
Nelle fonti essi sono in genere indicati con l’espressione “ingenui in odsequio”.
L’atto formale con cui nasceva il rapporto tra il re e il suo fedele era l’accomendatio, con la quale
il secondo metteva le proprie nelle mani del monarca, significando in tal modo di affidare se
stesso, i suoi familiari e i suoi beni al primo.
60
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Con l’accomendatio il fedele si impegnava a servire e a rispettare il suo signore, dal canto suo il
signore si impegnava a fornire all’accomandato protezione e mantenimento.
Il signore poteva provvedere in due maniere ad adempiere i suoi obblighi:
accogliendo il fedele nella propria casa, e mantenendolo con le rendite domestiche;
oppure concedendogli un dominio fondiario e consentendogli di godere delle entrate di
questo fino a quando durava il servizio che il fedele stesso doveva svolgere quando era
adottata la seconda soluzione nasceva il particolare rapporto personale e reale, tra re-
signore e fedele che è all’origine del rapporto vassallatico o feudale.
I Carolingi introdussero importanti novità:
Sul piano formale si deve segnalare, accanto alla consuetudine della cerimonia
dell’accommndatio, l’altra della prestazione del giuramento di fedeltà, la quale conferiva
carattere sacro al vincolo di fedeltà tra signore e accomandato;
Sul piano sostanziale poi, deve essere messa in risalto l’abitudine di estendere il rapporto
a persone appartenenti ai ceti più elevati della società (nasce per gli umili, ma si afferma
per i ricchi) essi chiedevano ed ottenevano la concessione, a titolo precario, di domini
appartenenti alle terre fiscali: per queste acquisivano la qualità di vassallo del monarca che
aveva la conseguenza di innalzare la loro posizione sociale.
Divennero, allora, feudatari del sovrano sia grandi signori, sia persone che ricoprivano le cariche
militari e giudiziarie dell’ordinamento popolare, come i conti e i marchesi.
Il diritto feudale, quindi, cominciò a formarsi in età carolingia come complesso di norme
consuetudinarie relativo all’amministrazione del patrimonio fiscale.
Il sovrano concedeva ad un suo fedele una porzione delle proprie terre per un determinato
periodo, ottenendo in cambio fedeltà e servizi dal concessionario: proprio perché posseduta
dall’assegnatario in via non definitiva, tale porzione di terreno viene indicata con il termine di
“beneficio”.
L’atto dispositivo del monarca non conteneva l’indicazione dei poteri che il concessionario
esercitava sulla terra, ma si limitava a stabilire il trasferimento temporaneo di questa.
Il concessionario assumeva nel fondo ricevuto potestà di tipo signorile.
Il concedente non abbandonava completamente la terra al suo vassallo il fondo dopo un certo
periodo rientrava nel patrimonio diretto del sovrano e anche durante la concessione era
considerato appartenente al fisco regio e come tale soggetto all’autorità signorile del monarca.
Il vincolo feudale nacque come strumento di coesione tra persone e patrimoni, non come
elemnto di disintegrazione della società.
5. UNA PROPOSTA DI GIUDIZIO CONCLUSIVO
61
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
RIASSUNTO DEL TUTTO
6. FORMAZIONE CONSUETUDINARIA E DIFFUSIONE DEL DIRITTO FEUDALE
Già nell’806 Carlo Magno aveva progettato una divisione dell’Impero tra i suoi figli.
Di fatto ad una prima spartizione delle regioni occidentali si procedette poco dopo la sua morte
con l’ordinatio imperii dell’817.
Alla fine del secolo IX l’unità carolingia risultava divisa in tre grandi parti:
il regno dei Franchi occidentali che si estendeva dal Reno ai Pirenei;
il regno dei Franchi orientali che comprendeva l’area ad est del Reno;
il regno di Borgogna situato tra il primo e le Alpi.
Il regno d’Italia mantenne una propria individualità distinta, ma venne collegato ad una delle tre
partizioni dell’Impero.
La crisi del mondo carolingio non riguardò soltanto l’unità politica dell’impero essa fu la crisi
della politica, portata avanti da Carlo Magno, intesa a difendere la sopravvivenza degli
ordinamenti della tradizione germanica.
Il secolo IX infatti segna la definitiva e generalizzata affermazione del sistema curtense e la
decisa emarginazione delle forme associative di origine popolare-militare.
La protezione della vita e dei beni delle persone veniva diffusamente assunta come proprio
compito dal signore fondiario.
La crescente crisi dell’organizzazione tradizionale aveva la conseguenza di indebolire
ulteriormente il ruolo dell’autorità unitaria che in questa trovava la sua ragione di esistere, cioè il
sovrano.
I monarchi dei regni in cui l’impero di divise svolsero funzioni decisamente meno importanti di
quelle esercitate da Carlo Magno.
I compiti assunti come propri da Carlo Mango ben presto vennero abbandonati dai suoi
successori.
Né miglior sorte conobbe il potere di protezione dell’ordinamento ecclesiastico.
Né d’altro canto, alcuno dei sovrani fu in grado di svolgere un significavo ruolo di guida militare
del popolo.
Si deve ricordare che i successori di Carlo Magno non riuscirono nemmeno a conservare il
controllo dell’immenso patrimonio fondiario di cui quello era stato titolare.
Molte curtes fiscali passarono in mano a signori di fondi limitrofi o degli stessi agenti patrimoniale
del sovrano, mentre nell’ambito del diritto feudale si affermava la prassi per cui i benefici concessi
dal re non tornavano nel patrimonio fiscale alla morte del beneficiario, ma rimanevano in
possesso degli eredi di quest’ultimo.
62
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Si cominciava così ad allentare il nesso tra fedeltà e possesso (tra l’elemento personale e quello
reale, cioè, del feudo) che era stato inscindibile sotto Carlo Magno ed i suoi immediati successori.
Il diritto feudale a partire dal secolo IX si formò e di diffuse anche al di fuori del quadro di
relazioni in cui era nato: esso fu utilizzato non solo dai monarchi, ma anche e soprattutto da
singoli signori fondiari.
Il diritto feudale fu lo strumento più idoneo a collegare tra loro le monadi curtensi in cui la società
si trovò divisa.
A partire dal Bloch si ritiene che l’evoluzione del diritto feudale nel Medioevo sia passata
attraverso varie fasi, la prima delle quali va dal secolo IX all’XI ed ebbe come centro principale le
regioni comprese nel regno dei Franchi occidentali.
Il rapporto giuridico nato dal contratto feudale si affermò come rapporto complesso, articolato
in tre elementi:
quello personale, costituito dalla fedeltà;
quello regale, rappresentato dal beneficio;
e l’immunità, l’esenzione del vassallo dalla potestà o da alcune potestà del signore nella
guida del beneficio.
Il rapporto feudale nasceva dall’espletamento di alcune formalità, consis tenti:
sia nella prestazione dei giuramenti di omaggio e di fedeltà da parte del vassallo;
sia nell’investitura, l’atto con il quale il signore immetteva il vassallo nel possesso materiale
del fondo dato in beneficio.
L’omaggio era composto da due elementi:
l’immixtio manuum;
e la dichiarazione di volontà del vassallo.
La fedeltà consisteva nel giuramento prestato dal vassallo il quale teneva le mani sui libri sacri o
su sacre reliquie.
I due atti si svolgevano nella casa del signore ed erano considerati in genere entrambi essenziali
per la nascita del rapporto feudale.
La consuetudine feudale, inoltre, precisò il complesso dei diritti e dei doveri reciproci che
legavano i 2 contraenti.
Il vassallo era tenuto a conservare la propria fedeltà verso il signore e tale fedeltà presentava
un duplice contenuto poiché:
da un lato consisteva nell’astensione da ogni azione che potesse procurare, danno al
signore;
dall’altro comprendeva il dovere di prestare al signore medesimo “consilium et auxilium”.
63
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Il consilium era il dovere del vassallo di assistere con il proprio parere il suo dominus nell’esercizio
dei poteri signorili, in particolare partecipando alla corte da quello convocata e presieduta, nella
quale venivano giudicate le vertenze insorte nell’applicazione delle norme del diritto feudale.
A partire dagli ultimi decenni del secolo IX si affermò, infatti, la regola per cui il dominus era
giudice feudale dei suoi vassi ed aveva quindi la diretta responsabilità di dirimere nella sua
corte le liti insorte tra quelli, insieme con le vertenze che li opponevano a lui stesso.
Di modo che i grandi signori fondiari si trovarono a presiedere due tipi distinti di corti:
quella signorile, nella quale era tutelato il diritto che disciplinava i rapporti interni alle
comunità inserite nell’organizzazione curtense;
quella feudale, dove trovava tutela il diritto vassallatico.
L’auxilium si esprimeva nel dovere del vassallo di prestare al dominus il servizio militare e altre
forme di soccorso materiale.
Il servizio militare consisteva nell’invio di un contingente di cavalieri e di fanti che partecipava alla
formazione dell’esercito del signore il mantenimento di tale contingente avveniva ad esclusivo
carico del feudatario e costituiva una delle principali prestazioni in cambio delle quali era
assegnato un feudo.
Tra il X e l’XI secolo si diffuse anche l’uso di consentire la sostituzione del servizio militare con il
versamento di una somma (scutagium), con la quale il signore avrebbe potuto provvedere da
solo alla formazione dei suoi contingenti militari.
L’auxilim, peraltro, non si limitava alla sola prestazione di un contigente armato esso
comportava anche l’obbligo del vassallo di collaborare alla gestione patrimoniale del signore e
soprattutto nell’obbligazione di assicurare al signore stesso alcuni aiuti pecuniari (disciplinati
dalle norme consuetudinarie).
Si affermò l’uso per cui il vassallo inviava denaro al signore in 3 occasioni principali:
quando era necessario raccogliere la somma per pagare il riscatto del signore tenuto
prigioniero;
quando il figlio primogenito del signore diventava cavaliere e doveva procurarsi il necessario
e costoso armamento;
quando la figlia primogenita del signore si sposava.
Il signore aveva il diritto di chiedere ai suoi vassalli contributi pecuniari straordinari nel caso in
cui si fosse verificata una situazione di bisogno eccezionale, si fosse venuto a creare uno stato di
necessità per l’intero complesso dei domini signorili che imponeva l’intervento congiunto del
dominus e dei suoi vassi (guerra).
Ai doveri del vassallo corrispondevano poi quelli del signore.
Il signore era tenuto innanzi tutto a mantenere salda la propria lealtà e fedeltà ai suoi vassalli, di
modo che non poteva legittimamente privarli del beneficio loro concesso in feudo se i vassalli
64
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
stessi avevano tenuto fede al loro dovere di obbedienza e si erano comportati in maniera
adeguata al loro obbligo feudale.
Doveva, inoltre, fornire ai suoi feudatari protezione e mantenimento.
Per quanto riguarda la protezione, essa comprendeva la tutela del possesso fondiario concesso
ai vassalli e quindi la difesa contro ogni tentativo di invasione o di spogliazione portato avanti da
nemici esterni, nonché il dovere di intervenire in soccorso del vassallo ogni volta che questo lo
richiedeva.
La protezione comprendeva anche il dovere del signore di garantire al feudatario il pieno e
completo esercizio del potere di banno necessario alla guida del beneficio ricevuto in feudo, e
quindi di integrarlo con la propria superiore autorità, nonché il dovere di assistere il vassallo
medesimo con i propri consigli nell’esercizio del potere signorile.
L’obbligo di mantenimento del vassallo gravante sul signore consisteva, poi, nel dovere di
quest’ultimo di mettere il primo nelle condizioni materiali necessarie per fornire le prestazioni ed
i servizi cui era tenuto in virtù del contratto feudale.
Sin dalla prima metà del IX sec. si affermò la consuetudine per cui i fedi maggiori (cioè quelli
concessi direttamente dal sovrano franco) non tornavano al re alla morte del vassallo, ma
passavano all’erede di questo.
Nel corso del secolo X cominciò ad affermarsi l’uso di ammettere la successione ereditaria anche
per i feudi non concessi direttamente dal sovrano, almeno in riferimento ai benefici più
consistenti e più importanti.
Corrado II il Salico nel Capitolare del 1037 stabilì l’ereditarietà dei feudi minori grazie a questo
atto la prassi si diffuse ampiamente al di fuori della Francia, in particolare in Italia e in Germania.
Si affermò già sulla metà del secolo XI la prassi per cui l’erede era ammesso alla prestazione
dell’omaggio e della fedeltà solo dopo aver versato al dominus una somma, relevium, il cui
ammontare prima fissato dal signore o concordato fra le parti, poi venne stabilito dalla
consuetudine.
Regole particolari, poi, disciplinarono i casi in cui l’erede non avesse raggiunto la maggiore età.
In genere il signore assumeva la custodia e la tutela del minore, diventando il suo procurator, o
bajulus, o cutos, si appropriava dell’intero reddito del beneficio, ma aveva l’obbligo di mantenere
ed educare il suo protetto.
Un’altra disciplina seguita soprattutto nella regione circostante Parigi, ma non ignota altrove,
prevedeva, invece, che il parente più prossimo del minore divenisse vassallo del signore e
provvedesse all’educazione e al mantenimento del signore stesso.
Al momento il cui l’erede raggiungeva la maggiore età venivano a cessare i rapporti giuridici nati
alla morte del feudatario: l’erede prestava i dovuti giuramenti e diveniva vassallo a pieno titolo
ricevendo l’investitura del beneficio da parte del signore.
Se infine il feudatario non aveva eredi maschi per un lungo periodo venne esclusa la possibilità di
lasciare in eredità il dominio alla discendenza femminile.
65
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Quando fu ammessa, si stabilì allora che l’erede del feudo scegliesse un uomo in grado di
assumere l’intero impegno feudale nei confronti del signore e che questo uomo prestasse al
signore fedeltà ed omaggio, venendo così a stabilire il rapporto vassallatico tra se stesso e il
signore.
Se la donna era sposata, o quando la donna si sposava, era il marito ad assumere tale ruolo.
Non si affermò un preciso ceto sociale come titolare univoco del ruolo di signore e perciò
contrapposto ad uno stato sociale inferiore, che ricopriva la funzione di feudatario.
L’intreccio di legami feudali che si andò sviluppando in quel periodo presenta non pochi casi di
titolari di autorità maggiori che tenevano domini in feudo da altre potestà signorili minori, nonché
di signori fondiari che contemporaneamente rivestivano i ruoli di signore e di vassallo nei riguardi
di altri.
Sin dalla fine del secolo IX si diffuse in Francia la consuetudine per la quale un vassallo prestava
omaggio a più signori, entrando così in possesso di un vasto numero di benefici e legandosi con
vari vincoli di fedeltà.
La condizione del vassallo onerato da una pluralità di impegni era singolare: egli, infatti, poteva
scegliere tra i suoi signori e di conseguenza finiva per non garantire a nessuno di loro la propria
fedeltà.
In alcune zone si affermò per qualche tempo l’uso di riconoscere come prevalente l’impegno
cronologicamente più risalente, in altre si diffuse la prassi di considerare prioritario il rapporto
instaurato con il signore che aveva concesso il beneficio più esteso.
Sulla metà del secolo IX, infine, cominciò ad apparire il sistema della cosiddetta “fedeltà ligia”,
in virtù della quale il vassallo di più signori stabiliva un legame speciale con uno solo di loro: il
vassallo, infatti, si impegnava a servire questo dominus <integre> cioè senza riserve e <contra
omnes>, perciò anche contro gli altri signori cui aveva giurato fedeltà.
Il signore che riceveva tale particolare impegno, era, allora definito come dominus ligius, mentre il
vassallo diveniva nei suoi confronti homo ligius.
La diffusione del sistema vassallatico non si limitò ai grandi fondiari laici, ma coinvolse anche le
maggiori dignità ecclesiastiche, nonché i titolari di cariche popolari di natura militare e
giurisdizionale come i conti.
I signori locali intervenivano nella scelta del vescovo e dell’abate soprattutto in due maniere:
concedendo la < licentia eligendi > al capitolo o ai monaci e provvedendo in un secondo
tempo alla conferma dell’eletto;
oppure procedendo direttamente alla nomina del titolare della diocesi e del monastero.
L’intervento signorile nella vita ecclesiastica non si limitava, peraltro, alla nomina del titolare della
dignità: si estendeva anche al beneficio, collegato alla dignità stessa, secondo meccanismi che
potevano variare in dipendenza del grado di subordinazione della carica ecclesiastica al signore.
66
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Quando tale subordinazione era molto accentuata il signore si considerava dominus,
dell’intero beneficio e riteneva il vescovo o l’abate un suo vassallo.
In tal caso, appena nominato il titolare della carica doveva prestare giuramento di fedeltà al
signore con la cerimonia della commendatio e successivamente entrava in possesso del beneficio
attraverso l’atto solenne dell’investitura.
Quando, invece la subordinazione era più ridotta, la concessione feudale poteva riguardare una
parte sola delle terre che costituivano il beneficio oppure riferirsi a un dominio assegnato in feudo
in un momento successivo alla nomina.
CAPITOLO 4 – L’EUROPA POST CAROLINGIA
1. REGNI, DUCATI E CONTEE DOPO LA FINE DELL’UNITA’ CAROLINGIA
L’interesse del mondo post-carolingio deriva dal fatto che la fine dell’unità istituzionale del mondo
occidentale non solo si espresse nella divisione dell’impero in tre regni, ma provocò anche la
disgregazione di ciascuno di questi in unità minori, i ducati nel regno orientale, ducati contee e
signorie negli altri due.
Nel regno dei Franchi orientali già alla fine del secolo IX cominciano a delinearsi i ducati di
Sassonia, Baviera, Svevia, Franconia, Lotaringia e Turingia tali ducati sono stati interpretati
tradizionalmente come < ducati etnici> (Stammesherzogtumer), ducati composti da comunità che
riconoscevano di far parte di un’unica etnia e si affidavano alla guida di un loro capo.
Si riteneva che, una volta tramontato il tentativo carolingio di unificare sotto la guida dei franchi i
vari popoli residenti tra il Reno e L’Elba, questi ultimi avevano riacquistato l’individualità
precedente la conquista carolingia e avevano recuperato le forme tradizionali del loro
ordinamento popolare – militare sotto la guida di un capo al quale le fonti assegnano il titolo
militare di dux, cioè condottiero, e quindi duca.
Minor importanza il ducato rivestì nel regno occidentale, dove l’unità istituzionale prevalente fu
quella della contea e della signoria minore.
Anche per la Francia è stato sostenuto che il fattore connettivo preminente fu la comunanza
etnica.
Tale interpretazione è stata però criticata.
67
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Werner ha sostenuto per le regioni tedesche che l’unità etnica non è riscontrabile in tutti i ducati
e che, di conseguenza, la stessa non puo’ essere assunta come elemento distintivo
dell’ordinamento stesso.
Secondo lui, le fonti non attestano in maniera sicura che il duca riceveva dal sovrano l’incarico
feudale di reggere il ducato, di modo che non si potrebbe parlare di ducato come ufficio
burocratico.
Inoltre, secondo Werner, la vera natura dell’unità istituzionale affermatasi nel regno orientale si
dovrebbe cogliere partendo dall’articolazione dell’ordinamento carolingio.
Quest’ultimo prevedeva, oltre al nucleo centrale (costituito dalle regioni dei regni merovingi), una
serie di unità giuridiche amministrative e militari, costituite dai regna e dalle marche, la cui
organizzazione rispondeva a concrete esigenze di governo e di difesa e non seguiva, quindi,
l’obiettivo di riunire la popolazione di una stessa etnia.
Quando si aprì la crisi dell’autorità monarchica carolingia, l’unità dell’impero si ruppe e gli
ordinamenti regionali emersero come realtà istituzionali a sé stanti, indipendenti dall’autorità
centrale del re.
Quindi, i ducati tedeschi, in quanto eredi delle precedenti articolazioni amministrative carolingie,
avrebbero avuto carattere di ordinamenti indipendenti o semindipendenti, emersi in virtù di
necessità storiche ed in opposizione alla potestà centralizzante del sovrano.
Altra critica è stata fatta da Goetz, il quale ha sostenuto che il titolo ducale non puo’ essere
utilizzato per designare l’autorità affermatasi al vertice degli ordinamenti territoriali germanici.
Infatti, secondo lui, il duca franco era stato un funzionario del re, mentre il principe di quelle unità
regionali derivava la propria autorità dalla potestà di guida della nobiltà fondiaria della regione da
lui assunta.
Inoltre, secondo il Goetz, alla base del principato si trova la concreta capacità di uno dei grandi
signori della regione di affermarsi come primo sugli altri nobili, di imporre su di loro la sua
autorità.
Queste 2 interpretazioni (di Werner e di Goetz) mettono in rilievo l’impossibilità di far coincidere
sempre l’etnia e il ducato.
Alla guida dei ducati, siano essi emersi come realtà individuali dal corpo morente dell’impero
(secondo Werner), siano essi nati dalle concrete esigenze della popolazione di un territorio
(secondo Goetz), si sarebbe trovata un’autorità titolare di una giurisdizione pubblica uguale a
quella regia.
2. PLURALITA’ DI ORDINAMENTI GIURIDICI E INCERTEZZA DEL DIRITTO
Le incertezze e l’inefficacia dei sistemi di tutela del diritto aumentarono, rendendo ancora più
acuta la crisi della giustizia.
68
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Continuarono ad essere in vigore numerosi diritti, senza un’effettiva e sicura coordinazione tra
loro.
Erano in vigore le leggi etniche tradizionali, il cui intreccio all’interno delle comunità residenti
nella medesima zona era guidato, al di là del principio della personalità del diritto, dalla
formazione di consuetudini locali che adattavano norme popolari tradizionali alle esigenze nuove
della vita associata.
Si deve tener presente che le leggi personali e le consuetudini locali costituivano il diritto
seguito da soggetti liberi.
E i liberi erano non soltanto i componenti di comunità non sottoposte ad alcun signore fondiario,
non soltanto i titolari di possedimenti mantenutisi al di fuori delle signorie fondiarie, non soltanto
i signori curtensi, ma anche soggetti che vivevano all’interno delle aziende fondiarie facendo
parte di comunità di villaggio o possedendo mansi signorili per costoro la soggezione al
dominus si affiancava alla titolarità dei diritti della tradizione.
Si diffuse in tutto l’occidente l’economia curtense e la forma organizzativa della signoria fondiaria.
Il regime più comune in questo periodo, definito <classico> dalla storiografia, presentava una
pars dominica molto estesa, la cui lavorazione richiedeva un numero cospicuo di servizi personali
da parte dei possessori di mandi tale regime è prevalente nelle regioni della Francia centro-
settentionali.
Nel Midi era diffusa una differente organizzazione che presentava un demanio signorile più
limitato e affidava il controllo della produzione contadina ad agenti del signore inviati nelle
terre che componevano l’azienda tali agenti, indicati con il titolo di ministeriales,
appartenevano all’amministrazione della domus e curavano che a questa pervenissero le quantità
di prodotto dovute.
Nelle regioni tedesche, poi, l’azienda curtense si caratterizzò per la dispersione dei mansi in
zone diverse e per le dimensioni ridotte della pars dominica, a sua volta generalmente divisa in
lotti tra loro separati.
Il controllo della produzione dei mansi spettava ad un agente domestico designato con il termine
di villicus, al quale erano affidati gruppi di mansi contigui: e dal titolo dell’agente signorile tale
forma di azienda curtense è denominata villicatio.
Nelle regioni del Regno italico, infine, le unità curtensi continuarono ad essere affiancate da
possedimenti di minori dimensioni fino all’inizio del secolo X, quando si diffuse in maniera
massiccia la forma signorile < classica> e i piccoli proprietari cominciarono a trasformarsi in coloni
dei grandi signori.
Di frequente il signore fondiario non era in grado di assicurare da solo la guida delle comunità del
suo patrimonio e aveva perciò bisogno di un’integrazione della sua autorità da parte di un altro
signore tale integrazione poteva avvenire sia da un signore di pari posizione, sia da un signore
che si presentava come superiore all’altro.
69
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
L’ordinamento della chiesa conobbe una decisa evoluzione in senso signorile, dato che
l’intervento del vescovo venne generalmente ridotto e la chiesa privata, con il presbyter e gli altri
clerici, passò in maniera sensibile nell’ambito della signoria fondiaria.
A questa venivano riconosciuti:
lo ius regalie il diritto in virtù del quale, una volta terminata la concessione, le rendite del
beneficio legato alla chiesa tornavano al signore;
lo ius spolii grazie al quale il signore aveva il diritto di reclamare i beni mobili personali dei
chierici;
nonché il diritto dello stesso signore di imporre ai fedeli il versamento di tributi per servizi
religiosi di particolare rilievo.
Oltre che sulle chiese private, i signori laici esercitavano ampie potestà anche sui monasteri di
loro fondazione: a volte tali potestà si esprimevano nella stessa titolarità della carica di abate,
grazie alla quale il signore godeva del pieno controllo sulla gestione del beneficio.
Il regime giuridico del beneficio vassallatico è diverso nelle varie regioni e il beneficio non costituì
un bene difendibile erga omnes quando poi nel 1037 con l’Edictum de beneficiis l’imperatore
Corrado il Salico riconobbe l’ereditarietà anche sui feudi minori, la natura reale del feudo prevalse
in Italia su quella personale.
Va segnalata la coesistenza di più ordinamenti, l’intreccio tra più giurisdizioni, l’incontro nelle
medesime persone di diritti e doveri derivanti da ciascuno dei sistemi di cui esse allo stesso
tempo facevano parte.
Così, le comunità libere che continuavano ad esistere all’interno di signorie fondiarie vantavano i
diritti tradizionali del loro popolo, ma al contempo rientravano nel meccanismo signorile, per il
quale erano gravate di doveri e godevano di diritti nei riguardi del titolare del banno.
E così anche il signore era spesso tenuto ad osservare, oltre ai doveri verso le comunità del suo
patrimonio, anche obblighi nei riguardi di signori che lo aiutavano o che a lui erano superiori:
obblighi che, nel caso di rapporto vassallatico, erano disciplinati dalle consuetudini feudali.
E nello stesso tempo il signore, nella sua qualità di soggetto libero, faceva parte della comunità
popolare della tradizione all’interno della quale rivestiva una posizione paritetica a quella del
signore a lui superiore, o inferiore, di fatto o per diritto feudale.
Non solo ciascuno di tali ordinamenti prevedeva forme di tutela del diritto tra loro differenti:
corti popolari, corti signorili, corti feudali si venivano così ad intrecciare e a sovrapporre tra loro.
La soluzione delle vertenze era affidata alle armi di qui lo stato di endemica lotta che sembra
caratterizzare tutte le regioni europee dopo il crollo dell’unità.
70
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
La reazione a questo stato di cose si espresse nella ricerca di nuove forme di giustizia.
La risposta più immediata fu quella di conseguire una sospensione temporanea dei conflitti
privati, senza intervenire nel merito della vertenza in altre parole senza pretendere di fare
giustizia.
In questo settore si distinsero soprattutto le dignità ecclesiastiche, la cui autorità spirituale era in
grado di imporsi sul mondo laico.
Lo strumento più efficace usato dal clero in tutte le regioni dell’Europa post-carolingia fu quello
della proclamazione della pace di Dio: in questo caso il vescovo formulava un elenco dettagliato
dei comportamenti che dovevano essere seguiti da tutti i liberi della diocesi e cercava di imporne
il rispetto in virtù della propria autorità morale, sollecitando gli abitanti ad impegnarsi con
giuramento e minacciando sanzioni spirituali ai trasgressori.
Sul modello della pace si diffuse l’altro meccanismo della tregua di Dio, che si limitava ad imporre
la sospensione delle controversie in corrispondenza di alcune festività religiose.
3. LA SIGNORIA TERRITORIALE
L’emersione della signoria territoriale deve essere messa in rapporto con l’ondata di invasioni
scandinave e ungheresi cui fu sottoposto l’Occidente europeo a partire dagli ultimi anni del secolo
IX, invasioni che si aggiungevano alle incursioni portate dai Saraceni alle coste mediterranee
cristiane.
Contro gli invasori e gli incursori era difficile opporre l’antica organizzazione germanica del
popolo-esercito, da tempo in crisi di fronte al nuovo indirizzo della produzione e alle aggregazioni
sociali a questo legate.
La difesa del territorio e delle comunità ivi residenti finì per essere svolta da singole persone,
capaci di assumere la guida unitaria degli armati di una zona, coordinandone l’azione costoro si
accollarono anche il compito di assicurare la pace interna al territorio da loro difeso, pace che
poteva essere conseguita solo attraverso la tutela dei diritti vigenti.
Difesa militare e giustizia appaiono, allora, gli aspetti dominanti della signoria territoriale.
La storiografia definisce la signoria territoriale come l’autorità assunta su una regione da uno dei
signori fondiari della medesima in grado di fornire un adeguato coordinamento della difesa e
della giustizia agli altri signori ai benedici ecclesiastici, alle comunità e ai singoli liberi residenti
nell’area interessata.
Accanto alla emersione della signoria territoriale ci fu l’emersione del fenomeno
dell’incastellamento il castello costituiva il centro difensivo ed amministrativo di un vasto
territorio.
A partire dagli ultimi anni del secolo IX tutte le regioni europee si riempirono di castelli e luoghi
fortificati vecchie mura difensive vennero restaurate e rinforzate, nuove costruzioni vennero
erette per accogliere, in caso di bisogno, la popolazione del territorio circostante e proteggerla
con l’aiuto di uomini d’arme.
71
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Oggi il castello è considerato come centro di difesa non solo dai nemici esterni, ma anche da
aggressioni di signori e di armati della regione e, al contempo, sede dell’autorità che guidava il
territorio.
Mediante il castello, un signore offriva protezione alle comunità residenti non solo nel suo
patrimonio fondiario, ma anche in quelli vicini, provvedeva a difendere la pace interna tutelando i
diritti vigenti nel territorio medesimo.
La signoria di castello, secondo gli studiosi odierni, era una forma della signoria territoriale la
signoria territoriale poteva esistere anche senza la fortificazione, ma laddove era un castello si
trovava una signoria territoriale.
Bisogna individuare i titolari di questa signoria secondo la visione statualistica, i signori
territoriali titolari di un castello potevano essere solo duchi, marchesi, conti, cioè coloro che
esercitavano pubblica autorità in nome del re tale interpretazione è stata smentita da
numerose indagini che hanno rivelato l’esistenza di un consistente numero di castelli innalzati da
signori privi di ogni intitolatura ufficiale.
Infatti, secondo alcuni studiosi (che criticano la visione statualistica), la signoria territoriale si
sarebbe modellata sul paradigma della signoria fondiaria: infatti quella territoriale avrebbe
ripetuto dilatandosi i caratteri principale della signoria curtense la tesi appare interessante, ma
difficilmente può essere condivisa.
La signoria fondiaria nasceva dalle necessità produttive dell’azienda curtense e dalla conseguente
organizzazione della comunità che nella stessa azienda operava.
Nella signoria territoriale, invece, il titolare non vantava il dominium delle terre diverse dal suo
patrimonio e quindi non partecipava alla direzione del processo produttivo: la sua posizione
appare diversa da quella del signore fondiario che integrava la potestà di un altro signore, come il
dominus feudale nei confronti del vassallo o il patrono nei riguardi della chiesa privata.
Egli limitava la sua funzione al coordinamento delle difese e alla ricerca della pace interna
attraverso la tutela dei diritti vigenti.
La signoria territoriale venne assunta in maniera spontanea da signori fondiari della regione in
grado di svolgere le due principali funzioni, quella di difensore delle popolazioni e l’altra di tutore
dei diritti tali signori furono re, duchi, marchesi e conti.
L’unità della signoria territoriale deve essere intesa solo come un tentativo di soluzione dei
problemi più urgenti di un territorio (difesa e pace interna), nel rispetto dell’articolazione
sociale spontaneamente affermatasi nello stesso.
La difesa e la giustizia continuarono a dipendere non solo dalla capacità e dall’autorità del signore
territoriale, ma anche dalla volontà dei signori fondiari, dei titolari delle cariche ecclesiastiche,
delle comunità dei liberi, dei soggetti singoli di accettare il coordinamento unitario del signore.
Sotto il profilo delle attività difensive, in verità, la storiografia ha spesso sottolineato il successo
dei titolari dei castelli, rilevando che questi sarebbero riusciti con grande frequenza a coordinare
l’azione militare dei liberi del territorio e a dar vita ad un efficiente servizio di guardia della
fortezza tuttavia, tali risultati non sembrano connessi con la nascita di definite potestà di
72
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
comando in mano al signore e di correlati doveri precisi in testa ai soggetti che espletavano il
servizio.
In effetti, l’organizzazione dei liberi armati continuò a fondarsi sulla volontà degli stessi liberi, sulla
necessità da loro avvertita di unire le forze in vista della comune difesa.
Per quanto riguarda poi il servizio di fortezza, chiamata “guaita” (consistente nell’avvistamento
dei nemici e nell’allarme) e la “custodia” (la partecipazione attiva alla difesa della fortezza), erano
di solito imposte come “corvées” a coloro che erano chiamati a svolgerle se questa era la loro
natura, si deve pensare che esse rientrassero tra i servizi personali dovuti al signore fondiario da
parte dei contadini della sua azienda curtense in questo caso i servizi di fortezza sarebbero
stati imposti solo a quelli che risiedevano nel patrimonio personale del signore, in particolare nel
fondo sul quale era stato costruito il castello stesso.
Altro aspetto della signoria fondiaria da considerare è quello della giustizia il signore
territoriale, ed in particolare quello del castello, aveva il compito specifico di garantire la
giustizia e la pace interna attraverso la tutela dei diritti esistenti.
Quale diritto trova applicazione nella corte signorile?
Sappiamo che le corti della tradizione popolare, là dove erano sopravvissute, continuavano a
tutelare le leggi etniche e l’evoluzione consuetudinaria da queste conosciuta;
sappiamo che la corte del signore fondiario giudicava le vertenze insorte all’interno
dell’organizzazione curtense;
sappiamo infine che la corte feudale del dominus risolveva i conflitti nati nell’applicazione
delle consuetudini vassallatiche.
Non sappiamo invece quale fosse la specifica competenza del signore territoriale una traccia
per scoprirlo è comunque offerta dalla costatazione che la ragion d’essere della signoria
territoriale risiedeva nell’incapacità delle corti ora nominate di garantire la pace interna ad un
territorio e nella conseguente necessità di un intervento nuovo per la solitudine dei cogliti.
Il ruolo primario del signore era quello di mediare tra singole pretese e singoli ordinamenti.
La complessità della vita associata favoriva l’intreccio di situazioni e comportamenti tra loro in
contrasto, situazioni e comportamenti che ove consolidati nell’uso si trasformavano, in virtù della
forza vincolante della consuetudine, in diritto, cioè in attività protette dall’ordinamento.
Il contrasto nasceva anche tra ordinamenti diversi, dato che il medesimo soggetto giuridico
poteva appartenere contemporaneamente a più sistemi Il signore territoriale, allora, sembra
aver avuto soprattutto la funzione di mediare tra detti conflitti di varia natura.
Al pari di quanto accadeva per il ruolo difensivo, anche la funzione di giustizia del signore si
fondava sia sulla sua abilità e sulla sua autorità, sia sulla disponibilità dei soggetti di diritto ad
accettare la sua mediazione il suo intervento era richiesto quando il valore della pace interna
assumeva per i contendenti un significato superiore alla difesa delle proprie pretese.
Quindi, il funzionamento della corte signorile è occasionale e saltuario e privo degli strumenti
indispensabili ad imporre le delibere raggiunte.
73
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Con la signoria territoriale, dunque, prendeva vita un nuovo ordinamento giuridico che si
affiancava agli ordinamenti tradizionali con la funzione di proteggerli e di coordinarli un
ordinamento che proprio in virtù del suo compito presentava una composizione unitaria ed
estremamente articolata.
L’obiettivo della potestà signorile non fu mai quello di eliminare gli ordinamenti particolari vigenti
nel territorio.
4. CONTEE E DUCATI COME FORME DI SIGNORIA TERRITORIALE
Gli studiosi che attribuiscono a contee e ducati natura di ordinamento unitario guidato da
un’autorità centrale legittima, posti di fronte all’emersione della signoria territoriale parlano di
una duplice struttura istituzionale:
una ufficiale quella delle dignità comitale e ducale;
l’altra guidata da soggetti che avevano usurpato potestà legittime.
Contee e ducati in età carolingia erano articolazioni tradizionali dell’ordinamento del popolo-
esercito il rapporto tra contee e ducati, da un lato, e signoria territoriale, dall’altro, deve essere
posto in termini diversi.
I conti erano comunemente titolari di castelli.
E’ facilmente comprensibile, allora, che molti di costoro fossero di fatto i signori fondiari più
potenti o più autorevoli della regione e, di conseguenza, riuscissero a fornire un’adeguata
protezione alla comunità di una vasta regione, in particolare ai signori, laici ed ecclesiastici, della
stessa.
L’altro dato significativo è costituito da quella che gli storici chiamano imitatio comitis,
l’aspirazione, cioè, di molti signori privi di intitolazione a modellare la loro potestà sul paradigma
dell’autorità comitale un’aspirazione che deve essere intesa come volontà di assumere la guida
militare e di giustizia della comunità alla stregua di quanto faceva il conte nell’ordinamento della
tradizione.
La potestà del signore territoriale e quella del conte appartengono a due ordinamenti distinti, ma
allo stesso tempo risultano convergenti.
L’autorità comitale cessava di fungere come mera carica popolare, posta alla guida di una
comunità di liberi armati, assumeva la difesa di una determinata area geografica, l’onere della
difesa armata e della pace interna.
La difesa armata, infatti, era assicurata innanzi tutto dal patrimonio del signore-conte, dai
castelli da costui posseduti nelle sue terre e difese dagli uomini di queste: a tale struttura militare
di base si potevano, poi, aggiungere i contributi dei signori fondiari e delle comunità di liberi
residenti nel territorio che il signore accoglieva sotto la sua guida unitaria.
Quanto alla pace interna, il signore conte non si limitava più ad integrare i meccanismi della
giustizia privata dell’ordinamento popolare, ma assumeva anche il nuovo compito di intervenire
74
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
nei conflitti che turbavano l’armonia della comunità tali conflitti non si limitavano alle
vertenze tra soggetti dello stesso ordinamento, ma comprendevano anche contrasti tra
ordinamenti.
Il conte, divenuto signore territoriale, assumeva un ruolo attivo nell’amministrazione della
giustizia, affiancandolo a quello sostanzialmente passivo della tradizione, ed estendeva la sua
tutela a tutti gli ordinamenti vigenti del territorio (non solo a quello popolare), per tentare quella
mediazione che poteva assicurare una pace più duratura.
L’autorità comitale conservava i suoi legami con il passato e quindi rimaneva carica popolare
tale continuità non solo rafforzava il ruolo di guida militare del signore, ma gli assegnava anche
una funzione significativa in merito alla tutela dei diritti dei liberi, inserendolo nella gestione della
giustizia popolare.
L’incontro con la signoria territoriale, quindi, ebbe l’effetto di avviare una evoluzione della natura
dell’autorità comitale questa acquisiva significativi contenuti territoriali e al contempo si
affermava come potestà superiore alle altre della regione.
L’evoluzione della carica comitale si svolse mediante l’assunzione dell’onere personale di difesa e
si protezione delle comunità e degli ordinamenti di un’area geografica da parte di chi continuava
ad essere titolare di una carica rilevante dell’ordinamento popolare-militare della tradizione
germanica.
La potestà di guida del conte, in questa situazione, trovava la sua fonte di legittimazione non
tanto nell’organizzazione tradizionale del popolo-esercito, quanto nella sua personale capacità di
difendere il territorio dai nemici e di assicurare la pace all’interno dello stesso, mediando tra i
soggetti di diritto attivi in esso e tra gli ordinamenti ivi presenti ed esercitando su tutti il proprio
comando superiore.
Contenuti del potere del conte in quanto signore territoriale, egli aveva il compito di difendere
l’esistenza dei soggetti ivi residenti e di tutelare i diritti e, poiché ciascun soggetto era titolare di
diritti appartenenti a diversi ordinamenti, il signore-conte tutelava e proteggeva tutti
gli ordinamenti particolari del suo territorio.
La ragion d’essere della sua autorità risiedeva, quindi, nella funzione di difesa armata e di
giustizia.
Di conseguenza, il rapporto tra autorità comitale e soggetti e ordinamenti della regione deve
essere visto come un rapporto di collaborazione e di reciproco completamento quando il conte
non operava nella direzione voluta dagli ordinamenti e dalle potestà particolari, l’unità territoriale
si rompeva e si apriva la strada per diverse composizioni.
La formazione di contee più vaste derivava dalle concrete necessità di tutela di una comunità e
che le stesse rimanevano in vita fino a quanto erano in grado di rispondere a tali necessità.
La contea più grande svolgeva funzioni di difesa e di giustizia della stessa natura di quelle
esercitate dalla signoria territoriale minore: sembra, in altre parole, un grado diverso di signoria
territoriale rispetto alla contea più piccola.
75
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Di solito, titolare di detta carica comitale fu uno dei signori territoriali della regione, il quale era in
grado di integrare utilmente le potestà unitarie esercitate nei loro territori dagli altri signori.
Bisogna chiarire i contenuti dell’autorità del conte preposto ad un’unità regionale più vasta
innanzi tutto si deve dire che risultano del tutto assenti regole definite per disciplinare le relazioni
tra costui e i signori territoriali o quelli fondiari della contea.
Il diritto feudale continuò a disciplinare una parte delle relazioni tra signori curtensi,
prescindendo del tutto dal ruolo che costoro avevano all’interno della società.
Peraltro, il patrimonio di signori fondiari e territoriali continuò ad essere composto da numerosi
allodi.
Il feudo, dunque, rimaneva limitato alla disciplina dei rapporti tra signori e tra fondi, mentre
mancava una rete diffusa di vincoli vassallatici che legasse tutti i titolari di patrimoni al conte.
Nel Midi francese e nelle contee catalane era diffuso il contratto di convenientia, in virtù del
quale il dominus remunerava il suo fedele, in cambio della fedeltà e del servizio militare non già
con la cessione temporanea del beneficio, ma con la donazione definitiva di una terra anche la
convenientia riguardava esclusivamente la disciplina dei rapporti tra fondi e tra persone, fu
utilizzata da signori curtensi a prescindere dal loro ruolo nella comunità del territorio e non legò
al conte tutti i titolari di terre.
L’autorità del conte, collegata come era con i bisogni degli ordinamenti particolari, risulta diversa
a seconda delle singole parti della regione che a lui faceva capo.
Nel signore titolare di una contea di vaste dimensioni appaiono convivere tre diversi ordini di
potestà:
egli era in primo luogo un grande signore fondiario, con un vasto patrimonio che in genere
aveva conosciuto ampliamenti in seguito all’acquisizione di gran parte del fisco imperiale
della regione, acquisizione resa possibile dall’incapacità del re di conservare il possesso delle
sue terre.
L’amministrazione del patrimonio forniva al signore i mezzi economici indispensabili per
assolvere le funzioni unitarie nei riguardi della regione che a lui faceva capo di qui
l’attenzione verso la gestione delle aziende curtensi cui continuavano a provvedere.
I poteri signorili poi comprendevano quelli spettanti al conte in virtù della sua autorità su
altri fondi: come advocatus o patrono egli riscuoteva quote della rendita prodotta nei
benefici ecclesiastici sottoposti alla sua potestà.
In qualità di signore fondiario egli amministrava nelle terre del suo patrimonio la giustizia
signorile ed era spesso legato ad altri signori da vincoli feudali sia in qualità di dominus, sia in
quella di vassus, dato che il suo patrimonio era costituito, oltre che da terre allodiali, anche
da fondi da lui ricevuti in feudo da altri signori;
76
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
il conte era, poi, signore territoriale della regione in cui si trovava la parte più consistente
del suo patrimonio in tale veste assicurava difesa e giustizia alle comunità e agli
ordinamenti interessati;
infine, egli era autorità unitaria di un territorio più vasto comprendente altre signorie
territoriali a queste il conte forniva, in caso di necessità un coordinamento della difesa
armata; forniva anche una possibilità di mediazione nei contrasti che li dividevano.
Sotto quest’ultimo aspetto, l’intervento del conte è di modesto significato infatti, in
nessuna contea non sembra attiva nessuna corte signorile in grado di esercitare il ruolo di
arbitro tra i conflitti (l’intervento era svolto direttamente dal conte, con l’eventuale ausilio di
un prepositus).
Quindi, la potestà unitaria del conte sembra costituire un grado di signoria territoriale più alto di
quella di base, ma ancora meno penetrante di questa in una società che privilegiava le forme
istituzionali particolari l’autorità prevalente era quella di chi era legato a tali istituzioni in maniera
più diretta.
All’interno della grande contea, dunque, convivevano più ordinamenti particolari:
alcuni con contenuti territoriali la signoria fondiaria, laica ed ecclesiastica, la signoria
territoriale, l’ordinamento feudale;
altri con prevalente carattere personale come l’ordinamento generale di tutti gli uomini
liberi e l’ordinamento ecclesiastico.
Essi trovano diverse forme di tutela anche la potestà del signore-conte era uno strumento
della loro tutela.
Tale particolare natura delle strutture istituzionali di questo periodo spiega perché non è raro
trovare nelle fonti testimonianze di conti i quali, trovandosi nel territorio di un signore,
esercitavano la giustizia al posto di questo, oppure presiedevano la corte di questo o la corte
dell’antica amministrazione popolare, oppure erano destinatari di suppliche da parte di comunità
o soggetti liberi per la conferma dei loro diritto tradizionali.
Il compito di tutela degli ordinamenti particolari, di cui il conte era investito, lo autorizzava ad
amministrare direttamente la giustizia insieme con chi più di frequente lo faceva o in sostituzione
di costui.
Anche i ducati (si affermarono i Germania e in Francia) emersero come forma istituzionale
richiesta dalle necessità della popolazione e degli ordinamenti particolari di una regione.
77
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Anche in questo caso la potestà unitaria venne assunta da uno dei maggiori, se non il maggiore,
signori territoriali della regione medesima, titolare di un vasto patrimonio, parte del quale
costituito da terre fiscali dell’Impero non più rivendicate dal monarca universale.
Anche la potestà ducale sembra delinearsi per la sua capacità di provvedere ad una coordinata
difesa del territorio e di tentare la conservazione di una stabile pace interna, al di fuori di un atto
formale di riconoscimento da parte del sovrano.
Anche nei ducati la potestà unitaria si limitò a coordinare le forze militari esistenti nella regione e
ad intervenire come arbitro nei conflitti tra soggetti di diritto.
La natura del ducato post-carolingio è di un grado di signoria territoriale, con tutte le sfumature,
le incertezze e le potenzialità che questa presentava.
Per quanto riguarda, in particolare, le funzioni del duca, è stato messo in rilievo come nei ducati
tedeschi egli svolgesse nel campo della giustizia prevalentemente il ruolo di mediatore per
vertenze insorte tra signori territoriale e fondiari a questo fine si avvaleva di una corte ristretta,
specificamente competente al riguardo.
La formazione di questo particolare Herzogsgerchi, che si rinviene in molti ducati, fa pensare ad
una certa regolarità e frequenza dei suoi interventi deve essere comunque chiaro che esso
operava solo quando spontaneamente soggetti in lotta tra loro si rivolgevano ed erano disposti a
rispettare le sue decisioni.
Il duca tedesco, poi, convocava e presiedeva anche un più ampio consiglio, un’assemblea erede
dell’antica riunione germanica degli uomini liberi questa corte tutelava il diritto
consuetudinario popolare, difendendo i diritti dei liberi a prescindere dall’ulteriore loro
inserimento in altri ordinamenti.
Il duca-signore continuava, in questa maniera, l’attività di giudice popolare dei sui predecessori
nel titolo. Il tribunale ristretto del duca sembra, invece, assente nei ducati francesi, dove è
attestata soltanto l’assemblea erede della tradizione popolare.
Nel duca:
è assente una superiorità definita su altri signori territoriali e su signori fondiari;
aveva funzioni di difesa degli ordinamenti particolari delle regioni;
fusione della potestà signorile con quella della sua carica appartenente all’ordinamento della
tradizione popolare- militare;
compresenza in lui dell’autorità unitaria dell’intera regione, dipendenza dei contenuti di
quest’ultima dalle concrete condizioni della società e dai bisogni di questa, con la
conseguente variabilità di poteri non solo tra ducato e ducato, tra momenti e momenti della
vita di questo, ma anche da area ad area all’interno del medesimo ducato.
E anche per il duca si deve segnalare come la fonte principale della sua potenza risiedesse nella
rendita delle sue aziende curtensi e come alla gestione di queste continuassero a provvedere gli
78
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
uffici dell’amministrazione domestica coadiuvati da agenti signorili inviati nelle unità fondiarie
tra questi si trovavano anche alcuni specialisti, come i “forestari”, incaricati dell’amministrazione
delle foreste.
CAPITOLO 5 – TRADIZIONE GIUSTINIANEA, EREDITA’ LONGOBARDA, CONTINUITA’
BIZANTINA IN ITALIA
1. INTRODUZIONE
La vita della società occidentale nell’alto Medioevo risulta disciplinata allo stesso tempo da vari
ordinamenti giuridici:
alcuni a base territoriale come il diritto delle signorie fondiarie;
altri con contenuti personali come l’ordinamento che riguardava tutti gli uomini liberi, e il
diritto della Chiesa;
altri, infine, con natura personale e reale come il diritto feudale.
Per tutti questi ordinamenti la consuetudine costituiva non soltanto fonte primaria di esistenza,
ma anche strumento principale di evoluzione.
Gli ordinamenti erano vari e ciascuno si avvaleva di propri strumenti di giustizia.
Per quanto riguarda il mondo franco sappiamo che rimasero in vita le corti popolari, presiedute
dai conti e da altri titolari della tradizionale funzione dichiarativa: presso di loro il processo si
svolgeva come in passato e la soluzione della vertenza fu a lungo riservata soprattutto al giudizio
di Dio e al duello giudiziario.
A questi si affiancarono successivamente il giuramento, la prova testimoniale e il documento
negoziale l’introduzione di tali prove aveva la funzione di individuare il responsabile di un reato
e l’illegittimo pretendente di una vertenza.
La corte, attraverso gli scabini, si limitava a dichiarare l’esito della prova.
Nel corso di tale periodo, i contatti tra liberi di differenti etnie residenti nella stessa regione
cominciarono a far emergere usi che erano osservati da tutti gli abitanti a prescindere dalla legge
personale di ciascuno di loro tali consuetudini locali si fondavano sul diritto della tradizione
popolare, ma allo stesso tempo ne costituivano un superamento dato che derivavano dalle
esigenze concrete della società.
Nelle regioni centro-settentrionali che costituivano il regno d’Italia la tradizione giuridica
germanica, più precisamente di origine longobarda e in misura minore franca, si trovò a contatto
con quella del diritto romano, un diritto che trovava i suoi punti di riferimento soprattutto nella
disciplina giustinianea.
Il regno italico riguardava una parte soltanto della penisola: il resto era sotto il dominio dei
Longobardi, nei ducati che sopravvissero alla caduta del regno e costituiscono la Longobardia
79
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
minor, o sotto il controllo dell’amministrazione bizantina o dei ducati autonomi che da questa
avevano avuto origine.
Dalla metà del secolo IX, poi, la Sicilia venne occupata dagli Arabi, mentre la Sardegna conosceva
le prime forme dell’inedito ordinamento giudicale.
2. DOCUMENTO E PRASSI GIURIDICA NELLE REGIONI DEL REGNO ITALICO
Un dato risulta caratterizzare le regioni centro – settentrionali della penisola sin dal periodo del
regno longobardo, quello della larga diffusione del documento negoziale testimonia la
significativa influenza della tradizione giuridica romana.
Gli estensori dei documenti appartenevano a due sole categorie, quelle degli ecclesiastici e l’altra
dei notarii.
Le charte negoziali redatte da costoro sembrano essere state accettate come valide dalle corti
popolari di giustizia, in virtù della credibilità del loro autore.
Con l’età franca le regioni Italiane dovettero conoscere alcuni cambiamenti inseguito alle
disposizioni di Carlo Magno secondo le quali presso i conti e le altre autorità popolari, nonché
presso i vescovi, doveva operare un notaio nominato da un missus dominicus e i presbiteri non
potevano più redigere carte negoziali.
Ed esperti di diritto, in grado di redigere documenti contrattuali affidabili e con ogni probabilità
legati all’attività delle corti di giustizia della tradizione popolare, operarono nel regno italico anche
nei secoli successivi, portatori di una cultura giuridica e attivi presso il palatium di Pavia.
Si puo’ affermare che nelle regioni del regno italico l’ordinamento della tradizione popolare
germanica sopravvisse e le sue corti di giustizia continuarono ad operare vi ricorrevano
singoli soggetti di diritto, comunità di liberi, signori fondiari.
Le vertenze discusse dinnanzi non erano solo quelle insorte tra soggetti di pari condizione (2
liberi, 2 signori), ma anche tra soggetti che si trovavano in situazioni diverse.
Per quanto riguarda l’età longobarda in questo periodo non vennero elaborati schemi e formule
precise e definite per le singole figure contrattuali.
Tale situazione sembra prolungarsi anche nei primi tempi del regno italico, almeno fino al secolo X
allora i tecnici del diritto iniziarono ad utilizzare nelle loro carte modelli e formulari desunti
dalla tradizione romana tale novità è dovuta all’esigenza di conferire una qualche
normalizzazione al sistema negoziale.
Negli schemi forniti dai formulari romani cominciarono ad essere inserite le numerose, variegate
e spesso tra loro contraddittorie consuetudini locali, i cui contenuti risalivano alla tradizione
romana dei Longobardi, Franchi, Alemanni o alla matrice antica del diritto romano.
La conseguenza fu duplice perché:
da un canto la complessa materia consuetudinaria riceveva un primo inquadramento;
80
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
dall’altro il ripetuto uso dei formulari diveniva a sua volta fonte di consuetudine e quindi
improntava di sé gli usi della prassi quotidiana.
Gli schemi e le formule di origine romana furono utilizzati per incanalare una realtà giuridica per
più versi diversa da quella del mondo produttivo dell’antichità e per precisare in maniera meglio
definita i doveri che gravavano sulle parti contrattuali.
L’uso da parte dei redattori di care contrattuali e di formulari giuridici di tradizione romana non
comportò la formulazione di categorie giuridiche ben definite nelle quali la massa magmatica
della consuetudine potesse essere inquadrata e sistemata per avere questo risultato bisogna
attendere la rinascita bolognese.
Per il momento gli esperti del diritto si limitavano a tentare di rendere più chiara e precisa la
disciplina degli obblighi che nascevano dalle concrete situazioni della vita sociale.
Il problema più rilevante posto dalla presenza diffusa di carte negoziali nelle regioni del Regno
Italico è, infine, quello della loro funzione in ordine al negozio giuridico già alla fine del secolo
scorso il Brunner aveva messo in luce come tra le formalità di rito che accompagnavano la
conclusione di un negozio giuridico nelle regioni del regno italico dovesse essere considerata la
traditio chartae lo scambio del documento negoziale tra le parti.
Il significato della traditio venne approfondito dal Brandileone e dal Freundt che sostennero che
la carta aveva la sola funzione di provare l’esistenza di un negozio, già concluso in virtù
dell’espletamento delle formalità contrattuali della tradizione, e che, di conseguenza, la traditio
della carta serviva a mettere a disposizione di una delle parti una prova dell’esistenza del
contratto da usare validamente davanti ad una corte di giustizia.
Astuti sostenne la natura costitutiva della carta e della sua traditio l’opinione dell’Astuti ,
comunque, non sembra essere stata accolta dagli studiosi successivi: in particolare il Costamagna
ha ritenuto difficile credere che i contraenti di origine germanica rinunciassero, nei contratti
espressi nella carta, alle formalità negoziali della loro tradizione, ed ha messo in luce come la
stesura del mundum, il documento originale completo in tutte le sue parti, avvenisse sempre in
un momento successivo al contratto, di modo che la conclusione di questo doveva
necessariamente precedere la consegna della carta.
Sembra, allora, possibile ritenere che la conclusione dei negozi giuridici continuasse, come in
passato, ad essere affidata all’espletamento delle formalità tradizionali.
In alcuni casi e in certe circostanze, prima di tutte la presenza di tecnici capaci di scrivere, dotati di
nozioni giuridiche e affidali, del contratto concluso veniva redatto un documento nel quale i
rispettivi diritti e doveri delle parti trovavano una precisazione migliore di quanto sarebbe
avvenuto se la disciplina del rapporto fosse stata lasciata alla complessa prassi consuetudinaria.
Tale documento poteva essere usato come prova nel caso in cui in merito al contratto nascesse
una vertenza di fronte ad una corte popolare.
La carta negoziale, dunque, costituiva una prova come tale essa era usata nell’ambito del
processo della tradizione germanica.
81
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
E qui si trovò naturalmente a svolgere non già il ruolo che le era riconosciuto dal diritto
giustineaneo e che le attribuisce il diritto odierno, bensì la medesima funzione dell’ordalia, del
duello giudiziario, del giuramento della prova testimoniale.
Anche quando si rivolse alla carta, la corte, continuò a limitare il proprio compito a dichiarare il
risultato obiettivo della prova così come voleva la tradizione germanica (non era una prova
documentale come oggi).
L’incontro tra tradizione romana e tradizione germanica allora, assumeva nella carta un carattere
di particolare interesse:
dalla prima veniva l’esigenza di stendere per iscritto il contenuto degli obblighi fissata dalla
consuetudine e di precisarli in maniera più adeguata attraverso l’utilizzazione di formulari;
la seconda, dal canto suo, forniva il quadro giuridico e processuale nel quale il documento
trovava applicazione.
E’ proprio il carattere di prova germanica rivestito dal documento altomedievale a giustificare
l’attenzione riservata dalle leggi popolari alla veridicità della carta ne è un es. il cap. 243
dell’Editto di Rotari che stabilì il taglio delle mani per gli autori di documenti falsi.
Alla carta, infatti, era affidata la soluzione di vertenze presente alla corti popolari ed essa di
conseguenza, doveva contenere tutti gli elementi di affidabilità e di certezza che
caratterizzavano gli altri tipi di prova giudiziaria.
Per il regno italico, il processo tenuto dinnanzi ad una corte popolare era definito con il termine
di “placito”, termine usato anche per indicare il documento che registrava le varie fasi del
processo medesimo.
La corte era presieduta dal conte o da un notaio locale, oppure da un agente regio (conte, messo,
giudice palatino) presente nel luogo in cui il placito si teneva: ove, poi, in quel medesimo posto si
fosse trovato il re, era egli stesso ad assumere la presidenza del tribunale.
Della corte facevano parte esponenti della comunità dei liberi, sia grandi signori (laici ed
ecclesiastici), sia boni homines, sia liberi privi di particolare qualifica, non esperti di diritto, come
notai, scabini e giudici sia locali, sia regi.
La soluzione della causa era affidata alle prove dedotte in giudizio, di modo che la corte si
limitava a pronunciare l’esito delle prove stesse.
Al riguardo, si deve notare che il duello giudiziario e l’ordalia risultano sostanzialmente assenti nei
placiti a noi pervenuti e le prove presentate alla corte consistono in quella testimoniale, in quella
documentale, nel giuramento e nella confessione.
L’ordalia e il duello erano utilizzate diffusamente nel regno, mentre anche in altre regioni europee
ad esse si ricorreva soprattutto quando c’era un’accesa contestazione sui fatti, altrimenti si
preferiva utilizzare mezzi meno violenti.
82
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
I placiti testimoniano della continuità del sistema processuale della tradizione germanica in tutto
il periodo del regno italico sono infatti in funzione le corti popolari, presiedute dal conte e
composte da esponenti della comunità dei liberi.
L’intervento in esse del re o dei suoi agenti attesta che continuava a mancare, come in passato,
una gerarchia tra le corti popolari e che il re non costituiva potestà giurisdizionale d’appello, bensì
autorità rivestita dalla stessa funzione di pace e di giustizia di cui le altre cariche militari, a
cominciare dal conte erano investite.
Una mancanza di gerarchia che risulta chiaramente testimoniata dall’espressione < et finita est
causa> che concludeva sempre il giudizio, anche quando a presiedere il placito era stato il conte
locale, ovvero non esisteva l’appello.
La tradizione germanica, poi, trova la sua più evidente espressione nella conservazione del
carattere dichiarativo della sentenza della corte.
3. LA SCIENZA GIURIDICA
La storiografia è concorde nel sottolineare che nelle regioni italiane del regno, longobardo prima,
italico poi, la cultura giuridica si manifestò sia nella redazione di documenti negoziali, ma anche
nell’elaborazione di alcune opere esegetiche.
Nel corso dell’Alto Medioevo circolavano nelle regioni centro-settentrionali della penisola testi
giuridici tratti dalla compilazione giustineanea di quest’ultima furono conosciute:
le Istitutiones, in forma integra;
il Codex, nella forma ridotta dell’Epitome Codicis relativa ai soli primi libri della raccolta,
forma che con il tempo fu accresciuta dagli amanuensi con l’inserimento di costituzioni
assenti nei manoscritti più antichi, indicata con l’espressione di Epitome aucta, e le Novellae
secondo il testo della raccolta della Epitome Juliani che contiene il testo ridotto di 122-123
costituzioni latine;
Sconosciuto fu il Digesto.
Furono elaborate opere di esegesi e di commento alle singole parti della compilazione
giustinianea la forma di letteraria di tali opere è quella della glossa, annotazione marginale o
interinale al testo, diretta a spiegare il significato di un termine o di un’espressione.
Anche l’Editto longobardo venne studiato, come attestano alcune opere del IX sec. si tratta in
particolare della “Concordia de singulis causis”.
83
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
L’autore prese in esame il solo Editto di Rotari, ne seguì l’ordine delle norme e per ciascuna di loro
o per ogni gruppo di esse, segnalò affinità o differenze con altre norme dello stesso Editto o di
quelli successivi.
Più importanti sono altre opere di diritto germanico composte nelle regioni del Regno Italico,
come:
Il liber legis longobardorum è un’opera che riunisce in ordine cronologico le norme
dell’Editto Longobardo;
e quello del Capitolare italicum.
Nella prima metà del secolo XI si ebbe la loro riunione, mentre il Capitolare italico fu aggiornato
fino ai provvedimenti di Enrico III.
Nella sua forma definitiva il Liber papiensis, realizzato dalla scuola di Pavia, riunisce la
legislazione longobarda (con i suoi editti) – franca (con i capitolari) relativa ad un periodo di
circa 400 anni.
Oltre alla Vulgata, che costituisce la redazione maggiormente diffusa, si può ricordare la
gualcausina attribuita a Galcasio o Walcauso si tratta di una redazione che si caratterizzava per
il fatto che il commento risulta inserito nel testo stesso delle leggi, come parte integrante di
questo.
Nella seconda metà dell’XI sec. la legislazione longobardo-franca formò poi oggetto di una
seconda raccolta, detta Lex longobarda, nella quale venne disposta in maniera sistematica (non
più in ordine cronologico) è articolata in 3 libri, suddivisi in titoli.
La cultura giuridica germanica non si limitò a raccogliere in maniera organica le fonti legislative
longobardo-franche, ma sottopose anche le stesse ad un attento lavoro esegetico sono
significative le glosse ed i commenti che arricchiscono le diverse redazioni del Liber papiensis:
esse rivelano nei loro autori una buona conoscenza non solo della materia longobarda, ma anche
del diritto giustinianeo.
L’Exposito ad librum papiensem è un apparato legislativo di notevole ampiezza che riguarda
l’intero corpo legislativo longobardo-franco e dà conto dell’attività interpretativa condotta su di
esso da varie generazioni di giuristi.
La compilazione del Liber papiensis e dell’Expositio è stata attribuita dal Merkel ad una scuola di
diritto attiva a Pavia nell’XI sec. di tale scuola non si trova alcun cenno nelle fonti, ma
l’esistenza di essa si spiega con la presenza a Pavia del tribunale palatino, inteso dal Merkel come
suprema corte del regno italico.
La maggior parte degli storici ha accettato l’esistenza di una scuola di diritto a Pavia, anche se ha
messo in evidenza la mancanza di testimonianze certe.
L’interesse dell’Expositio risiede non solo nell’articolata esegesi del testo longobardo-franco, ma
anche nella testimonianza che offre della conoscenza delle fonti giuridiche giustinianee da
parte dei giudici pavesi conoscenza che comprende anche il Digesto.
84
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Le opere esegetiche del diritto longobardo-franco sembrano confermare il tentativo degli esperti
del diritto del secolo XI di utilizzare le fonti romanistiche per una migliore comprensione della
complessa ed articolata realtà giuridica vigente.
Una conferma dello stretto legame tra le due tradizioni giuridiche potrebbe venire da alcune
opere che utilizzano allo stesso tempo il diritto romano e la legislazione longobardo-franca.
La prima opera, il cui titolo completo è “Petri viri disertissimi Exceptiones Legum Romanarum”,
deriva dall’unione di 2 raccolte precedenti:
il “Libro di Tubinga” comprende 145 capitoli, composti da passi tratti dalle fonti
giustinianee, riprodotte non sempre in maniera fedele, nonché dall’Editto di Rotari e da
capitolari franchi;
il “Libro di Ashburnham” si articola in 120 capitoli formati da passi desunti dalla
compilazione giustinianea, riportati con maggiore fedeltà ma in maniera frammentaria.
La seconda opera, il “Brachylogus iuris civilis”, è diviso in 4 libri e basato non solo sulle fonti
giustinianee e sul Capitolare italico, ma anche sulla Lex romana Wisigothorum.
A prescindere da queste 2 opere è attestata in maniera chiara, nelle regioni del regno italico, la
diffusione di un’intensa cultura giuridica, che matura di più nel corso dell’XI sec.
4. DUCATI E PRINCIPATI LONGOBARDI
Sembra che anche nel ducato di Spoleto si manifestò la progressiva diffusione della signoria
curtense con la formazione di alcune importanti dinastie fondiarie.
La carica popolare più importante era quella di duca: ad essa era legata la titolarità di un
ragguardevole patrimonio per la gestione del quale erano impiegati agenti locali e gli ufficiali
domestici che componevano il palatium ducale.
Al duca, inoltre, faceva capo una corte popolare che esercitava la giustizia nelle forme della
tradizione germanica.
La conquista del regno longobardo da parte dei franchi ebbe la conseguenza di porre fine al
ducato spolentino.
Il territorio passò per un breve periodo sotto l’amministrazione pontificia, per entrare
successivamente a far parte del regno italico.
Nella caduta degli altri domini longobardi non rimase invece coinvolto il ducato di Benevento a
partire da quel momento, il duca assunse il titolo di summus princeps gentis Longobardarum.
Nel 849 l’unità del ducato si ruppe e da essa sorsero due distinti principati, Benevento e
Salerno.
85
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Nella seconda metà del secolo i due principati furono impegnati sia contro il pericolo saraceno,
sia contro la ripresa militare bizantina.
L’ordinamento giuridico dei 3 principati longobardi (Salerno, Benevento e Capua) conobbe
un’evoluzione quasi analoga a quella vissuta nei secoli IX-XI dalle regioni europee che avevano
fatto parte dell’impero carolingio.
Nelle terre longobarde dell’Italia meridionale, infatti, oltre al sistema curtense si affermò una
potente signoria territoriale lo attesta il fenomeno dell’incastellamento.
I continui contrasti tra signori e la persistente minaccia saracena sollecitarono la formazione di
unità territoriali capaci di assicurare alle comunità residenti nei territori della Langobardia minor
una sufficiente difesa delle persone e dei beni titolari di tali signorie furono sia grandi abbazie,
sia signori laici che si avvalsero delle cariche di conte o di gastaldo per affermarsi come autorità
unitaria di una zona.
La stessa contea di Capua si formò all’interno del principato salernitano come signoria territoriale
e con una propria definita individualità passò in quello di benevento, per raggiungere, infine,
piena indipendenza.
A loro volta le signorie locali ebbero bisogno del sostegno di un’autorità unitaria.
Al principe venne riconosciuta una forma di potestà signorile territoriale principe, conti e
gastaldi rappresentavano con i loro titoli la continuità dell’ordinamento della tradizione
germanica.
A loro faceva capo una corte popolare che continuava ad intervenire nell’amministrazione della
giustizia secondo le norme della tradizione germanica.
Infine, principe e signori territoriali erano anche titolari di vasti patrimoni, che erano articolati in
varie aziende curtensi gestite secondo i meccanismi della signoria fondiaria.
Nell’amministrazione delle terre ognuno di loro si avvaleva degli uffici domestici.
Dalle regioni del regno italico, la Longobardia minor non conobbe il diritto feudale perché le
concessioni di terre venivano fatte con l’antica forma della donazione con il conseguente
passaggio del pieno dominio.
Bisogna infine rilevare che al pari di quanto avveniva nelle regioni centro-settentrionali della
penisola, anche in quelle longobarde meridionali si diffuse un’interessante cultura giuridica, che si
manifestò soprattutto nella redazione di carte negoziali e diplomi ducali e principeschi.
86
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
CAPITOLO 6 – L’ORDINAMENTO GIURIDICO DELLA CHIESA
1. INTRODUZIONE
Il diritto per la Chiesa si articolava in:
diritto divino costituito dalla Rivelazione, dalla tradizione della Chiesa e dal diritto
naturale (cioè l’ordine universale della creazione);
diritto umano costituito dal diritto eccelesiastico, o canonico (che riguardava
l’organizzazione della Chiesa e le norme di comportamento dei fedeli) e dal diritto secolare,
quello che regolava i rapporti temporali tra i soggetti.
L’ordinamento ecclesiastico presenta elementi tra loro divergenti dato che la sua disciplina
dipendeva dalle forze concretamente attive in ciascuna regione.
Tra la metà del secolo X e il secolo successivo all’interno della Chiesa occidentale si sviluppò un
importante movimento riformatore il cui obiettivo principale era quello di introdurre una stabile
ed univoca forma organizzativa delle strutture ecclesiastiche e di affermare l’individualità
dell’ordinamento rispetto agli altri.
Tale movimento può essere compreso nella sua interezza soprattutto tenendo presente il
particolare rapporto esistente tra l’autorità della Chiesa e il diritto secolare.
2. LE RACCOLTE DI NORME CANONICHE DEI SECOLI V-X
Fonte primario del diritto divino era la Sacra Scrittura, cioè il Vecchio e il Nuovo Testamento.
Ad essa si aggiunge la tradizione, all’interno della quale si distingue:
la traditio divina costituita dai precetti trasmessi direttamente da Gesù agli Apostoli;
e quella humana comprendente l’apostolica, derivante dall’insegnamento degli Apostoli e
l’ecclesiastica, cioè la dottrina formula dalle autorità della Chiesa.
Il diritto umano della Chiesa trovava sin dai primi tempi del Cristianesimo la sua fonte principale
nelle regole approvate dalle assemblee che riunivano i titolari delle maggiori cariche
ecclesiastiche.
Queste assemblee erano designate con il termine di concilio (provinciale o ecumenico), mentre
per le loro delibere veniva usato il termine di canone.
A tali norme nel mondo occidentale si vennero ad aggiungere, con la progressiva affermazione
dell’autorità di primate del vescovo di Roma, le decisioni da lui adottate e fondate sulla superiore
autorità a lui riconosciuta.
Tali decisioni furono designate con i termini di constitutiones, edita, rescripta, decreta, epistolae
decretales e più brevemente decretales: quest’ultimo termine finì con il prevalere sugli altri.
87
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Tra le raccolte di canoni e decretali del secolo V si ricorda la “Versio antiqua romana”, la Collectio,
o Versio, Isidoriana o Hispana e la Collecrio Prisca o Itala., la Collectio Dionysio- Hadriana (insieme
di canoni e decretali).
Tra la fine del V e l’inizio del sec. successivo, poi, vennero redatte a Roma dal monaco Dionigi 2
raccolte:
una contenente la versione latina di 50 canoni pseudo-apostolici e di quelli approvati nel
corso dei più importanti concili orientali, ecumenici e particolari;
l’altra di decretali pontificie emanate tra la fine del IV sec. e la fine del secolo successivo.
Le 2 raccolte furono unite in un’unica collezione detta “Collectio Dionysiana” una redazione,
ampliata rispetto a quella originale, venne inviata dal pontefice Adrinao I a Carlo Magno nel 774 e
nell’802 fu approvata come raccolta del diritto della Chiesa franca.
Tra il VI e il VII sec. comparvero alcune interessanti raccolte elaborate da singole Chiese regionali,
come le collezioni della Chiesa africana (la “Breviatio canonum” e la “Concordia cononum”) e
quella della Chiesa spagnola intitolata “Collectio Hispana).
Cominciarono anche ad essere compilati a cura delle varie Chiese Libri poenitentiales, contenenti
elenchi dei peccati con le relative penitenze.
A partire dal secolo IX si diffusero le falsificazioni Franche, in cui si alterarono le fonti canoniche,
sia fonti secolari, quali costituzioni imperiali romane e capitolari franchi.
Attraverso le collezioni trovavano una più sicura definizione le fonti normative del diritto secolare,
al pari di quanto andava accadendo nello stesso periodo per alcune fonti di diritto divino, come
quelle della tradizione ecclesiastica.
Le decisioni canoniche, una volta precisate nel loro contenuto, potevano essere fatte valere,
insieme con le fonti di diritto divino, per intervenire all’interno del nucleo più consistente di
norme giuridiche quello delle regole prodotte dalla consuetudine.
Nell’intera Cristianità occidentale si diffusero usi i quali riducevano l’ambito dell’ordinamento
ecclesiastico o, addirittura, in alcune regioni ne mettevano in pericolo la continuità.
Le ingerenze di autorità laiche nella gestione dei benefici comportavano di solito anche
l’intervento delle stesse nella scelta dei titolari delle cariche e la conseguente formazione di
regole consuetudinarie che finivano per sospendere l’applicazione delle norme, approvate nei
concili o disposte dal pontefice, in virtù delle quali quella scelta era riservata al clero.
Allo stesso tempo il predominio dei più forti , il prevalere delle armi, la rozzezza delle condizioni di
vita favorivano la diffusione di usi che disciplinavano i rapporti intersoggettivi in termini ben
lontani dall’insegnamento della Chiesa, mentre le pretese di questa di disciplinare, in quanto
rientranti nel proprio ordinamento, rapporti giuridici intersoggettivi particolarmente rilevanti sul
88
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
piano spirituale trovavano non poche difficoltà a tradursi in prassi consolidata di fronte al
diffondersi di usi di segno opposto.
La Chiesa vantava il diritto e l’autorità di adprobare le consuetudini, annullando quelle che
fossero risultate in opposizione alle sue regole e quest’ultime erano fissate non soltanto dalla
Rivelazione, dalla tradizione e dall’ordine della creazione: erano anche stabilite dalle autorità
ecclesiastiche, i concili e il papa.
3. LA RIFORMA DELLA CHIESA
Nei secoli IX e X molte regioni europee conobbero ordinamenti ecclesiastici caratterizzati dal
pieno controllo delle dignità ecclesiastiche, dalle minori alle più elevate, da parte di signori laici
costoro erano soliti scegliere i titolari di tali cariche tra le persone che potevano garantire loro
fedeltà e servizi.
I monaci cluniacensi, richiamandosi alla potestà dell’adprobatio, rivendicavano il diritto di
respingere la disciplina consuetudinaria che aveva sottomesso i benefici ecclesiastici, in
particolare quelli del clero regolare, al dominium di signori laici.
Proponevano, quindi, la restaurazione delle norme canoniche sulle elezioni e la condanna di tutte
le pratiche simoniache cui correntemente si ricorreva per la scelta dei titolari delle dignità.
L’ingerenza laica nell’ordinamento ecclesiastico si era affermata in virtù delle concrete necessità
insorte nella vita produttiva ad organizzativa dei benefici si era, infatti constatato che, per la
maggior parte, questi ultimi non riuscivano ad ottenere dal signore ecclesiastico la protezione di
cui le comunità avevano bisogno e, di conseguenza era maturata l’esigenza di integrare il potere
di banno del titolare della dignità ecclesiastica con quello di un altro dominus.
Il programma riformistico si completò allora con l’individuazione di un’autorità bannale in grado
di assicurare, insieme con la piena difesa del clero e delle comunità residenti nei benedici, anche
la continuità della libertas Ecclesia tale autorità era quella del vescovo di Roma, primate della
Chiesa delle terre occidentali e quindi vertice naturale di tutte le dignità ecclesiastiche, e dei
benefici loro collegati, esistenti nelle medesime regioni.
Il programma riformistico cluniacense, allora, trovava nella signoria fondiaria pontificia il suo
elemento focale.
La riforma ebbe una significava diffusione nel mondo occidentale.
La soluzione cluniacense, se individuava il dominus che doveva integrare l’autorità curtense del
titolare del beneficio, di fatto non risolveva completamente il problema della protezione ordinaria
del beneficio stesso per la maggior parte dei monasteri del mondo occidentale il pontefice
costituiva un’autorità lontana e la sua protezione si esprimeva attraverso l’autorevolezza della sua
superiore dignità e l’obbedienza ad essa dovuta dai fedeli, non certo in interventi effettivi, che
potevano verificarsi soltanto in via saltuaria ed eccezionale.
Questa situazione allora lasciava aperti spazi all’ingerenza di signori laici nella gestione dei
benefici: un’ingerenza che non poteva assumere la forma giuridica del dominium, dato che il
89
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
dominus superiore era il solo pontefice, e assumeva allora quello dell’advocatia, il potere di
protezione, cioè, non legato necessariamente al diritto reale.
Il potere di advocatia venne assunto in genere dai grandi domini fondiari che nella loro regione
erano in grado di esercitare autorità di signore territoriale vi si rivolgevano le abbazie che si
volevano liberare della presenza opprimente del signore fondiario.
Nei monasteri riformati, il dominio superiore spettava al pontefice, che riconosceva non solo che
l’abbazia era titolare di un dominio, ma anche che la gestione del beneficio doveva essere svolto
da questa con un’ampia sfera di immunità dalla Santa Sede e il signore territoriale si faceva
garante del rispetto di tale ordinamento.
Il programma cluniacense riguardava soprattutto i benefici del clero ordinario; ma il movimento
riformistico da lui innestato si estese in breve anche ai benefici del clero secolare, coinvolgendo
in tal modo una gamma ben più estesa di interessi.
A partire dall’inizio del secolo XI la Chiesa venne maturando la convinzione che il dominium
pontificio doveva essere rivendicato per tutti i benefici ecclesiastici e, di conseguenza, dovevano
essere abrogate tutte le norme, per lo più di origine consuetudinaria, che riconoscevano gli stessi
come parte di patrimoni di potestà laiche.
Il punto nodale in discussione era l’individuazione della potestà superiore legittimata ad
<investire> il titolare della dignità ecclesiastica, assegnandogli la carica e mettendolo in possesso
del patrimonio a questa collegato, la lotta tra papato e Impero è stata definita “lotta delle
investiture”.
La difesa della libertas Ecclesiae presenta, allora, un duplice aspetto:
lotta contro i signori locali che vantavano forme di dominium sui benefici;
e lotta contro gli imperatori che rivendicavano l’appartenenza dei patrimoni beneficiali al
demanio imperiale e proclamavano il proprio diritto di mundeburdio, di protezione, cioè,
sull’intero ordinamento della Chiesa.
A Gregorio VII si deve la compilazione di un’opera di grande interesse, il Dictatus Papae, una
raccolta di ventisette proposizioni che introducevano una radicale modifica dell’ordinamento
ecclesiastico attraverso la ricezione dei principi fondamentali del programma riformista.
Vi si sosteneva, infatti, la sostituzione della tradizionale articolazione paritetica dei vescovati con
una struttura gerarchica al vertice della quale era posto il vescovo di Roma costui, erede
diretto di S.Pietro, veniva dichiarato, proprio in virtù di tale qualifica, immune da qualsiasi
superiore autorità, spirituale e temporale, e di conseguenza , da ogni giudizio terreno.
Nella formulazione del Dictatus, il pontefice non era soltanto il dominus dell’intero patrimonio
beneficiale della Chiesa occidentale, come avevano sostenuto i cluniacensi era il vertice
dell’intero ordinamento giuridico ecclesiastico, il perno su cui quello poggiava, il garante della sua
sopravvivenza e della sua libertà dagli ordinamenti temporali.
90
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
L’organizzazione della Chiesa secolare e regolare si fondava ovunque sul principio della libertas da
ogni altro ordinamento e sulla superiore autorità del papa, vertice di ogni potestà e garante
massimo della medesima libertas.
PARTE SECONDA – IL BASSO MEDIOEVO
CAPITOLO 1 – LA RINASCITA DEL SECOLO XII
1. INTRODUZIONE
Nella seconda metà del secolo XI in alcune regioni dell’Europa occidentale ci fu una ripresa della
vita economica tale ripresa si accentuò e si diffuse nel secolo successivo, provocando una
trasformazione degli ordinamenti giuridici e degli assetti sociali.
Essa si caratterizza per un deciso miglioramento delle condizioni ecologiche e di vita, per
l’espansione della produzione rurale e per il crescente sviluppo del commercio a lunga distanza.
L’interpretazione di queste cause è dominata dalla tesi di Pirenne, secondo cui motore primo fu la
riattivazione delle linee del commercio a lunga distanza che avrebbe portato alla ripresa degli
scambi locali e alla crescita della produzione fondiaria quindi la ripresa del commercio a lunga
distanza sarebbe stata la causa principale della rinascita delle città.
Non tutti gli studiosi sono però d’accordo, il Bloch accetta la ripresa mercantile come fattore
primario ma riconosce molta importanza anche alle trasformazioni della produzione agricola e
dell’organizzazione signorile.
Invece, il Dobb ha sottolineato il ruolo svolto da fattori interni al sistema curtense (come la
tensione dei contadini verso il miglioramento delle condizioni di vita) nello sviluppo del sistema
fondiario e ha rilevato l’importanza del fatto che la ripresa mercantile coesisteva con il perdurante
regime signorile.
Oggi la storiografia riconosce una pluralità di fattori e mette in risalto l’incremento demografico,
lo sviluppo del commercio locale, l’uso di strumenti tecnicamente più avanzati nella coltivazione
agricola, il valore della messa a cultura di nuove aree, il duplice processo della colonizzazione
interna ed esterna.
2. LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLA SIGNORIA FONDIARIA
In questo periodo la struttura dell’azienda signorile subisce una sensibile trasformazione.
L’ordinamento fondiario si era fino ad allora basato sulla divisione del dominio in riserva
dominicale e in terra divisa in mansi questi ultimi erano assegnati a contadini liberi e non, i
quali dovevano cedere al signore parte del prodotto ottenuto e dedicare alcune giornate
lavorative alla coltivazione della riserva signorile.
91
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Tale ordinamento era diretto in primo luogo al soddisfacimento del fabbisogno interno al quale
non potevano contribuire prodotti esterni provenienti dal mercato.
Nella nuova realtà economica affermatasi a partire dalla seconda metà del secolo XI questo
ordinamento risultò superato e inadeguato alle necessità produttive i signori fondiari
cominciarono a cercare un incremento della produzione sia per far fronte alla domanda interna
cresciuta in seguito all’espansione demografica, sia per destinare al mercato una parte del
prodotto eccedente il consumo interno.
Questo obiettivo è perseguito innanzitutto attraverso il dissodamento di aree prima trascurate.
Secondo Duby vennero utilizzati tre sistemi principali:
- furono attaccati i terreni boscosi e paludosi confinanti con i villaggi per accrescere le
radure ed ampliare l’area destinata al pascolo;
- fondazione di nuovi stanziamenti contadini nel cuore delle foreste;
- venne ampliata l’area destinata alla coltivazione, grazie all’apertura di nuovi arativi in
territori rimasti fino ad allora boscosi o paludosi o lasciati al pascolo.
L’incremento della coltivazione è stato possibile anche grazie all’introduzione di strumenti tecnici
più avanzati come l’aratro pesante che permetteva di coltivare terre più dure.
Accanto alla ricerca di nuovi territori fu la modifica dell’organizzazione interna della signoria
fondiaria a consentire una crescita consistente della produzione rurale.
A partire dalla seconda metà del secolo XI si avvertì un graduale cambiamento consistente nella
trasformazione dei mansi in fondi concessi dietro pagamento di un censo ed esenti da prestazioni
personali di lavoro e nella contrazione della riserva signorile trasformata in gran parte in lotti
assegnati in affitto o a censo.
La graduale riduzione delle corvées e la trasformazione dei contadini in censuari ebbe la
conseguenza di stimolare la produzione, impegnando in maniera esclusiva sul fondo la forza
lavorativa del contadino che possedeva il lotto.
Il censo assunse forme e caratteri diversi, ma comunque consisteva nel versamento di una
quota del prodotto sotto forma di parte del raccolto o di denaro.
Il fenomeno della divisione in lotti della riserva signorile non è stato riscontrato ovunque, ad
esempio in alcuni territori francesi la riduzione della riserva deriva dalla sua spartizione tra gli
eredi del signore, conseguenza di un regime ereditario.
L’aspetto più interessante dell’evoluzione dell’ordinamento fondiario risiede nella progressiva
espansione delle potestà bannali del signore in questo modo si garantiva una consistente
quota del prodotto contadino accentuando i contenuti della sua autorità di governo e di guida sui
possessori dei mansi, accrescendo l’ambito della giustizia signorile e limitando l’efficacia
dell’antico ordinamento della tradizione popolare e la competenza delle corti di giustizia.
L’espansione delle potestà bannali si accompagnò con un’azione diretta ad estendere il dominio
fondiario a danno di possedimenti allodiali e di minori signorie vicine in questi casi l’allodio si
92
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
trasformava in lotto, posseduto in affitto o dietro pagamento di censo, e il suo proprietario
originario assumeva una condizione giuridica analoga a quella degli altri contadini liberi.
L’espansione delle potestà bannali e l’estensione del dominio signorile su allodi e aziende curtensi
minori avevano la conseguenza di ridurre i contenuti dei diritti tradizionali degli uomini liberi e di
contrarre l’ordinamento di origine popolare.
La condizione giuridica del libero rientrante nella giurisdizione signorile è caratterizzata da vincoli
di soggezione, di modo che l’espressione più genuina del soggetto di diritto diventava il signore
fondiario il cui patrimonio non rientrava nell’organizzazione curtense di altri e poteva liberamente
disporre dei propri beni.
La nuova struttura interna dell’azienda signorile impose al titolare la necessità di avvalersi di
agenti che amministrassero i poteri bannali tali agenti erano domestici, appartenevano cioè
alla familia del signore ed erano di stato servile; erano retribuiti mediante la concessione di un
fondo, del cui prodotto avevano il diritto di appropriarsi senza lasciare una parte al signore,
nonché attraverso l’attribuzione di una quota delle entrate che riscuotevano.
L’evoluzione dell’ordinamento fondiario risulta conosciuta tra la seconda metà dell’XI sec. e la fine
del successivo da molte regioni dell’Europa occidentale:
in Francia tendenza di signori territoriali, in particolari castellani, si affermavano come
signori fondiari nell’area da loro controllata, attraverso la formazione degli allodieri liberi in
affittuari e dei minori signori fondiari in feudatari.
Inoltre, vi è la tendenza verso la trasformazione dei mansi signorili in fondi concessi a senso e
verso la progressiva riduzione delle corvées contadine;
in Germania il sistema della villicatio cominciò a modificarsi, i signori dividevano in lotti sia
l’area dei mansi, sia la riserva e li concedevano in affitto con contratti a breve termine, ed
accentuarono i contenuti dell’autorità bannale su coloro che partecipavano alla produzione
curtense.
Nelle regioni meridionali era più limitata la tendenza alla contrazione della riserva
dominicale, che spesso risulta conservata intatta e destinata a colture particolari.
In Italia la storiografia è concorde ad affermare che la crescita si verificò prima che altrove grazie
alla crescita demografica, l’espansione produttiva e la modifica dell’ordinamento interno.
Anche qui si verificò la tendenza a ridurre la riserva domenicale, alla trasformazione in lotti da
concedere con contratti agrari dietro versamento di canoni annui e alla riduzione delle corvées.
In questo modo i contadini erano stimolati a lavorare il loro possedimento mentre il signore
aumentava il suo potere bannale per conservare il controllo sulla comunità.
L’evoluzione del regime fondiario nell’Italia centro-settentrionale presenta, comunque, caratteri
particolari per la forte presenza di centri cittadini e per l’influenza che questi esercitarono sulla
produzione rurale e sugli ordinamenti signori.
93
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
In Spagna si aggravò la crisi della piccola proprietà allodiale e si consolidò il processo di
inserimento di questi fondi liberi all’interno delle maggiori signorie fondiarie.
In Inghilterra, l’azienda curtense del precedente periodo anglosassone si modificò per influenza
francese si affermò l’ordinamento del manor, che presenta analogie con il sistema signorile
francese della seconda età feudale.
Anche nell’ordinamento inglese il signore fondiario accentuò nel corso del XII i suoi diritti bannali
e cercò di ampliare la sua autorità giurisdizionale sui contadini e censuari.
Infine, la colonizzazione germanica nelle regioni ad est dell’Elba dette via ad un tipo di
ordinamento differente da quello dei territori occidentali per attirare i contadini nelle nuove
terre vennero infatti offerti loro non solo il possesso pieno di un manso, ma anche ampi diritti
personali.
3. LE ORIGINI DELLA RINASCITA CITTADINA
La ripresa demografica e produttiva iniziata alla fine del secolo XI trova la sua espressione più
significativa nella rinascita della vita cittadina.
Per quanto riguarda le origini di questa rinascita:
alcuni studiosi sottolineano la continuità tra la tradizione cittadina romana e quella
medievale;
altri attribuiscono il merito della ripresa alla tradizione comunitaria germanica o alla
consuetudine di vita;
altri infine vedono i privilegi di mercato concessi dai signori fondiari.
Tali teorie vengono superate dalla tesi del Pirenne, secondo cui la città medievale presentava il
prevalente carattere di centro artigianale e mercantile, perciò la sua fioritura era frutto della
ripresa commerciale in seguito alla riapertura delle grandi linee del commercio internazionale.
Oggi la rinascita cittadina non è più vista come fenomeno unitario, uguale in tutti i territori, bensì
come realtà diversa da regione a regione.
Si è soliti distinguere tre diverse aree:
- La prima, costituita dalle regioni settentrionali della Germania e dell’Inghilterra, viene
caratterizzata per l’assenza di una significativa tradizione urbana di origine romana, per la
presenza di una popolazione limitata, per la prevalenza di insediamenti rurali dominati
dai signori.
In quest’area gli stanziamenti diversi da quelli rurali erano costituiti dai wiks (vici),
agglomerati di comunità mercantili sistemati lungo le linee principali del commercio;
- Diversa la situazione nella seconda area, ovvero le regioni nord-occidentali europee.
La tradizione romana qui non è del tutto assente, gli stanziamenti mercantili assunsero
94
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
anche qui la forma del wik ma erano posti ai bordi dei castelli signorili o di mura urbane
allo scopo di ricevere protezione e tutela.
Caratteristica di questa zona è il tipo di insediamento articolato in due nuclei abitativi
distinti: il castrum, il castello o la città fortificata dominata da un signore in cui trovava
rifugio la popolazione; il suburbium, posto al margine della fortezza e sede dei mercanti.
- L’Italia centro-settentrionale e il Meridione della Francia costituivano la terza area,
caratterizzata da una continuità della tradizione urbana del mondo romano a
differenza delle altre regioni occidentali, qui la vita cittadina non si spense mai del tutto
ed in molti casi conobbe un’intensa attività sotto la guida dei vescovi.
Secondo l’interpretazione più diffusa, in queste tre aree dunque la rinascita cittadina sarebbe
avvenuta in maniera diversa.
Per quanto riguarda le prime due, si ritiene che, in un quadro istituzionale caratterizzato dalla
rottura dell’ordinamento carolingio e dalla parcellizzazione della sovranità, la grande crescita
economica conosciuta in seguito alla riattivazione delle linee del commercio a lunga distanza
indusse i mercanti a fondere le due componenti in cui si articolava l’insediamento altomedievale e
a cercare una piena autonomia della città dal signore.
Uniti in associazioni giurate, dette conjurationes, mercanti ed artigiani avrebbero assimilato gli
altri ceti abitanti nella città e avrebbero guidato il movimento di ribellione.
Alle origini del movimento cittadino troviamo anche altri gruppi urbani diversi come gli scabini o
le corporazioni di vicini.
Secondo Max Weber anche nelle regioni germaniche la vita cittadina era stata riattivata ad opera
di gruppi di famiglie titolari di signorie fondiarie.
Poi con la tesi del Pirenne venne evidenziato che le conjurationes erano strette da signori fondiari
della zona.
Secondo la tesi di Duby, i signori fondiari cominciarono a disporre di eccedenze di prodotto e le
destinarono al mercato dove potevano acquistare beni diversi dai frutti della loro terra, il risveglio
della domanda e dell’offerta conferì nuova vitalità ai centri dando origine alla rinascita delle città.
Diversa è l’interpretazione generalmente accolta in storiografia in merito all’Italia centro-
settentrionale e nelle regioni meridionali della Francia, zone in cui le città di origine romana non
erano mai state abbandonate.
Gli storici si sono posti il problema della continuità diretta del centro urbano romano in quello
medievale e per lungo tempo è prevalsa l’opinione di una diretta derivazione del secondo dal
primo.
Oggi questa tesi è scarsamente condivisa dagli studiosi, i quali considerano la città romana
centro di amministrazione e di consumo, mentre giudicano quella medievale centro di produzione
95
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
artigianale e mercantile, ed al contempo mettono in luce la derivazione della ripresa cittadina da
fattori sociali ed economici maturati nell’alto Medioevo.
Il Dilcher ha sottolineato che l’eredità romana si manifesta nel fatto che la città continuò a
rivestire un ruolo significativo nella società come centro di residenza e di produzione per alcuni
gruppi.
La rinascita cittadina nell’Italia centro-settentrionale fu dovuta soprattutto all’incremento della
produzione fondiaria grazie a tale incremento alcuni signori poterono investire nel mercato e
si sarebbero quindi uniti ai mercanti e agli artigiani dando vita alla nuova organizzazione del
Comune cittadino.
La storiografia ha cercato di individuare meglio la composizione del gruppo di signori fondiari
promotori della rinascita cittadina e tra di loro ha trovato liberi possessori discendenti dagli
arimanni longobardi e feudatari dei maggiori signori laici ed ecclesiastici.
Oggi il fenomeno della rinascita della città viene inserito in un quadro istituzionale generale
caratterizzato dalla profonda crisi dell’ordinamento carolingio, crisi che avrebbe facilitato la
formazione di nuove strutture organizzative.
E’ stata quindi proposta una distinzione tra le regioni lombarde e quelle toscane:
nelle prime la crisi dell’ordinamento del regno avrebbe favorito l’affermazione dei vescovi
come signori territoriali;
in Toscana invece le strutture istituzionali conservarono maggiore vitalità e non cedettero
alle pretese signorili dei maggiori episcopati.
Come ha precisato il Dilcher, elementi caratteristici della città medievale sono la pace, la
libertà, il diritto particolare e l’organizzazione.
1) Per quanto riguarda la pace, si deve ricordare che la rinascita municipale deriva
dall’accordo di un gruppo di persone le quali stabilirono di vivere nell’ambito del territorio
delimitato dalla cerchia delle mura urbane nel rispetto dei diritti di ciascuno di loro.
2) Quanto alla libertà, si deve sottolineare che coloro che facevano parte della comunità
avevano lo status di liberi, di soggetti di diritti esenti da ogni forma di subordinazione
personale ad altri; lo status di libero comportava sia la piena capacità giuridica, sia
l’assoluta disponibilità del patrimonio.
Lo status giuridico del componente della comunità cittadina era uguale a quello del
signore fondiario che non riconosceva alcun signore superiore a sé e si distingueva dalla
condizione dei liberi nelle aziende curtensi e dai signori soggetti ad altri signori.
3) Per quanto riguarda il diritto particolare, appare evidente che all’interno di una comunità
residente nel medesimo ambito territoriale i rapporti giuridici intersoggettivi si
modellavano secondo le condizioni economiche e naturali in cui la comunità stessa si
trovava a vivere, cioè vennero regolati da consuetudini che nascevano dalle concrete
esigenze di ciascuna collettività e dunque variavano da luogo a luogo, differenziando
96
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
inoltre il mondo cittadino da quello rurale, dominato dagli usi giuridici che regolavano la
vita della signoria fondiaria e territoriale.
4) Ultimo elemento è l’organizzazione o ordinamento: ogni comunità cercò di provvedere
all’amministrazione diretta della propria esistenza, alla tutela dei diritti dei suoi
componenti, alla difesa del proprio territorio.
Di questi quattro elementi, i primi due appaiono i principali, quelli cioè che furono alla base
della nascita del nuovo ordinamento cittadino.
In tutte le regioni europee, infatti, la comparsa della nuova unità istituzionale costituita dalla città
si caratterizzò per l’esigenza di conseguire la completa libertà personale e la piena, assoluta,
disponibilità dei loro patrimoni fondiari.
Appare evidente che la ripresa della vita urbana derivò dal complesso fenomeno della rinascita
economica e non può essere attribuita ad uno solo dei fattori che compongono questo fenomeno.
Di grande significato è l’evoluzione che dalla seconda metà dell’XI sec. andava conoscendo il
mondo signorile la ricerca di un’espansione del prodotto rurale dovette sollecitare i signori
fondiari più potenti ed i signori territoriali ad estendere il contenuto della propria autorità
cercando di trasformare in propri concessionari i minori signori fondiari e gli allodieri.
La risposta a tale azione fu la formazione della comunità cittadina vi partecipavano non solo
signori fondiari, ma anche piccoli proprietari allodieri.
Il movimento cittadino fu uno dei modi in cui si espresse l’evoluzione della società europea in
quel periodo.
Gli ultimi due elementi possono essere considerati la conseguenza necessaria dei primi due.
Infatti la consuetudine di vita comune dette vita a usi giuridici particolari i componenti della
comunità urbana erano tutti liberi e godevano della piena disponibilità dei loro beni, tale
situazione favoriva lo svolgimento di scambi mercantili.
Più complesso è il discorso sull’organizzazione cittadina.
La conseguenza della conjuratio originaria era la formazione di un ordinamento distinto da quello
che faceva capo al signore, un ordinamento capace di tutelare i diritti individuali di coloro che
avevano giurato l’alleanza, di proteggere la nuova comunità, di attuare le decisioni adottate da
quest’ultima.
Con la formazione della realtà municipale prendeva forma una nuova unità istituzionale dotata di
un preciso ambito territoriale.
Un’unità istituzionale che si distingueva da quella signorile soprattutto perché la sua guida non
spettava ad una sola persona, bensì alla comunità di signori che avevano posto in essere la nuova
realtà; ma i contenuti del potere erano del tutto eguali sia per il signore sia per la comunità.
97
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Alcune comunità furono in grado di assolvere da sole i propri compiti (Comuni dell’Italia centro-
settentrionale) in questo caso, l’organizzazione cittadina fu autosufficiente.
Altre invece ebbero bisogno della collaborazione di un signore fondiario (come nelle regioni
centro-settentrionali d’Europa), stabilendo una sorta di governo diarchico con due distinte sfere
di competenza di cui una era rappresentata da membri della comunità, l’altra da delegati del
signore fondiario.
4. GLI ORDINAMENTI COMUNALI DELL’ITALIA CENTRO-SETTENTRIONALE
La giurisdizione cittadina più ampia è quella dei Comuni italiani.
La storiografia segnala alla loro origine una conjuratio, un patto di alleanza stretto tra soggetti
liberi di varia estrazione sociale.
Secondo alcuni studiosi tale conjuratio avrebbe dato vita ad un’alleanza di natura “privata” che
avrebbe riguardato esclusivamente i contraenti, escludendo ogni altro abitante della città con
il passare del tempo, questa associazione avrebbe eroso il potere del signore e avrebbe finito per
coinvolgere tutti coloro che risiedevano all’interno della cerchia urbana.
L’esistenza di una conjuratio alle origini di tutti i Comuni è stata messa in discussione da Goetz e
Leicht, i quali hanno rilevato la debolezza delle testimonianze rinvenibili in proposito nelle fonti.
Quindi:
Alcuni studiosi le attribuiscono il carattere di associazione privata;
Altri natura pubblica.
Questa discussione tra natura pubblica e privata nasce dal diverso modo di intendere la prima
apparizione del Comune:
I primi lo vedono come associazione rientrante nel quadro signorile e priva di precisi
connotati territoriali;
I secondi lo intendono come unità istituzionale già definita e dotata di un ambito
circoscrizionale definito.
Si deve rilevare che la rinascita cittadina nelle regioni dell’Italia centro-settentrionale fu
precedente a quella conosciuta dagli altri territori europei, dato che nella penisola le condizioni
generali vennero precocemente a maturazione.
Sin dagli ultimi decenni del secolo XI il movimento comunale acquistò in Italia connotati precisi:
nel 1099 a Genova venne concluso il primo accordo giurato, la cosiddetta Compagna Communis, a
fondamento dell’istituzione cittadina.
All’origine della nuova realtà unitaria istituzionale sembra trovarsi sempre un accordo tra signori
di terre poste nella zona circostante la città costoro decidevano di allearsi tra loro per poter dar
vita ad un ordinamento separato e distinto da quelli che facevano capo alle autorità fondiarie o
territoriali della regione.
98
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
I due ordinamenti, quello comunale e quello signorile, vissero per un certo tempo affiancati, dato
che il primo non era ancora in grado di caricarsi dell’intero complesso di funzioni che il potere
signorile svolgeva nei riguardi della comunità e aveva bisogno dell’integrazione fornita da questo.
Promotori e partecipi dell’accordo iniziale sembrano essere soprattutto i signori fondiari della
zona.
Fine principale dell’associazione era, infatti, la difesa dei patrimoni fondiari degli associati
contro le pretese signorili delle maggiori autorità della regione.
Chi aderiva alla nuova comunità si proponeva di guidare in piena libertà il proprio dominio
fondiario, di farne sviluppare ed espandere la produzione, appropriandosi dell’intera rendita
senza doverla dividere con un signore di grado più elevato.
All’interno dell’azienda patrimoniale non si pose nessun cambiamento di gestione, il rapporto tra
il signore e le comunità contadine del suo dominio non si modificò per effetto della rinascita
comunale ma continuò a seguire gli stimoli che venivano dall’espansione del mercato.
La rinascita cittadina non introdusse nel mondo rurale circostante un diverso modo di produzione,
ma si inserì come elemento importante dell’evoluzione economica che aveva conosciuto
spontaneamente l’azienda fondiaria.
I signori che dettero vita all’istituzione cittadina portarono in questa anche le forme associative ed
organizzative cui erano usi nel mondo rurale.
La storiografia recente sottolinea la presenza di consorterie familiari che, al loro interno, si
articolavano in maniera gerarchica, quindi la nuova unità comunale sembra essere sorta
dall’incontro di più consorterie L’articolazione consortile della prima società comunale ci
mostra che la stessa non era una comunità di uomini liberi perfettamente uguali tra loro.
Il ceto prevalente risulta formato dai principali esponenti delle consorterie familiari dal cui
accordo aveva preso vita l’istituzione municipale, mentre la restante popolazione urbana si
trovava divisa tra gruppi associativi e seguiva le direttive stabilite dai capi di tali gruppi.
Obiettivo dell’ordinamento giuridico cittadino è sempre quello di difendere i diritti dei signori che
lo avevano creato.
Con la nascita del comune tale forma di autorità si espanse ulteriormente, perché le consorterie
originarie si estesero a gran parte degli abitanti della città.
La prima società comunale presenta al suo vertice un ristretto gruppo di potenti (capi delle
consorterie), i quali detenevano il monopolio del potere unitario in città a loro erano
riservate in via esclusiva le principali cariche di governo per assumere le decisioni più importanti
ed amministrare la giustizia.
La forma di governo affermatasi in questo periodo comprendeva:
un’assemblea generale (anche detta parlamento, consiglio, ecc) era l’espressione
immediata della collettività dei soggetti liberi e si riuniva solo in occasioni straordinarie per
prendere importanti decisioni per la vita dell’intero municipio;
99
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
i consoli il numero variava ed erano scelti fra le famiglie principali, a loro spettava il
governo dell’unità comunale e l’amministrazione della giustizia, la durata della carica era
annuale;
la credenza un consiglio più ristretto formato dalle famiglie più potenti che assisteva i
consoli, chiamato così perché composto da “homines credentes – degni di fede”.
I titolari dell’ufficio consolare dovevano coordinare le proprie scelte e la propria azione con la
volontà di tale consiglio ristretto e non avevano la possibilità di modificare l’assetto cittadino a
vantaggio dei gruppi consortili e familiari.
La natura signorile dell’ordinamento comunale consente di comprendere alcuni aspetti del
primo governo cittadino.
Innanzi tutto è da rilevare come, al pari dei signori territoriali che si avvalevano di agenti per
l’esercizio del loro potere, anche il governo consolare fosse coadiuvato da magistrati, scelti dai
consoli e preposti agli uffici municipali si tratta del camerario, responsabile della gestione delle
entrate, degli estimatori, incaricati della valutazione di beni mobili e immobili, dei consoli della
giustizia, devono esaminare e decidere le vertenze giudiziarie, dei gastaldi, controllano il regolare
svolgimento delle operazioni di mercato, dei notai, registrano gli atti di governo.
Il regime consolare si presenta con una notevole flessibilità che non puntava a monopolizzare le
funzioni di carattere pubblico nelle città.
Il sistema comunale, nato come mezzo per difendere e tutelare i diritti e la potestà di signori
fondiari, non potrebbe mai assumere l’obiettivo di eliminare gli stessi diritti.
Si deve infine rilevare che il Comune cittadino si comportava in maniera analoga alle signorie
territoriali al pari di questa cercava di difendersi da tentativi promossi da altri signori per
sottometterlo alla loro superiorità e di rafforzare la propria autorità e potenza estendendo la sua
zona di competenza.
L’ampliamento della sfera territoriale del Comune non poteva indirizzarsi se non nella campagna
circostante la città.
Un tratto di questa zona risulta sin dall’inizio collegata al Comune: si tratta del territorio occupato
dai patrimoni delle famiglie che avevano dato vita all’istituzione municipale e che ricevevano da
quest’ultima immediata e diretta protezione.
Nel corso del secolo XII, poi, troviamo un movimento di inurbamento volontario, cioè le famiglie
signorili della campagna circostante la città si mettevano sotto la potestà comunale poiché
assicurava ai patrimoni agrari uno sbocco sicuro e remunerativo delle eccedenze di prodotto.
Dal canto suo il Comune aveva bisogno di controllare la campagna circostante sia per conseguire
un’adeguata difesa del territorio urbano, sia per avere il pacifico controllo delle principali vie di
accesso alla città ed assicurarsi una regolare e consistente acquisizione delle materie prime e dei
beni alimentari prodotti nella zona.
100
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Non sempre l’assimilazione della nobiltà fondiaria nella comunità cittadina avvenne in via pacifica.
Comunque il Comune rispettò completamente le potestà signorili e non pretese mai di
sostituirsi ad esse, si limitò soltanto a riservarsi il potere di intervenire in casi eccezionali.
Il governo comunale, quindi, nel periodo consolare non creò mai magistrature e uffici per
l’amministrazione della campagna, che veniva definita in genere con il termine di contado o
distretto ciò non significa che la subordinazione dei signori del contado alla signoria comunale
non avesse alcuna espressione sul piano istituzionale.
In effetti, essa favorì innanzi tutto la formazione dei cosiddetti Comuni rurali, organizzazioni
comunitarie di villaggi e centri minori, i quali rivendicavano alcune maggiori libertà dal signore
fondiario cui facevano capo o si muovevano per uscir fuori dal dominio di questo e mettersi sotto
il diretto controllo del Comune.
L’ordinamento comunale nel periodo consolare risulta consistere nella signoria territoriale
riguardante un’ampia zona, incentrata in una città, signoria la cui titolarità spettava ad un ristretto
gruppo di famiglie risulta quindi difficile immaginare una differenza sostanziale tra il potere
comunale e quello signorile.
I Comuni e le signorie della vicina campagna costituivano due espressioni della medesima realtà
produttiva e sociale e gli stretti vincoli riguardavano anche i profili economici ed istituzionali.
I contrasti e le lotte che di frequente divisero i grandi Comuni dalle più potenti signorie della
campagna non possono essere intesi come manifestazione dell’incompatibilità tra due diverse
forme istituzionali, ma devono essere interpretati come espressione della dialettica interna ad
una realtà omogenea, così come lo erano le guerre che continuavano a dividere tra di loro i
signori territoriali.
Si deve sottolineare inoltre che troviamo delle consistenti modifiche degli equilibri sociali
originari: troviamo una modifica della struttura delle consorterie originarie, le quali passarono da
gruppi di famiglie consanguinee in fazioni, raggruppamenti più articolati e diversificati al loro
interno.
La fazione si presenta come un’associazione verticale ed orizzontale a un tempo, la quale univa
grandi e piccoli uomini e costituiva la forma assunta dal naturale adeguamento
dell’organizzazione consortile originaria alle profonde trasformazioni sociali.
Inoltre, la complessità degli interessi e la molteplicità dei gruppi che caratterizzavano la fazione la
rendevano unità meno compatta dell’originaria consorteria.
Tra ultimi anni del XII sec. e i primi del successivo, il governo consolare cominciò ad essere
sostituito da quello imperniato su un unico magistrato, il podestà.
5. IL CASO DI VENEZIA
101
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
La rinascita cittadina tra la fine del secolo XI e la prima metà del successivo aveva interessato tutte
le regioni dell’Italia centro-settentrionale queste si dividevano in due aree principali:
quella che riconosceva l’autorità dell’Imperatore dette “terrae Imperii”;
e quella che indicava nel pontefice il suo signore temporale le “terrae Ecclesiae”.
Le vicende ed il carattere degli ordinamenti comunali nelle regioni centro-settentrionali della
penisola presentano aspetti diversi tra di loro, dipendendo dalle condizioni politiche, sociali ed
economiche della regione in cui gli stessi vennero formati, ma mantengono comunque la loro
unitarietà.
Da loro si differenzia, invece, il Comune di Venezia questo si formò nella città lagunare
all’interno della preesistente unità istituzionale del ducato di origine bizantina, assimilando
magistrature ed uffici vigenti in quest’ultimo e presenta una continuità con il passato più
accentuata degli altri comuni.
Negli ultimi decenni del secolo XI, la società veneziana cominciò a conoscere una progressiva
differenziazione tra le famiglie che in maniera più appropriata riuscivano a trarre vantaggio dallo
sviluppo dei traffici con l’Oriente.
Tale differenziazione si accentuò nel corso della prima metà del secolo XII e deve essere messa
alla base della nascita del Comune Veneciarum con la sua istituzione (1152) le principali
famiglie rialtine (dell’isola di Rialto) intendevano conseguire un’adeguata difesa dei loro interessi
e quindi dar vita ad una forma di governo che esprimesse il nuovo assetto sociale.
Esse modificarono il precedente assetto di potere che si articolava:
nell’assemblea generale;
la concio cui tutti i soggetti liberi del ducato potevano partecipare;
e nel doge che garantiva il rispetto dei tradizionali equilibri interni alla società lagunare e
la difesa dei diritti di tutti.
A partire dalla metà del secolo l’elezione del doge risulta sottratta al concio ed affidata ad una
ristretta commissione di sapienti, diretta espressione della ristretta aristocrazia che aveva assunto
di fatto il potere nel ducato.
Nel corso degli anni ’70 furono introdotte alcune rilevanti riforme istituzionali.
Le funzioni dell’antica concio vennero ridotte ai soli compiti di acclamare il doge dopo la sua
elezione e di ratificare le decisioni importanti adottate dalle magistrature principali.
Funzioni di grande rilievo spettavano al Maggior Consiglio, derivazione dell’assemblea dei
sapienti, era l’espressione completa del gruppo dominante a Venezia e svolgeva compiti di
fondamentale importanza.
Al Maggior Consiglio erano eleggibili tutti i membri delle famiglie dell’aristocrazia cittadina che
avessero compiuto i venti anni.
102
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Le dimensioni necessariamente ampie del Maggior Consiglio lo rendevano, però, poco adatto a
seguire con efficacia la gestione del governo.
Di qui l’istituzione di consigli più ristretti i cui componenti erano scelti dal Maggior Consiglio.
Nel 1179 il Maggior Consiglio procedette alla creazione di una commissione di quaranta persone
cui affidò la gestione di alcuni compiti, come la suprema amministrazione della giustizia e la
preparazione dei provvedimenti monetari e finanziari che il Maggior Consiglio doveva approvare.
I membri di questa commissione, detta Consiglio dei Quaranta o Quarantia, restavano in carica
solo un anno.
Nello stesso periodo fu istituito anche il Minor Consiglio, composto di sei membri che erano
eletti dal Maggior Consiglio tra gli aristocratici di oltre venticinque anni e duravano in carica un
solo anno il suo compito era affiancare il doge nella sua quotidiana gestione di governo.
Al vertice del sistema c’era infine il doge, eletto dal Maggior Consiglio, si impegnava con solenne
giuramento (promissione dogale) a rispettare le consuetudini affermatesi nel Comune e
l’articolazione sociale che si era venuta a determinare e le forme istituzionali che la
rappresentavano.
Il doge, i membri del Minor Consiglio e i tre capi della Quarantia costituivano la Signoria, a cui
spettava la formulazione delle principali proposte da sottoporre all’esame dei Consigli, il controllo
sul rispetto delle norme, le decisioni nei momenti di crisi.
6. LE CITTA’ IN FRANCIA E IN GERMANIA
L’ordinamento comunale delle città italiane esprimeva la forma più estesa di giurisdizione
municipale poiché univa alla libertà dei cittadini il loro potere di autogovernarsi.
Tale forma di governo si ritrova raramente nel resto dell’Europa occidentale dove prevalsero
forme di governo che prevedevano una sfera di autonomia cittadina e la continuazione della
precedente signoria territoriale.
Le forme di governo municipale risultano variare da regione a regione.
Si deve avvertire che il fenomeno della rinascita cittadina fu al di là delle Alpi posteriore a quello
delle regioni italiane ne consegue che le forme istituzionali non sempre risultano del tutto
definite nel periodo in esame.
Per quanto riguarda la Francia si deve ricordare come un’interpretazione a lungo dominante e
risalente a Thierry, che distingueva i municipi di quel regno in cinque zone principali:
- assegnando al Midi le forme di governo da consolato;
- al Nord i Comuni, collocando tra le due aree le città di prevostura;
- e infine, delineando due zone ai margini, i modelli principali si presentavano con caratteri
propri.
103
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Attualmente la storiografia francese preferisce distinguere tre soli tipi di città: le città di
prevostura o di franchigia, le città di Comune giurato, le città di consolato, assegnando a ciascun
tipo un’area geografica principale, senza escludere che si possa manifestare in zona diverse.
La forma istituzionale della città veniva fissata in un documento scritto che conteneva i privilegi
municipali e che veniva concesso alla comunità urbana dal signore.
Il primo tipo di città viene definito di franchigia, di prevostura, di borghesia per indicare una
realtà municipale ancora fortemente inserita nell’ambito di una signoria risulta caratterizzato
da tre elementi principali:
la conservazione dell’autorità da parte del signore, il quale si faceva rappresentare da un
agente detto prevosto;
la concessione da parte del signore di una carta di franchigia, nella quale elencava le libertà
spettanti ai cittadini;
la titolarità di una serie di privilegi concessi ai cittadini e che spettavano a chiunque entrasse
a far parte della comunità cittadini.
Le libertà godute dai cittadini riguardavano soprattutto la loro persona, i loro beni e il loro diritto
di rifiutare prestazioni non previste dalla carta di franchigia questo tipo di città riguardavano
l’area attorno a Parigi e la Francia centrale.
Maggiore era l’ambito di autonomia dei Comuni giurati, i quali esprimevano una vitalità cittadina
più sviluppata ed organizzata.
Alla loro origine si rinviene una conjuratio stretta tra soggetti di diritto desiderosi di garantirsi
piena libertà personale, completa disponibilità patrimoniale ed un’ampia sfera di autogoverno.
Alla conjuratio aderivano non solo esponenti di famiglie mercantili, ma anche signori fondiari
della regione circostante.
Alla comunità il signore concedeva una carta di privilegi nella quale concedeva la piena libertà
personale, la completa disponibilità del patrimonio e la potestà di gestire una quota del governo.
Quindi accanto al rappresentante del signore, operavano magistrature municipali sia gli scabini
che erano ufficiali di giustizia questo ordinamento si rinviene nella Francia settentrionale.
Infine le città di consolato si trovano soprattutto nella Francia meridionale.
Prevedevano una sfera ampia di autogoverno ma si differenziavano dai Comuni giurati per il
diverso modo di formazione e per la differente forma di governo.
All’origine delle città di consolato si trova raramente una conjuratio analoga a quella delle città di
Comune.
La loro istituzione avvenne in maniera generalmente pacifica, dato che la signoria cittadina nel
Midi era certamente più debole e meno organizzata di quella settentrionale.
104
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Spesso furono gli stessi signori a favorire la nascita degli ordinamenti municipali; in altri casi
furono associazioni spontaneamente formatesi a chiedere al signore il riconoscimento di
particolari diritti.
La forma di governo, poi, è articolata in un organismo collegiale, composto da consoli , a cui
spettava la guida del governo autonomo attribuito al municipio.
I consoli si avvalevano di un Consiglio ristretto, mentre competenze limitate aveva l’assemblea
generale.
Si deve segnalare l’esistenza di un ultimo tipo di autonomia cittadina, che si rinviene soprattutto
nelle regioni meridionali e che esprime forme sensibilmente limitate di libertà si tratta della
cosiddetta città di sindacato, costituita da comunità residenti all’interno di una signoria le quali
avevano ottenuto il privilegio di ricorrere al signore chiedendo il diritto di gestire liberamente i
propri interessi; tali comunità rimanevano di fatto sotto il governo del loro signore.
Ordinamenti per più versi simili a quelli dei Comuni giurati francesi sono quelli delle città del
mondo germanico: anch’esse si affermarono all’interno di una signoria fondiaria che
continuarono a rispettare, ebbero per lo più origine da un’associazione giurata, una conjuratio,
conclusa tra gli abitanti di un centro urbano desiderosi di sottrarsi alla soggezione signorile.
La prima forma assunta dal diritto cittadino derivò dal riconoscimento della libertà personale e
patrimoniale concesso dal signore a tutti coloro che facevano parte della comunità municipale;
alla tutela dei diritti soggettivi provvedevano magistrati incaricati di tale funzione.
Il signore conservò competenze giurisdizionali e continuò ad occuparsi dell’amministrazione e
della difesa della comunità urbana.
Solo verso la fine del secolo la comunità sostituì il signore nella gestione di una parte del governo
cittadino: la nascita di consigli cittadini segna l’inizio di un governo diarchico nel centro urbano.
Questo modello era diffuso nelle regioni tedesche occidentali in cui signori della città erano nobili,
vescovi, abati, principi e lo stesso imperatore.
7. L’INGHILTERRA
L’ordinamento cittadino in Inghilterra nacque nell’ambito di una signoria fondiaria, regia o
nobiliare che fosse suo elemento essenziale era, come nel Continente, la libertà personale e
patrimoniale dei cittadini, definita in Inghilterra con l’espressione libero “burgage ”.
Tale privilegio costituiva il fondamento dei diritti che caratterizzavano l’ordinamento del municipio
indicato con il termine di borough: l’esistenza di magistrati cittadini che tutelavano i diritti degli
abitanti e la presenza di un mercato al quale era legata l’attività di una parte della popolazione
urbana.
105
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Anche in Inghilterra, come nel Continente, il contenuto dei privilegi municipali era fissato in una
carta che il signore concedeva alla città.
I borghi regi erano tra l’altro tenuti a versare regolari tributi al funzionario che rappresentava il
monarca della regione, lo sceriffo.
La richiesta di autonomia da parte delle città inglesi presenta contenuti originali.
Sin dai primi decenni del secolo XII alcuni borghi regi chiesero al monarca di godere del privilegio
di provvedere in via autonoma alla riscossione del tributo e di consegnarlo direttamente al
competente ufficio della corte sovrana, senza passare attraverso lo sceriffo al fine di evitare
indebite esazioni da parte di quest’ultimo.
Le carte di concessione regia si arricchirono così di un ulteriore privilegio, definito “firma burgi”,
con il quale il sovrano accoglieva l’istanza ora ricordata.
A differenza delle regioni dell’Europa centrale ed occidentale, non si aveva nelle città regie inglesi
la contemporanea presenza di due distinte sfere di giurisdizione, l’una municipale (i Comuni in
Inghilterra non si affermarono) e l’altra signorile.
L’ordinamento rimaneva unico e il sovrano continuava a garantire direttamente l’osservanza dei
diritti speciali della comunità, attraverso funzionari scelti da quest’ultimo: costoro erano
espressione della municipalità ma operavano a nome del re. Il borgo provvedeva al governo della
comunità tramite magistrati- reeves, baglivi, mayor.
Agli stessi magistrati, inoltre, spettava l’attuazione dei doveri di cui il borgo era gravato nei
riguardi del re, doveri che nel secolo XII consistevano nel versamento del tributo cittadino e
nell’amministrazione della giustizia.
Il carattere originale dell’ordinamento istituzionale dei borghi regi inglesi nasceva dagli stretti
vincoli che li legava al monarca.
I cittadini godevano della completa libertà personale e patrimoniale, indispensabile per la
sicurezza dei loro diritti sui beni immobili e mobili e per il pieno sviluppo dei loro interessi
economici.
8. LE CITTA’ NELL’ITALIA MERIDIONALE E IN SPAGNA
La storiografia è stata a lungo dominata dall’idea per cui le città dell’Italia meridionale nel secolo
XII presentavano una scarsa autonomia giuridica e una limitata vivacità economica, si trovavano
cioè in una situazione di profonda debolezza in confronto con i Comuni delle regioni centro-
settentrionali.
Le città meridionali avrebbero goduto in genere di una florida attività mercantile fino alla seconda
metà del secolo XI.
L’occupazione dell’Italia meridionale da parte dei Normanni avrebbe profondamente modificato
questa situazione.
106
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Le città si trovano in rapporto con una potente signoria territoriale che incentrava il proprio
interesse sulla produzione rurale e cercava di estendere il proprio controllo politico alle città.
Tale situazione si aggravò dopo la fusione dei vari domini normanni in un solo regno nel 1130; la
monarchia normanna adottò una politica di repressione dell’autonomia giuridica cittadina e delle
naturali forze commerciali.
Questa impostazione storiografica ha conosciuto una parziale revisione grazie alla chiara presa di
coscienza delle peculiarità della storia meridionale nei riguardi di quella delle altre regioni della
penisola e dell’errore metodologico di una sua interpretazione fondata sul continuo confronto con
la realtà del mondo centro-settentrionale.
L’interpretazione complessiva della situazione delle città meridionali è rimasta legata ai canoni
precedenti si continua ad attribuire alla monarchia normanna la principale responsabilità del
mancato sviluppo mercantile delle città, della sostanziale involuzione che l’economia di molti
centri conobbe nel periodo in esame.
Il favore che i sovrani normanni manifestarono da un canto verso il predominio della grande
nobiltà e la prevalenza della campagna sulla città, dall’altro verso le compagnie mercantili delle
regioni centro-settentrionali, sarebbe stato determinante nel frenare lo sviluppo mercantile
autoctono del Meridione.
A ben vedere, l’idea per cui fu la monarchia normanna a reprimere l’economia urbana del
Meridione si fonda su alcune inesattezze derivanti dall’uso di concetti odierni per
l’interpretazione delle istituzioni medievali.
In primo luogo essa attribuisce alla potestà regia un potere di governo della vita economica di
tutte le articolate realtà del regno quale solo in anni a noi molto vicini è stato raggiunto negli Stati
del mondo occidentale tale rispetto è vero non solo sul piano meramente istituzionale, ma
anche sotto quello economico.
Risulta difficile attribuire ad una monarchia del secolo XII una precisa linea di politica economica
che coinvolgesse tutte le realtà produttive del regno e determinasse le loro scelte.
Le monarchie di questo periodo non si ponevano certamente tali obiettivi, dato che rimanevano
sempre esterne alla vita produttiva di città e feudi, tanto meno avevano i mezzi per imporsi.
Favori, protezione e privilegi vennero concessi a mercanti italiani da numerose case regnanti e
principesche dell’Europa continentale e dalla monarchia inglese a partire dal secolo XII; la
storiografia ha sempre riconosciuto che l’attività di tali mercanti non ostacolò la crescita di
commercianti locali, ma al contrario la favorì.
In secondo luogo, si deve rilevare come l’interpretazione tradizionale consideri le città come
espressione esclusiva del mondo mercantile, insanabile contrasto con il mondo rurale dominato
dalla nobiltà feudale una tale impostazione risulta ancora ferma all’idea di separazione tra
economia agricola ed economia mercantile.
107
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
La città nel Meridione, come nelle regioni centro-settentrionali, non deve essere vista come realtà
contrapposta alla campagna, bensì come a questa intimamente collegata sia sul piano politico-
istituzionale, sia su quello della produzione.
Si deve sottolineare che l’interpretazione tradizionale continua a considerare le città come una
realtà univoca, come centri produttivi accomunati dagli stessi interessi economici e contrapposti
alla produzione signorile delle campagne.
Una simile ottica deve essere respinta, poiché ogni città costituiva un mondo a sé, con propri
interessi economici, con una propria composizione sociale, con un proprio ordinamento
consuetudinario che la distinguevano nettamente da ogni altro municipio.
Le città che si trovavano nella stessa regione erano di frequente in contrasto tra loro perché tutte
ambivano ad un più esteso controllo territoriale.
Le indagini sulle città meridionali nel secolo XII devono sbarazzarsi dell’influenza ancora esercitata
dall’interpretazione tradizionale e ricostruire le condizioni sociali ed economiche dei singoli
centri.
In questa sede ci dobbiamo limitare a sottolineare come la realtà economica fosse
profondamente diversa da un municipio all’altro.
Tale diversità derivava dalle concrete forze sociali che componevano la comunità cittadina e dal
rapporto tra loro e la signoria della circostante campagna.
L’autorità monarchica risulta del tutto estranea al gioco politico e all’evoluzione del sistema
economico.
Nell’Italia meridionale l’assetto sociale cittadino esprimeva una gerarchia di poteri che vedeva
al vertice della comunità un ristretto gruppo di famiglie tra queste e la monarchia si instaurò
uno stretto rapporto d’intesa, dato che le prime avevano bisogno della protezione della seconda e
questa si fondava sul loro controllo territoriale per assicurare la pace interna alle popolazioni e
per ottenere l’indispensabile consenso.
Tale intesa implicava uno stabile equilibrio tra le tendenze unitarie della monarchia e le libertà
necessarie all’ordinamento cittadino; perciò le consuetudini non potevano contrastare con le
disposizioni regie.
Per il medesimo motivo l’autonomia cittadina doveva armonizzarsi con gli altri ordinamenti locali
che componevano il Regno tale armonia venne realizzata con un meccanismo uguale a quello
adottato nel regno inglese e diverso dagli altri nel Continente.
Mentre, infatti, in Francia e in Germania l’equilibrio tra il governo del signore territoriale e
l’autogoverno cittadino si esprimeva in un sistema diarchico, in Sicilia come in Inghilterra il
governo cittadino rimase unico e fu affidato ad un magistrato regio, il quale era scelto
liberamente dalla comunità al proprio interno ed era responsabile della tutela dei diritti specifici
di cui godevano gli abitanti.
108
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Nelle regioni iberiche, il movimento municipale si manifestò già alla fine dell’XI sec. con il
riconoscimento da parte dei sovrani del diritto particolare goduto da comunità cittadine tale
riconoscimento si esprimeva nella concessione di una carica che elencava i diritti dei componenti
della libertà personale e patrimoniale.
Le libertà cittadine trovarono immediata espressione nel consiglio municipale, assemblea che
riuniva tutti i liberi della città tale consiglio era indicato con il termine “consilium”.
L’amministrazione della giustizia e la guida della comunità erano affidate ad uno iudex, assistito da
alcaldes e da jurados.
Anche nei regni spagnoli, quindi, l’equilibrio tra la signoria monarchica e l’autonomia
municipale si espresse nella forma che affidava ad un magistrato regio scelto dalla comunità la
tutela dello speciale diritto di cui i cittadini godevano tale ordinamento non era ripetuto nelle
signorie nobiliari, dove le autonomie cittadine risultano limitate.
CAPITOLO 2 – LA RINASCITA DEGLI STUDI GIURIDICI
1. LA RINASCITA DEGLI STUDI DI DIRITTO GIUSTINIANEO
Nelle regioni centro-settentrionali della penisola nel corso del secolo XI si andò formando un ceto
di giuristi impegnati contemporaneamente nell’attività di giudice, causidico, notaio e nello studio
e nell’interpretazione dei testi giuridici.
Oggetto del rinnovato interesse per le fonti giuridiche e della più sensibile attenzione verso la loro
ricostruzione filologica furono in primo luogo le raccolte della compilazione giustinianea.
Le origini del nuovo corso restano oscure.
Odofredo, giurista del secolo XIII, in una glossa divenuta celebre, affermò che il primo maestro di
diritto giustinianeo sarebbe stato un giurista di nome Pepo o Pepone.
Nonostante i progressi compiuti dalle ricerche più recenti, il contributo di Pepone alla rinascita
degli studi giuridici resta, comunque, imprecisato.
Per tale rinascita fu certamente determinante l’opera di Irnerio, causidico (avvocato medievale) e
giudice tra il 1112 e il 1125, autore di un formulario notarile.
Con Irnerio l’analisi esegetica dei testi di diritto si concentrò esclusivamente sull’opera
giustinianea ed abbandonò le altre raccolte.
Le norme giustinianee furono considerate come diritto vigente, valido per tutti gli uomini liberi e a
prescindere dagli ordinamenti particolari.
L’interesse filologico acquistò nuovi contenuti e l’insegnamento di Irnerio ruppe il precedente
sistema didattico.
La scelta di incentrare l’analisi filologica ed interpretativa sulla compilazione giustinianea esprime
la convinzione secondo la quale l’imperatore bizantino aveva adempiuto alla sua funzione,
109
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
affidatagli da Dio, di precisare un ordinamento giuridico in grado di disciplinare i rapporti
intersoggettivi alla luce dei principi supremi dell’equità e della ragione.
Le norme giustinianee finivano per essere considerate come regole attraverso le quali si era
manifestata la stessa volontà ordinatrice di Dio.
Per quanto riguarda l’opera filologica di Irnerio, bisogna ricordare che le fonti offrono ampia
testimonianza della ricostruzione dei testi giustinianei da lui elaborata, ma la storiografia giuridica
più recente ha messo in particolare risalto la gradualità con cui Irnerio ed i suoi allievi pervennero
alla ricostruzione dei testi giustinianei, rifiutando l’idea dell’improvviso e miracoloso ritrovamento
della raccolta del Digesto nella sua redazione integra.
La compilazione giustinianea risultava composta in 5 volumi, detti “libri legum” o “libri legales”:
primo libro 1-22.2 ed era intitolato “Digestum Vetus”;
secondo libro ultimi libri delle Pandette dal 39 al 50 ed era detto “Digestum Novum”;
terzo libri intermedi che definì “Infortiatum”;
quarto era formato dal Codex che comprendeva i primi 9 libri dell’opera giustinianea;
quinto “Volumen parvum” che comprendeva le restanti 2 parti dell’opera giust. (tres libri,
istituzioni e novelle).
Irnerio, infine, dette inizio ad un insegnamento del diritto che innovava radicalmente rispetto al
passato e avviò un’intensa opera esegetica dei testi giustinianei che andavano ricostruendo.
Per quanto concerne l’insegnamento del diritto si deve ricordare che nell’Alto Medioevo esso
veniva impartito nell’ambito dell’ordinamento delle sette arti liberali articolato nel trivium
(grammatica, dialettica e retorica) e nel quadrivium (geometria, aritmetica, astrologia e musica)
ed ispirato ad una “visione enciclopedica del sapere”.
In questo ordinamento il diritto non costituiva una materia specifica ma rientrava nella retorica.
Tale sistema dialettico venne spezzato da Irnerio che iniziò a leggere i testi giustinianei al di fuori
delle arti liberali e presentò il diritto come materia a sé, separata dalla retorica.
La forma letteraria principale fu la glossa: da questa la scuola inaugurata da Irnerio è detta dei
glossatori.
Era una forma già usata in passato costituita dalla spiegazione di passi e di termini dei testi
giuridici collocata dagli interpreti tra le righe del testo commentato (glossa interlineare) o ai
margini dello stesso (glossa marginale).
Irnerio ed i suoi allievi preferirono la glossa marginale che offriva maggior spazio per l’intervento
interpretativo e indussero una novità a questo genere letterario tradizionale.
110
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Con loro, infatti, la spiegazione del testo venne accompagnata dal richiamo dei “passi paralleli”, le
altre disposizioni delle fonti giustinianee che potevano in qualche modo riconnettersi a quello in
esame.
La glossa, quindi, non si propose solo di spiegare il significato di singole parole o di singoli passi
essa era diretta, attraverso la lettura congiunta ed unitaria dell’intero complesso di norme, ad
individuare le categorie giuridiche usate dai compilatori.
2. LA SCUOLA DEI GLOSSATORI
L’opera esegetica e didattica dei glossatori proseguì con vivace intensità e con costante impegno.
Le opinioni dei maestri erano considerate a tal punto importanti ed autorevoli che su di esse si
andò indirizzando l’analisi dei nuovi interpreti.
Le nuove glosse si proponevano di spiegare quelle precedenti più che la norma giustinianea.
Tra il terzo e il quarto decennio del secolo XIII Accursio, uno dei componenti della scuola, passò al
vaglio il vastissimo materiale di glosse che si era accumulato, scelse quelle che meglio
rappresentavano l’elaborazione scientifica precedente ed elaborò un estesissimo apparato di
glosse (novantaseimila) quest’opera ebbe un immediato successo e venne definita “glossa
ordinaria o magna glossa”.
L’opera dei glossatori era proseguita secondo le direttrici inaugurate da Irnerio. In primo luogo
quella della ricostruzione filologica dei testi giuridici.
Oltre che alla raccolta giustinianea i glossatori, a differenza di Irnerio, volsero la loro attenzione
anche a fonti di diritto diverso, in particolare a quelle di diritto feudale.
Alcuni giuristi, come Giovanni Bassiano, rivolsero la loro attenzione agli usi feudali, mentre
cominciò a circolare una prima redazione delle consuetudini vassallatiche (Libri feudorum).
Si tratta della raccolta detta “obertina” dal nome del giurista Oberto dall’Orto, sollecitato dal figlio
a spiegargli la mancanza di interesse da parte dei maestri bolognesi per questa materia; Oberto
rispose al figlio con due lettere nelle quali descriveva i fondamenti dell’ordinamento giuridico
feudale.
La ricostruzione filologica dei testi continuò ad accompagnarsi con una intensa attività
interpretativa degli stessi.
I generi letterari in cui tale attività si espresse sono stati di recente inquadrati dal Cortese in due
filoni principali, corrispondenti agli obiettivi che l’insegnamento si poneva, quello esegetico e
quello espositivo-sistematico.
Al filone esegetico possono essere assegnate le glosse, le lecturae, le repetitiones, i commenta,
i casus per quanto riguarda le prime si deve ricordare che l’insieme di glosse relative ad uno
dei libri legales è indicato con il temine di apparato e che numerosissimi sono i manoscritti
glossati del Corpus juris a noi pervenuti.
111
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
• Le lecturae raccoglievano i corsi di lezione impartiti dai maestri;
• le repetitiones riunivano le lezioni impartite dai maestri, al di fuori del corso ordinario, a
studenti desiderosi di approfondire la propria preparazione;
• i commenta si proponevano di cogliere il senso della disposizione presa in esame;
• i casus consistevano in elencazioni di fattispecie concrete presentate agli studenti per
rendere più intelligibile il contenuto delle norme analizzate.
Il secondo filone, poi, comprendeva:
• le summae titulorum, ovvero esposizioni sistematiche dei titoli del Corpus juris relativi ad
una specifica materia;
• le summulae, che esaminavano in maniera organica un tema particolare;
• più importanti delle altre le summae, le quali offrivano la trattazione sistematica e
completa di un’intera parte del Corpus juris oggetto delle summae fu prettamente il
Codex, anche se non mancano per il Digesto e per le Istituzioni.
Per quanto riguarda il metodo esegetico, esso si riallacciava all’uso scolastico dei discenti di porre
domande ai maestri da parte degli studenti, per poi passare a veri propri confronti dialettici basati
sul ragionamento logico-deduttivo.
C’erano allora vari generi letterari da utilizzare:
• i quare che contrapponevano due norme apparentemente contradditorie al fine di
tentare una loro armonizzazione;
• i broccarda raccolte di principi generali sui quali si basava la disciplina di una
specifica materia (regulae juris);
• le quaestiones confronti tra opinioni divergenti su un problema teorico (quaestiones
legitimae o dialecticae) o ad un caso concreto (quaestiones de facto o disputate);
• le distinctiones raccolte di ragionamenti condotti secondo il metodo logico-deduttivo;
• le dissensiones dominorum confronto tra opinioni espresse da due o più maestri
senza l’aggiunta della proposta risolutiva del dibattito;
• i tractatus esposizioni sistematiche di una materia diversa dalle summae in quanto si
riferivano non ad una partizione del Corpus juris, ma ad un tema specifico.
L’esegesi dei testi giustinianei veniva condotta all’interno della scuola.
112
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Nella fase iniziale dell’insegnamento bolognese il rapporto tra maestro ed allievo fu disciplinato
esclusivamente dall’accordo raggiunto tra i due; l’accordo dava vita ad una societas tra maestro e
discente, nell’ambito della quale al primo spettava il titolo di magister e di dominus.
Il docente decideva insieme con gli allievi gli argomenti da trattare e con loro sceglieva la sede in
cui tenere scuola.
In seguito alla sensibile crescita del numero degli studenti questa prima forma organizzativa si
rivelò inadeguata.
A partire dalla metà del secolo XII gli studenti cominciarono a dar vita ad associazioni, definite con
il termine di consortia, per aiutarsi a vicenda nella soluzione dei problemi.
Negli ultimi decenni del secolo i consortia vennero sostituiti da un ordinamento associativo di
maggior respiro, l’universitas degli studenti che comprendeva tutti coloro che studiavano a
Bologna.
Era dunque l’associazione degli studenti di cui non facevano parte i docenti; era guidata da capi
liberamente eletti detti consules, poi sostituiti da una carica individuale, quella del rector,
studente liberamente eletto dai suoi colleghi, il quale rappresentava l’universitas nei rapporti con
il governo cittadino, con i docenti e successivamente anche con il pontefice.
Tra la fine del secolo XII e l’inizio del successivo contrasti insorti sia con docenti sia con il governo
comunale spinsero gruppi di studenti ad abbandonare Bologna e a trasferirsi in altri Comuni.
3. IL DIRITTO CANONICO: RACCOLTE E LORO ESEGESI
Nel corso dell’alto Medioevo numerose furono le raccolte di canoni e di decretali, che
riproducevano i testi senza operare al loro interno alcuna distinzione tra le norme morali e quelle
giuridiche.
La rinascita dello studio scientifico del diritto romano ebbe l’effetto di stimolare l’interesse della
cultura ecclesiastica verso una più chiara definizione dell’ordinamento giuridico di cui si coglieva
l’importanza decisiva sia per l’organizzazione della Chiesa, sia per l’opera da questa svolta
all’interno della comunità dei fedeli.
Poco prima della metà del secolo il monaco camaldolese Graziano, padre del diritto canonico, si
dedicò alla stesura di una vasta compilazione nella quale raccolse le fonti più svariate ma
soprattutto canoni di concili ecumenici e provinciali.
La raccolta, composta dalla Sacra Scrittura, Libri Penitenziali, lettere ai pontefici, fonti laiche come
il Codex Theodosianus e la raccolta Giustinianea, il Breviario Alariciano (Lex Romana
Visighotorum) e i capitolari carolingi, è terminata tra il 1140 ed il 1142, ebbe il titolo di
Concordia discordantium canonum o Decretum, titolo che indicava l’obiettivo dell’autore.
Graziano, infatti, si proponeva di riordinare in modo sistematico il vastissimo materiale raccolto (i
decretali quasi di mille anni), di conciliare tra loro disposizioni che erano state deliberate in
113
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
momenti e ambienti culturali diversi (eliminando contrasti e contraddizioni) e di dar vita ad una
raccolta organica ed omogenea.
La novità sta anche nel commento che spiega la norma, eliminando aporie e contraddizioni.
• Ricercò la concordanza delle norme canoniche ratione significationis, tenendo conto
dello spirito delle decisioni;
• ratione temporis, considerando abrogata la norma più antica da parte della successiva;
• ratione loci, per cui la norma particolare derogava alla generale;
• infine ratione dispensationis, ammettendo deroghe alle norme generali per casi
particolari.
L’importanza dell’opera di Graziano risiede non soltanto nel metodo seguito dall’autore e nella
vastità del materiale raccolto, ma anche nella netta separazione tra diritto e teologia la sua è la
prima compilazione di diritto della Chiesa.
Il Decretum, come fu chiamata la raccolta, non era un’opera ufficiale della Chiesa, dato che la sua
redazione non era stata commissionata dalle autorità, ma era derivata dall’iniziativa personale del
suo autore.
Esso fu subito riconosciuto di indiscussa autorità in quanto riuniva testi di sicura autenticità e di
piena potestà cogente e da allora fu il pilastro su cui si basa l’ordinamento giuridico della
Chiesa e sul quale il diritto canonico poté ulteriormente svilupparsi.
Al pari della compilazione giustinianea, il Decretum fu oggetto di analisi esegetica e di
insegnamento da parte di maestri di diritto che si avvalsero del metodo interpretativo usato dai
civilisti per il Corpus juris e vennero detti “decretisti” essi si distinguono dai glossatori civilisti
perché questi ultimi operarono esclusivamente nello Studio bolognese, i decretisti ebbero centri
di studio anche fuori l’Italia.
La codificazione del diritto della Chiesa proseguì nei secoli successivi.
I generi letterari usati dai decretisti furono la glossa (con la glossa ordinaria o magna glossa) e la
summa.
Il Decretum fu oggetto di esegesi e di insegnamento a partire dagli ultimi anni del XII sec. ci fu
un arricchimento dei manoscritti dell’opera grazianea, in quanto furono aggiunti ad essa i testi di
decretali pontificie innovative.
Tali decretali si chiamarono “extravagantes” delle stesse decretali cominciarono a circolare
raccolte separate chiamate “Quinque compilationes antiquae”.
Gregorio IX, nel 1234, richiede la compilazione del “Liber Extra” sistemò le decretali in 5 libri.
Anche al Liber Extra si volse l’attenzione dei giuristi, i quali cominciarono ad avvalersi delle forme
letterarie con loro ha inizio la scuola dei decretalisti.
114
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Le glosse del Liber Extra vennero sistemate dalla glossa ordinaria composta sulla metà del XIII sec.
da Bernardo da Parma.
Dopo Gregorio IX i pontefici fecero continuo ricorso alle decretali (lettere firmate dal papa
contenenti disposizioni giuridiche riguardanti un caso singolo alle quali andava riconosciuto un
valore generale) per riformare l’ordinamento della Chiesa ed affermare la propria autorità sui
fedeli.
Compilazioni furono disposte da Innocenza IV e da Gregorio X.
Alla fine del XIII sec., Bonifacio VIII incaricò una commissione di giuristi ed ecclesiastici di redigere
una raccolta completa delle decretali successive al Liber Extra promulgata nel 1298 e intitolata
“Liber Sextus”.
Infine, le decretali promulgate dopo il 1298 furono riunite in una raccolta promossa da Clemente
V, iniziata nel 1314 e completata nel 1317 sotto Giovanni XXII.
4. IL GIUDIZIO DELLA STORIOGRAFIA SULLA RINASCITA DEGLI STUDI GIURIDICI
In primo luogo appare interessante prendere in esame la questione delle cause della rinascita
dello studio del diritto giustinianeo.
Essa è stata messa in relazione sia con l’autorità riconosciuta nell’intero corso dell’Alto Medioevo
al diritto romano, sia con la riscoperta del testo integrale del Digesto, sia con il rinnovamento
delle attività mercantili ed artigianali vissuto dalle regioni centro-settentrionali della penisola.
La rinascita bolognese è stata presentata da alcuni come prodotto dell’improvvisa maturazione
raggiunta dalla tradizione del diritto romano, tradizione che già in precedenza aveva costituito la
forza intrinseca latente nell’organismo, da altri come conclusione di un lungo processo di crescita
della tradizione romana all’interno dell’ordinamento altomedievale.
I legami tra la rinascita bolognese e la nuova intensificazione delle correnti commerciali appaiono
oggi correntemente accettati dalla storiografia, anche se non mancano rilievi critici sulla
possibilità di stabilire un rapporto diretto di causa-effetto tra la seconda e la prima.
Altrettanto diffusa è l’idea secondo cui la ricostruzione del testo integrale del Digesto fu
determinante per la rinascita degli studi scientifici.
Alcuni recenti contributi hanno collocato la rinascita degli studi nell’ambiente culturale maturatosi
nella seconda metà dell’XI sec., dove i giuristi impegnati nella vita pratica del diritto avvertivano il
bisogno di definire i diritti e gli obblighi nati dagli accordi negoziali e a tal fine si avvalevano
dell’esegesi dei testi giuridici.
La seconda questione riguarda il rapporto tra la dottrina dei glossatori civilisti e la vita pratica
del diritto.
115
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Secondo un’interpretazione condivisa da numerosi studiosi, inaugurata dallo stesso Savigny e
sostenuta fino ai nostri giorni, i glossatori avrebbero elaborato una raffinata scienza giuridica che
si fondava sull’analisi dei testi giustinianei e si interessava solo a questi.
Essi non avrebbero preso in considerazione la contraddittoria e complessa realtà concreta del
diritto ed avrebbero aperto una profonda frattura in quell’unità di scienza e prassi che nel secolo
precedente aveva caratterizzato la cultura giuridica nelle regioni centro-settentrionali.
A questo indirizzo interpretativo si oppone l’altro che, a partire dal Ficker, ha cercato di
evidenziare nei glossatori la continuità di interesse per la vita reale del diritto.
La questione presenta 2 aspetti:
incidenza della dottrina nella prassi giuridica;
natura dell’esigenza che spinse a Bologna molti studenti.
Si deve comunque precisare che la discussione storiografica si è incentrata soprattutto sulle prime
generazioni dei glossatori.
Nei primi decenni del secolo XII i maestri bolognesi cominciarono ad occuparsi prima del diritto
feudale e poi del diritto statuario; una tale impostazione fa coincidere la prassi giuridica con il
diritto degli ordinamenti particolari, il feudale e il comunale, in particolare con la forma che tale
diritto assunse quando trovò una precisa definizione scritta.
Di modo che dalla prassi finisce per restare fuori la consuetudine che disciplinava i rapporti
giuridici dei soggetti appartenenti all’ordinamento generale degli uomini liberi, senza essere
tradotta in un testo scritto.
I motivi di tale esclusione derivano da una particolare impostazione degli studi, che riguarda il
terzo problema affrontato dalla storiografia.
Tale problema riguarda la natura dell’ordinamento che a partire dai glossatori venne teorizzato
dalla scienza giuridica, trovò prima applicazione in Italia e fu successivamente esteso anche ad
altre regioni europee.
Secondo tale proposta detto sistema avrebbe trovato le sue radici nell’ordinamento universale
dell’Impero medievale, presentato come realtà unitaria bifronte che conteneva tanti ordinamenti
particolari, ognuno con una propria individualità ed autorità.
All’unità dell’Impero corrisponderebbe un ordinamento universalmente valido che si
articolerebbe nel diritto civile e in quello canonico, il primo competente per gli aspetti temporali
della vita, il secondo per gli spirituali, tra loro inscindibilmente legati.
Il diritto civile sarebbe costituito dall’opera giustinianea interpretata dalla dottrina giuridica
inaugurata da Irnerio e proseguita fino al secolo XIX, quello canonico dalle compilazioni iniziate
con la raccolta di Graziano e dall’ esegesi delle stesse elaborata dai giuristi sin dal secolo XII.
116
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Diritti tra loro chiaramente distinti, ma al contempo intimamente legati, tanto da essere designati
con l’espressione “utrumque ius” (l’uno e l’altro diritto, il civile e il canonico) che ne esprime
l’unità nella differenza.
Ma nelle regioni imperiali il diritto civile era giustinianeo e lo spirituale il canonico, mentre nelle
terrae Ecclesiae il canonico disciplinava anche la materia temporale.
L’utrumque ius, dunque, sarebbe stato il diritto dell’ordinamento unitario universale.
Quest’ultimo si componeva di tanti ordinamenti particolari a base territoriale, ciascuno dei quali
consisteva in norme giuridiche disciplinanti la vita della comunità appartenente all’ordinamento
medesimo.
L’ordinamento unitario era comune a tutti gli ordinamenti particolari, così l’utrumque ius era
diritto comune per il diritto di ciascuno di questi.
In proposito veniva messo in evidenza che il concetto di diritto comune è un concetto relativo, nel
senso che acquista significato in rapporto alle realtà particolari.
Era il diritto valido per tutti i soggetti, a prescindere dall’ulteriore inserimento di ciascuno di loro
in organizzazioni civili locali (a differenza degli iura propria che disciplinavano gli ordinamenti
particolari).
Ius commune e ius proprium, allora, avrebbero costituito due momenti del medesimo sistema.
Le relazioni tra di loro sarebbero state regolate da una precisa graduatoria delle fonti giuridiche
dove trovava applicazione prima la norma del diritto proprio e, in caso di sua mancanza, quella di
diritto comune.
Nei Comuni detta graduatoria prevedeva prima l’applicazione dello statuto municipale, in assenza
di una norma adatta alle consuetudini locali e in mancanza di un uso adatto al diritto comune.
Nei regni, invece, la graduatoria è più articolata, infatti la legge regia costituisce diritto comune
per gli ordinamenti particolari e al contempo ius proprium per il diritto comune.
La gerarchia delle fonti parte dal diritto degli enti locali, passa per il diritto regio e termina con lo
ius commune.
Questa raffigurazione sistematica del diritto comune presentava due corollari importanti.
Interpretando tale diritto come diritto dell’unità universale dell’Impero, gli storici riuscirono a
spiegare i motivi della recezione del sistema e del suo rifiuto.
Francia e Inghilterra lo avrebbero respinto perché i loro sovrani andavano affermando la propria
completa indipendenza dall’imperatore; per la stessa ragione fu naturale la recezione del sistema
in Germania, formalizzata con l’istituzione del tribunale della Camera imperiale (1495).
Il secondo corollario riguarda l’evoluzione del sistema di diritto comune nel lungo arco di tempo,
dal secolo XII al secolo XVIII.
Secondo la tesi del Calasso, il diritto comune sarebbe passato per tre fasi distinte:
117
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
- la prima, secoli XII e XIII, definita “del diritto comune assoluto” e caratterizzata dal
predominio del diritto comune;
- la seconda, secoli XIV e XV, detta “periodo del diritto comune sussidiario”, infatti questo
diritto trova vigenza soprattutto come fonte sussidiaria ed integrativa degli iura propria;
- la terza, iniziata con il secolo XVI, definita come “periodo del diritto comune particolare”
in quanto il diritto comune era in vigore perché accettato dalla volontà dei sovrani dei
singoli regni.
Inoltre il Calasso poneva l’accento sul rapporto dialettico tra diritto comune e diritti propri e
sottolineava l’efficienza del sistema attraverso l’integrazione delle diverse fonti giuridiche.
Grazie all’idea del sistema del diritto comune anche il diritto intermedio acquisiva quella struttura
definita, unitaria e funzionale.
Le prime crepe nell’ordinata costruzione teorica del diritto comune sono comparse quando è
cominciata ad entrare in crisi la concezione sistematica del diritto vigente e del diritto romano.
Una delle prime componenti ad entrare in crisi è stata l’idea dell’utrumque ius, che non
convinceva il Cassandro il quale ritenne che il diritto comune era solo il civile, mentre il diritto
canonico aveva la sola funzione di fornire la disciplina generale della Chiesa.
E non convinceva neanche il Legendre il quale, dopo aver messo in rilievo l’idea di “utrumque
ius” si fondi sul presupposto di un’identica autorità dei due diritti, affermò che le fonti medievali
negano tale presupposto.
Inoltre, la differenza tra i due presentava anche un altro aspetto:
- diritto civile l’adesione alla norma giustinianea alla realtà concreta era assicurata
dall’elaborazione esegetica della dottrina;
- diritto canonico le raccolte di norme la garantivano.
A partire dalla fine del XIII sec., comunque, il diritto canonico (sempre secondo Legendre) fu
considerato sullo stesso piano di autorità del civile ma tale novità non comportò l’insorgere del
rapporto inscindibile denunciato dall’espressione utrumque ius.
Tra i due diritti sarebbero nati contrasti incessanti, dovuti ai conflitti politici tra papato ed Impero
e dovuti alla pretesa dei pontefici di raggiungere piena indipendenza dal diritto romano.
I due diritti dunque non avrebbero mai dato vita all’unità cui pensava la storiografia.
Le osservazioni critiche relative all’effettiva valenza dell’utrumque ius non sollevavano alcun
dubbio sull’esistenza di un sistema di diritto comune inaugurato dalla scuola dei glossatori.
Più radicali risultano invece i rilievi alla concezione sistematica che vennero sollevati dall’Astuti
secondo lui, la rinascita degli studi giuridici a Bologna era maturata in virtù della capacità del
diritto giustinianeo di offrire una disciplina utile alla regolamentazione dei rapporti economici-
sociali.
Quindi, secondo lui, mancava il presupposto culturale ed istituzionale su sui poteva essere
fondato un ordinato sistema di diritto l’inesistenza di tale sistema era confermata dall’assenza
118
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
di fonti che testimoniassero nei giuristi la consapevolezza di un preciso rapporto tra ius commune
e iura propria.
Secondo Astuti, le fonti attestano una situazione differente, cioè che i giuristi, a partire dai
glossari, non riconoscevano al diritto giustinianeo un valore assoluto ed esclusivo, ma
dichiaravano di accettarne ed applicarne le disposizioni secondo il loro discernimento esse,
quindi, non teorizzavano l’esistenza di un sistema.
5. QUALCHE OSSERVAZIONE SUI TEMI DISCUSSI DALLA STORIOGRAFIA
3 temi: l’origine della rinascita bolognese, il rapporto tra dottrina e prassi, l’esistenza di un
organico sistema di diritto comune.
La discussione su di loro deve necessariamente partire dall’individuazione del contributo fornito
dalla dottrina giuridica inaugurata dai glossatori civilisti.
I giuristi pratici del secolo XI utilizzavano formulari notarili della tradizione romana per leggere le
situazioni concrete e tentare di precisare, all’interno della complessa e disorganica disciplina
fornita dalle consuetudini, i diritti e gli obblighi che spettavano alle parti negoziali.
A partire da Irnerio invece, i maestri di diritto attraverso l’esegesi delle norme giustinianee
elaborarono precise categorie giuridiche ed affermarono che le situazioni concrete offerte dalla
vita quotidiana del diritto, potevano essere comprese soltanto se inserite all’interno delle
medesime categorie.
Allo stesso tempo, cercarono di ricostruire la disciplina degli istituti giuridici di cui andavano
riscoprendo le forme.
La ricostruirono estrapolandola dalle norme giustinianee attraverso l’esegesi coordinata e
congiunta delle stesse e la presentarono come disciplina unitaria stabilita in ogni sua parte dal
Corpus juris civilis.
Sia le categorie giuridiche elaborate, sia la disciplina teorizzata trovavano il loro fondamento nelle
norme giustinianee, considerate autorevoli sopra ogni altra fonte, in quanto direttamente legate
alla suprema volontà di giustizia e di ordine di Dio.
Per quanto riguarda la rinascita degli studi giuridici, la ricostruzione dei testi giustinianei dovette
conoscere sollecitazioni decisive dalla consapevolezza per la quale la compilazione imperiale era
in grado di fornire stabilità e chiarezza al rapporto tra l’uomo libero e il suo patrimonio.
All’origine della rinascita degli studi non si troverebbe tanto la ripresa delle attività commerciali,
quanto la necessità di precisare i contenuti del diritto di dominium spettante ai soggetti
pienamente liberi.
Innanzi tutto del dominium fondiario, dato che la tutela di questo risulta essere l’obiettivo
primario delle conjurationes municipali e anche del dominium mobiliare.
La ricostruzione dei testi integri della compilazione giustinianea appare legarsi strettamente al
clima culturale che presiedette alla rinascita cittadina.
119
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Di decisivo significato fu, in particolare, la ricostruzione del testo delle Pandette.
Esso guidava gli interpreti medievali nella precisazione delle categorie giuridiche e nella
definizione della disciplina dei diversi rapporti intersoggettivi, offrendo loro approfondimenti dei
singoli problemi e metodi interpretativi raffinati.
E soprattutto indicava con chiarezza il ruolo decisivo dell’esegesi giuridica.
La scienza giuridica presentava il diritto giustinianeo come diritto vigente, tale diritto si affiancava
alla consuetudine delle singole regioni, ai numerosi ordinamenti che guidavano le comunità.
Compito dell’interprete era coordinare diritto giustinianeo e mondo delle consuetudini. La scienza
dei glossatori civilisti appare, dunque, sin dalla sua prima apparizione “scienza pratica che si
rivolgeva a giuristi pratici e concreti”. Si deve notare che i glossatori civilisti proposero la vigenza
del diritto giustinianeo soltanto in riferimento alla disciplina che di fatto poteva essere utilizzata
nella prassi quotidiana del diritto; operarono quindi una sorta di selezione, utilizzando come
criterio decisivo l’effettiva realtà della pratica concreta del diritto. I glossatori civilisti cercarono di
precisare categorie, concetti, istituti desumendoli dall’esegesi delle norme giustinianee e li
usarono per leggere la confusa realtà giuridica vigente nata da consuetudini ispirate a tradizioni
molteplici e legate alle variegate condizioni della vita associata.
La contraddittorietà degli studiosi risiede nell’idea per cui la pratica del diritto finisce con il
coincidere con gli ordinamenti particolari.
L’attenzione dei glossatori per la vita concreta del diritto è fatta iniziare solo dal momento in cui il
diritto feudale e quello municipale trovarono definizione in raccolte scritte.
Tale impostazione sembra riflettere l’articolazione del sistema di diritto comune: il rapporto tra
prassi e dottrina avrebbe potuto essere preso in considerazione dai glossatori soltanto nei termini
della relazione tra ius proprium e ius commune.
Il diritto che venne investito in maniera diretta ed immediata dalla scienza giuridica fu quello
relativo all’ordinamento generale degli uomini liberi.
L’inquadramento nelle categorie e negli istituti teorizzati dalla dottrina bolognese dovette
riguardare innanzi tutto il variegato mondo delle consuetudini locali; i giudici, i notai, i causidici
lessero allora tali consuetudini con gli occhiali forniti dagli interpreti bolognesi.
Ma alcune consuetudini non riuscirono a farsi piegare nell’incasellamento proposto dalla scienza
e continuarono a rimanere in vigore per propria forza intrinseca (soprattutto per l’alta forza di
condivisione nel popolo).
L’utilizzazione delle medesime categorie giuridiche da parte sia della dottrina sia di un’estesa
prassi consente di capire perché fosse correntemente accettata l’idea, con fondamento nella
regola ermeneutica di Papiniano, secondo cui dalla disciplina della seconda era lecito risalire a
quella elaborata dalla prima.
La differenza fra prassi e dottrina non riguardava dunque la sostanza del diritto ma solo le forme
della disciplina.
120
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Il meccanismo per cui dalla norma particolare si risaliva a quella generale presupponeva
un’identità di categorie e istituti in modo che, in mancanza di regole consuetudinarie, si poteva
rivolgersi alla disciplina giustinianea.
Nacque l’idea di “utrumque ius”.
Difficile credere che la scienza giuridica medievale avesse teorizzato o accettato l’idea di un diritto
unico, formato dal diritto civile e da quello canonico.
La recezione delle categorie giuridiche, dei concetti, degli istituti, della disciplina elaborate dalla
scienza giuridica risulta diversa per il diritto civile e per quello canonico.
Il diritto canonico fissato dalle compilazioni ed elaborato dalla dottrina introduceva in maniera
diretta ed immediata ordine e disciplina alle consuetudini relative sia all’organizzazione
ecclesiastica, sia alle materie temporali che venivano correntemente riconosciute all’autorità
spirituale della Chiesa.
Negli ultimi decenni del secolo XII il glossatore civilista Giovanni Bassiano formulò una tesi, la
quale operava una divisione all’interno del concetto di dominium, che i romani avevano costruito
saldamente unitario.
Secondo il glossatore, era necessario distinguere al suo interno tra dominium directum, che
esprimeva il momento astratto della semplice appartenenza formale, e il dominium utile, che
riguardava la concreta ed effettiva utilizzazione del bene immobile.
Questa teoria è sollecitata dall’esigenza di mettere ordine alla complessa disciplina
consuetudinaria del patrimonio fondiario, nella quale la compresenza di più domini rendeva
difficile la precisazione dei contenuti della potestà spettanti a ciascuno di loro.
La tesi del glossatore consentiva ora di leggere la complessa realtà negli schemi e nelle categorie
del diritto romano.
Venivano detti “pays de droit écrit” quei paesi (tipo il Midi) dove il diritto si avvaleva anche delle
raccolte di un’altra legge (Lex Romana Wisigothorum quindi con influenze di origine romana) e la
dottrina bolognese venne accolta e approfondita; i “pays de droit coutumier” sono quei paesi
(tipo l’impero germanico) in cui l’ordinamento si fonda essenzialmente sulla prassi
consuetudinaria e la dottrina bolognese non trovò recezione.
L’ordinamento di diritto comune allora sembra ben più complesso e articolato di quanto risulta
dalla rappresentazione sistematica ancora oggi diffusa nella storiografia.
Il funzionamento della gerarchia delle fonti dipendeva dalle concrete esigenze della società che lo
utilizzava.
Esso operava in maniera significativa quando le norme particolari e quelle generali si rifacevano
alle medesime categorie giuridiche.
6. IL PROCESSO ROMANO-CANONICO
121
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
I glossatori civilisti si sentirono gli eredi diretti di quei giuristi romani la cui dottrina era
conservata dalle Pandette: al pari di costoro, essi illuminavano e ordinavano la massa multiforme
delle consuetudini.
Dai giuristi romani essi si distinsero per un aspetto decisivo della loro opera esegetica: mentre
quelli legavano in maniera inscindibile la precisazione dei contenuti dei singoli diritti con le forme
della difesa giudiziaria degli stessi, i glossatori individuavano categorie giuridiche e precisavano
discipline proponendole come ovunque e sempre valide, offrendole come diritto generale per
tutti i singoli ordinamenti particolari e non le agganciavano a concreti meccanismi di tutela
giudiziaria.
Le norme giustinianee comunque presentavano un’accurata disciplina del sistema processuale, e
a questa i glossatori non potevano non volgere la propria attenzione.
Lo fecero usando la stessa impostazione metodologica seguita per individuare il contenuto della
disciplina sostanziale dei vari istituti, cioè formulando uno schema generale di procedura
giudiziaria e proponendolo come recepibile da ogni tipo di corte.
Il processo romano da loro preso in esame era, naturalmente, quello giustinianeo.
Quest’ultimo eliminava la tradizionale articolazione del processo romano in due momenti
distinti, separati dalla litis contestatio, riduceva il precedente formalismo, ammettendo la difesa
di diritti anche al di là delle formule, enfatizzava il ruolo del giudice costui era un funzionario
dell’amministrazione imperiale e svolgeva la sua attività giurisdicente non più in modo
occasionale, dietro richiesta delle parti, ma stabilmente come funzione propria dell’ufficio da lui
ricoperto.
Il giudice era tenuto ad accertare, attraverso l’esame della dichiarazione delle parti e delle prove
da queste addotte, la verità dei fatti e a pronunciare il proprio giudizio sulla vertenza con sentenza
scritta che aveva l’autorità di ripristinare o confermare una fattispecie concreta uguale a quella
astratta prevista dalle norme.
Contro la sentenza era ammesso appello dalle parti, entro un breve termine.
A questo modello guardarono sia i civilisti, sia i canonisti sin dalla seconda metà del secolo XII,
teorizzando una forma processuale imperniata sull’autorità del giudice, al quale veniva assegnato
il compito di accertare i fatti e stabilire la loro conformità alle norme.
Il processo proposto dalla dottrina civilistica e canonistica, detto romano-canonico, si fondava
sul ruolo attivo e decisionale del giudice a lui spettava innanzi tutto la ricostruzione degli
avvenimenti alla quale perveniva attraverso la valutazione delle prove.
Queste erano distinte in:
- probationes plenae erano ritenute tanto autorevoli da permettere al giudice di
giungere direttamente all’accertamento dei fatti;
- probationes semiplenae.
Si trattava dei documenti contrattuali e della prova testimoniale: questa veniva prestata nel corso
di un’inchiesta (inquisitio) consistente nell’interrogatorio da parte del giudice dei testimoni citati
o presentati dalle parti.
122
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Il sistema con il quale le testimonianze erano assunte divenne un tratto caratteristico del processo
romano-canonico, tanto che il procedimento stesso è definito inquisitorio.
Si deve sottolineare che esso riservava al giudice un ruolo determinante dato che egli doveva
stimolare i testimoni a prestare le loro dichiarazioni e doveva accertare che le stesse fossero
veritiere.
Al contrario, l’inquisitio carolingia consisteva in un’inchiesta, ordinata dall’imperatore per
accertare la consistenza di beni demaniale, il rispetto di diritti regi, il funzionamento dei
meccanismi della giustizia popolare.
Le probationes semiplenae erano numerose, ma nessuna era decisiva.
Nell’usarle, pertanto, il giudice era tenuto a seguire varie regole: non poteva fondare la sua
decisione su una sola, a meno che non riuscisse a farla confermare da un giuramento; la concorde
dimostrazione di più prove semipiene equivaleva a quella di una prova piena; e così via.
E altrettanto decisiva era la funzione del giudice nella fase conclusiva del giudizio: egli infatti, una
volta accertata la situazione concreta, valutava se la stessa era conforme o meno al diritto e
quindi decideva, con sentenza costitutiva, che la fattispecie concreta doveva conformarsi a quella
prevista dalle norme.
Il processo romano-canonico, dunque, appare radicalmente diverso da quello della tradizione
popolare germanica.
Questo, infatti, non era il solo meccanismo di tutela del diritto, ma si limitava ad integrare il
funzionamento della giustizia privata, basata sulla faida e sulle compositiones; non si preoccupava
di raggiungere la verità dei fatti controversi, ma solo la rapida composizione della lite per
restaurare in breve tempo la pace sociale; lasciava la soluzione della vertenza alla prova decisiva
espletata o presentata nel corso del giudizio, riservando al giudice la sola funzione di dichiarare il
risultato della prova medesima.
La giustizia cominciava a diventare pubblica nel senso che l’ordinamento aveva interesse a
tutelare determinate situazioni e a deplorare altre (reati del diritto penale).
Oltretutto risulta superato l’ordinamento popolare di origine germanica: al suo posto stanno
emergendo ordinamenti radicati nel territorio- signorie fondiarie, signorie territoriali, Comuni-
all’interno dei quali la funzione della tutela della giustizia, della difesa del diritto, veniva assunta
come compito precipuo, come responsabilità specifica, da un’autorità espressamente preposta
all’esercizio di detto compito.
CAPITOLO 3 – GLI ORDINAMENTI MONARCHICI DEL XII SEC: INGHILTERRA E SICILIA
1. INTRODUZIONE
Gli elementi di novità che caratterizzarono il mondo occidentale a partire dagli ultimi decenni
dell’XI sec. non si limitarono alla riapertura dei traffici commerciali nel Mediterraneo, alla
rinascita cittadina e alla ripresa degli studi giuridici essi consistono anche nell’affermazione di
ordinamenti monarchici unitari in Inghilterra e nell’Italia meridionale.
123
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
La fondazione del nuovo ordinamento monarchico in Inghilterra anticipa di qualche decennio
l’inizio della rinascenza medievale che trovò nel XII sec. il suo momento più maturo essa fu la
conseguenza della conquista operata dal duca di Normandia, Guglielmo, che nel 1066 sconfisse
ad Hastings le forze anglosassoni e si impadronì del loro territorio.
Anche in Italia meridionale e in Sicilia la dominazione normanna aveva dato vita già nella
seconda metà dell’XI sec. ad ordinamenti unitari di nuovo significato, anche se non ancora elevati
alla dignità di regno.
Fu nel corso del XII sec. che l’ordinamento monarchico nelle 2 regioni europee acquisì definitiva
stabilità e si dotò di strutture istituzionali nuove.
La novità delle monarchie inglese e siciliana rispetto alle dignità regie risiede nella capacità della
potestà regia di esercitare una funzione di signoria territoriale.
Da ciò discendono 2 conseguenze:
il monarca, per svolgere il ruolo di signore territoriale, doveva essere titolare di vasti
patrimoni nell’intera regione che gli faceva capo quindi nella sua potestà devono essere
segnalati 2 momenti distinti:
- quello di signore fondiario;
-quello di autorità unitaria.
A fondamento della sua autorità unitaria si trovavano i bisogni concreti della comunità e
degli ordinamenti particolari di una regione il monarca recuperava il tradizionale titolo
germanico di capo del popolo-esercito per sottolineare il proprio ruolo di guida della
nazione.
La ragion d’essere del potere unitario del re risiedeva, quindi, nella protezione che lui, come
signore territoriale, poteva garantire agli ordinamenti particolari.
Nei regni d’Inghilterra e di Sicilia venne introdotto dai Normanni l’ordinamento feudale il
monarca concesse ai suoi fedeli vasti benefici e questi a loro volta cedettero in feudo a propri
amici parte delle loro terre.
Si venne, allora, a formare una piramide feudale che vedeva al suo vertice il monarca, al secondo
gradino i suoi feudatari diretti (definiti “tenentes in capite”) e successivamente i vassalli di questi
(detti “tenentes in servitio”).
Questo sistema garantiva la rapida convocazione dell’esercito feudale (dato che ciascun vassallo
era tenuto a prestare al suo signore il servizio militare) e una disciplina definita dei rapporti tra
signorie fondiarie.
Bisogna ricordare che l’ordinamento feudale si limitava a disciplinare i rapporti tra signori e tra
patrimoni, mentre la potestà che il feudatario esercitava sulla terra ricevuta dipendevano dalla
consuetudine del luogo e dai bisogni concreti delle comunità.
2. IL REGNO D’INGHILTERRA DOPO LA CONQUISTA
124
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Dopo la vittoria di Hastings del 1066, i cavalieri e gli altri Normanni che avevano partecipato
all’impresa del duca Guglielmo si insediarono in Inghilterra si ebbe, allora, nell’isola l’incontro
di due nationes distinte, ciascuna delle quali conservò le proprie tradizioni ed i propri
ordinamenti.
Gli Anglosassoni continuarono a seguire il loro antico diritto consuetudinario, mantennero la
precedente articolazione della comunità in centene (hundreds) e contee (shires), nonché le corti
popolari di giustizia che centene e contee fornivano.
Nella centena veniva pagata l’imposta popolare tradizionale del “danegeld” che colpiva le signorie
fondiarie in ragione delle loro unità di superficie inoltre essa veniva utilizzata per dar vita ad un
particolare sistema di controllo sugli uomini liberi (quello del frankpledge), per il quale la centena
veniva divisa in gruppi di 10 uomini e l’appartenenza ad uno di questi gruppi attestava lo status di
libero.
Infine, la corte di centena continuò ad occuparsi della soluzione delle vertenze tra vicini e
mantenne la tradizionale competenza sul reato di furto.
Anche i conquistatori normanni conservarono le loro consuetudini e le difesero con le corti di
giustizia della loro tradizione.
Quindi la comunità degli uomini liberi del regno inglese si trovò divisa in due diversi ordinamenti,
secondo l’articolazione del sistema della personalità del diritto.
I Normanni non si limitarono a portare in Inghilterra il loro diritto nazionale ma introdussero
anche l’ordinamento feudale.
Guglielmo I divise il territorio conquistato riservando a sé stesso ampi patrimoni in ciascuna
regione e assegnando in feudo ai suoi cavalieri le terre rimaste in questo modo il sovrano si
affermava dominus di gran parte del territorio e si poneva al vertice della piramide feudale che
vedeva al secondo gradino i cavalieri che ricevevano la terra da lui (tenentes in capite) e al terzo i
vassalli di costoro (tenentes in servitio).
Allora i rapporti tra signorie fondiarie vennero regolati dall’ordinamento feudale della tradizione
normanna.
Secondo tale tradizione:
il signore feudale era tenuto a difendere il suo vassallo, tutelarne i diritti, proteggere la sua
famiglia ed i suoi beni;
il vassallo invece doveva mantenersi fedele al signore e prestargli il servizio, l’aiuto e il
consiglio necessario, ad esempio il servizio militare (evitabile tramite il pagamento dello
scutagium) o contribuire alle spese del signore come i 3 casi della tradizione mediavale
(riscatto, matrimonio figlia, primogenito in armi).
La violazione di uno di tali doveri legittimava la controparte a rifiutare l’adempimento dei suoi
obblighi.
125
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Infine, l’ordinamento feudale normanno conteneva numerose norme che disciplinavano
importanti aspetti dei rapporti tra signore e vassallo:
il vassallo che succedeva ad altro nel feudo versava al signore una somma detta relevium;
al signore spettava la tutela degli orfani minorenni dei suoi vassalli
il signore doveva autorizzare il matrimonio delle vedove e delle orfane dei suoi feudatari;
i tenentes in capite potevano essere esentati dal servizio militare attraverso il versamento di
una somma, detta “scutagium”.
Insieme con l’ordinamento popolare degli uomini liberi della loro natio e con quello feudale, i
Normanni portarono anche il loro diritto signorile.
Le consuetudini normanne prevedevano già prima del 1066 l’ereditarietà della signoria
fondiaria questa, detta manor, presentava la tradizionale divisione tra pars dominica e mansi
assegnati ai contadini.
Secondo la grande inchiesta disposta da Guglielmo I nel 1086 sui patrimoni fondiari e riportata
nel “Domesday Book”, nella maggior parte dei manors i mansi erano concessi in affitto.
Il signore amministrava il suo patrimonio con la collaborazione della sua domus, l’household,
ed era titolare del banno nei riguardi delle comunità che risiedevano nelle sue terre.
A lui faceva capo la corte di giustizia signorile, che si occupava delle vertenze tra gli abitanti del
manor o tra costoro e il signore oltre a questa corte esisteva la corte feudale la quale si
occupava delle sole vertenze vassallatiche.
Accanto ai due ordinamenti degli uomini liberi, a quello feudale, a quello signorile vigeva inoltre
l’ordinamento della Chiesa.
Guglielmo I era un deciso sostenitore della riforma gregoriana e favorì l’affermazione di un clero
sensibile agli interventi della S. Sede e tenace difensore delle libertà ecclesiastiche contro le
ingerenze temporali.
La scelta di Lanfranco a vescovo di Canterbury, avvenuta nel 1070 nel corso di un concilio della
Chiesa inglese, inaugurò il nuovo corso della vita ecclesiastica del regno.
A tale corso lo stesso monarca recò un contributo con l’ordinanza del 1072 – 1076 con la quale
assegnò alle corti ecclesiastiche la competenza sulle cause spirituali e vietò agli agenti regi di
intervenire nella vita della Chiesa.
La pluralità degli ordinamenti giuridici trovava un punto di incontro nell’ordinamento unitario che
faceva capo al sovrano.
All’interno della potestà regia dobbiamo distinguere due aspetti:
- il primo legato alla sua titolarità di un vasto patrimonio e di diritti demaniali;
126
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
- l’altro relativo alla sua funzione di autorità unitaria.
Essendosi riservato vasti patrimoni ed essendo in ogni regione il titolare del maggior numero di
manors, Guglielmo I era in grado di esercitare ovunque la funzione di signore territoriale
quindi la sua autorità unitaria si legava alla sua potestà di signore fondiario.
L’amministrazione del patrimonio del sovrano spettava alla sua household, ovvero la sua
organizzazione domestica.
Quindi, sotto questo profilo nessuna differenza esisteva da questo punto di vista tra la gestione
fondiaria del re e quella degli altri signori curtensi del regno.
Rispetto alla domus di questi ultimi, l’household regia, dovendo occuparsi della gestione di un
numero considerevole di manors, presenta una precoce definizione degli uffici interni.
Troviamo infatti:
la camera, con specifica competenza sulle entrate regie;
la cappella, dove venivano redatti i diplomi e i documenti regi;
l’aula, cioè la cucina e la dispensa quindi gli approvvigionamenti della casa;
la cantina, si occupava della produzione delle vigne regie;
le stalle, curavano l’allevamento equino.
L’household seguiva il re nei suoi spostamenti all’interno dei due domini, in Inghilterra e in
Normandia.
L’amministrazione dei manors regi, quando il re non era presente, era svolta sul piano locale da
un agente regio detto sceriffo (sheriff) che amministrava i beni e i diritti regi al momento di
entrare in carica versava al re una somma il cui ammontare era calcolato sul reddito presunto dei
manors e dei diritti patrimoniali della circoscrizione e trattenevaa per sé quanto effettivamente
riscuoteva.
L’ufficio cominciò a funzionare con regolarità dopo il 1070, ma solo il 1086 si diffuse in tutte le
regioni del regno ricoperto soprattutto da cavalieri della nobiltà media, l’ufficio aveva anche la
funzione di intervenire nell’attività delle corti di contea e in quelle corti di catena; infine, curava la
custodia dei castelli e delle foreste regie.
Accanto allo sceriffo, poi, operarono nelle terre demaniali altri agenti regi, privi di un titolo
definito.
Il secondo aspetto della potestà regia, poi, era costituito dalla sua autorità unitaria
127
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Il monarca era innanzi tutto il capo della tradizione germanica per la natio degli Anglosassoni e
per quella dei Normanni: il popolo confermava con il giuramento di fedeltà, prestato nelle corti di
contea, di volere come suo capo il sovrano in carica.
Inoltre il re era il suzerain (“signore dei signori”) feudale dei signori fondiari, il supremo tutore
dell’ordinamento ecclesiastico e il primo signore territoriale del regno.
Il sovrano entrava in carica attraverso la cerimonia dell’incoronazione le formule pronunciate
sottolineavano che il re riceveva direttamente da Dio il compito di difendere e di proteggere il
popolo, di tutelare la giustizia e di mantenere la pace.
La cerimonia dell’incoronazione si concludeva con la prestazione di un giuramento (giuramento
dell’incoronazione) con il quale si impegnava formalmente ad esercitare con costanza e dedizione
i suoi compiti.
La funzione del re, quindi, consisteva nella difesa dai nemici esterni e soprattutto nella tutela del
diritto vigente non era previsto per il re nessun compito di governo unitario: la guida delle
singole comunità spettava alle autorità locali.
Il compito del re si concentrava nella tutela degli ordinamenti in cui si articolava il diritto vigente
nel regno.
Che il compito unitario del monarca si incentrasse nella giustizia non deve indurre a ritenere che a
lui passasse in via esclusiva la tutela del diritto.
La difesa degli ordinamenti vigenti comportava necessariamente anche il rispetto dei mezzi di
tutela del diritto previsti da ciascuno di questi.
Il re non avrebbe potuto tutelare i diritti delle comunità senza mantenere in vita le corti di
giustizia nate dalla medesima tradizione perciò:
le corti di centena e di contea continuarono a tutelare i diritti della comunità degli uomini
liberi;
le corti signorili i diritti nati all’interno dell’azienda curtense;
quelle feudali a giudicare le vertenze tra vassalli e tra questi ed il loro signore;
le corti ecclesiastiche a difendere l’ordinamento canonico.
Nei primi decenni della dominazione normanna la funzione giudiziaria del sovrano si limitò
all’attività della Curia Regis il termine indica sia la grande assemblea convocata in solenni
occasioni, sia il più ristretto gruppo di fedeli che collaborava quotidianamente con il sovrano.
In entrambe le forme, la curia regis discuteva questioni rientranti nella funzione unitaria del
sovrano ovvero problemi di difesa contro nemici esterni, mantenimento dell’ordine, pace interna,
giustizia.
La curia regis non era una corte di appello e poteva essere adita direttamente senza che fossero
state sentite in precedenza le altre corti.
128
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Si puo’ ritenere che nella curia regis vi si discutessero vertenze relative a diritti degli uomini liberi
delle due nationes, a diritti feudali e, forse, questioni connesse con l’ordinamento ecclesiastico.
3. IL REGNO DI ENRICO I (1100-1135)
Nei primi decenni del secolo XII la potestà monarchica inglese conobbe una significativa
evoluzione sia sotto l’aspetto signorile sia sotto l’aspetto di autorità unitaria.
Sotto il primo profilo, vediamo il riordinamento degli uffici domestici regi.
Un breve trattato intitolato “Constitutio domus regis” ci informa che nei primi decenni del secolo
XII, mentre i principali uffici dell’household regia rimanevano gli stessi, la camera diventava il
centro della gestione delle finanze del sovrano.
L’oro, le monete, i gioielli del re erano custoditi in castelli sicuri, i più importanti erano in
Inghilterra quello di Winchester e in Normandia quello di Rouen.
Dai castelli, la camera regia riceveva il denaro necessario per il mantenimento del sovrano e della
sua famiglia.
Il personale della camera era formato da vari camerarii, da alcuni funzionari di grado inferiore e
da un tesoriere, tutti guidati da un magister camerarius in particolare, il tesoriere controllava i
responsabili dei tesori conservati dei castelli.
L’attenzione di Enrico I per la miglior gestione del patrimonio regio e la corretta riscossione delle
entrate che da questo provenivano non si manifestò solo nella ristrutturazione dell’ufficio
domestico della camera.
Sin dai primi anni del suo regno risulta un particolare sistema di controllo sui conti presentati
alla corte regia dagli sceriffi: costoro si presentavano due volte l’anno (a Pasqua e nel giorno di S.
Michele) presso il tesoro di Winchester ed erano ascoltati da un gruppo di consiglieri del
monarca, i quali riscuotevano i denari, verificavano l’esattezza dei conti e in caso di approvazione
rilasciavano quietanza, mentre in caso contrario imponevano multe allo sceriffo.
I consiglieri regi stendevano sul tavolo una tovaglia a scacchi che facilitava i conti, così la corte
venne chiamata Corte dello Scacchiere.
Una corte dello Scacchiere venne organizzata nello stesso periodo anche in Normandia, dove
l’agente patrimoniale del duca non era lo sceriffo bensì il vîcomte.
La natura delle due corti è stato oggetto di dibattito presso gli studiosi.
Secondo alcuni, la loro istituzione avrebbe comportato una radicale trasformazione
dell’amministrazione regia lo Scacchiere avrebbe quindi avuto natura di ufficio amministrativo
e la caratteristica di operare al di fuori dell’household.
129
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Tale tesi non è condivisa dalla storiografia gli studiosi più recenti vedono nello Scacchiere non
un ufficio, ma la composizione che la curia regis assumeva in occasione del controllo contabile
sugli agenti patrimoniali del re-duca.
Il miglioramento della gestione patrimoniale vi fu sotto Enrico I continuò ad essere riscossa la
tradizionale imposta popolare del danegeld e vennero riscossi aiuti eccezionali da contee e
contributi annuali dai borghi, tra il 1127 e il 1130.
Particolarmente interessanti sono le novità conosciute dalla potestà unitaria del sovrano.
Prima la funzione principale del sovrano, accanto alla difesa dai nemici esterni, era la tutela del
diritto vigente nel regno tale funzione comportava non solo la protezione delle consuetudini,
ma anche l’intervento diretto ad eliminare gli usi cattivi e a sostituirli.
Esplicitamente lo dichiarava il sovrano nel corso della cerimonia dell’incoronazione, sentendosi
legittimato a tale intervento dal carattere sacerdotale che l’incoronazione e l’unzione gli
conferivano Guglielmo I, abrogando la competenza delle corti di contea nelle cause
ecclesiastiche, aveva esercitato detta funzione.
Negli anni di Enrico I tale intervento acquista un respiro ben più ampio.
A questo periodo risale la raccolta intitolata “Leges Henrici primi” che riunisce le regole
consuetudinarie in vigore da questa raccolta sappiamo che si era affermata nella prassi una
prerogativa del sovrano a trattare nelle sue corti alcuni reati particolarmente rilevanti per l’ordine
pubblico.
I delitti in questione possono essere distinti in tre categorie:
- le offese più gravi, come l’omicidio o la rapina;
- le offese contro il sovrano e la sua household;
- le offese ai diritti demaniali del sovrano e l’intervento in caso di mancata o scorretta
giustizia da parte delle corti degli ordinamenti particolari del regno.
La giustizia regia diventava componente essenziale della giustizia esercitata nel regno: quando
veniva a conoscenza di un caso di difetto di giustizia, il re inviava alla corte competente un “breve”
(writ) con cui la invitava ad esercitare nella maniera dovuta le proprie funzioni.
I writs principali di questo periodo erano di due tipi:
- il writ of rights (breve de recto) con cui il sovrano invitava la corte ad operare dopo aver
accertato la veridicità della notizia di difetto di giustizia;
- i writs esecutivi, con cui il re chiedeva a questa di curare la restituzione dei beni sottratti a
colui che al re stesso si era rivolto.
Esistevano due categorie di giudici regi, quelli stabilmente residenti nelle contee e quelli
itineranti.
130
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
La definizione della prerogativa giudiziaria del re aveva la conseguenza di consentire un più
omogeneo coordinamento tra detti ordinamenti, eliminando i conflitti di competenza che si
aprivano tra le diverse corti di giustizia quando reo di uno di quei delitti era una persona la quale
partecipava allo stesso tempo a più ordinamenti.
Ad esempio il caso del libero legato da vincoli di vassallaggio con un signore.
In tutti i casi le corti popolari, quelle signorili, le feudali e le ecclesiastiche potevano vantare tale
competenza.
Le consuetudini definite nelle “Leges Henrici primi” erano sorte proprio per evitare tali conflitti e
dando vita ad un’apposita competenza regia in merito ai reati più importanti, consentivano alle
corti particolari di giustizia di funzionare senza impantanarsi in contrasti tra di loro.
Nel 1108 Enrico I emanò un’ordinanza con cui definiva in termini chiari le competenze
giurisdizionali di tutte le corti.
Infatti si affermò che le corti del re erano anche corti feudali per le vertenze tra tenentes in capite,
che le corti feudali di quest’ultimi giudicavano le vertenze tra vassalli di un medesimo signore, che
quelle signorili trattavano le cause sorte all’interno dell’azienda curtense, che quelle popolari di
contea erano competenti sia per le vertenze tra liberi sia per quelle tra vassalli di diversi signori.
Nei confronti degli ordinamenti signorili, Enrico I si mostrò favorevole ad alcuni dei suoi vassalli
diretti concesse, in via eccezionale, potestà giurisdizionali rientranti nella sua prerogativa.
Tali concessioni, a differenza delle altre con cui il re assegnava terre ai suoi vassalli diretti, era la
fonte della potestà giurisdizionale passata nelle mani del beneficiario esse rendevano il
concessionario immune dalla giurisdizione delle corti regie e allo stesso tempo competente a
giudicare i reali commessi all’interno della sua signoria.
La vera novità che caratterizza nei primi decenni del XII sec. gli ordinamenti particolari del
regno inglese risiede nell’emersione dell’ordinamento cittadino, accanto a quelli tradizionali.
Nella seconda metà del secolo XI anche l’Inghilterra aveva conosciuto una timida ripresa della vita
cittadina mentre alcuni decenni dopo la vita produttiva conobbe una sensibile espansione e le
comunità urbane cominciarono a chiedere ai signori del territorio il riconoscimento di diritti
particolari per un utilizzo più libero dei beni.
Si voleva chiedere una libera trasmissione dei domini fondiari e tali richieste vengono ricordate
come “libero burgage”.
Enrico I dispose alcune concessioni del privilegio, conferendo alle comunità beneficiarie lo status
giuridico di città.
A questa concessione potevano aggiungersene altre 2:
- il riconoscimento dell’attività delle gilde (associazioni di mercanti attivi in città)
riconoscimento che conferiva agli iscritti alla gilda il monopolio del settore commerciale
nel territorio urbano;
131
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
- la c.d. “firma burgi” che assicurava l’immunità dell’esazione dello sceriffo e consentiva
alla comunità cittadina di riscuotere tutte le entrate signorili.
4. GLI INIZI DELLA “COMMON LAW”
La morte di Enrico I nel 1135 aprì una lunga e grave crisi nel regno inglese: la successione di
Matilde (figlia di Enrico I, vedova dell’imperatore tedesco Enrico V e moglie del conte d’Angiò
Goffredo) venne contestata da alcuni grandi signori normanni che le preferirono Stefano di Blois,
figlio di una sorella di Enrico I e titolare di vasti honours.
Il regno inglese si divise in 2 parti: parte orientale a Stefano e parte occidentale a Matilde.
La crisi fu risolta solo nel 1154 quando, morto Stefano, tutti accettarono come sovrano Enrico II,
figlio di Matilde e nipote di Enrico I.
Il nuovo sovrano, che inaugurava la dinastia angioina, era titolare in Francia di vasti domini; a
questi ne aggiunse altri sempre in Francia, dando vita ad un vasto impero che nel momento di
massima estensione comprendeva l’Inghilterra, l’Angiò, la Touraine, il Maine, la Normandia,
l’Aquitania, la Bretagna, il Ponthieu, il territorio di Calais. In ciascuno dei suoi domini Enrico II
costituiva l’autorità unitaria.
Nel regno inglese egli proseguì la politica inaugurata dal nonno e migliorò sia la gestione delle
entrate regie, sia l’amministrazione della sfera di giustizia che competeva al sovrano.
Sotto Enrico I la riscossione delle entrate della giustizia amministrata dai giudici itineranti era stata
affidata ad agenti regi che portavano il titolo di sergenti alla morte del re tali agenti erano stati
eliminati e sostituiti da sergenti delle contee, competenti anche in caso di omicidio a condurre
indagini sui corpi delle vittime.
Dal 1168-69 Enrico II restaurò i sergenti regi, attribuendo loro anche le competenze di quelli di
contea: i nuovi ufficiali furono detti “custodes placitorum coronae”, ovvero coroners.
Quanto alle entrate feudali, il nuovo indirizzo si espresse nell’uso dello scutagio, cioè il
pagamento della somma sostitutiva del servizio militare vassallatico, come tributo generale su
tutti i feudatari diretti del sovrano.
Il ricorso a tale forma esattiva, però, avveniva in casi eccezionali senza minacciare le fondamenta
stesse dell’esercito regio.
Perciò il sovrano preferì rivolgersi ad un’imposta che rientrava nella tradizione del danegeld, nel
senso che gravava su tutti gli uomini liberi ed aveva quindi natura di tributo popolare: si tratta
del tallagium introdotto nel 1166.
132
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
La funzione unitaria del sovrano conobbe poi un’importante espansione nel campo
dell’amministrazione della giustizia le novità sono di due tipi, riguardano sia l’organizzazione
delle corti regie, sia il contenuto della loro giurisdizione.
Per quanto riguarda le corti sovrane, la curia regis nella forma di corte dello Scacchiere fu
trasformata in corte stabile essa si affiancò a quello itinerante la quale continuava a seguire il
sovrano nei suoi spostamenti.
La Curia Regis fu quindi sdoppiata in due corti: una itinerante guidata dal re; l’altra, sotto forma
di corte dello Scacchiere, stabile presieduta dal gran giustiziere.
Enrico II, inoltre, riformò anche le corti regie provinciali abolì i giudici regi stabiliti nelle
contee e cominciò a riordinare il funzionamento dei giudici itineranti.
Da quel momento il sovrano inviò i suoi giudici nelle diverse regioni del regno, ridisegnando i loro
circuiti ed estendendosi all’intero territorio, distribuendoli in modo equo nei vari distretti.
Inoltre assistiamo all’introduzione di una nuova procedura: quando si fermavano in una località i
giudici erano tenuti a convocare un gruppo di persone, vincolate da giuramento a parlare secondo
verità, detto giuria, composto da dodici uomini della centena e da quattro uomini per ciascuna
città demaniale della stessa centena.
Questo gruppo, detto Grande Giuria, indicava alla corte dei giudici itineranti le persone accusate
di aver commesso delitti di competenza regia, costoro erano poi sottoposti alla procedura ordalica
(dell’ordalia, prova) introdotta dalla Assise di Clarendon del 1166, la Grande Giuria saldava la
giustizia penale regia alla comunità dei liberi.
A partire dal 1164 qualsiasi libero possessore , anche se sottoposto all’autorità bannale di un
signore, fu legittimato a ricorrere direttamente alla giustizia regia per difendere il proprio diritto
di possesso, senza aspettare più come prima i casi di difetto di giustizia o non eseguire le
sentenze.
La procedura prevedeva che il richiedente ottenesse dal sovrano un writ indirizzato allo sceriffo
della contea di sua residenza e contenente l’ordine di convocare una giuria di dodici uomini saggi
presso la corte dei giudici itineranti e di incaricarla di inquirere sulla vicenda.
Se l’inquisitio si concludeva con l’accertamento delle ragioni del richiedente, i giudici itineranti
invitavano la corte particolare competente a tutelare il diritto di questo.
Durante il regno di Enrico II vennero definite cinque fattispecie protette da tale procedura:
1) La prima, precisata dalle Assise di Clarendon del 1164, si proponeva di stabilire se una terra
costituiva un feudo laico oppure un beneficio ecclesiastico concesso in elemosina; si
chiedeva “utrum sit laicum feudum an elemosina”, da cui il titolo utrum assegnato al writ
regio che dava inizio alla procedura l’intervento della corte regia risolveva un conflitto di
competenza tra ordinamento signorile e ordinamento ecclesiastico;
133
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
2) La seconda fattispecie, detta del novel disseisin, introdotta dalle Assise di Clarendon del
1166, era una vertenza tra un signore e un possessore libero della sua azienda curtense;
l’inchiesta promessa dal writ regio doveva accertare se l’espropriazione disposta dal
signore a danno del ricorrente aveva rispettato il diritto consuetudinario vigente nel fondo,
era stata cioè legittimata dall’inosservanza dei doveri gravanti sul possessore.
L’intervento dell’autorità regia metteva in evidenza che in questo caso non ci si trovava di
fronte al solo ordinamento signorile, ma anche a quello generale degli uomini liberi.
Si venivano allora ad incontrare due diversi ordinamenti particolari e per coordinarli era
necessario imporre a ciascuno il rispetto dei propri limiti.
Il giudice regio precisava che il libero rispettoso dei doveri consuetudinari non poteva essere
lasciato alla mercé del signore, ma era titolare di diritti che prevalevano sulla potestà bannale.
Quest’ultima non veniva negata, ma solo reinserita nei suoi limiti e il giudice regio interveniva per
richiamare la corte signorile alla corretta amministrazione della giustizia, in particolare alla tutela
del diritto del possessore libero.
3) Natura uguale presenta la terza fattispecie, del writ detto mort d’ancestor, introdotta dalle
Assise di Northampton del 1176; se alla morte di un possessore libero il signore bannale
assegnava ad altro contadino il fondo, l’erede naturale del defunto poteva invocare un
proprio diritto al possesso tenuto dalla sua famiglia da più generazioni e nella regolare
osservanza dei doveri consuetudinari.
4) Più vicina alla prima era la quarta fattispecie, quella del writ detto darrein presentment,
che si proponeva di individuare il legittimo titolare del diritto di presentazione di un
chierico per una chiesa rimasta vacante.
Questi quattro writs sono definiti writ delle petty assizes o possessory assizes, dal titolo assegnato
alle giurie incaricate di svolgere l’inquisitio diretta a ricostruire la verità dei fatti.
Si deve aggiungere però un quinto tipo di writ, il cosiddetto praecipe, con il quale il giudice regio
intimava, tramite lo sceriffo, ad un soggetto libero di presentarsi davanti alla propria corte per
rispondere in merito ad accuse relative a sottrazione di dote, debiti non saldati, circa il possesso
di una terra e così via.
Questi cinque writs costituiscono i primi casi di common law, ovvero un sistema basato su
precedenti giurisprudenziali più che su codici, leggi o atti normativi.
A fondamento del diritto comune nelle regioni centro-settentrionali dell’Italia si trova la dottrina.
L’Inghilterra conobbe un sistema diverso mancò una dottrina giuridica che avesse l’ambizione
di dare sistemazione completa all’intero ordinamento; al contempo, l’obiettivo di fissare punti
fermi del diritto degli uomini liberi venne assunto come compito proprio da una concreta
autorità, quella unitaria del sovrano.
134
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Perciò la common law non investì in maniera immediata l’intera realtà del diritto, ma si limitò a
definire singole fattispecie: per tali fattispecie garantì a tutti gli uomini liberi l’effettiva tutela
attraverso corti espressamente investite di tale compito.
I meccanismi seguiti in ambito di common law risultano diversi da quelli usati dal diritto comune.
Qui si seguiva la regola interpretativa del rinvio dalla norma particolare alla generale,
rappresentata dalla dottrina del diritto comune; quindi poteva essere offerto a qualsiasi
ordinamento vigente che riuscisse a calare la propria tradizione consuetudinaria nelle categorie
giuridiche elaborate dalla dottrina.
La common law invece non poteva uscire dall’ambito della tradizione inglese perché si
collegava agli ordinamenti particolari vigenti nel regno.
La procedura dei casi di common law prendeva le mosse da un writ regio e proseguiva attraverso
un giudizio formulato dalla corte dei giudici itineranti sulla base dei risultati di una inquisitio
condotta da esponenti della contea e diretta ad accertare la verità dei fatti.
Si tratta di una procedura che presenta almeno due aspetti: conferma i legami tra la potestà
giudiziaria del sovrano e l’ordinamento della tradizione popolare.
In secondo luogo, l’amministrazione della giustizia nelle fattispecie di common law veniva assunta
come responsabilità diretta del sovrano: perciò le sue corti chiedevano l’accertamento della
veritas e non potevano accontentarsi dell’antica funzione dichiarativa del giudice germanico che
lasciava al risultato della prova la soluzione della vertenza.
Le Assise di Windsor del 1179 stabilirono che, in caso di contestazione del diritto di possesso, il
libero possessore di beni allodiali poteva rifiutare di difendersi davanti ad una delle corti popolari
e scegliere la protezione del sovrano.
Allora, il re convocava con un writ una commissione di dodici buoni uomini del luogo scelti da
quattro cavalieri della contea e indicata con il titolo di Magna Assisa, Grand Assize; dovevano
testimoniare sotto giuramento l’opinione che sulla vertenza prevaleva nel territorio dove le due
parti risiedevano e tale testimonianza costituiva il fondamento della sentenza regia.
L’espansione della giurisdizione regia nella seconda metà del XII sec. non comportò alcuna crisi
degli ordinamenti particolari del regno quello feudale e quello signorile conservarono i loro
contenuti particolari, con il solo limite dei casi di common law, e le loro corti tradizionali.
5. LA FORMAZIONE DEL REGNO NORMANNO DI SICILIA
Le conquiste territoriali conseguite nel corso del secolo XI dai Normanni coinvolsero anche l’Italia
meridionale e la Sicilia.
Le modalità con cui i Normanni formarono i loro domini nell’Italia meridionale furono diverse da
quelle con le quali procedettero alla conquista dell’isola siciliana: tale diversità determinò una
significativa distinzione tra gli ordinamenti peninsulari e quello insulare.
135
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Gruppi di cavalieri normanni giunsero in Italia meridionale all’inizio del secolo XI e ottennero dai
signori locali l’indispensabile legittimazione dei domini conquistati.
L’organizzazione di questi domini normanni appare pienamente fedele a quella della tradizione
popolare germanica con una pluralità di capi- ciascuno con il proprio seguito di cavalieri-
coordinati da un’autorità che aveva la sola funzione di conferire unità all’azione militare.
Tale forma organizzativa fu conservata negli anni successivi, nel corso dei quali i signori normanni
sconfissero ed eliminarono tutte le potestà territoriali preesistenti.
Un cambiamento significativo si ebbe nel 1059 quando i Normanni ricevettero dal pontefice
Leone IX la legittimazione del loro dominio l’accordo, raggiunto a Melfi, prevedeva:
da un canto che il pontefice concedeva in feudo ai Normanni il territorio da loro conquistato;
dall’altro che l’investitura non riguardava più ogni singolo capo militare normanno, bensì il
solo Roberto il Guiscardo, della famiglia Altavilla, il quale veniva investito del ducato di
Puglia, comprendente la maggior parte dei domini normanni, e che riceveva in maniera
formale la potestà di guida unitaria del popolo.
La concessione feudale serviva al pontefice per affermare che le regioni meridionali rientravano
tra le terrae Ecclesiae e al capo dei cavalieri normanni per legittimare le conquiste del suo popolo.
La realtà risultò di segno inverso i successori di Leone IX continuarono a ricevere l’omaggio
feudale del Guiscardo e dei suoi successori, ma mai interferirono nel dominio normanno
pretendendo di esercitare potestà feudali.
All’interno dell’ordinamento normanno, poi, la potestà unitaria del Guiscardo conservò il
carattere di capo popolare della tradizione germanica tale situazione si consolidò in Puglia
sotto gli eredi del Guiscardo, che non godevano dell’autorità militare di quello.
Ciascuno dei signori normanni agiva in maniera individuale, fungendo da unica autorità unitaria
nel territorio di propria competenza.
All’interno dei singoli domini si vennero ad incontrare comunità di tradizione diversa dato che le
unità signorili riunivano popolazioni di origine bizantina e longobarda le quali avevano vissuto
esperienze tra loro differenti.
Il diritto vigente nella regione riunita nella signoria era articolato e composito non solo per la
compresenza di più ordinamenti ma anche per il pluralismo delle consuetudini riguardanti gli
uomini liberi.
Tale complessità fu ulteriormente arricchita dai Normanni i quali portarono sia il diritto della loro
tradizione popolare, sia il diritto feudale.
La forma istituzionale del ducato di Puglia si ritrova anche nel principato di Capua, l’altro dominio
unitario normanno dell’Italia meridionale il quale si mantenne separato dal ducato fino alla
fondazione del Regno.
Non si ritrova invece in Sicilia, soprattutto perché la conquista dell’isola e la distribuzione delle
terre avvennero in maniera del tutto diversa la conquista dell’isola fu la conseguenza di
136
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
un’apposita campagna militare progettata da Roberto il Guiscardo e dal fratello Ruggero e
condotta da quest’ultimo alla guida di un gruppo di cavalieri normanni.
Ruggero seppe mantenere unite le sue forze e procedette alla liberazione dell’isola (occupata
dagli Arabi) attraverso la costruzione di castelli le cui guarnigioni avevano il compito di far
avanzare la conquista nelle zone circostanti.
Una volta raggiunto il controllo completo dell’isola egli provvide alla divisione delle terre tra i
vincitori: conservò per sé un patrimonio molto consistente e diffuso in tutte le regioni dell’isola;
assegnò ai suoi cavalieri signorie di dimensioni ridotte; legò a sé i signori attraverso il vincolo
feudale.
Ruggero era in grado di esercitare la funzione di signore territoriale in tutta l’isola e i signori locali
potevano conservare il controllo delle loro terre solo mantenendo vivi i rapporti tra di loro e salda
l’unità sotto la guida di Ruggero.
Ruggero si riconosceva vassallo del fratello Roberto per dare legittimazione formale all’autorità
esercitata in Sicilia e venne insignito del titolo di conte.
La sua autorità si arricchì quando Ruggero provvide a restaurare la gerarchia della Chiesa in un
paese prima dominato dagli arabi allora ricevette dal pontefice Urbano II nel 1098 il privilegio
della legazia apostolica, cioè il legato era il diretto rappresentante del pontefice in una regione e
come tale vi fungeva da vertice della gerarchia ecclesiastica.
L’esperienza normanna appare duplice:
Da una parte quella delle regioni peninsulari dove l’autorità unitarie del duce di Puglia e
del principe di Capua non avevano contenuti particolarmente rilevanti;
dall’altra quella siciliana, caratterizzata da una maggior importanza della potestà unitaria,
titolare di una effettiva autorità di signore territoriale, suzerain feudale dei cavalieri
normanni e vertice della gerarchia ecclesiastica.
Presupposto indispensabile di detta potestà era la buona gestione del patrimonio comitale: tale
gestione, comunque, rimase nell’ambito tradizionale degli uffici domestici, dove risulta affidata
alla camera.
6. LA FONDAZIONE DEL REGNO E LE ASSISE DI ARIANO
Nel 1127, alla morte del duca di Puglia Guglielmo, Ruggero II, conte di Sicilia, invase i domini
peninsulari normanni e l’anno successivo ottenne la loro investitura dal pontefice Onorio II.
Nel 1130, poi, ottenne dal pontefice romano Anacleto II di elevare il suo dominio al rango di
regno: nella notte di Natale dello stesso anno fu incoronato re di Sicilia all’interno della cattedrale
di Palermo la sua promotio regia venne infine confermata nel 1139 da Innocenzo II che, alla
morte di Anacleto, aveva ricomposto l’unità della Chiesa.
137
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Vassallo del Papa e allo stesso tempo titolare della potestà di guida unitaria del suo popolo
confermata dal sacramento dell’incoronazione regia, Ruggero II cercò di estendere all’intero
regno l’armonia tra ordinamenti particolari che caratterizzava la contea di Sicilia.
Nella grande assemblea popolare svoltasi ad Ariano nel 1140 fu approvato un consistente corpo
di leggi regie, indicate con il termine di Assise, che precisarono la prerogativa giurisdizionale del
sovrano, la disciplina dei diritti demaniali, la competenza dei magistrati regi incaricati di esercitare
l’autorità del monarca, i limiti degli ordinamenti particolari, le modifiche che dovevano essere
introdotte negli stessi per migliorare il coordinamento tra di loro.
Le Assise ruggeriane sono di grande importanza si tratta del primo corpo di leggi promulgate
da un sovrano di un regno particolare non per mettere per iscritto le consuetudini tradizionali del
suo popolo, bensì per modificare il diritto vigente nel regno.
Nel Proemio delle Assise Ruggero affermava che la funzione primaria della monarchia era quella
di fare giustizia ed aggiungeva che per svolgere correttamente tale compito il re doveva
intervenire a modificare il diritto vigente dove questo disponesse in maniera difforme dal
superiore principio di equità.
L’originalità dell’Assise consiste nel fatto che per la prima volta la funzione regia veniva
esercitata concretamente mediante l’eliminazione di consuetudini e la promulgazione di norma
valide per tutti i soggetti liberi, con la giustificazione che il re ubbidiva al volere divino.
L’importanza delle Assise di Ariano risiede dunque nella decisione del sovrano di esercitare in
maniera effettiva nell’intero territorio del regno i compiti di giustizia che a lui spettavano.
L’intervento regio realizzato dalle Assise presenta tre aspetti principali:
- l’eliminazione di tutte le consuetudini locali inique e superate;
- la correzione di norme rientranti in ordinamenti particolari;
- la definizione di una sfera di prerogativa giudiziaria del sovrano.
Per il primo aspetto, con l’assisa De legum interpretatione dispose la vigenza di tutte le numerose
consuetudini seguite dalle comunità del regno e contemporaneamente dovevano essere
considerate abrogate tutte quelle contrarie manifestatamente alle leggi regie infine attribuì
alla sua competenza alcuni reati particolarmente rilevanti ai fini della conservazione dell’ordine
sociale: lesa maestà, omicidio, furto…….
Nell’ordine delle fonti giuridiche stabilito dalle Assise, la legge regia non costituiva la norma
generale cui si rinviava quando quelle degli ordinamenti particolari non disponevano al
contrario, essa, in quanto capace di tradurre in diritto l’aequitas, eliminava ogni altra norma nella
materia disciplinata e trovava immediata ed esclusiva applicazione.
138
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
L’impegno nell’amministrazione della giustizia, proclamato da Ariano, venne attuato da Ruggero
attraverso l’istituzione, disposta dalle Assise, dei giustizieri provinciali, con il compito di esercitare
le competenze giurisdizionali rientranti nella prerogativa del sovrano.
Le corti dei giustizieri non furono le uniche corti di giustizia regia nei territori demaniali
operarono anche i baiuli con funzioni di giudici penali per cause di importanza minore rispetto a
quelle dei giustizieri e competenza anche in alcune cause civili.
L’organizzazione della giustizia regia affermatasi durante il regno di Ruggero II, infine, risulta
completata dall’emersione, all’interno della ristretta curia regis, di un gruppo di consiglieri con
esclusivi compiti giudiziari, i cosiddetti grandi giustizieri.
Essi ordinavano lo svolgimento di inchieste per conoscere situazioni locali di fatto e di diritto e
giudicavano liti portate alla conoscenza del re in prima istanza o in seguito a denegata giustizia da
parte di corti locali.
Ruggero rivolgeva anche molta attenzione all’amministrazione delle sue entrate: nelle regioni
meridionali la riscossione e la gestione patrimoniale è affidata ad agenti provinciali, detto
camerario, e diretta dall’ufficio domestico della camera; in Sicilia e Calabria la competenza delle
entrate regie spettò ad un nuovo ufficio di corte, detto la dohana de secretis.
7. L’ORDINAMENTO DEL REGNO NORMANNO NELLA SECONDA META’ DEL SECOLO XII
Il sistema inaugurato da Ruggero II si conservò anche sotto il figlio Guglielmo I (1154 – 1166),
anche se la pace fu turbata nel Regno da conflitti tra il sovrano e il papa e tra il primo e i baroni.
Trovò, infine, piena e distesa realizzazione durante il regno del figlio, Guglielmo II (1166 – 1189),
regno che coincide con un lungo periodo di pace interna.
Guglielmo II riuscì a recuperare e ad amministrare correttamente vasti patrimoni nelle regioni
peninsulari che gli consentirono di assumere anche qui quella potestà di signore territoriale che la
dinastia tradizionalmente esercitava nell’isola di Sicilia inoltre, conferì stabilità all’organizzazione
della giustizia regia.
Grazie al recupero di terre demaniali nelle regioni peninsulari il sovrano estese in maniera
definitiva anche ai rapporti con i signori di queste zone l’ordinamento feudale.
Al regno di Guglielmo II risale la compilazione di un’opera, il “Catalogus baronum”, che registra le
grandi signorie dell’Italia meridionale e divide i loro titolari tra tenentes in capite e tenentes in
servitio si tratta di una classificazione già adottata in Inghilterra e che attesta l’esistenza di una
precisa piramide feudale al cui vertice si trovava il sovrano, quale suzerain di tutti i grandi signori, al
secondo gradino i suoi vassalli diretti, alla base i feudatari di questi ultimi.
L’accresciuta presenza dell’autorità regia nelle regioni peninsulari è confermata dalla nascita di
un apposito ufficio finanziario centrale, la dohana baronum, che si affiancava alla dohana de
secretis e aveva le medesime funzioni di controllo sulle entrate regie per l’Italia meridionale.
139
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Guglielmo II, poi, proseguì l’opera del nonno nel campo della giustizia anche a lui si devono
numerose leggi, non raccolte in un corpo unico, ma conservateci dal “Liber Augustalis” di Federico
II di Svevia in cui confluirono.
Tali disposizioni eliminarono consuetudini considerate inique e superate e intervennero a regolare
materie appartenenti ad ordinamenti particolari in campo feudale, ad es., disciplinarono la
materia matrimoniale, la vedovanza delle mogli dei vassalli diretti, la loro dote, la successione nei
benefici, la prestazione dei servizi dovuti.
Guglielmo II, inoltre, perfezionò il funzionamento della giustizia regia, soprattutto in periferia
sotto di lui i giustizieri provinciali aggiunsero alle loro precedenti competenze anche quella di
confermare privilegi feudali e di curare la corretta esecuzione dell’investitura nel feudo.
I camerari provinciali esercitavano funzioni giurisdizionali specialmente per vertenze mosse da
comunità di liberi contro i loro signori bannali per chiedere il rispetto degli accordi e delle norme
consuetudinarie.
L’ordinamento normanno nel periodo più maturo presenta una significativa funzione unitaria di
giustizia della monarchia: la sua tutela degli ordinamenti particolari si arricchiva con un corrente
esercizio di compiti concreti in materie precisamente definite, compiti esercitati attraverso una
rete diffusa di giudici provinciali e una ristretta corte di giustizia centrale.
CAPITOLO 5 – GLI ORDINAMENTI MONARCHICI DEL MEDIOEVO MATURO
1. INTRODUZIONE
Lo sviluppo dell’economia occidentale, iniziato negli ultimi decenni del secolo XI, conobbe la sua
massima fioritura nel periodo compreso tra la fine del XII secolo e la metà del XIV.
La crescita demografica, l’incremento della produzione agricola, l’intensità dei traffici mercantili sia
locali sa a lunga distanza, l’espansione dell’artigianato costituiscono i momenti salienti di questa
crescita felice e ricca.
2. IL REGNO D’INGHILTERRA E LA MAGNA CHARTA
L’inizio di questo periodo si può far coincidere in Inghilterra con il regno di Riccardo I (1189 –
1199), figlio di Enrico II, anche se le novità più importanti furono introdotte nel regno successivo,
quello di Giovanni Senza Terra (1199 – 1216).
Correntemente gli storici fanno terminare la fase espansiva dell’economia medievale con
l’epidemia della Peste Nera che colpì l’Europa sulla metà del secolo XIV (1347-1352).
L’inizio della recessione si riscontra negli stessi anni anche nel regno inglese all’interno di tale
periodo si possono distinguere tre fasi:
- la prima, ovvero i regni di Riccardo I e Giovanni Senza Terra (1189 – 1216);
140
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
- la seconda, il regno di Enrico III (1216 – 1272);
- la terza, i regni dei tre Edoardi (1272– 1377).
La prima fase vide l’avvio dell’espansione produttiva delle signorie fondiarie e la conseguente
riorganizzazione delle stesse tale riordinamento si espresse nella riduzione dell’area costituita
dai mansi e nell’aumento della pars dominica che veniva affidata alla lavorazione di manodopera
salariata, la cui remunerazione non era stabilita dalla consuetudine e quindi poteva essere fissata
liberamente dal signore.
Questi venivano controllati da agenti domestici del signore detti baglivi.
La ristrutturazione dell’ordinamento curtense risulta in fase avanzata già alla fine del regno di
Giovanni.
In un primo momento il sovrano conservò l’organizzazione tradizionale, fondata sull’appalto degli
sceriffi, limitandosi ad elevare l’ammontare delle loro farm il primo incremento venne disposto
da Riccardo e dopo da Giovanni.
Nel 1204 Giovanni abolì il meccanismo dell’appalto, trasformando lo sceriffo in uno dei tanti agenti
patrimoniali salariati con l’incarico di riscuotere le entrate regie del suo distretto e trasferirle per
intero allo Scacchiere questa riforma si rivelò poco efficace, sia perché le entrate regie non
incrementarono, sia perché lo sceriffo, trasformato in agente patrimoniale, non esercitava più le
altre funzioni.
Nel 1208, allora, Giovanni ritornò al sistema tradizionale dell’appalto, limitandosi negli anni
successivi ad introdurre alcuni aumenti nell’ammontare dello stesso infatti in questi anni il
sovrano incontrava delle difficoltà nell’aumentare in maniera adeguata la sua rendita patrimoniale.
Il diritto inglese si componeva di tanti ordinamenti particolari: il popolare, l’ecclesiastico, il
signorile, il feudale, il municipale e quello unitario del re in questo periodo quello signorile subì
una trasformazione che ne accentuava il significato sociale e quindi ne accresceva l’ambito di
competenza.
Anche la giurisdizione unitaria del sovrano assunse nuove forme organizzative.
Dopo il ritorno di Riccardo I Cuor di Leone dalla Terrasanta le corti di giustizia regia tornarono ad
operare come ai tempi di Enrico II: i giudici itineranti ripresero i loro circuiti regolari, mentre
presso il sovrano operava la curia regis sia nella composizione tradizionale sia come corte dello
Scacchiere.
Queste corti avevano competenza nelle materie riservate alla prerogativa del monarca e nei casi di
common law.
Dagli ultimi anni di Riccardo I l’organizzazione della curia regis centrale cominciò a modificarsi
all’interno dello Scacchiere, corte sempre stabile, emerse una corte nuova, la corte dei Common
Pleas (o Bench at Westminster) composta di giudici professionisti.
141
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Nei primi anni di Giovanni si definì la corte detta coram rege, una corte itinerante che seguiva il
sovrano nei suoi spostamenti ed era quindi composta dai familiari e dai fedeli appartenenti alla
household.
Queste due corti regie avevano uguale competenza e differivano tra loro solo per la
composizione, in quanto la prima era formata da giudici professionisti, mentre la seconda da
familiari del sovrano.
Il motivo della compresenza di varie corti regie centrali deve essere cercato nell’organizzazione
inaugurata da Enrico II sotto di lui la curia regis assumeva sia la forma tradizionale, sia quella
dello Scacchiere:
la prima seguiva il re nei suoi spostamenti, formata da familiari del sovrano;
la seconda era più stabile, formata da giudici e professionisti.
Nella “Leges Henrici primi” l’espressione “common pleas” indica le vertenze di cui erano parte
uomini liberi e per le quali il giudice naturale non avesse reso giustizia o l’avesse resa in maniera
inadeguata.
Quindi: CURIA REGIS 3 FORME: TRADIZIONALE, SCACCHIERE, COMMON PLEAS (che nasce dalla
vastità delle competenze dello scacchiere).
Nasce un’ulteriore corte, chiamata coram rege è una corte tradizionale che aveva le stesse
competenze dello Scacchiere.
La nuova articolazione delle corti centrali regie, con l’emersione di quella dei Common Pleas,
sembra pertanto esprimere l’accresciuta frequenza con cui le comunità ed i signori si rivolgevano
alla giustizia del sovrano, soprattutto per sollecitarne l’intervento in vista del corretto
funzionamento degli ordinamenti particolari.
Quindi, sembra opportuno ritenere che tale corte, attraverso il giudizio di esperti del diritto,
potesse offrire una tutela più attenta a specifici casi, soprattutto in quelli in cui non era stata resa
giustizia.
Le altre due, lo Scacchiere e la corte tradizionale, continuavano ad avere le stesse funzioni, con la
prima che aveva anche competenza contabile.
Il sovrano inglese, dunque, si confermava principale garante dell’osservanza degli ordinamenti
vigenti nel regno.
Ma negli anni in cui la giustizia regia rafforzava il suo significato e trovava nuove forme di
organizzazione, era proprio l’azione del sovrano a mettere a rischio la continuità degli ordinamenti
tradizionali.
Si è già detto delle difficoltà incontrate da Riccardo e poi da Giovanni nell’accrescere le loro entrate
patrimoniali.
Per far fronte all’aumento delle spesse ricorsero ai vari tipi di imposizione straordinaria consentiti
dai singoli ordinamenti del regno.
142
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Riccardo I chiese a tutti i liberi un tributo di un decimo delle loro entrate e dopo di un quarto;
Giovanni impose a sua volta l’imposta prima di un settimo e poi di un tredicesimo.
Oltre ad essere capo del popolo inglese, il sovrano era signore di un esteso patrimonio: in tale
veste Giovanni impose ai soli abitanti delle terre demaniali un contributo straordinario, detto
tallagium, cioè taglia imposta con la forza e non con il diritto poiché eccedeva le prestazioni fissate
dalla consuetudine.
Poi Giovanni si rivolse al clero, facendo valere la sua autorità di custode e protettore
dell’ordinamento ecclesiastico del regno ma Giovanni si rivolse soprattutto ai suoi vassalli
diretti, i tenentes in capite, i quali erano tenuti dal diritto feudale a versare un contributo
(auxilium) nel caso in cui si corresse grave pericolo e il signore si trovasse a sostenere spese
eccezionali per la difesa.
Il ripetuto ricorso del sovrano alla contribuzione straordinaria introduceva una disciplina del diritto
di dominio dei liberi che riduceva la quantità della rendita fondiaria la novità era negativa per i
grandi signori: i sussidi da loro versati al sovrano e l’incremento abnorme dello scutagium
avrebbero potuto dar vita ad un nuovo uso, cioè quello del versamento ordinario di una quota
della loro rendita patrimoniale al re, ma che di conseguenza avrebbe ridotto l’asta estensione del
loro diritto di dominio.
Nel 1215 (anno successivo alla sconfitta di Giovanni a Bouvines in Francia) i magnati ottennero dal
sovrano la definizione scritta dell’intero complesso dei diritti che per tradizione formavano i vari
ordinamenti vigenti in Inghilterra, si impegnarono a rispettarlo e pretesero dal sovrano lo stesso.
Venne definita la “Magna Carta libertatum” con la quale furono specificati tutti i diritti di ognuno
(clero, nobili, mercanti, liberi) e al contempo fu introdotto un nuovo meccanismo di difesa per gli
ordinamenti particolari del regno.
Inoltre la Carta stabilì al cap. 12 che “nullum scutagium vel auxilium ponatur in regno nostro, nisi
per comune consilium regni nostri” sostanzialmente per introdurre tributi straordinari in eventi
eccezionali era necessario il consenso della Magna Curia (l’erede della tradizionale assemblea
popolare ormai composta solo da ricchi laici e ecclesiastici e dalla famiglia del re).
L’evento straordinario non doveva esser lasciato alla discrezione del re, ma sarebbe dovuto esser
concordato da tutti.
L’obiettivo principale della Magna Carta è la conferma degli ordinamenti particolari nella forma e
nei contenuti della tradizione.
Nella Magna Carta la difesa della tradizione si legava con l’introduzione di novità: la norma per cui
l’azione del sovrano, se interferiva con la conservazione dei diritti particolari, non poteva operare
senza limiti ma doveva essere valutata ed accettata dagli esponenti di quegli stessi ordinamenti.
3. DALLA MAGNA CURIA AL PARLAMENTO
Per quanto riguarda il regno di Enrico III (1216 – 1272) quattro sono gli aspetti più significativi
dello sviluppo del diritto.
143
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
In primo luogo, l’accresciuta produzione economica provocò trasformazioni degli ordinamenti
particolari i borghi chiesero una precisa definizione della loro autonomia, maggiori immunità
dall’autorità signorile, un governo libero.
I borghi demaniali acquisirono in gran numero la firma burgi, che li esentava dall’esazione dello
sceriffo e un governo libero guidato da magistrati da loro eletti.
Il secondo aspetto è il miglioramento della gestione patrimoniale regia, dopo le difficoltà del
periodo di Giovanni nei manors regi venne introdotta la nuova organizzazione curtense, con
l’ampliamento della pars dominica, l’impiego della manodopera salariata e la riduzione dei mansi
concessi in affitto; alla guida di ogni manor venne posto un agente patrimoniale, chiamato custos,
con il compito di controllare il lavoro dei contadini.
La riorganizzazione delle aziende demaniali impose una revisione delle funzioni dello sceriffo, che
tornò ad essere mero esattore delle entrate regie, incaricato di custodirle e consegnarle allo
Scacchiere.
L’incremento delle entrate demaniali e l’aumento del numero degli agenti patrimoniali ebbero
conseguenza di accentuare la funzione dello Scacchiere in ordine al controllo contabile.
Lo Scacchiere controllava anche una serie di uffici incaricati di ricevere e custodire le entrate regie
e di disporre le spese decise dal sovrano.
Al di fuori di questi uffici operava il Guardaroba che sotto Enrico III acquisì una propria individualità
e diventando l’ufficio principale per la gestione finanziaria della household regia.
La progressiva specializzazione dello Scacchiere favorì l’emersione di una nuova corte, il King’s
Bench, composta da pochi giudici specialisti, stabile e con la stessa competenza della tradizionale
curia regis.
La sensibile crescita della produzione favoriva i più importanti signori fondiari, in primo luogo il
sovrano essa comportava una decisa trasformazione sociale e della tradizione: l’azione dei
magnati e del re colpiva in particolare i diritti degli uomini liberi appartenenti all’ordinamento della
tradizione popolare.
Ed è proprio tale evoluzione del diritto, con la conseguente riduzione delle libertà garantite ai liberi
dalla consuetudine, il terzo aspetto.
Di fronte all’espansione della competenza regia e signorile le comunità di contea reagirono in vari
modi alcune di loro cercarono di ottenere dal monarca il riconoscimento esplicito dei diritti
tradizionali sotto forma di concessione in cambio del versamento di somme; altre si ribellarono;
molte inviavano al monarca proteste e lagnanze con cui accusavano i suoi rappresentanti di
violazione dei diritti della tradizione e le corti regie di incapacità di assicurare la tutela degli stessi.
Dopo il matrimonio con Eleonora di Provenza (1236), il sovrano aveva cominciato a favorire i nobili
giunti al seguito della moglie.
Per la prima volta nel regno inglese, e questo è il quarto aspetto, il patronato regio veniva
esercitato in modo da ledere i diritti tradizionali dei magnati e delle comunità popolari di contea.
144
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Le proteste della comunità contro gli abusi sia dei funzionari regi, sia dei baroni, sia dei favoriti del
sovrano esplosero nella rivolta del 1258 che si concluse con la riunione della Magna Curia ad
Oxford e con l’approvazione di un complesso di norme detto “Provisions of Oxford”.
I provvedimenti principali furono 3:
- venne creato un consiglio regio formato dal gran giustiziere, dal tesoriere e da quindici
componenti scelti da quattro elettori, nominati due dal re e due dai magnati;
- si stabilì che la magna curia si riunisse tre volte l’anno per esaminare le questioni
connesse con il rispetto degli ordinamenti tradizionali;
- fu istituita in ogni contea una commissione con il compito di raccogliere le lamentele
della comunità contro la violazione dei loro diritti e di presentarle alle corti dei giudici
itineranti i quali dovevano esaminarli e nel caso ripristinare giustizia.
Il nuovo consiglio regio rimase in vita pochi anni: nel 1265 Enrico III riuscì ad avere ragione del
partito riformatore e ad abolire il consiglio che gli era stato imposto ad Oxford.
Il sovrano riuscì anche a ripristinare il carattere eccezionale della magna curia, la quale tornò a
riunirsi solo in occasioni straordinarie.
Nel 1268 per la prima volta Enrico III invitò ventisette città e borghi ad inviare loro rappresentanti
alla magna curia per discutere la definizione dei diritti delle loro comunità la convocazione
proseguì anche negli anni successivi ed introdusse gradualmente una disciplina consuetudinaria
dell’assemblea.
Questa continuava ad essere composta esclusivamente dai magnati, laici ed ecclesiastici, i quali
ribadivano il proprio diritto ad esercitare con il sovrano la potestà giurisdizionale unitaria.
La fase di espansione economica sotto Enrico III continuò con una crescita della grande signoria,
un sensibile incremento della prosperità cittadina, con conseguente accentuazione
dell’autonomia municipale, un netto miglioramento del commercio della lana.
Anche nel terzo periodo, relativo ai regni dei tre Edoardi, gli ordinamenti particolari del regno
inglese avvertirono le sollecitazioni al cambiamento proveniente dallo sviluppo economico e dai
conseguenti mutamenti sociali.
In questa lunga fase il monarca migliorò la gestione delle sue entrate, riorganizzando la
riscossione locale delle stesse ed accentuando il controllo centrale da parte dello Scacchiere.
L’esercizio della giustizia regia si caratterizzò per due elementi: l’aumento dei casi di common law,
la riorganizzazione delle corti centrali.
Ai writs affermatisi nel periodo di Enrico II molti altri vennero ad aggiungersi nel corso del secolo
XIII: lo Statuto di Westminster del 1285 li definì in modo formale, vietando al contempo che a
145
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
quelli già in vigore (brevia de curso) se ne aggiungessero altri e autorizzando la cancelleria regia a
rilasciare brevia inediti solo quando alla vertenza fosse estensibile per analogia la disciplina di un
caso di common law già regolato (brevia in consimili casu).
Questo statuto, però, non fu in grado di opporsi all’espansione della common law: nuovi writs
entrarono nell’uso corrente e emerse una nuova forma di giurisdizione esercitata dal cancelliere.
Tale prassi portò alla definizione di una vera e propria corte presieduta dal cancelliere, ma corte di
equità e non di giustizia.
La corte del cancelliere si venne ad aggiungere alle precedenti corti centrali regie, ovvero lo
Scacchiere (controllo contabile), la corte dei Common Pleas, il King’s Bench (corte stabile, erede
della coram rege), mentre il consiglio regio, erede della curia regis originaria, continuava ad
esercitare funzioni di giustizia.
Il periodo in esame è caratterizzato dalla definizione dei compiti e della composizione della
Magna Curia, l’assemblea che cominciò ad essere designata con il termine di Parlamento.
Per quanto riguarda la composizione, i suoi elementi erano tre: il re con i suoi ministri e le corti di
giustizia, i magnati laici e i titolari delle più elevate cariche ecclesiastiche.
Non venne comunque definito in maniera precisa un diritto-dovere di magnati laici ed
ecclesiastici di far parte della magna curia, essi si recavano alla riunione solo se avevano ricevuto
un writ di convocazione dal sovrano, il quale era libero di scegliere i destinatari.
L’assemblea era una grande corte di giustizia dalla composizione articolata: sin dagli anni di
Edoardo I venne definita la corte del re nel suo consiglio e nel suo Parlamento alle riunioni il
sovrano convocava a volte anche i rappresentanti delle comunità di contea.
Tale invito seguiva una procedura precisa: il sovrano ordinava agli sceriffi di mandare alla corte
della loro contea e alle città del loro distretto un writ invitandole a scegliere i loro rappresentanti
e a inviarli all’assemblea con la plena potestate di impegnarsi a nome della comunità
rappresentata.
Essi si riunivano separatamente ed erano chiamati ad esprimersi sulla decisione adottata dai
magnati.
La distinzione delle 2 riunioni rispondeva alla diversa funzione spettante:
- ai magnati erano i consiglieri del sovrano, i giudici che con lui amministravano la
giustizia regia nei casi in cui l’ordinamento unitario si scontrava con gli ordinamenti
particolari del regno la Confirmatio cartarum del 1297, che ribadì le norme della
Magna Charta, precisando che lo stato di necessità invocato dal re per la richiesta del
sussidio straordinario doveva riguardare il bene comune dell’intera collettività inglese;
- agli esponenti delle comunità difendevano l’ordinamento della tradizione popolare,
cioè quello riguardante tutti gli uomini liberi.
Essi quindi avevano il compito di valutare se questo ordinamento era rispettato dalla
delibera del Parlamento.
146
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Inoltre, portavano all’attenzione del sovrano e delle sue corti di giustizia casi di violazione
dei diritti delle comunità.
Oltre ai casi previsti dalla Magna Carta, l’assemblea affermò l’obbligatorietà del proprio intervento
in occasione di alcune importanti decisioni fiscali.
In primo luogo, i tributi gravanti su tutti i liberi, come quelli sui mobili, dato che i magnati finivano
per essere i soggetti passivi più importanti di tale imposizione.
In secondo luogo, la taglia era un tributo imposto dal re nella sua qualità di signore fondiario
sugli abitanti delle terre demaniali, come tale non era stata annoverata dalla Magna Carta tra i
casi di intervento dell’assemblea.
Ma nel corso del secolo XIII si avvicinò sempre di più alla tassa sui beni mobili e dall’inizio del
Trecento cominciò ad essere compresa tra i casi in cui era necessario sentire il Parlamento.
Oltre al consenso sui tributi straordinari, il Parlamento affermò la propria competenza di corte di
giustizia in un altro settore.
Nel corso del Good Parliament del 1376 il camerato regio Lord Latimer venne accusato di aver
violato ripetutamente il diritto delle comunità l’accusa fu portata all’assemblea dei
rappresentanti delle contee e dei borghi nel quadro delle lagnanze.
Il Parlamento giudicò i contenuti delle accuse, le accolse e condannò Latimer fu il primo caso di
impeachment di un ministro regio e appaiono chiari sia la procedura sia il reato perseguito.
Infine l’assemblea si affermò come occasione nel corso della quale il sovrano promulgava i
provvedimenti legislativi più importanti, detti Statuti.
Questi erano una sorta di risposta della Magna Curia alle lagnanze e alle petizioni avanzate dai
rappresentanti delle contee: quando la tutela dell’ordinamento degli uomini liberi aveva bisogno
di una definizione formale dei diritti di costoro, l’assemblea promulgava norme generali che
precisavano e formalizzavano usi non sempre chiari.
La funzione legislativa del Parlamento si lega inscindibilmente con l’amministrazione della
giustizia da esso svolta.
4. IL REGNO DI SICILIA SOTTO FEDERICO II
Un ruolo particolarmente rilevante la monarchia lo svolse anche in un altro regno, quello di Sicilia
nella prima metà del secolo XIII.
Le forme assunte dall’amministrazione regia e dai rapporti tra la potestà unitaria del sovrano e gli
ordinamenti particolari furono qui diverse da quelle del regno inglese.
147
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Nel 1194 la corona di Sicilia fu conquistata da Enrico VI di Svevia, figlio dell’imperatore Federico I
e marito di Costanza d’Altavilla, ma il suo regno fu breve a lui successe Federico II ancora
minorenne, il quale riuscì a restaurare l’ordinamento regio inaugurato dai suoi avi normanni e a
conferirgli ulteriore slancio e autorità.
Questo viene definito come il periodo di massimo splendore (1220-1250) della potestà
monarchica meridionale.
Federico II divenne re di Sicilia, dei Romani e di Gerusalemme, per matrimonio, e imperatore del
Sacro Romano Impero.
L’esame di questa interpretazione trae origine dall’analisi dell’ordinamento giuridico del regno nei
primi anni di Federico II.
La lotta tra i sostenitori di Tancredi e quelli di Enrico VI, la breve durata del regno del primo svevo,
le guerre combattute nel territorio meridionale negli anni della minore età di Federico II, la sua
assenza dal regno per un breve periodo, resero difficile il funzionamento dell’amministrazione
demaniale e giudiziaria del sovrano, ma non ne segnarono un collasso.
Gli uffici finanziari continuarono a funzionare la “dohana de secretis” operò con buona
efficienza, controllando l’attività di camerari provinciali e degli uffici locali, indicati con il titolo di
dohana.
Maggiori difficoltà incontrò l’esazione regia nelle regioni continentali, dove sin dagli anni di Enrico
VI venne restaurata la magistratura superregionale del maestro camerario di Puglia e Terra di
Lavoro, che sostituì la “dohana baronum”, e dove sono testimoniati in attività camerari provinciali
e altri uffici locali, anch’essi indicati con il titolo di dohana.
Sostanzialmente immutata rispetto al periodo normanno rimase l’organizzazione della giustizia
regia.
Quando, risolti i problemi relativi all’Impero, decise di dedicare la sua attenzione al dominio
siciliano, Federico II si trovò di fronte ad un ordinamento unitario che aveva continuato a vivere
nonostante la lunga crisi politica e ad un’amministrazione regia di cui era necessario restaurare
non le strutture, ma la precedente efficacia.
Il riordinamento del Regno venne affrontato dal sovrano durante il viaggio che lo riportava in
Italia dalla Germania, nel corso di una solenne assemblea generale svoltasi nel 1220 a Capua.
Le costituzioni approvate, note come Assise di Capua, ribadirono l’articolazione degli ordinamenti
conosciuta dal Regno nel periodo normanno venne confermata la giurisdizione dei giustizieri
provinciali regi sia nelle terre demaniali, sia in quelle signorili.
Inoltre si dava risalto al rispetto delle consuetudini approbatae, cioè quelle legittimate da
un’applicazione costante e risalente nel tempo.
Negli anni successivi Federico II realizzò il programma delineato a Capua, dando vita ad
un’articolata organizzazione amministrativa capace di svolgere con efficacia le competenze
spettanti alla potestà regia.
148
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Curò la corretta acquisizione delle entrate. Al centro la guida della gestione finanziaria fu assunta
definitivamente dal grande camerario, mentre il tesoro fu collocato nel castello napoletano di S.
Salvatore a Mare, detto Castel dell’Ovo, e qui affidato ai custodes erarii.
Una corte di controllo contabile, con competenza su tutti gli esattori regi, formati da tre magisteri
rationales.
La riorganizzazione degli uffici finanziari consentì a Federico II di rendere stabile e consistente il
gettito delle entrate regie e quindi di disporre dei mezzi indispensabili per svolgere in maniera
soddisfacente i compiti unitari che gli spettavano nel Regno.
Federico II costruì nelle terre demaniali una diffusa rete di castelli che provvedevano alla
protezione armata delle regioni e al contempo costituivano gli strumenti attraverso i quali il
sovrano svevo svolgeva concretamente in ogni zona la sua potestà di principale signore
territoriale.
L’ambito della giustizia regia rimase nella sostanza quello del periodo normanno venne ribadita
la prerogativa monarchica in alcune materie e soprattutto per alcuni reati.
Le costituzioni approvate nel corso della grande assemblea generale svoltasi a Melfi nel 1231 -
costituzioni che formano il nucleo principale della grande raccolta legislativa di Federico II
intitolata Liber constitutionum Regni Siciliae o nota anche come Liber Augustalis- assegnarono
all’esclusiva competenza regia reati come la lesa maestà, l’omicidio, il furto, l’incendio, la violenza,
il naufragio, i danni dati, l’ingiuria ai curiali, l’ingiuria ai nobili, la falsificazione dei documenti, la
sottrazione di testamento, nonché alcuni delitti altrove spettanti all’ordinamento ecclesiastico
come l’apostasia (ripudio del proprio credo), il sacrilegio, l’adulterio, il lenocinio (favoreggiamento
della prostituzione), l’eresia, la bestemmia, l’usura e lo spergiuro.
I giudici regi, comunque, non erano competenti soltanto nella materia penale della prerogativa
regia essi amministravano anche la giustizia civile.
Inoltre, secondo le costituzioni federiciane, le corti dovevano abbandonare il metodo ordalico per
sostituirlo con quello inquisitorio così da dar piena responsabilità al giudice (quindi la giustizia
non era più privata).
L’importanza della giustizia regia fu messa in risalto dallo stesso Federico nel “Liber Augustalis”.
Nel Proemio dichiarava che era stato Dio stesso a conferire al monarca la funzione di difendere e
tutelare il diritto vigente nel territorio del Regno e di integrarlo con norme che consentissero una
migliore protezione della pace inoltre tali costituzioni avevano l’obiettivo di migliorare la
giustizia regia, sostituendo usi inadeguati e superati con regole eque.
Le costituzioni federiciane stabilirono alcuni punti fondamentali.
Riprendendo l’analoga disposizione di Ruggero II, Federico stabilì che gli usi palesemente contrari
alle sue leggi dovevano intendersi non più in vigore ne conseguiva che tutti gli ordinamenti
particolari conservavano i tradizionali contenuti, con l’eccezione di quegli usi che erano eliminati
dalle costituzioni regie.
149
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Inoltre venne stabilito che la gerarchia delle fonti nell’ordinamento degli uomini liberi era: le
costituzioni, in mancanza di queste le consuetudini locali, infine gli “iuria communia,
Lagabardorum videlicet et Romanum”.
Per quanto riguarda il diritto feudale, la monarchia sveva si arrogò la potestà di disciplinare
direttamente alcuni aspetti dell’ordinamento mentre per tutto il resto continuò a valere la
consuetudine e le singole disposizioni di concessione e le tradizionali corte di giustizia.
Infine anche l’ordinamento municipale risulta pienamente rispettato nei suoi contenuti
tradizionali.
L’aspetto che segna in maniera particolare la monarchia sveva e la distingue dalle altre è costituito
dall’estesa articolazione e dall’efficiente funzionamento degli uffici regi incaricati
dell’amministrazione dell’entrate e dell’esercizio delle potestà unitarie il sovrano svevo non
pretese di avere una potestà unitaria più ampia di quella data dalla tradizione, cercò soltanto di
esercitare l’autorità consueta nel modo migliore.
Il sovrano stabilì che due volte l’anno si tenessero in varie località del Regno assemblee generali
alle quali dovevano intervenire, insieme con i magistrati provinciali regi, prelati, conti, baroni e
rappresentanti delle comunità cittadine della regione.
Compito delle assemblee era quello di pronunciarsi in merito alle lagnanze contro gli abusi
commessi da giustizieri regi e contro ogni altra violazione di diritto da chiunque fosse stata
perpetrata.
Le curie regionali erano le assemblee cui Federico convocava tutte le comunità, sia demaniali, sia
le signorili e le ecclesiastiche, per ottenere il consenso alla collecta, che era il tributo generale
della tradizione normanna soggetti passivi della collecta erano quindi tutte le comunità.
5. I DUE REGNI DI SICILIA
L’ordinamento affermatosi con Federico II proseguì senza sostanziali mutamenti sotto i suoi
successori, Corrado IV e Manfredi le uniche novità di rilievo sono costituite da un canto
dall’acquisizione da parte di alcune signorie feudali di potestà più estese rispetto a quelle
precedenti, dall’altro da una minor efficienza degli uffici finanziari e giudiziari regi.
Carlo I d’Angiò conservò immutata l’organizzazione degli uffici regi centrali e periferici.
La novità principale che caratterizzò i primi anni del governo di Carlo I fu la riscossione
frequente della collecta, che il sovrano introduceva senza consultare l’assemblea generale del
Regno.
L’accresciuto onere fiscale e l’impossibilità di difendere le proprie ragioni nella curia generale
spinsero le comunità dell’isola di Sicilia a ribellarsi al monarca angioino nel 1282, con il
movimento noto come “rivolta dei Vespri”.
Esse accusavano la nuova dinastia di violare il loro diritto tradizionale, introducendo forme di
soggezione contrarie alla consuetudine, e la giudicavano incapace di svolgere la funzione di
giustizia che costituiva la ragion d’essere del potere monarchico.
150
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Esercitarono allora il loro diritto di affidare tale funzione ad una persona diversa: si rivolsero al
sovrano d’Aragona Pietro III e gli consegnarono la corona di Sicilia.
L’unità del Regno fondato dai Normanni veniva spezzata i tentativi degli Angioini di recuperare
l’isola fallirono e il trattato di Caltabellotta del 1302 sancì in via definitiva la separazione.
Da allora ebbero due regni di Sicilia:
quello citra Farum, comprendente le regioni continentali, sotto gli Angioini;
quello ultra Farum, riguardante l’isola, sotto gli Aragonesi.
Il Farum era il faro del porto di Messina.
Nel primo, sin dagli anni successivi ai Vespri siciliani, la giurisdizione unitaria del sovrano si ridusse
a vantaggio degli ordinamenti particolare, specialmente dell’ecclesiastico, del feudale e del
signorile.
I “Capitoli di San Martino”, disposizioni approvate nel corso dell’assemblea generale convocata
da Carlo II di Salerno nella piana di S. Martino nel 1283, riconobbero alla Chiesa del Regno e alle
signorie laiche potestà nuove e più estese alla Chiesa fu garantita piena libertà nella scelta
delle cariche episcopali e monasteriali e nella riscossione della decima, mentre le signorie
ecclesiastiche erano esentate dal versamento della collecta e dei dazi sul commercio di cereali al
di fuori del Regno, nonché dal dovere di fornire ospitalità ai funzionari regi.
I grandi signori laici ottennero:
la riduzione della licenza regia per il matrimonio ai soli beni feudali;
il diritto di esigere dai loro vassalli un moderato sussidio straordinario in caso di necessità;
l’immunità dal dazio regio per il commercio di cereali fuori del Regno;
l’impegno a ridurre la collecta solo in casi eccezionali.
Infine, la competenza penale dei giustizieri nei territori signorili fu limitata a reati di sangue.
L’indirizzo inaugurato a San Martino venne poi proseguito dalla “Constitutio super ordinatione
regni Siciliae” emanata nel 1285 dal pontefice Onorio III essa eliminava la licenza regia per i
matrimoni tra appartenenti alle grandi famiglie baronali, aboliva l’obbligo del servizio militare
feudale e disciplinava la prestazione del sussidio straordinario feudale.
Lo stesso indirizzo fu portato avanti dalla successiva legislazione angioina, i cui atti prendono il
nome di Capitoli, che ridusse la competenza dei giustizieri nei domini signorili ed esentò le
comunità dei benefici feudali dal versamento della collecta.
Sotto Carlo II e sotto Roberto l’evoluzione degli ordinamenti meridionali confermò la svolta
iniziata dopo i Vespri siciliani.
151
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Modifiche rispetto all’età sveva si ebbero anche nell’ordinamento delle città demaniali venne
abbandonata la forma di governo precedente, sostituita con una sorta di governo diarchico
composto da un rappresentante del sovrano e da magistrati eletti dalla comunità.
Ognuna delle due componenti aveva una propria sfera di giurisdizione, ma le sovrapposizioni tra
di loro erano frequenti.
Il periodo in esame sembra caratterizzarsi soprattutto per una progressiva espansione degli
ordinamenti signorile ed ecclesiastico, mentre l’autorità monarchica, da una parte, rinunciava
ad alcune regalie e ad alcune competenze giurisdizionali e dall’altra, esercitava con efficienza
minore rispetto al passato le potestà che le erano riconosciute.
La ridotta competenza giudiziaria delle corti regie provinciali può spiegare l’aumento degli
interventi della curia regis centrale: ad essa finirono per essere presentate direttamente le
vertenze insorte tra nobili, laici ed ecclesiastici, i quali sempre meno trovavano nei giustizieri
provinciali il loro giudice naturale.
L’aumento dell’attività giudicante della curia centrale risulta attestata dalla formazione di ben
definite corti di giustizia presso il sovrano.
In primo luogo la Magna Regia Curia della Vicaria: tale corte non fu eliminata dopo il ritorno a
Napoli di Carlo II, ma si affiancò alla Magna Curia Regia, dividendone il lavoro.
All’interno di quest’ultima si precisarono due corti di giustizia: quella presieduta dal gran
giustiziere e quella guidata dallo judex appellationum.
Sotto Roberto il complesso delle corti centrali venne riordinato: nel 1338 la Magna Regia Curia
cessò di funzionare come corte di giustizia; la corte del gran giustiziere si affermò come corte
penale; la Magna Regia Curia della Vicaria era adita direttamente per le vertenze civili, relative ai
privilegi ecclesiastici e per le questioni di giurisdizione volontaria.
Dalle decisioni della corte del gran giustiziere era ammesso appello al giudice delle appellazioni e
alla Vicaria: non erano appellabili però i giudizi emessi dal giustiziere come giudice di secondo
grado.
Una trasformazione più profonda conobbe la Sicilia ultra la monarchia aragonese era
sostanzialmente acquiescente nei riguardi dell’azione dei nobili maggiori (per lo più Spagnoli) e,
mentre diminuivano i possedimenti regi, aumentavano le unità signorili.
Già alla fine del secolo XIII Federico III eliminò, con la costituzione “Volentes” del 1296, il
preventivo assenso regio alla vendita di benefici feudali, rinunciando all’intervento regio in uno
degli aspetti più delicati del mondo signorile.
Negli anni successivi riconobbe esplicitamente ad alcuni nobili la titolarità di giurisdizioni che per
tradizione rientravano nella prerogativa regia.
Dopo il regno di Federico III si vennero a formare alcune grandi signorie territoriali la cui
estensione occupò la maggior parte del territorio siciliano.
Anche nei confronti dell’ordinamento ecclesiastico, la monarchia aragonese seguì una politica
opposta a quella sveva rinunciò ad ogni ingerenza nella scelta dei titolari delle cariche
152
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
maggiori, giungendo addirittura a tutelare tale libertà anche contro gli interventi del papato, e
lasciò che le materie ecclesiastiche prima disciplinate dal re tornassero alla competenza esclusiva
e tradizionale della Chiesa.
Con un patrimonio molto ridotto e di fronte ad una signoria nobiliare forte e potente, la
monarchia siciliana non riusciva più ad esercitare un significativo ruolo di signore territoriale
nell’isola.
L’articolazione degli ordinamenti siciliani trovò una significativa espressione nel Parlamento che
venne disciplinato a partire dal 1296.
In questa occasione Federico III dispose che ogni anno si riunisse un’assemblea generale,
composta da conti, baroni, alti dignitari ecclesiastici e rappresentanti delle città demaniali, con il
compito di decidere in merito ai problemi della difesa dell’isola ed altre questioni di interesse
comune.
Tale assemblea non comprendeva però esponenti degli uomini liberi e non aveva alcuna funzione
in ordine all’esame di lagnanze della comunità, ma piuttosto esprimeva la volontà di nobili e clero
di prendere parte direttamente all’esercizio della potestà unitaria del re.
6. ORDINAMENTI PARTICOLARI E UNITA’ MONARCHICA IN FRANCIA
Il lungo periodo preso in esame costituisce una fase di grande significato per l’evoluzione del
diritto nelle regioni francesi.
Tale evoluzione presenta alcuni aspetti principali:
a) Le novità conosciute dalle consuetudini locali in seguito alla trasformazione dell’organizzazione
curtense e alle conseguenti modifiche intervenute nei rapporti tra signorie fondiarie e tra queste
e le signorie territoriali.
Sotto questo primo aspetto, anche per le regioni francesi il periodo compreso tra la fine del
secolo XII e i primi decenni del XIV costituisce una fase di sensibile espansione economica.
Le aziende curtensi aumentarono la loro produzione con l’obiettivo di ottenere non solo
quantitativi adeguati all’accresciuta domanda interna, ma anche un surplus da destinare al
mercato.
Si diffuse la tendenza ad una modifica della divisione interna dei fondi; mentre nell’isola prevalse
l’uso di aumentare l’estensione della pars dominica, in Francia questa fu ridotta e divisa in mansi
assegnati a contadini dietro versamento di un censo.
Tale ristrutturazione venne accompagnata dalla tendenza dei signori più potenti ad estendere
l’ambito territoriale del loro dominio, mirando ad affermare la loro potestà bannale l’obiettivo
fu conseguito facendo ricorso alle regole del diritto feudale, nonché ad istituti di diversa
consuetudine.
153
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
L’evoluzione riguardò anche i benefici ecclesiastici e comportò un aumento dell’autorità
patrimoniale dei vescovi, i quali estesero la propria potestà bannale anche sui signori laici,
facendo ricorso sia ai rapporti feudali sia alle censive.
All’interno dei loro domini, i signori laici ed ecclesiastici presiedevano la corte signorile, che
applicava il diritto consuetudinario della zona, e la corte feudale la cui giurisdizione riguardava i
rapporti vassallatici.
I grandi signori laici ed ecclesiastici si avvalsero anche dell’esercizio delle giurisdizioni possedute
in via consuetudinaria su comunità, chiese, benefici ecclesiastici minori, signorie più piccole,
giurisdizioni di cui l’avvocazia, il patronato, l’abbaziato laico costituiscono esempi significativi.
L’espansione economica non riguardò soltanto le aziende curtensi, ma coinvolse anche le città
--- queste allargarono la loro sfera di dominio nelle regioni circostanti facendo rientrare nella
loro orbita economica e politica le signorie e le altre potestà locali.
Gli ordinamenti particolari di ducati e contee appaiono in grado di svolgere in maniera adeguata
l’esercizio della loro giurisdizione, di modo che la giustizia unitaria ducale / comitale spesso si
mantenne nei limiti tradizionali.
Nessun duca o conte cercò di imporre vincoli di dipendenza feudale generalizzati su tutti i signori,
territoriali e fondiari, della regione e di affermarsi come suzerain della stessa.
b) La diffusione in alcune regioni meridionali della scienza giuridica e dell’influenza bolognese,
nonché della contemporanea redazione scritta delle consuetudini delle varie regioni.
Il secondo aspetto significativo dell’evoluzione del diritto nelle regioni francesi è costituito dalla
fondazione di università nelle quali si studiava, sull’esempio bolognese, il diritto giustinianeo e
quello canonico.
Nelle regioni meridionali della Francia la consuetudine locale aveva salde radici di tradizione
romanistica, legate al Breviario alariciano, e quindi fondate sul diritto pregiustinianeo, cioè quello
teodosiano.
In questi territori, sin dal secolo XII, la prassi recepì l’inquadramento dottrinario che la scuola
bolognese andava elaborando, mentre nelle altre regioni la tradizione romanistica era stata
nettamente superata da quella germanica.
Non sorprende che nelle prime sorgessero Studi di diritto sul modello di Bologna e che questi
conservassero vivi i rapporti con questa università.
L’utilità di ricorrere nell’interpretazione del diritto a schemi ed a categorie chiare nonché ad una
tecnica esegetica ben definita era apprezzata sin dal secolo XII anche da interpreti e pratici del
diritto di regioni europee nelle quali la principale matrice dell’ordinamento consuetudinario non
era quella romanistica, bensì la germanica.
Uno Studio di diritto romano e canonico venne fondato in Francia a Orléans, una delle regioni
settentrionali dove la tradizione prevalente era quella germanica.
154
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Sorta sulla metà del secolo XIII, la scuola di Orléans conobbe importanti sviluppi negli ultimi
decenni del secolo, quando i suoi maestri (come de Révigny e de Belleperche) cominciarono ad
applicare un nuovo indirizzo metodologico nell’interpretazione del diritto romano e canonico.
Tale indirizzo applicava alla lettura delle norme la dialettica aristotelica (che parte da ipotesi non
del tutto verificate o da domande sul perché e cerca di raggiungere il probabile) che la filosofia
scolastica aveva riscoperto e andava rielaborando l’insegnamento di Orléans è alla base della
scuola del commento che si sviluppò in Italia nel corso del secolo XIV.
Viene attribuita alla scuola di Orléans la funzione primaria di formazione dei funzionari
dell’amministrazione regia e dei chierici destinati alle cariche più elevate della Chiesa francese.
Nel corso del secolo XIII in molte regioni della Francia centro-settentrionale, cominciarono ad
essere compilate raccolte di consuetudini locali.
Tali raccolte, dette coutumiers, erano opera di privati quindi non avevano carattere ufficiale;
comunque le corti di giustizia le riconobbero piena autorità.
La più antica è intitolata “Très anciens Coutumiers de Normandie”, ad essa seguì il più ampio
“Grand Coutumier de Normandie” scritto prima in latino e poi in francese.
Seguirono le compilazioni di consuetudini come il “Vermandois” e “l’Artois”, la raccolta degli usi
del Beuvaisis (opera del giurista Philippe de Beaumanoir) la stesura di dette raccolte si
proponeva di definire in maniera chiara il contenuto di regole della tradizione.
c) L’espansione del demanio regio e la prima definizione di un ruolo unitario della monarchia.
Il terzo aspetto principale dell’evoluzione dell’ordinamento francese è costituito dall’espansione
del demanio e dell’autorità regia.
Il sovrano, che ancora alla fine del secolo XII era uno dei tanti signori territoriali delle regioni
francesi, riuscì ad estendere la sua autorità su numerose altre regioni.
Nel 1202 Filippo II Augusto conquistò al monarca inglese la Normandia, il Maine, l’Angiò, la
Touraine, il Poitou e la Bretagna e nel 1214 consolidò il successo sconfiggendo in maniera
definitiva Giovanni Senza Terra.
Luigi VIII partecipò alla crociata contro gli Albigesi, promossa dal pontefice Onorio III per stroncare
l’eresia catara particolarmente diffusa nelle regioni meridionali e nel 1226 sottrasse la contea di
Provenza a Raimondo VII: la conquista divenne definitiva nel maggio 1258 con il trattato concluso
tra Luigi IX e Giacomo I d’Aragona.
Sotto Filippo III altri principati passarono sotto l’autorità regia.
Le forme assunte dall’espansione monarchica furono tre.
In alcune regioni il sovrano assunse per sé il ruolo di autorità unitaria fino ad allora tenuta da un
principe è il caso della Normandia dove il monarca entrò in possesso del patrimonio e dei diritti
demaniali fino ad allora spettanti al duca, li esercitò per il tramite di magistrature già attive in
155
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
precedenza, ora divenute da ducali a regie, e conservò nei termini tradizionali i rapporti con gli
ordinamenti particolari della regione.
In altre fu conservata la precedente guida principesca del territorio e il legame tra principe e
sovrano fu affidato a volte al rapporto di fedeltà personale tradizionale, a volte fu meglio definito
attraverso il diritto feudale quest’ultimo è il caso del duca bretone che si riconobbe vassallo del
re.
Infine il sovrano concesse la potestà unitaria di alcuni territori passati sotto il suo dominio a
membri della sua famiglia: una tale signoria viene detta appannaggio.
Questa tripartizione del territorio che a vario titolo faceva capo al sovrano caratterizza la
monarchia francese e la differenzia dalle altre sue contemporanee.
In Francia il demanio regio era assente sia nelle unità territoriali principesche, sia negli
appannaggi: in queste regioni il sovrano costituiva una potestà lontana, incapace di svolgere una
concreta ed effettiva autorità unitaria.
Una tale autorità era possibile per il sovrano solo nel primo dei tre tipi, qui continuavano a
sussistere tutti i precedenti ordinamenti particolari, ma la presenza di un diffuso e consistente
patrimonio regio consentiva al re di essere un effettivo signore territoriale e di stabilire rapporti
continui con detti ordinamenti.
Non è un caso che anche nel periodo in esame il termine regnum continui a designare l’esclusivo
ambito geografico dove il sovrano operava come vera potestà unitaria territoriale.
Per comprendere i termini in cui si sviluppano i rapporti tra ordinamenti nelle regioni francesi
appare necessario distinguere l’area rientrante nella signoria territoriale effettiva del monarca
dall’altra in cui prevalevano le realtà unitarie locali costituite da principati ed appannaggi.
Nella prima la potestà monarchica raggiunse una migliore gestione del patrimonio e dei diritti
demaniali e riuscì a conquistarsi una significativa funzione unitaria nei riguardi degli ordinamenti
particolari.
Con Filippo II Augusto si affermò il principio per cui il sovrano francese non poteva essere vassallo
di alcun signore e le terre da lui tenute dovevano considerarsi suo patrimonio allodiale a pieno
titolo.
L’ambito della rete feudale dipendente dal sovrano non riguardava tutte le signorie fondiarie ma
soltanto quelle stabilite su terre di natura demaniale.
Infine, sin dagli anni di Filippo II Augusto la disciplina dei rapporti tra il re e i suoi vassalli seguì
regole in parte diverse dalla tradizione e da quelle osservate negli altri contratti feudali.
Nelle terre demaniali di gestione diretta i sovrani francesi cercarono di introdurre nuovi e migliori
sistemi amministrativi e di controllo contabile.
156
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Filippo II Augusto formò la domus regia, affidando gli uffici domestici a suoi fedeli, ed infine
organizzò una forma di corte regia, detta Curia in compositis, che controllava i conti presentati
dagli agenti patrimoniali.
In Normandia Filippo Augusto conservò i tradizionali uffici ducali questa struttura di uffici
patrimoniali venne conservata dai successori di Filippo II nel corso del secolo XIII.
Al centro continuò ad essere attivo il ristretto Consiglio regio, mentre il tesoro regio veniva
affidato all’ordine monastico-militare dei Templari che lo custodì nella sede di Parigi, qui si riuniva
anche la Curia in compositis.
Gli uffici domestici furono riorganizzati ed ordinati in una struttura diretta a provvedere alle
necessità del sovrano, detta Hôtel du roi.
L’amministrazione signorile-patrimoniale del re venne disciplinata agli inizi del secolo XIV da
Filippo IV il Bello.
Le terre demaniali furono divise in distretti affidati a senescalchi o balivi, nominati dal Consiglio
ristretto del re, i quali esercitavano tutte le potestà signorili di esazione e giustizia spettanti al
sovrano, erano coadiuvati da luogotenenti, controllavano le attività di funzionari minori e
presentavano i loro rendiconti alla Curia in compositis.
Da quest’ultima curia si delineò una sorta di commissione permanente che in un primo tempo
operò negli intervalli tra le riunioni della Curia, poi ne assorbì le competenze; era definita Camera
comptorum.
Anche l’ufficio di cancelleria partecipava all’amministrazione delle finanze regie; il titolare
(cancelliere) faceva parte della corte itinerante del monarca e curava la redazione dei suoi
diplomi.
La competenza della Camera comptorum venne ampliata e le fu assegnato il controllo degli atti di
alienazione di beni demaniali, dei provvedimenti di confisca adottati da agenti regi per terre di
singoli signori, la competenza sui conti degli ufficiali del sovrano incaricati della riscossione di
tributi straordinari.
Nel 1348 le fu affiancata la Camera delle monete, con specifica competenza in materia di
coniazione regia.
Il buon funzionamento della gestione patrimoniale metteva il sovrano nelle condizioni di svolgere
un’interessante attività di giustizia nelle regioni che rientravano nella sua signoria territoriale.
Le disposizioni di Luigi IX precisavano che in caso di difetto di giustizia le comunità demaniali
potevano ricorrere alla curia regis centrale questa corte risiedeva stabilmente a Parigi e
cominciò ad essere definita con il termine di Parlamentum.
Sotto Filippo IV il Bello il Parlamento acquistò un’articolazione nuova e si formarono tre diverse
camere: la Grande Camera (Grande Chambre), la Camera delle Inchieste (Chambre des Enquêtes),
la Camera delle Richieste (Chambre des Requêts).
157
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
La Grande Camera era competente per vari tipi di vertenze e in campo criminale per i reati
maggiori il suo giudizio si fondava sui risultati dell’inchiesta da lei affidata a commissari,
detti auditores, e si esprimeva con una sentenza, detta arrêt, definitiva ed inappellabile.
I risultati delle inchieste erano valutati preventivamente dalla Camera delle Inchieste, la quale
giudicava direttamente le vertenze di minor rilievo.
La Camera delle Richieste, infine, aveva il compito di esaminare le richieste di giudizio presentate
al Parlamento.
L’organizzazione del Parlamento venne ulteriormente precisata dalle riforme che si susseguirono
tra il 1316 e il 1360: fu allora definitoli numero di componenti di ciascuna camera e si stabilì che
costoro fossero non ecclesiastici o nobili ma esperti di diritto.
Il Parlamento acquistò la sua caratteristica fisionomia di corte di giustizia regia composta da
esperti giuristi scelti dal sovrano quindi il Parlamento non era organo legislativo, ma
giudiziario.
Tale composizione esprimeva la volontà del re di esercitare la potestà giudiziaria unitaria per il
solo tramite di suoi rappresentanti, non con la partecipazione di esponenti degli ordinamenti
particolari.
Una volontà che si manifestò anche nell’istituzione, con Filippo V, della corte centrale regia delle
Requêtes de l’Hotêl la corte seguiva il sovrano nei suoi spostamenti e lo aiutava a rendere
immediata giustizia a chi a lui si rivolgeva direttamente.
Nelle rimanenti regioni l’autorità unitaria del sovrano interferiva poco con lo sviluppo degli
ordinamenti particolari.
La tuitio regia, cioè la protezione che l’autorità superiore del sovrano offriva a tutti i diritti
affermatisi nelle regioni che al sovrano facevano capo, era ricca di potenzialità così, nel corso
degli anni ’80 del secolo XIV l’intervento del re venne invocato dai cittadini minores (le famiglie
popolari) dei Comuni fiamminghi in lotta contro i maiores (l’aristocrazia) che erano sostenuti dal
conte di Fiandra.
Le potenzialità di cui si diceva si concretizzarono in alcune norme che disciplinarono i rapporti tra
l’autorità regia ed alcuni ordinamenti delle regioni.
CAPITOLO 6 – COMUNI, SIGNORIE, UNITA’ MONARCHICHE NELLE ALTRE REGIONI
ITALIANE
1. INTRODUZIONE
Le regioni centrali e settentrionali della penisola italiana confermarono il precedente pluralismo
degli ordinamenti territoriali locali costituiti dai Comuni cittadini e dalle signorie.
Secondo le tradizioni, le regioni centro-settentrionali erano o terrae Imperii o terrae Ecclesiae,
riconoscevano come potestà unitaria le une l’imperatore, le altre il pontefice.
158
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Nelle terrae imperii, il tentativo di Federico II di dar vita ad una funzionale amministrazione delle
terre e dei diritti demaniali vantati dall’imperatore si espresse nell’istituzione, tra il 1239 e il 1240,
di distretti affidati a vicari.
Dopo la morte di Federico II, l’ordinamento svevo non sopravvisse.
Le regioni centro-settentrionali italiane conobbero, accanto ai comuni, forme di signoria fondiaria
e di signoria territoriale, mentre l’economia risulta legata sia all’agricoltura che al commercio.
2. PODESTA’, POPOLO, PLURALISMO ORGANIZZATIVO NEI COMUNI CENTRO-SETTENTRIONALI
Tra la fine del secolo XII e la metà del XIV i Comuni vissero la fase più vivace dello sviluppo
economico.
L’ordinamento del primo Comune era la prima forma unitaria di più ordinamenti particolari
costituiti sia dall’organizzazione di tutti gli uomini liberi, sia dalle strutture privilegiate dalle
famiglie signorili.
Il primo regime comunale è soprattutto la sintesi dei sistemi istituzionali di famiglie signorili,
ciascuna delle quali da sola non sarebbe stata in grado di difendere le proprie libertà.
La magistratura consolare e i consigli cittadini costituiscono la forma di governo che esprime una
sostanziale armonia all’interno dell’oligarchia delle grandi famiglie.
Tale armonia che derivava da numerosi fattori, come il comune interesse delle famiglie
oligarchiche e della restante popolazione urbana ad affermare la separazione dell’ordinamento
cittadino da ogni signoria fondiaria e territoriale e la volontà di eliminare le intromissioni imperiali
(risultato garantito dalla vittoria della Lega Lombarda e dalla pace di Costanza).
Inoltre, sempre più famiglie signorili e contadine contribuirono al fenomeno dell’inurbamento
le famiglie signorili aspirarono a conseguire una posizione uguale a quella delle famiglie
dell’originaria aristocrazia cittadina, attraverso un’identica protezione da parte del Comune
dell’ordinamento particolare.
Tra il secolo XII e quello successivo si spezza l’unità interna dell’antica aristocrazia infatti, in
molti Comuni le famiglie oligarchiche dettero vita ad alleanze dette consorterie basate su accordi
formali tra aderenti e regolate da norme interne ed avevano una struttura di governo simile a
quella del Comune tali alleanze erano dette consorterie; i magistrati delle consorterie avevano
autorità sui liberi che ne facevano parte.
Per salvaguardare l’unità dei Comuni, il governo venne affidato ad un magistrato diverso, il
podestà, il quale aveva il compito di garantire il rispetto del diritto vigente e di mediare i
conflitti interni si stabilì che il podestà doveva venire da una città diversa rispetto a quella in
cui operava, ciò per garantire la sua neutralità e l’efficacia del suo governo.
I compiti del podestà:
secondo una parte della storiografia erano identici a quelli dei consoli, quindi funzioni
militari, giurisdizionali, di governo e di amministrazione;
159
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
invece, secondo altri studiosi l’istituzione del podestà forestiero ruppe l’unicità del potere
consolare, nel senso che i consigli cittadini assunsero la guida della città, si occuparono delle
scelte politiche e della gestione del potere, mentre il podestà si limitò a curare l’attuazione
delle delibere consiliari e a garantire il rispetto del diritto statuario, tentando mediazioni tra
le diverse consorterie.
Il governo podestarile venne lodato dai contemporanei e teorizzato in alcuni trattati sul regime
comunale.
Il giudizio degli storici, invece, non è positivo ne è stata messa in luce la debolezza e la
generale inadeguatezza a risolvere la profonda conflittualità cittadina.
Esso ebbe comunque la funzione di esprimere l’interesse delle consorterie al mantenimento
dell’unità dell’ordinamento comunale, al di là dei dissidi che le dividevano.
L’importanza dell’unità comunale per le consorterie cittadine era evidente ciascuna di loro
voleva impadronirsi in via esclusiva della gestione del Comune per imporre un proprio
ordinamento che privilegiasse i propri interessi e i propri diritti.
Ma alle fine del XII e i primi del ‘200 la situazione divenne ancora più complessa i gruppi
familiari che non facevano ancora parte dell’oligarchia cominciarono ad organizzarsi in
ordinamenti particolari, retti da norme interne e magistrati propri, ottenendo il pieno
riconoscimento del loro sistema istituzionale da parte del Comune.
Tali gruppi vennero identificati dalle fonti come popolo il loro intervento nella vita politica
mise fine al primo comune e lo trasformò in ordinamento unitario più articolato, composto da
più sistemi particolari privilegiati.
Il popolo, secondo la tesi Ottokar (più condivisa), era composto da un miscuglio di mercanti,
artigiani e titolari di fondo accumunati dalla loro totale estraneità all’oligarchia dei primi Comuni
il popolo, di conseguenza, presentava un’organizzazione articolata che non si esauriva nella
corporazione.
E’ proprio la ricca articolazione sociale del popolo che ci consente di comprendere il
funzionamento e la composizione degli ordinamenti unitari.
La forma più nota era la corporazione di mestiere, o arte era un ordinamento che riuniva in sé
tutti i capibottega e i maestri impegnati nel medesimo settore mercantile o artigianale al fine di
riservare il monopolio della produzione in quel settore.
La corporazione aveva piena giurisdizione sui loro aderenti: fissava negli statuti le norme da
ritenere valide, giudicavano le vertenze e vigilavano sul corretto comportamento.
Inoltre ogni corporazione era retta da magistrati e da un consiglio maggiore per le decisioni più
importanti e un consiglio minore che adottava le decisioni di ordinaria amministrazione, nonché
una vasta gamma di officia cui spettava l’attuazione delle decisioni adottate dal governo delle
corporazioni queste non comprendevano però i garzoni e gli operai, quanti prestavano il lavoro
in cambio di salario.
160
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Accanto alla corporazione trovò ampia diffusione l’organizzazione della vicinia o parrochia, un
ordinamento a base territoriale che riuniva tutti gli abitanti di un’area cittadina non compresi
nelle strutture delle famiglie aristocratiche quest’organizzazione era meno solida rispetto a
quella corporativa perché non fondata su una solida comunanza di interessi produttivi.
Nella prima metà del secolo XIII, il popolo procedette in tutti i principali Comuni ad articolarsi in
vari ordinamenti particolari e a fondere detti ordinamenti in una istituzione unitaria che
garantisse più protezione dei loro diritti dette così vita ad un Comune di popolo con propri
magistrati e statuti.
All’interno delle mura municipali, si trovarono a coesistere 2 diversi comuni, quello originario (che
accentuava il suo carattere oligarchico e aristocratico) e quello popolare.
La scissione però non durò a lungo il ruolo centrale assunto dalla città nel sistema produttivo
sollecitò il popolo a cercare di giungere ad un controllo dell’intero municipio e a restaurare l’unità
dell’ordinamento urbano sotto la propria guida (metà sec. XIII).
Questo nuovo indirizzo assunse forma diverse nei vari Comuni ad es. in numerose città della
Lombardia si giunse ad accordi tra una consorteria aristocratica e il popolo, il quale partecipava al
governo cittadino con la magistratura degli Anziani e si affiancò al podestà, assumendo la
direzione politica del Comune.
I successi del popolo si collocano in una società in rapida evoluzione nella quale l’espressione
economica provocava l’ascesa di famiglie nuove e allo stesso tempo metteva in difficoltà quelle
dell’antica aristocrazia.
Tra la metà del XIII sec. vi fu la trasformazione delle elites economiche: sempre più famiglie
popolari riuscirono ad arricchirsi, mentre altre di aristocratici conobbero un rapido declino
tutto questo comportò un mutamento della classe dirigente: si venne a formare un nuovo ceto
dirigente di famiglie o di mestieri potenti, all’interno del quale non si teneva conto dell’origine del
nucleo familiare.
L’Artifoni ha indicato 3 forme principali di governo comunale di popolo sulla base del rapporto
tra corporazioni ed altre associazioni popolari:
- quella dell’assenza si ebbe quando mancò qualsiasi ordinamento corporativo (in
Piemonte);
- quella della concorrenzialità espressa dai contrasti tra arti ed altre associazioni
popolari (comune di Padova);
- quella della fusione portò ad una piena identificazione tra arte e popolo (Perugia).
Tale classificazione non esaurisce tutte le situazioni presenti nelle singole città esse variano da
municipio a municipio.
L’ordinamento comunale si confermò come ordinamento unitario comprendente sistemi
particolari sia vecchi che nuovi ai primi appartenevano l’ordinamento dei liberi, quello
signorile e quello del contado, quelli nuovi quelli prima elencati.
161
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Nel corso del ‘200 si aggiunsero altri ordinamenti, come:
le associazioni tra famiglie (consorterie e societates militum),
le corporazioni di mestiere
e le società popolari ognuno di loro cercava di assicurare protezione e tutela agli aderenti
ed aveva sugli stessi ampia autorità.
A questi, poi, si aggiungevano organizzazioni con base nel contado cittadino ciò si verificò sotto
2 forme principali:
in alcuni casi il municipio eliminò precedenti signorie territoriali e si sostituì loro nella guida
delle comunità in questo caso i funzionari comunali avevano piena giurisdizione;
in altri venne riconosciuto come potestà superiore da signori o da comuni, che continuarono
a rimanere in vita come ordinamenti particolari in questo caso esercitavano solo una
parte della potestà perché l’altra era in mano ai signori o ai comuni.
Gli ordinamenti particolari compresi nell’unità istituzionale del Comune erano nati dalla necessità
di difendere i diritti e gli interessi dei loro aderenti all’interno della comunità cittadina e
proprio tali interessi spingevano i componenti di un Comune a cercare alleati in altre città e a
stringere con loro consorterie.
Espressione di questo fenomeno sono ad es. i due partiti dei guelfi e ghibellini, che riunivano in
un sistema di alleanze e in una complicata rete di vincoli di fedeltà le consorterie di tanti Comuni
dell’Italia centro-settentrionale.
L’alleanza tra fazioni di diversi comuni spiega anche la diffusione di una particolare forma di
rapporto tra municipi, quella della sottomissione del governo di una città alla potestà di un’altra
es. Vicenza: nel 1266 gli Anziani affidarono la guida del Comune al governo popolare di
Padova.
Ancora più diffuse furono le sottomissioni di comuni minori a quelli più importanti della regione
sottomissioni realizzate attraverso la presa del potere nei primi da parte della fazione alleata
alla consorteria dominante nei secondi.
3. STATUTI COMUNALI, CORPORATIVI E ASSOCIATIVI
I vari ordinamenti giuridici vigenti all’interno dell’unità comunale trovarono espressioni in raccolte
unitarie di norme detti statuti queste dovevano essere osservate sia da coloro che ne facevano
parte sia da coloro che ne entravano in contatto.
Tali norme, nate dalla consuetudine, una volta inserite negli statuti, seguivano la sorte di questi,
soprattutto nelle modalità di revisione.
L’ordinamento municipale unitario trovava la sua espressione nello Statuto Comunale che
comprendeva tre elementi:
- le consuetudini cittadine;
162
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
- i brevia (gli impegni giurati di rispettare il diritto urbano assunti dai magistrati al
momento di entrare in carica);
- le deliberazioni delle assemblee cittadine.
Il testo statutario comprendeva norme di diritto privato, criminale e disposizione sulla
competenza dei magistrati.
Inoltre provvedeva anche alle procedure per la revisione: tale compito era affidato in genere a
magistrati particolari- reformatores- i quali erano dottori di diritto o esperti che formulavano un
testo di revisione totale o parziale da sottoporre all’assemblea.
Il diritto statuario costituiva un ordinamento particolare rispetto a quello osservato dagli uomini
liberi della regione: era perciò allo stesso tempo diritto comune per tutti i cittadini del municipio e
diritto proprio nei confronti dell’ordinamento consuetudinario riguardante l’intera comunità degli
uomini liberi.
La sua tutela era affidata a giudici comunali e ad una gerarchia delle fonti ispirata al principio
per il quale si applicava in primo luogo la norma particolare e da questa si risaliva a regole
generali perciò i giudici comunali prima seguivano il diritto statutario; ove questo non fosse
disposto, riprendevano la consuetudine dell’ordinamento generale; e anche se questa non
disciplinava il caso, si rivolgevano alla dottrina giuridica e alla sua interpretazione delle norme
giustinianee e canoniche.
Il rinvio ultimo al diritto manca invece in alcuni statuti, come quelli di Venezia in mancanza di
una norma statutaria i giudici cittadini dovevano rivolgersi agli usi locali e, ove anche in questi non
avessero reperito alcuna regola adatta, erano tenuti a decidere con giustizia ed equità.
Il ricorso all’equità in luogo della dottrina di diritto comune si spiega con l’inadeguatezza delle
regole e degli istituti giustinianei nella disciplina dei rapporti giuridici nati dagli ambiti
commerciali.
L’ordinamento consuetudinario non si avvaleva in città di proprie corti di giustizia esse erano
sostituite dai giudici cittadini.
Conseguentemente le antiche corti di giustizia della tradizione popolare vennero soppiantate
dalle nuove unità organizzative.
Gli statuti municipali costituiscono il modello per quelli delle corporazioni che riunivano le
norme in virtù delle quali erano disciplinate l’organizzazione del lavoro, le relazioni tra membri, lo
svolgimento delle attività lavorative, i rapporti con il Comune e la comunità urbana.
Anche questi statuti prevedevano magistrature proprie e ufficiali competenti per la revisione,
nonché corti di giustizia preposte alla tutela delle disposizioni statutarie incaricate della soluzione
tra vertenze insorte tra aderenti.
In questa situazione l’incertezza del diritto era palese e valeva la gerarchia dalla norma particolare
dell’ordinamento minore a quella più generale dello Statuto cittadino.
163
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
4. ARBITRIUM SIGNORILE E AUTORITA’ VICARIALE
Nel XIII sec. in diversi municipi si verificò un passaggio dal governo repubblicano a quello signorile
perché una consorteria prevaleva su tutte le altre organizzazioni particolari e riusciva ad imporre
un equilibrio all’interno del Comune che non mortificava nessuno.
DIFFERENZE TRA SISTEMA COMUNALE E LA SIGNORIA
Il sistema comunale si fondava sulla tutela del diritto vigente nelle città tramite i magistrati.
Nel sistema signorile il signore aveva l’autorità di governare, amministrare giustizia ed adottare
provvedimenti in ordine alla difesa militare anche al di là del diritto vigente disponeva quindi
della potestà di imperio, di banno e di equità che non trova paralleli nelle magistrature
municipali.
Al riguardo, è interessante la delibera con cui nel 1277 l’assemblea cittadina veronese conferì il
governo ad Alberto Della Scala tale delibera attribuiva al signore una ricca potestà
giurisdizionale, indicata con il termine “arbitrium”, che gli attribuiva un potere svincolato
dall’obbligo del rispetto dell’ordinamento giuridico vigente.
Tale potere poteva essere conferito:
in seguito ad un atto formale in questo caso, le magistrature comunali si trovavano
svuotate nella sostanza e l’ordinamento municipale era violato senza essere sostituito da un
diverso ordine formale;
in seguito ad un atto di fatto in questo caso, la fonte del potere è conferita
dall’ordinamento comunale che, tramite una delibera, concedeva, modificava o eliminava le
competenze attribuite al signore.
A volte, poi, la concessione dell’arbitrium veniva limitata ad alcuni settori del governo ad es. a
Verona nel 1272 il Consiglio maggiore lo aveva assegnato al podestà Andalò degli Andalò per
quanto riguardava le decisioni in tema di guerra e di repressione dei reati più gravi.
Rispetto al sistema cittadino, una novità importante è l’istituto del vicariato che cominciò a
diffondersi nei primi anni del ‘300 nelle terrae Imperi l’imperatore attribuiva l’autorità di suo
vicario-rappresentante- a colui che, di fatto o di diritto, esercitava in un Comune il governo
signorile.
Fonte del potere diventava allora la potestà imperiale, la cui giurisdizione di dominus fondiario
continuava ad essere riconosciuta da tutti gli ordinamenti locali della regione.
Il sistema vicariale dava vita ad una giurisdizione distinta da quella comunale ad essa sovrapposta:
il vicario non era un magistrato dell’ordinamento cittadino, ma un’autorità diversa da
quest’ultimo in quanto rappresentante dell’imperatore.
Il governo vicariale coincise con un’accentuata espansione dell’autorità di grandi centri municipali
nella regione circostante tale espansione coinvolse importanti città e potenti signorie
territoriali.
164
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Nella fase della signoria-vicariato la potestà del signore acquisì un rapporto diretto con tutte le
realtà istituzionali del territorio, un rapporto diretto che rendeva superflua l’intermediazione del
Comune quindi, signorie territoriali, Comuni rurali del contado, municipi cittadini minori si
ponevano nell’ordinamento signorile quali sistemi particolari in immediato rapporto con il vicario
e di questo solo riconoscevano la funzione unitaria e la conseguente giurisdizione superiore,
ricevendo in cambio protezione e tutela dei diritti e privilegi.
Il Comune maggiore, pur continuando ad essere il centro del sistema signorile, diventava allora
uno dei tanti ordinamenti particolari che componevano il vicariato.
La concessione del vicariato segna il passaggio dal Comune alla Signoria.
Le principali caratteristiche di questa forma di governo sono 2:
affermazione della superiore autorità signorile, separata e distinta da quella del comune
principale, che sollecitò la formazione di strutture amministrative e di governo nuove,
direttamente dipendenti dal signore il perno del governo unitario divenne il consiglio del
signore, composto dai suoi fedeli;
nuove forme per gli ordinamenti particolari la signoria introdusse un rapporto più equo
tra i ceti dirigenti, assicurando una difesa più equilibrata dei loro privilegi.
Infine, l’evoluzione istituzionale descritta non riguardò tutti i comuni delle terrae imperii:
- molti di loro conservarono la forma di governo municipale es. Firenze;
- altri furono inglobati in signorie territoriali incentrate in domini fondiari della regione
es. Piemonte.
5. IL DOMINIO TEMPORALE DELLA CHIESA
(XII sec.) Alla Santa Sede si riconosceva una potestà temporale che tagliava trasversalmente la
penisola dall’Adriatico al Tirreno, ma i confini era incerti.
Il papato rivendicava alla propria autorità parte dell’attuale Emilia e la Romagna che erano
contese dall’impero.
L’autorità papale non era messa in dubbio ad Ancona e nell’attuale Umbria mentre non era
pacifica nel Lazio.
Mentre al Nord erano sorti i Comuni, nei restanti territori si erano affermate signorie territoriali
ma mancava un ordinamento unitario regionale che rendeva debole il papato.
Le zone di diretto dominio della Chiesa erano sparse in tutte le regioni, affidate a castellani o a
signori che alla fine del XII sec. si comportavano con grande libertà dal papato.
A questo tipo di terre si devono aggiungere quelle che formavano i benefici delle grandi dignità
ecclesiali e che spesso erano molto estese: le libertà che l’ordinamento canonico garantiva a
165
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
vescovati e a monasteri rendeva immuni tali fondi da un controllo diretto ed immediato da parte
della S. Sede.
La debolezza del possesso fondiario impediva alla Chiesa di dar vita ad un sistema signorile
territoriale che le facesse capo e che riguardasse una specifica regione un tentativo in questo
senso era stato fatto nel corso della metà dell’XI sec.: i pontefici avevano cercato di imporre
vincoli di dipendeva feudale dalla S. Sede ai signori che dominavano le terre del Lazio, allo scopo
di affermare il papato come suzerain feudale di quelle terre tali successi vennero vanificati nel
XII sec. quando l’evoluzione sociale portò ad una trasformazione dell’oligarchia signorile e alla
nascita di nuove dinastie.
Quindi, il papato non poteva contare su un consistente dominio territoriale diretto inoltre,
nel corso del XII sec. lo stesso controllo di Roma gli era stato contestato dalla nascita di un
comune che rivendicava il pieno governo.
Fino agli inizi del XIII sec. la Chiesa risulta priva di un’organizzazione omogenea ed il papato era
lontano dal formulare un programma temporale unitario le pretese della S. Sede
riguardavano solo l’esercizio dei diritti signorili su singoli fondi e terre.
L’ordinamento introdotto da Innocenzo III (1198-1216) si basava sulla divisione delle terre
ecclesiastiche:
in mediate subiectae, o di dominio indiretto costituite dalle signorie territoriali nei
confronti di queste terre il papato non avanzava alcuna richiesta rilevante: accettava la
giurisdizione signorile senza tentare di sottometterla a vincoli di natura feudale e si
accontentava di un formale riconoscimento della propria superiorità e del versamento di un
censo.
e immediate subiectae, o di dominio diretto quelle che potremmo chiamare demaniali.
Queste vennero divise in ampie circoscrizioni e al vertice di ciascuna venne posto un
rappresentante del pontefice detto rettore questo era scelto tra gli ecclesiastici titolari di
un’alta dignità (i cardinali), ma non mancarono laici, per lo più nobili.
I loro compiti erano il governo delle terre e dei diritti signorili spettanti alla Chiesa, alla
riscossione delle entrate (poi affidato al tesoriere), all’amministrazione della giustizia delle
zone di dominio diretto; presiedevano una corte itinerante ed erano coadiuvati da giudici e
da altri ufficiali, tra cui il maresciallo.
A partire dal 1233-1234 si avvalsero di vicari, nonché di rettori in spiritualibus.
Particolare importanza tra gli ufficiali aveva il tesoriere, il quale sottrasse al rettore la
gestione delle entrate, poiché venne istituito come rappresentante diretto della Camera
apostolica e fu posto al vertice di una circoscrizione territoriale.
Le terre su cui i rettori avevano autorità comprendevano anche i Comuni demaniali con
magistrati scelti al popolo e riconosciuti di fatto dal papato.
Il rapporto tra l’autorità della S. Sede e quella dei municipi comprendeva anche l’esercizio delle
rispettive competenze nel territorio della giustizia la debolezza del ruolo unitario della Chiesa
rendeva marginale l’intervento del rettore rispetto alla funzione dei magistrati cittadini.
Il rettore vantava l’alta giurisdizione penale e il potere d’appello in campo civilistico.
166
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Il quadro dell’ordinamento temporale della Chiesa è completato con un’altra istituzione
provinciale detta Parlamento.
In alcuni rettorati vennero riunite con regolarità assemblee generali (in realtà deboli, poco
presenti e non accettate dagli ordinamenti locali) composte da signori territoriali, dignitari
ecclesiastici e rappresentanti delle città demaniali della circoscrizione.
Compito di queste assemblee era tutelare il diritto degli ordinamenti locali del rettorato,
risolvendo le vertenze in atto tra loro ed intervenendo contro le violazioni delle loro potestà, di
migliorare la protezione del diritto vigente mediante la promulgazione di ordinamenta,
costituzioni che integravano o modificavano le norme generali precedenti.
L’ordinamento istituzionale del dominio ecclesiastico venne a sovrapporsi alla moltitudine degli
ordinamenti locali vigenti nelle regioni della Chiesa con l’obiettivo duplice di raggiungere una
qualche forma di amministrazione dei beni e dei diritti demaniali della S. Sede e di ottenere il
riconoscimento definitivo della superiorità temporale della Chiesa da parte degli ordinamenti
medesimi.
Le magistrature provinciali consentirono nelle terre immediate subiectae un miglior governo delle
terre demaniali e una regolare riscossione delle rendite di quest’ultime solo il comune era
tenuto a versare i tributi richiesti dalla Chiesa e consistenti nel censo, l’affitto (pagamento dovuto
per il possesso di un fondo demaniale) e il focatico (somma versata a titolo di riconoscimento
della superiore autorità pontificia).
Le entrate si dividevano in temporali e spirituali quelle che provenivano dai benefici ecclesiastici
sparsi in tutte le terre cattoliche.
Nonostante tutto questo, la Chiesa non poteva vantare in alcuna regione un dominio territoriale
tanto consistente ed importante da consentirle l’esercizio di significativi poteri signorili nell’intera
regione.
Inoltre si affermarono forme di vicariato che venne definito apostolico tale concessione
garantiva la fedeltà dell’ordinamento locale e l’indiscusso riconoscimento della sua alta potestà
temporale.
Nelle regioni intorno a Roma i pontefici accettarono il pluralismo degli ordinamenti signorili
affermatosi spontaneamente e favorirono il rafforzamento delle dinastie a loro fedeli.
La signoria familiare, o quella dei fedeli, del pontefice sostituiva quindi la signoria territoriale della
Chiesa non si equivalevano:
la seconda ove fosse sorta da bisogni di governo delle comunità locali, avrebbe avuto
carattere stabile e avrebbe dato vita ad un ordinamento unitario della regione in mano alla S.
Sede;
la prima difendeva solo in via indiretta i diritti del papato, dato che era prioritaria la tutela
degli interessi signorili.
167
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
L’ordinamento introdotto all’inizio del ‘200 consentì qualche progresso nella gestione delle terre e
dei diritti demaniali l’assetto istituzionale non cambiò, ma mutò la gestione concreta del
governo demaniale, nel senso che i magistrati papali operarono con minor controllo.
Allo stesso tempo si ridusse la fedeltà di signori e Comuni nei riguardi della Chiesa per porre
rimedio a questo declino delle istituzioni temporali, nel 1353 Innocenzo IV inviò come legato e
vicario generale nelle terre della Chiesa il cardinale Egidio d’Albornoz, il quale combattè
vittoriosamente signorie ostili all’autorità pontificia, restaurò il controllo della santa sede su
castelli e rocche ed emanò un nuovo codice di leggi chiamato “Consistutiones aegidianae”.
Tali costituzioni ribadivano l’ordinamento istituzionale della chiesa veniva confermata la
distinzione tra terre di dominio mediato e quelle di dominio diretto.
6. GIUDICATI, COMUNI, SIGNORIE, POTESTA’ MONARCHICA IN SARDEGNA
Tra la fine del XII e la metà del XIV sec. anche gli ordinamenti sardi conobbero un’importante
evoluzione alle forme organizzative autoctone se ne aggiunsero altre importate dalla penisola
italiana e da quella iberica.
In una prima fase, che arriva al terzo decennio del XIV sec., le novità vennero da Pisa e da Genova,
le quali fissarono alcuni importanti insediamenti in Sardegna a partire dal XII sec.
La penetrazione pisana e genovese nell’isola fu favorita dagli stessi giudici sardi, che concessero
privilegi a famiglie e alle chiese cattedrali dei due comuni.
La Sardegna cominciò allora ad essere inserita nelle rotte del commercio mediterraneo e ad
essere coinvolta nella vita politica ed economica dei due comuni.
Gli ordinamenti introdotti in Sardegna dai Pisani presentano forme diverse da quelle promosse
dai Genovesi.
Nel corso del XII sec. e nella prima metà del successivo gli insediamenti pisani si limitarono alle
zone costiere e furono promossi da mercanti che i giudici riconoscevano come liberi ed immuni
dalla propria autorità questa comunità di mercanti venne chiamata “Commune portus”.
Alla fine del XII sec., Pisa cominciò ad inviare propri rappresentanti per governare queste
comunità: i consoli costituivano da una parte la principale magistratura del Commune portus,
dall’altra il collegamento di questo con il comune pisano.
Nel corso della prima metà del secolo, poi, il Commune portus si evolse verso una forma
istituzionale più completa: le colonie di mercanti pisani estesero la loro autorità su un preciso
territorio intorno all’originario insediamento e dettero vita ad un ordinamento uguale a quello del
Comune.
Il comune nato in Sardegna era legato alla potestà del municipio toscano di cui recepiva il diritto
ed era chiamato Comune pazionato.
Quindi, il comune pazionato si inseriva all’interno del sistema giudicale senza modificarlo.
L’autorità pisana e quella giudicale sono in equilibrio:
168
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
- la prima esprimeva le esigenze di una società in rapida ascesa e gli interessi di
un’economia mercantile in sviluppo;
- la seconda rappresentava il mondo tradizionale dell’isola.
I due mondi però non rimasero a lunga separati fin dalla fine del XII sec. le maggiori famiglie
dell’oligarchia pisana si insediarono in Sardegna.
Nel 1190 esse riuscirono ad intervenire nella successione del giudicato di Cagliari e a conquistare
la carica giudicale per uno dei loro esponenti, Oberto di Massa alla fine del XIII sec. un altro
pisano, Lamberto Visconti, si impossessò del titolo giudicale di Gallura.
……………
CAPITOLO 7 – LA SCIENZA GIURIDICA. L’INTERPRETAZIONE DEGLI STATUTI E LA
TEORIA DELLA SOVRANITA’ MONARCHICA
1. L’UNIVERSITA’ DI NAPOLI
Si distingue dagli altri sotto molti aspetti lo Studio fondato a Napoli nel 1224 da Federico II con
l’obiettivo di offrire agli abitanti delle regioni meridionali la possibilità di acquisire una
preparazione giuridica approfondita senza dover varcare i confini del Regno.
A differenza delle altre, l’Università di Napoli nasceva non per spontanee esigenze di scuola,
bensì per esclusiva iniziativa del monarca: nasceva come Università non di studenti ma di
professori.
E il legame con il sovrano segnò lo Studio napoletano anche sotto altri aspetti: i docenti chiamati
ad insegnare erano in genere ufficiali e magistrati regi; il loro insegnamento non riguardava
soltanto i testi giustinianei e le raccolte canonistiche, ma anche la grande compilazione legislativa
del sovrano svevo, il “Liber constitutionum regni Siciliae” o “Liber Augustalis”.
In questo Studio furono attivi nel corso del secolo XIII numerosi docenti, tra i quali ricordiamo
Benedetto d’Isernia, Nicolò Rufolo, Francesco da Telese, Riccardo Petroni, Guglielmo e soprattutto
Andrea Bonello da Barletta, Marino da Caramanico.
Il loro contributo all’interpretazione del diritto giustinianeo è oggi correntemente apprezzato.
2. LA SCUOLA DEI COMMENTATORI
La glossa ordinaria alla compilazione giustinianea portata a termine da Accursio sulla metà del
secolo XIII offriva un bilancio conclusivo dell’intensa e grandiosa opera esegetica dei glossatori
civilisti.
169
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Essa non venne affiancata dalla definizione di nuove metodologie esegetiche, di modo che anche
dopo la sua redazione i giuristi continuarono ad affidarsi a quelle tradizionali.
Costoro preferirono dedicarsi all’esame di singoli argomenti, in particolare di materie di grande
significato pratico ed usarono soprattutto la forma letteraria del tractatus.
Tali giuristi sono definiti glossatori postaccursiani. Tra loro si ricordano Martino da Fano, Guido da
Suzzara, Jacopo d’Arena, Lambertino Ramponi, Dino dal Mugello, Alberto da Gandino, Guglielmo
Durante, Rolandino de’ Passeggeri e Salatiele.
La dottrina civilistica, inoltre, non era più monopolio della scienza italiana: sin dalla prima metà
del secolo XIII, importanti interpreti delle norme giustinianee, in genere educati in Università
italiane o in Studi sorti nei loro Paesi sul modello bolognese, apportarono interessanti contributi
all’esegesi del Corpus Iuris ed al contempo cercarono di applicare categorie, istituti e principi
elaborati dalla scienza giuridica agli ordinamenti nati dalla consuetudine e in vigore nelle loro
regioni.
In Inghilterra fu attivo Henri Bracton (1210- 1268), che aveva studiato a Bologna ed era stato
allievo di Azzone; la sua opera principale “De legibus et consuetudinibus regni Angliae” si
proponeva non soltanto di raccogliere in un corpo unitario gli usi vigenti nel regno, ma anche di
interpretarne la disciplina alla luce di criteri elaborati dalla dottrina bolognese.
Particolare attenzione al diritto consuetudinario mostrarono anche alcuni giuristi francesi tra
Francia e Italia, come Jean de Blanot, autore di un “Tractatus de actionibus”, e il più noto Philippe
de Beaumanoir, autore della raccolta “Coutumes de Clermont en Beauvaisis”.
Arrivarono decise sollecitazioni ad una trasformazione dell’indirizzo metodologico.
Ad Orléans, infatti, nuove strade furono sperimentate da maestri di diritto come Jacques de
Révigny e Pierre de Belleperche formatisi agli studi filosofici e teologici che in Francia avevano
una lunga tradizione, costoro iniziarono ad interpretare le norme giustinianee alla luce del
modello dialettico che era stato riscoperto dalla Scolastica e si andava affermando nella cultura
occidentale come strumento esegetico primario.
Veniva così superato per la prima volta il metodo della glossa, si aprivano alla dottrina nuove
prospettive di approfondimento interpretativo dei testi giustinianei e di più organica e coordinata
costruzione di un sistema teorico in cui principi, categorie e istituti giuridici potessero essere
messi in relazione tra loro in base a criteri logico-formali.
L’impostazione metodologica seguita dai maestri francesi venne approfondita e perfezionata
dal giurista italiano Cino Sighibuldi da Pistoia, che fu loro allievo nello Studio d’Orléans la sua
opera principale, la “Lectura super Codice”, costituisce la prima espressione matura del metodo
scolastico applicato all’interpretazione delle leggi.
Il giurista non si limitava più alla spiegazione delle parole o delle espressioni del testo e al
richiamo dei passi paralleli, ma si proponeva di ricercare il senso più risposto della norma vale a
dire la ratio legis.
A questo fine procedeva ad un’analisi articolata in vari momenti:
170
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
• innanzi tutto la divisio legis l’individuazione delle fonti e delle parti che componevano
la norma;
• poi l’expositio la spiegazione sintetica del suo contenuto;
• quindi la positio casum la citazione di fattispecie concrete
• collectio notabilium l’’indicazione dei rilievi principali che potevano essere formulati in
merito alla norma;
• le oppositiones (o contraria) ovvero l’elencazione delle obiezioni sollevabili;
• infine le quaestiones l’individuazione dei problemi aperti dalla norma cercando di dare
un’interpretazione univoca.
Cino da Pistoia inaugurò un nuovo indirizzo di studio, nettamente distinto da quello della glossa
la scuola venne detta scuola del commento (XIV-XV secolo) ed i giuristi detti commentatori.
Secondo l’Horn caratteri distintivi della scuola sono, oltre alla novità metodologica, la maggiore
attenzione rivolta ai diritti particolari (come quello statuario, feudale, longobardo, nonché la
prassi notarile) e la diffusione della sua dottrina in tutto il mondo occidentale.
Ulteriore peculiarità dei commentatori risiede nel loro congiunto interesse per il diritto
giustinianeo (che rimane il cardine della scuola) e per il canonico, di modo che per loro non
appare possibile tracciare una netta separazione tra le due categorie di civilisti e canonisti che
segna la scuola dei glossatori.
I giuristi fecero ricorso, accanto ai commentari, ai casus, alle additiones, alle quaestiones, ai
consilia, ai tractatus, alle distinctiones, compilarono repertori, elaborarono opere di sintesi.
Principali esponenti della scuola del commento furono Bartolo da Sassoferrato nella prima metà
del secolo XIV, nella seconda metà il perugino Baldo degli Ubaldi entrambi autori di esaustivi
commentari a tutte le parti della compilazione giustinianea, si occuparono anche di temi
particolari:
- Bartolo ha lasciato vaste raccolte di consilia, tractatus, quaestiones;
- Baldo di consilia insieme con una Lectura al Liber Extra di Gregorio IX, scritti di materia
processuale e l’esegesi dei “Libri feudorum”.
Nella prima metà del Trecento insegnarono tra gli altri Riccardo Malombra, Iacopo da Belviso,
Oldrado da Ponte, Raniero da Forlì, Jacopo Buttrigario, Alberico da Rosate, autore di un
“Dictionarum iuris”.
Nella seconda metà del Trecento fiorirono Angelo degli Ubaldi (fratello di Baldo), Bartolomeo da
Saliceto, i meridionali Niccolò Spinelli da Giovinazzo e Luca da Penne, nonché il cardinale
Francesco Zabarella, Pietro d’Ancarano e Antonio da Budrio.
171
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Le opere dei commentatori italiani, in particolare quelle di Bartolo e di Baldo, furono conosciute e
apprezzate in tutto l’Occidente europeo: esse vennero anche utilizzate per l’inquadramento e la
definizione dei diritti consuetudinari, di molteplice natura, vigenti in quelle stesse regioni.
La scuola dei commentatori proseguì anche nel Quattrocento e si può dire che il contributo dei
commentatori all’approfondimento della dottrina giuridica è stato determinante.
Grazie alla loro analisi, che esaminava il testo in profondità per giungere alla ratio della norma, la
definizione di principi, categorie, istituti acquistava un rigore teorico, una precisione scientifica ed
un’articolazione fino ad allora sconosciute.
I commentatori apportarono un contributo decisivo alla dottrina giuridica medievale non solo
attraverso l’approfondimento del pensiero precedente e la definizione di una tecnica
interpretativa più elaborata, ma anche grazie all’individuazione di un sistema unitario e
complessivo del diritto in cui tutti gli ordinamenti particolari potessero rientrare dato che per
tutti potevano esser fatte valere categorie e principi giuridici desunti dalla compilazione
giustinianea e delle raccolte canoniste.
L’interesse verso gli ordinamenti particolari e verso questioni di pratica processuale e notarile sta
a dimostrare un coinvolgimento della dottrina nella realtà effettiva della vita associata, sta ad
indicare un impegno ancora più deciso ad inquadrare la variegata, contradditoria, complessa
disciplina consuetudinaria negli schemi limpidi e definiti, ma al contempo ricchi ed estesi,
costruiti sulla base sicura ed autorevole del Corpus iurisi civilis e delle raccolte canoniste.
3. L’INTERPRETAZIONE DEGLI STATUTI
L’attenzione dei postaccursiani e dei commentatori verso la vita concreta del diritto non si limitò
alla prosecuzione e al perfezionamento dell’opera dei glossatori volta ad inquadrare la molteplice
ed articolata disciplina maturata dalla consuetudine nelle categorie e nei principi elaborati
attraverso l’interpretazione dei testi giustinianei e canonistici si espresse anche nell’analisi
esegetica degli statuti cittadini, quelle raccolte di diritto particolare nelle quali la tradizione
giuridica locale trovava precisa definizione ed organica sistemazione.
I giuristi si posero il problema della legittimità dello statuto come fonte di diritto.
La questione non era soltanto di scuola, ma aveva implicazioni concrete di grande rilievo, dato che
i testi giustinianei limitavano le fonti del diritto alla consuetudine, alla legge del principe, alla
dottrina e non ne riconoscevano altre.
Le principali teorie formulate in proposito furono due:
quella della permissio secondo questi sostenitori, la potestas statuendi (la potestà di
promulgare statuti) si sarebbe fondata sulla concessione fatta da Federico I alle città della
Lega lombarda con la pace di Costanza.
Cioè, l’imperatore, in quanto dominus delle città che rientravano nel Reichsgut, avrebbe loro
concesso di promulgare complessi unitari di norme, di stabilire che solo queste dovevano
essere rispettate nel territorio comunale come diritto particolare di prima applicazione, di
172
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
precisare le formalità per l’evoluzione delle norme medesime, evoluzione che non poteva più
essere lasciata alla mera consuetudine.
La tesi, però, non riusciva ad assicurare un fondamento definitivo alla potestà normativa
comunale, sia perché la faceva dipendere dalla volontà dell’imperatore, sia perché la
collegava ad uno specifico trattato di pace.
quella della jurisdictio questa teoria era più salda.
Secondo Bartolo il diritto vigente nell’Impero universale si articolava in una vasta gamma di
jurisdictiones, che andavano da quella più semplice del dominus fondiario a quella di
massimo respiro dell’imperatore (vari ordinamenti): ciascuna di loro si dotata di specifiche
norme e stabiliva la forma che il proprio diritto doveva assumere.
Nella visione di Bartolo ogni jurisdictio corrispondeva ad uno specifico ordinamento
giuridico: quello comunale esprimeva nello statuto la sua volontà normativa ed organizzativa.
A fondamento dello statuto non c’era più la concessione di un’autorità superiore, ma la
sostanza stessa del sistema giuridico vigente nell’Impero universale con le sue articolate
componenti.
I giuristi dei secoli XIII e XIV, inoltre, non si limitarono a ricercare la legittimazione delle norme
statuarie, ma a queste rivolsero anche la loro attività esegetica l’interesse verso la realtà
concreta del diritto è alla base stessa della rinascita degli studi.
I maestri del Duecento e del Trecento si trovarono di fronte ad un diritto consuetudinario locale
che non si limitava alla forma tradizionale dell’uso non scritto, ma trovava espressione anche nelle
raccolte unitarie degli statuti.
Di conseguenza non solo continuarono ed approfondirono il lavoro esegetico inaugurato dai
glossatori nei riguardi del vastissimo ed informe mondo della consuetudine, ma si rivolsero anche
agli specifici testi statutari.
Questi lessero utilizzando le tecniche interpretative che erano soliti adoperare per i testi
giustinianei e canonistici ed al contempo conferendo all’inquadramento delle norme statutarie
negli schemi teorici un carattere ben più definito e stabile di quanto non era stato possibile fino
ad allora per le norme, continuamente mutevole ed eccessivamente numerose, delle
consuetudini locali.
4. LE DOTTRINE SULLA POTETSA’ MONARCHICA
4.1 IMPERATOR-REX
La dottrina giuridica dei secoli XIII e XIV volse la sua attenzione anche all’analisi della potestà
unitaria del monarca, una potestà di cui la realtà politica del periodo offriva alcune interessanti
manifestazioni e i testi giustinianei una complessa disciplina.
173
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Uno degli argomenti fu quello dell’equiparazione tra la potestà imperiale e quella dei singoli re.
L’esame di tale problema era sollecitato dalla contraddittorietà tra le norme giustinianee, che
disciplinavano la sola potestà imperiale, e la realtà politica del Duecento e Trecento che vedeva
come concrete potestà unitarie singoli re e lasciava all’imperatore una sfera molto limitata di
intervento.
La consapevolezza dell’uguaglianza tra la potestà imperiale e quella regia era certamente diffusa
nei regni nazionali sin dal secolo XII.
La dottrina non si fermò ad una comparazione generica e cominciò a precisare i requisiti che il re
doveva avere per essere equiparato all’imperatore.
Nella glossa di Alano si rinviene un accenno alla teoria che in seguito troverà ampio sviluppo il
canonista si occupava della secolare questione della dipendenza dell’imperatore dal papa e si
pronunciava a favore della suddetta subordinazione, affermando che la potestà del pontefice era
superiore a tutte le potestà temporali del mondo.
Aggiungeva una distinzione tra l’imperatore e gli altri titolari di potestà e dignità “sub
imperatore”: il primo poteva essere deposto dalla carica solo per un crimine di eccezionale
gravità, mentre gli altri potevano essere rimossi anche per reati minori.
Alano restringeva la categoria dei principi equiparabili all’imperatore, precisando la sua
precedente affermazione: introduceva il criterio della non dipendenza, dichiarando che un re
era uguale all’imperatore solo quando “nulli subest” (non soggetto a nessuno).
Il principe veniva rappresentato come non soggetto ad alcuno e perciò equiparato all’imperatore,
qualora non riconoscesse su di sé alcun “superiorem”.
Ora, il termine “superior” era usato correntemente per indicare il signore feudale: la dottrina
cominciò a restringere l’equiparazione con l’imperatore ai soli re il cui patrimonio fondiario avesse
natura esclusivamente allodiale, non contenesse cioè alcuna terra sotto forma di beneficio
vassallatico tale terra avrebbe comportato vincoli di subordinazione del re ad altra persona e
ne avrebbe limitato la libertà di decisione e di guida.
Il pensiero dei giuristi correva immediatamente al re di Francia, il quale sin dagli ultimi decenni
del secolo XII andava proclamando la completa allodialità del suo patrimonio.
Il richiamo alla monarchia francese quale esempio di re non soggetto feudalmente e perciò
equiparabile all’imperatore ha indotto alcuni studiosi ad attribuire ai giuristi francesi il merito di
aver maturato per primi una piena riflessione sull’argomento.
E’ stato indubbio merito del Calasso l’aver chiarito che l’idea dell’equiparazione dell’imperatore al
solo re non vassallo si formò in ambiente bolognese e che il riferimento al sovrano di Francia
nasceva dal naturale richiamo di una situazione universalmente nota, la quale costituiva il
paradigma immediato per la tesi che i giuristi andavano elaborando.
Se il re di Francia era conosciuto come esempio di re che nelle sue regioni non si riconosceva
vassallo di alcuno, il re di Sicilia era noto per la sua dipendenza feudale dal pontefice.
174
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Proprio questa particolare condizione del re siciliano indusse Marino da Caramanico ad
approfondire ulteriormente il tema dell’indipendenza feudale del re al fine di dimostrare che
anche il monarca meridionale rientrava a pieno titolo nella categoria dei sovrani la cui potestà
doveva considerarsi pari a quella imperiale.
Ne venne fuori la più esauriente formulazione della teoria, già abbozzata dai giuristi bolognesi,
che individuava nell’esperienza feudale il requisito indispensabile di una monarchia regia uguale a
quella imperiale.
Nel Proemio della glossa ordinaria Marino da Caramanico cercò di dimostrare che la superiorità
feudale del pontefice riguardava soltanto l’unità complessiva del Regno, non già le singole parti di
questo: pertanto il sovrano poteva essere considerato a ragione signore allodiale del suo
patrimonio, libero da qualsiasi soggezione vassallatica in merito a questo.
Marino proseguiva, poi, precisando i contenuti della potestà monarchica, di cui erano titolari sia
l’imperatore sia i re liberi qetti contenuti erano sostanzialmente tre: la potestà legislativa, la
funzione di ultima istanza di giustizia, il complesso dei diritti demaniali e fiscali.
La dottrina dei glossatori era riuscita dunque ad elaborare un’attenta riflessione sulla potestà
monarchica e ad individuare un preciso criterio di distinzione tra i re che potevano equipararsi
all’imperatore e gli altri.
La teoria si esprimeva sinteticamente in una frase: “rex superiorem non recognoscens est
imperator in regno suo” egli ribadiva ancora una volta che solo l’indipendenza dal dominio
feudale consentiva agli ordinamenti istituzionali di vantare un complesso di potestà uguale a
quello che il testo giustinianeo attribuiva all’imperatore.
Marino da Caramanico non aveva limitato l’analisi della libertà del sovrano siciliano al solo
rapporto tra costui e il papa, ma l’aveva anche estesa alla relazione tra lo stesso re e l’imperatore,
il quale non vantava alcuna superiorità feudale sulle regioni meridionali.
In conclusione, Marino immaginava una situazione originaria caratterizzata da un ordinamento
unitario comprendente tutto il mondo occidentale.
In Sicilia il re era vassallo del papa nel complesso del regno, ma per i domini era libero da
qualsiasi soggezione vassallatica divisione tra dominio diretto (papa) e dominio utile (re).
4.2 LA GIUSTIZIA E LA LEGGE DEL RE
Marino da Caramanico indicava nella potestà legislativa, nella funzione di tutore supremo del
diritto vigente e nella titolarità di beni e diritti demaniali, le componenti della sfera giurisdizionale
del principe e quindi sia dell’imperatore sia dei re liberi.
La stessa articolazione della potestà del principe venne teorizzata ed ampiamente illustrata circa
un secolo più tardi da un altro grande giurista meridionale, Luca da Penne nel suo noto
commento ai “Tres Libri”.
Si è visto a proposito del “Liber costitutionum” di Federico II come l’imperatore svevo esaltasse,
quale compito precipuo del principe, l’amministrazione della giustizia.
175
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Non si trattava di idee nuove, bensì di teorie ormai definitivamente affermatesi grazie alla
diffusione della dottrina bolognese questa aveva saputo individuare l’inscindibile connessione
tra la titolarità di iurisdictio e quella di potestas e di imperium, nel senso cioè che la prima era
riconosciuta come spettante a coloro che godevano di una posizione di superiorità rispetto ad
altri soggetti di diritto e avevano sugli stessi un’autorità di comando.
Un legame talmente stretto che già nel secolo XIII il termine iurisdictio era diventato sinonimo di
potestas, come si legge, ad esempio, nella glossa accursiana.
E l’imperatore non poteva non avere la più elevata iurisdictio in materia temporale nel suo
Impero.
La dottrina aveva chiaro il contenuto della iurisdictio i titolari di questa dovevano curare il
rispetto del diritto vigente ed imporre l’applicazione della disciplina da questo prevista per la
fattispecie concreta sottoposta al loro giudizio.
Il giudice non limitava più la sua funzione a dichiarare il risultato della prova giudiziale, come
avveniva nell’ordinamento germanico, ma si faceva carico della difesa del diritto e ne imponeva
l’osservanza alle parti in causa a lui spettava l’onere di garantire la certezza del diritto e quindi
di conservarne intatta l’esistenza.
Ma entrambe le definizioni sopra ricordate aggiungevano allo ius dicere l’aequitatem statuere: i
titolari di iursdictio non limitavano il loro ruolo alla difesa del diretto vigente, ma partecipavano
anche all’evoluzione dello stesso, poiché nell’applicare la norma dovevano tener conto anche
dell’equità.
Il tentativo di precisare il concetto di aequitas risulta presente nella dottrina sin dai primi tempi
della scuola bolognese.
L’aequitas è distinta in:
rudis è l’equità inespressa che si rinviene a fondamento delle norme di diritto;
constituta: è quella che ha trovato piena manifestazione in un atto legislativo.
L’aequitas, quindi, è per la dottrina la ragione di esistenza della stessa norma giuridica, il suo
fondamento etico di giustizia.
Può allora accadere che il giudice sia costretto a scegliere tra l’applicare ad un caso concreto una
norma vigente ma inadatta a disciplinare in maniera adeguata la fattispecie stessa, oppure
rivolgersi all’equità che gli farebbe disattendere la lettera della norma gli consentirebbe di
stabilire una migliore disciplina.
I titolari di iurisdictio dovevano garantire il diritto vigente, ma al contempo non potevano
disinteressarsi dell’equità.
E il contrasto tra ius ed aequitas si faceva particolarmente grave quando si trattava di applicare la
particolare fonte giuridica che era costituita dalla lex, poiché questa promanava dal principe il
quale era tenuto ad amministrare nel modo migliore la giustizia.
176
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
E proprio sull’applicazione della lex si appuntò l’attenzione della dottrina: si trattava di un
problema che le era del tutto familiare, dato che la stessa ragione d’essere della scuola di diritto
risiedeva nell’interpretazione della legge romana e nella sua applicazione ad una realtà giuridica
profondamente mutata.
L’interpretazione della legge rientrava a pieno titolo nella iurisdictio e quindi spettava innanzi
tutto al principe a quest’ultimo competeva favorire l’avvicinamento tra ius ed aequitas
attraverso la promulgazione di nuove leges che integrassero e aggiornassero le antiche.
In sostanza, la dottrina assegnava all’interpretazione della legge spettante al principe quale
titolare di iurisdictio il compito di migliorare il complesso delle fonti di diritto costituite dalle leges
attraverso la trasformazione in legge dell’aequitas rudis.
Le 2 componenti della potestà regia, quella di amministrare la giustizia e l’altra di legiferare, erano
quindi viste dalla dottrina come connesse.
Lex era il termine con cui in origine era designata la deliberazione approvata dal popolo romano
e valida per tutti i componenti di questo successivamente, l’autorità cogente della lex venne
riconosciuta anche ad altre fonti di diritto da questa differenti, il plebiscito ed il senatoconsulto.
Anche gli atti normativi disposti dall’imperatore venivano equiparati alla lex, in virtù della legge
regia, quella con cui il popolo romano aveva trasferito al principe l’imperium e la potestà di cui
era titolare.
Azzone sosteneva che nel suo significato più esteso, la lex comprendeva anche le costituzioni e gli
editti imperiali.
4.3 PRINCEPS-LEX
La volontà del principe era giudicata in grado di tradurre l’equità in norma di diritto positivo
dotata della forza cogente della legge solo a condizione che esprimesse una disciplina generale e
comune, valida, cioè, per tutti i liberi che facevano parte dell’ordinamento giuridico.
Una volontà dotata di tali requisiti poteva assumere sia la forma della costituzione, sia quella della
sentenza giudiziaria definitiva: in ogni caso aveva valore di legge.
I giuristi si chiedevano se l’imperatore fosse tenuto a rispettare l’espressione di volontà
manifestata in precedenza da lui stesso o da coloro che avevano regnato prima di lui, se
l’imperatore doveva essere legibus alligatus o legibus solutus.
La questione era della massima importanza, poiché dalla sua soluzione dipendeva la possibilità di
utilizzare lo strumento della legge imperiale per seguire l’evoluzione della società e per tradurre
in maniera adeguata l’equità in norma di diritto positivo.
Mentre i soggetti di diritto potevano contare su un quadro preciso di disposizioni per quanto
riguardava le altre fonti giuridiche, dato che ne conoscevano i meccanismi di aggiornamento e di
evoluzione, per quanto riguardava le costituzioni imperiali non avevano alcuna sicurezza, poiché
l’esistenza della disposizione veniva fatta dipendere esclusivamente dalla volontà dell’imperatore
in carica.
177
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Si riteneva che Augusto, pur non essendo obbligato a conservare le norme introdotte dai suoi
predecessori, doveva comunque seguirne il dettato per rispettare l’ordinamento vigente
nell’esercizio della sua propria potestà.
Su alcuni testi romanistica si appuntò la discussione dei giuristi medievali.
I glossatori cercarono di conciliare queste norme tra loro sostanzialmente contraddittorie,
proponendo l’idea per la quale l’imperatore era libero dall’osservanza delle leggi imperiali
precedenti dal punto di vista meramente giuridico, ma era ugualmente tenuto alla loro
osservanza per motivi spirituali.
Azzone affermava che sebbene l’imperatore non potesse imporre ai propri successori l’osservanza
delle leges da lui promulgate, poteva indurli ugualmente a rispettarle con la persuasione:
- primo argomento per conseguire detta persuasione era il ricordo che proprio una lex, la
lex regia de imperio, era a fondamento della potestà imperiale, di modo che tutti i
successori di Augusto dovevano sentirsi obbligati a rispettare le leges;
- secondo argomento era l’inserimento dell’osservanza delle leggi tra le virtù d’animo
richieste al principe.
Alla “virtus animi” Azzone si appellava per richiedere al principe di rispettare, anche se
non tenuto da obbligo giuridico, le leggi da lui medesimo promulgate.
Le conclusioni raggiunte da Azzone vennero riprese da Accursio, il quale insistette soprattutto sul
contenuto morale e spirituale della voluntas del principe di osservare le leggi e sullo stretto
legame tra la stessa voluntas e la funzione di giustizia del monarca.
La voluntas si collegava, dunque, in maniera inscindibile con l’esercizio della giustizia, cioè con
la funzione primaria del principe.
Il monarca necessariamente aveva come virtù la voluntas della giustizia, diretta a realizzare quella
“constans et perpetua” di Dio.
Il rispetto delle leggi precedenti sarebbe necessariamente venuto a mancare quando l’aequitas
avesse imposto una normativa o un giudizio innovativo ancora una volta si sottolineava come
la funzione del principe fosse quella del giudice, cioè del tutore del diritto vigente: ad essa erano
subordinate tutte le altre potestà rientranti nella iurisdictio monarchica.
La questione venne approfondita dai giuristi successivi i quali formularono nuove tesi per
sostenere le ragioni del rispetto della legge precedente nonostante la libertà di azione del
principe.
Il postaccursiano Guido da Suzzara in una quaestio feudale si pose il quesito se l’imperatore fosse
tenuto a rispettare un patto o una concessione di un suo predecessore.
La tesi di Guido si svolgeva tutta in termini di diritto: l’impegno assunto dall’imperatore con un
patto o una concessione non era disciplinato dalla legge imperiale, bensì dal diritto delle genti; se
dunque si poteva ammettere la libertà del monarca dall’osservanza delle leggi, tale libertà non si
178
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
poteva certamente invocare nei riguardi del diritto delle genti che costituiva un ordinamento
separato.
Era un ulteriore limite che veniva proposto alla “legibus solutio” dell’imperatore.
Un significativo contributo alla materia venne, poi, nella seconda metà del Duecento da San
Tommaso egli distingueva due forze all’interno della legge, la coattiva e la direttiva, e
sosteneva che mentre era certamente libero dalla prima, l’imperatore si sottoponeva, tramite la
propria voluntas, alla seconda.
La medesima teoria si ritrova nella prima metà del Trecento in Andrea d’Isernia.
Per capire il significato di questa teoria analizziamo il senso di queste due espressioni:
- la “vis coactiva” è l’autorità cogente del testo legislativo nella forma voluta
dall’imperatore che lo aveva promulgato;
- la “vis directiva” manifestava il principio di diritto esterno e immutabile cui il legislatore si
era ispirato nel formulare il testo, ovvero la ratio legis.
Se alla luce di queste teorie torniamo ad esaminare i passi di s. Tommaso e di Andrea d’Isernia ci
accorgiamo che la distinzione da loro operata rendeva possibile conciliare la forza evolutiva della
legge con la necessità della certezza del diritto e quindi della giustizia.
La voluntas dell’imperatore onesto e giusto riguardava solo il rispetto della “vis directiva”, cioè
della ratio legis, di modo che mentre tutti gli altri soggetti di diritto erano vincolati all’osservanza
della norma, egli solo ne era sciolto.
Tale libertà gli consentiva di giudicare e di legiferare tenendo presente in primo luogo le ragioni
dell’equità, di modo che la sua funzione di tutore della giustizia potesse svolgersi nella maniera
più completa.
Ma la stessa libertà di azione non era riconosciuta all’imperatore nei riguardi della “vis directiva”
della legge: il monarca poteva innovare la legge precedente, ma doveva rispettarne la ratio.
In questo modo l’evoluzione della legge non intaccava la certezza del diritto: i soggetti
dell’ordinamento, infatti, erano garantiti che il principio di diritto eterno incorporato nella singola
disposizione di legge non sarebbe stato alterato né eliminato da un imperatore che intendesse
comportarsi da sovrano giusto e retto.
Si affermò quindi la tendenza a considerare l’imperatore legibus alligatus il principe
amministrava giustizia, garantendo il diritto vigente e rispettando le disposizioni precedenti senza
tentare di innovarle in maniera completamente nuova.
Le conclusioni raggiunte dalla dottrina in merito al rapporto tra imperatore e legge dovevano
adattarsi necessariamente anche a quello tra re e legge, vista l’equiparazione tra il sovrano
universale e i re liberi.
Tuttavia, quando si occuparono di quest’ultimo rapporto i giuristi appaiono assumere un
atteggiamento più deciso nel sottolineare il dovere dell’osservanza delle leggi tale
atteggiamento si coglie innanzitutto nella dottrina italiana.
179
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
La tesi del Bracton, intesa a sottolineare la natura al contempo morale e giuridica del dovere regio
di osservare le leggi, è stata oggetto di particolare attenzione da parte degli storici del nostro
secolo, i quali l’hanno variamente interpretata.
La maggior parte di loro l’ha intesa come diametralmente opposta alle idee prevalenti nella
dottrina italiana, giudicando quest’ultima come favorevole ad escludere ogni vincolo del principe
al rispetto delle leggi:
- alcuni autori hanno definito la dottrina italiana sostenitrice dell’assolutismo monarchico
e, di contro, Bracton come teorico del costituzionalismo;
- altri hanno giudicato l’interpretazione di Bracton come del tutto originale rispetto alla
dottrina bolognese;
- altri, infine, hanno evidenziato la concordanza del pensiero del giurista con la specifica
realtà istituzionale del regno inglese.
A questa corrente interpretativa si oppone l’altra che ritiene il pensiero di Bracton perfettamente
coincidente con l’opinione dei giuristi italiani e attribuisce all’inglese il solo merito di aver
precisato il significato del dovere dei re in ordine all’osservanza delle leggi, significato che nella
precedente dottrina non è definito.
Si deve ricordare che Bracton studiò a Bologna e fu allievo di Azzone; sembra allora legittimo dire
che in Bracton non si trova una dottrina opposta a quella bolognese.
Per lui nella definizione di lex si rinviene l’idea della norma generale e comune, che vincola tutti i
soggetti di diritto e che è diretta alla più equa amministrazione della giustizia.
Accanto alla legge opera la consuetudine come fonte di diritto: entrambe sono strettamente
connesse con la giustizia umana che doveva seguire la constantia ed essere perpetua.
Per concludere, Bracton ripeteva che il principe era tenuto al rispetto della legge dato che da una
legge aveva ricevuto la sua giurisdizione.
4.4 PRINCEPS-IUS
La dottrina medievale appare concorde nel sottolineare il dovere del principe rispetto alla legge,
dovere morale o dovere giuridico, un dovere comunque cogente per il principe medesimo.
Questa dottrina appare interessante non solo per i suoi contenuti ma anche per l’impostazione da
lei seguita nel porre il problema del rapporto tra principe e diritto.
Risulta evidente che l’unica possibilità di intervento innovativo del principe nel mondo del diritto
era ristretta al campo di quella particolare fonte di produzione delle norme indicata come lex.
Con la lex il principe poteva modificare il diritto vigente per poter svolgere nel modo migliore la
funzione di giustizia per la quale la sua stessa autorità si era formata.
Ma al di fuori della lex né i testi romani né i giuristi medievali riuscivano ad immaginare
provvedimenti o comportamenti del principe in contrasto con il diritto, né a concepire la
180
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
possibilità che fosse messa in dubbio la subordinazione del principe all’ordinamento giuridico nel
suo complesso.
Non era verosimile che l’imperatore volesse sovvertire lo ius civile dato che dal diritto egli
derivava la sua stessa autorità, ove questa ipotesi si fosse verificata rappresentava una fattispecie
illecita.
Nel secolo XIV Bartolo da Sassoferrato la teorizzò con estrema puntualità nel trattato “De
tyranno” rilevando che la violazione dell’ordinamento poteva esprimersi:
- nel defectu tituli, ovvero nella mancanza di un legittimo atto di investitura;
- ex parte exercitii, nell’esercizio del potere cioè intendendo la violazione corrente
dell’ordinamento giuridico;
- propter titulum, nella violazione dei limiti della potestà unitaria.
In tutti questi casi non si è di fronte ad un princeps bensì ad un tiranno.
Per i giuristi medievali non era proponibile una questione di libertà del principe dall’osservanza
del diritto: ius è cosa ben diversa dalla lex.
L’ordinamento giuridico, sia nel mondo romano, sia in quello medievale, affondava le sue radici
nella vita quotidiana delle comunità era la consuetudine l’uso nato dalle necessità della vita e
riconosciuto cogente (che costringe) dai componenti della società ad indicare innanzitutto quale
comportamento umano fosse necessario proteggere ed elevare a diritto; la validità di questo era
a tutti evidente proprio perché intimamente legato alla vita e alla tradizione del popolo.
Al diritto nato in questo modo si aggiungeva quello prodotto dalla legge del principe: in questo
caso non era la realtà sociale, ma la volontà del principe a stabilire quale comportamento umano
doveva essere tutelato dall’ordinamento:
- nel primo caso la legittimità della norma era insita nella norma stessa perché fondata su
concrete esigenze della vita associata il principe avrebbe potuto sovvertire l’ordine
nato dalla vita senza porsi contro la propria ragione d’esistere;
- nel secondo si basava sulla mera volontà soggettiva del principe che aveva formulato la
norma il principe avrebbe potuto modificare la disciplina legislativa, dato che questa
poggiava soltanto sulla sua volontà.
L’espressione medievale plena potestas o plenitudo potestatis ricorre di frequente nelle opere dei
giuristi in riferimento all’autorità universale del pontefice e, in misura minore, dell’imperatore
risulta legata alla funzione di giustizia spettante a detta autorità universale, funzione che si
esprimeva anche nella promulgazione di nuove leggi e nell’interpretazione del diritto vigente.
Infatti l’autorità del papa era plena perché illimitata nel genere e senza limitazione.
Inoltre gli dava l’autorità di violare eccezionalmente il diritto sempre in funzione della sua
autorità.
181
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Il papa poi era legittimato a promulgare norme nuove alle quali tutti erano tenuti ad obbedire,
senza porsi il problema della conformità di queste al diritto divino.
Il concetto di plenitudo potestatis non riguarda il rapporto tra autorità universale e diritto, non
configura la legittimazione di un potere svincolato dall’osservanza degli ordinamenti giuridici; si
fonda sulla differenza tra l’autorità universale e quelle unitarie degli ordinamenti particolari:
queste ultime erano limitate al loro specifico ordinamento, mentre la prima non conosceva limiti.
La potestà unitaria di giustizia delle autorità particolari presentava confini ben definiti; l’altra,
quella delle autorità universali, non aveva limiti ed era perciò plena.
Per i giuristi romani come per quelli medievali non era pensabile la libertà del principe
dall’osservanza del diritto, la sua completa superiorità rispetto all’ordinamento.
L’unica ipotesi era quella di un singolo provvedimento del principe, adottato in circostanze
eccezionali, in violazione di una norma specifica era il caso del “rescriptum contra ius”
disciplinato da due costituzioni, una di Valentiniano e Teodosio, l’altra di Anastasio.
Infatti si prevedeva che nessun rescritto contrario al diritto poteva essere tenuto presente dai
giudici, a meno che la sua osservanza non avesse nuociuto a terzi e fosse andata ad esclusivo
vantaggio del beneficiario.
In conclusione, la dottrina risulta concorde nel legare il principe all’osservanza del diritto vigente,
non prese nemmeno in considerazione l’ipotesi di una sua piena libertà dall’ordinamento vigente,
anzi teorizzò numerosi limiti alla sua potestà di violare una norma, in via eccezionale, con un
singolo provvedimento.
Il principe era iure alligatus: solo con una lex- ed atti ad essa equipollenti- poteva innovare il
diritto- quello umano, ma anche il divino e il naturale- dato che la lex era strumento primario
della sua giustizia.
4.5 PRINCEPS DOMINUS
La subordinazione del principe all’ordinamento giuridico non era sufficiente a garantire ai singoli
soggetti la certezza dei loro diritti.
Tale situazione di incertezza riguardava il dominium, il diritto centrale nel sistema giuridico
romano e medievale.
L’imperatore infatti dichiarava di essere “dominus mundi” e i giuristi si chiesero se tale
espressione potesse comportare il dominium del principe su tutti i beni, mobili ed immobili, dei
soggetti di diritto.
L’imperatore era titolare di due diversi patrimoni, quello privato e quello demaniale:
- il primo legato alla sua famiglia o alla sua persona;
- il secondo alla carica da lui ricoperta tale patrimonio era destinato ad essere usato dal
principe solo in vista del bene comune del popolo.
182
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Tale destinazione dei beni demaniali venne condivisa dalla dottrina successiva che giunse a
definire come “quasi sacrae” queste res e ne precisò la disciplina: esse erano inalienabili,
inusucapibili ed imprescrittibili, erano inoltre rivendicabili dall’imperatore in tutte le regioni dove
era riconosciuto come potestà unitaria superiore.
Il dominio privato e quello demaniale del principe erano chiaramente individuabili; non
altrettanto era il suo “dominium mundi”.
Il cronista Ottone di Morena narra che Federico I aveva chiesto ai due maestri bolognesi
Bulgaro e Martino se in base al diritto civile poteva essergli riconosciuto il dominium su tutte le
res del mondo.
Secondo la tesi di Martino nessun dominio privato sarebbe stato più sicuro, dato che di esso
avrebbe potuto liberamente disporre, in quanto dominus, l’imperatore.
Seguendo la tesi di Bulgaro, il dominium del principe sarebbe stato svuotato di contenuti concreti
e si sarebbe limitato alla protezione dei domini privati ovviamente la tesi di Bulgaro fu la più
seguita.
La maggioranza dei giuristi, dunque, preferiva pensare che l’imperatore avesse giurisdizione e
potestà di protezione sulle res dei privati e non il dominium, di conseguenza escludeva un’autorità
di espropriazione del principe.
Un provvedimento di esproprio, adottato dal principe sine causa, pur essendo atto formalmente
legittimo, avrebbe configurato la violazione di una norma morale, avrebbe costituito un peccato.
In astratto il principe avrebbe la potestà di espropriare liberamente i privati, ma è tenuto a
comportarsi secondo la virtù dell’onestà che operava per sollecitare l’imperatore a rimanere
fedele alla sua funzione primaria di tutore delle comunità affidategli da Dio e dei loro diritti.
La dottrina medievale, allora, ci appare costantemente preoccupata di interpretare le norme
giustinianee nel senso di sottolineare il dovere del principe al rispetto dell’ordinamento vigente.
Un dovere che, presentato dai più come espressamente previsto dallo stesso ius civile e da una
parte della dottrina come morale, in ogni caso risulta decisamente vincolante per l’imperatore.
CAPITOLO 9 – LA DOTTRINA GIURIDICA DI FINE MEDIOEVO. LE TEORIE SULLA
POTESTA’ MONARCHICA
183
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
1. COMMENTATORI E UMANISTI
Nel Quattrocento l’indirizzo scientifico ed interpretativo dei commentatori continuò a dominare
nella dottrina e nelle università sorte sul modello bolognese.
Più marcata si fece, invece, la distinzione tra civilisti e canonisti:
- I civilisti appaiono impegnati in maniera particolare in un’intensa attività consulente. Tra i
maggiori civilisti possono essere ricordati Paolo di Castro, Alessandro Tartana, Raffaele
Fulgosio, Giason del Maino, Giovanni da Imola, Angelo Gambiglioni da Arezzo, Francesco
Accolti detto l’Aretino, Bartolomeo Cipolla, Bartolomeo Socini e Filippo Decio;
- Tra i canonisti particolarmente significativi furono Niccolò de’ Tedeschi, vescovo di
Palermo perciò detto Panormita, Francesco Zabarella, Pietro d’Ancarano, Andrea
Barbozza, Antonio da Budrio, Mariano Socini il Vecchio, Felino Sandeo.
L’indirizzo prevalente negli studi giuridici rimaneva legato all’impostazione tradizionale nel
momento in cui il mondo della cultura conosceva la grande stagione della rinascita umanistica.
Ma gli umanisti si volsero ai testi imperiali recando con sé la nuova cultura e il nuovo metodo di
studio.
L’umanesimo giuridico si distinse dagli indirizzi precedenti per due aspetti principali, l’importanza
attribuita all’analisi filologica del testo e la prospettiva storica con cui le norme giustinianee
venivano esaminate.
Gli entusiasmi filologici con i quali l’umanesimo penetrò nella scienza giuridica nascevano non
soltanto dall’impostazione generale degli studi classici seguita nel Quattrocento ma anche
dall’analisi di una redazione delle Pandette giustinianee che era stata a lungo conservata a Pisa e
che nel 1406 era passata a Firenze quando quest’ultima aveva sconfitto la città rivale.
Il manoscritto, indicato come littera pisana o littera fiorentina, presentava il testo completo del
Digesto e fu considerato dai giuristi il codice originario della raccolta, quello uscito dalla
cancelleria di Giustiniano.
Angelo Poliziano lo mise a confronto con i numerosi manoscritti delle Pandette che erano stati
usati tradizionalmente dai giuristi sin dall’inizio della scuola bolognese e che costituivano la
cosiddetta littera bononiensis, o vulgata.
Il suo obiettivo era l’elaborazione di un’edizione critica del testo giustinianeo, ma la morte
precoce gli impedì di portare avanti tale progetto.
L’impostazione del Poliziano venne seguita da Ludovico Bolognini e successivamente da Andrea
Alciato, al quale si fa risalire correntemente l’avvio della scuola culta o umanistica del diritto.
Gli umanisti guardavano alla compilazione giustinianea con occhi del tutto diversi, la vedevano
come una testimonianza altissima di un’epoca di fondamentale significato che poteva essere
compresa solo se posta in relazione al momento storico in cui era stata elaborata.
184
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Il contrasto tra i due indirizzi assumerà forme particolarmente significative nel Cinquecento
quando il metodo umanistico verrà recepito dai giuristi francesi, mentre gli italiani si attardavano
sulle posizioni metodologiche tradizionali.
Sarà allora scontro tra il “mos gallicus iura docendi” e il “mos italicus iura docendi”.
Dunque la dottrina delle università non riusciva ad aprirsi ai nuovi apporti della cultura e perciò
perdeva il primato della cultura civile.
2. LA DOTTRINA GIURIDICA NEI REGNI OCCIDENTALI
La perdita da parte delle Università del monopolio della cultura si riscontra anche in altre regioni
europee, ma in un senso parzialmente diverso da quello indicato per l’Italia centro-
settentrionale.
Qui la dottrina giuridica si allontanò dagli sviluppi della cultura umanistica, ma rimase concentrata
nelle Università, lì fu la stessa dottrina giuridica a trovare centri alternativi agli Studi generali.
Tale fenomeno può essere segnalato per l’Università di Napoli la quale sotto Alfonso e Ferrante
d’Aragona conobbe una nuova fioritura, ma non riuscì ad evitare che l’insegnamento del diritto
offerto nel Regno da privati si imponesse come il polo più carico di energie, sul piano tecnico-
giuridico, e che fermenti culturali più vivaci segnassero soprattutto l’attività professionale dei
giudici e degli avvocati.
Al mondo della burocrazia regia appare anche legata la dottrina negli altri grandi regni occidentali,
l’inglese e il francese, nei quali peraltro continuò l’analisi scientifica del diritto nelle università.
Altra caratteristica comune alla dottrina giuridica dei regni europei fu il particolare interesse da
essa mostrato per la realtà concreta del diritto vigente nei territori del regno.
3. LA POTESTA’ MONARCHICA SECONDO I GIURISTI INGLESI E FRANCESI
Particolarmente interessante appare l’analisi della potestà monarchica proposta dalla dottrina
inglese.
Secondo il Fortescue l’esperienza del mondo occidentale aveva mostrato che esistono due forme
di governo monarchico, il dominium regale e il dominium politicum:
- Il primo è quello dei re che da soli formulano le leggi e le impongono come espressione
della loro volontà, da soli governano il popolo ed entrano in possesso del regno per
diritto ereditario tale forma di governo corrisponde ad una fase più arretrata della
storia della civiltà;
- Nel dominio politico, invece, le leggi sono stabilite dal popolo insieme con il re ed è il
popolo a scegliere i suoi governanti tale forma di governo rappresenta una forma
progredita dell’evoluzione umana, con essa gli uomini rifiutano di accettare un’autorità
che in cambio della difesa loro garantita ne pretenda la sottomissione e decidono di
185
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
provvedere direttamente alla tutela dei propri diritti, delle proprie persone, dei propri
beni.
Accanto alle due forme estreme il giurista ne pone una terza che costituisce una via intermedia
tra di loro, quella del monarca che regna “non tantum regaliter set etiam politice”: si tratta del
sovrano che non esercita da solo il potere di promulgare le leggi, di amministrare la giustizia
unitaria e di imporre tributi, ma fa partecipare il popolo o gli esponenti di questo all’esercizio di
dette potestà.
A detta del Fortescue, la differenza tra il re che governa “tantum regaliter” e quello che opera
“regaliter e politice” non è di sostanza la loro potestà è identica, cambia soltanto il modo in cui
viene esercitata.
Tanto che il titolare del dominium regale resta soggetto alla legge divina e se usa tale potestà in
danno dei cittadini commette peccato.
Il pensiero del Fortescue è stato variamente interpretato dalla storiografia secondo la tesi
dominante il giurista inglese sarebbe il primo teorico della monarchia limitata, costituzionale,
parlamentare dell’Inghilterra, colui che per primo con estrema chiarezza avrebbe affermato la
supremazia del Parlamento nell’ordinamento del regno.
Caratteristica del regno inglese sarebbe stata per il Fortescue la superiorità del diritto
tradizionale sul re, che non poteva cambiare le leggi antiche nemmeno operando insieme con il
Parlamento.
Secondo il Fortescue, il re inglese rispettava l’intero complesso di norme, costituito dal diritto di
natura, dalle consuetudini tradizionali, dalle leggi da lui promulgate tale rispetto non si
traduceva però nell’obbligo di conservare immutate le norme vigenti, al contrario il sovrano
poteva modificare ed integrare il diritto positivo e quando lo faceva agiva insieme al Parlamento.
L’esaltazione congiunta del ruolo del Parlamento e della superiorità del sovrano nell’ordinamento
non costituisce una contraddizione in termini.
L’esperienza inglese aveva conferito al sovrano un compito insostituibile in ordine alla
distribuzione dei privilegi di cui le signorie nobiliari maggiori avevano bisogno per affrontare la
grave crisi economica apertasi a partire dagli ultimi decenni del secolo XIV.
La mobilità sociale comportava un deciso superamento degli equilibri sostanzialmente consolidati
che avevano caratterizzato il sistema istituzionale del regno nei secoli precedenti.
La monarchia svolgeva un compito essenziale, quello di rendere legittima l’acquisizione di
potestà giurisdizionali da parte dei nuovi vertici sociali.
La dottrina giuridica, allora, non poteva non riconoscerne l’autorità superiore la sua attenzione
non era più concentrata sul dovere del sovrano di rispettare l’ordinamento esistente, ma si
rivolgeva alla funzione da lui svolta nel processo evolutivo; al contempo si preoccupava di
precisare alcuni limiti all’autorità regia ed il Parlamento era indicato come istituzione unitaria
pienamente idonea a collaborare con il re.
186
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
Il giudizio del Fortescue sulla monarchia francese risulta condiviso dalla dottrina giuridica di
questo regno.
Già nella seconda metà del secolo XIII Philippe de Beaumanoir aveva rilevato che il sovrano era
legittimato a promulgare da solo leggi vincolanti per tutto il regno, anche se aveva ammesso tale
potestà solo in via eccezionale.
Nel secolo XV l’idea venne ripresa ed enfatizzata da Juvénal des Ursins, il quale insistette
nell’affermare la superiorità del monarca sulla legge emanata da lui stesso o dai suoi predecessori
e nell’indicare come unico limite alla potestà del sovrano il rispetto delle norme divine e la
conformità della funzione regia al dovere primario di amministrare la giustizia.
La dottrina di Juvénal des Ursins si trova a fondamento dell’interpretazione storiografica che
attribuisce alla monarchia francese di fine Medioevo la piena superiorità sugli ordinamenti
particolari del regno e una forma precoce di quel potere che la maggior parte degli studiosi
definisce assoluto e considera caratteristica peculiare in età moderna di molte autorità sovrane.
Appare necessario precisare che la teoria del giurista francese si limitava alla potestà riconosciuta
al monarca all’interno del solo territorio demaniale, inoltre il monarca continuò ad operare nei
ristretti limiti consentiti dagli ordinamenti particolari.
Juvénal des Ursins dichiarò la piena legittimità dei diritti della nobiltà e di libertà ecclesiastiche ed
al contempo proclamò la subordinazione della monarchia all’intero ordinamento giuridico del
regno.
La violazione del diritto vigente da parte del re comportava la disobbedienza del monarca a Dio,
dal quale aveva ricevuto il compito di tutelare il popolo.
Sia il Fortescue sia Juvénal riconobbero nella monarchia francese una potestà senza limiti
nell’esercizio delle sue giurisdizioni e, mentre in Inghilterra il re condivideva con altri l’esercizio
dei suoi poteri, in Francia il sovrano operava da solo.
4. LA POTESTA’ MONARCHICA SECONDO LA DOTTRINA NAPOLETANA E SICILIANA
I temi della superiorità monarchica, dei limiti del suo esercizio, del rapporto tra re e un complesso
di norme giuridiche più ampio di quello costituito dalle sole sue leggi si ritrovano anche nella
dottrina meridionale e siciliana del secolo XV, ma in termini diversi da quelli proposti dai giuristi
inglesi.
Per quanto riguarda il regno napoletano, particolarmente interessante è il pensiero di Matteo
d’Afflitto, vissuto tra la metà del Quattrocento e l’inizio del secolo successivo.
Per quanto riguarda l’autorità del re, il giurista ribadiva la tesi dell’uguaglianza del re libero
all’imperatore in particolare riprendeva la tesi sostenuta in Inghilterra nel secolo XII, per cui i
re nazionali di fatto esercitavano una giurisdizione più ampia di quella gestita dall’imperatore.
Esplicitamente lo aveva sostenuto Andrea d’Isernia e Matteo d’Afflitto.
187
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
La tradizionale impostazione della dottrina di diritto comune risulta pienamente rispettata dal
D’Afflitto, a proposito del diritto del sovrano sulle terre concesse in feudo egli si rifaceva alla tesi
del dominio diviso, elaborata per primo da Giovanni Bassiano.
Insieme con il dominium sull’intero territorio del Regno il sovrano, a detta del giurista, aveva il
potere esclusivo di legiferare e di amministrare la giustizia.
Ma l’analisi di Matteo non si limitava a ripetere concetti tradizionali.
In primo luogo, il modo stesso usato per presentare la potestà di giustizia del sovrano sembra
evidenziare il significato dell’attività legislativa di questo, che viene presentata prima dell’altra
potestà, quella della tutela del diritto vigente, quasi a sottolineare l’importanza del suolo svolto
dal monarca nel processo di trasformazione dell’ordinamento giuridico.
La soluzione data dal giurista al problema della liceità del provvedimento regio contrario al diritto
vigente risulta diversa da quella che era stata prospettata dalla glossa.
A suo parere, il provvedimento contra ius del sovrano era da considerare legittimo solo nel caso in
cui fosse stato giustificato da una iusta causa, cioè il bene della comunità.
Il giurista del tardo secolo XV indirizzava la sua attenzione non tanto al rapporto tra il re e le sue
leggi, quanto al problema della violazione dell’ordinamento vigente da parte di un monarca che
prendeva parte attiva al processo di trasformazione del diritto tradizionale.
Il monarca era inoltre titolare, a detta del d’Afflitto, del mero e misto impero si trattava di una
prerogativa esclusiva del sovrano, di una potestà solo a lui riservata.
La dottrina medievale del tardo Quattrocento – inizi Cinquecento presentava l’autorità
monarchica come titolare del dominium directum sull’intero territorio del regno, del mero
imperio con cui esercitava la funzione di tutore della giustizia, della potestà legislativa al
sovrano era attribuita una giurisdizione amplissima che ne esaltava il ruolo all’interno
dell’ordinamento.
Per quanto riguarda l’esercizio delle potestà regie Matteo D’Afflitto non solo condizionava la
legittimità di un provvedimento contra ius ad una ragione di pubblica utilità, ma dichiarava anche
che il sovrano non poteva a proprio arbitrio alienare il demanio della corona.
Ancora più interessante appare il pensiero del D’Afflitto in merito al rapporto tra l’autorità unitaria
del sovrano e gli ordinamenti territoriali.
Il giurista distingueva due aspetti della potestà rivestita dai signori territoriali, il dominium
relativo al patrimonio concesso in feudo dal sovrano e la titolarità di una più ampia
giurisdizione.
In Matteo d’Afflitto la superiorità del monarca e la stabilità degli ordinamenti territoriali della
grande nobiltà risultano coordinati in maniera originale il sovrano è titolare di una
giurisdizione vastissima ed al contempo è fonte dei privilegi di cui godono i grandi feudatari.
La sua funzione di fonte si esprimeva nel fatto che egli solo legittimava l’esercizio delle ampie
potestà legate al mero impero e che le stesse ritornavano nelle sue mani quando i concessionari
non si comportavano correttamente.
188
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
lOMoARcPSD|9237083
L’attenzione del giurista si rivolge alla relazione tra sovrano ed i grandi feudatari per affermare la
dipendenza dei secondi dal primo e allo stesso tempo per garantire la certezza e la legittimità del
complesso e articolato sistema istituzionale del Regno, con la frantumazione giurisdizionale che lo
caratterizzava, sottraendone la conservazione alla mera volontà del principe.
Gli stessi temi risultano trattati anche dalla dottrina giuridica siciliana.
Spunti interessanti si trovano nel “Tractatus super cap. Volentes” di Gualtiero Paternò, giurista
attivo nell’età dei Martini commentando la disposizione regia che aveva concesso ai feudatari
la potestà di alienare il loro beneficio senza la preventiva autorizzazione regia, il giurista affermava
che la norma non poteva essere eliminata da una legge successiva.
Più ricco ed elaborato è il pensiero di Guglielmo Perno, allievo di Raffaele Fulgosio, e attivo per
molti anni al servizio di Alfonso d’Aragona nei “Consilia pheudalia” egli dedicò particolare
attenzione all’analisi della giurisdizione regia e dei suoi rapporti con quella dei grandi nobili.
L’esaltazione della superiorità del monarca appare nella dottrina del Perno più decisa di quanto
risulta nel pensiero d’Afflitto rispetto al giurista napoletano il Perno offre una trattazione più
concisa, che finisce per presentare le conclusioni senza le sfumature e le distinzioni che si trovano
in quello.
Ciò non significa che il giurista siciliano pensasse di assegnare all’autorità monarchica una potestà
libera dal dovere di rispettare l’ordinamento vigente il monarca è tenuto a rispettare
l’ordinamento che ha creato e non può modificarlo né violarlo senza una giusta causa.
Nell’interpretazione del Perno, dunque, la potestà monarchica è al centro del sistema, da lei
dipende l’esistenza degli ordinamenti particolari, ma una volta che ha deciso di far vivere
giurisdizioni particolari, essa è obbligata a rispettarle e può violarle solo nei casi eccezionali
imposti dai superiori motivi dell’utilità generale.
Potestà regia e potestà signorili erano così prospettate in un equilibrio capace di rispettare il
significato ed il ruolo di entrambe.
189
Downloaded by ale Nazzaro (nazzaroale@gmail.com)
Potrebbero piacerti anche
- Libretto Cresime e Prime Comunioni 2019Documento12 pagineLibretto Cresime e Prime Comunioni 2019Ismaele SalvagnoNessuna valutazione finora
- Benedizione Degli Oli e Dedicazione Della Chiesa e Dellaltare Web PDFDocumento218 pagineBenedizione Degli Oli e Dedicazione Della Chiesa e Dellaltare Web PDFParrocchiaNessuna valutazione finora
- Io, Vescovo Esorcista - Andrea Gemma PDFDocumento207 pagineIo, Vescovo Esorcista - Andrea Gemma PDFSanto Diano100% (1)
- MANUALE DI LITURGIA Vol IV. Dei Sacramenti e Sacramentali. Funzioni ParticolariDocumento340 pagineMANUALE DI LITURGIA Vol IV. Dei Sacramenti e Sacramentali. Funzioni ParticolariPeter Emanuel BútoraNessuna valutazione finora
- Consacrazione ReDocumento120 pagineConsacrazione ReSebastiano TottiNessuna valutazione finora
- Mittner Storia Della Letteratura TedescaDocumento44 pagineMittner Storia Della Letteratura TedescaCarolina SalamancaNessuna valutazione finora
- Rito DellIniziazione Cristiana Degli AdultiDocumento300 pagineRito DellIniziazione Cristiana Degli Adultifrancesca971100% (2)
- Catechesi Al Popolo - Cromazio Di AquileiaDocumento243 pagineCatechesi Al Popolo - Cromazio Di AquileiaMiguel Ángel Barrientos Blanco100% (1)
- Storia Del Diritto in Europa Padoa Schioppa RiassuntoDocumento127 pagineStoria Del Diritto in Europa Padoa Schioppa RiassuntoGraziana Ranieri100% (6)
- Unzione Degli InfermiDocumento106 pagineUnzione Degli InfermiTomDokNessuna valutazione finora
- Teologia PDFDocumento13 pagineTeologia PDFAndrea Raffaele FilanninoNessuna valutazione finora
- Teologia Pratica 1Documento382 pagineTeologia Pratica 1Magda Cruz100% (1)
- Filippo Cassola I Gruppi Politici Romani Nel III Secolo A.C.Documento215 pagineFilippo Cassola I Gruppi Politici Romani Nel III Secolo A.C.longino78100% (1)
- Le Istituzioni Politiche Del Mondo RomanoDocumento29 pagineLe Istituzioni Politiche Del Mondo RomanoJennifer Elisabeth Sofia Costa100% (1)
- Il RegnumDocumento31 pagineIl RegnumSTEFANIA FORTUNATONessuna valutazione finora
- ScovazziDocumento260 pagineScovazziMorgause2011Nessuna valutazione finora
- Vassallaggio e Beneficio - BarberoDocumento10 pagineVassallaggio e Beneficio - BarberoGiovannaNessuna valutazione finora
- Padoa SchioppaDocumento116 paginePadoa SchioppaRolove100% (1)
- Storia Del Diritto Italiano AscheriDocumento15 pagineStoria Del Diritto Italiano AscheriGiovanna SfanòNessuna valutazione finora
- (FUCI) Commissione Cultura - La Famiglia RomanaDocumento18 pagine(FUCI) Commissione Cultura - La Famiglia RomanaLia PatrascuNessuna valutazione finora
- Oriani A. - 1921 - La Lotta Politica in Italia Vol. I PDFDocumento363 pagineOriani A. - 1921 - La Lotta Politica in Italia Vol. I PDFMarco PanciroliNessuna valutazione finora
- Lezione 2. I Caratteri Dell'impero Romano e La Sua DissoluzioneDocumento5 pagineLezione 2. I Caratteri Dell'impero Romano e La Sua DissoluzioneFrancesco LentiNessuna valutazione finora
- La Rivoluzione Americana: Una Rivoluzione Senza IdeologiaDocumento3 pagineLa Rivoluzione Americana: Una Rivoluzione Senza IdeologiaPietro VivianiNessuna valutazione finora
- Talamanca 86 PagDocumento87 pagineTalamanca 86 PagSalvatore CascellaNessuna valutazione finora
- Istituzioni Di Diritto Romano Pugliese Parte 1Documento45 pagineIstituzioni Di Diritto Romano Pugliese Parte 1Giovanni PorcedduNessuna valutazione finora
- La Città Italiana nell'Alto Medio Evo: Il Periodo Langobardo-FrancoDa EverandLa Città Italiana nell'Alto Medio Evo: Il Periodo Langobardo-FrancoNessuna valutazione finora
- Istituzioni Di Diritto Romano 2Documento21 pagineIstituzioni Di Diritto Romano 2Amasia MeloniNessuna valutazione finora
- Dal Medioevo All'età ModernaDocumento27 pagineDal Medioevo All'età ModernaValerio TagliaferriNessuna valutazione finora
- Caduta Impero Romano e Regni Romano BarbariciDocumento4 pagineCaduta Impero Romano e Regni Romano BarbariciFrancesco LentiNessuna valutazione finora
- Diritto MedievaleDocumento67 pagineDiritto MedievaleFlavia MantaNessuna valutazione finora
- Nuvole a occidente: La conquista romana della GreciaDa EverandNuvole a occidente: La conquista romana della GreciaNessuna valutazione finora
- GILM20 1870a 07Documento5 pagineGILM20 1870a 07Aurora MarinoNessuna valutazione finora
- Senza Nome 1Documento8 pagineSenza Nome 1Francesco GenualdoNessuna valutazione finora
- Appunti Storia Romana 2bss - PARTE 1Documento4 pagineAppunti Storia Romana 2bss - PARTE 1leo.marusicNessuna valutazione finora
- Appunti Diritto Romano PDFDocumento103 pagineAppunti Diritto Romano PDFNicolò RumiNessuna valutazione finora
- PDocumento8 paginePSconosciuto PerfettoNessuna valutazione finora
- 28 Febbraio, Passaggio Dalla Monarchia Alla RepubblicaDocumento7 pagine28 Febbraio, Passaggio Dalla Monarchia Alla RepubblicaEli MioNessuna valutazione finora
- Letteratura Latina La Prosa ArcaicaDocumento4 pagineLetteratura Latina La Prosa Arcaicalivia del gaizoNessuna valutazione finora
- La Famiglia Nel Diritto RomanoDocumento28 pagineLa Famiglia Nel Diritto RomanoMartina CelsoNessuna valutazione finora
- La Famiglia RomanaDocumento52 pagineLa Famiglia RomanaAngelo ChiarleNessuna valutazione finora
- Riassunto Storia Del Diritto Medievale e Moderno in EuropaDocumento98 pagineRiassunto Storia Del Diritto Medievale e Moderno in Europarox041Nessuna valutazione finora
- La Germania Di Tacito Dal Rinascimento Al NazismoDocumento2 pagineLa Germania Di Tacito Dal Rinascimento Al NazismoCamilla CrippaNessuna valutazione finora
- Luigi Copertino in Morte Dello Stato (E Della Pubblica Amministrazione)Documento14 pagineLuigi Copertino in Morte Dello Stato (E Della Pubblica Amministrazione)Historica VariaNessuna valutazione finora
- Sulla Storia Del Principio Di Maggioranza by Otto Von GierkeDocumento75 pagineSulla Storia Del Principio Di Maggioranza by Otto Von GierkeAshley HughesNessuna valutazione finora
- Diritto RomanoDocumento42 pagineDiritto RomanoMichele D'AmatoNessuna valutazione finora
- Docsity Modelli Politici Di Roma Antica Luca Fezzi 1Documento41 pagineDocsity Modelli Politici Di Roma Antica Luca Fezzi 1giacomoNessuna valutazione finora
- Tacito Commento Su Germania 4Documento4 pagineTacito Commento Su Germania 4psyttacoNessuna valutazione finora
- Mores MaiorumDocumento2 pagineMores MaiorumsetarofedericaNessuna valutazione finora
- L'uomo Del SeicentoDocumento138 pagineL'uomo Del SeicentoPietro NeriNessuna valutazione finora
- Diritto Romano e CristianesimoDocumento5 pagineDiritto Romano e CristianesimodonpedrodetoledoNessuna valutazione finora
- Il Costituzionalismo Statunitense All in PDFDocumento20 pagineIl Costituzionalismo Statunitense All in PDFraphapeixotoNessuna valutazione finora
- Istituzioni Di Diritto RomanoDocumento27 pagineIstituzioni Di Diritto RomanoGiacomo BondarelliNessuna valutazione finora
- Sulle Dodici TavoleDocumento25 pagineSulle Dodici TavoleGabriele BaiNessuna valutazione finora
- Storia delle repubbliche italiane dei secoli di mezzo, Tomo V (of 16)Da EverandStoria delle repubbliche italiane dei secoli di mezzo, Tomo V (of 16)Nessuna valutazione finora
- Riassuntini Medievale GIODocumento7 pagineRiassuntini Medievale GIOFrancesco AlbertiniNessuna valutazione finora
- Storia Medievale GrilloDocumento45 pagineStoria Medievale Grillog.bartoleNessuna valutazione finora
- StoriaDocumento4 pagineStoriaChiara29 EspositoNessuna valutazione finora
- Appunti: Leviatano T.HobbesDocumento28 pagineAppunti: Leviatano T.Hobbesfedro.schmidtzulianNessuna valutazione finora
- Il pensiero federalista nella storia del Sardismo: Enciclopedia del SardismoDa EverandIl pensiero federalista nella storia del Sardismo: Enciclopedia del SardismoNessuna valutazione finora
- 2 Alfabetico Paniere AperteDocumento17 pagine2 Alfabetico Paniere ApertedsgaNessuna valutazione finora
- Storia Del Diritto ItalianoDocumento111 pagineStoria Del Diritto ItalianoRoberta PasquarelliNessuna valutazione finora
- Read Online Textbook Economics 13Th Edition Roger A Arnold Ebook All Chapter PDFDocumento22 pagineRead Online Textbook Economics 13Th Edition Roger A Arnold Ebook All Chapter PDFmichael.french283100% (7)
- Dispensa Di Elementi Di Diritto Romano Pubblico e PrivatoDocumento67 pagineDispensa Di Elementi Di Diritto Romano Pubblico e Privatos.squitieriNessuna valutazione finora
- Publio Cornelio TacitoDocumento7 paginePublio Cornelio TacitoLuigi FiladoroNessuna valutazione finora
- Pater Familias e Famiglia RomanaDocumento5 paginePater Familias e Famiglia RomanaSara OlivieriNessuna valutazione finora
- Etã Tardo AnticaDocumento11 pagineEtã Tardo AnticaIrene MicheliNessuna valutazione finora
- Dal Decemvirato Legislativo Alla Censura Di Appio ClaudioDocumento35 pagineDal Decemvirato Legislativo Alla Censura Di Appio ClaudiogliintrovabiliNessuna valutazione finora
- BIROCCHI Alla Ricerca Dell'Ordine Fonti e Cultura Giuridica Riass Capp 1 3Documento47 pagineBIROCCHI Alla Ricerca Dell'Ordine Fonti e Cultura Giuridica Riass Capp 1 3Giovanni Di Gennaro100% (2)
- La Messa È FinitaDocumento2 pagineLa Messa È Finitagreenbuddy123Nessuna valutazione finora
- Museodiocesano GuidaDocumento94 pagineMuseodiocesano GuidaPierpaoloNessuna valutazione finora
- La Vera Storia Delle Sorelle Faioli e Dell'istruzione in AnticoliDocumento156 pagineLa Vera Storia Delle Sorelle Faioli e Dell'istruzione in AnticolisilvioincocciatiNessuna valutazione finora
- Analisi Eucologica Della Benedizione Dell'olio Degli InfermiDocumento9 pagineAnalisi Eucologica Della Benedizione Dell'olio Degli InfermiREBoquirenNessuna valutazione finora
- Principi Di Diritto Ecclesiastico - CardiaDocumento66 paginePrincipi Di Diritto Ecclesiastico - CardiaGabriele Farinelli33% (3)
- Quaderno 61Documento159 pagineQuaderno 61ramazottirbrNessuna valutazione finora
- Pastores GregisDocumento94 paginePastores GregisBeatrice SavoldelliNessuna valutazione finora
- Libretto Cresime e Prime Comunioni 2018Documento12 pagineLibretto Cresime e Prime Comunioni 2018Ismaele SalvagnoNessuna valutazione finora
- Moroni. Dizionario Di Erudizione Storico-Ecclesiastica Da S. Pietro Sino Ai Nostri Giorni. 1840. Volume 96.Documento344 pagineMoroni. Dizionario Di Erudizione Storico-Ecclesiastica Da S. Pietro Sino Ai Nostri Giorni. 1840. Volume 96.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisNessuna valutazione finora
- 2011 05 15Documento7 pagine2011 05 15Bradford BernardNessuna valutazione finora
- I Movimenti Ecclesiali, Speranza Per La Chiesa e Per Gli UominiDocumento13 pagineI Movimenti Ecclesiali, Speranza Per La Chiesa e Per Gli UominihaploynNessuna valutazione finora
- Corriere Cesenate 08-2017Documento24 pagineCorriere Cesenate 08-2017settimanale Corriere CesenateNessuna valutazione finora
- B - Sussidi Prima Evangelizzazione RagazziDocumento13 pagineB - Sussidi Prima Evangelizzazione Ragazziapi-421393782Nessuna valutazione finora
- Limmagine Sacra Nel Periodo Preiconoclasta PDFDocumento107 pagineLimmagine Sacra Nel Periodo Preiconoclasta PDFIvano D'aleoNessuna valutazione finora
- Moroni. Dizionario Di Erudizione Storico-Ecclesiastica Da S. Pietro Sino Ai Nostri Giorni. 1840. Volume 14.Documento326 pagineMoroni. Dizionario Di Erudizione Storico-Ecclesiastica Da S. Pietro Sino Ai Nostri Giorni. 1840. Volume 14.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisNessuna valutazione finora
- RosminiDocumento38 pagineRosminiGBNessuna valutazione finora
- Archeologia Medievale Secondo SemestreDocumento21 pagineArcheologia Medievale Secondo SemestreMartina CostanziNessuna valutazione finora
- Corriere Cesenate 04-2015Documento33 pagineCorriere Cesenate 04-2015settimanale Corriere CesenateNessuna valutazione finora
- Caravaggio MadonnaDocumento36 pagineCaravaggio Madonnagiordana214Nessuna valutazione finora
- Storie Di ZUAVIDocumento841 pagineStorie Di ZUAVISimone SimonacciNessuna valutazione finora
- Api Ingegnose N. 3Documento80 pagineApi Ingegnose N. 3Nicola SgueraNessuna valutazione finora