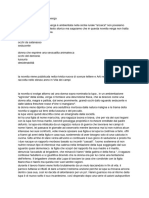Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
873 visualizzazioni7 pagineD'ANNUNZIO
Il documento parla di D'Annunzio e Pascoli come esponenti del decadentismo in Italia. D'Annunzio fu un uomo politico e figura di spicco nella società, mentre Pascoli fu solo uno scrittore. Il documento descrive le diverse fasi artistiche di D'Annunzio, tra cui l'estetismo, il simbolismo e la teoria del superuomo.
Caricato da
sofia muraCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
873 visualizzazioni7 pagineD'ANNUNZIO
Il documento parla di D'Annunzio e Pascoli come esponenti del decadentismo in Italia. D'Annunzio fu un uomo politico e figura di spicco nella società, mentre Pascoli fu solo uno scrittore. Il documento descrive le diverse fasi artistiche di D'Annunzio, tra cui l'estetismo, il simbolismo e la teoria del superuomo.
Caricato da
sofia muraCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd