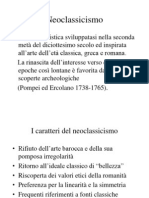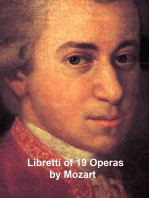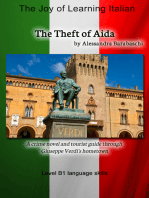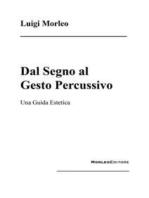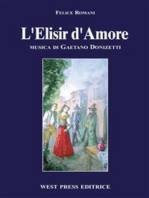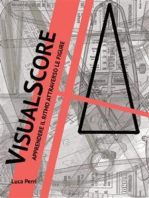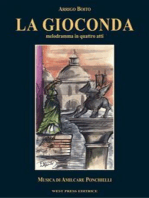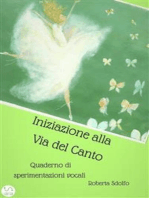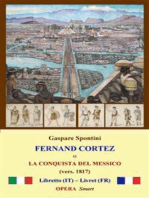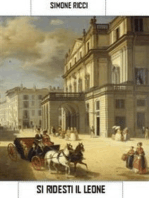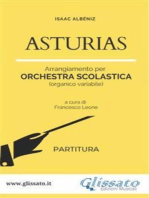Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Fussi - Fisiologia Dei Registri Della Voce Cantata
Caricato da
Roberta CeccottiCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Fussi - Fisiologia Dei Registri Della Voce Cantata
Caricato da
Roberta CeccottiCopyright:
Formati disponibili
Medart - medicina per gli artisti
Medicina per gli Artisti
home e-mail links news documenti canto danza strumenti indice
FISIOLOGIA DEI REGISTRI DELLA
VOCE CANTATA
di Franco Fussi
Ergonomia Le proprietà dei muscoli tensori delle corde vocali.
Quello che chiamiamo voce è un movimento di aria causato da specifiche
Medicina attività muscolari laringee. Per lo sviluppo di adeguate capacità tecniche
vocali, è importante come questi complessi sistemi interagiscono al fine di
rendere fisiologicamente equilibrato e funzionalmente corretto il lavoro
delle corde vocali e dei loro meccanismi tensori.
All'interno della laringe, il muscolo tiroaritenoideo, detto anche muscolo
vocale, determina con la sua contrazione un accorciamento - e
conseguente allargamento- delle corde vocali. Questo fa sì che le due
corde si comportino come fusi a sezione cilindrica realizzando, durante
l'adduzione sulla linea mediana, un ampio contatto tra i loro bordi liberi.
Quando la corrente aerea sottoglottica incontra corde vocali addotte è
dunque costretta ad affrontare una notevole resistenza glottica, dovuta
all'accollamento delle due corde, che avviene - grazie all'azione del
muscolo vocale - su un margine molto ampio, su una superficie verticale,
con il bordo libero cordale accorciato.
Di regola, pertanto, tutti gli atteggiamenti cordali e le azioni muscolari
laringee che riducono l'area della glottide (come fa il muscolo vocale)
determinano un aumento delle resistenze glottiche. La contrazione del
muscolo vocale coopera dunque all'addu-zione, accorcia la corda, la
ispessisce e ne provoca un aumento della massa. Di conseguenza, il
numero di volte in cui la corrente aerea espiratoria riuscirà ad aprire la
glottide nell'unità di tempo sarà minore, con il risultato di produrre toni
gravi, corrispondenti a basse frequenze vibratorie.
L'azione del muscolo cricotiroideo ha invece la funzione di allungare le
corde vocali, consentendo così l'emissione di suoni a frequenze vibratorie
elevate; tale allungamento viene realizzato attraverso il basculamento in
avanti ed in basso della cartilagine tiroidea su quella cricoidea, che
determina appunto l'allungamento e stiramento delle corde vocali.
Quest'azione condiziona pertanto una riduzione della massa cordale con
incremento dell'elasticità dovuto alle forze elastiche da stiramento;
inoltre si assiste all'"appiattimento" della corda vocale con
assottigliamento del margine libero. L'azione del muscolo cricotiroideo
determina quindi, nel momento dell'adduzione, un contatto cordale che è
http://www.medart.pillole.com/can-registri.cfm (1 of 18)31/08/2006 15.36.34
Medart - medicina per gli artisti
esclusivamente laminare, lineare.
In tutti i casi in cui la fonazione prevede un uti-lizzo primario di questo
muscolo avremo perciò un aumento dell'area di contatto dei bordi (nel
senso della lunghezza) con diminuzione della massa. Ne consegue un
contatto instabile con buon gioco delle forze aeree sottoglottiche e
relativa elevazione della frequenza del ciclo vibratorio, cioè toni acuti. Ma
il tempo di contatto dei bordi liberi delle corde, cioè la durata della fase
di accollamento durante un singolo ciclo vibratorio, è soggetto a varia-
zioni determinate proprio dai rapporti che, di volta in volta, intercorrono
tra i due muscoli tensori e le forze adduttorie, ed anche in relazione ai
valori della pressione sottoglottica. Le variazioni di tali rapporti
condizionano la qualità e le caratteristiche del suono risultante e sono
all'ori-gine di quei complessi fenomeni, comunemente definiti registri
vocali, che cercheremo di illustrare.
"Registro" come qualità timbrica dell'emissione cantata e come prevalenza
d'azione dei gruppi tensori.
Nelle voci incolte, la qualità vocale è raramente omogenea lungo tutta
l'estensione, mostrando timbri diversi e caratteristici nei vari settori
tonali. Quando, nel percorrere una scala dai toni gravi agli acuti, una voce
maschile passa dal cosiddetto registro "modale", o normale, usato
comunemente per le note gravi, al registro di "falsetto" (per intenderci
quella modalità d'emissione vocale usata dall'uomo per imitare la voce
femminile), si avverte un break vocale, come una rottura della voce che
separa bruscamente due qualità timbriche diverse, a riprova che nel
passaggio dai suoni gravi agli acuti si realizzano cambiamenti
anatomofunzionali laringei.
Tali cambiamenti lungo l'estensione vocale vengono gestiti dal cantante in
maniera graduale. Ogni registro copre un determinato ambito di frequenze
di fonazione ma, negli ambiti cosiddetti di passaggio, il cantante può
produrre alcuni suoni della gamma con l'uno o l'altro tipo di emissione,
cioè di azione muscolare laringea, secondo modalità che mettono in
rapporto la tensione stessa dei muscoli laringei intrinseci ed estrinseci a
differenti gradi di pressione sottoglottica e a differenti atteggiamenti
delle cavità di risonanza.
Nel descrivere la qualità timbrica di un'emissione vocale, sia i melomani
che i cantanti ed i maestri di canto, utilizzano frequente-mente termini
quali "voce di petto", "di testa", "registro pieno", "falsetto", "falsettone" e
ancora "suono coperto", "flautato", "affondato", "girato" attribuendo talora
a questi il valore di registri. Tale terminologia, anche nei trattati storici di
tecnica vocale, viene inoltre utilizzata con accezioni tutt'altro che
univoche, assegnando talora alle definizioni significati diversi nel corso dei
secoli in rapporto allo sviluppo storico e tecnico della vocalità.
Garcia affermava che i registri sono una serie consecutiva di suoni
http://www.medart.pillole.com/can-registri.cfm (2 of 18)31/08/2006 15.36.34
Medart - medicina per gli artisti
omogenei e contigui prodotti da un determinato meccanismo d'azione
laringea, differenti da un'altra serie di suoni ugualmente omogenei
prodotti da un altro meccanismo. Potremmo perciò definire come registro
una specifica qualità vocale, una caratteristica timbrica di un gruppo
contiguo di suoni, individuabile percettivamente ed elettroacusticamente;
vedremo in realtà essere, quanto descritto da Garcia, l'effetto acustico, il
risultato sonoro delle dinamiche d'utilizzo dei registri fisiologicamente
intesi.
Tale qualità vocale è di fatto prodotta da una determinata funzionalità
delle corde vocali, che viene a caratterizzarsi nella prevalenza di azione di
un sistema muscolare sul suo naturale antagonista; in altre parole, è il
rapporto di tensione esercitata tra il gruppo che chiameremo dei
cricotiroidei e quello degli aritenoidei.
Il gruppo che è definito in senso lato degli aritenoidei (e che comprende il
tiroaritenoideo o muscolo vocale, i muscoli adduttori cricoaritenoidei
laterali e gli interaritenoidei) e il gruppo dei cricotiroidei, agiscono
contemporaneamente e in antagonismo come determinatori dello stato
tensionale e della forza di contatto delle corde sulla linea mediana, perciò
anche della loro conformazione dimensionale; la prevalenza d'azione di
uno dei due gruppi differenzia i registri, tanto che si può affermare che i
veri registri laringei primari sono solo due in base alla prevalenza d'azione
di un gruppo muscolare sull'altro, e sono caratterizzati dalla durata del
contatto glottico durante il ciclo vibratorio.
La quantità stessa di varianti timbriche che può emergere come
conseguenza della combinazione dei due registri primari tra loro, nei vari
settori tonali e in vari gradi di intensità possibili, e le varie conformazioni
del tubo di risonanza, ha portato alla proliferazione di termini che possono
descrivere, ma non definire, un registro.
Considerato che tra i fini della didattica del canto vi è anche quello di
rendere il colore vocale il più possibile uniforme su tutto l'ambito tonale,
alcune impostazioni pedagogiche parlano di un unico registro evitando, di
con-seguenza, di contemplare didatticamente le modalità di "passaggio".
Tali concezioni, centrando l'attenzione su un'immagine percettiva
esclusiva-mente legata all'omogeneità timbrica, ignorano volutamente
l'esistenza dei registri fisiologici per evitare di creare confusione o
complicazioni alla "libertà" d'emissione negli allievi. All'estremo teorico
opposto c'è chi tratta pedagogicamente la voce a piccoli comparti tonali
giungendo a frammentare l'estensione anche in sei, sette registri, che
vengono considerati separatamente in fase di impostazione tecnica e
vengono poi successivamente collegati curando singolarmente i vari
passaggi.
Com'è possibile notare, a dispetto di concezioni totalmente antitetiche,
l'obiettivo comune è quello di rendere uniforme il timbro dell'emissione
vocale che è controllata in parte dal flusso aereo ed in parte dagli
http://www.medart.pillole.com/can-registri.cfm (3 of 18)31/08/2006 15.36.34
Medart - medicina per gli artisti
adattamenti delle corde vocali la cui massa e grado di tensione sono
correlati all'attività della muscolatura laringea. Questi due fattori
esercitano il controllo sulla nota emessa (cioè sulla frequenza
fondamentale), sul volume (o intensità di fonazione) e, come preciseremo
in seguito, su alcune caratteristiche timbriche che dipendono
dall'andamento del ciclo vibratorio cordale.
Frequenza fondamentale e registri primari.
Il suono generato dalla vibrazione cordale (che nel passaggio attraverso le
cavità di risonanza subisce fondamentali modificazioni nelle dina-miche
timbriche e di intensità) possiede determinate caratteristiche spettrali
acustiche che dipendono dal modo in cui si realizza il ciclo vibratorio (ed
in particolare dalla durata delle fasi di apertura e di chiusura della
glottide) e che corrispondono ai cosiddetti registri primari che sono
conosciuti come "registro pieno" e "registro di falsetto" (identificabili
rispettivamente nell' "heavy" e nel "light mechanism" della letteratura
anglosassone).
Sappiamo che la frequenza fondamentale della voce corrisponde alla
frequenza di vibrazione delle corde vocali ed è espressa in cicli di
ondulazione per secondo.
Tale frequenza vibratoria è poi direttamente controllata dallo stato di
tensione e dalla lunghezza delle corde vocali: ad elevati gradi di
allungamento e stiramento corrisponde un cospicuo numero di vibrazioni
per secondo (con emissione di toni acuti) e viceversa. L'emissione della
nota più grave del basso (Do l) comporta solo 65 vibrazioni al secondo
(Hertz) mentre il Sol sopracuto del soprano di coloratura (Sol 5)
corrisponde ad una frequenza di 1567 Hertz.
E' facilmente intuibile il motivo per cui, a parità di tecnica vocale,
risultino più esposti alla possibilità di traumatismo (con potenziale
formazione di noduli cordali) i cantanti a tessitura acuta i quali possono
sottoporre le proprie corde vocali ad un numero molto elevato di urti
nell'unità di tempo.
La fondamentale, la nota emessa, l'altezza del suono è certamente un
fattore importante per la scelta del registro, ma la reale distinzione tra i
registri è nella qualità del suono emesso, che è il risultato di differenti
atteggiamenti laringei nella produzione del suono.
Le funzioni dei due sistemi tensori.
La conformazione fisica e le dimensioni delle corde vocali sono
determinate dai loro meccanismi tensori: in questi adattamenti il gruppo
degli aritenoidei, secondo la nota da cantare e il volume da ottenere, si
oppone alla contrazione dei muscoli cricotiroidei e, quando il livello di
intensità cresce e/o la frequenza cala, è attivo in maggior misura.
La funzione del sistema aritenoideo può essere esplorata isolatamente
http://www.medart.pillole.com/can-registri.cfm (4 of 18)31/08/2006 15.36.34
Medart - medicina per gli artisti
verificando le limitazioni del falsetto puro. Ciò può compiersi chiedendo di
eseguire in falsetto una gamma tonale discendente fin verso le note più
gravi, dove la voce sarà scarsamente udibile; poi proseguendo con bocca
aperta su una /a/ a più alta intensità: sarà improvvisamente coinvolto il
gruppo aritenoideo e poiché i cricotiroidei, scendendo la gamma tonale,
saranno divenuti virtualmente sempre più inattivi, gli aritenoidei
funzioneranno come entità isolata.
Quando i due gruppi muscolari sono utilizzati con queste limitazioni
d'altezza e intensità essi estrinsecano chiaramente l'esistenza dei due
registri laringei primari, con bruschi passaggi dall'uno all'altro come nei
cantanti non allenati o in certi generi vocali (lo jodel ad esempio).
La funzione dei cricotiroidei è di controllare le corde vocali nella gestione
dell'altezza tonale; questo ruolo unidimensionale spiega le capacità
limitate della sua controparte tonale, il falsetto, ad aumentare in volume
man mano che si scende in toni più gravi. Per compensare l'incapacità dei
cricotiroidei a gestire dinamiche d'intensità e rendere più "piena" la
qualità del tono emesso dentro il range tonale del falsetto puro, la
tensione degli aritenoidei deve crescere determinando un aumento del
tempo di contatto delle corde vocali e rendendo così in grado il
meccanismo di accettare maggiori pressioni sottoglottiche mantenendo
contemporaneamente l'intonazione. Infatti, se si aumenta l'intensità
d'emissione di un suono, cioè se aumenta la pressione sottoglottica,
l'attività del solo cricotiroideo non riesce a controllare quell'incremento ed
evitare una contemporanea elevazione della frequenza fondamentale a
meno che non intervenga un contributo di riequilibrio tensionale delle
corde da parte dei suoi oppositori che permetta di mantenere
l'intonazione voluta, come accade quando si eleva improvvisamente il
volume nel parlato.
E' il sistema aritenoideo che deve compensare l'inabilità dei cricotiroidei a
resistere all'incremento di pressione che accompagna ogni aumento di
intensità, mantenendo le corde vocali in posizione adduttoria.
Alla luce di tale interdipendenza le procedure adottate per rafforzare e
rendere più sonoro il falsetto, come anche per rafforzare l'intensità delle
note più gravi del settore che viene definito di testa (corrispondente più o
meno alle ultime note centrali, a cavallo tra prima e seconda ottava
dell'estensione), devono indurre una maggiore attivazione degli
aritenoidei.
Se dunque lunghezza, massa e tensione delle corde devono essere
compatibili con la frequenza fondamentale emessa, rispondendo alle leggi
fisiche di tutte le membrane vibranti, sono i loro meccanismi tensori a
determinare la natura della conformazione fisica delle corde stesse e le
caratteristiche primarie di vibrazione e perciò di spettro acustico
risultante. L'aspetto più cruciale della fonazione nel determinare i registri,
quindi la qualità dei suoni, è il grado di tonicità e relazione coordinata tra
http://www.medart.pillole.com/can-registri.cfm (5 of 18)31/08/2006 15.36.34
Medart - medicina per gli artisti
questi meccanismi tensori.
L'origine di molti problemi vocali può essere ricondotta a inadeguatezze
nel rapporto tensorio dei muscoli intrinseci laringei.
Riassumendo, la partecipazione del sistema muscolare aritenoideo regola
ogni aspetto di funzione che vada oltre i limiti dell'attività cricotiroidea,
ed è responsabile nell'evitare le costrizioni di gola, costruire il volume e
rinforzare il falsetto stesso legittimandone la qualità vocale in senso
artistico all'interno del range tonale in cui è normalmente esercitabile.
Le sue funzioni sono quelle di: mantenere l'adduzione delle corde vocali
sul piano glottico (e dall'entità di questa funzione dipendono tempi di
contatto cordale diversi, e perciò spettri e "registri" - o qualità timbriche -
diversi), opporsi come antagonisti alla azione dei cricotiroidei quando la
frequenza fondamentale si eleva verso l'acuto, tanto più quanto il registro
viene mantenuto "pieno", regolare l'intensità dei toni centrali ispessendo la
superficie vibrante delle corde vocali (permettendo cioè un aumento del
tempo di contatto dando così luogo a una emissione più "piena")
coadiuvare la tensione nei sovracuti, quando i cricotiroidei raggiungono il
limite della loro contrazione regolare le variazioni d'intensità in rapporto
alla variazione di pressione sottoglottica, controllando anche l'intonazione
determinare una qualità timbrica che in prevalente assenza dell'attività
cricotiroidea viene percepita come "voce di petto", tanto che
probabilmente anche le tecniche di "affondo" si basano proprio su questa
netta prevalenza di azione, accompagnata da notevole guadagno
morfovolumetrico nelle cavità di risonanza per estremizzazione
dell'abbassamento laringeo.
La "voce piena"
Quando la fase di contatto tra le corde è un po' più lunga di quella di
apertura si assiste alla formazione di un buon numero di armoniche che
determinano una voce timbricamente ricca, di buona intensità, che viene
definita "voce piena".
Nel descrivere i suoni emessi da un cantante lirico diciamo infatti che la
sua voce è "piena" ed usiamo generalmente il termine voce "di petto" per
riferirci all'emissione dei toni gravi, caratterizzati da un basso numero di
vibrazioni al secondo; tale usanza è legata alla fun-zione contrattile del
muscolo vocale (e del sistema degli aritenoidei in generale) che,
accorciando la corda, ne incrementa la massa favorendo l'insorgenza di
vibrazioni scheletriche dirette verso la cassa toracica.
Parlare quindi di voce di petto significa fare riferimento a quel fenomeno
percettivo di pienezza del suono che provoca, nel cantante, sensazioni di
consonanza vibratoria soggettiva a livello muscolare e scheletrico proprio
nella regione toracica. In relazione a tale fenomeno di "falsa vibrazione"
risulta evidente come sia preferibile l'espressione "registro pieno con
http://www.medart.pillole.com/can-registri.cfm (6 of 18)31/08/2006 15.36.34
Medart - medicina per gli artisti
consonanza di petto", che caratterizza le regioni tonali grave e media
delle voci maschili e quella grave delle voci femminili di mezzosoprano e
di contralto.
Nel corso di un'emissione su toni ascendenti a intervalli di grado
congiunto, entra gradualmente in attività il muscolo cricotiroideo che,
situato all'esterno dello scheletro cartilagineo, allunga la corda.
Grazie al mantenimento dell'attività tensoria del muscolo vocale, viene
evitato il sollevamento della laringe e la conseguente riduzione dello
spazio di risonanza: in tal modo viene permesso alla corda di vibrare in
tutta la sua ampiezza ed il suono mantiene le sue qualità acustiche di
pienezza. Le sensazioni vibratorie soggettive, essendo la corda ora
assottigliata, si dirigono verso la scatola cranica.
Si comprende così come gli "acuti" possano essere definiti come suoni
emessi in registro "pieno con consonanza di testa" e come siano invece da
sfatare alcune scelte terminologiche improprie che, ad esempio, portano a
definire "di petto" il Do acuto dei tenori che è invece una nota emessa a
voce piena ma con sensazioni vibratorie "di testa".
Appurato quindi come i termini "di petto" e "di testa" non siano i veri
registri e si riferiscano esclusivamente all'apprezzamento soggettivo da
parte dei cantanti di risposte vibratorie di alcune parti del corpo alle onde
sonore prodotte dalla laringe, cerchiamo ora di comprendere come i veri
fenomeni di risonanza si verifichino in quelle cavità naturali (orofaringea e
nasale) nelle quali il suono si propaga e che sono pertanto i veri
"risuonatori".
La "copertura"
Analizzando l'evoluzione storica della pedagogia del canto, possiamo
notare come l'abitudine a gestire il settore tonale acuto con atteggiamenti
in registro pieno si sia consolidata intorno ai primi decenni dell'Ottocento,
con la ricerca dei cosiddetti meccanismi di "copertura" del suono, dettata
da esigenze sia d'ordine stilistico ed estetico sia legate a motivi di natura
psicoacustica ambientale: gli spazi e gli organici orchestrali tendevano,
infatti, ad ampliarsi, comportando per l'emissione vocale problemi
d'udibilità e di proiezione del suono. Si rendeva quindi necessario
individuare una modalità di canto che potesse comunque emergere
superando i notevoli livelli d'intensità orchestrale che ponevano sempre
più problemi all'udibilità della nota fondamentale cantata dall'artista, in
quanto stavano diventando sempre più intensi e acusticamente competitivi
con le "note" da cantare.
Si giunse così a quelle "esagerazioni nervose e muscolari" che avrebbero
caratterizzato la vocalità romantica e l'evoluzione stilistica del
melodramma, dirigendo il gusto estetico verso l'efficacia drammatica e la
"portanza" vocale, e allontanandolo gradualmente dai concetti di bellezza
ed omogeneità di colore su tutta la gamma tonale.
http://www.medart.pillole.com/can-registri.cfm (7 of 18)31/08/2006 15.36.34
Medart - medicina per gli artisti
Parallelamente, in nome di esigenze più legate ad evoluzioni estetiche che
tecniche, venne meno il ricorso a quei "prodigi" vocali che avevano
caratterizzato la prassi esecutiva belcantistica. Il termine "copertura",
comparso nella didattica per spiegare il fenomeno dell'omogeneizzazione
timbrica nel passaggio dal settore medio-grave a quello acuto dell'ambito
tonale, è identificabile in una serie di fenomeni di adattamento delle
cavità di risonanza nel momento del passaggio di registro che si
concretizzano in un'abbassamento di laringe e mandibola, appiattimento
della base linguale, allargamento del cavo oro-faringeo ed elevazione del
velo palatino.
E' dunque cosiderabile come un registro secondario, differenziando il
colore vocale, ad esempio, dai suoni aperti, ipercinetici o con diffusione
armonica.
Coprire i suoni permette di mantenere una certa uniformità di colore nel
registro pieno durante ed oltre il passaggio agli acuti, consentendo una
buona udibilità per la concentrazione dell'energia acustica nella zona di
armoniche tra i 2500 ed i 3000 Hz, che viene definita "formante del
cantante".
A questo fenomeno si associano, più o meno impropriamente, modi di dire
quali "girare la voce" o "immascherare il suono". Influenza delle cavità di
risonanza e degli organi articolatori sui gruppi tensori Le cavità di
risonanza esercitano la loro influenza sulla configurazione delle corde
vocali sia sul piano della ricerca del colore (chiaro, scuro, aperto, coperto)
che sul piano strettamente articolatorio fonetico.
Per quanto riguarda il colore è essenziale ricondursi a due fenomeni
acustico-percettivi: quello appena descritto della "copertura", che nel
ricercare il controllo di un ampio spazio ipofaringeo (come inducono i
suggerimenti pedagogici dello "sbadiglio" e dell' "affondo") realizza una
intensificazione formantica sui 2500-3000 Hz (la citata "formante del
cantante") dando rotondità e proiezione alla percezione del suono
(abbinata a prevalenza di controllo del gruppo degli aritenoidei), più
necessaria alle voci maschili o femminili gravi, e il fenomeno di
intensificazione della nota fondamentale che si verifica nelle voci
femminili sugli acuti, con netto guadagno di intensità vocale, per
sovrapposizione o sintonizzazione della prima formante sulla frequenza
fondamentale.
Ne deriva la sensazione di un suono più brillante. Esso viene realizzato
aumentando sugli acuti l'apertura della bocca.
Per questo motivo, a livello percettivo, quello che noi ascoltiamo
maggiormente nelle emissioni maschili è soprattutto l'intensità della
formante di canto, mentre nelle voci femminili non gravi la frequenza
fondamentale potenziata dalla sovrapposizione della prima formante;
inoltre, durante la vibrazione, il contorno fisico delle corde vocali è
fortemente influenzato dai fonemi vocalici, cioè dalla vocale che si sta
http://www.medart.pillole.com/can-registri.cfm (8 of 18)31/08/2006 15.36.34
Medart - medicina per gli artisti
cantando, a causa dell'azione pressoria retrograda sulle stesse determinata
dalla messa in rapporto degli organi di articolazione della parola. Insieme
all'altezza e intensità, anche le vocali influenzano il rapporto di tensione
tra cricotiroidei e tiroaritenoidei, come pure il carattere più aperto o
chiuso della vocale scelta.
I sistemi muscolari intrinseci laringei possono allora essere influenzati ad
un equilibrato utilizzo attraverso una scelta pedagogica di selezionate
combinazioni di altezze, intensità e tipo di vocale, che costituiscono il
bagaglio didattico della scuola di canto e che giustificano le preferenze
dei maestri di canto verso questa o quella vocale per produrre una
corretta emissione o correggere eventuali suoi sbilanciamenti.
L'influenza della muscolatura laringea estrinseca Se, al contrario di quanto
è stato appena descritto, si "sale" con la voce senza "coprire" il suono
modificando l'atteggiamento degli apparati di vibrazione e risonanza, si
ottiene uno spontaneo sollevamento della laringe con un conseguente
stato di contrazione muscolare avvertibile come un senso di costrizione e
di fatica fonatoria (si può dire che la voce diviene "spinta", "pressata") che
conduce ad un punto in cui è impossibile risolvere l'equilibrio delle forze
muscolari coinvolte senza incorrere in una "rottura" del suono. Poiché i
cambiamenti di altezza tonale riflettono cambiamenti di rapporto tra le
cartilagini cricoide e tiroide, possiamo affermare che i muscoli del collo
che agiscono sulle posizioni della laringe possono cooperare con i
cricotiroidei nel creare una tensione longitudinale.
E' infatti istintivo per i muscoli tiroioidei innalzare la laringe verso l'osso
ioide al salire dell'altezza tonale. La cricoide è invece parzialmente
ancorata all'esofago e alla trachea. Ne deriva allungamento delle corde.
Questa modalità dimostra in realtà una incapacità tecnica sul controllo
dell'altezza tramite i muscoli intrinseci della laringe. Tale evento può
comunque essere anche una scelta stilistica, come nelle frasi più tese di
alcuni generi di musica leggera ad impianto prevalentemente melodico,
come il pop e il belting. Nella voce piena ma "spinta", il tempo di contatto
tra le corde vocali durante il ciclo vibratorio è notevolmente allungato
(oltre il 60% dell'intero ciclo) e, a livello spettrale, si assiste alla
formazione di numerose armoniche, fino oltre i 5000 Hz. (fenomeno della
dispersione armonica): il timbro vocale assume allora caratteristiche
stridenti e compresse (da cui il termine di emissione "spinta" o "forzata")
perdendo quelle caratteristiche di "rotondità" proprie della corretta
emissione lirica. In questo caso si parla di ipercinesia fonatoria.
Modalità ipercinetiche vengono spesso sfruttate come scelta stilistica nella
musica pop e rock (stile "graffiato"). E' curioso notare come, in genere, a
quel tipo di emissioni che si allontanano da modalità fisiologicamente
corrette non venga mai attribuito il termine di registro e come i cantanti
di musica leggera, parlando di registro "di testa", si riferiscano agli acuti
eseguiti a voce piena gridata, cioè con tempo di contatto cordale
http://www.medart.pillole.com/can-registri.cfm (9 of 18)31/08/2006 15.36.34
Medart - medicina per gli artisti
aumentato (non attuano infatti meccanismi di copertura) ed utilizzino tale
termine per distinguerli dalle emissioni in falsetto. Anche nel caso di
questi artisti, l'esercizio dei risuonatori con ricerca di potenzialità
timbriche molto personali, consente di limitare lo sforzo fonatorio;
l'emissione graffiata, pressata ed aspra, non è più allora "obbligata" per
incompetenza tecnica ma può divenire opzionale e legata a particolari
scelte estetiche. Un'alternativa alla copertura è rappresentata dal salire
agli acuti con un tipo di emissione più leggera (registro medio), come nella
canzone italiana, oppure in registro di falsetto, e molto dipende dalle
"mode" del momento.
Esistono inoltre, sia nel canto lirico che moderno, meccanismi di
compenso attraverso lo sfruttamento dei risuonatori superiori per evitare
gli atteggiamenti ipercinetici, con risultati non sempre accettabili sul
piano estetico, almeno nel canto classico, come nel caso della
nasalizzazione.
I tipi di "falsetto"
Come precedentemente accennato, una delle possibilità di emissione degli
acuti è quella di ricorrere al registro di "falsetto". La prevalenza del
sistema cricotiroideo fa sì che le corde vibrino solo sul loro bordo libero,
con un tempo di contatto che è inferiore al 40% dell'intero ciclo vibratorio.
Il timbro vocale risulta allora povero di armoniche, debole di intensità e
spesso correlato a sensazione percettiva di "fissità"; il termine falsetto è
quindi giustificato alla luce di un tentativo di definire un timbro vocale
"non vero".
Per quanto concerne una sua collocazione artistica, il registro di falsetto
viene utilizzato dai tenori primi di cori polifonici per eseguire brani con
tessitura molto elevata, dai cantanti di yodeling tirolese (con
atteggiamento vocale caratterizzato da continui e repentini passaggi tra
registro modale e falsetto), di country music o di repertori folkloristici in
genere, dai cosiddetti ventriloqui per ottenere effetti comici e
caricaturali, da alcuni tenori leggeri ad impostazione lirica per emettere
note acute in "pianissimo" che risultano di difficile esecuzione in registro
pieno e dai falsettisti nel repertorio rinascimentale e barocco.
Chi canta in falsetto in maniera incolta, con voce velata, mostra un
triangolo d'insufficienza glottica adduttoria posteriore, cioé ha i
cricoaritenoidei laterali attivi ma non gli interaritenoidei. Il falsetto è
velato e debole. Se il cantante attiva invece soprattutto gli
interaritenoidei chiude il triangolo e la sua voce risulterà più chiara e,
anche se il tempo di contatto è molto basso, l'area glottica si apre e
chiude completamente ad ogni ciclo.
Nel falsetto incolto, da un punto di vista laringostroboscopico, notiamo un
allungamento delle corde vocali per innalzamento laringeo con aumento
della tensione longitudinale delle corde vocali, diminuzione del tempo di
http://www.medart.pillole.com/can-registri.cfm (10 of 18)31/08/2006 15.36.34
Medart - medicina per gli artisti
contatto glottico e riduzione dell'onda mucosa al bordo libero, ed inoltre
conseguente riduzione dell'ampiezza e delle cavità di risonanza.
I cosiddetti "controtenori" o falsettisti artificiali utilizzano un falsetto
"rinforzato" ottenuto aggiungendo a tale meccanismo un abbassamento
della scatola laringea che consente, tramite un incremento dei fenomeni
armonici, l'e-missione di un suono più ricco e rotondo nel quale sono
tuttavia facilmente riconoscibili le caratteristiche del falsetto.
Le analisi spettrografiche, come ad esempio quelle condotte in alcuni
studi da Seidner, dimostrano come il cosiddetto falsetto professionale sia
caratterizzato da una gamma di diversi atteggiamenti tecnici possibili ed
in particolare che la tecnica dei comunemente chiamati controtenori
mostra rilievi spettrografici non tipici del falsetto puro ma una
sintonizzazione della prima formante alla frequenza fondamentale: in
considerazione di ciò Seidner ha proposto il termine di "male alto", cioè
"alto maschile", al posto di controtenore nella sua accezione di falsettista
artificiale.
La resa vocale del falsettista, su tutta la gamma tonale, è in qualche modo
diversa e per alcuni musicologi ritenuta insufficiente a confronto di quella
che doveva essere un tempo la vocalità del castrato: sia per volume, che
per estensione, che per pienezza di suono (cioè ricchezza armonica),
spessore nel registro grave, qualità d'emissione (suoni penetranti ma aspri
nel falsettista), lontana comunque dalla flessibilità, duttilità e ricchezza
di colori dei castrati. In effetti l'uso del falsetto professionale su tutta la
gamma impone al falsettista una certa uniformità di emissione (e perciò di
gestione del vocal tract) per realizzare la sintonizzazione Fo-F1 ed evitare
il pericolo di scivolamento al registro modale nei toni gravi e centrali.
Un terzo modello di utilizzo del falsetto è anche descritto come "stop-
closure falsetto" ed in esso gran parte della corda non vibra essendo in
stretto contatto/compressione con la controlaterale.
La compressione mediale e l'intensa attività interaritenoidea, con
abbassamento laringeo, rendono le corde talmente addotte che solo una
piccola porzione anteriore di esse entra in vibrazione, raggiungendosi
frequenze sovracute per effetto dell'accresciuta tensione longitudinale
concomitante: è il fenomeno del "damping" (descritto da Pressman) o "stop-
closure falsetto" (Mackenzie) della zona glottica posteriore.
Esso si accompagna a maggiore pressione sottoglottica e maggiore
ampiezza di coinvolgimento della porzione del corpo cordale vibrante,
dando luogo ad un suono quindi che ha caratteristiche più importanti in
volume e in struttura armonica rispetto al falsetto puro e che,
percettivamente e spettrograficamente, risulta analogo al registro medio
degli acuti dei soprani liricoleggeri.
A livello laringostroboscopico assistiamo ad un abbassamento laringeo al
salire della gamma tonale con guadagno di volume del vocal tract e una
singolare riduzione della porzione vibrante delle corde vocali alla metà
http://www.medart.pillole.com/can-registri.cfm (11 of 18)31/08/2006 15.36.34
Medart - medicina per gli artisti
anteriore circa, per iperpressione aritenoidea posteriore (da presumibile
iperattività degli interaritenoidei e dei cricoaritenoidei laterali), con buon
contatto glottico e maggiore ampiezza d'onda mucosa (atteggiamenti che
caratterizzerebbero non un registro di falsetto ma un registro modale
femminile).
C'è dunque, rispetto al falsetto puro una prevalenza del sistema
"aritenoideo". Tale modalità caratterizza le emissioni acute di alcuni
falsettisti e determina diversi risultati spettrografici, anche perché,
quando estremizzata e gestita con maggiori pressioni sottoglottiche o
maggiore controllo posizionale laringeo, configura un registro non più
riconoscibile come falsetto ma confondibile, anche spettrograficamente,
con quello che nel settore acuto della voce femminile di categoria leggera
o lirico-leggera definiremmo registro medio: ne sono esempi alcuni
sopranisti nel canto classico e le emissioni sovracute piene di alcuni generi
pop.
Sopranisti, contraltisti e castrati
Nelle emissioni acute dei sopranisti si rileva in maniera costante in tutti i
rilievi una persistente sintonizzazione tra frequenza fondamentale e prima
formante e l'inviluppo formantico non presenta ulteriori prominenze
rilevanti.
Non c'è intensificazione della formante di canto. Sembra che
l'abbassamento laringeo abbia allora lo scopo unicamente di cooperare alla
tensione cordale per il raggiungimento del tono acuto. Tuttavia le note
gravi mostrano un inviluppo formantico con due concentrazioni di energia
nettamente evidenti e distinte: la prima, di bassa frequenza, non più
sintonizzata sulla frequenza fondamentale e la seconda di alta frequenza
nella zona 2800-4000 Hz, "cluster" di 2 o 3 formanti superiori.
La tecnica di enfatizzazione della fondamentale tramite sintonizzazione
F1-Fo è utilizzata dal sopranista solo sugli acuti, mentre è abbandonata sui
gravi dove il "cluster formantico" di alta frequenza potrebbe fare
ipotizzare una sorta di enfatizzazione del tipo "formante del cantante".
Nell'emissione dei contraltisti, oltre alla sintonizzazione tra frequenza
fondamentale e prima formante, si nota una frequente amplificazione
delle armoniche nella zona tra 2800 e 3400 Hz (all'interno della quale si
colloca tradizionalmente la formante del cantante). Peraltro l'unica voce
femminile che la letteratura accredita dell'eventuale uso della formante
del cantante è proprio il contralto.
Sappiamo che approssimativamente nella banda 2000- 3000 Hz una buona
prominenza formantica riesce a prevalere sull'accompagnamento
orchestrale, rendendo più energica e limpida l'emissione cantata di bassi,
tenori e contralti. I cantanti più esperti ottengono tale effetto
aumentando il volume della faringe grazie ad un abbassamento della
laringe. In alternativa a tale meccanismo i soprani possono ottenere un
http://www.medart.pillole.com/can-registri.cfm (12 of 18)31/08/2006 15.36.34
Medart - medicina per gli artisti
effetto acustico equivalente abbassando la mandibola al salire della nota
(fino circa al la 880 Hz), con ciò aumentando via via l'apertura buccale;
anche le note più acute del contralto e quelle acute del tenore possono
essere eseguite con tale manovra. In questo caso vi è un potenziamento
della fondamentale su cui viene mantenuta accordata la prima formante:
si parla allora di sintonizzazione Fo-F1.
Il contraltista sembrerebbe perciò utilizzare entrambi i meccanismi di
enfatizzazione sfruttando così entrambe le tecniche di amplificazione
(come in effetti nel contralto). Riferiamo ora sull'analisi della voce di un
soggetto di 82 anni con castrazione spontanea nell'infanzia, un caso di
ermafroditismo, che può forse illuminare sulle potenzialità di emissione di
quelli che furono gli evirati cantori dell'epoca barocca.
Nella sua impostazione e nell'esercizio della sua vocalità l'ermafrodito
sembra unire, lungo la sua ampia estensione, modalità fonatorie che
vanno, dal grave all'acuto, dall'emissione caratteristica della voce parlata
all'uso del registro pieno con consonanza di petto in cui compaiono per le
prime note cluster formantici inizialmente a valori superiori a quelli
classicamente individuabili come formante del cantante e poi salendo la
gamma, più propri, ma sempre più deboli, per procedere infine alla
sintonizzazione F0-F1 nel settore acuto in registro pieno con consonanza di
testa.
Quella del castrato era forse allora l'unione di tre voci in una? E' forse per
questo che nell'unica registrazione a noi pervenuta di un castrato, il
Moreschi, oltre una più ampia gamma di colori e volumi rispetto al
controtenore odierno percepiamo un imbarazzante ma netto scivolamento
tra registri o modalità fonatorie diverse?
Come ha evidenziato Gisela Rohmert, nell'antico simbolismo numerico di
Pitagora l'ermafrodito è un 3: il 3 unisce dunque l'arte di fondere l'uno e
l'altro, e così pure le frequenze acute della voce sopranile ai toni gravi
dello speech maschile. Per i seguaci d'Orfeo l'ermafrodito era all'inizio
delle cose e poteva risolvere le dicotomìe.
Falsettone e registro medio
Il cosiddetto registro di "falsettone" (descritto come la modalità attraverso
la quale venivano emessi i toni acutissimi da parte dei tenori fino ai primi
decenni dell'Ottocento) potrebbe essere una terminologia di comodo,
mutuata da una cattiva traduzione dal tedesco "falsett -tone" (cioè tono di
falsetto), utilizzata per giustificare le differenze di portanza vocale nei
suoni emessi prima dell'avvento della copertura.
In realtà il fenomeno è meno leggendario e, sicuramente, accanto al
Duprez già da diverso tempo altri tenori eseguivano emissioni più piene
che differivano dalle precedenti non perché queste fossero in falsetto ma
perché erano soltanto più leggere e non estremizzate nell'affondo, cioè
eseguite in quello che oggi ascoltiamo dalle voci dei tenori leggeri, e che
http://www.medart.pillole.com/can-registri.cfm (13 of 18)31/08/2006 15.36.34
Medart - medicina per gli artisti
non potremmo definire falsettone ma al più registro medio.
E' infatti da considerare che, tra il registro pieno e quello di falsetto,
esistono numerose possibilità intermedie connotate da gradi di tensione
più modesti dei due muscoli tensori che caratterizzano l'emissione dei toni
medi ed acuti nella donna e quelli acuti dei tenori lirico-leggeri.
Questa modalità, definibile come registro "medio", fu probabilmente
utilizzata dalle voci maschili, unitamente al falsettone per i toni
acutissimi, in un'epoca precedente quella in cui Donzelli, Duprez e altri
iniziarono ad usare Do acuti estremamente "coperti" in registro pieno.
Il ricorso al registro medio è comunque da considerare indispensabile per
una corretta esecuzione delle mezze voci e dei "pianissimo". La vocalità
del cantante di musica leggera melodica non sfrutta sempre la voce piena
per salire agli acuti ma utilizza un atteggiamento laringeo simile, per il
tempo di contatto cordale, al registro medio, sebbene con posizioni
laringee più elevate di quelle utilizzate dal cantante lirico, con un
risultato sonoro dal timbro chiaro ed aperto.
Il "belting", lo stile utilizzato dai cantanti di Musical e tipico della
produzione teatrale di Broadway, si distingue per una modalità di
emissione maggiormente "piena" e gridata, caratterizzata da notevole
pressione sottoglottica ed elevazione laringea, con emissione ipercinetica,
che comporta frequenti situazioni fonasteniche e di precoce
deterioramento vocale.
L'influenza del fattore intensità
La gestione del flusso aereo, attuato attraverso le funzioni di "appoggio" e
di "sostegno" costo-diaframmatico, ha principalmente lo scopo di variare
l'intensità della voce che sarà infatti tanto più elevata quanto più ingenti
saranno i valori pressori nella regione sottoglottica.
Le variazioni di pressione sono tuttavia richieste anche per modificare la
frequenza fondamentale della nota emessa; per salire verso gli acuti è
infatti necessario ottenere un allungamento delle corde vocali che viene
raggiunto a prezzo di un incremento della pressione sottoglottica. Il
cantante deve perciò regolare e controllare il livello pressorio in relazione
sia all'intensità che alla frequenza che desidera ottenere.
A rendere maggiormente complessa l'operazione vi è il fatto che la
pressione sottoglottica influenza l'altezza tonale con un rapporto di
proporzionalità diretta; tale fenomeno è tuttavia da ritenersi passivo ed
inconsciamente regolato da un incremento d'attività del muscolo
cricotiroideo.
Peraltro, se le relazioni fossero semplicemente queste, dovremmo
attenderci uno sbalzo tonale ad ogni aumento del volume. Non
verificandosi questo fenomeno, dobbiamo ammettere l'esistenza di un
controllo indipendente che il cantante riesce ad attuare su entrambi i
parametri.
http://www.medart.pillole.com/can-registri.cfm (14 of 18)31/08/2006 15.36.34
Medart - medicina per gli artisti
Per questo motivo, lo scarso controllo dell'accoppiamento tra pressione
espiratoria e tensione cordale è spesso chiamato in causa nei difetti
d'intonazione. E' inoltre stato sperimentalmente rilevato che, ai fini
dell'intonazione e dell'emissione in genere, il controllo neuromotorio
dell'apparato pneumofonico deve "accordare" i livelli di pressione
sottoglottica al grado d'attività del muscolo cricotiroideo, non solo in
relazione ad altezza tonale e intensità ma anche alle condizioni istantanee
del volume respiratorio.
La pressione esercitata per aumentare il volume implica una modifica
nella gestione e nel rapporto dei sistemi muscolari laringei dando luogo a
differenti risultati acustici. La relazione tra registri e intensità è più
evidente quando l'attenzione viene focalizzata sui passaggi, ad esempio
verso la fine delle note centrali o verso le frequenze più gravi eseguibili in
falsetto.
Una delle maggiori evidenze di sbilanciamento nell'impostazione è che i
toni più gravi del falsetto (o della voce di testa) s'indeboliscono viaggiando
verso il dominio delle note che si canterebbero a voce piena o di petto.
Poiché invece i toni più alti del registro di petto, cioè i toni centrali verso
il passaggio, divengono più intensi man mano che si sale, dovrà essere
eseguito un qualche accomodamento se vogliamo che le due parti lavorino
insieme come unità armoniosa e omogenea. Le procedure necessarie a
riconciliare tali discrepanze dipendono largamente dalla regolazione in
intensità tra le due modalità di affronto di questa zona tonale: così il
livello d'intensità del registro di petto deve essere abbassato, una
procedura che unirà i due meccanismi e li fonderà in un'unità funzionale
(voce piena non gridata): ciò non solo combinerà i due registri ma
modificherà anche le loro qualità caratteristiche. Il grado di
"alleggerimento" del "meccanismo di petto" dipende probabilmente dal
repertorio e dalla tipologia vocale del cantante, oscillando tra una voce
più piena (alleggerimento minore) ed emissioni che più facilmente saranno
definite come registro medio (alleggerimento maggiore).
Nell'ambito tonale centrale l'intensità può dunque essere vista come
catalizzatore dominante rispetto alla frequenza, poiché un cambiamento
di livello d'intensità determinerà un brusco cambiamento da un
meccanismo di registrazione al suo opposto. Solo quando i registri sono
integrati e precisamente bilanciati, la voce è omogenea e l'influenza del
fattore intensità tende ad essere oscurata dall'abilità tecnica dell'artista.
E' per questo che le difficoltà incontrate quando si tenta di eseguire una
"messa di voce" possono solo essere attribuite a cambiamenti che
avvengono entro la muscolatura laringea in risposta alla intensità. Se l'atto
di diminuire o aumentare il volume di un singolo tono fosse il prodotto di
un unico meccanismo di registro la messa di voce non produrrebbe
problemi.
Ciò che ne rende difficile l'apprendimento è il fatto che deve essere
http://www.medart.pillole.com/can-registri.cfm (15 of 18)31/08/2006 15.36.34
Medart - medicina per gli artisti
compiuta una transizione dinamica nel rapporto di tensione esercitato tra
il gruppo dei cricotiroidei e quello degli aritenoidei per ottenere adeguati
cambiamenti nelle dimensioni fisiche delle corde vocali. Il break che
usualmente avviene nel passaggio da un piano a un forte (come nei filati)
avviene quando le dimensioni cordali cambiano da lunghe e sottili per
livelli medi o bassi di intensità a corte e spesse per i livelli più alti di
volume.
Deve perciò essere dinamicamente effettuata una modifica nel tipo di
contrazione muscolare a livello dei tensori: in particolare il sistema
aritenoideo, nell'aumento d'intensità, deve diventare più attivo.
L'intensità deve essere considerata un importante fattore nello sviluppo di
queste relazioni coordinate, tanto da essere inclusa, con altezza e
risuonatori, tra i fattori che provocano cambiamenti di qualità tonale nelle
dinamiche dal piano al forte, attribuibili anche in questo caso a
cambiamenti nel rapporto di tensione tra i due registri.
Il falsetto femminile
Per quanto riguarda le voci femminili, alcuni didatti negano l'esisten-za
dell'emissione in registro di falsetto; in effetti, almeno nel canto lirico, gli
acuti della voce femminile sono per lo più eseguiti in registro pieno o
medio.
Ci si chiede però perchè, da un punto di vista fisiologico, ciò che è
possibile ad una laringe maschile (la vibrazione del solo bordo libero della
corda) non possa esserlo anche per la voce femminile. In realtà esiste
anche per la donna tale possibilità ma, almeno nel canto lirico, il registro
ottenuto con tale modalità (per emettere note acute e sovracute) viene
denomi-nato "di flauto", in riferimento al particolare timbro vellutato che
lo caratterizza. I rilievi spettrografici sono peraltro del tutto analoghi a
quelli del registro di falsetto maschile mostrando una evidentissima
intensificazione dell'intensità della fondamentale per sintonizzazione tra
prima formante e frequenza fondamentale, con formanti superiori
pressochè inconsistenti.
Il registro di flauto viene usato da alcuni soprani leggeri nelle note
sovracute. Inoltre, nella condizione di massima chiusura, vicina allo
spasmo glottico, la voce si riduce ad un fischio emesso attraverso un
piccolo orifizio a livello di commissura anteriore, quasi in assenza di
vibrazione dei bordi: "registro di fischio". Pensando alle voci femminili
possiamo inoltre dire che l'aggiungersi o meno dell'attività interaritenoidea
al lavoro dei cricoaritenoidei laterali può fare la differenza anche tra il
falsetto comune femminile (usato peraltro solo nella musica leggera o
nella polifonia) e il registro di fischio del soprano leggero.
Modalità di affronto del settore tonale acuto I risultati percettivi e la
gestione del settore tonale acuto nei vari tipi di vocalità in relazione ai
registri possono essere così riassunti: Registro di falsetto nell'uomo e nella
http://www.medart.pillole.com/can-registri.cfm (16 of 18)31/08/2006 15.36.34
Medart - medicina per gli artisti
donna.
Viene usato nella musica leggera con elevazione laringea, tempo di
contatto ridotto, onda mucosa limitata al bordo, armoniche deboli fino a
2000 Hz. Nell'uomo può anche avere carattere incolto o imitativo o
caricaturale.
Può avere carattere di maggiore rotondità per rinforzo armonico legato al
controllo della posizione laringea nel collo.
Il contatto glottico è migliore se vi è attività adduttoria
dell'interaritenoideo.
Registro di fischio nella donna.
Prodotto con meccanismo di strumento ad ancia, con contatto glottico
pressocchè assente, così pure l'onda mucosa; vi è intensa attività
adduttoria intra ed extra-laringea Registro medio nel settore sovracuto del
soprano lirico-leggero e registro medio nel settore acuto del sopranista.
E' caratterizzato da intensa attività adduttoria dell'interaritenoideo e
cricoaritenoideo laterale, con aumento della tensione longitudinale e
abbassamento laringeo (almeno nell'uomo). Nei sovracuti inoltre le
deficienze inerenti l'attività dei cricotiroidei devono essere compensate
con un aumento della tensione del gruppo aritenoideo, perché la loro
capacità di allungare le corde vocali attraverso la loro contrazione
raggiunge un limite fisiologico; di conseguenza nei sovracuti le aritenoidi
divengono il meccanismo regolatore dominante la regolazione dell'altezza
e dell'intensità, rendendo più alta l'impedenza glottica al flusso aereo
riducendo la porzione vibrante delle corde o alimentando la risposta in
termini di pressione sottoglottica.
Questo sarà importante per discriminare diverse modalità di emissioni
comunemente dette in falsetto di molti sopranisti: infatti sono state
dimostrate differenti modalità fisiologiche di affronto dei sovracuti da
parte di voci maschili in registro leggero che sono descrittivamente e
percettivamente diverse tra loro: esse dipendono molto dalla attivazione
aritenoidea e dal suo grado potendosi distinguere un falsetto puro con
certe caratteristiche di funzionamento fisiologico, da un falsettone, e da
un registro medio del tutto analogo ai soprani leggeri percettivamente e
spettrograficamente ma eseguito da parte di corde maschili con
estremizzazione del ruolo svolto dal gruppo degli aritenoidei nella
produzione di sovracuti dotati di buona intensità.
La focalizzazione del suono in maschera è inoltre facilitata, specie nei
sovracuti femminili, da modifiche di risonanza (che fanno parte dei
cosiddetti registri secondari) conosciute dai maestri di canto come
"tecniche a sorriso" che, accorciando la lunghezza della cavità di
risonanza, ottengono uno spostamento formantico verso l'acuto, da cui
maggiore brillantezza nel timbro. Registro medio e registro pieno in
consonanza di testa per gli acuti del castrato , nell'ambito di una
http://www.medart.pillole.com/can-registri.cfm (17 of 18)31/08/2006 15.36.34
Medart - medicina per gli artisti
estensione talmente ampia che, investendo nei toni gravi registri dello
speech e del parlato maschile, ha fatto parlare di doppio registro.
Registro pieno con consonanza di testa nel canto lirico. Trascinamento in
acuto del registro pieno in consonanza di petto in vocalità quali il Belting,
il Blues e il Rock. La cosiddetta voce piena gridata è in realtà lo
sconfinamento in ipercinesia del registro pieno in consonanza di petto dal
passaggio di registro agli acuti, ed è caratterizzata da aumento del tempo
di contatto glottico, elevazione laringea e aumento di pressione
sottoglottica, caratterizzando la vocalità "belting" e in parte quella "rock".
Vogliamo ricordare infine come la "nuova" vocalità, sia nella musica "colta"
che in quella popolare, sfrutti oggi sempre più spesso una miscellanea
delle varie possibilità che l'organo vocale può esprimere, senza più confini
nell'uso dei registri in relazione ad un codice formalizzato di appartenenza
ad uno "stile" vocale tecnicamente uniforme.
Ne sono esempio, ognuno con sue caratteristiche, Cathy Berberian, Nina
Webmaster Hagen, Demetrio Stratos, Sainko Namcilak, Diamanda Galas, per citare
Daniele Franchini
solo alcuni interpreti.
http://www.medart.pillole.com/can-registri.cfm (18 of 18)31/08/2006 15.36.34
Potrebbero piacerti anche
- Dal canto al parlato: La didattica del canto nella terapia di un caso di Disartria AtassicaDa EverandDal canto al parlato: La didattica del canto nella terapia di un caso di Disartria AtassicaNessuna valutazione finora
- 00 La Voce - Corso LightDocumento22 pagine00 La Voce - Corso LightImt VocalProjectNessuna valutazione finora
- Mi sento meglio: Esperienze di applicazione di musica elettronica in musicoterapia per l'educazione dell'orecchio con Ic, dsa, sindrome di Down e autismoDa EverandMi sento meglio: Esperienze di applicazione di musica elettronica in musicoterapia per l'educazione dell'orecchio con Ic, dsa, sindrome di Down e autismoNessuna valutazione finora
- ESTRATTO DAL Work Shop LA VOCE CHE FAI - FEDERICA BACCAGLINIDocumento20 pagineESTRATTO DAL Work Shop LA VOCE CHE FAI - FEDERICA BACCAGLINIFederica BaccagliniNessuna valutazione finora
- Ginnastica respiratoria - Purificazione - Salute - Forza - Energia mediante l'esercizio fisico e psichico della respirazioneDa EverandGinnastica respiratoria - Purificazione - Salute - Forza - Energia mediante l'esercizio fisico e psichico della respirazioneValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (1)
- Tecnica Vocale e AnatomiaDocumento11 pagineTecnica Vocale e AnatomiaGiorgia MoranaNessuna valutazione finora
- Strumenti Musicali - VoceDocumento42 pagineStrumenti Musicali - VoceAngelo Conto100% (2)
- Vademecum del Musicista Terza Edizione: Guida per chi pratica e/o ascolta musicaDa EverandVademecum del Musicista Terza Edizione: Guida per chi pratica e/o ascolta musicaNessuna valutazione finora
- Cenni Di Fisiologia Vocale (p.29)Documento29 pagineCenni Di Fisiologia Vocale (p.29)rossanaruelloNessuna valutazione finora
- Canto e postura, principi posturali ed osteopatici al servizio del cantanteDa EverandCanto e postura, principi posturali ed osteopatici al servizio del cantanteValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (2)
- Fussi Fisiologia RegistriDocumento13 pagineFussi Fisiologia Registrimel martiganNessuna valutazione finora
- La Voce - L'Apparato Respiratorio e FonatorioDocumento1 paginaLa Voce - L'Apparato Respiratorio e FonatorioEdoardo PresicceNessuna valutazione finora
- Il sentimento del suono: L’espressività musicale nell’estetica analiticaDa EverandIl sentimento del suono: L’espressività musicale nell’estetica analiticaNessuna valutazione finora
- Riassunto Tecnica VocaleDocumento5 pagineRiassunto Tecnica VocaleFrancesca GiorgiNessuna valutazione finora
- PRODUZIONE VOCE Da SSIS Ult CorrettoDocumento17 paginePRODUZIONE VOCE Da SSIS Ult CorrettoCesareMarinacciNessuna valutazione finora
- La voce di Mignon. Viaggi nel canto tra Goethe e SchubertDa EverandLa voce di Mignon. Viaggi nel canto tra Goethe e SchubertNessuna valutazione finora
- Officina Voce Magnani PDFDocumento41 pagineOfficina Voce Magnani PDFPatrizia LietiNessuna valutazione finora
- Corde VocaliDocumento3 pagineCorde VocaliNatalia Di TommasoNessuna valutazione finora
- Esercizi Logopedia LabbraDocumento3 pagineEsercizi Logopedia LabbraMarina LuciaNessuna valutazione finora
- Il Metodo TomatisDocumento9 pagineIl Metodo TomatisGiovanna SeverinoNessuna valutazione finora
- Elena Vivaldi-Il CantoDocumento25 pagineElena Vivaldi-Il Cantomel martiganNessuna valutazione finora
- Valenza Formativa Del Canto CoraleDocumento16 pagineValenza Formativa Del Canto CoraleCecilia004Nessuna valutazione finora
- Tre Eta SitoDocumento44 pagineTre Eta SitoPatrizia LietiNessuna valutazione finora
- Effetti Somatici Dei Suoni Sistema 1Documento6 pagineEffetti Somatici Dei Suoni Sistema 1Manuel RodriguezNessuna valutazione finora
- Ebook - Alessandra CartocciDocumento31 pagineEbook - Alessandra CartocciGiusy Aurora SciaccaNessuna valutazione finora
- Del Parlato Al CantoDocumento7 pagineDel Parlato Al CantoSergio BlardonyNessuna valutazione finora
- Programma Didattico Del Corso Di Canto ModernoDocumento2 pagineProgramma Didattico Del Corso Di Canto ModernoFrancesco Frà FrankNessuna valutazione finora
- Seminario Voce Nella ProfessioneDocumento39 pagineSeminario Voce Nella ProfessionemariottoalbertoNessuna valutazione finora
- Tomatis ImpaginatoDocumento4 pagineTomatis ImpaginatoSteveDF100% (1)
- Benenzon Manuale Di Musicoterapia RiassuntoDocumento20 pagineBenenzon Manuale Di Musicoterapia RiassuntofloranoceraNessuna valutazione finora
- Mauro Ubertiil Metodo Pratico Di Canto Di VaccaiDocumento21 pagineMauro Ubertiil Metodo Pratico Di Canto Di VaccaiMyriam TokerNessuna valutazione finora
- Autismo e MusicaDocumento23 pagineAutismo e Musicaio sonoNessuna valutazione finora
- Educare Alla Voce (Dispensa)Documento15 pagineEducare Alla Voce (Dispensa)Alessio CarrusNessuna valutazione finora
- Diaframma Lezioni Di CantoDocumento2 pagineDiaframma Lezioni Di Cantosalvo_50Nessuna valutazione finora
- Musica Nei ServiziDocumento123 pagineMusica Nei ServiziMirco Marchetti100% (1)
- Paolo Zedda - Divergenza Canto Classico e ModernoDocumento14 paginePaolo Zedda - Divergenza Canto Classico e ModernoEleonora RebecchiNessuna valutazione finora
- La Mente Musicale John A Sloboda ICLBH452ANDocumento4 pagineLa Mente Musicale John A Sloboda ICLBH452ANRcatNessuna valutazione finora
- Alessandro Volta - in Principio Era Il SuonoDocumento3 pagineAlessandro Volta - in Principio Era Il SuonoMasini DanieleNessuna valutazione finora
- Riflessi PrimitiviDocumento19 pagineRiflessi PrimitiviDavide DelfinoNessuna valutazione finora
- Elementi Di MusicoterapiaDocumento65 pagineElementi Di MusicoterapiaMichele Buonsanti100% (1)
- Riscaldamento VocaleDocumento4 pagineRiscaldamento VocaleGabriele ValenteNessuna valutazione finora
- Considerazioni Tecnica Canto PDFDocumento15 pagineConsiderazioni Tecnica Canto PDFValeria LongoNessuna valutazione finora
- GarciaGarcia - Trattato - Di - Canto - I - Parte Trattato Di Canto I ParteDocumento88 pagineGarciaGarcia - Trattato - Di - Canto - I - Parte Trattato Di Canto I ParteDario DragoNessuna valutazione finora
- Juvarra I, II e IIIDocumento13 pagineJuvarra I, II e IIIJeanNessuna valutazione finora
- Lezioni Sulla Voce - Laura PigozziDocumento30 pagineLezioni Sulla Voce - Laura PigozziVala Bellamy100% (1)
- Musicoterapia PDFDocumento20 pagineMusicoterapia PDFMirco MarchettiNessuna valutazione finora
- Respirazione e AppoggioDocumento9 pagineRespirazione e AppoggioAmedeoPomiNessuna valutazione finora
- Suvini Muratori MusicoterapiaDocumento9 pagineSuvini Muratori MusicoterapiaCris RiatoNessuna valutazione finora
- Musica e ScienzaDocumento11 pagineMusica e ScienzaBarbara BianconiNessuna valutazione finora
- APPOGGIO E SOSTEGNO RESPIRATORIO - OdtDocumento5 pagineAPPOGGIO E SOSTEGNO RESPIRATORIO - OdtFabioNessuna valutazione finora
- 0133 PPM00201 La Voce Espressiva Vol CopDocumento1 pagina0133 PPM00201 La Voce Espressiva Vol CopTatianaScigaevaNessuna valutazione finora
- Tecnica Avanzata Per Il Cantante Moderno. La Costruzione Del Suono, Con Spiegazioni Chiare e Comprensibili (Riccardo Tasselli)Documento114 pagineTecnica Avanzata Per Il Cantante Moderno. La Costruzione Del Suono, Con Spiegazioni Chiare e Comprensibili (Riccardo Tasselli)Luca SabellaNessuna valutazione finora
- Igiene Vocale Per Il Professionista Della VoceDocumento4 pagineIgiene Vocale Per Il Professionista Della VoceSara Battiloro AraujosaxNessuna valutazione finora
- Fabio Gherardelli Musica e CervelloDocumento10 pagineFabio Gherardelli Musica e CervellonevereverNessuna valutazione finora
- Musica e Disabilitą Nella Scuola PrimariaDocumento13 pagineMusica e Disabilitą Nella Scuola PrimariasilviaNessuna valutazione finora
- Tosto La Voce Musicale 9788860409072Documento158 pagineTosto La Voce Musicale 9788860409072Teresa RanieriNessuna valutazione finora
- Scrivere La Musica 133Documento6 pagineScrivere La Musica 133Juka EnergyNessuna valutazione finora
- I' Te Vurria VasàDocumento3 pagineI' Te Vurria VasàEnzo De SanctisNessuna valutazione finora
- Bibliotheca Sarda - 046 - Giovanni Spano - Canzoni Popolari Di Sardegna IIIDocumento246 pagineBibliotheca Sarda - 046 - Giovanni Spano - Canzoni Popolari Di Sardegna IIIRoberta CeccottiNessuna valutazione finora
- AA - Vv. LaCanzoneNapoletanaDocumento363 pagineAA - Vv. LaCanzoneNapoletanaFiammuus80% (5)
- Scheda Per L Analisi Di Un Testo NarrativoDocumento2 pagineScheda Per L Analisi Di Un Testo NarrativoRoberta CeccottiNessuna valutazione finora
- Pierluigi Ighina - L'Atomo MagneticoDocumento11 paginePierluigi Ighina - L'Atomo Magneticoaagnoletti100% (1)
- La Pioggia Nel PinetoDocumento7 pagineLa Pioggia Nel PinetoRoberta CeccottiNessuna valutazione finora
- Fiabe MassonicheDocumento4 pagineFiabe MassonicheRoberta CeccottiNessuna valutazione finora
- Antropologia Culturale 6 CFU UniPegasoDocumento16 pagineAntropologia Culturale 6 CFU UniPegasoRoberta Ceccotti100% (3)
- PUB - 01 - Piccola Guida Al Testo TeatraleDocumento4 paginePUB - 01 - Piccola Guida Al Testo TeatraleRoberta CeccottiNessuna valutazione finora
- Itinerai EducativiDocumento21 pagineItinerai EducativiRoberta CeccottiNessuna valutazione finora
- Patologie PsicomotorieDocumento15 paginePatologie PsicomotorieRoberta CeccottiNessuna valutazione finora
- Classificazione HandicapDocumento17 pagineClassificazione HandicapRoberta CeccottiNessuna valutazione finora
- 1.pedagogia SpecialeDocumento19 pagine1.pedagogia SpecialeSARONessuna valutazione finora
- Patologie PsicomotorieDocumento15 paginePatologie PsicomotorieRoberta CeccottiNessuna valutazione finora
- Autismo EziologiaDocumento15 pagineAutismo EziologiaRoberta CeccottiNessuna valutazione finora
- Canzoni Tradotte e Traduzioni MusicaliDocumento16 pagineCanzoni Tradotte e Traduzioni MusicaliRoberta CeccottiNessuna valutazione finora
- Le Divulgazioni Di George I. GurdjieffGuDocumento58 pagineLe Divulgazioni Di George I. GurdjieffGuRoberta CeccottiNessuna valutazione finora
- Poesia MusicaDocumento34 paginePoesia MusicaRoberta CeccottiNessuna valutazione finora
- Testo Teatrale Del MunacielloDocumento16 pagineTesto Teatrale Del MunacielloRoberta CeccottiNessuna valutazione finora
- Le Canzoni Che Hanno Fatto Litaliano in PDFDocumento69 pagineLe Canzoni Che Hanno Fatto Litaliano in PDFRoberta CeccottiNessuna valutazione finora
- Trasformazione Racconto in CopioneDocumento5 pagineTrasformazione Racconto in CopioneRoberta CeccottiNessuna valutazione finora
- Canzoni Tradotte e Traduzioni MusicaliDocumento16 pagineCanzoni Tradotte e Traduzioni MusicaliRoberta CeccottiNessuna valutazione finora
- Dal Testo Letterario Al Testo Spettacola PDFDocumento12 pagineDal Testo Letterario Al Testo Spettacola PDFRoberta CeccottiNessuna valutazione finora
- Escatologia Popolare e Riti Musicali Dei PDFDocumento15 pagineEscatologia Popolare e Riti Musicali Dei PDFRoberta CeccottiNessuna valutazione finora
- Cortocircuiti e Nuove Prospettive Nel LiDocumento30 pagineCortocircuiti e Nuove Prospettive Nel LiRoberta CeccottiNessuna valutazione finora
- La Traduzione Del Testo Musicale Rap Asp PDFDocumento87 pagineLa Traduzione Del Testo Musicale Rap Asp PDFRoberta CeccottiNessuna valutazione finora
- Un Giullare Contemporaneo Caparezza Tra PDFDocumento14 pagineUn Giullare Contemporaneo Caparezza Tra PDFRoberta CeccottiNessuna valutazione finora
- La Penna Interprete Della Cetra I Salmi PDFDocumento368 pagineLa Penna Interprete Della Cetra I Salmi PDFRoberta CeccottiNessuna valutazione finora
- Mellace - D'Annunzio e La Musica - NS03 2013Documento4 pagineMellace - D'Annunzio e La Musica - NS03 2013Andrea PanaroNessuna valutazione finora
- Monumento Funebre A Maria Cristina D'austriaDocumento5 pagineMonumento Funebre A Maria Cristina D'austriaSimone RiggiNessuna valutazione finora
- Biografia Romeo CastellucciDocumento2 pagineBiografia Romeo CastelluccielmediodiaNessuna valutazione finora
- Ceramica Romana PDFDocumento38 pagineCeramica Romana PDFdfsaewqrq dqfNessuna valutazione finora
- Nicola Pucci - Opere 1999-2019 CatalogoDocumento68 pagineNicola Pucci - Opere 1999-2019 Catalogoapi-414396441Nessuna valutazione finora
- New Orleans Revival - Gino RomanoDocumento125 pagineNew Orleans Revival - Gino RomanoGino Romano100% (1)
- PostimpressionistiDocumento7 paginePostimpressionistiSara SuciNessuna valutazione finora
- Neoclassicismo RomanticismoDocumento28 pagineNeoclassicismo RomanticismoAlessandra Frittelli0% (1)
- La Repubblica Milano 20 Settembre 2017Documento20 pagineLa Repubblica Milano 20 Settembre 2017stefanoNessuna valutazione finora
- Materiali BioediliziaDocumento24 pagineMateriali Bioediliziap.pal6197Nessuna valutazione finora
- Investire in ArteDocumento2 pagineInvestire in ArteGhosy RiderlyNessuna valutazione finora
- B. Bartok - Mikrokosmos (Libro 4) - Breve AnalisiDocumento19 pagineB. Bartok - Mikrokosmos (Libro 4) - Breve AnalisiAlessandro Bono100% (1)
- Patron Funny Rainbow StarDocumento4 paginePatron Funny Rainbow StarE M CNessuna valutazione finora
- Ludwig Mies Van Der RoheDocumento8 pagineLudwig Mies Van Der RoheoggianniNessuna valutazione finora
- ImpressionistiDocumento2 pagineImpressionistiAndreata1995Nessuna valutazione finora
- Carlo ScarpaDocumento17 pagineCarlo Scarpaq_zzNessuna valutazione finora
- FotoromanzowDocumento5 pagineFotoromanzowapi-492367167Nessuna valutazione finora
- Decroupet - Materiali e Drammaturgia in Gesang Der Jünglingen Di StockhausenDocumento16 pagineDecroupet - Materiali e Drammaturgia in Gesang Der Jünglingen Di StockhausenGianfranco TinelliNessuna valutazione finora
- Ioarch 40 IpadDocumento52 pagineIoarch 40 IpadPierulisNessuna valutazione finora
- BovisaDocumento19 pagineBovisaMichele ColomboNessuna valutazione finora
- Toni e Modi Canto Fermo e FiguratoDocumento26 pagineToni e Modi Canto Fermo e FiguratoEzio BuaNessuna valutazione finora
- Franco Albini e Palazzo Bianco A GenovaDocumento14 pagineFranco Albini e Palazzo Bianco A Genovapaolo_pupNessuna valutazione finora
- The Theft of Aida - Language Course Italian Level B1: A crime novel and tourist guide through Giuseppe Verdi's hometownDa EverandThe Theft of Aida - Language Course Italian Level B1: A crime novel and tourist guide through Giuseppe Verdi's hometownNessuna valutazione finora
- Le nozze di Figaro: Libretto in versione integraleDa EverandLe nozze di Figaro: Libretto in versione integraleNessuna valutazione finora
- Ortografia e fonologia. Teoria + esercizi svolti. La grammatica senza segretiDa EverandOrtografia e fonologia. Teoria + esercizi svolti. La grammatica senza segretiNessuna valutazione finora
- Die Meistersinger von Nürnberg (I Maestri Cantori di Norimberga)Da EverandDie Meistersinger von Nürnberg (I Maestri Cantori di Norimberga)Nessuna valutazione finora
- Come trovare le note sulla tastiera della chitarraDa EverandCome trovare le note sulla tastiera della chitarraValutazione: 3 su 5 stelle3/5 (3)
- Quaderni Musicologici (Ritmo, Melodia, Armonia, Timbro)Da EverandQuaderni Musicologici (Ritmo, Melodia, Armonia, Timbro)Nessuna valutazione finora
- Iniziazione alla via del canto: Quaderno di sperimentazioni vocaliDa EverandIniziazione alla via del canto: Quaderno di sperimentazioni vocaliValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (2)
- Oh Happy Day - Orchestra Scolastica (partitura): GospelDa EverandOh Happy Day - Orchestra Scolastica (partitura): GospelValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- 20 Prove d'esame: PER STRUMENTI A PERCUSSIONEDa Everand20 Prove d'esame: PER STRUMENTI A PERCUSSIONEValutazione: 2 su 5 stelle2/5 (1)
- Fernand Cortez (1817): o La conquista del MessicoDa EverandFernand Cortez (1817): o La conquista del MessicoNessuna valutazione finora
- Timing per Bassisti 1: eBook interattivo per BASSISTI con partiture/tab/video/audioDa EverandTiming per Bassisti 1: eBook interattivo per BASSISTI con partiture/tab/video/audioValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Asturias - orchestra scolastica smim/liceo (partitura)Da EverandAsturias - orchestra scolastica smim/liceo (partitura)Valutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)