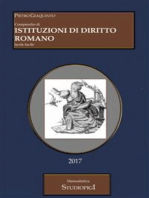Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Diritto Romano
Caricato da
qz7jcbg6rbTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Diritto Romano
Caricato da
qz7jcbg6rbCopyright:
Formati disponibili
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO – Proff.
Di Maria, Beggio – AA 2021/2022
INTRODUZIONE E NOZIONI PRELIMINARI
Il diritto e l’istituzione
Istituzioni deriva dal verbo istituere. La forma verbale viene tradotta in italiano come fondare, costruire. Il termine
istituzione indica quindi le fondamenta del diritto romano.
Non esiste una definizione univoca del diritto a causa della soggettività di intendere proprio il diritto. Nelle fonti del
diritto romano, una delle definizioni che viene spesso riportata è quella di Ulpiano, che descrive il diritto come “l’arte
del buono e dell’equo”. In latino il termine diritto viene tradotto in ius, che ha la stessa radice del termine iustitia. La
giurisprudenza (iuris prudentia) è la scienza del diritto.
Perché studiare diritto romano
Quando è nata la prima università (Bologna, XI secolo) si studiava diritto romano anche se l’Impero romano era già
caduto da un pezzo. Oggi, a distanza di più di 15 secoli dalla caduta dell’Impero, questo studio è diffuso anche fuori
dall’Italia perché molti dei Paesi europei hanno ereditato molto dal diritto romano, sia direttamente che indirettamente.
Inoltre, è importante conoscere la dimensione storica dell’istituto romano, in modo da comprendere le differenze negli
ordinamenti che da esso traggono ispirazione.
Il diritto romano è caratterizzato dal primato che Roma ha avuto nel campo dell’approccio scientifico al diritto. I romani
si occupavano del diritto con un metodo, una scienza giuridica creata per distinguere il diritto dalla morale e dalla
religione. Questo fa del diritto romano una scienza che ha influenzato enormemente le moderne codificazioni (formulate
a partire dal XIX secolo).
Il diritto casistico
I romani hanno costruito un diritto casistico, che non parte dalla regola generale ed astratta ma da casi concreti. Nel
leggere le fonti del diritto romano si ritrova spesso il caso concreto, che viene risolto creando una regola ad hoc. Il diritto
romano è caratterizzato da un vivo dibattito tra posizioni diverse sostenute dai diversi giuristi (ius controversum). Il
giurista moderno, studiando il diritto romano, è educato alla logica perenne dell’argomentazione giuridica. Se visto in
quest’ottica, il diritto romano non è morto e, anzi, mai come in questa fase storica è stato vivo. Al diritto romano si
richiama spesso anche la cassazione: quando c’è un contrasto, la cassazione emana delle sentenze a sezioni unite dettate
dall’interpretazione del caso. Spesso le sentenze a sezioni unite si richiamano al diritto romano per ottenere una chiave
di lettura della situazione che metta tutti d’accordo.
Le fasi del diritto privato romano e Giustiniano
Il diritto romano che studiamo è il diritto privato romano, diviso in diverse fasi: arcaica (dalla fondazione di Roma fino
al III secolo a.C., periodo della monarchia), preclassica (dall’apice alla crisi della repubblica), classica (dal 27 a.C,
coincide con il principato), postclassica (a partire dal 300 d.C., il periodo del dominato) e giustinianea (sottoinsieme
della postclassica, XI secolo d.C.).
La maggior parte dei testi oggetto di studio risalgono all’età giustinianea. Giustiniano è un imperatore romano d’Oriente
del XI secolo d.C. che durante gli anni del suo regno (527 – 565) scrisse il Corpus Iuris Civilis (la denominazione
dell’opera è postuma, risalente al periodo medievale). Giustiniano è stato il primo grande codificatore della storia:
circondatosi di ministri e tecnici ha redatto molte opere giuridiche tra cui il Codice, le Istituzioni di Giustiniano, il
Digesto (accorpamento di tutto il diritto romano antecedente), un secondo Codice e le Novelle (leggi che vennero
emanate dopo il secondo Codice). Tutte queste opere vennero definite nel periodo medievale come Corpus Iuris Civils.
Queste opere costituirono la base su cui lavorare per tutti i giuristi dall’età giustinianea fino alla promulgazione dei
primi codici moderni.
Fonti del diritto romano – fase arcaica
Nella fase arcaica le fonti di produzione del diritto sono principalmente i mores, i costumi del popolo romano, cui si
affiancano anche le cosiddette leges (sinonimo: costitutiones), termine che in diritto romano assume un significato
diverso a seconda del periodo storico di riferimento. Nel periodo arcaico le leges erano le leggi pronunciate dal
magistrato, che in questa fase era un funzionario della monarchia, di fronte ai comizi, l’assemblea del popolo. Questo
tipo di leggi prende il nome di leges publicae. Oltre alle leges publicae vi erano anche le leges rogate (chieste), leggi
solo proposte dal magistrato e approvate dai comizi. Una delle più note leges publicae è la legge delle dodici tavole, che
contemplava diversi precetti giuridici.
Durante il periodo arcaico, tuttavia, affianco ai mores e alle leges c’erano anche i cosiddetti plebiscita (provvedimenti
della plebe), leggi dell’assemblea dei plebei. Questi plebiscita venivano approvati dall’assemblea di patrizi e plebei
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
insieme, ma vincolavano solo i plebei al contrario delle leges publicae e rogate. Questa distinzione di applicazione venne
portata avanti fino all’introduzione della lex hortensia (286 a.C.), che abolì la differenza tra plebiscita ed altre leggi.
Nella fase arcaica i pontefici svolsero un ruolo importantissimo. Il termine pontefice deriva dal latino “pontem facere”,
infatti i pontefici (non da intendere come i papi) erano considerati gli ingegneri del diritto perché davano
l’interpretazione ufficiale delle leges di fatto creando il diritto. Si dice quindi che, nell’età arcaica, la giurisprudenza
fosse pontificale e molto ristretta: gli interpreti del diritto erano, di fatto, solo i pontefici. Il diritto, in questo momento,
è detto ius quiritium (la parola quiritium deriva dai quiriti, gli antichi romani). In seguito, però, il diritto prese il nome
di ius civile perché venne ulteriormente ampliato.
Fonti del diritto romano – fase preclassica
Nella fase preclassica le fonti di produzione aumentano: i mores perdono sempre più importanza, e ciò che cambia è
soprattutto il ruolo degli interpreti del diritto, i giuristi: la giurisprudenza diventa laica, quindi l’interpretatio dello ius
civile non è un monopolio esclusivo dei pontefici ma viene affrontata anche dai giuristi (iuris prudentiae o iuris consulti),
che nell’interpretare il diritto lo rivoluzionano dando la soluzione personale alle questioni d’interpretazione e
vincolando, nei casi più importanti, l’organo giudicante (stare decisis: principio generale in forza del quale il giudice è
obbligato a confrontarsi con le decisioni adottate precedentemente).
In questa fase ai mores e alle leges si affiancano altre fonti di produzioni del diritto, i pretori, organi dello Stato che
avevano il compito di amministrare la giustizia (ma non di decidere). Il pretore non è il giudice (che è un privato
cittadino), ma è un organo istituito nel 367 a.C. che amministra la giustizia inizialmente solo per i cittadini romani
(pretor urbanus) ma poi, quando Roma si ampliò, anche per i peregrini, gli stranieri che non avevano la cittadinanza
romana (pretor peregrinus). All’inizio del suo anno di carica il pretore emana un editto (una sorta di manifesto
programmatico) in cui dice che concederà l’azione (strumento giudiziale dell’attore) solo in determinate situazioni.
[Attore: chi agisce in giudizio; convenuto: chi viene chiamato in causa; azione: strumento giudiziale in mano all’attore;
eccezione: strumento giudiziale del convenuto, con cui si può paralizzare l’azione]. L’editto era teorico, ma quando si
verificava la situazione in concreto l’attore poteva scegliere di agire solo con le azioni concesse dal pretore. Nel periodo
preclassico, quindi, allo ius civile si affiancò anche lo ius honorarium (o pretorium). Questi due diritti si affiancheranno
fino all’età giustinianea. Lo ius pretorium fa da correttivo e da integrazione allo ius civile. Ogni pretore, quando entrava
in carica, emanava un proprio editto personale. Dopo un po’ di tempo, però, cominciò ad imperare uno stesso editto che
si trasmetteva da pretore a pretore (perpetuum), che venne anche codificato nel 130 d.C. da Salvio Giuliano.
Fonti del diritto romano – fase classica
La fase classica (epoca dell’apoteosi della scienza giuridica romana) è caratterizzata dalla forma di governo del
principato, che si caratterizza per la diarchia tra il princeps ed il senatus. I senatus consulta sono provvedimenti del
senato, a cui si affiancano anche le leges che non sono più il prodotto legislativo dei comizi ma del princeps (leges o
costitutiones). Pertanto, nel periodo classico, le fonti di produzione sono le leges nella nuova accezione, i senatus
consulta, i mores e l’editto del pretore (che proprio in questa fase viene codificato). Accanto a queste fonti si intensifica
il lavoro interpretativo degli iures prudentiae (nell’età classica ci sono giuristi come Ulpiano, Paolo, Papiniano,
Modestino e Gaio), i grandi giuristi che hanno trasformato il diritto romano in scienza ricoprendo ruoli di funzionari
statali importanti come il questor e creando il diritto attraverso opere enciclopediche imponenti che prescindono dal
caso concreto per spostarsi nell’ambito astratto e generale.
Soprattutto il periodo classico è contraddistinto dal fenomeno dello ius controversum, che parte già dal momento in cui
la giurisprudenza diventa laica. Infatti spesso, in età classica, il diritto diventa casistico e i giuristi danno risposte diverse
ad un singolo caso (come nei moderni sistemi di common law). Il termine giurisprudenza è usato in questo ambito per
designare i giuristi che interpretano il diritto e che, in questo modo, lo creano. Oggi, il termine giurisprudenza indica
l’insieme delle sentenze dei giudici, mentre il termine più vicino al concetto di giurisprudenza romano è dottrina (gli
studiosi del diritto).
Nell’epoca del principato i giuristi creano diritto perché danno delle soluzioni al caso concreto interpretando sia lo ius
civile che lo ius honorarium. Nel principato, non tutti i giuristi erano dotati di ius publicae respondendi (diritto di
rispondere pubblicamente): tutti i giuristi davano i loro pareri, ma solo coloro dotati dello ius publicae respondendi, dato
loro dal princeps, potevano esporre pareri che fossero presi in considerazione dalle autorità. Questi particolari giuristi
facevano parte del concilium princips, il consiglio dei collaboratori più stretti del princeps. A questa categoria
appartenevano solo i giuristi più importanti, che ricoprivano un determinato incarico all’interno della corte del princeps.
Le leges del princeps si dividono in: edicta (editti, non coincidenti con l’editto del pretore ma leges promulgate dal
princeps e rivolte a tutti i cittadini), mandata (leges rivolte solo ai funzionari, in particolare nel periodo postclassico i
mandata sono leges rivolte ai funzionari imperiali dislocati nelle provincie), decreta (decisioni del princeps e,
successivamente dell’imperatore, nella sua veste di giudice), rescripta (scritto due volte, erano le risposte che
l’imperatore dava ai quesiti giuridici che gli venivano sottoposti dai privati) ed epistule (risposta dell’imperatore ai
quesiti dei funzionari).
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
Fonti del diritto romano – fase postclassica
Tutta la magnificenza giuridica dell’età classica scompare nel periodo postclassico (contraddistinto dal dominato), in
cui i giuristi non scrivono nuove opere ma si limitano a riassumere le opere precedenti, a fare pitomi e collage. In questa
epoca viene meno la creatività del giurista, segnando un momento di decadenza del diritto.
Nell’epoca postclassica le fonti di produzione sono sostanzialmente due, le leges e gli iura (plurale di ius). In questo
momento le leges sono le leggi dell’imperatore/dominus (dette anche costitutiones dell’imperatore), mentre gli iura sono
le opere e le opinioni dei giuristi classici ormai deceduti.
La legge delle citazioni
Il problema pratico nella fase postclassica era quello della recitatio giudiziaria, fase del processo postclassico in cui nella
propria arringa gli avvocati citavano, a sostegno della propria linea difensiva, le opinioni dei giuristi classici. Ma mentre
oggi si può controllare tramite le banche dati se una determinata sentenza citata nell’arringa esista, in epoca postclassica
si poneva il problema della falsificazione delle opere: i giuristi citavano un fantomatico testo di qualche famoso giurista
classico, ma il giudice non aveva modo di verificare se la citazione fosse pertinente. Per far fronte a questo problema
nel 426 d.C. venne emanata a Ravenna, la capitale dell’impero romano d’Occidente, la legge delle citazioni, che stabiliva
che i giuristi che potevano essere citati in giudizio fossero solamente cinque: Papiniano, Paolo, Ulpiano, Gaio e
Modestino. Questi erano i giuristi più prestigiosi nell’epoca classica, quindi le loro opere circolavano con molta più
facilità.
La legge delle citazioni viene emanata sotto Valentiniano III, figlio di Galla Placidia, che nel 426 aveva solo 7 anni: la
legge venne dunque scritta dalla cancelleria imperiale. La legge delle citazioni regolava anche il meccanismo delle
citazioni: se una parte citava tre giuristi e l’altra parte ne citava due, vinceva la maggioranza. Le opere citate dovevano
essere prodotte in giudizio, cioè si dovevano portare di fronte al giudice. In caso di parità, invece, vinceva la parte che
aveva citato Papiniano, giurista molto casistico e particolarmente apprezzato in epoca postclassica e giustinianea. Se,
nonostante tutto, ci fosse stata ancora parità, solo in questo caso la decisione sarebbe stata rimessa all’organo giudicante.
La legge delle citazioni venne presto estesa anche alla parte orientale dell’impero, sotto l’imperatore Teodosio. La
cancelleria imperiale orientale aggiunse però che, oltre ai cinque giuristi citabili, si poteva citare anche un giurista citato
da uno dei cinque, purché si portasse in giudizio l’opera originaria.
La legge delle citazioni regolamenta l’uso degli iura nella prassi forense sino all’intervento del Digesto di Giustiniano.
Il codice teodosiano
Un altro passaggio importante è quello che si verifica sotto il governo di Teodosio II (imperatore orientale), che nel 439
emanò il codice teodosiano. Questo è il primo codice ufficiale mai redatto che raccolga tutte le leges vigenti, ma per noi
non ha molta importanza perché gioca un ruolo minore rispetto a quello di Giustiniano. Il termine codex assunse il
significato di “fogli spillati, messi insieme”. Prima di Teodosio II erano stati emanati solo codici privati, senza sigilli di
ufficialità.
Giustiniano e Teodora
Nel 527 sale al trono Giustiniano, figura molto interessante perché sale al trono con il disegno preciso di mettere ordine
nel diritto romano (“dalle leggi trasse il troppo e il vano”). Giustiniano sposa Teodora, una “attrice”: il matrimonio tra i
soggetti di rango senatorio e i soggetti di altra classe era vietato, ma con una legge ad personam Giustiniano abolì questo
divieto. Teodora influenza molto la legislazione di Giustiniano, perché addirittura alcuni studiosi hanno parlato di
femminismo giustinianeo, perché nelle costitutiones dell’imperatore c’era spesso una apertura al mondo femminile
anomalo in quei tempi.
Il Digesto
La prima cosa fatta da Giustiniano alla salita al trono fu l’abolizione del codice di Teodosio II e l’introduzione nel 528
di un nuovo codice, il novus giustinianus codex. Poco tempo dopo,
Giustiniano creò una commissione deputata alla redazione del Digesto, una raccolta di tutti gli iura classici. La
commissione era presieduta da Triboniano, il questor sacri palati (una sorta di moderno ministro della giustizia che
segnò tutte le opere di Giustiniano. La commissione (composta da 16 elementi: 11 avvocati, 4 professori universitari e
Triboniano) aveva il compito di leggere le opere di tutti i giuristi classici, selezionare le parti più utili ed inserirle in
un’opera, il Digesto, composta da 50 libri. Le parti che non servivano delle opere classiche vennero scartate e
dimenticate.
Ogni libro del Digesto è diviso in titoli, e ogni titolo è diviso in frammenti o paragrafi. All’inizio di ogni frammento si
trova un codice: ad esempio il codice D.1.2.7 indica il frammento 7 del titolo 2 del libro 1 del Digesto. A sua volta il
frammento può essere diviso in paragrafetti. Per ogni frammento è presente la scriptio, la referenza dell’opera classica
citata.
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
Il Digesto mette fine al problema degli iura cristallizzandoli e conferendogli valore di legge superando, quindi, la legge
delle citazioni.
Ma quanto c’è di classico nel Digesto di Giustiniano? Nel redigere l’opera i giustinianei hanno fatto molto spesso delle
interpolazioni, cioè hanno modificato parte dei frammenti inseriti nell’opera, ma nella sostanza molto di classico c’è.
L’unica opera che non è inclusa nel Digesto sono le Istituzioni di Gaio, trovate nel 1816 nella biblioteca capitolare di
Verona. Il Digesto viene definito il templum sanctissimae iustitiae (tempio santissimo della giustizia).
L’incarico di scrivere il Digesto venne dato da Giustiniano nel 530 attraverso una costitutio chiamata Deo auctore
(essendo Dio l’autore). La pubblicazione del Digesto avvenne tramite la costitutio Tamta dedokem (533).
Quest’opera mastodontica è stata compiuta in soli tre anni (secondo l’ipotesi di Blume, giurista tedesco) perché la
commissione, formata in totale da 16 componenti, era stata divisa in tre sottocommissioni da 5 persone ciascuna più
Triboniano che faceva da jolly. A ciascuna delle sottocommissioni veniva assegnata una massa, un tema: la prima
commissione ha letto tutte le opere di diritto civile, la seconda tutte le opere di commento di diritto pretorio e la terza
tutte le opere casistiche. Le sottocommissioni facevano poi delle riunioni plenarie per decidere cosa inserire
propriamente nel Digesto.
Le Istituzioni
In contemporanea con il digesto la commissione emanò anche le Istituzioni, un’opera divisa in quattro libri rivolta alla
“cupida legum juventus” (gioventù desiderosa di apprendere le leggi). Le Istituzioni sono dedicate agli studenti di diritto
e regolamentano il corso di studi in giurisprudenza in funzione di formare nel migliore dei modi i futuri funzionari
imperiali. Le Istituzioni vengono pubblicati con la costitutio Omnem. Con le Istituzioni la laurea in giurisprudenza passa
da quattro a cinque anni, e le matricole vengono chiamate “i nuovi giustinianei” e non più “diupondi”, termine greco
usato in precedenza che significa persone squattrinate.
Approfondimento. Le Istitutiones di Gaio (metà del II secolo d.C.) sono un manuale destinato all’insegnamento, nel
quale Gaio cerca di descrivere i vari istituti romani. Le Istitutiones sono famose perché sono state scritte secondo la
tripartizione persone, res, actiones (mezzi processuali, di tutela). Questa tripartizione si va a riflettere sulle Istituzioni di
Giustiniano, che sta concettualmente alla base dell’organizzazione dei codici moderni. Le Istituzioni di Gaio sono
importanti anche perché ci sono giunte quasi integralmente, senza essere accorpate nel Corpus iuris civilis. Infatti è
giunto fino a noi il cosiddetto palinsesto veronese: Nebuhr, nel 1816, scoprì questo palinsesto nella biblioteca scaligera
di Verona.
Il secondo codice giustinianeo
Nel 534 entrò in vigore il secondo codice di Giustiniano, il codex repetitae praelectionis, per uniformare nel codice tutte
le leges pubblicate dal 528 fino ad allora.
Le Novelle
Dopo il secondo codice Giustiniano emanò altre leges, che resteranno sempre fuori dal codice e prendono il nome di
Novelle.
_______________________________________________________________________________________________
IL PROCESSO ROMANO
La regula ed il processo
Il diritto romano va inteso con categorie diverse da quelle che siamo soliti utilizzare oggi: per noi è quasi scontato che
il diritto prenda le mosse dalla legge secondo un processo deduttivo (diritto sostanziale), ma i romani avevano un
approccio induttivo nei confronti del diritto: dal caso concreto si traeva la regula, cioè la soluzione più equa (l’equità
era un principio importantissimo per gli antichi romani) per regolare quel problema giuridico. Giacché la regula era
astratta e pertanto non era pensata per risolvere il caso concreto ma un caso generale, poteva essere applicata per analogia
ad altre fattispecie simili. Questo significa che il momento in cui il diritto operava concretamente era il processo: in
quella sede, infatti, la regula astrattamente individuata dal giurista trovava la sua applicazione concreta e veniva posta
sotto un vaglio critico circa la sua attuabilità.
Escludendo l’età della Roma arcaica (durante la quale le controversie venivano risolte autonomamente o in forma
religiosa), quando si parla di processo privato nel diritto romano si parla di tre tipi di processo.
I diritti soggettivi e le actiones
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
I diritti soggettivi, nella Roma antica, non esistevano. Il diritto soggettivo è una norma di relazione o di comportamento,
che serve a risolvere i conflitti di interessi contrapposti. Il diritto soggettivo è quindi la facoltà che si attribuisce ad un
soggetto il cui interesse viene ritenuto prevalente rispetto ad altri interessi potenzialmente in conflitto. Il titolare del
diritto soggettivo può pretendere da colui che sia portatore di interessi diversi e contrapposti un determinato
comportamento, che può essere a contenuto positivo (un fare) o a contenuto negativo (un astenersi). I diritti soggettivi
si dividono a loro volta in diritti soggettivi assoluti e in diritti soggettivi relativi.
I romani non ragionavano per diritti soggettivi ma per actiones. Essi, cioè, valutavano se una pretesa giuridica fosse o
meno meritevole di tutela. Se meritevole di tutela, il magistrato avrebbe concesso la actio, strumento che aveva una
connotazione sia processuale (era la possibilità di agire, di instaurare il processo) che sostanziale (il magistrato la
concedeva quando riteneva che vi fosse almeno un minimo di fondatezza della richiesta).
Le azioni romane si distinguono in due grandi macrocategorie: le actiones in rem (azioni che si rivolgevano nei confronti
di una cosa, per quelli che noi oggi chiamiamo diritti reali) e le actiones in personam (azioni nei confronti di una persona,
il soggetto che l’attore riteneva essere il suo debitore; alle actiones in personam corrispondono oggi i diritti relativi).
La costruzione moderna dei diritti soggettivi si fonda completamente sullo studio delle fonti e del diritto romano. La
tradizione giurisprudenziale romana, restia a dare definizioni, ha fornito comunque un patrimonio notevole arricchito
poi nei secoli che, una volta recepito, ha gettato le basi per la formazione del concetto di diritto soggettivo (espressione
usata per la prima volta nel 1875).
Il processo romano si basava, quindi, sulle actiones. La definizione di actio venne data dal giurista Celso: l’actio non è
altro che “il diritto di perseguire ciò che è dovuto”. La definizione aveva in ogni caso un valore di massima, non voleva
essere imperativa.
Si suol dire che a Roma antica le actiones fossero tipiche, ossia che le azioni che si potevano utilizzare fossero solo
quelle date dalla legge. La tipicità riguardava però quasi sempre il contenuto delle azioni e quasi mai le fattispecie
concrete.
Anche a Roma, tendenzialmente, si conoscevano azioni dichiarative (che potevano essere di condanna, di accertamento
e costitutive) ed azioni esecutive.
PRIMO TIPO DI PROCESSO: LE LEGES ACTIONES
Il primo tipo di processo che venne elaborato fu il sistema delle leges actiones, risalente all’età monarchica e riguardante
anche parte dell’età repubblicana. Il sistema delle leges actiones si sviluppò prima dell’emanazione delle dodici tavole
(451/450 a.C.), ma proprio nelle dodici tavole venne organizzato giuridicamente. Il giurista classico Gaio racconta che
le leges actiones, ad un certo punto, andarono in odio ai romani perché rappresentavano una forma processuale
estremamente formale, per cui il minimo errore da parte dell’attore avrebbe portato alla sconfitta. Le leges actiones
pretendevano l’utilizzo delle “certa verba”, formule specifiche che dovevano necessariamente essere usate all’interno
del processo. Questa forma processuale andò a scalzare quella che precedentemente era l’unica via per risolvere le
controversie, l’autotutela. La compilazione delle dodici tavole sistematizzò il tema delle leges actiones, che però
risalivano già all’epoca monarchica, in cui il ruolo principale nella gestione del processo era giocato dal rex.
I certa verba altro non erano che formule verbali solenni, precise e certe che dovevano essere recitate davanti al
magistrato in maniera puntuale dalle parti affinché il processo potesse andare avanti. Queste formule verba costituivano
le actio in senso stretto, perché era lì che si condensava la pretesa giuridica.
In età monarchica il rex gestiva la prima parte del processo, in età repubblicana invece questa funzione veniva esercitata
dai magistrati dotati di imperium (consoli e pretori). L’imperium era un potere originario, non derivato, che competeva
ai sommi magistrati della repubblica e che attribuiva loro non soltanto la facoltà di esperire determinate attività (es.
condurre guerra, condannare i traditori…) ma anche la facoltà di eseguire la iurisdictio, che definiva il potere di emanare
regole, gestire il processo ed emanare edicta. L’edictum era un atto magistratuale dotato di potere supremo che conteneva
normalmente regole di varia natura.
Davanti ai magistrati si svolgeva il processo civile (che tanto qui quanto nel processo formulare era strutturato in due
fasi). La prima fase del processo è la fase in iure, nella quale si andava a discutere della questione giuridica e nella quale
l’attore definiva il tema decidendum ed il convenuto reagiva alle pretese attoree attraverso i certa verba. La fase in iure
si completava con la litis contestatio, che cristallizzava il tema decidendum.
La decisione del processo non spettava però al magistrato e nemmeno ad un organo ufficiale rappresentativo della res
pubblica, ma spettava al iudex privatus, un privato cittadino scelto di comune accordo dalle parti da un albo apposito.
Al iudex privatus spettava il compito di esprimersi sul merito della causa concreta: tutto questo avveniva nella seconda
fase del processo, la fase apud iudicem (davanti al giudice), in cui il giudice doveva decidere le sorti della causa
emanando una sentenza non motivata.
Nell’ambito delle leges actiones si distinguono le leges actiones dichiarative e le leges actiones esecutive. Le leges
actiones dichiarative sono la legis actio sacramento in rem, la legis actio sacramento in personam, la legis actio per
iudicis arbitrive postulationem (introdotta per la prima volta con le dodici tavole) e la legis actio per conditionem. Le
leges actiones esecutive sono la legis actio per manus iniectionem e la legis actio per pignoris capionem.
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
La legis actio sacramento
La legis actio sacramento è una cosiddetta legis actio generalis: qualora non vi fosse un’altra diversa actio specialis si
poteva sempre utilizzare, per ogni pretesa, la legis actio sacramento. Il sacramentum era una somma di denaro oggetto
di una scommessa tra le parti, che veniva versata al magistrato. La parte che perdeva la causa perdeva anche la somma
di denaro, che non andava all’altra parte ma all’aerarium saturni, le casse del popolo romano. Il sacramentum ha in realtà
origini profondamente religiose: in origine era infatti un giuramento, che nella Roma arcaica aveva un valore
importantissimo perché, se violato, rischiava di violare la pax theorum (la pace tra gli dei). Non solo, quindi, le parti
versavano la somma alle casse dell’erario, ma dovevano fornire anche dei praedes, garanti che dovevano rispondere per
la parte perdente. Quando il giudice andava ad esprimersi in merito alla controversia, diceva soltanto quale dei due
giuramenti fosse iustum e quale fosse iniustum. Solo chi dava un giuramento giusto prevaleva.
La legis actio sacramento in rem
La legis actio sacramento in rem veniva utilizzata quando un soggetto voleva far valere un diritto reale. Di fatto, in
questo caso, non si ha una distinzione vera e propria tra attore e convenuto: per entrambe le parti, infatti, i verba
consistevano in una vindicatio, un’affermazione proveniente da entrambe le parti circa la proprietà della res. L’attore
(prior vindicans) affermava che la res fosse sua per diritto dei quiriti (per ius civile), mentre il convenuto (adversarius)
faceva una controvindicatio, che consisteva nel dire le stesse identiche cose che diceva il prior vindicans attribuendosi
però la proprietà della res. Questo avveniva per tre ragioni, per una questioni di formalismo, per una forma linguistica
e perché si doveva affermare il legame diretto con la proprietà della cosa.
Entrambe le parti, durante questo rituale, toccavano poi la res con un bastoncino (festuca). Se la res era immobile o ci
si recava alla locazione della res e la si toccava oppure si portava davanti al magistrato un oggetto che rappresentasse in
astratto quella res (es. un pezzetto di terra davanti all’immobile). Da notare è il fatto che anche gli schiavi venivano
considerati delle res.
Un’altra fase del formulario consisteva nel passaggio in cui il prior vindicans chiedeva in base a quale causa
l’adversarius avesse effettuato la vindicatio. L’adversarius doveva necessariamente rispondere con la certa verba “ho
agito secondo ius”. A questo punto si arrivava alla cosiddetta provocatio sacramento, che consisteva in una sfida al
giuramento. A questo punto la prima fase del processo era conclusa e ad uno dei due contendenti spettava il possesso
della cosa fino alla promulgazione della sentenza. Il magistrato, quindi, decideva a chi concedere il possesso interinale
della res tramite l’ordine “mitite ambo rem” (lasciate tutti e due la cosa). La decisione del possesso interinale della res
avveniva osservando i due contendenti e valutando chi fosse colui che potesse verosimilmente essere il proprietario
della res, considerando anche chi dei due potesse dare maggiori garanzie per la restituzione: i garanti più affidabili, in
questo contesto, aiutavano la parte ad ottenere il possesso interinale.
Chiusa la parte in iure si arrivava alla litis contestatio, momento centrale del processo che portava alla cristallizzazione
della causa. Una volta arrivati alla sentenza, non si poteva più ripetere la medesima azione, contro il medesimo soggetto
(secondo il principio nevis in item). Era il magistrato, con il suo imperium, che decideva quando la discussione potesse
essere chiusa.
Nella fase apod iudicem il giudice privato scelto dalle parti in accordo con il pretore si esprimeva non in merito alla lite
ma sul sacramentum.
Santucci, pagina 10 (leggi).
La legis actio sacramento in personam
La legis actio sacramento in personam è anche essa una legge generale. In questo caso esistevano verba specifici a
seconda delle varie prestazioni immaginabili (dare, fare, risarcimento danni…). Quando si parla di questi rapporti
obbligatori ci si trova davanti all’oportere, il vincolo giuridico che trovava il proprio fondamento nello ius civile.
Nella legis actio sacramento in personam il creditore doveva agire contro la parte che riteneva essere la sua debitrice.
Verosimilmente, il formulario di questa legis era simile a quello della legis actio sacramenti in rem: l’attore agiva
rivendicando il fatto che l’altra parte gli dovesse una prestazione. Più o meno, la formula era quella dell’ammissione
(aio) o della negazione (nego) da parte del convenuto dell’accusa dell’attore. L’ammissione da parte del convenuto
consisteva in una confessione (confessio in iure) che aveva lo stesso valore di una sentenza; la negazione portava alla
fase della provocatio sacramenti.
La legis actio per iudicis arbitrive postulationem
La legis actio per iudicis arbitrive postulationem comparve per la prima volta nelle dodici tavole ed è una legis actio
speciale: il soggetto interessato avrebbe potuto agire con questa legis actio solo nei casi espressamente previsti
dall’ordinamento, ossia (secondo la testimonianza di Gaio) per richiedere la divisione dell’eredità, per richiedere la
divisione della cosa comune tra comproprietari (innovazione introdotta dalla lex licinia) e per far valere un credito nato
da una sponsio, una verborum obbligatio (obbligazione che si contraeva verbalmente).
Il verba formulato nell’agere ex sponsionem era lo stesso della legis actio sacramento in personam, con la differenza
che in queste verba non si doveva solo affermare l’accusa ma si doveva anche indicare la causa, da dove derivasse
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
l’obbligazione. Questa actio diventava lo strumento principe per tutelare le obbligazioni nate da sponsio. Anche qui il
convenuto poteva o ammettere o negare il capo d’accusa; se il convenuto negava l’attore si rivolgeva al magistrato e,
anziché sfidare il convenuto ad un sacramentum si rivolgeva a lui attraverso la iudici postulatio, cioè la richiesta che
venisse nominato un iudex o, nei giudizi divisori, un arbiter (sempre un privato cittadino che, però, aveva dei poteri
decisionali più ampi rispetto al iudex; l’arbiter doveva infatti individuare anche le porzioni della cosa comune spettanti
a ciascuna delle parti).
La legis actio per conditionem
La legis actio per conditionem è la legis actio più recente tra quelle dichiarative ed è anch’essa specialis. Venne introdotta
sul finire del III secolo a.C. relativamente ad una certa pecunia, cioè ad un credito certo. Nel II secolo a.C. venne
permesso di agire per conditionem anche per una specifica res. Anche in questo caso il sacramentum venne rimosso.
La legis actio per manus iniectionem
Le leges actiones esecutive erano due, ma la più importante era la legis actio per manus iniectionem. Il presupposto per
una legis actio esecutiva era il più delle volte l’emanazione di una sentenza di condanna al termine di un processo di
cognizione, nel quale era stata applicata una legis actio dichiarativa (o cognitiva). La responsabilità del debitore, dopo
la sentenza, era stata sancita con la condanna: il debitore aveva un arco temporale (triginta dies, trenta giorni, previsti
già dalle dodici tavole) entro il quale poter adempiere a quanto ordinatogli nella sentenza di condanna. Trascorsi i triginta
dies, qualora il debitore non avesse adempiuto, veniva data al creditore la possibilità di prendere il debitore ovunque lo
incontrasse (ad esclusione della domus, il domicilio, che per i romani era inviolabile) e costringerlo a recarsi insieme in
ius davanti al magistrato, affinché si aprisse la fase in iure. Una volta davanti al magistrato il creditore poteva far partire
l’actio, che recitava una formula sacra: “poiché tu sei stato condannato a pagarmi la somma di X sesterzi e poiché non
li hai ancora pagati, per tale motivo io esercito su di te la manus iniectio per X sesterzi iudicati (sulla base del giudicato,
della sentenza)”.
La actio serviva per far andare avanti la procedura: il pretore non doveva controllare il merito della richiesta dell’attore,
perché questo era già stato accertato dalla sentenza, ma si limitava solo a verificare che da parte dei soggetti coinvolti
fossero state scrupolosamente rispettate le forme previste per quella legis actio. Se questo avveniva, il pretore poteva
ordinare la cosiddetta addictio del debitore.
Il debitore, di fronte alle pretese attoree, non poteva contestare quanto richiesto dall’attore in prima persona, ma doveva
far ricorso ad un terzo, il vindex, disposto a difenderlo. Se non trovava un vindex il debitore subiva immediatamente la
addictio, se lo trovava veniva invece estromesso dal processo in quanto la parte del convenuto spettava al vindex. La
figura del vindex era dovuta ai rapporti tra persone e famiglie tipici della società romana, pervasa da vincoli sociali
molto stretti rispetto alla società odierna. Molti di questi rapporti tra i soggetti coinvolti in un processo e soggetti terzi
erano fondati sulla fides, un valore molto importante per la società romana.
Solo dopo l’estromissione del debitore dal processo la fondatezza della richiesta dell’attore poteva essere contestata: in
questo caso il processo assumeva le forme di una legis actio sacramento in personam. Se il vindex difendeva il debitore
in modo inefficace si verificava il cosiddetto fenomeno della litis crescentia, cioè la condanna del vindex a pagare una
somma pari al doppio di quanto originariamente dovuto dal debitore. Questo era un po’ uno stimolo ad evitare una difesa
temeraria ed effimera, basata su argomentazioni non valide. Se, invece, il vindex avesse vinto si sarebbe semplicemente
accertata l’infondatezza della manus iniectio esperita.
Qualora avvenisse la cosiddetta addictio contro il debitore costui diveniva addictus, una condizione definita paraservile:
l’addictus non perdeva lo status libertatis (non diventava schiavo) e non perdeva lo status civitatis (cittadinanza), ma il
creditore poteva tenerlo presso di sé anche in catene (secondo la regola della prigionia per debiti, che venne ribadita
anche nelle dodici tavole), purché gli desse nutrimento. Il debitore poteva accordarsi con il creditore per estinguere il
proprio debito tramite una pactio, ossia l’offerta di una prestazione di lavoro. Se il debitore non fosse stato capace di
ripagare il creditore, egli avrebbe potuto esporlo per tre volte in sei mesi al mercato cercando qualcuno che saldasse il
suo debito. Passati i sei mesi, vigeva ancora la regola per cui il creditore poteva portare l’addictus trans tiberi (in territorio
straniero) ed ucciderlo. Se i creditori fossero stati più di uno, dopo l’uccisione avrebbero potuto dividersi il corpo
dell’addictus secondo la percentuale di debito che egli doveva a ciascuno.
Si davano anche casi di manus iniectio che poteva essere attivata non sulla base di una sentenza di condanna, ma ad
esempio sulla base del riconoscimento di un debito che già esisteva. Se non vi era una sentenza di condanna alla base,
la procedura della manus iniectio non mutava. Con il passare del tempo ci si rese conto che tale procedura in situazioni
che non nascevano in seguito a sentenze di condanna era troppo gravosa: intorno al III secolo a.C., quindi, si permise al
debitore che si trovasse in questa situazione di difendersi da solo (rimaneva comunque l’effetto della litis crescentia, in
questo caso però a carico totale del debitore).
La legis actio per pignoris capionem
L’altra legis actio esecutiva che conosciamo era la legis actio per pignoris capionem, che poteva essere utilizzata al di
fuori del tribunale del magistrato, in assenza della controparte (debitore) e addirittura anche durante i dies nefasti (giorni
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
durante i quali non si potevano svolgere tutta una serie di attività). Gaio affermò tuttavia che anche questa legis actio
fosse una forma processuale, perché basata su certa verba.
Circa questa legis actio si sa che il creditore poteva impossessarsi materialmente di cose del debitore, ovunque esse si
trovassero, pronunciando certa verba. Si ricorreva a questa legis actio quando il creditore vantasse una pretesa non
coperta da oportere (vincolo giuridico di ius civile). Il creditore cercava di impossessarsi delle cose (ma non poteva
venderle) per cercare di generare nel debitore una forma di coazione indiretta (il debitore era spinto a pagare il debito).
Quando, ad esempio, il publicanus (riscossore delle tasse romane) non riusciva a farsi pagare un tributo da un cittadino,
si impossessava di cose del soggetto spingendolo così a pagare.
SECONDO TIPO DI PROCESSO: IL PROCESSO FORMULARE
Il processo formulare è la forma processuale più importante di Roma antica perché vide una stretta collaborazione tra
magistrati e giuristi, che gettò le basi per l’evoluzione laica della scienza del diritto e per la convivenza di ius civile e
ius honorarium.
Il processo per formulas nacque introno al IV secolo a.C., ma si sviluppò tra il III e il II secolo a.C., sulla scia dell’astio
popolare verso le leges actiones. In questo periodo Roma era ormai definibile come “impero mediterraneo”, non per una
forma di governo imperiale ma per il dominio indiscusso su tutto il Mediterraneo. Con l’espansione di Roma
aumentarono anche i commerci e quindi i contatti con gli stranieri. Per dirimere i contrasti tra i cives romani e i peregrini
non si potevano però utilizzare le leges actiones (valide solo per i cives).
Nel 367 a.C., con la leges licinie sextie, si arrivò a determinare quali fossero i magistrati nel processo romano e venne
introdotta anche la figura del pretore urbano, dotato della funzione della iurisdictio (derivante da ius dicere): il pretore
urbano aveva il potere di concedere azioni processuali, che indicava nell’edictum emanato di anno in anno.
Nel 242 a.C. ci si rese conto che il pretor urbanus non era più sufficiente per amministrare la giustizia, quindi venne
istituita la figura del pretor peregrinus, che si occupava della giurisdizione tra i cives ed i peregrini. Prima che il processo
formulare raggiungesse la sua struttura tipica, il pretor urbanus concedeva alcune azioni ai soggetti coinvolti nelle
controversie oppure usava i suoi poteri coercitivi per obbligare il contraente debitore ad adempiere. Tra i poteri coercitivi
del pretore vi era, per esempio, la possibilità di erogare multe (multae dictio). Quando, però, il pretore voleva che si
sviluppasse un processo per dirimere le controversie, doveva far ricorso a delle regole che nello ius civile non c’erano.
Proprio grazie alla sua iurisdictio, il pretore cominciò a sviluppare il cosiddetto ius honorarium (la carica di pretore era
una carica onorifica). Da un lato il pretore si trovava a creare regole non già sancite dallo ius civile, dall’altro si ispirò
molto alla forma processuale delle leges actiones (molti elementi di queste ultime, infatti, vennero mantenute). Per far
sì che il iudex privato potesse emettere la propria sentenza, il pretore fece in modo che le parti in conflitto redigessero
davanti a lui una serie di formulazioni verbali, di argomentazioni e contro argomentazioni che sarebbero poi state
cristallizzate e portate di fronte al giudice. Queste formulazioni rappresentavano l’archetipo della formula, la struttura
base del processo formulare. Per citare le parole di Mario Talamanca, a Roma cominciò a crearsi un patrimonio di
schemi che venne poi tramandato di pretore in pretore, nonostante ciascun pretore fosse autonomo nell’esercizio della
giustizia. Queste formule e le relative situazioni che da loro ottenevano tutela erano sancite nell’edictum. Il pretore
aveva in fatti il potere dello ius edicendi.
I vari tipi di edicta
Si conoscono tre tipi di edicta del pretore: l’edictum tralaticium (nucleo stabile di formule tramandato da pretore in
pretore), l’edictum repentinum (correzione del pretore ancora in carica in riferimento all’editto già emanato) e l’edictum
perpetuum. L’edictum perpetuum, il più famoso fra tutti gli editti, venne reso statico intorno al 120 d.C. per volontà
dell’imperatore Adriano. Adriano diede ad uno dei suoi più fidati membri del suo consiglio, il giurista Salvio Giuliano,
l’incarico di redigere in forma definitiva l’edictum del pretore (“codificazione dell’edictum”). Salvio Giuliano prese
tutti gli edicta già emanati e cercò di redigerne un’edizione definitiva, cercando di integrarla anche con le opinioni dei
giuristi più importanti. Sull’edictum perpetuum, lo studioso Otto Lenel, scrisse l’opera Das edictum perpetuum (1883),
cercando di ricostruirne la struttura.
La lex aebutia
Il processo formulare cominciò ad affermarsi per la sua struttura flessibile, che ai certa verba delle leges actiones
sostituiva i concepta verba, formule verbali discorsive che potevano essere create con l’aiuto del pretore. Un passaggio
centrale si ebbe con l’emanazione della lex aebutia (120 a.C.), che fece sì che la legis actio per conditionem relativa alla
certa pecunia potesse essere esperita con le forme del processo formulare (condictio) e che la condicito formulare per
certa pecunia fosse efficace non solo per il ius honorarium ma anche sotto il profilo del ius civile. Se si fosse esperita la
condictio per certa verba nel processo formulare, avrebbe prodotto effetti civili ma non avrebbe estinto le leges actionem.
Non si sapeva, quindi, cosa fare nel caso in cui un soggetto avesse agito prima tramite processo formulare e dopo con
le leges actionem. È verosimile, però, che in questo caso il pretore avesse il potere di denegare l’azione al soggetto che
avesse richiesto un processo in leges actiones dopo aver partecipato ad un processo formulare.
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
La lex iulia iudicorum privatorum
Il processo formulare entrò definitivamente in gioco a Roma nel I secolo a.C., in particolare dopo l’emanazione della
lex aebutia. Intanto, le leges actiones non erano state formalmente abolite ma non venivano più utilizzate: la situazione
cambiò definitivamente nel 17 a.C., quando Augusto decise di riorganizzare definitivamente il processo romano
emanando le leges iuliae iudiciorum privatorum et publicorum, leggi che riorganizzano il processo cosiddetto privato
ed il processo cosiddetto criminale. La lex iulia iudicorum privatorum, in particolare, aboliva le leges actiones e stabiliva
che l’unico processo privato valido a Roma rimaneva il processo formulare, che diventò quindi il processo ordinario
romano.
La ius vocatio
Un momento centrale della fase in iure, poiché non si ammetteva processo in contumacia, consisteva nella convocazione
a giudizio del convenuto da parte dell’attore (in ius vocatio, oggi chiamato atto di parte dell’attore). La in ius vocatio
avveniva con l’intimazione dell’attore al convenuto di comparire dinnanzi al tribunale. Verosimilmente, l’attore avrebbe
anche dovuto descrivere per sommi capi la causa della in ius vocatio al convenuto. Se il convenuto avesse rifiutato,
l’attore avrebbe potuto esercitare una manus iniectio vocati, che nasceva cioè dalla in ius vocatio. Se il convenuto avesse
chiesto la possibilità di comparire dopo un certo numero di giorni avrebbe dovuto fornire un vindex, un garante.
Una volta comparsi davanti al magistrato, soprattutto nelle leges actiones dichiarative attore e convenuto dovevano
collaborare pronunciando i certa verba adeguati. Se il convenuto non avesse collaborato spontaneamente sarebbe incorso
nella cosiddetta indefensio, che avrebbe comportato una serie di sanzioni.
Iudicium legitimum e iudicium imperio continentia
La lex iulia iudiciorum privatorum stabiliva i requisiti affinché un giudizio formulare potesse esplicare con piena
efficacia i suoi effetti per ius civile, diventando quindi un iudicium legitimum. Il giudizio doveva essere celebrato in
territorio romano, tra cittadini romani e di fronte ad un iudex unum (giudice privato singolo, non collegiale). Sulla base
della lex iulia un’azione derivante tanto dall’antico ius civile quanto introdotta ex novo dal pretore avrebbe ottenuto
pieno riconoscimento come ius civile solo se avesse rispettato questi tre requisiti. Tutti i iudicia non legitimum (che non
rispettavano cioè uno o più dei tre requisiti) venivano detti iudicia imperio continentia (o iudicia co imperium
continentiur). Come dice il nome stesso, questi iudicia fondavano la loro efficacia sull’imperium magistratuale: era il
magistrato, forte del proprio imperium, ad assicurare lo svolgimento dell’operatività e l’esecuzione del processo. Ciò
era possibile perché i magistrati romani dotati di imperium potevano ius dicere. La caratteristica di questi iudicia imperio
continentia è che potevano durare al massimo per il tempo in cui il magistrato stava in carica, ossia un anno.
Le azioni civili e le azioni pretorie
Il pretore concedeva le azioni nel suo edictum, che conteneva le formule tanto dello ius civile quanto delle azioni
pretorie, cioè dettate dal pretore. Nel caso delle azioni civili il pretore si ispirava allo schema tipo delle vecchie leges
actiones, riadattandolo e piazzandolo sotto una rubrica recante il titolo della formula, in modo tale che ai cittadini fosse
chiaro in quali campi applicarlo. Nel caso delle azioni pretorie (azioni che il pretore riconosceva di anno in anno, che
indicavano quali fattispecie e in base a quali presupposti trovavano tutela quell’anno sulla base dell’imperium;
l’indicazione di questi pretesti prendeva il nome di clausola edittale) il pretore poteva non concedere tutela ad una
fattispecie che se la vedeva riconosciuta nell’editto: questa pratica prendeva il nome di denegatio actionis. La denegatio
actionis poteva essere utilizzata quando fossero intervenuti dei fatti chiari ed incontestabili, irrilevanti per il ius civile
ma rilevanti per il sentire giuridico dell’epoca, dei giuristi e del pretore.
La formula
La formula era il cuore della fase in iure del processo formulare. La formula consisteva in uno schema-discorso tipo,
che serviva ad indicare al giudice privato i criteri in base ai quali, nella fase apud iudicem, egli doveva procedere alla
soluzione della controversia. La formula descriveva quindi la pretesa attorea e la difesa della parte convenuta, e al tempo
stesso si poneva come fondamento e limite al contempo dei poteri decisori del giudice privato. Si parla di una certa
flessibilità della formula (concepta verba) perché lo schema andava adattato al caso concreto tramite una stretta
collaborazione tra le parti ed il pretore. Secondo una teoria ottocentesca, il processo formulare non era altro che una
sorta di negozio tra le parti, tanto importante era l’importanza data alla volontà delle parti.
La struttura della formula era ipotetica ed alternativa, perché la formula recitava a grandi linee “se saranno integrate
alcune circostanze per accogliere la domanda dell’attore – si paret – tu, giudice, accoglila; se queste condizioni non
risulteranno integrate – si non paret – tu, giudice, assolvi il convenuto” (vedi il testo del Santucci, pagina 23).
La formula iniziava con la datio iudicis, la nomina del giudice, che avveniva tramite un accordo tra le parti
supervisionato attivamente dal pretore. La formula constava poi di partes formularum: demonstratio, intentio,
adiudicatio e condemnatio (parti essenziali della formula, secondo la classificazione di Gaio). Le parti non essenziali
erano la exceptio, la praescriptio pro reo e la praescriptio pro actore.
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
L’intentio
L’intentio era il fulcro logico della pretesa dell’attore e della formula stessa. In essa, nelle aciones stricti iuris (derivanti
cioè da ius civile) veniva racchiusa la pretesa dell’attore e l’obbligo al quale era tenuto il convenuto nelle actiones in
personam oppure il diritto reale rispetto al quale era vincolato il convenuto nelle actiones in rem. Se l’azione era pretoria
la cui formula era la cosiddetta in factum concepta, invece, nell’intentio si ritrovava l’esposizione della situazione di
fatto che il magistrato riteneva essere meritevole di tutela. Le formule in factum concepta erano tipiche dell’editto
pretorio.
L’intentio era l’unica parte delle partes formularum che potesse esaurirne l’intera struttura. Ad esempio, il preiudicium
(indagine sullo status di un soggetto, ad esempio se una persona sia libera o schiava) si esauriva nella sola intentio.
L’intentio poteva inoltre essere certa o incerta. Quando si parla di actiones in personam derivanti da ius civile, l’intentio
era certa quando l’obbligo del convenuto avesse a che fare con una certa pecunia o una certa res. Nelle actiones in
personam civili l’intentio era incerta qualora prevedesse l’obbligo per il convenuto di dare una somma o compiere
un’attività dall’ammontare ancora da stabilire. Con le actiones in rem, invece, l’intentio era certa se si reclamava un
diritto reale sulla cosa ed era incerta soltanto se si rivendicava una quota di una proprietà in comproprietà.
La demonstratio
La demonstratio si andava ad inserire dopo la intentio qualora fosse necessario introdurre una descrizione che
permettesse di individuare chiaramente l’affare di cui si stava discutendo. Si inseriva la demonstratio soprattutto nelle
actiones che avessero una intentio incerta (esempio a pagina 24, Santucci). La formula con demonstratio inizia con
“posto che”.
La condemnatio
La condemnatio era quella parte della formula che attribuiva al giudice il potere (derivante dalla formula) di condannare
o di assolvere e al contempo fissava i criteri ai quali il giudice doveva attenersi per determinare l’ammontare della
condanna, che nel processo formulare era sempre di tipo pecuniario.
Anche la condemnatio poteva essere certa o incerta: era certa quando, nei concepta verba, fosse già determinata la
somma di denaro per cui poteva avvenire la condanna; era incerta quando il giudice, per capire quanto condannare il
convenuto, doveva procedere con la cosiddetta litis aestimatio. La condemnatio certa, nelle azioni civili, avveniva solo
nell’actio certae creditae pecunie e nell’actio certae ex testamento (nel caso in cui si agisse per un legatum per
dannationem).
La litis aestimatio poteva fare riferimento a diversi periodi temporali, a seconda del tipo di azione. La condanna poteva
infatti essere quanti ea res est (che si riferiva al valore della cosa nel momento della litis contestatio), quanti ea res erit
(riferita al momento futuro, cioè al momento in cui il giudice avrebbe emesso la sentenza), quanti ea res fuit (riferita al
momento precedente alla litis contestatio). La litis estimatio poteva portare ad una condanna pari al valore calcolato,
salvo alcune azioni, le azioni penali, che la portavano ad un multiplo (doppio, triplo, quadruplo). Le azioni penali non
erano azioni di diritto criminale, ma venivano chiamate in questo modo perché si diceva che la condanna prevedesse
una pena, cioè l’accrescimento dell’importo della sanzione. Già nel I secolo a.C., in caso di litis extimatio, si cominciò
a prendere in considerazione l’interesse positivo dell’attore, la valutazione che teneva conto non solo del valore della
cosa in sé ma anche del danno che l’attore aveva subito per il mancato rispetto delle obbligazioni da parte del convenuto
obbligato.
Nella condemnatio era possibile che le parti, in accordo tra loro e con l’approvazione della magistrato, introducessero
la cosiddetta taxatio, che fissava il limite massimo entro il quale il giudice poteva determinare il concreto ammontare
della condanna. La taxatio poteva inoltre rendere operativo il cosiddetto beneficium competentie, che indicava che la
condanna nei confronti del debitore doveva essere limitata entro l’attivo patrimoniale del debitore stesso, così da evitare
l’insolvenza (che poteva portare all’espropriazione parziale dei beni e, in certi casi, anche all’infamia, che rappresentava
uno stigma sociale e giuridico rilevante ed in alcuni casi poteva configurarsi anche come una condanna criminale).
L’adiudicatio
L’adiudicatio si trovava solo nei giudizi divisori, qualora ci fossero dei soggetti comproprietari di un bene (ad esempio
i coeredi, comproprietari dello stesso fondo). L’adiudicatio era la pars formulae che autorizzava il giudice a procedere
alla divisione della cosa, precedentemente indivisa, per quote individuali concretamente individuate. La formula tipica
di un giudizio divisorio stabiliva infatti quanto fosse opportuno attribuire a ciascuno dei comproprietari.
Originariamente, questa formula non prevedeva intentio. Se la cosa oggetto di comproprietà non fosse stata divisibile
(ad esempio, se l’oggetto del contendere fosse stato uno schiavo), il giudice poteva decidere di attribuire la cosa ad uno
dei soggetti, che sarebbe stato tenuto a fornire l’equivalente in denaro agli altri soggetti.
Le parti non necessarie
Per far entrare in gioco delle dinamiche processuali che permettessero di tener conto di elementi rilevanti per il ius
honorarium ed irrilevanti per il ius civile si integravano nella formula la praescriptio pro reo, la praescriptio pro actore
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
e la exceptio. Queste parti della formula (che Gaio classificava come non necessarie) servivano ad inserire nelle
descrizioni della formula quelle circostanze che potevano concretamente intervenire nei singoli casi concreti. Questo
avveniva allorquando fosse necessario, agli occhi del pretore, correggere (e non abrogare!) il ius civile nell’applicazione
al caso concreto per dare una soluzione equa. Così, il processo si adattava anche al sentire giuridico del tempo.
L’esempio più eclatante di introduzione di un elemento non preso in considerazione dal ius civile era il caso del dolus
malus negoziale, ossia la protezione che il pretore dava al convenuto che aveva stipulato un contratto sotto inganno,
violenza o imposizione. Applicare la denegatio actionis in questo contesto era possibile solo di fronte a fatti non
controversi, ma in caso di fatti controversi il pretore rischiava, tramite la denegazione dell’azione, di commettere un
arbitrio. Il processo veniva dunque aperto, ma si doveva farvi entrare questi fatti irrilevanti per il ius civile.
La praescriptio pro reo
Prima della exceptio, originariamente, era stata creata la praescriptio pro reo, che veniva premessa a tutto il resto della
formula. La praescriptio imponeva che, qualora i fatti in essa descritti risultassero essersi effettivamente verificati, il
giudice avrebbe dovuto considerare non avvenuta la litis contestatio su quel processo, di fatto non arrivando ad emettere
sentenza. Se non avveniva litis contestatio sul iudicium, però, la stessa azione per la stessa cosa contro lo stesso soggetto
avrebbe potuto essere riproposta.
La exceptio
Nel corso del I secolo a.C., la praescriptio pro reo venne sostituita dalla exceptio. La exceptio si inseriva nella parte
della formula tra intentio e condemnatio, oppure tra demonstratio e condemnatio se la demonstratio fosse stata presente.
La exceptio non era una mera difesa processuale ma era una condizione negativa della condanna, perché era quella parte
della formula attraverso la quale si introducevano le circostanze irrilevanti per il ius civile imponendo al giudice prima
di tutto di verificare se fosse fondata l’intentio e poi di non emettere condanna verso il convenuto se la exceptio fosse
stata fondata. Se fosse stata fondata, la exceptio prevaleva sull’intentio. Con la exceptio, quindi, il giudice andava ad
emettere una sentenza: se questa fosse stata di assoluzione del convenuto, l’azione non avrebbe potuto essere riproposta
dall’attore (principio del ne bis in idem).
Se l’attore voleva replicare all’exceptio poteva introdurre una replicatio. Se il convenuto avesse voluto a sua volta
addurre altre circostanze poteva chiedere una duplicatio. L’attore poteva rispondere con una triplicatio e così via,
andando avanti potenzialmente all’infinito (anche se ci sono giunte testimonianze di processi arrivati al massimo alla
triplicatio).
Le exceptio venivano distinte in peremptoriae e dilatoriae. Le exceptiones peremptoriae potevano essere apposte in
qualsiasi momento e contro qualsiasi persona e si riferivano di solito al dolo e alla violenza, mentre le exceptiones
dilatoriae avevano una efficacia limitata nel tempo e non potevano essere opposte a tutti, ma solo a determinate persone.
La praescriptio pro actore
La praescriptio pro actore si premetteva alla formula e delimitava l’oggetto della pretesa, sul quale avveniva la litis
contestatio. Se, infatti, vi fossero stati alcuni rapporti che prevedevano più prestazioni (ad esempio i pagamenti rateali)
e se l’attore avesse vinto la causa senza specificare nulla, l’azione si sarebbe consumata e quindi non avrebbe più potuto
essere riproposta secondo il principio di ne bis in idem.
Per ovviare a questi problemi si introdusse la praescriptio pro actore, che serviva a delimitare la pretesa attorea a quella
parte soltanto di obbligo al quale era tenuto il debitore (ad esempio l’azione veniva precluso al solo canone di maggio).
Nella formula si specificava che la litis contestatio si riteneva compiuta solo per quella parte dell’affare per la quale
fossero scaduti i termini.
La praescriptio pro actore scomparve con il venir meno del processo formulare.
La classificazione delle azioni: le azioni edittali
Nelle azioni di ius honorarium si ritrovava innanzitutto la grande categoria delle azioni edittali, le azioni concesse dal
pretore nel suo edictum. Esse potevano essere tanto azioni derivanti dall’antico ius civile (actiones stricti iuris) quanto
azioni pretorie che il pretore andava ad inserire nel suo editto.
Le azioni decretali
Le azioni pretorie non edittali, le cosiddette azioni decretali, venivano concesse dal pretore, nel singolo caso specifico,
con un atto chiamato decretum. Le azioni decretali venivano anche chiamate actiones in factum, perché si applicavano
alla fattispecie concreta. Le actiones in factum erano diverse dalle actiones con la formula in factum concepta, che erano
le azioni pretorie edittali costruite sulla base di analisi di fattispecie concrete non tutelate da ius civile.
Le azioni utili
Le actiones utilis erano anch’esse azioni decretali, ma non rappresentavano tanto una formula costituita in modo
particolare quanto una formula che veniva concessa per tutelare fattispecie già previste o dalle azioni civili o dalle azioni
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
pretorie ma che nel caso concreto mancavano di uno o più requisiti necessari per concedere la tutela. Queste azioni
venivano anche dette actiones ad exemplum, perché modellate sull’esempio di azioni già esistenti.
I giudizi di buona fede
I iudicia bonae fidei si fondavano sulla buona fede e riguardavano actiones in personam con intentio incerta e con
oportere ex fide bona (che non nasceva dal ius civile ma dalla buona fede). In questo caso al giudice venivano attribuiti
poteri amplissimi: infatti, egli poteva prendere in considerazione tutta una serie di elementi che nei giudizi non di buona
fede non poteva considerare, come i patti accessori stipulati insieme ad un patto di compravendita. Il giudice poteva
inoltre prendere in considerazione, nella fase apud iudicem, eccezioni che venissero sollevate in quel momento, dopo la
litis contestatio, e quindi non inserite nella formula. Le tipologie di eccezione che potevano essere sollevate in questa
fase erano la exceptio doli (qualora vi fosse stato dolo), la exceptio metus (nel caso di negozi giuridici il cui consenso
era stato estorto da una parte con l’uso di violenza) e la exceptio pacti (eccezione nascente da un patto). L’exceptio pacti
poteva essere sollevata dal convenuto anche per i patti che fossero stati stipulati a processo già iniziato (pacti ex
intervallo).
Dal regno di Marco Aurelio in poi il giudice poteva addirittura decidere di condannare il convenuto tramite la
compensazione debiti e crediti (il credito del creditore si estingueva in tutto, o in parte, perché da esso veniva dedotto
un credito che il debitore aveva verso di lui).
Le azioni arbitrarie
La più caratteristica azione arbitraria era la rei vindicatio, ossia l’azione a tutela della proprietà.
Le azioni arbitrarie contenevano una clausola arbitraria ed erano quasi unicamente actiones in rem. L’azione arbitraria
si caratterizzava per l’uso dell’espressione “arbitrio tuo”, e permetteva al giudice di effettuare nella fase apud iudicem
la cosiddetta pronuntiatio de iure, un ordine restitutivo (iussum de restituendo) della cosa all’attore da parte del
convenuto che, restituendola, non sarebbe stato condannato. Se il debitore non avesse voluto restituire la res, sarebbe
stato condannato ad un risarcimento pecuniario.
I praeiudicia
I praeiudicia erano azioni in cui serviva solo la intentio, perché erano azioni aventi funzione di accertamento.
Le azioni con trasposizioni di soggetti
Queste azioni avevano una struttura particolare: nella intentio veniva indicato come convenuto un certo soggetto, diverso
dal soggetto in posizione di convenuto indicato nella condemnatio. Questa situazione avveniva soprattutto quando ad
agire era un soggetto sottoposto ad una potestas altrui. Si poteva intentare l’azione contro, ad esempio, il figlio, ma la
sua capacità giuridica non piena imponeva di indicare il nome del padre, che esercitava la patria potestà, nella
condemnatio.
Le actiones adiecticiae qualitatis si inseriscono nella moderna categoria delle azioni con trasposizione di soggetti, che
era concessa a Roma antica perché si davano casi di soggetti sottoposti alla potestas del pater o al potere di un dominus
(figli, schiavi…), che avevano quindi una capacità giuridica limitata che permetteva loro di porre in essere commerci,
negozi e attività limitati (ad esempio, lo schiavo poteva gestire un’attività marittima per conto del dominus solo se
questo l’avesse autorizzato). Questa situazione si andava a riflettere sulla actio: nell’intentio della formula, l’attore che
agiva contro lo schiavo o contro il figlio faceva valere una pretesa contro questi ultimi. La demonstratio, se presente,
conteneva il nome di questi soggetti con parziale capacità giuridica. Giacché questi soggetti erano privi o con capacità
giuridica limitata non potevano rispondere in sede di condanna, ma dovevano rispondere coloro che esercitavano potere
o potestas sul soggetto.
Nella condemnatio, al nome dello schiavo o del figlio, si sostituiva quindi il nome rispettivamente del dominus o del
padre. L’eventuale assoluzione o condanna avveniva nei confronti del dominus o del pater. Ecco perché le actiones
adiecticiae qualitatis vengono definite come azioni che prevedono la trasposizione di soggetto.
Le azioni fittizie
La fictio iuris era uno strumento usato molto spesso dai giuristi romani perché consentiva di ampliare il raggio delle
tutele. Nelle azioni fittizie era quindi presente la fictio iuris, una clausola che autorizzava il giudice a ritenere avvenuta
(fictio positiva) o non avvenuta (fictio negativa) una determinata situazione al fine di poter concedere tutela nel caso
concreto all’attore.
La litis contestatio
Il processo civile romano si snodava attraverso le fasi in iure e apud iudicem. Nella fase in iure, grazie ai concepta verba,
si andava a creare la formula cercando un accordo sia su quest’ultima che sulla nomina del giudice privato. Per ovviare
alla necessità di formalizzare questo accordo, si passava attraverso la litis contestatio, che si verificava quando il pretore
ordinava alle parti di litem contestare, chiudendo la fase in iure.
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
La litis contestatio è stata oggetto di notevoli interpretazioni perché non si trova una sua vera e propria definizione nelle
fonti. È assai verosimile che le fonti che si trovano nel Digesto che riportano l’espressione litis contestatio siano state
interpolate dai giustinianei, perché i giuristi classici non avevano un’idea precisa dell’istituto della litis contestatio in sé
e per sé. Su questo concetto, però, si sono scontrate due grandi interpretazioni tra fine 1800 ed inizi del 1900: la prima
teoria, detta teoria individualistica, vedeva la litis contestatio come un vero e proprio contratto formale concluso tra le
parti, da cui nasceva l’obbligo di sottostare al giudicato per entrambe le parti (obligatio iudicati); la seconda fondava i
propri argomenti su di una concezione statualistica della litis contestatio, che voleva dare preminenza alla sua funzione
pubblicistica vista nel momento della concessione della formula da parte del magistrato (che secondo questa teoria era
un rappresentante dello Stato dalla quale volontà dipendeva la prosecuzione del processo). In questa concezione, il ruolo
delle parti passava in secondo piano. Entrambe queste teorie sono estreme: se si va a vedere le fonti si scopre infatti
come la situazione fosse più complessa.
Anzitutto, si sa che le parti dovevano effettuare una reciproca ed espressa accettazione della formula, senza particolari
formalismi (dictare et accipere iudicium). Senza il consenso delle parti, quindi, non si aveva litis contestatio. L’attore
avrebbe dovuto leggere la formula al convenuto, e quest’ultimo doveva accettarla espressamente. Il passaggio
successivo era la datio iudicii: dal magistrato derivava il cosiddetto iussum iudicandi (ordine di giudicare), l’ordine che
egli impartiva al iudex di giudicare sulla base della formula concordata tra le parti.
Secondo la definizione data da Bulgaro (glossatore vissuto tra l’XI e il XII secolo), il momento della litis contestatio
rappresentava un actus trium personarum (atto di tre persone).
Gli effetti conservativi della litis contestatio
Gli effetti della litis contestatio erano in primis di tipo conservativo: con la litis contestatio venivano fissati
definitivamente i termini della controversia di diritto sostanziale nella sua oggettività. La conseguenza era che la
posizione giuridica dell’attore sarebbe stata considerata tendenzialmente insensibile a qualsiasi variazione che fosse
intervenuta sull’originario rapporto sostanziale dopo la litis contestatio. Ad esempio, se il debitore aveva l’obbligo di
restituire un piatto d’argento all’attore, il fatto che il piatto fosse stato distrutto dopo la litis contestatio per cause non
riconducibili al debitore non avrebbe svincolato il debitore dalla restituzione: egli avrebbe dunque dovuto risarcire
l’attore con un ammontare in denaro.
Vi era però anche un altro tema, quello della soddisfazione della pretesa attorea dopo la litis contestatio: un esempio
tipico di ius controversum era dato dal pagamento spontaneo del debitore nei confronti del creditore avvenuto dopo la
litis contestatio. Infatti, la scuola sabiniana e la scuola proculiana si scontrarono sul tema (I secolo d.C.) offrendo due
interpretazioni diverse. I proculiani prediligevano un’interpretazione rigida dello ius civile, onde per cui dopo la litis
contestatio il debitore avrebbe comunque dovuto essere condannato; i sabiniani arrivarono invece a coniare il principio
secondo il cui “omnia iudicia absolutoria esse” (tutti i giudizi dovrebbero arrivare all’assoluzione), per cui se il debitore
avesse pagato dopo la litis contestatio avrebbe potuto essere assolto. Con i secoli si arrivò a far prevalere la regola
sabiniana.
Gli effetti preclusivi della litis contestatio
La litis contestatio aveva anche effetti preclusivi: non si doveva infatti dare azione per due volte alla stessa persona per
la stessa cosa e contro lo stesso soggetto, qualunque fosse stato l’esito del processo (principio del ne bis in idem). Gli
effetti preclusivi operavano già anche nelle leges actiones. Gli effetti preclusivi, nelle leges actiones, operavano ipso
iure: non serviva che le parti sollevassero un’eccezione per affermare il principio del ne bis in idem, ma la cosa doveva
essere rilevata dal giudice nell’azione successiva. Nel processo formulare, invece, l’effetto preclusivo operava ipso iure
se e soltanto se il primo processo celebrato da quelle parti su quella cosa fosse stato un iudicium legitimum relativo ad
una actio in personam con giudizio stricti iuris. In tutti gli altri casi, l’effetto preclusivo avrebbe operato ope exceptionis,
ossia doveva essere richiamato dal convenuto, caricato dell’onere di formulare l’eccezione.
Quando si parlava di medesima persona e di medesima cosa si apriva il tema dell’identificazione dell’azione sul piano
soggettivo, ossia si doveva capire se l’azione in questione fosse effettivamente uguale ad un’azione già proposta in
precedenza. Questa operazione era molto più facile se nelle due azioni si usava la stessa formula, mentre era un po’ più
complessa quando la formula usata era diversa. Il concetto di stessa cosa era ampissimo (la parola res indicava non solo
una cosa generale, ma anche un affare generale) e anche la stessa persona era difficile da individuare nel caso, per
esempio, di successori a titolo universale (che giuridicamente costituivano un’unica persona). Nel caso di pluralità di
soggetti, questo rilevava sia dal punto di vista dell’attore che da quello del convenuto: ad esempio, i comproprietari di
un fondo erano tutti legittimati ad agire o ad essere convenuti per quella proprietà. Oggi, con queste fattispecie si parla
di concorso di persone.
Oggettivamente parlando, per i giuristi non esisteva una definizione unitaria di affare o di res, ma questa andava valutata
caso per caso. Si poneva poi un altro problema, quello del concorso di azioni. Ad esempio, in caso di furto si agiva con
due azioni diverse (una di natura rei persecutoria e una di natura penale, che in Roma antica non era una azione criminale
ma rientrava nel diritto privato). L’azione rei persecutoria era volta a far sì che chi agiva riottenesse la res o il suo
equivalente in denaro, viceversa l’azione penale era l’azione con la quale si voleva fare in modo che al debitore venisse
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
erogata una pena, concetto che comprendeva in sé anche l’idea di una sanzione pecuniaria calcolata in un multiplo del
valore della cosa. Nel caso di un furto si potevano esperire entrambe le azioni per il medesimo fatto contro il medesimo
soggetto.
Viceversa, non erano cumulabili le azioni rei persecutorie con le azioni miste (che erano le azioni con le quali et rem et
pena persequimor, ossia che comprendeva già gli elementi del recupero della res e della pena).
Il cumulo era escluso anche quando per il medesimo fatto fossero date più azioni rei persecutorie, che si davano solo in
alcune fattispecie (tra cui il furto, in cui si fornivano due azioni: la condictio ex causa furtiva doveva essere rivolta
direttamente contro il ladro; la rei vindicatio agiva contro il possessore della res, anche se egli fosse stato senza colpe).
In questo caso si doveva scegliere contro chi e con quale azione agire (concorso elettivo tra azioni rei persecutorie).
Gli effetti estintivi della litis contestatio
L’effetto estintivo della litis contestatio era connesso all’effetto preclusivo, perché non potendo ripetersi l’azione il
diritto oggetto di quell’azione si estingueva, non esisteva più come rapporto sostanziale. Il diritto esisteva però in quanto
trasfuso in un rapporto di tipo processuale.
La conseguenza dell’estinzione del rapporto sostanziale sanciva la nascita di un rapporto meramente processuale tra le
parti.
La pluris petitio
Tutti questi effetti davano luogo alla consumazione processuale, che aveva rilevanza anche sotto il profilo della
cosiddetta pluris petitio (chiedere qualcosa di più). In termini generali la pluris petitio era la situazione in cui l’attore
presentasse nella formula la propria pretesa o l’obbligo del convenuto in un modo diverso dalla realtà, in modo tale da
aggravare la posizione dell’obbligato. Si poteva parlare di pluris petitio solo se l’azione aveva un’intentio certa. Si
conoscono quattro tipologie della pluris petitio: re, loco, tempore e causa.
La pluris petitio re era il caso in cui l’attore chiedesse oggettivamente più di quanto in realtà gli spettasse, ossia indicasse
l’oggetto della sua pretesa in modo più ampio di quanto effettivamente non fosse.
La pluris petitio loco si aveva allorquando si prevedeva che il debitore dovesse eseguire la propria prestazione in un
certo luogo determinato, e invece l’attore chiedeva che il debitore la eseguisse in un luogo diverso.
La pluris petitio tempore avveniva quando l’attore chiedeva l’esecuzione della prestazione prima del termine che le parti
avevano fissato oppure prima del termine che implicitamente si poteva desumere dal negozio.
La pluris petitio causa si aveva solo con due tipi di obbligazioni, le obbligazioni di genere (Tizio dà 500 sesterzi a Caio
affinché quest’ultimo gli dia tra un mese 200 chili di mele, provenienti dal suo orto o meno) e le obbligazioni alternative
(Tizio e Caio concludono una stipulatio con la quale Caio si impegna o a dare a Tizio tra un mese lo schiavo Stico o a
dargli tra un mese 1000 sesterzi). La pluris petitio si aveva quando, a fronte di un’obbligazione alternativa, l’attore
avesse chiesto che venisse eseguita una delle due prestazioni possibili non lasciando la scelta al debitore oppure quando,
a fronte di un’obbligazione di genere, l’attore avesse chiesto una prestazione specifica (le mele del campo di Caio) e
non una generale (le mele di un campo qualsiasi).
Nel corso dei secoli si pensò che l’attore che fosse incorso in una pluris petitio avrebbe perso il processo, perché
l’intentio non era fondata. Questa interpretaizone molto rigorosa cedette il passo ad una interpretazione più morbida
solo in epoca postclassica, durante la quale si prese in considerazione la base effettiva della richiesta attorea: se il
convenuto avesse dovuto pagare 5.000 sesterzi e l’attore ne avesse chiesti 10.000, il giudice avrebbe condannato il
convenuto solo al pagamento di 5.000 sesterzi.
La minus petitio
Nella minus petitio la pretesa veniva modificata al ribasso (al posto di chiedere 10, l’attore chiedeva 5): in questo caso
l’attore non avrebbe più potuto agire nei confronti del convenuto per il rimanente. Anche in questo caso il convenuto
avrebbe dovuto opporre una exceptio litis dividue, che faceva notare che su quell’affare tra i medesimi soggetti si era
già pronunciato un giudice.
L’indefensio
L’indefensio descriveva la situazione in cui il soggetto convenuto non volesse difendersi. Un soggetto si definiva
indefensus quando, a seguito di in ius vocatio, non si fosse presentato a giudizio e non avesse dato un vindex.
Una particolare fase della procedura giuridica romana era il vadimonium, un accordo con il quale le future parti del
processo concordavano di trovarsi il tal giorno alla tal ora dinnanzi al magistrato. Se il convenuto non si fosse presentato,
il vadimonium sarebbe stato definito desertum e il convenuto sarebbe stato indefensus.
Se la azione esperita era una actio in personam l’indefensus avrebbe subito la missio in bona, che concretamente
consisteva nell’entrare in possesso (fisicamente e giuridicamente) dei beni dell’indefensus. Chi entrava in possesso dei
beni di un altro soggetto sulla base della missio in bona, trascorso il tempo necessario previsto per l’usucapione, avrebbe
usucapito quei beni diventandone quindi, alla luce dello ius civile, il legittimo proprietario.
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
Nelle actiones in rem, ad esempio nella rei vindicatio, il primo passaggio che il pretore faceva sì che si verificasse era
la cosiddetta inversione del possesso della cosa: il possesso della cosa tornava all’attore che ne rivendicava la proprietà.
Se si trattava di una cosa immobile il pretore emetteva un ordine di trasferire il possesso della cosa all’attore, il cosiddetto
interdictum quem fundum. Se si trattava di una cosa mobile si arrivava allo stesso ordine attraverso l’attivazione della
actio ad exhibendum, nella quale l’attore doveva semplicemente provare che il convenuto fosse il legittimato passivo
dell’azione, il soggetto contro il quale correttamente si era rivolta la rei vindicatio. Se l’attore riusciva a provarlo, tornava
ad operare l’obbligo di restituzione della res. Se il potenziale convenuto non attendeva all’ordine del pretore,
quest’ultimo concedeva la missio in bona.
Le garanzie a carico del convenuto
Non c’era l’obbligo per le parti del processo di prestare garanzie, ma c’era la possibilità che esse si accordassero perché
il convenuto pagasse una certa somma di denaro come garanzia di arrivo alla litis contestatio. Normalmente, la garanzia
da parte del convenuto veniva data anche nei casi di convenuto potenzialmente insolvente.
L’unica forma di garanzia (in latino satisdatio, al plurale satisdationes) che entrava obbligatoriamente nel processo (in
caso di actiones in rem) era la satisdatio iudicatum solvi, che si articolava in tre clausole: ob rem iudicatam (che serviva
a garantire, eventualmente prestando dei garanti, che in caso di condanna si sarebbe pagata la somma di denaro prevista
dalla sentenza del giudice), ob rem bene defensam (che serviva per far sì che il convenuto si impegnasse ad assumere
correttamente la defensio e ad aderire alla litis contestatio) e la clausola finale, dal nome ignoto (che serviva a far sì che
il convenuto garantisse di non essersi comportato in modo doloso sino ad allora e che si sarebbe altresì astenuto dal
tenere comportamenti di natura dolosa nel corso del processo).
La rappresentanza processuale
Nel processo romano era data la possibilità sia all’attore che al convenuto di farsi rappresentare. In particolar modo nel
processo formulare si conoscono due figure principali di rappresentanza, il cognitor e il procurator ad litem.
Il cognitor era un soggetto che doveva essere nominato espressamente quale proprio rappresentante di fronte alla
controparte. Il cognitor conduceva il processo in proprio per conto della parte, perciò ci si trovava di fronte ad un caso
di azione con trasposizione di soggetti. Anche una eventuale actio iudicati che si esperiva dopo la sentenza doveva
essere esperita da o contro il cognitor, che figurava come vincitore o come sconfitto al posto della parte. Per permettere
che si agisse direttamente contro il debitore originario il pretore dava alla parte un’azione utile, modellata sulla struttura
della actio iudicati.
Il procurator ad litem, a differenza del cognitor, doveva essere nominato con un iussum o con un mandatum. Anche in
questo caso si aveva una azione con trasposizione di soggetti.
Sia il cognitor che il procurator of litem dovevano essere ritenuti idonei a postulare, ossia ad essere parti del processo,
sia in termini generali (dovevano avere un’età superiore a 17 anni, non dovevano essere sordi eccetera) che pro aliis
(dovevano essere in grado di sostenere il processo per qualcun altro: non potevano farlo i ciechi, le donne eccetera).
TERZO TIPO DI PROCESSO: LE COGNITIONES EXTRA ORDINEM
Il processo formulare rimase ufficialmente in vigore fino al 342 d.C., quando gli imperatori Costanzo e Costante decisero
di abolirlo. In precedenza, però, si registrò la nascita della nuova forma processuale del principato (che nasce con
Augusto): la forma delle cognitiones extra ordinem (processo che si sviluppa al di fuori del processo ordinario), che si
sviluppò intorno al 4-7 d.C. Questa forma processuale nacque perché un amico di Augusto, Lucio Lentulo, in un
documento detto Codicillo lasciò ad Augusto stesso dei beni, non usando la formula tipica del legato (istituto di ius
civile a mortis causa diverso dal testamento) né del testamento ma utilizzando lo strumento dei fede commessi (che era
simile al legato ma che lasciava intendere che stava alla buona fede di colui che avesse eseguito le sue disposizioni la
possibilità di dare efficacia a questi istituti), che però non era incorporato nello ius civile.
I fede commessi vennero riconosciuti extra ordinem, al di fuori delle forme dell’ordo. Augusto aveva infatti un imperium
tale da poter dare vita ad un sistema processuale totalmente nuovo, che derivava la sua efficacia proprio dall’essere un
processo legittimato dal potere imperiale.
Caratteristica centrale delle cognitiones è il fatto che esse venissero amministrate e gestite dal princeps e da tutta una
serie di funzionari che, con il nuovo sistema politico di Roma, erano inseriti in una gerarchia con al vertice il princeps.
Nell’utilizzo del processo extra ordinem sorsero anche istituti, funzionari e tribunali appositi. Ad esempio, per i fede
commessi si creò un apposito pretor fide commissarius; per tutta una serie di controversie che si fossero sviluppate nella
città di Roma sarebbe stato competente il prefettus urbi.
L’abbandono della bipartizione tra fase in iure e fase apud iudicem
Il processo per cognitiones extra ordinem non seguiva le regole del processo formulare e si svolgeva unitariamente in
un’unica fase: l’antica bipartizione tra fase in iure e fase apud iudicem scomparve. In questa fase era presente infatti un
solo soggetto (princeps, magistrato, funzionale imperiale…) che guidava da solo il processo. Venendo meno la
bipartizione del processo, la sentenza non si poneva più un parere (come era invece quella del iudex privato) ma era un
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
comando autoritativo di un organo gerarchicamente inserito nelle strutture che guidavano e che governavano Roma,
facenti tutte capo al princeps.
Questo mutamento avvenne tanto a Roma quanto nelle realtà provinciali, dove forse già prima che a Roma era iniziata
una fase di decadenza del processo formulare in quanto i governatori erano molto più liberi di scegliere come organizzare
e gestire il processo.
La contumacia
Il processo per cognitiones extra ordinem si poteva celebrare in contumacia: o l’attore o il convenuto potevano essere
assenti, con delle conseguenze diverse.
Per il convenuto non esisteva più la in ius vocatio, ma si introdussero nuove modalità di citazione in giudizio. L’attore
doveva infatti effettuare una denuntiatio, un atto di parte nel quale l’attore indicava sommariamente i punti essenziali
della questione controversa, da consegnare al convenuto con l’intervento dell’autorità pubblica degli ausiliari del
magistrato, che potevano recapitare la denuntiatio scritta al convenuto. La denuntiatio poteva anche essere eseguita
oralmente, ma per ragioni di certezza doveva essere eseguita davanti ai funzionari imperiali che avrebbero dovuto
redigerne un testo scritto con un procedimento detto testatio.
Per riconoscere la contumacia del convenuto, la citazione dello stesso doveva avvenire per tre volte consecutive e doveva
rispettare tutti i requisiti formali e sostanziali. Solo a quel punto il magistrato poteva emettere l’edictum perentorium,
un ordine rivolto al convenuto di comparire. Se il convenuto non si fosse presentato lo stesso il processo si sarebbe
aperto e si sarebbe svolto regolarmente, e la contumacia si sarebbe tradotta nella perdita del processo da parte del
convenuto, senza che l’attore avesse dovuto dimostrare la fondatezza della propria pretesa.
Se l’attore non si presentava al processo senza darne giustificazione, si aveva un semplice caso di inefficacia della
citazione che avrebbe però potuto essere ripetuta in futuro.
La mancanza della formula
Dinnanzi al magistrato delle cognitiones, il processo non era vincolato ad una formula: le parti erano libere di
argomentare e contro argomentare come meglio ritenevano; forse solo l’attore era tenuto a spiegare a quali actio aveva
fatto riferimento per attivare il processo qualora nel vecchio processo formulare ci fossero state actiones che avrebbero
potuto essere utilizzate per risolvere quel caso.
Nelle cognitiones extra ordinem potevano essere inseriti elementi che non venivano prese in considerazione nel processo
formulare: è questo il caso della compensazione.
La litis contestatio
La litis contestatio, nel processo per cognitiones, era semplicemente una scansione temporale che serviva a sancire
alcune questioni. Dopo la litis contestatio, infatti, il convenuto non poteva più proporre exceptiones e le pretese delle
parti relative a quanto richiesto dall’attore venivano fissate. Dopo la litis contestatio, inoltre, anche le azioni non
trasmissibili agli eredi diventavano trasmissibili.
La sentenza
La sentenza del giudice aveva una efficacia maggiore rispetto a quella del iudex privatus. Sebbene la condanna
maggioritaria fosse quella al pagamento di una somma di denaro, in questo tipo di processo si introdusse la cosiddetta
esecuzione in forma specifica (soprattutto nelle controversie che avevano a che fare con diritti reali). In caso di rivendica
della proprietà il convenuto, se avesse perso il processo, avrebbe dovuto restituire quella proprietà a colui che era stato
riconosciuto legittimo proprietario.
La sentenza si caratterizzava inoltre per la cosiddetta efficacia positiva del giudicato, ossia l’impossibilità di ripetere
l’azione che non derivava più dalla litis contestatio ma dalla sentenza stessa, che proveniva da un organo investito del
potere derivante dallo Stato e che quindi accertava definitivamente i termini della controversia.
L’appello
La sentenza di un processo per cognitiones extra ordinem era appellabile: di fronte alla decisione del magistrato il
convenuto condannato poteva fare appello al princeps per chiedere giustizia. L’appello non nacque ab origine con la
nascita delle cognitiones extra ordinem, ma si manifestò mano a mano e si dotò di una struttura completa solo all’età di
Adriano (II secolo d.C.). All’età di Diocleziano i gradi di appello arrivarono ad essere tre.
In origine l’appello era una misura eccezionale: si poteva ricorrervi solo se si avesse richiesto giustizia al princeps. In
seguito l’appello si istituzionalizzò e portò ad un giudizio di secondo grado che si poneva come un giudizio nuovo,
sostitutivo in toto del precedente. Il nuovo giudice non aveva limiti nella conoscenza dei fatti e nella richiesta delle
prove.
Originariamente, per chiedere l’appello bastava lamentare l’ingiustizia della prima sentenza, senza articolare i motivi
per i quali si ricorreva all’appello. Il giudice che aveva emesso la sentenza, però, aveva in questo modo un grande potere
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
discrezionale in capo alle parti in quanto la richiesta di appello andava presentata proprio a lui, e da lui poteva essere
rifiutata o accettata. Nemmeno lo stesso giudice era obbligato a motivare la scelta di concedere o meno l’appello.
L’appello andava proposto in tempi brevissimi: se lo si proponeva con il libellus (un atto scritto) vi erano circa due o tre
giorni di tempo, se lo si proponeva oralmente si doveva farlo subito dopo l’emanazione della sentenza da parte del
giudice. Se il giudice avesse voluto concedere l’appello avrebbe dovuto emanare un documento chiamato littere
dimissorie e darlo al soggetto che voleva appellare, che avrebbe dovuto agire entro un termine perentorio brevissimo
portando dinnanzi al giudice di appello le littere dimissorie.
I processi esecutivi
Nelle sentenze conseguenti a delle actiones in personam, qualora il debitore non avesse pagato il giudice avrebbe potuto
autorizzare i suoi ausiliari (i cosiddetti apparitores) a prendere in pegno uno o più beni del debitore, venderli all’asta e
soddisfare il creditore con il ricavato, rendendo l’eventuale superfluo al debitore.
Nelle sentenze conseguenti ad actiones in rem, si poteva addirittura avere un processo esecutivo manum militari, con la
forza. Se il soggetto condannato non avesse restituito la res, il giudice avrebbe mandato i suoi ausiliari dal soggetto per
impadronirsi con la forza del bene.
_______________________________________________________________________________________________
I NEGOZI GIURIDICI
Il negozio giuridico
Tra le categorie concettuali cui la dottrina fa riferimento vi è quella del fatto giuridico, che indica qualsiasi evento,
volontario o involontario, in grado di incidere sulla realtà giuridica estinguendo, modificando o creando un determinato
fenomeno giuridico. Il fatto giuridico è volontario quando c’è una azione umana che va nella direzione di modificare la
realtà giuridica, è involontario quando non dipende dall’azione umana.
Tra i fatti giuridici assumono particolare rilievo i fatti giuridici volontari, i cosiddetti atti giuridici, che possono essere
leciti o illeciti. Nell’ambito degli atti giuridici viene enucleata la categoria del negozio giuridico, che indica una
manifestazione di volontà in grado di far sorgere, modificare o estinguere delle situazioni giuridiche soggettive. La
categoria del negozio giuridico viene utilizzata perché è comoda ai fini didattici ma non è romanista in quanto nasce
con la pandettistica tedesca (XIX secolo), anche se nelle fonti giuridiche giustinianee si riscontra l’espressione negotium
iuridicum.
Il concetto di negozio giuridico non coincide con il nostro contratto, perché lo comprende ma non si esaurisce in esso.
Tra i negozi giuridici si possono individuare varie differenziazioni, di seguito elencate.
Negozi astratti e negozi causali
I negozi astratti sono validi anche in assenza di una causa, cioè della funzione economico-sociale del negozio giuridico.
I negozi causali diventano nulli in mancanza di causa.
Negozi a titolo oneroso e negozi a titolo gratuito
I negozi a titolo oneroso sono negozi in cui è presente un vantaggio dietro un corrispettivo: da un negozio a titolo oneroso
entrambe le parti derivano un vantaggio un vantaggio, che consiste per l’uno nel denaro e per l’altro nell’ottenimento
della cosa o della prestazione.
I negozi a titolo gratuito prevedono una sola delle parti abbia un vantaggio, perché non è presente il corrispettivo
(pagamento). Sono negozi a titolo gratuito i comodati.
Negozi puri e semplici e negozi a cui sono apposti degli accidentali a negozi
I negozi puri e semplici contengono solo gli elementi essenziali richiesti affinché quel negozio sia valido.
I negozi a cui sono apposti degli accidentali a negozi presentano elementi non fondamentali ai fini della validità del
negozio ma che, se inseriti, vanno rispettati. Gli accidenti sono il termine (evento futuro e certo), la condizione (evento
futuro e incerto che sospende l’efficacia del negozio giuridico nel momento in cui non si verifica) e il modus o onere
(elemento accidentale simile alla condizione che si riscontra soprattutto nei negozi giuridici successori e in atti di
liberalità, come la donazione).
Apporre un termine significa apporre un dies, che può essere un giorno o uno spazio di tempo. Il dies può inoltre essere
iniziale (quando viene inserito un giorno a partire dal quale il negozio produrrà i suoi effetti) o finale (quando indica il
giorno in cui gli effetti del negozio cessano). In latino, per indicare il termine iniziale e il termine finale venivano
utilizzate, rispettivamente, le espressioni “dies a quo” e “dies ad quem”.
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
Per quanto riguarda la condizione, le diverse condizioni si distinguono in potestative, casuali e miste.
Le condizioni potestative sono quelle il cui evento che deve avverarsi dipende da un atto volontario della persona
interessata. Le condizioni potestative possono essere positive (ti pago se vai al mercato) o negative (ti pago se non vai
al mercato). Le condizioni potestative negative hanno un problema di tempo: se il contratto è “eseguo questa prestazione
se tu non hai un determinato comportamento” non si riesce ad eseguire quella prestazione se la persona interessata è
ancora in vita. Alle condizioni potestative negative o si apponeva un termine oppure fu escogitato il rimedio della cautio
muciana, una stipulatio messa in atto per il problema delle condizioni potestative negative apposte ai legati, ossia a una
disposizione mortis causa particolare, che riguarda cioè una cosa specifica. Il legato è un soggetto che non viene
nominato erede nel testamento, ma che risulta il beneficiario di una cosa determinata. Il problema sorgeva quando il
legato era sottoposto ad una condizione potestativa negativa: morto il testatore, l’erede era incaricato di verificare il
rispetto della condizione potestativa negativa. Se non fosse stato apposto un termine si applicava la cautio muciana: il
legatario operava una promessa, con cui si impegnava con l’erede che gli avrebbe restituito quanto ottenuto a titolo di
legato se la condizione fosse venuta a mancare. La condizione apposta non deve essere impossibile né materialmente né
giuridicamente.
Le condizioni casuali sono quelle condizioni il cui avveramento dipende dal caso oppure dall’atto di un terzo.
Le condizioni miste dipendono in parte da un atto volontario della persona interessata e in parte da un evento esterno (ti
pagherò se andrai al mercato e se ci sarà bel tempo). Non sono invece ammesse le cosiddette condizioni meramente
potestative, il cui avveramento dipende dalla pura e semplice volontà della parte che ha un interesse contrario (ti pagherò
se vorrò).
Il modus, in italiano onere, consiste in un onere apposto a carico di un beneficiario di un atto di liberalità (ad esempio
la donazione). Il modus si distingue dalla condizione perché mentre quest’ultima sospende gli effetti del negozio
giuridico, il negozio con apposto il modus è immediatamente efficace.
Gli elementi accidentali non si possono inserire in quei negozi che, per il diritto romano, sono i cosiddetti atti legittimi
(con questo intendendosi i negozi solenni e formali di ius civile). Questi negozi sono la mancipatio e la in iure cessio.
La mancipatio si concludeva con una determinata messa in scena alla presenza di cinque testimoni scelti tra i cittadini
romani puberi (cioè uomini che avessero almeno 14 anni o donne che ne avessero almeno 12, l’equivalente della nostra
maggiore età), una bilancia (che serviva per pesare il metallo prezioso, spesso bronzo, utilizzato come risarcimento
prima dell’invenzione della moneta) e il libripens (colui che pesava il metallo).
L’in iure cessio veniva concluso con una scena in tribunale, in cui si doveva portare un pezzo o l’intero oggetto di cui
si contendeva. Mancipatio e in iure cessio erano negozi giuridici traslativi della proprietà, aveva effetti reali e quindi
non erano contratti.
Esisteva anche un terzo negozio traslativo della proprietà, la traditio, un negozio giuridico non formale e con causa. La
traditio consisteva in una consegna materiale della cosa e doveva avere una causa perché altrimenti qualsivoglia
consegna avrebbe fatto passare la proprietà della cosa: era quindi necessaria una iusta causa traditionis, costituita da un
contratto di compravendita.
Negozi formali e negozi non formali
I negozi formali richiedono una specifica forma, che il più delle volte è solenne.
I negozi non formali non richiedono una specifica forma ai fini della validità del negozio.
Negozi inter vivos e negozi mortis causa
I negozi inter vivos sono destinati a produrre effetti durante la vita dei soggetti che li pongono in essere.
I negozi mortis causa producono effetti dopo la morte del soggetto che ha posto in essere il negozio. Un esempio di
questi negozi è il testamento, mentre non lo è la donazione.
Negozi unilaterali, bilaterali e plurilaterali
I negozi unilaterali sono formalizzati da un’unica parte, che esercita la propria volontà.
I negozi bilaterali prevedono l’incontro della volontà di due parti per la formulazione dell’accordo. Le parti possono
anche essere formate da più soggetti, qualora essi perseguano un interesse comune (ad esempio, il mutuo viene richiesto
alla banca da marito e moglie insieme, che costituiscono un’unica parte.
I negozi plurilaterali vedono la compresenza e la collaborazione di tre o più parti.
Negozi validi e negozi invalidi
I negozi validi sono negozi che stanno in piedi in base all’ordinamento di afferenza.
I negozi invalidi non possono produrre effetti perché considerati non validi alla luce dell’ordinamento giuridico. Nel
sistema giuridico romano non esisteva il concetto di annullabilità e di nullità dei negozi, ma i negozi non regolari
venivano invalidati a prescindere, e l’invalidità era una condizione simile alla nostra nullità.
Era difficile che fosse invalidato un negozio solenne, purché si fossero rispettate le formalità prestabilite. Negli altri casi
il negozio era invalido se illecito (contra bonus mores), contrario ad una norma imperativa di legge (anche se c’erano
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
delle eccezioni, perché i romani differenziavano le leges perfecte, le leges minus quam perfecte e le leges imperfecte:
le leges perfecte prevedevano un divieto e l’invalidità del negozio giuridico che lo violava; le leges minus quam perfecte
erano leges che prevedevano un divieto e, in caso di violazione, prevedevano una sanzione ma non l’invalidità dell’atto;
le leges imperfecte prevedevano un divieto ma non prevedevano una sanzione per la trasgressione del divieto), o
nell’ipotesi in cui vi fosse un vizio del consenso (ossia a causa di errore, di dolo o di metus).
L’errore cagionava una divergenza tra ciò che veniva dichiarato e ciò che era effettivamente voluto. Poteva essere
ostativo (quando dipendeva da una svista o dalla cattiva conoscenza della lingua) o di vizio (quando incideva sul
processo formativo della volontà per cui una delle parti era convinta di circostanze che non erano vere).
Il dolo era una macchinazione altrui volta ad ingannare la parte che doveva concludere il negozio. Si distingueva tra
dolus bonus (dolo in buona fede, ad esempio la vanteria della merce che si voleva vendere esagerando le caratteristiche
del prodotto), che non pregiudicava il contratto, e dolus malus (macchinazione maligna volta ad ingannare il contraente).
In caso di dolo, l’eccezione che permetteva di paralizzare la pretesa attorea in caso di dolo era la exceptio doli. La
exceptio doli poteva essere generalis (o presentis), quando bloccava qualsivoglia comportamento doloso della parte
antagonista, oppure specialis (o praeteriti), quando il convenuto opponeva un dolo che c’era stato al momento della
stipulazione del contratto. Esisteva anche la actio de dolo che era però sussidiaria, poteva cioè essere esperita solo
quando non c’era nessuna altra azione disponibile.
Il metus era l’esercitazione della violenza.
Negozi ad effetti reali e negozi ad effetti obbligatori
I negozi ad effetti reali sono quei negozi che trasferiscono la proprietà o costituiscono diritti reali minori, che per esistere
presuppongono l’esistenza del diritto di proprietà. Un esempio di diritto reale minore è la servitù di passaggio.
I negozi ad effetti obbligatori sono negozi giuridici che fanno sorgere delle obbligazioni: in diritto romano, il contratto
(anche il contratto reale, che si perfeziona con il passaggio della cosa) non aveva mai effetti reali ma solo obbligatori.
_______________________________________________________________________________________________
IL DIRITTO DI FAMIGLIA
La persona
Nelle sue Istituzioni (libro primo, paragrafo ottavo), Gaio distinse i tre grandi argomenti del diritto romano in persone,
cose e azioni. Questa è la famosa tripartizione gaiana degli argomenti.
Quando si parla di persone, nel diritto moderno, si intendono le persone come soggetti di diritto ma si effettua una
distinzione tra le persone fisiche (gli esseri umani) e le persone giuridiche. Il concetto di persona giuridica era del tutto
sconosciuto ai romani, che viceversa avevano in mente il concetto di persona fisica. L’essere umano era persona in senso
stretto in quanto era libero. Nel libro I paragrafo IX delle Istituzioni Gaio parlava della cosiddetta summa divisio de iura
personarum: tutti gli uomini erano classificati in liberi oppure servi. A Roma, lo schiavo veniva concepito come una res.
L’evento nascita
La personalità veniva attribuita al soggetto al momento della sua nascita, che tendenzialmente veniva riconosciuta al
momento del completo distaccamento del feto dal corpo materno, a cui si doveva aggiungere l’elemento della potenziale
capacità del nascituro di condurre una vita autonoma. I giuristi romani cercavano sempre di indagare casisticamente
quando si potesse dire che il neonato fosse nato vivo o fosse nato morto. Se vi fossero stati dubbi circa la vita o la morte
del neonato, bisognava cercare di capire se vi fossero stati elementi tali a riconoscere l’avvenuta nascita e la persistenza
della vita per un tempo sufficiente all’attribuzione dei diritti soggettivi. In questo ambito si era creata una nuova
divisione tra la scuola proculiana e quella sabiniana: per i proculiani la prova della nascita veniva offerta dall’emissione
del primo vagito, mentre i sabiniani pensavano che fosse necessario un qualsiasi comportamento del nascituro che ne
potesse provare la vita. Nella costituzione imperiale conservata nel Codex, si enunciava che se ci fosse stato un
movimento oppure se il neonato avesse respirato, egli sarebbe stato considerato vivo: la visione sabiniana, quindi, ebbe
la meglio. Non si considerava nato vivo il cosiddetto portentum o monstrum, l’essere umano nato con deformità.
Il concepito
L’essere umano era oggetto di interesse giuridico al momento della nascita, ma non si escludevano casi in cui a rilevare
ai fini del diritto fosse già lo stesso concepimento. Ad esempio, in Roma esisteva l’istituto delle iuste nuptie, il
matrimonio legittimo: si aveva matrimonio legittimo quando i due soggetti che si sposavano erano liberi, romani,
adottavano una forma specifica per le nozze e vi era il connubium. Per valutare se il figlio fosse nato in un matrimonio
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
legittimo si andava a vedere il momento del concepimento. Se, dopo il concepimento, il padre fosse diventato schiavo
e le iuste nuptie si fossero rotte, la loro rottura non avrebbe influenzato lo status del figlio.
Il concepimento era fondamentale anche per capire se il nascituro avrebbe potuto ereditare da un certo soggetto: il figlio
già concepito ma nato dopo la morte del padre (postumus) entrava a far parte della successione. Poteva addirittura essere
nominato un curator ventris, che si occupava degli interessi del postumus una volta che questo fosse nato.
L’evento morte
Si doveva anche accertare l’evento morte: a differenza dei moderni, i romani non facevano ricorso alle presunzioni di
morte, salvo nel caso in cui più persone fossero morte contemporaneamente (commorienza, la giurisprudenza classica
sosteneva in questo caso che tutti i soggetti fossero morti allo stesso tempo). Caso per caso, la morte di un individuo
doveva essere provata da colui che avesse interesse a farlo con qualsiasi mezzo a disposizione. Un altro caso di
presunzione di morte si aveva con la premorienza, che si verificava quando il padre ed il figlio morivano più o meno
allo stesso tempo: in questo caso, se il figlio era impubere e senza eredi, si presumeva che egli fosse morto prima così
l’eredità del padre avrebbe potuto essere divisa tra gli altri suoi eredi.
La capacità di agire e la pubertà
Secondo il diritto civile odierno, l’individuo che nasce è dotato della capacità giuridica (attitudine di un soggetto ad
essere titolare di diritti e doveri) e della capacità di agire (attitudine che l’ordinamento riconosce ad un individuo di
porre in essere atti e negozi giuridici che producano effetti giuridici previsti dall’ordinamento stesso). Nella realtà
romana gli schiavi non erano considerati persone, ma avevano comunque una limitata capacità di agire.
La capacità di agire era connessa anzitutto alla capacità intellettuale della persona: oggi si presume che la maturità di
pensiero venga raggiunta superata una determinata età, mentre a Roma la capacità intellettuale si acquistava con la
pubertà, che si raggiungeva nell’antichità con una valutazione caso per caso tramite una inspectio corporis (tenuta valida
dalla scuola sabiniana), mentre in seguito tramite il raggiungimento di una determinata età, che per le femmine era di
12 anni e per i maschi a 14 anni (idea propria della scuola proculiana, che alla fine prevalse).
L’infante
Tra gli impuberi vi erano varie categorie: la prima era quella degli infantes (definiti da Gaio come coloro che non erano
capaci di ragionare, che “nullum intellectum habent”), considerati a Roma antica come totalmente incapaci di agire.
L’età dell’infanzia si superava, anticamente, non appena il soggetto avesse raggiunto la capacità di loqui (l’emissione
di un eloquio ragionevole e comprensibile), che andava valutata volta per volta; in età classica l’infanzia terminava una
volta raggiunto il quinto anno di età; con Giustiniano si ritenne che l’infanzia fosse superata dopo il settimo anno di età.
L’infante maior
L’impubere non infante si chiamava infante maior (plurale maiores). L’infanzia maior riconosceva ai soggetti una
limitata capacità di agire: essi potevano infatti acquistare il possesso e dall’età classica in poi vennero considerati
responsabili per gli atti illeciti che avevano compiuto, qualora si ritenesse che il loro sviluppo intellettuale fosse tale da
renderli capaci di agire con dolo o con colpa.
Gli infantia maiores potevano inoltre concludere negozi giuridici, o con l’ausilio di un tutore (che prestava la sua
auctoritas tramite la interpositio auctoritatis) oppure autonomamente. Se l’impubere infantia maior avesse concluso il
negozio sine auctoritas del tutore, su di lui sarebbero ricaduti solo gli effetti vantaggiosi del negozio, che rimaneva
valido ma si definiva claudicante perché era vantaggioso solo per uno dei contraenti. Per tutelare il soggetto contraente
che avesse contrattato con l’infante maior vennero elaborate le actiones adiecticiae qualitatis.
Il pubertati proximo
Un’ulteriore sottocategoria degli infantia maiores era infatti quella dei pubertati proximi, che erano tendenzialmente
capacies doli e capacies culpa.
Il pubere con meno di 25 anni
All’incirca nel 200 a.C. si ritenne che non fosse sufficiente raggiungere la pubertà per poter porre in essere negozi
giuridici validi, per cui la piena capacità di agire fu assegnata solo ai maggiori di 25 anni di età.
La lex laetoria stabilì a riguardo che se un individuo di età inferiore ai 25 anni avesse concluso un negozio senza
l’interpositio dell’auctoritas del tutore e se il suddetto minore fosse stato danneggiato dal negozio concluso e non fosse
stato adempiente (quindi se non avesse corrisposto la prestazione dovuta), chiamato quindi formalmente in giudizio
dalla controparte, in virtù della sua età il pretore avrebbe potuto concedergli una exceptio volta a paralizzare l’azione
della controparte.
Se fosse stato il minore a lamentare di aver subito un danneggiamento (anche in assenza di dolo da parte della
controparte) il pretore, valutata la situazione, poteva decidere di concedere la restitutio in integrum, ossia lo strumento
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
con il quale si sarebbe riportata la situazione giuridica allo status quo ante, cioè a prima che il negozio fosse stato
concluso, come se esso non si fosse mai avverato.
Con Marco Aurelio (161-180 d.C.) si decise che il minore di 25 anni avrebbe sempre dovuto essere seguito da un curator
stabile.
Il furiosus
La capacità intellettuale poteva mancare anche per ragioni diverse dall’età del soggetto: era totalmente incapace di agire
anche il furiosus, ossia la persona pazza, che se non era sottoposta alla potestà di un pater familias veniva sottoposta
automaticamente alla potestà di un curator. Al furiosus veniva equiparato colui che, pur sano di mente, per una qualche
ragione avesse momentaneamente perso l’uso della ragione. Se costui avesse posto in essere un negozio nel momento
della perdita della ragione, il negozio sarebbe stato considerato invalido.
In età giustinianea si distinse il furiosus (pazzo che aveva un qualche intervallo di lucidità, nel quale gli si riconosceva
la capacità di agire) dal demens o mentecaptus (una persona totalmente priva delle proprie facoltà mentali).
Il prodigus
Un altro motivo di parziale incapacità di agire era la condizione di prodigus, colui che sperperava il proprio patrimonio
e che così facendo rischiava di danneggiare anche la sua famiglia. Nel caso del prodigus era necessaria la formale
interdizione da parte del magistrato. Anche per il prodigus veniva nominato un curator, e se avesse agito senza la sua
interposizione avrebbe potuto concludere il negozio giuridico ma si sarebbero potute produrre nei suoi confronti solo le
condizioni favorevoli del negozio, come nel caso dell’infante maior.
La dottrina degli status
Lo schiavo non era considerato un essere umano, ma gli veniva riconosciuta una parziale capacità di agire. Lo schiavo
era sprovvisto della capacità giuridica perché questa era data (nella Roma monarchica e durante la prima repubblica) a
coloro i quali avessero i requisiti di libertà, cittadinanza e l’essere sui iuris, ossia il non essere sottoposti alla potestas di
qualcun altro.
Per comprendere questi requisiti la modernità ha elaborato la dottrina degli status: si poteva avere capacità giuridica
allorquando si possedessero lo status libertatis, lo status civitatis e lo status familiae.
A questa idea esistevano dei temperamenti, ad esempio il figlio (in età classica) poteva liberamente obbligarsi nei limiti
del proprio peculio castrense, il quantitativo di beni che aveva quando andava nell’esercito. Vi erano poi tutta una serie
di altri temperamenti, ad esempio gli stranieri potevano commerciare con i cittadini romani se ottenevano lo ius
commerci.
La status permutatio
I romani prendevano in esame i mutamenti di status (libertatis, civitatis, familiae), la status permutatio, che era
conseguenza di una capitis deminutio (diminuzione della persona in senso sia fisico che giuridico), mutamento della
condizione giuridica di un soggetto. Si distinguevano le capitis deminutio massima, media e minima: la capitis deminutio
era massima quando il soggetto perdeva la libertà, media quando perdeva la cittadinanza e minima quando si aveva una
permutatio rispetto ai vincoli familiari, ossia quando si aveva una recisione dei vincoli agnatiti (derivanti da adgnatio, il
vincolo di parentela del diritto civile romano, diverso dalla cognatio, il vincolo di sangue).
La capitis deminutio massima
Tramite la capitis deminutio massima l’individuo prima libero diventava schiavo. Le cause della schiavitù (comuni a
tutti i popoli dell’antichità) erano la nascita da madre schiava (chiunque fosse il padre) e la prigionia di guerra, che dava
luogo alla cosiddetta captivitas: se il captivus fosse stato uno straniero prigioniero dei romani diventava originariamente
una proprietà del soldato che lo aveva catturato, ma con il passare del tempo si ritenne più opportuno che il captivus
diventasse di proprietà dello Stato romano, andando a confluire nella categoria dei servi populi. Se il captivus fosse stato
un romano che diventava schiavo del nemico, per costui (in caso fosse riuscito a liberarsi e a tornare a Roma) vigeva la
regola del postliminium (o ius postliminii), per cui lo schiavo tornava ad essere libero ed ingenuo (nato libero e sempre
stato libero) come se non fosse mai caduto in prigionia. In età sillana (I secolo a.C.) si emanò una lex cornelia, che
introdusse una fictio data per ragioni ereditarie: se il cittadino romano fosse stato catturato come schiavo da un altro
popolo il suo testamento sarebbe divenuto invalido, quindi per salvaguardarlo si preferiva ritenere che il captivus fosse
morto esattamente un istante prima di perdere la libertà. La fictio era una finzione giuridica, uno strumento che si
utilizzava normalmente per ragioni di equità per correggere storture che derivavano o da una pedissequa applicazione
del ius civile o dagli effetti nturali derivanti da atti e negozi giuridici. La fictio era anche lo strumento che permetteva
di dare protezione giuridica laddove non si poteva avere per legge, e come concetto era così duttile che si trovava tanto
nelle leggi (fictio legis) quanto nelle azioni (fictio iuris).
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
Altre cause antichissime di schiavitù, questa volta caratteristiche solo di Roma erano il caso dell’incensus, ossia di colui
che non si iscriveva nelle liste del censo (redatte ogni cinque anni dai censori) e quello dell’infrequens, ossia il sottrarsi
alla chiamata alle armi.
Il debitore che non avesse pagato il suo debito poteva diventare schiavo in senso lato, ossia addictus.
Un’altra causa di schiavitù risaliva al senatus consulta dell’imperatore Claudio del 54 d.C. e prevedeva che la donna
libera che intrattenesse relazioni con uno schiavo diventasse a sua volta schiava se reiterava il suo comportamento dopo
essere stata denunciata per tre volte diverse e consecutive dal dominus dello schiavo.
Altro caso di riduzione in schiavitù era la revocatio in servitutem del libertus ingrato. Il libertus era lo schiavo liberato
che, se non avesse adempiuto a tutta una serie di compiti che aveva comunque nei confronti dell’ex dominus (diventato
patronus), poteva essere ridotto nuovamente in schiavitù.
L’ultima causa di schiavitù a Roma era, nell’età del principato, l’erogazione di una pena capitale che riduceva il soggetto
condannato alla condizione di servo della pena. Questa causa era legata al diritto criminale, e la schiavitù che comportava
non era da intendersi in senso stretto perché era molto particolare.
La capitis deminutio minima
Quando si recideva il vincolo familiare agnatitio, ossia quando cessava qualsiasi parentela civile agnatitia, ci si trovava
di fronte alla capitis deminutio minima. Questo accadeva quando un soggetto passava dallo stato di alieni iuris a quello
di sui iuris o anche quando un soggetto cadeva sotto la potestas di un altro pater (ad esempio, nel caso della moglie del
figlio di un pater familias).
Il servus
Nella realtà romana il servus era assimilato ad una res, sul quale il dominus esercitava un potere che, sino a tutto il
periodo della repubblica, era pressoché illimitato a livello giuridico: essendo di proprietà del dominus, lo schiavo era
nella piena disponibilità giuridica e materiale del padrone. Questa piena disponibilità si riassumeva nel cosiddetto ius
vitae ac necis (diritto di vita e di morte), che comportava (in termini astratti) che il dominus potesse mandare a morte lo
schiavo quando voleva. Questo comportamento veniva tuttavia percepito come eccessivamente arbitrario anche nella
società arcaica, nella quale il controllo maggiore sul dominus era esercitato dalle altre familiae, che lo avrebbero colpito
con un forte stigma sociale se avesse mandato a morte il servus senza un motivo effettivo. Già a partire dalla media
repubblica subentrò inoltre il regimen morum dei censori, il controllo che essi potevano esercitare sui comportamenti
dei cittadini secondo criteri etici. I censori avevano il potere di erogare l’infamia per comportamenti ritenuti contrari ai
valori del tempo. Il regimen morum consentiva quindi di temperare il potere del dominus. Nel principato, con lo sviluppo
delle cognitiones, si tendeva non solo a reprimere penalmente la messa a morte dello schiavo senza validi motivi ma
anche a colpire i casi di sevizia, al punto che se il padrone se ne fosse macchiato avrebbe potuto essere costretto a
vendere il servo. Si cominciò a reprimere anche la morte dello schiavo a causa delle sproporzionate punizioni corporali
inflittegli dal padrone.
Lo schiavo aveva una totale incapacità di essere soggetto a diritti ed obblighi sul piano del diritto privato e a livello
processuale. L’incapacità dello schiavo a livello processuale interessava in particolar modo allorquando si fosse in
dubbio se colui che veniva ritenuto schiavo fosse invece libero. Nei tempi più remoti, per verificare se la persona fosse
libera o schiava si doveva esercitare una legis actio sacramento in rem, nella quale le parti in gioco erano il presunto
proprietario e un soggetto che volesse dichiarare la libertà della persona. Questo soggetto prendeva il nome di adsertor
in libertatem e rivendicava a sua volta la proprietà dello schiavo: se avesse vinto l’adsertor in libertatem, egli avrebbe
di fatto emancipato lo schiavo oppure avrebbe rinunciato alla sua proprietà. Si poteva agire anche con l’agere per
sponsionem fino a quando, nel processo formulare, non entrò in gioco il praeiudicium an liber sit, un’azione con una
formula che si componeva della sola intentio. Serviva sempre un adsertor in libertatem che attivasse il praeiudicium.
Dal punto di vista della parentela, lo schiavo era privo dei vincoli che rilevavano per il ius civile, i vincoli agnatiti, ma
aveva solo vincoli di sangue (cognatio), che rilevavano solo in casi particolari puniti dal diritto criminale (come
l’incesto).
Se lo schiavo commetteva dei delicta (illeciti di diritto privato) entrava in gioco il principio della nossalità: dal momento
che lo schiavo non poteva rispondere per l’illecito compiuto, ne veniva chiamato a rispondere il suo proprietario. Il
proprietario aveva due alternative, o si difendeva ed eventualmente subiva la condanna oppure dava a nossa (noxae
deditio) lo schiavo a colui che aveva subito il danno.
Sul piano patrimoniale lo schiavo poteva compiere determinati negozi ad effetti nei confronti dei terzi, che avevano nei
confronti dello schiavo solo effetti di natura favorevole (negozi claudicanti). Per porre rimedio a questi negozi il pretore
introdusse le actiones adiecticiae qualitatis, che si davano per i rapporti tra un filius sottoposto alla potestà del pater e
un terzo oppure tra un servo sottoposto al dominio del dominus e un terzo.
Le manumissiones civili
Il modo principale per riacquistare la libertà si chiamava manumissio. Già dal periodo della prima repubblica esistevano
tre manumissiones: la manumissio vindicta, la manumissio testamento e la manumissio censu. A seguito di una di queste
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
tre manomissioni, il soggetto manomesso acquistava la libertas ex iure quiritium, una libertà piena alla quale si
affiancava la cittadinanza.
La manumissio vindicta era un caso di applicazione di strumenti processuali al di fuori dal processo: questa manumissio
constava infatti dell’utilizzo della in iure cessio. Il proprietario dello schiavo, lo schiavo e un adsertor in libertatem
(soggetto terzo) dovevano incontrarsi davanti ad un magistrato. L’adsertor in libertatem esercitava una vindicatio in
libertatem, con la quale rivendicava che lo schiavo fosse libero. Il proprietario dello schiavo taceva e il pretore passava
direttamente alla addictio dello schiavo, la cosiddetta addictio secundum libertatem, che aveva valore costitutivo e
attribuiva immediatamente la libertà allo schiavo. La manumissio vindicta era un atto legittimo, non tollerava quindi
l’apposizione né di condizione né di termine.
La manumissio testamento consisteva nell’inserimento nel testamento di una formula secondo la quale risultasse che,
all’apertura del testamento, lo schiavo sarebbe stato liberato. Si doveva utilizzare una formula precisa, che normalmente
recitava “Sticus servus meus liber esto”. A questa manumissio si potevano apporre sia termine sia condizione.
La manumissio censu avveniva durante il censimento romano (che si svolgeva ogni cinque anni), quando lo schiavo,
dietro autorizzazione del dominus, si recava presso i censori e chiedeva, con una dichiarazione chiamata professio, di
essere iscritto come cittadino e libero alle liste del censo.
Nel principato scomparve del tutto la manumissio censu e si semplificarono gli altri due tipi di manumissiones civili:
nella manumissio testamento non era più presente una formula rigida da rispettare, mentre nella vindicta non era più
necessaria la presenza dell’adsertor in libertatem perché il dominus si recava semplicemente davanti al pretore,
pronunciava una formula liberatoria tipica e, con l’atto dell’impositio vindictae, liberava lo schiavo.
Le manumissiones pretorie
Già dal I secolo a.C. vennero istituite altre forme di manumissiones, che davano una libertà di fatto allo schiavo ma che
non valevano per ius civile. Se il padrone, dopo queste manumissiones, avesse rivendicato la proprietà dello schiavo, il
pretore dava tutela alla libertà di fatto dello schiavo negando l’azione al dominus. Sempre per tutelare i liberti, nel 19
a.C. venne promulgata la lex iunia norpana, che attribuiva una sorta di status libertatis agli schiavi liberati, chiamati
latini iuniani (persone libere ma sprovviste di cittadinanza).
Le manomissioni libere dalla forma presero il nome di manomissioni pretorie. Le manomissioni pretorie potevano essere
eseguite nei modi più svariati: per epistulam (lo schiavo veniva liberato tramite la stesura di una lettera da parte del
dominus), inter amicos (il padorme si trovcava di fronte a cinque amici, che fungevano da testimoni, e pronunciava
parole con le quali dichiarava di voler liberare lo schiavo), solo per citarne alcune.
Nel IV secolo d.C. cominciarono a comparire tutta un’altra serie di manumissiones, tra le quali la più caratteristica era
la cosiddetta manumissio in ecclesia, che poteva avvenire in qualsiasi luogo di aggregazione della comunità cristiana: il
proprietario vi portava il proprio schiavo e, con la massima libertà di forma, poteva dichiararne la libertà. In questo
modo lo schiavo otteneva sia la libertà che la cittadinanza. In questo momento, però, la cittadinanza romana non aveva
lo stesso valore che aveva nella Roma del II o I secolo a.C. perché era già intervenuta la costitutio antoniana, una
costituzione imperiale del 212 d.C. di Antonino Caracalla con la quale si attribuì la cittadinanza a tutti i sudditi
dell’impero ad esclusione di gruppi molto piccoli di soggetti (tra cui i latini iuniani che avessero violato determinate
regole di comportamento). L’estensione della cittadinanza produsse uno schiacciamento di tutti i sudditi dell’impero
rispetto ad un potere totale quasi assoluto del princeps.
Le problematiche della manomissione
Vi erano anche tutta una serie di problemi legati alle manomissioni: molto spesso si liberavano gli schiavi per la loro
fedeltà oppure li si liberava come membri di bande armate che lottassero contro le bande armate di altri soggetti (come
nel caso dello scontro tra Mario contro Silla: prima che Silla ottenesse il potere, tanto Mario ed i suoi seguaci quanto
Silla ed i suoi seguaci fecero ricorso agli schiavi liberti affinché combattessero al loro fianco). La manomissione degli
schiavi portava poi ad un impoverimento del patrimonio del dominus; inoltre, per i più accaniti sostenitori della romanità
(come Catone) dare la cittadinanza agli schiavi significava introdurre elementi estranei nella civiltà romana.
Nell’età di Augusto vennero emanate delle leggi per cercare di limitare le manomissioni: una legge del 2 a.C., la lex
fufia canina, impose che si potessero manomettere un numero massimo di schiavi comunque non eccedente i 100, inoltre
la manomissione doveva essere nominatim, ossia era necessario indicare il nome esatto dello schiavo da manomettere e
non si poteva procedere a manomissioni generiche.
Nel 4 d.C. venne emanata anche una lex aelia sentia, con la quale si vietava che venissero manomessi schiavi di età
inferiore a 30 anni e che un minore di 20 anni potesse manomettere i suoi schiavi. La manomissione effettuata da un
minore di 20 anni poteva essere concessa solo in alcuni casi e solo dopo l’istruttoria di un apposito consilium presieduto
da un magistrato, che avrebbe dovuto fornire un’autorizzazione alla manomissione.
In ogni caso, veniva vietata ogni forma di manomissione operata in frode ai creditori. La valutazione veniva fatta ex
post (dopo l’avvenimento della manomissione); se fosse risultato che la manomissione era stata fatta in frode ai creditori,
l’atto veniva reso nullo.
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
Gli schiavi che durante la loro schiavitù avessero subito pene infamanti non avrebbero potuto ottenere la cittadinanza
dopo la manomissione, ma sarebbero stati dei soggetti nullius civitatis. Per rimanere libera, una persona nullius civitatis
avrebbe dovuto rispettare la regola di non entrare entro il perimetro di 100 miglia (il miliarum) che si estendeva intorno
a Roma; se l’avesse fatto, il nullius civitatis sarebbe diventato servus publicus, un servo del popolo romano.
Il liberto
Lo schiavo manomesso diventava un liberto. Il liberto veniva tenuto distinto dall’ingenuo, ossia colui che nasceva libero
e che non aveva mai perso la sua libertà. L’imperatore stesso, nel principato, poteva però intervenire previa ricevimento
di una petizione affinché il liberto fosse equiparato ad un ingenuo: per farlo, occorreva un atto che si chiamava restitutio
natalium.
Il liberto possedeva dei doveri verso il suo patronus, colui che l’aveva liberato, e se questi doveri non fossero stati
rispettati il patronus avrebbe potuto richiedere la revocatio in servitutem del liberto ingrato.
Tra i vari doveri che caratterizzavano il rapporto di patronato vi erano anche dei divieti (ad esempio, il liberto non poteva
citare in giudizio il proprio patronus senza aver prima ottenuto una autorizzazione dal magistrato) e doveri di carattere
personale (ad esempio il cosiddetto obsequiuum, che si traduceva in alcuni comportamenti che il liberto doveva tenere
nei confronti del patronus). Il patronus poteva esercitare sul liberto anche dei poteri di natura disciplinare, ma non poteva
esercitare il ius vitae ac necis.
Vi erano anche dei doveri di natura patrimoniale: il liberto poteva essere tenuto a svolgere le cosiddette opere. Inoltre,
se fosse morto senza lasciare eredi, metà del patrimonio del liberto sarebbe andato al patronus.
Il liberto presentava inoltre una serie di incapacità, innanzitutto di diritto pubblico: egli non poteva accedere al cursus
honorum, non poteva entrare a far parte dell’ordine senatorio, non poteva accedere all’ordine equestre (l’ordine
immediatamente inferiore al senatorio; al liberto venne permesso di accedervi solo dall’età del principato) e non poteva
contrarre matrimonio con persone appartenenti all’ordine senatorio.
Le situazioni paraservili
Nella società romana era presente anche tutta una serie di situazioni paraservili, ossia di situazioni che presentavano dei
caratteri di libertà uniti a dei caratteri di schiavitù.
Le persone cosiddette in causa mancipii o in mancipio (vendute cioè dal pater familiae nell’esercizio del suo ius
vendendi) erano sottoposte contemporaneamente alla potestas del pater familias e alla causa mancipii rispetto
all’acquirente (anche se la potestas ed i vincoli agnatiti rimanevano quelli che già erano presenti con il pater familias
originario). Questi soggetti mantenevano la cittadinanza e la libertà, avevano capacità quanto ai rapporti personali ma
non erano totalmente capaci quanto ai rapporti patrimoniali.
Vi erano poi le figure dei debitori addicti, di cui si è già parlato.
Dall’età di Diocleziano in poi emerse inoltre la particolare figura conosciuta come colonato, un istituto che vincolava le
i soggetti al loro lavoro, imponendo anche la necessità dell’ereditarietà del lavoro stesso. Si cominciò soprattutto a legare
il coltivatore della terra al proprio fondo. Il colonato tardo antico si pose alla base del suo corrispettivo nell’età
intermedia e, soprattutto, della servitù della gleba. Il colonato nacque modellandosi sulla struttura di un contratto, la
locatio conductio, ma il rapporto che lo caratterizzava era perpetuo e creava un vincolo giuridico tra colono e terra.
Colui che dava la terra al colono chiedeva in cambio un corrispettivo in denaro o in frutti della terra. Con il tempo,
quello di colono divenne un vero e proprio status personale, che si otteneva con la nascita ma poteva anche essere
assunto liberamente da chi lo volesse. Anche lo Stato poteva obbligare dei soggetti a diventare coloni dell’impero. La
capacità del colono dal punto di vista personale e patrimoniale veniva generalmente riconosciuta, però il proprietario
della terra esercitava su di lui un potere pressoché assoluto.
Da ultime, diventarono condizioni paraservili quelle dei decuriones e dei curiales (coloro che governavano le piccole
comunità locali), cariche che diventarono obbligatorie ed ereditarie così come quelle degli appartenenti alle corporazioni
(come quella dei fabbri).
Lo status civitatis
Lo status civitatis presupponeva il possesso della cittadinanza romana da parte del soggetto, la sua perdita corrispondeva
alla capitis deminutio media. Nei tempi più antichi la cittadinanza era necessaria per essere capaci giuridicamente, ma
già in età repubblicana la qualità di cittadino contraddistinse più generalmente il soggetto in grado di godere del ius
civile.
Vi erano dei temperamenti alle rigidità nascenti dai diritti legati alla cittadinanza, dettati dai contatti con le altre
popolazioni anzitutto della penisola italica. Innanzitutto si era data la possibilità di riconoscere il matrimonio tra un
cittadino romano e uno straniero, tramite la concessione del ius conubii. Il ius conubii rilevava soprattutto dal lato
maschile, perché se era un uomo romano a sposare una donna straniera e questa donna aveva il conubium, il figlio nato
da questa unione sarebbe stato libero, legittimo e cittadino; viceversa, se la donna romana sposava un uomo strainero
con conubium, il vincolo legittimo si riconosceva secondo l’ordinamento giuridico del marito.
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
Un altro ius molto importante che spesso veniva riconosciuto agli stranieri era il commercium o ius commercii. Il
commercium non consisteva solo nell’autorizzazione per gli stranieri di commerciare con i romani, ma dava anche la
possibilità agli stranieri non romani di compiere i gesta per aes et libram.
L’acquisto della cittadinanza
La cittadinanza si acquistava anzitutto per nascita: fino al I secolo a.C., se un bambino nasceva da un matrimonio
riconosciuto e da padre romano era un cittadino romano; se il figlio fosse nato fuori dal matrimonio avrebbe ottenuto la
cittadinanza della madre. Nel I secolo a.C. una lex dispose che il figlio di una donna romana e di uomo straniero doveva
avere sempre la cittadinanza del padre.
Otteneva la cittadinanza anche il servo mancipato.
La cittadinanza venne attribuita anche ad intere popolazioni: nel I secolo a.C., dopo la guerra sociale (che frappose
Roma a tutte le popolazioni sue alleate), venne data la cittadinanza anche ai latini.
Nel 212 d.C., con la costitutio antoniniana, la cittadinanza venne estesa a tutti gli abitanti dell’impero ad eccezione di
piccoli gruppi dei latini iuniani.
La perdita della cittadinanza
La cittadinanza si perdeva quando si fosse persa la libertà.
Molto problematica era la questione della doppia cittadinanza: da Augusto in poi si poteva avere contemporaneamente
la cittadinanza romana e quella di un altro popolo; prima, l’acquisto della cittadinanza di un altro popolo faceva perdere
quella romana.
Dall’età di Silla fece perdere la cittadinanza anche il cosiddetto esilio volontario, strumento con il quale ci si sottraeva
alla pena di morte.
In età imperiale si perdeva la cittadinanza anche se si fosse subita la pena della deportatio.
La struttura della familia romana
La familia romana classica si chiamava familia proprio iure. Nella familia proprio iure l’unico soggetto di diritti era il
pater familias, mentre tutti gli altri soggetti della familia erano sottoposti alla sua potestas. Il pater familias poteva
esercitare il ius vitae ac necis nei confronti dei membri della sua familia.
Poteva far parte della familia sia il soggetto nato da iustum matrimonium sia un soggetto nato esternamente ad essa (ad
esempio colui che veniva adottato). La più antica forma di adozione ideata a Roma era la adrogatio, mentre una forma
di adozione più recente era costituita dalla adoptio. Anche la conventio in manum della moglie, che avesse contratto con
determinate modalità il matrimonio con un figlio di pater familias, sarebbe stata soggetta ai vincoli agnatiti della familia.
La potestas del pater terminava alla morte del pater stesso. I figli diventavano allora sui iuris (non sottoposti a nessuna
potestà), mentre prima erano alieni iuris (cioè sottoposti alla potestas del pater).
Il filius
Nella familia il figlio maschio rivestiva un ruolo importante anzitutto perché, pur con qualche diversità giuridica, la sua
posizione era in qualche modo simile a quella dello schiavo, a causa dei poteri che il pater poteva esercitare nei suoi
confronti. Il pater poteva inoltre vendere il figlio con mancipatio attraverso il ius vendendi. Nel tempo vennero introdotti
una serie di temperamenti al potere del pater, come avvenne nel caso dello schiavo.
A differenza dello schiavo, il figlio era anzitutto capace dal punto di vista sacrale ed era comunque civis romanus, poteva
quindi partecipare sia alla vita religiosa che alla vita politica di Roma (potendo prendere eventualmente parte anche al
cursus honorum, la carriera politica, da cui venivano tendenzialmente escluse le donne). Il filius poteva inoltre decidere
di contrarre matrimonio, ma solo con il consenso del pater familias. Se il filius aveva a sua volta figli, questi erano
sottoposti alla potestas del nonno.
Anche per il filius valevano dei vincoli pesanti dal punto di vista dei diritti patrimoniali: nella Roma arcaica il figlio era
incapace di obbligarsi in qualsiasi modo, in seguiti cominciarono però a svilupparsi casi di responsabilità adiecticiae,
nella quale il figlio poteva contrarre taluni negozi subendone solo gli effetti favorevoli. Dall’età di Augusto, il filius
poté disporre del peculium castrense, patrimonio composto da tutti quei beni prima ottenuti e poi eventualmente
acquistati dal filius durante il servizio militare, sui quali beni egli aveva una piena capacità di disporre. Dall’età di
Costantino il peculium castrense fu affiancato dal peculium quasi castrense, acquistato durante il servizio ecclesiastico
o tramite attività di tipo burocratico. Il peculium profecticium era invece il patrimonio che veniva concesso dal pater al
filius, il quale poteva utilizzarlo limitatamente.
Nell’età di Vespasiano c’era stato un caso eclatante di un filius che aveva chiesto un prestito di denaro al pater e poi
l’aveva ucciso per non dovergli più rendere i soldi prestati. Venne quindi emanato il senatus consulta macedoniano, che
introduceva il divieto per il pater (e anche per i terzi) di prestare denaro ai figli, a patto che non intervenissero
autorizzazioni particolari davanti al magistrato.
L’acquisizione della patria potestas per nascita
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
Il pater acquistava la patria potestas alla nascita del figlio concepito in iustum matrimonium. Il pater poteva rifiutare di
riconoscere il figlio tramite l’esercizio del ius exponendi.
Se il figlio fosse nato fuori da iustum matrimonium sarebbe stato un cosiddetto vulgo conceptus, un figlio sui iuris in
quanto non sottoposto ad alcuna potestas.
La adrogatio
Un altro modo per acquistare la patria potestas era l’adozione, che in Roma antica si suddivideva in adrogatio ed adoptio.
L’adrogatio era la forma più antica di adozione e consisteva nell’acquisto della patria potestas da parte di un pater
familias su un altro pater familias. La adrogatio si doveva svolgere dinnanzi ai comitia curiata, le assemblee del popolo
romano, alla presenza del pontifex maximum, la massima carica religiosa di Roma.
Il senso della adrogatio risiedeva nel fatto che il pater adottante volesse trovare nell’adrogato un erede legittimo, che
quindi avrebbe non solo ereditato i suoi beni ma avrebbe anche perpetuato la vita della famiglia dell’adrogante, non solo
per scopi sociali ma anche religiosi, sacrali. Originariamente, l’adrogante poteva scegliere qualunque altro pater per
farlo entrare nella sua familia; l’unica possibilità di negare la adrogatio spettava al pontifex maximum. Il veto del
pontifex maximum cominciò a dar vita ad una serie di vincoli per l’adrogatio: per esempio, non si concedeva adrogatio
se l’adrogante avesse già dei discendenti legittimi oppure se l’adrogante fosse stato più giovane della persona adrogata.
A partire dal III secolo d.C. l’adrogatio poteva essere eseguita solamente previa richiesta dell’imperatore, che avrebbe
risposto alla richiesta dell’adrogante tramite la costituzione tipica del rescripta.
Colui che effettuava l’adrogatio subentrava con una successione universale inter vivos nel patrimonio di colui che era
stato adrogato e nel contempo ne acquistava la potestas. L’adrogato subiva una capitis deminutio minima, che
comportava che i suoi debiti risultassero estinti. Per tutelare i creditori di un adrogato si sviluppò una tutela pretoria che
riconosceva delle azioni in loro favore oppure che prevedeva che il pretore, a fronte di una frode palese nei confronti
dei creditori, potesse concedere loro la restitutio in integrum.
La adoptio
La adoptio era l’acquisto della patria potestas da parte di un pater familias su un filius. Solo dalle Dodici tavole in poi
si riuscì ad applicarla, perché una regola delle Dodici tavole facente leva sullo ius vendendi individuò lo strumento per
procedere all’adoptio. Il pater aveva infatti il diritto di vendere il figlio, quindi la giurisprudenza pontificale elaborò una
teoria secondo la quale, se il pater vendeva il figlio per tre volte consecutive, egli perdeva la potestà e il figlio poteva
essere adottato.
L’istituto dell’adoptio si suddivideva in due fasi. Nella prima fase il pater vendeva il figlio per tre volte (tramite
mancipatio) ad un soggetto di fiducia. All’estinzione della patria potestas iniziava la seconda fase, nella quale il pater
venditore usava l’istituto della in iure cessio, un’applicazione negoziale della legis actio sacramento in rem: si prendeva
la struttura della legis actio, la si svolgeva come se ci si trovasse in un processo senza però passare alla fase apud
iudicem. In questo caso, l’adottante affermava davanti al magistrato che il figlio fosse suo; il pater taceva anziché
eccepire la controvindicatio e il magistrato operava l’immediata addictio del figlio all’adottante, che ne acquistava la
patria potestas. Stando a Gaio pare che, in realtà, fosse sufficiente effettuare una sola mancipatio e non tre mancipationes
consecutive qualora il figlio fosse stato di sesso femminile.
Poteva effettuare l’adozione il maschio pubere cittadino romano di età non inferiore a quella dell’adottato. Si poteva
adottare qualsiasi persona che fosse alieno iuris subiecta. In età giustinianea si ammise anche la donazione del servo.
L’adottato manteneva con la famiglia di origine soltanto i vincoli di sangue, la cognatio.
Nel III secolo d.C. la procedura della adoptio si semplificò sensibilmente perché sarebbe bastato che l’adottante
effettuasse una dichiarazione di adozione davanti al magistrato e al padre e che l’adottato non contraddicesse le
dichiarazioni dell’adottante. Dall’età giustinianea in poi, l’unica forma di adozione utilizzata rimase la adrogatio, intesa
come una forma generalizzata di adozione.
L’estinzione della patria potestas
La patria potestas si estingueva alla morte del pater, con l’emancipazione di uno dei soggetti sottoposti, con l’adozione
da parte di un altro pater o con la conventio in manum.
Nel caso dell’emancipatio si faceva ancora ricorso alla regola della triplice vendita del filius; dopo la terza volta la patria
potestas veniva estinta e il pater continuava a detenere soltanto il mancipium sul filius, il quale poteva essere manomesso
dal pater e diventare sui iuris. Anche nel caso del figlio manomesso i debiti si estinguevano e anche in questo caso il
pretore valutava la condizione per decidere se concedere o meno azioni contro l’emancipato.
Il matrimonio cum manu
La forma di matrimonio più conosciuta a Roma era il iustum matrimonium: la moglie entrava a far parte della famiglia
del marito con la conventio in manum. Il matrimonio cum manu era una condizione giuridica. Se la moglie sposava un
uomo alieni iuris subiectum, ella ricadeva sotto la potestas del pater potestas; se il marito era sui iuris la moglie cadeva
sotto la manus del marito, ossia sotto la sua potestas. In ogni caso, la moglie entrava nella famiglia del marito loco filiae,
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
cioè in posizione di figlia del marito. Per aversi iustum matrimonio cum manu i soggetti dovevano essere cittadini, liberi,
puberi, sani di menti e non imparentati né per cognatio né per agnatio. I soggetti dovevano poi essere dotati di conubium:
il ius conubii era una sorta di antico diritto appartenente ai patrizi che gli permetteva di contrarre legittimamente
matrimonio; con le proteste plebee e con una legge del 445 a.C. il conubium venne riconosciuto anche ai plebei. Anche
gli stranieri potevano in certi casi vedersi riconosciuto il conubium.
Si aveva conventium in manum con l’uso di determinate forme di matrimonio: la confarreatio (rito religioso alla
presenza del pontifex maximum e di un sacerdote; il tutto si concludeva con l’offerta di una focaccia di farro a Giove),
la coemptio (forma di immaginaria venditio, che si realizzava tramite mancipatio immaginaria della donna) o l’usus
(istituto che in sé e per sé non dava vita ad un matrimonio ma che consisteva in una situazione di fatto e di diritto che
sanava eventuali vizi della coemptio tramite la convivenza tra uomo e donna in condizione di matrimonio per almeno
un anno ininterrotto; le tre notti trascorse fuori dalla casa maritale da parte della donna – trinoctium – interrompeva
l’usus, che doveva essere ripreso da capo).
In epoca imperiale la manus cominciò a perdere importanza come concetto; nel tardo antico, sebbene restò ferma l’idea
che l’affectio maritalis (ossia la volontà reciproca e durevole dei coniugi ad essere marito e moglie, prestata in modo
efficace e chiaro) potesse essere esposta liberamente, venne spesso richiesta la forma scritta. Sotto l’influenza cristiana
ci furono molti interventi imperiali per limitare lo scioglimento dei rapporti matrimoniali essenzialmente solo alla morte
di uno dei due coniugi. Si cominciò anche ad impedire il matrimonio a coloro che avevano preso gli ordini sacri.
Il matrimonio sine manu
Il matrimonio sine manu era un matrimonio in senso stretto. Il presupposto per avere matrimonio era innanzitutto
l’affectio maritalis: se vi era affectio maritalis era presente il presupposto fondamentale per avere matrimonio. La manus
era invece la condizione giuridica che caratterizzava la posizione del luxor, della moglie. In questo senso si poteva
concepire il matrimonio (in questo caso sine manu) come esistente anche in assenza di manus sulla moglie.
Per rendere chiaro il rapporto di coniugio il marito poteva portare la moglie a casa sua (deductio in domun mariti). Il
marito doveva comportarsi con la sposa in un modo diverso da come si comportava con la concubina: il concubinato
era infatti un rapporto tra uomo e donna che volevano instaurare una unione duratura, senza però la presenza della
affectio maritalis. I figli nati dal concubinato erano liberi naturales, ossia erano figli naturali e non legittimi: non si
creavano quei diversi rapporti agnatiti tra la moglie e la famiglia del marito.
Gli sponsalia
Prima del matrimonio avvenivano gli sponsalia, il fidanzamento ufficiale, che nella Roma antica avveniva con una vera
e propria sponsio. In forza degli sponsalia il futuro coniuge che non avesse più voluto contrarre matrimonio avrebbe
dovuto pagare all’altro una somma di denaro.
Nel periodo classico gli sponsalia non ebbero più rilevanza giuridica, ma recuperarono importanza nella tarda età
classica. In particolare, giocò un ruolo importante la arrha sponsalica (l’arrha era un concetto di derivazione greca che
sta alla base del moderno concetto di caparra), una somma di denaro che il fidanzato dava alla fidanzata (o al di lei
padre) che veniva incamerata nel caso in cui il fidanzato non avesse più voluto sposarsi e veniva restituita in un suo
multiplo se era la fidanzata a non volersi più sposare.
La lex iulia papia poppea e la lex iulia de maritandis ordinibus
Augusto (noto per essere stato il primo princeps romano e perché si distinse per il suo tentativo di correzione dei costumi
della Roma antica facendo dell’adulterio un crimine e restituendo gli antichi mores anche tramite la sua legislazione
relativa alle disposizioni matrimoniali) emanò due leges che spesso sono citate come un’unica lex, la lex iulia papia
poppea (9 d.C.), preceduta nel 18-17 a.C. dalla lex iulia de maritandis ordinibus. Per la prima volta, con queste leggi, a
Roma si cominciò a regolare la vita privata dei soggetti.
Tra le regole principali introdotte dalle due leges vi era quella secondo cui gli uomini tra i 25 e i 60 anni e le donne tra
i 20 e i 50 anni dovevano necessariamente sposarsi, o risposarsi nel caso fossero divorziati o vedovi. Se non lo avessero
fatto, avrebbero subito tutta una serie di svantaggi patrimoniali e fiscali e i loro beni, alla loro morte, sarebbero diventati
dei caduca (beni di proprietà di nessuno che il fisco imperiale si sarebbe potuto accaparrare). C’erano però delle
esenzioni da questi obblighi, ad esempio nel caso della donna che, precedentemente sposata in un matrimonio rispettoso
dei criteri dati dalla legislazione augustea e divenuta poi vedova, non si sarebbe dovuta risposare se dal precedente
matrimonio avesse avuto almeno tre figli.
C’erano anche delle limitazioni alla possibilità di contrarre matrimonio: gli ingenui (persone libere e cittadine) non
potevano contrarre matrimonio con donne di dubbia fama; i senatori e i loro discendenti non potevano sposarsi con
attrici o liberte.
Lo scioglimento del matrimonio
Il matrimonio si scioglieva alla morte di uno dei coniugi, quando interveniva una capitis deminutio massima e forse
anche quando interveniva una capitis deminutio media (in molte fonti sembra che questa capitis deminutio non
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
comportasse lo scioglimento del matrimonio salvo nel caso in cui essa dipendesse dall’irrogazione della pena della
deportatio, una sorta di esilio forzato in un luogo remoto), per il venir meno dell’affectio maritalis (che doveva risultare
da un accordo tra le parti, una sorta di divorzio consensuale), in caso di repudium (che consisteva nella dichiarazione
unilaterale e recettizia di uno dei due coniugi che volesse ripudiare l’altro coniuge; era possibile farlo solo per motivi
molto gravi come la sterilità o tramite difarreatio, atto contrario alla confarreatio).
Nel periodo tardo antico il repudium venne regolato in maniera più precisa indicando delle forme specifiche per
esercitarlo (redigendo per esempio un libellus). Nell’età di Giustiniano il repudium venne limitato solo a casi gravissimi.
In età giustinianea lo scioglimento del matrimonio divenne difficilissimo per l’influenza cristiana e per lo sfavore
sentitissimo nei confronti delle seconde nozze.
Le actiones adiecticiae qualitatis
Le actiones adiecticiae qualitatis erano uno strumento di diritto onorario nato originariamente per correggere lo ius civile
romano per quanto riguardava la condizione degli schiavi (al contempo trattati come res e come persone, che potevano
porre in essere negozi in ambito mercantile che potevano danneggiare in qualche modo i terzi), che poi venne esteso
anche al caso del figlio. Queste actiones erano uno degli esempi più noti di azioni con trasposizione di soggetti: nella
intentio c’era il nome del soggetto agente (schiavo o filius), nella condemnatio c’era il nome del dominus o del pater.
Questa formula particolare si spiega in ragione della capacità giuridica in teoria inesistente o fortemente limitata sul
piano patrimoniale dei soggetti sottoposti.
Le actiones adiecticiae qualitatis potevano essere esperite quando lo schiavo o il figlio ponevano in essere una attività
che astrattamente avrebbe dato luogo al sorgere di una obbligazione, ma che per ius civile avrebbe portato all’attuazione
solo degli effetti favorevoli per dominus o pater. Era poi necessario anche il requisito della responsabilità dell’azione
del sottoposto da imputare in capo al dominus o al pater. La responsabilità del padrone poteva configurarsi in maniera
di autorizzazione esplicita o implicita.
Le actiones adiecticiae qualitatis erano in tutto sei, distinte in due gruppi: il primo gruppo era formato dalle azioni in cui
la responsabilità del pater o del dominus emergeva da una esplicita autorizzazione al sottoposto. L’esplicita
autorizzazione al tempo stesso era rivolta al soggetto terzo, che entrava in affari con il figlio o con lo schiavo. In questa
categoria si ricomprendono la actio institoria, la actio exercitoria e la actio quod iussu. In queste azioni il dominus o il
pater rispondeva per intero ai debiti contratti dal sottoposto. Il secondo gruppo era formato dalle azioni nelle quali il
requisito della responsabilità del pater o del dominus si fondava su una autorizzazione implicita, ossia che si desumeva
esserci stata. Le due azioni che facevano parte di questa categoria erano la actio de peculio e la actio tributoria. Non
rientrava in nessuna di queste classificazioni la actio de in rem verso, che in qualche modo era residuale e che veniva
concessa solo quando si comprendeva che il dominus o il pater aveva in qualche modo tratto un vantaggio dal negozio
posto in essere dal sottoposto ma non si poteva applicare nessun’altra azione.
La actio exercitoria
la actio exercitoria era connessa con le dinamiche di commercio interno ed internazionale e nasceva dall’autorizzazione
esplicita che l’armatore (exercitor) dava ad un suo schiavo, che veniva preposto in qualità di magister navis (comandante
della nave) alla guida di una nave o di una flotta di navi commerciali. Il magister navis doveva essere autorizzato con
l’atto esplicito della praepositio. La praepositio era una autorizzazione a svolgere attività di natura commerciale; i
romani, a meno che il dominus non escludesse esplicitamente la sua responsabilità per alcuni affari tramite la stessa
praepositio, ne individuavano i limiti in maniera abbastanza ampia, includendovi non solo gli affari ma anche ogni altra
attività svolta per poter portare avanti la campagna commerciale della nave. L’armatore doveva rispondere di tutte le
obbligazioni (nella loro interezza) contratte dallo schiavo sulla base della praepositio.
La actio institoria
La actio institoria nasceva con riferimento all’institor, che preponeva il proprio schiavo alla guida di una attività
commerciale terrestre. Anche in questo caso il dominus dava la sua autorizzazione tramite la praepositio e rispondeva
in solido per tutte le obbligazioni nascenti dallo svolgimento delle attività.
La actio quod iussu
La actio quod iussu richiedeva sempre una autorizzazione specifica, un iussum (ordine), che il proprietario dava al
soggetto terzo per concludere uno specifico negozio con il proprio schiavo o figlio. Nella actio quod iussu il dominus o
pater limitava la propria responsabilità in solido al negozio che aveva autorizzato a concludere e non ad altre ulteriori
attività. Se lo iussum mancava, il pater o dominus poteva sistemare la situazione con una ratifica successiva, che
prendeva il nome di ratihabitio, che serviva da un lato a legittimare il negozio compiuto e dall’altro alla presa di
responsabilità da parte del padrone delle obbligazioni risultanti dalle azioni dello schiavo o del figlio.
La actio de peculio
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
La actio de peculio era molto importante dal punto di vista pratico, perché schiavi e figli ricevevano spesso dai rispettivi
padroni un peculium, costituito beni e situazioni giuridiche che andavano a formare un loro patrimonio di fatto: a livello
di diritto il proprietario dei beni e delle situazioni giuridiche rimaneva infatti il dominus o il pater. L’attribuzione del
peculium non richiedeva particolari formalità.
La actio de peculio rendeva responsabile il pater o il dominus per gli atti compiuti dal sottoposto nell’amministrazione
e gestione del peculium. Il pater o il dominus rispondeva nei limiti dell’attivo del peculium: se i creditori vantavano un
credito di 100 sesterzi e il peculio ammontava a 70 sesterzi, i crediti dei creditori venivano ridotti e ciascuno di essi
poteva soddisfarsi con meno denaro di quanto gli spettasse. Se tra dominus e servus si creavano delle situazioni di debito
e credito per cui il servus era debitore verso il dominus, quest’ultimo soddisfaceva il proprio debito tramite l’aggressione
del peculium. Il dominus era creditore privilegiato del servo, scavalcava quindi altri eventuali creditori che volessero
rivalersi sul peculium.
La actio tributoria
La actio tributoria era molto simile alla actio de peculio, ma presupponeva che vi fosse stata una autorizzazione implicita
da parte del padrone affinché lo schiavo o il figlio esercitasse una o più specifiche attività commerciali utilizzando i beni
del peculio. In questo caso il dominus o pater non aveva la prelazione rispetto ad altri creditori qualora fosse anch’egli
creditore del sottoposto (par condicio creditorum).
La actio de in rem verso
La actio de in rem verso era una azione residuale, si poteva cioè farvi ricorso solo qualora mancassero i requisiti specifici
sussistenti per le altre actiones. Lo schiavo o il filius doveva quindi aver concluso un negozio senza praepositio, senza
iussum e senza utilizzare il proprio peculio. In questo caso, il dominus o il pater rispondeva delle obbligazioni contratte
dal suo sottoposto nei limiti in cui avesse tratto vantaggio dal negozio posto in essere.
Questa azione aveva una formula con una struttura pensata sulla base della actio de peculio, nella quale tuttavia si diceva
che se il peculium fosse stato incapiente (non poteva soddisfare in toto la pretesa del terzo) o inesistente, si sarebbe agito
nei confronti del pater o del dominus nei limiti dell’arricchimento, di quel vantaggio patrimoniale che egli avesse tratto
dalla conclusione del negozio giuridico.
Le curatele
A Roma determinati soggetti erano privi totalmente o parzialmente di capacità di agire. Questi soggetti erano il pazzo,
il prodigo e il minore di 25 anni. Le forme più antiche di curatela erano la cura furiosis e la cura prodigi, già disciplinate
dalle dodici tavole.
La cura furiosis
La quinta tabula delle dodici tavole diceva che la potestas (e quindi la cura) sul furiosus e sulla sua pecunia veniva
attribuita per il ius civile in prima istanza agli agnati. In assenza di agnati si ricorreva ai gentiles, gli appartenenti alla
gens del furiosus. Non si diede mai peso alla designazione del curator per via testamentaria.
La posizione del furiosus veniva avvicinata a quella dell’infante: il furiosus, fino alla tarda repubblica, era un soggetto
totalmente incapace di agire. Per verificare che il furiosus fosse veramente tale non si poteva effettuare un controllo
magistratuale, né esisteva un praeiudicium an furiosus sit. Sostanzialmente, quindi, o il pazzo aveva concluso un negozio
e un soggetto lo contestava sottolineando il fatto che egli fosse furiosus in sede giudiziale, oppure, poiché gli agnati o i
gentiles erano curatori di diritto, il furiosus poteva agire per mettere in discussione l’atto di gestione del curatore.
Se non esisteva un curatore legittimo, il pretore procedeva alla nomina di un curatore esterno, il cosiddetto curatore
dativo. Il pretore doveva in questo caso agire causa cognita, ossia avrebbe dovuto verificare la condizione del soggetto
da sottoporre a curatela prima della nomina del curatore dativo. In questa sede il pretore poteva anche tenere conto della
nomina di un curatore testamentario, anche se l’atto di nomina testamentario non produceva effetti autonomamente.
I rapporti tra il curatore e il pazzo non erano regolati da alcuna azione specifica; l’unica azione che poteva essere data
era una actio negotiorum gestorum, che normalmente si riconosceva per la gestione di affari altrui.
La cura prodigi
L’altra forma di cura risalente all’antichità era la cura prodigi, anch’essa disciplinata dalla quinta delle dodici tavole. Il
prodigus era originariamente inteso come la persona che dissipava il patrimonio familiare ricevuto in eredità dal pater
familias; successivamente venne inteso come colui che dilapidava il proprio patrimonio, senza che questo dovesse per
forza essere frutto di un’eredità.
Anche nel caso della cura prodigi i soggetti che venivano riconosciuti come curatori legittimi erano gli agnati e i gentiles.
Per designare la cura prodigi serviva l’intervento del magistrato, che doveva valutare la condizione del soggetto e
concedere una interdictio, dando il là o alla nomina di un curatore legittimo oppure alla nomina di un curatore dativo. Il
prodigo non poteva, di fatto, compiere atti che diminuissero il proprio patrimonio a meno che non avesse agito con
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
l’assistenza del curatore. Se il prodigo avesse posto in essere un atto autonomo che avesse accresciuto il suo patrimonio
bisognava cercare di tutelare i terzi, concedendo loro una azione in via utile.
Il prodigo si trovava in una situazione simile all’impubere ma era pienamente capace sia per il diritto pubblico che per
il diritto criminale. Anche per il prodigo si concedeva una actio negotiorum gestorum.
La cura minorum
L’ultimo tipo di cura che si conosce è la cura minorum, la cura per i minori di 25 anni. La cura minorum non era
contemplata dal ius civile e non era disciplinata dalle dodici tavole: prima della sua istituzione, all’uscita dalla pubertà,
a 12 anni le ragazze sarebbero state immediatamente sottoposte a tutela mentre a 14 anni i ragazzi sarebbero stati
completamente capaci di agire.
Nel II secolo a.C. intervenne tuttavia la lex laetoria, che andava a disciplinare la condizione dei minori di 25 anni. La
lex laetoria (che era una legge minus quam perfectam, ossia non rendeva nullo l’atto compiuto ma prevedeva una pena
per i trasgressori) prevedeva come pena una sanzione pecuniaria a carico di colui il quale, nel concludere un atto di
rilevanza patrimoniale, avesse abusato dell’inesperienza del minore, cagionando quindi un danno di natura patrimoniale
verso quest’ultimo.
Nella pratica, i minori di 25 anni cominciarono a farsi assistere da persone di fiducia per evitare di essere ingannati e
per dare maggiori garanzie ai terzi. Qualora vi fosse stata circumscriptio (ossia se il soggetto terzo avesse abusato
dell’inesperienza del minore) e il soggetto terzo avesse voluto agire contro un minore non affiancato da un curatore, il
pretore (riconosciuta la sussistenza tanto della circumscriptio quanto del danno patrimoniale) avrebbe potuto concedere
al minore la exceptio legis laetoria. L’alternativa era che il minore lamentasse il danno subito al di fuori di un processo;
il pretore avrebbe quindi potuto operare una restitutio in integrum causa cognita. Per la restitutio in integrum non era
necessaria la presenza della circumscriptio.
La cura minorum venne istituita a Roma dal pretore ed era fondata sulla nomina di un curatore dativo. Originariamente,
il pretore riteneva fosse necessario dare un curatore solamente per singoli negotia. Il curatore doveva dare al minore
un’autorizzazione informale, la auctoritas. Lo sviluppo ulteriore portò però a ritenere utile l’estensione della cura
minorum in via generalizzata ai minori di 25 anni: per avere il riconoscimento ufficiale a livello generalizzato si dovette
attendere l’epoca di Marco Aurelio, che con un rescripto indicò come necessaria l’estensione di questa regola a livello
generale e non per singoli affari. Il curatore poteva a questo punto gestire il patrimonio del minore e addirittura venne
obbligato a svolgere la sua professione senza possibilità di recesso dopo essere stato nominato (ufficio non rinunciabile).
Anche per i rapporti tra minore e curator l’unica azione disponibile era la actio negotiorum gestorum.
_______________________________________________________________________________________________
___
I DIRITTI REALI
La res
Riguardo agli oggetti dei diritti reali, oggi si fa una distinzione tra “beni” e “cose”: l’articolo 810 del codice civile
definisce “beni” le cose che possono formare oggetto di diritti. Per i giuristi moderni non tutte le cose sono beni, tanto
che per il diritto vengono in rilievo solo i beni.
A Roma non esisteva la distinzione del concetto di cosa da quello di bene, ma esisteva solo il concetto di res. In latino,
il termine “res” significa letteralmente “cosa”, ma per i romani rientravano tra le res anche gli schiavi e i diritti reali,
oltre alle res materiali.
I romani operavano tutta una serie di distinzioni tra le varie tipologie di res.
In primo luogo, si faceva una distinzione tra le res corporales (ossia le cose che si possono toccare, le cose materiali) e
res incorporales (le cose che non si possono toccare, i diritti reali).
Un’altra distinzione che veniva fatta era quella tra le res fungibili (o cose di genere, che si identificavano e si identificano
tuttora in rapporto al peso, al numero o alla misura) e le res infungibili (o cose di specie, che si identificavano con una
specifica identità materiale).
Un’altra differenza sussisteva tra le res in commercio, di cui si poteva disporre, e le res extra commercium, ossia cose
per cui non si poteva disporre (ad esempio gli altari sacri).
C’erano poi le res mancipi, ossia tutte quelle cose che per essere trasferite avevano bisogno della procedura di mancipatio
o, successivamente, di in iure cessio (i fondi e gli edifici che si trovavano in suolo italico, gli schiavi, gli animali da tiro
e gli animali da soma, ossia tutte quelle res legate alla società romana arcaica, all’agricoltura), che si contrapponevano
alle res nec mancipi (tutte le altre res), che potevano essere trasferite semplicemente con una traditio.
Le cose potevano essere poi mobili o immobili (il suolo e tutto ciò che ineriva stabilmente ad esso).
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
Una ulteriore distinzione era quella che sussisteva tra beni consumabili (che si esaurivano con un unico o con pochi
utilizzi) e beni inconsumabili (che non si esaurivano con un uso unico, anche se non duravano per sempre).
I diritti reali
I diritti reali sono i diritti soggettivi su una cosa. Questi diritti sono assoluti, ossia vengono tutelati nei confronti di tutti
i soggetti diversi dal titolare, sono opponibili ai terzi. Tali diritti assoluti si contrappongono ai diritti di credito, che sono
invece diritti relativi. I diritti di credito sono i diritti delle obbligazioni, laddove ci sia un legame tra due soggetti, il
debitore e il creditore. Chi vanta il credito non può agire in giudizio contro chiunque, ma solo verso il debitore insolvente.
La distinzione tra diritti reali (assoluti) e diritti di credito (relativi) nasce dalla distinzione tra actiones in rem e actiones
in personam.
Il diritto di proprietà
Il diritto reale per antonomasia è il diritto di proprietà. La proprietà tutelata dal ius civile romano era il dominium ex
iure quiritium, al quale poi si affiancarono la proprietà commerciale e la cosiddetta proprietà pretoria.
Nel dominio ex iure quiritium la proprietà presentava due caratteristiche fondamentali, l’illimitatezza interna (la
proprietà non aveva limiti verticali, si era proprietari del terreno “fino alla volta celeste” e “fino agli inferi”) e l’elasticità
(se la proprietà era gravata da un peso, come la servitù di passaggio, appena il peso veniva meno la proprietà si
riespandeva).
I romani definivano il diritto di proprietà come ius utendi et abutendi re sua (il diritto di usare e abusare della propria
cosa). Il nostro codice civile definisce invece il diritto di proprietà come il diritto di godere e disporre della cosa in modo
pieno ed esclusivo. Il titolare del diritto di proprietà ha quindi il pieno potere sulla cosa: può alienarla, costituire altri
diritti su di essa, darla in dotazione, coglierne i frutti… L’unico limite che ha il diritto di proprietà nel nostro ordinamento
(che i romani non identificavano) è quello degli atti emulativi, ossia atti di esercizio del proprio diritto di proprietà messi
in pratica al solo scopo di danneggiare un terzo.
I modi di acquisto della proprietà
Quando si parla di modi di acquisto della proprietà si devono distinguere i modi di acquisto a titolo originario (non c’è
una relazione tra il precedente proprietario e il proprietario attuale) dai modi di acquisto a titolo derivato (in cui c’è un
rapporto tra compratore e venditore, come nel caso del contratto).
Per quanto riguarda l’acquisto della proprietà a titolo originario, si suole distinguere i vari modi in cui questo acquisto
avveniva a Roma antica in occupazione, accessione e specificazione.
L’occupazione
L’occupazione era un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, che faceva in modo che le res nullius (le cose
di nessuno) o le res deredicte (le cose abbandonate) diventassero di proprietà di chi le acquisiva. Due esempi di acquisto
per occupazione sono il caso del cacciatore che uccideva una preda (che, non avendo proprietari precedentemente
all’uccisione, diventava di proprietà dell’uomo) e il caso del ritrovamento di un tesoro in un fondo privato. In questo
caso, se il tesoro fosse stato rinvenuto da un terzo nel fondo di proprietà di un’altra persona, il tesoro sarebbe stato per
metà del proprietario del fondo e per metà di chi l’aveva trovato.
L’accessione
Un altro modo di acquisto della proprietà a titolo originario era la accessione, che derivava dal fatto che una cosa
corporale avesse subito un incremento per l’aggiunta di un’altra cosa (come nel caso degli incrementi fluviali al terreno
di un contadino oppure della semina, che veniva seminata in un terreno e i cui frutti erano di proprietà del contadino
proprietario del terreno). Un esempio particolare di accessione era la inedificatio, che consisteva nella costruzione di un
edificio con materiali appartenenti ad una persona diversa dal costruente e proprietario dell’edificio. Se la costruzione
avveniva sul terreno proprio con materiale di un altro soggetto il proprietario dei materiali non perdeva il suo diritto di
proprietà su di essi, ma il suo diritto rimaneva quiescente fino a quando la costruzione non fosse crollata. Il proprietario
dei materiali non poteva chiedere in giudizio la demolizione della casa, in ragione della quiescenza del proprio diritto.
Se si costruiva un edificio con materiali propri sul terreno di un altro, il proprietario dei materiali manteneva la proprietà
solo se al momento della costruzione avesse agito in buona fede.
La specificazione
Un altro modo di acquisto a titolo originario era la specificazione, nella quale si prendeva un materiale e la si specificava,
le si dava cioè una forma diversa (ad esempio, se si fosse preso dell’oro per forgiare un anello oppure se si fosse presa
dell’uva per produrre del vino). Sulla questione avvenne l’ennesimo scontro tra sabiniani e proculiani: per i proculiani
chi aveva specificato la materia acquistava la proprietà della cosa, per i sabiniani la proprietà rimaneva del proprietario
del materiale. Per dirimere la questione intervenne una media sentenza, secondo la quale bisognava distinguere se il
processo di specificazione fosse o meno un processo reversibile. Se reversibile il proprietario della matria ne avrebbe
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
ottenuto la proprietà, se irreversibile la proprietà rimaneva allo specificatpre. Nel nostro codice civile la proprietà della
cosa specificata dipende invece dal valore della materia e da quello della manodopera.
L’usucapione
Tanti anni fa si annoverava nella categoria dei modi di acquisto della proprietà a titolo originario anche l’usucapione.
Per aversi usucapione in diritto romano erano necessari dei requisiti specifici, il più importante di questi era che la cosa
che si usucapiva fosse una res abilis: la res non abilis per eccellenza è la res furtiva. Doveva poi essere trascorso un
determinato periodo di tempo prima di usucapire il bene (tempus, che consisteva per i romani in 2 anni per beni immobili
e un anno per beni mobili; se un uomo utilizzava un determinato bene immobile per un anno e poi moriva, il figlio del
de cuius poteva utilizzare il bene solo per un anno prima di usucapirlo, questo perché il tempo si sommava), doveva
esserci la buona fede dell’usucapente, ossia l’ignoranza di ledere un diritto altrui, e l’uso della res (usus). Era anche
importante che l’usucapente avesse un titulus, idoneo a giustificare il possesso del bene usucapito.
Il possesso
Già i romani distinguevano il dominium ex iure quiritium (la proprietà vera e propria) dall’istituto del possesso. Quando
si parla di possesso, per i giuristi si intende una situazione di fatto che avviene quando sia presente sia il corpus
possidendi (la disponibilità materiale della res) sia l’animus (la volontà di possedere quel bene uti dominus, ossia come
se si fosse il proprietario). Se è presente solo il corpus possidendi e non l’animus, l’azione configuratasi nei confronti
dell’oggetto non è possesso ma è una mera detenzione. Il conduttore di un appartamento in locazione, per esempio, non
è un possessore ma è un detentore. Un altro esempio di detenzione è il caso del comodatario: il comodato è un prestito
che ha ad oggetto non il denaro (in tal caso si parlerebbe di mutuo) ma un oggetto determinato. Il comodatario ha il
corpus (ossia è detentore dell’oggetto) ma non ha l’animus (in quanto sa che l’oggetto che ha in quel momento gli è dato
in comodato da un altro soggetto). Il detentore non può usucapire il bene che detiene.
Il possessore veniva tutelato a Roma con degli strumenti pretori, gli interdicta.
Non ogni possesso è utile ad usucapire, per esempio non lo è il possesso del creditore pignoratizio.
Le azioni a difesa del proprietario
L’azione principale a tutela del proprietario era la rei vindicatio (oggi chiamata azione di rivendica). La rei vindicatio
era l’azione reale per antonomasia e presentava anche una clausola restitutoria o arbitraria, consistente nell’invito da
parte del pretore di restituire la res. L’attore che utilizzava la rei vindicatio doveva provare di essere il proprietario della
res tramite la presentazione di un valido negozio traslativo non solo tra lui e colui dal quale l’aveva acquistato, ma anche
tra il venditore e il precedente venditore e così via (probatio diabolica). Se, però, il proprietario avesse posseduto per
più di due anni l’immobile l’avrebbe comunque usucapito, quindi non avrebbe dovuto cimentarsi nella probatio
diabolica.
Il proprietario aveva anche altre azioni che poteva esperire in giudizio. Una di queste era l’azione negatoria, che veniva
esperita dal proprietario per negare la servitù di passaggio o l’usufrutto illecitamente esercitato da altri.
Un’altra azione a difesa della proprietà era la cautio damni infecti (cauzione per il danno temuto), strumento che veniva
utilizzato dal proprietario quando questi temeva un danno alla propria proprietà che non si era ancora verificato, ma che
aveva fondato timore che potesse verificarsi. Il soggetto da cui derivava il possibile danno doveva promettere (da qui
cautio, una promessa che veniva fatta tramite stipulatio) che qualora ci fosse stato effettivamente il danno temuto dal
proprietario, gliel’avrebbe risarcito.
L’ultima azione di questo genere all’epoca romana era la operis novi nuntiatio (intimazione di nuova opera), che veniva
utilizzata dal proprietario quando sul fondo del vicino era in corso una costruzione e si aveva un fondato timore che da
quell’opera di edificazione derivasse un danno al proprio edificio. Con l’operis novi nuntiatio il proprietario intimava al
vicino di sospendere l’esecuzione dell’opera. Se questo non lo faceva, il pretore emetteva l’interdictum demolitorum,
l’ordine di demolizione dell’edificio.
La proprietà in bonis habere
Le tipologie di proprietà previste dal diritto romano erano tre, una di queste era la proprietà bonitaria (anche detta
proprietà in bonis habere o proprietà pretoria). Un soggetto era proprietario bonitario quando o acquistava un bene
tramite un negozio traslativo non idoneo oppure quando acquistava a non domino, ossia da chi non era il legittimo
proprietario della cosa acquistata. Queste due situazioni portavano a conseguenze inique per cui ben presto il pretore
concesse un’azione a tutela del proprietario bonitario, la actio publiciana.
Nel caso in cui il proprietario possedesse la cosa tramite un negozio traslativo non idoneo non era possibile utilizzare
una rei vindicatio e quindi si esperiva in giudizio la actio publiciana. La actio publiciana era parametrata sulla rei
vindicatio e rientrava nelle actiones pretorie fittizie, perché il pretore fingeva che fosse decorso il tempo utile ad
usucapire in favore del compratore, che quindi diventava proprietario legittimo della res.
Esempio: Tizio vende a Caio il suo bue migliore e, di questo bue, fa traditio. Il bue, dopo un po’ di tempo che stava con
Caio, se ne va dalla sua stalla e un terzo se ne impossessa. Caio può agire in giudizio contro il terzo che ha il bue nella
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
stalla con la rei vindicatio? No, perché Caio non è proprietario per ius civile in quanto, per aversi un passaggio di
proprietà valido per ius civile, avrebbe dovuto acquistare il bue tramite una mancipatio.
Esempio: Tizio vende a Caio il suo bue con traditio. Dopo pochi mesi, il bue torna nella stalla di Tizio, che se lo tiene
in virtù dell’errore nel negozio traslativo. In questo caso il proprietario bonitario agiva contro il dominus per ius civile
con la actio publiciana, ma il dominus per ius civile si difendeva con la exceptio iusti dominii, ossia eccepiva di essere
proprietario della res per ius civile. Il proprietario bonitario esperiva quindi la replicatio doli, quindi il proprietario per
ius civile soccombeva.
Nel caso dell’acquisto a non domino (Caio vende il carro a Tizio, ma il carro non era di Caio bensì di un terzo proprietario
che non c’entra nulla con il negozio), quando il dominus legittimo scopriva la vendita fraudolenta del suo bene poteva
agire contro il proprietario bonitario con la rei vindicatio. Il proprietario bonitario eccepiva quindi la exceptio rei
venditae et traditae (eccezione di cosa venduta e consegnata). Il problema dell’acquisto a non domino era che il
proprietario legittimo poteva controbattere con la replicatio domini e il proprietario bonitario soccombeva a questa
azione. Ma se il proprietario bonitario avesse acquistato a non domino ma avesse perso il possesso in favore di un terzo,
avrebbe potuto agire contro il terzo con la actio publiciana, diventando di fatto egli stesso il possessore legittimo del
bene.
I diritti reali su cosa altrui
Al diritto di proprietà vengono affiancati i diritti reali su cosa altrui (diritti reali minori), detti in latino in re aliena. I
diritti su cosa altrui presuppongono il diritto di proprietà di un terzo. I diritti reali su cosa altrui si distinguono in diritti
reali minori di godimento (come l’usufrutto e la servitù, che consentono al titolare di godere della res di proprietà di un
altro soggetto) e diritti reali minori di garanzia (come il pegno romano o la moderna ipoteca, che consentono al titolare
di soddisfarsi sulla res altrui in caso di inadempimento di un’obbligazione). Tutti i diritti reali, anche quelli su cosa
altrui, sono assoluti e sono tutelati erga omnes. In diritto romano, per costituire il diritto di proprietà e i diritti reali
minori i negozi giuridici che si utilizzava erano traditio, in iure cessio e mancipatio.
L’azione a tutela dei diritti reali su cosa altrui era la actio confessoria.
Il pegno
In epoca romana non esisteva l’istituto dell’ipoteca ma un suo equivalente si poteva individuare nel pegno, il diritto
reale su cosa altrui di garanzia. Il pegno poteva essere o datio pignoris (dazione di pegno) o conventio pignoris (accordo
del pegno). La datio pignoris era la consegna di una cosa dal debitore al creditore in modo tale che il creditore la tenesse
presso di sé finché il debitore non avesse pagato il proprio debito, a garanzia del pagamento. La conventio pignoris, vera
e propria antecedente dell’ipoteca, aveva ad oggetto un bene immobile ed implicava un patto tra il creditore e il debitore
con il quale si stabiliva che il creditore avrebbe preso possesso dell’immobile nel caso in cui il debitore non avesse
pagato.
L’azione che veniva concessa al creditore pignoratizio era la actio serviana (o ipotecaria): il creditore pignoratizio
diventava possessore del bene, ma il possesso non era utile ai fini dell’usucapione bensì al fine della tutela interdittale.
Il creditore pignoratizio poteva quindi ricorrere agli interdetti, gli strumenti concessi dal pretore a tutela del possesso,
ma non poteva usucapire la proprietà.
Al momento della costituzione del pegno poteva essere aggiunto il cosiddetto patto commissorio (abolito in età
postclassica), che stabiliva che, in caso di inadempimento del debitore, il creditore sarebbe diventato proprietario.
Un’altra tipologia di accordo sempre riconducibile al patto commissorio era il cosiddetto patto dello ius vendendi:
creditore e debitore si mettevano d’accordo in modo tale che il debitore fornisse al creditore il potere di vendere la cosa
ed utilizzare il ricavato per soddisfare il proprio credito. Se il ricavato era superiore al credito vantato dal creditore, egli
era tenuto a restituire la differenza al debitore.
L’usufrutto
Oltre al pegno, gli altri diritti reali minori erano le servitù prediali e l’usufrutto, diritti reali su cosa altrui di godimento.
L’usufrutto era (ed è tutt’oggi) il diritto di usare la cosa e percepirne i frutti “salva rerum substantia” (fatta salva la
destinazione economica della res). L’usufruttuario poteva usare la cosa e percepirne i frutti, ma non poteva modificarne
la destinazione economica. In diritto romano l’usufrutto poteva avere ad oggetto cose mobili e immobili, purché non
consumabili e fruttifere. L’usufrutto era anche detto servitù personale, era quindi un diritto reale su cosa altrui di
godimento in relazione alla persona, non alla cosa. Il proprietario della cosa su cui si costituiva l’usufrutto prendeva il
nome di nudo proprietario, perché la sua proprietà veniva compressa dal diritto minore di usufrutto.
In diritto romano l’usufrutto si costituiva tramite un negozio giuridico ad effetti reali (il più diffuso era la in iure cessio,
ma si poteva utilizzare anche la mancipatio); non si poteva costituire con la traditio perché il diritto di usufrutto non si
poteva consegnare materialmente. L’usufrutto si poteva costituire anche tramite il legato per vindicationem, che aveva
effetti reali.
L’usufrutto si estingueva con la morte dell’usufruttuario. L’usufrutto si estingue anche per non uso, oltre che per
confusione (quando l’usufruttuario e il proprietario vengono a coincidere) e per rinuncia dell’usufruttuario.
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
In diritto romano era molto diffusa la cautio fructuaria, una stipulazione tra usufruttuario e nudo proprietario con la
quale l’usufruttuario si impegnava a restituire la cosa al termine dell’usufrutto (in caso di sopraggiunto evento morte la
cosa doveva essere restituita al nudo proprietario dagli eredi) e a trattarla con la diligenza del buon padre di famiglia.
La cautio fructuaria era il contratto che si affiancava all’usufrutto, il quale di per sé non aveva natura di obbligazione.
Il quasi usufrutto
Il quasi usufrutto era invece un usufrutto che aveva ad oggetto dei beni consumabili.
L’usufrutto nasceva per tutelare la donna vedova: nei matrimoni sine manu, alla morte del marito, la vedova non
diventava erede. Per evitare l’indigenza della vedova fu escogitato il diritto di usufrutto: in questo modo il marito
inseriva nel testamento il legato per vindicationem predisponendo un usufrutto in favore della moglie, evitando
l’indigenza della donna e al contempo prevedendo che, alla morte della moglie, i beni tornassero in proprietà del figlio
erede.
Spesso, però, l’usufrutto non era stabilito per una cosa determinata ma era su tutto il patrimonio del de cuius. Questo
implicava che all’interno dell’usufrutto ci potessero essere anche dei beni consumabili, per esempio del denaro. Venne
quindi istituito il quasi usufrutto: sui beni consumabili l’usufruttuario acquistava la proprietà, ma all’estinzione
dell’usufrutto doveva restituire al nudo proprietario l’equivalente dei beni consumabili che aveva acquistato.
Un’ulteriore differenza con l’usufrutto classico stava nel fatto che il quasi usufrutto era un contratto.
Le servitù prediali
Le servitù, secondo il nostro codice civile, sono “un peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo”. In
diritto romano le servitù prediali erano un diritto reale su cosa altrui di godimento della forma di servitutes in rem,
costituite per l’utilità della cosa e non del soggetto (a differenza dell’usufrutto). Il fondo che aveva accesso alla via
pubblica si chiamava fondo servente, il fondo che aveva benefici dalla servitù si chiamava fondo dominante.
Se il proprietario del fondo che non aveva accesso alla via pubblica pretendeva la costituzione di una servitù di passaggio
per futili motivi non poteva ottenerla, perché l’utilitas non sarebbe stata propria del fondo ma sua.
La servitù di passaggio si costituiva con mancipatio, in iure cessio e legato per vindicationem.
Le servitù non si estinguevano alla morte del titolare ma si trasmettevano agli eredi, in quanto erano servitutes in rem,
inerenti al fondo. Le servitù si potevano estinguere per rinuncia, non uso (normalmente di due anni) e confusione.
Oltre alla servitù di passaggio ci potevano essere anche servitù di deflusso delle acque, servitù di passaggio a piedi,
servitù di passaggio con i carri…
Il contenuto della servitù non poteva mai consistere in un facere per il proprietario del fondo servente, che però era
sempre costretto ad un pati (sopportare): il proprietario doveva quindi tenere un comportamento passivo non impedendo
il passaggio del proprietario del fondo dominante, ma non era costretto ad interventi attivi. Il proprietario del fondo
dominante poteva invece essere tenuto ad un facere (servitù di passaggio) nel caso delle servitù positive ma anche ad
un non facere (servitù di non sopraelevare, esempio: Tizio e Caio sono proprietari di due case in collina, ma se Tizio
costruisse un secondo piano della casa che andasse a coprire la visuale del mare sottostante alla casa di Caio, che
potrebbe costituire – tramite una in iure cessio – una servitù che obblighi Tizio a non sopraelevare la casa) nel caso delle
servitù negative. Nel caso delle servitù negative si può riscontrare il seguente caso concreto: Tizio e Caio sono proprietari
di due edifici confinanti. A favore della casa di Tizio è costituita la servitù di non sopraelevare, ma Tizio parte e non
torna per due anni (decorre quindi il termine di non uso). In quei due anni Caio costruisce altri due piani alla casa,
violando la servitù di non sopraelevare. Tizio, tornato nel suo paese, esperisce la actio confessoria ma Caio ribatte con
la exceptio di estinzione, affermando che la servitù è caduta in prescrizione (a seguito della mancanza di azione da parte
del titolare del diritto di servitù per due anni dopo la violazione della servitù).
_______________________________________________________________________________________________
LE OBBLIGAZIONI
I diritti di credito e le obbligazioni
I diritti di credito vengono comunemente chiamati obbligazioni.
Il diritto di credito è un diritto relativo: lo specifico creditore può agire solo verso lo specifico debitore. L’obbligazione
è un vincolo giuridico (vinculum iuris) che lega un soggetto, il creditore, ad un altro soggetto detto debitore.
L’obbligazione ha sempre un oggetto, che si chiama prestazione. L’oggetto dell’obbligazione può consistere in un dare,
un facere o un prestare. Il dare indica una prestazione materiale (dare una somma di denaro); il facere può essere sia
positivo (costruire una casa) che negativo (non fare concorrenza); il prestare indica tutto ciò che è diverso dal dare e dal
facere. L’oggetto dell’obbligazione deve avere determinati requisiti: deve essere determinato o determinabile, possibile
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
(dove la possibilità indica sia l’aspetto materiale che l’aspetto giuridico), suscettibile di una valutazione economica e il
creditore deve avere un interesse (non per forza economico) a ricevere la prestazione.
Le fonti delle obbligazioni
Oggi, le fonti delle obbligazioni (ossia gli atti o i fatti da cui nasce il vincolo giuridico) sono elencate nel codice civile
e sono il contratto, il fatto illecito e qualsiasi altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità
dell’ordinamento giuridico.
Il contratto, oggi, ha sia effetti obbligatori che effetti reali, mentre in diritto romano aveva solo effetti obbligatori.
Il fatto illecito consiste in un fatto contrario all’ordinamento giuridico.
Gli altri fatti tipici sono l’arricchimento, la gestione di affari altrui eccetera.
Questa tripartizione nasce perché le fonti delle obbligazioni, in diritto romano, attraversarono varie fasi: inizialmente,
nelle Istituzioni di Gaio, le fonti delle obbligazioni erano il contratto e il delictum (fatto illecito). Ad un certo punto Gaio
cambiò però idea, passando ad una tripartizione: in un’opera successiva, intitolata Res quotidiane, Gaio aggiunse anche
le “variae causarum figurae”, varie figure di cause, alle fonti di obbligazioni. Gaio operò questa nuova divisione per
inserire in una categoria figure che prima non l’avevano, come il pagamento dell’indebito (che consisteva nel pagare un
qualcosa che non si doveva pagare; da cui sorgeva l’obbligazione di restituire l’indebito). Con Giustiniano si passò
addirittura ad una quadripartizione perché l’imperatore scisse le variae causarum figurae in quasi contratti e quasi delitti.
La differenza tra contratti e quasi contratti era che i contratti implicavano un consenso, un accordo, che mancava nei
quasi contratti.
La responsabilità contrattuale
Quando una delle parti non esegue la prestazione dedotta nell’obbligazione l’altra parte agisce in giudizio. Perché la
parte inadempiente sia tenuta al risarcimento del danno è necessario che ne sia responsabile. La responsabilità della
parte si misura attraverso i criteri di imputazione della responsabilità: il dolo, la colpa e la custodia tecnica (o
responsabilità oggettiva).
Il dolo consiste nella non esecuzione intenzionale della prestazione; chi si comporta in questo modo è responsabile a
titolo di dolo.
Il responsabile a titolo di colpa è invece colui che non abbia eseguito la prestazione per imprudenza, negligenza o
imperizia. Nell’ambito della colpa i romani distinguevano la culpa lata (negligenza grave, grossolana, non capire ciò
che tutti capiscono), la culpa levis (colpa lieve) e la culpa levissima.
La culpa si ha quando il soggetto non rispetta le regole che avrebbe rispettato il buon padre di famiglia. Il diligente padre
di famiglia è un modello astratto di confronto adoperato anche dal nostro codice civile per stabilire se ci sia stato dolo
o colpa nell’obbligazione. Un modello di confronto concreto che si applicava in diritto romano in casi specifici era
invece la diligentia quam in suis, ossia la diligenza che ognuno mette nello svolgere i suoi affari.
L’imperizia si aveva quando ad avere colpa era un professionista, nell’esercizio della sua attività lavorativa. In questo
caso il secondo termine di paragone era la diligenza di un professionista medio dello stesso livello.
La custodia tecnica era una responsabilità oggettiva e ricorreva quando il soggetto era considerato responsabile anche
in assenza di dolo e colpa. Oggi, un esempio di responsabilità tecnica è la responsabilità per i danni causati da un minore.
La responsabilità oggettiva è la responsabilità più gravosa, onerosa.
Ci sono dei casi in cui il debitore non può essere considerato responsabile, ossia quando c’è una impossibilità
sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile. La responsabilità è però sempre imputabile quando
l’oggetto dell’obbligazione è una somma di denaro, che è il bene fungibile per eccellenza.
In caso di responsabilità scatta il risarcimento dei danni cagionati al creditore per la mancata esecuzione della
prestazione.
Ai fini del risarcimento bisogna anche vedere anche su chi grava il perimento della res: se Caio deve consegnare a Tizio
10 quintali di vino di quella determinata qualità il 20 novembre e, nel frattempo, il vino va a male e se la causa è
imputabile al soggetto perché non ha fatto una adeguata manutenzione della botte, anche se il vino è andato a male Caio
deve comunque pagare Tizio. Si parla in questo caso di perpetuatio obligationis. In questo caso il periculum (inteso
come rischio dipendente da un evento pregiudizievole) grava sul proprietario.
Le obbligazioni naturali
Quelle descritte finora sono obbligazioni che nascevano da rapporti civili o pretori. Le obbligazioni naturali, invece,
nascevano originariamente in capo agli schiavi o ai filii familiae, soggetti sprovvisti della capacità giuridica. Se il
soggetto obbligato con filii familiae o con schiavi aveva eseguito una prestazione egli non aveva diritto alla restituzione
di quella prestazione (soluti retentio, il creditore tratteneva quanto eseguito dalla parte). Un altro effetto delle
obbligazioni naturali era la mancanza di azione da parte del creditore.
Il contratto
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
Il contratto era un negozio giuridico con soli effetti obbligatori che presupponeva un consenso tra le parti. Oggi, nel
codice civile italiano il contratto è definito come l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un
rapporto patrimoniale. I romani definivano il contratto come una conventio tra parti.
Quanto agli effetti, i contratti unilaterali facevano sorgere obbligazioni in capo ad una sola delle parti, i contratti bilaterali
facevano sorgere obbligazioni in capo ad entrambe le parti e i contratti bilaterali imperfetti facevano di norma sorgere
obbligazioni in capo ad una sola parte, ma in alcuni casi facevano sorgere obbligazioni anche per l’altra parte.
Riguardo al momento di formazione del contratto, ossia il momento dello scambio della volontà delle parti, i romani
operavano una distinzione tra contratti reali, consensuali, letterali e verbali. I contratti consensuali erano i contratti che
si perfezionavano con il mero consenso delle parti. Negli altri tipi di contratto il consenso si perfezionava in un altro
momento: i contratti reali si perfezionavano con la consegna della res, anche se non c’entravano nulla con i diritti reali;
i contratti letterali (il solo tipo era rappresentato dai nomina trascripticia, in cui si scrivevano le entrate e le uscite di una
famiglia o di un’altra entità economica o commerciale) si perfezionavano con la scrittura; i contratti verbali si
perfezionavano con la pronuncia di determinate parole.
I contratti reali
In diritto romano i contratti reali erano il mutuo, il deposito, il comodato e la fiducia.
Il comodato
Il comodato (o prestito d’uso) era un contratto reale a titolo gratuito in forza del quale il soggetto comodante consegnava
all’altra parte, detta comodatario, una cosa determinata (e quindi infungibile) affinché il comodatario la potesse usare.
Il comodato era un contratto bilaterale imperfetto, le obbligazioni sorgevano quindi solo in capo al comodatario, salvo
alcune eccezioni. L’obbligazione che sorgeva in capo al comodatario era l’obbligo di restituire la res al comodante. Se
questo non avveniva il comodante disponeva della actio comodati directa, da esperire in giudizio all’occorrenza.
Sorgevano obblighi in capo al comodante quando il comodatario esborsava del denaro per spese relative alla
manutenzione della cosa che comunque il comodante avrebbe dovuto affrontare (come ad esempio le spese relative
all’alimentazione dello schiavo); nel caso di spese sostenute dal comodatario per la manutenzione straordinaria della
cosa, il comodatario poteva agire in giudizio con la actio comodataria contraria per richiedere la restituzione del denaro
utilizzato.
Il comodatario era responsabile a titolo di custodia tecnica (e quindi anche in assenza di dolo e colpa) quando non
restituiva o quando distruggeva la cosa. La responsabilità del comodatario era così gravosa perché il contratto era a
titolo gratuito. Nell’ambito della responsabilità contrattuale vigeva infatti la regula dell’utilitas contrahentium, secondo
cui maggiore era l’utilità ricavata dal contratto e maggiore era la responsabilità (la responsabilità era a titolo di custodia
tecnica in caso di utilitas esclusiva della parte responsabile, di colpa in caso di utilitas condivisa e di dolo nel caso di
utilitas della sola parte non responsabile). Nel caso del comodato, l’unico che aveva l’utilitas era il comodatario, che
dunque era responsabile per custodia tecnica. Con dei patti aggiunti al contratto, però, le parti contraenti potevano
modificare la responsabilità ma non potevano escludere la responsabilità contrattuale minima, il dolo. Un riferimento
alla diminuzione di responsabilità si può riscontrare nelle fonti al passo del Digesto D.13.6.5.10 (Ulpiano, pagina 59
Santucci)
Le uniche eccezioni alla responsabilità erano il caso fortuito e la forza maggiore, eventi che prescindevano dalla volontà
umana (disastro naturale, evento atmosferico ecc.). Sono dati casi, però, in cui il comodatario rispondeva anche in questi
eventi, nel momento in cui ci fosse stato un esorbitare dalle modalità contrattuali.
Il comodato aveva ad oggetto beni inconsumabili, tuttavia i romani ammettevano un tipo di comodato di cose
consumabili (detto comodato ad pompam vel ostentationem) fatto per ostentare la cosa. Era ammesso ad esempio il
comodato di un cesto di frutta fresca, che il comodatario non doveva mangiare ma usare come centrotavola.
Il mutuo
Se il prestito aveva ad oggetto cose fungibili era configurato come un prestito di consumo, ove la quantità di cose veniva
prestata per il consumo di colui che le riceveva. Il prestito di consumo si chiamava mutuo ed era un contratto reale, che
si perfezionava con la consegna dal mutuante al mutuatario di una determinata quantità di cose fungibili, facendo sorgere
in capo al mutuatario l’obbligo di restituzione della stessa quantità di cose. Oggi il mutuo è un contratto reale, ma si
discute di questa natura reale perché molte volte si dice che il mutuo dovrebbe essere un contratto consensuale, perché
si perfezionerebbe nel momento in cui banca e cliente stipulano l’accordo.
Il mutuo, in diritto romano, era (teoricamente) un contratto a titolo gratuito, ossia non erano previsti gli interessi (che in
latino si chiamavano usurae). Affiancando però al contratto di mutuo un contratto verbale, la stipulatio, si potevano
concordare degli interessi.
Il mutuante aveva a disposizione la actio certae creditae pecuniae nel caso in cui il mutuatario non gli avesse restituito
il denaro. Questa era una actio in personam con formula senza demonstratio; nell’intentio era indicata la quantità che il
convenuto doveva restituire.
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
Il deposito
Il deposito era un altro contratto reale a titolo gratuito con il quale il deponente consegnava al depositario una cosa
affinché egli la custodisse.
L’utilitas era solo del deponente, quindi il depositario rispondeva solo a titolo di dolo. La responsabilità poteva essere
portata alla culpa (ma non fino alla custodia tecnica) con un accordo tra le parti. Il deponente agiva contro il depositario
che avesse operato con dolo attraverso la actio depositi.
La fiducia
La fiducia viene individuata come l’antecedente storico del trust. I romani facevano la differenza tra fiducia cum amico
e fiducia cum creditore.
Il rapporto del contraente con la res
Il depositario e il comodatario avevano sulla cosa la semplice detenzione, il mutuatario acquistava in diritto romano la
proprietà del denaro, non in virtù del contratto di mutuo ma in virtù della traditio, che stava alla base del mutuo: il mutuo
consisteva infatti nella consegna di quella quantità di denaro o di quelle cose fungibili. Nel caso del comodato e del
deposito la consegna non veniva configurata traditio: la consegna diventava traditio e aveva effetti reali quando aveva
una iusta causa traditionis, che nel mutuo si riscontrava ma nel comodato e nel deposito no.
La stipulatio
La stipulatio era un contratto verbale, che si perfezionava con la pronuncia di certa verba. La stipulatio era un contratto
tipico per quanto riguardava la forma, non nei contenuti. All’interno della stipulatio si poteva promettere infatti
qualsivoglia cosa. Questo fece sì che la stipulatio diventasse uno dei contratti più diffusi. Tutte le cautiones, per esempio,
erano stipulationes. Forma della stipulatio: pagina 68 e 69 Santucci.
L’antecedente storico della stipulatio classica era la sponsio, che consisteva in una domanda a cui doveva seguire una
risposta congrua: lo stipulante chiedeva al promittente “spondes?”, il promittente doveva rispondere “spondeo”. La
sponsio era propria solo dei cittadini romani. Mano a mano essa venne allargata ai peregrini e si ammise che non fosse
necessario che nella risposta vi fosse lo stesso verbo della domanda, fino alla riforma del 472 d.C. (imperatore Leone),
dopo la quale il promittente avrebbe potuto rispondere semplicemente “sì” o “no” alla domanda dello stipulante.
A Roma vigeva il divieto di stipulare in favore di terzi (alteri stipulari nemo potest, pagina 70 Santucci). Nel nostro
ordinamento, invece, ci sono vari contratti a favore di terzi (come ad esempio l’assicurazione). Per stipulare in favore
di terzi i romani ricorrevano ad una stipulatio poenae, che imponeva il pagamento di una somma di denaro allo stipulante
nel caso in cui il promittente non avesse eseguito la prestazione pattuita in favore di un terzo.
L’azione derivante dalla stipulatio era la actio ex stipulatu, esperita dallo stipulante se il promittente non avesse
adempiuto quanto stabilito.
I contratti consensuali
I contratti consensuali erano la compravendita, la locatio conductio, il mandato e la società.
La compravendita
La compravendita (o emptio venditio) era un contratto consensuale da cui nascevano due obbligazioni: quella di pagare
il prezzo in capo all’acquirente e quella di fare acquisire all’acquirente il pacifico godimento della cosa (l’acquirente
doveva godere della res acquistata senza che nessuno lo disturbasse) in capo al venditore. Per trasferire la proprietà si
accompagnava al contratto consensuale un negozio traslativo della proprietà (mancipatio, in iure cessio, traditio). La
causa del contratto di compravendita è lo scambio della cosa con il prezzo.
Ad un certo punto i sabiniani dissero che non era necessario, affinché ci fosse compravendita, che ci fosse uno scambio
di cosa contro prezzo ma che poteva esserci anche solo lo scambio di cosa contro cosa (che però si chiamava permuta).
Questa visione non venne accettata.
Per garantire il pacifico godimento della res il venditore aveva l’obbligo della responsabilità per evizione, che
rappresentava la responsabilità che sorgeva in capo al venditore nell’ipotesi in cui il compratore avesse subito l’evizione
(ossia il fatto che un terzo avesse rivendicato con successo la cosa acquistata). Se il terzo agiva in rivendica e riotteneva
la cosa (di sua proprietà) che era stata venduta, il venditore ne sarebbe stato responsabile. La compravendita cominciò
infatti ad essere accompagnata da una stipulatio duple, che prevedeva che se il compratore avesse subito evizione il
venditore sarebbe stato condannato a pagare il doppio del prezzo ricevuto. L’azione a tutela del compratore era la actio
empti, l’azione a tutela del venditore era la actio venditi.
Alla compravendita (come a qualsivoglia altro tipo di contratto) venivano spesso aggiunti dei patti. Il patto non era un
contratto, perché il contratto era tutelato da azioni mentre il patto era un accordo sprovvisto di azione ma tutelabile
tramite eccezione. Ad esempio, Tizio consegna a Caio 100.000 sesterzi che gli devono essere restituiti entro il 20 marzo.
Il mutuatario che si è fatto prestare i soldi è un negoziante che vende carri per i buoi. Il mutuante compra tanti buoi
senza pagarli fino ad arrivare ad un importo di 100.000 sesterzi, quindi al contratto di mutuo le parti aggiungono un
patto che stabilisca che Tizio non debba chiedere a Caio la restituzione del 100.000 sesterzi (pactum de non petendo,
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
patto di non chiedere). Se, però, il mutuante agisce in giudizio con la actio certae creditae pecuniae, il convenuto (Caio)
blocca la pretesa dell’attore con l’exceptio pacti conventi (eccezione di patto concluso).
I patti più diffusi aggiunti alla compravendita erano il patto commissorio, l’in diem addictio e il pactum displicentiae.
Con il patto commissorio venditore e acquirente facevano un patto a parte in cui stabilivano che, se il compratore non
avesse pagato entro un certo termine, la compravendita si sarebbe data per non avvenuta. Il pactum in die addictio
prevedeva che se il venditore avesse ricevuto una migliore offerta entro un determinato periodo la vendita si sarebbe
considerata come non avvenuta. Il pactum displicentiae era a favore del compratore: se nel termine convenuto il
compratore non avesse trovato la cosa di suo gradimento, la vendita si sarebbe data per non avvenuta.
Per la compravendita il diritto romano prevedeva delle azioni a favore dell’acquirente anche nel caso di vizi occulti della
cosa. Le azioni edilizie (così chiamate dal nome degli edili curuli, magistrati che si occupavano di commercio di animali
o di schiavi) prevedevano infatti che, qualora il venditore avesse venduto un animale o uno schiavo occultando i vizi
che esso realmente aveva, il compratore avrebbe avuto due azioni da poter esperire: l’actio redibitoria o l’actio quanti
minoris. L’actio redibitoria poteva essere esperita entro sei mesi dalla vendita; con questa azione si chiedeva la
risoluzione del contratto (il compratore restituiva la res difettosa e il venditore doveva restituire il prezzo). L’actio quanti
minoris (azione di riduzione del prezzo) poteva essere esperita entro un anno e con essa il compratore chiedeva una
diminuzione del prezzo della res acquistata.
Il mandato
Il mandato era un contratto consensuale con il quale una parte, detta mandante, incaricava l’altra parte, detta mandatario,
per lo svolgimento di alcuni affari. Da questo contratto discendeva la actio mandati diretta (per il mandante) e l’actio
mandati contraria (per il mandatario).
In diritto romano il contratto di mandato si presumeva a titolo gratuito, oggi invece si presume a titolo oneroso (un
esempio è il mandato per l’avvocato).
La locatio conductio
La locatio conductio era un altro contratto consensuale, uno schema contrattuale che racchiudeva in sé tre tipi diversi di
locazione: locatio rei, locatio operis e locatio operarum. Le azioni della locazione erano la actio locati per il locatore e
la actio conducti per il conduttore.
La locatio rei (corrispondente alla moderna locazione) era il contratto attraverso il quale il locatore consentiva al
conduttore di godere di una cosa mobile o immobile; il conduttore (mero detentore della cosa) era obbligato a pagare
un canone periodico, detto canone di locazione.
La locatio operis era un tipo di locazione in cui un soggetto dava una cosa ad un altro soggetto affinché egli svolgesse
un opus su quella cosa e poi gliela restituisse dietro pagamento. La locatio operis era per esempio quella di chi portava
i propri vestiti al lavandaio o dal sarto. Anche le due parti della locatio operis si chiamavano locatore e conduttore. Il
conduttore era responsabile per custodia tecnica se la cosa periva o veniva danneggiata.
Pagina 93 Santucci, caso concreto: Nella locatio operis il materiale doveva essere proprio del locatore, mentre nella
compravendita il materiale era di proprietà del venditore.
La locatio operarum (oggi definita contratto di lavoro subordinato) era il contratto con cui un soggetto metteva a
disposizione di un altro soggetto la propria forza lavoro, dietro pagamento.
La società
La società era quel contratto consensuale per cui due o più soci mettevano insieme i propri beni e le proprie attività al
fine di conseguire un lucro e di dividere questo lucro tra tutti. Era ammesso un patto aggiunto in forza del quale uno dei
soci poteva dividere il lucro ma non le perdite, non era invece ammesso il patto con il quale si stabiliva che uno dei soci
dividesse solo le perdite e non il lucro.
L’azione a tutela dei soci contro gli altri soci era la actio pro socio.
I contratti innominati: STUDIA DAL LIBRO
I delicta: il furto
Il furto era inizialmente definito come la sottrazione illecita di una cosa mobile altrui. Nell’epoca classica il furto iniziò
ad indicare invece un qualunque delitto diverso da quelli tipici. Bastava che ci fosse la concrectatio rei fraudolosa, ossia
un contatto materiale con la cosa fatta al fine di conseguire un lucro e invito domino (senza l’autorizzazione del
dominus). In questo modo si potevano annoverare nell’ambito del furto anche casi come quello del depositario
(obbligato a custodire e a non usare la res) che avesse usato la res.
Il furto si configurava come manifesto se il ladro fosse stato preso, come non manifesto se il ladro non fosse stato
catturato. Da questo delictum discendevano delle azioni esperibili dal derubato: l’actio furti manifesti e l’actio furti nec
manifesti. Entrambe queste azioni erano penali, quindi il condannato era costretto a pagare una poena, un multiplo del
valore della res configurato per il quadruplo della cosa rubata nel caso dell’actio furti manifesti e per il doppio nella
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
actio furti nec manifesti. Queste azioni potevano essere esperite da chiunque avesse un interesse giuridicamente
apprezzabile ad avere la cosa: se Tizio presta a Caio il proprio cavallo (comodato) e il cavallo viene rubato al
comodatario, egli risponderà comunque per custodia tecnica. L’interesse giuridicamente apprezzabile ad esperire l’actio
furti è in questo caso del comodatario, Caio.
Nell’ipotesi di furto era possibile esperire anche una condictio (azione che veniva esperita ogni qualvolta ci fosse stata
una datio), la condictio ex causa furtiva. La condictio ex causa furtiva non era una azione penale ma reipersecutoria e si
poteva cumulare con l’actio furti. Il legittimato attivo alla condictio ex causa furtiva era solo il proprietario. Il
proprietario poteva scegliere se esperire l’azione di rivendica o la condictio ex causa furtiva: se colui che aveva rubato
la cosa fosse stato una persona piena di debiti, al proprietario della cosa sarebbe convenuto esperire la rei vindicatio
perché questa azione gli avrebbe permesso di recuperare l’intera cosa; se invece avesse esperito la condictio ex causa
furtiva e ci fossero stati più creditori, il proprietario sarebbe stato soddisfatto in proporzione e non per intero. Se il ladro
non aveva debiti, invece, era conveniente esperire la condictio ex causa furtiva perché la rei vindicatio poteva essere
esperita contro il ladro solo se egli fosse stato il possessore della res rubata, non nel caso in cui egli si fosse sbarazzato
della res.
Contratto di comodato: Tizio presta il cavallo a Caio affinché Caio lo usi e lo restituisca il 20 settembre. Se Caio non
restituisce il cavallo, questo viene considerato come furto d’uso e Tizio può esperire contro Caio o l’actio comodati o
l’actio furti.
Il danneggiamento
Un altro delictum era il danneggiamento, un delitto introdotto dalla lex aquilia de damno, da cui deriva la nostra
responsabilità extracontrattuale (art. 2043 cc e seguenti). La lex aquilia era composta da tre capita: il primo prevedeva
che chiunque avesse ucciso lo schiavo o un quadrupede altrui sarebbe stato tenuto a risarcire il danno, sempre che quel
“damnum iniuria datum” (fosse stato un danno ingiusto); il secondo capo cadde in desuetudine e non interessa; il terzo
capo prevedeva il danneggiamento o la distruzione di schiavi o qualsivoglia altri animali non annoverabili tra i
quadrupedi del primo caput e tutti gli altri oggetti inanimati. Colui che violava questi due capi era tenuto al risarcimento
del danno che consisteva, nel caso di uccisione (capo I) nel risarcimento del maggior valore che lo schiavo o l’animale
avevano avuto nell’anno precedente all’evento, nel caso di danneggiamento (capo III) del maggior valore che la cosa
aveva avuto negli ultimi 30 giorni.
La responsabilità in caso di danneggiamento veniva chiamata responsabilità extracontrattuale o aquiliana, perché non
nasceva da un contratto ma da un delitto. In questo caso il danno veniva cagionato al quisque de populo, cioè ad una
persona qualsiasi che non era legata da alcun vincolo con il danneggiante. Il danneggiamento ingiusto sancisce il
principio del neminem laedere, ossia il dovere di non ledere nessuno.
Affinché colui che aveva commesso l’evento dannoso fosse obbligato a risarcire l’offeso era necessario che il danno
fosse stato cagionato iniuria, cioè ingiustamente. I danni non ingiusti sono danni coperti da una causa di giustificazione
(ad esempio lo stato di necessità o la legittima difesa). I giuristi romani arrivarono a dire che il danno, per essere ingiusto,
doveva essere stato commesso con dolo o colpa e doveva essere corpore corpori datum (col corpo al corpo dato), che
nel diritto classico si configurava non solo come un comportamento commissivo ma anche come una omissione (Tizio
provoca la morte dello schiavo di Caio omettendo di dargli da mangiare per giorni): il danno doveva quindi essere una
conseguenza diretta del comportamento posto in essere dall’agente, anche se questo comportamento era di natura
omissiva.
In questi casi il proprietario della res danneggiata esperiva la actio legis aquilia (sulla quale vennero poi parametrate
delle azioni utili), azione inizialmente penale che nel periodo classico venne però assimilata ad una azione
reipersecutoria perdendo quindi la caratteristica cumulabilità.
Caso: Tizio da in locazione a Caio le sue mule, che servono a Caio per trasportare della legna, dietro pagamento di un
corrispettivo in denaro. Queste mule, sovraccaricate dal conduttore, vengono fiaccate al punto che due di esse muoiono.
Il proprietario-locatore può esperire l’actio locati e, in alternativa, anche la actio legis aquiliae. Se il locatore vuole agire
direttamente contro il locatore usa l’actio locati, ma se vuole agire contro i collaboratori che hanno effettivamente
sovraccaricato le mule deve esperire l’actio legis aquiliae.
Agnese Tumicelli Istituzioni di diritto romano AA 2021/2022
Potrebbero piacerti anche
- Riassunto Istituzioni Di Diritto Romano MarroneDocumento106 pagineRiassunto Istituzioni Di Diritto Romano MarroneIgor Nobile67% (3)
- RIASSUNTO MARRONE - Docx OooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkDocumento85 pagineRIASSUNTO MARRONE - Docx OooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkFederica Lorenza PerpignanoNessuna valutazione finora
- Istituzioni Di Diritto Romano - Mario TalamancaDocumento84 pagineIstituzioni Di Diritto Romano - Mario Talamancauncle_sam94Nessuna valutazione finora
- Riassunto - Istituzioni-Di-Diritto-Romano - (Dalla,-Lambertini)Documento84 pagineRiassunto - Istituzioni-Di-Diritto-Romano - (Dalla,-Lambertini)MIX100% (1)
- Istituzioni Di Diritto Romano Dalla LambertiniDocumento57 pagineIstituzioni Di Diritto Romano Dalla LambertiniFederico Galli100% (1)
- Storia Del Diritto Privato Dei Romani Mannino Riassunto CompletoDocumento85 pagineStoria Del Diritto Privato Dei Romani Mannino Riassunto CompletohhhbuuNessuna valutazione finora
- Appunti Di Diritto RomanoDocumento24 pagineAppunti Di Diritto Romanocandu890% (1)
- Riassunto MarroneDocumento91 pagineRiassunto MarroneFederica Lorenza PerpignanoNessuna valutazione finora
- Manuale Di Istituzioni Di Diritto Romano - Diritto Romano - Eva CantarellaDocumento29 pagineManuale Di Istituzioni Di Diritto Romano - Diritto Romano - Eva Cantarellaaleelli_elli100% (2)
- L Diritto Comune e Il Rapporto Con I Diritti ParticolariDocumento6 pagineL Diritto Comune e Il Rapporto Con I Diritti ParticolariGiacomo BondarelliNessuna valutazione finora
- Biglietto Trenitalia Verona RomaDocumento1 paginaBiglietto Trenitalia Verona RomaAlessia TessitoreNessuna valutazione finora
- Riassunto RomanoDocumento41 pagineRiassunto RomanoLatchezar AtanassovNessuna valutazione finora
- Diritto Privato RomanoDocumento88 pagineDiritto Privato RomanoNaomi MereutiNessuna valutazione finora
- Docsity Appunti Lezioni Di Storia Del Diritto Italiano I Prof Ssa Sigismondi Universita La Sapienza Di Roma Canale M ZDocumento70 pagineDocsity Appunti Lezioni Di Storia Del Diritto Italiano I Prof Ssa Sigismondi Universita La Sapienza Di Roma Canale M ZmikhaelspertiNessuna valutazione finora
- Storia Del Diritto Romano-9Documento49 pagineStoria Del Diritto Romano-9raffaele di bonitoNessuna valutazione finora
- Marrone - LineamentiDocumento107 pagineMarrone - LineamentiNuccia Malta100% (1)
- Fondamenti Romanistici - IntroduzioneDocumento6 pagineFondamenti Romanistici - Introduzionemariannasommella65Nessuna valutazione finora
- Fondamenti APPUNTI CORSODocumento14 pagineFondamenti APPUNTI CORSOMarco ScaranoNessuna valutazione finora
- Diritto RomanoDocumento9 pagineDiritto RomanoNatalia BilottoNessuna valutazione finora
- Storia Del Diritto Medievale e Moderno IiDocumento21 pagineStoria Del Diritto Medievale e Moderno IiCostanzaNessuna valutazione finora
- PDFDocumento53 paginePDFAndrea SpadoniNessuna valutazione finora
- Il Sistema Del Diritto ComuneDocumento6 pagineIl Sistema Del Diritto ComuneCostanzaNessuna valutazione finora
- Fondamenti Del Diritto RomanoDocumento40 pagineFondamenti Del Diritto RomanoMartina MengaNessuna valutazione finora
- RIASSUNTO DIRITTO ROMANO (Prima Lezione Soprattutto)Documento6 pagineRIASSUNTO DIRITTO ROMANO (Prima Lezione Soprattutto)costanzaNessuna valutazione finora
- Parte Generale D. RomanoDocumento14 pagineParte Generale D. RomanoTiziano BenedettiNessuna valutazione finora
- Diritto Dei Privati Nell'esperienza RomanaDocumento64 pagineDiritto Dei Privati Nell'esperienza RomanaSilvia LeoneNessuna valutazione finora
- Appunti Diritto Romano PDFDocumento103 pagineAppunti Diritto Romano PDFNicolò RumiNessuna valutazione finora
- riassunto diritto romano-M. Marrone (senza cap VII e VIII)Documento51 pagineriassunto diritto romano-M. Marrone (senza cap VII e VIII)chiara.bassi30Nessuna valutazione finora
- Istituzioni Di Diritto Romano Eva CantarellaDocumento29 pagineIstituzioni Di Diritto Romano Eva CantarellagioviduNessuna valutazione finora
- Istituzioni Diritto Romano ManfrediniDocumento88 pagineIstituzioni Diritto Romano ManfrediniVittoria FaraldiNessuna valutazione finora
- Istituzioni Di Diritto RomanoDocumento27 pagineIstituzioni Di Diritto RomanoGiacomo BondarelliNessuna valutazione finora
- Istituzioni Diritto Romano PDFDocumento59 pagineIstituzioni Diritto Romano PDFgiuliafanesi.gfNessuna valutazione finora
- DIRITTO ROMANO Appunti GiustiDocumento71 pagineDIRITTO ROMANO Appunti GiustiVeronica CircostaNessuna valutazione finora
- BIROCCHI Alla Ricerca Dell'Ordine Fonti e Cultura Giuridica Riass Capp 1 3Documento47 pagineBIROCCHI Alla Ricerca Dell'Ordine Fonti e Cultura Giuridica Riass Capp 1 3Giovanni Di Gennaro100% (2)
- Il Processo Nell'antichitàDocumento78 pagineIl Processo Nell'antichitàGiuseppe CozzaNessuna valutazione finora
- Lovato Istituzioni Di Diritto RomanoDocumento71 pagineLovato Istituzioni Di Diritto RomanoSalvatore CascellaNessuna valutazione finora
- Appunti Storia Del Diritto Romano - Prof Sciortino - A.A. 2017 - 2018Documento149 pagineAppunti Storia Del Diritto Romano - Prof Sciortino - A.A. 2017 - 2018SamNessuna valutazione finora
- Resumen Del Libro de Instituciones de Derecho RomanoDocumento29 pagineResumen Del Libro de Instituciones de Derecho RomanoAhlam SaadaneNessuna valutazione finora
- Ist. Di Diritto Romano PUGLIESEDocumento225 pagineIst. Di Diritto Romano PUGLIESEBeatriceAlbanese4_220% (1)
- Le Fonti Del DirittoDocumento3 pagineLe Fonti Del DirittoFrancesco PiloneNessuna valutazione finora
- Istituzioni Di Diritto RomanoDocumento86 pagineIstituzioni Di Diritto RomanoMicheleNessuna valutazione finora
- Diritto RomanoDocumento55 pagineDiritto RomanocamisaskNessuna valutazione finora
- Storia Del Diritto Tardantico (Dom - Freque Avolio Davide)Documento9 pagineStoria Del Diritto Tardantico (Dom - Freque Avolio Davide)Rosaria NudoNessuna valutazione finora
- Corpus Iuris Civilis - Il Problema Del Diritto RomanoDocumento53 pagineCorpus Iuris Civilis - Il Problema Del Diritto RomanoNicole GomezNessuna valutazione finora
- Diritto RomanoDocumento68 pagineDiritto RomanoalicescartozziNessuna valutazione finora
- Lovato Diritto Privato RomanoDocumento90 pagineLovato Diritto Privato RomanoSalvatore CascellaNessuna valutazione finora
- Le FONTI DEL DIRITTODocumento19 pagineLe FONTI DEL DIRITTOSara OlivieriNessuna valutazione finora
- Storia Del Diritto Italiano Del 30 MarzoDocumento5 pagineStoria Del Diritto Italiano Del 30 MarzonataliaNessuna valutazione finora
- Lezione 1Documento13 pagineLezione 1marioNessuna valutazione finora
- A30 STT Sbonine Storia Del Diritto Medievale e ModernoDocumento224 pagineA30 STT Sbonine Storia Del Diritto Medievale e Modernomarcobaio230Nessuna valutazione finora
- Riassunto X Diritto RomanoDocumento62 pagineRiassunto X Diritto RomanoeleonoracodoNessuna valutazione finora
- CAPITOLO 1 Il Diritto Romano e Le Sue FontiDocumento12 pagineCAPITOLO 1 Il Diritto Romano e Le Sue FontiGiacomo BondarelliNessuna valutazione finora
- Diritto Romano e FontiDocumento5 pagineDiritto Romano e FontiALESSIA LI CAUSINessuna valutazione finora
- Sistemi Giuridici Comparati PDFDocumento20 pagineSistemi Giuridici Comparati PDFvaleria espositoNessuna valutazione finora
- Schemi RomanoDocumento24 pagineSchemi Romanomalik_uxNessuna valutazione finora
- Diritto Romano Parte 1Documento7 pagineDiritto Romano Parte 1Andrea cazzanigaNessuna valutazione finora
- Diritto Romano Parte 5Documento26 pagineDiritto Romano Parte 5Andrea cazzanigaNessuna valutazione finora
- Le Grandi Linee Della StoriaDocumento78 pagineLe Grandi Linee Della StoriaMatteoFalconeNessuna valutazione finora
- 1 Introduzione StoricaDocumento7 pagine1 Introduzione StoricaAlessioNessuna valutazione finora
- Le Influenze del Codice Napoleonico e del BGB Tedesco sul Codice Civile Italiano: Sistemi Giuridici ComparatiDa EverandLe Influenze del Codice Napoleonico e del BGB Tedesco sul Codice Civile Italiano: Sistemi Giuridici ComparatiNessuna valutazione finora
- Il Canone Letterario Italiano e Le RagioDocumento4 pagineIl Canone Letterario Italiano e Le RagioImperfetta EllisseNessuna valutazione finora
- Ricambi Decespugliatori PDFDocumento49 pagineRicambi Decespugliatori PDFGian Piero Milesi BoNessuna valutazione finora
- VADEMECUM Operatori TASER U.V.Documento6 pagineVADEMECUM Operatori TASER U.V.Luca BigiNessuna valutazione finora