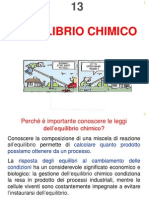Lezione 6 Titolazioni
Caricato da
Gio FioLezione 6 Titolazioni
Caricato da
Gio FioTecniche analit iche
Tecniche volumet riche
Tecniche spet t roscopiche
Tecniche cromat ograf iche
Tecniche elet t rochimiche
Saggi qualit at ivi
Valut azione di una t ecnica analit ica
Accurat ezza capacit di det erminare il valore vero
Precisione capacit di replicare le misure
Concent r azione
S
e
g
n
a
l
e
Sensibilit capacit di
dist inguere due concent razioni
dif f erent i ma molt o vicine
Limit e di rivelabilit
concent razione minima di analit a
che pu essere rivelat a
Range dinamico lineare range di
concent razioni in cui la rispost a
analit ica lineare
Selet t ivit capacit di dist inguere t ra due analit i
Ef f et t i mat rice ef f et t i di alt re component i del campione
sulla rispost a analit ica dello st rument o di misura
Limit e int ervallo di rispost a dinamico;
olt r e quest a concent r azione non si
possono f ar e misur e
I nt ervallo di linearit ; r ange di
concent r azioni compr esa t r a il
limit e di r ivelabilit e il limit e di
linear it .
Limit e di linearit ; la
concent r azione massima al di l
della quale il segnale non pi
pr opor zi onale alla concent r azione
(con una t oller anza del 5%).
Limit e di rivelabilit
concent r azione minima che d
una r ispost a doppia del r umor e di
f ondo
I nt ervallo di rispost a
dinamico; int er vallo di
concent r azioni ent r o il
quale il r ivelat or e
r isponde, anche se non in
manier a linear e
S
Conc
Tecniche analit iche
Tecniche volumet riche
Tecniche spet t roscopiche
Tecniche cromat ograf iche
Tecniche elet t rochimiche
Saggi qualit at ivi
da integrare dal libro di testo consigliato:
D. Harris, Chimica analitica quantitativa, Cap. 20-21, Zanichelli Ed. 1991
Attrezzature
a: beaker a: beaker
b: beuta b: beuta
c: beuta da vuoto c: beuta da vuoto
d: matraccio a pera d: matraccio a pera
e: bottiglia e: bottiglia
f: contagocce f: contagocce
g: imbuto g: imbuto
h: essiccatore h: essiccatore
i: cilindro graduato i: cilindro graduato
La capacit La capacit dei contenitori dei contenitori
varia in multipli di 1, 2, 5 (1 varia in multipli di 1, 2, 5 (1
mL, 2 mL, 5,mL, 10 mL, 20 mL, 2 mL, 5,mL, 10 mL, 20
mL, 50,mL, 100 mL, ecc.). mL, 50,mL, 100 mL, ecc.).
a
b
e
c
d
f
h
i
g
H
2
O
a
a
b
c
d
e
f
Attrezzature
a: pipetta
b: buretta
c: sostegno
d: beuta
e: agitatore
f: spruzzetta
piano di
lettura
Caratteristiche medie dei vari tipi di bilancia. Caratteristiche medie dei vari tipi di bilancia.
Capacit Capacit (g) (g) Precisione (mg) Precisione (mg)
Macro (tecniche) Macro (tecniche) 1000 1000- -5000 5000 10 10- -100 100
Analitica Analitica 150 150- -200 200 0,1 0,1
Semimicro Semimicro 10 10- -30 30 0,01 0,01
Micro Micro 0,5 0,5- -3 3 0,001 0,001
Ultra Ultra- -micro micro 0,025 0,025 0,0001 0,0001
Le bilance in commercio
sono classificabili come
macrobilance (tecniche),
bilance analitiche,
semi-microbilance,
Microbilance,
ultra-microbilance.
7
PRINCIPI DI VOLUMETRIA
Lanalisi volumetrica consiste nel misurare il volume di
reagente richiesto dalla reazione con lanalita.
1. Titolazione
- Titolante e titolato
- Completezza e rapidit
- Indicatore
- Punto di equivalenza
- Punto finale
- Errore di titolazione
- Titolazione in bianco
Nell'analisi volumetrica la concentrazione di analita viene determinata
mediante titolazione, cio mediante aggiunta di un volume noto di una
soluzione di reattivo a concentrazione nota, il titolante, che reagisce
quantitativamente con l'analita in esame.
la reazione tra analita e titolante deve essere rapida (condizione verificata
in tutte le titolazioni acido-base), quantitativa e a stechiometria nota;
non devono essere possibili reazioni collaterali del titolante con
interferenti, con l'ossigeno disciolto in soluzione o con l'anidride
carbonica, ecc.;
deve essere possibile reperire un indicatore, cio una sostanza che
permetta di identificare il p.e. cambiando di colore in vicinanza di esso
(viraggio).
Il punto di arresto o finale della titolazione, al quale vengono interrotte le
aggiunte di titolante, deve essere il pi possibile vicino al punto equivalente,
p.e., cio al punto al quale si sarebbe pervenuti dopo aver aggiunto la quantit
esattamente stechiometrica di titolante. Ma:
METODI DI ANALISI BASATI SU TITOLAZIONE
essere stabile e reagire rapidamente completamente e
selettivamente con lanalita
poter essere reperito facilmente e deve essere essiccabile
(preferibilmente a 110-120C) e conservabile allo stato puro;
rimanere inalterato durante le operazioni di pesata (non deve
essere igroscopico, ossidabile all'aria o assorbire anidride
carbonica);
poter essere analizzato con metodi idonei al fine della
determinazione della purezza (maggiore del 99,98%);
avere preferibilmente un alto peso equivalente in modo da
minimizzare l'errore di pesata;
essere facilmente solubile in acqua.
St andard primario
Uno standard primario una sostanza che pu essere usata per
preparare soluzione a concentrazione nota con esattezza. Uno
standard primario deve:
Standard primari
Massa molare,
g/mol
Ftalato acido di
potassio
204
HCl 36
a
c
i
d
i
KH(IO
3
)
2
390
H
2
NC(CH
2
OH)
3
121
KHCO
3
100
NaOH 40
HgO 216
Na
2
CO
3
106
b
a
s
i
Na
2
B
4
O
7
10 H
2
O 381
KSCN, NH
4
SCN 97
NaCl 58
La concentrazione di una soluzione standard, ovvero nella quale nota la
concentrazione di un dato analita, viene stabilita:
mediante dissoluzione di una quantit nota di standard primario solido
(metodo diretto)
Preparazione della soluzione di carbonato sodico: pesare circa esattamente
0,2 g di carbonato puro per analisi anidro (MW= 105,989 g/mol) nella navicella; con
l'aiuto di una spruzzetta di acqua deionizzata trasferirlo quantitativamente in un
matraccio tarato e portare a volume.
Circa esat t ament e, signif ica allincirca una cerca quant it ma esat t ament e. Se la
procedura indica pesare c. e. 0, 2 g di NaCl, si deve prelevare una massa di
circa 0, 2 g ma not a alla quart a cif ra decimale. Le seguent i masse sono t ut t e
corret t e:
0,1905 g 0,2085 g 0,2103 g 0.1886 g
3
,
/ ,
,
M ,
dm V
mol g MM
g M
C =
mediante standardizzazione, ovvero titolazione di una soluzione con
uno standard primario (se la soluzione standardizzata usata per
titolare una soluzione incognita, allora detta standard secondario).
Tipi di curve di titolazione
La curva di titolazione il
grafico ottenuto
riportando in ordinate il
logaritmo negativo di una
concentrazione (pH, pCl,
pMg, ecc.) o un segnale
(per es. potenziale) in
funzione del volume di
titolante.
Esistono titolazioni
1. acido-base,
2. di precipitazione,
3. di complessazione
4. di ossidoriduzione.
Determinazione del punto finale
1. Indicatori cromatici 2. Misura diretta del pH
Un indicatore acido-base anchesso un acido o una base le cui diverse
specie protonate hanno colori diversi
O O
SO
3
HO OH
SO
3
pK
1
= 1.7
O OH
SO
3
pK
1
= 8.9
Titolazioni acido-base:
C HOOC
HO
OH
pK
a
= 8.8
C
OOC
O
O HO
Fenolftaleina
da integrare dal libro di testo consigliato D. Harris, Zanichelli Ed.
1991, Chimica analitica quantitativa, Cap. 12
Colore
Indicatore
Intervallo di
viraggio, A acido base
Metilvioletto 0.0 1.6 giallo blu
Rosso cresolo 0.2 1.8 rosso giallo
Blu timolo 1.2 2.8 rosso giallo
Metilarancio 3.1 4.4 rosso arancione
Verde
bromocresolo
3.8 5.4 giallo blu
Rosso metile 4.8 6.0 rosso giallo
Blu bromotimolo 6.0 7.6 giallo blu
Rosso fenolo 6.4 8.0 giallo rosso
Blu timolo 8.0 9.6 giallo blu
Fenolftaleina 8.0 9.6 incolore rosso
Giallo di
alizarina
10.1 12.0 giallo arancio
Nitrammina 10.8 13.0 incolore bruno
La scelta di un indicatore ricade su quello che presenta un intervallo di
viraggio che COINCIDE il pi possibile con la parte pi ripida della
curva di titolazione
| |
| |
0
H pK pH + =
HIn
In
log
ind
bicolore pH = f(concentrazione) variazione di tonalit
monocromatici pH = f(concentrazione) variazione di intensit
misti deviazioni di tonalit sul grigio (A < 0.4 pH)
Reazione di neutralizzazione
Reattivi: H
+
standard o OH
standard?
H
+
+ OH
H
2
O
HCl standard
ftalato acido di potassio
NaOH
COOK
COOH
Reazione di neutralizzazione
H
+
+ OH
H
2
O
C HOOC
HO
OH
pK
a
= 8.8
C
OOC
O
O HO
Fenolftaleina
V
finale finale
H
+
H
+
H
+
H
+
H
+
H
+
OH
OH
OH
H
O
H
H
+
V
eq
Determinazione del titolo di una soluzione di NaOH ~ 0.1M
Reattivi: HCl standard (o ftalato acido di potassio, 204.2g/mol)
H
+
+ OH
H
2
O
1. Si prepara una soluzione satura di NaOH (14M)
2. Si lascia decantare: CO
2
+ 2OH
CO
3
2
+H
2
O
3. Si filtra il carbonato, insolubile nella soluzione satura di
NaOH
4. Si conserva la soluzione chiusa in bottiglia di polietilene
5. Si preparano 100ml di una soluzione di NaOH ~ 0.1M e si
portano in buretta
Determinazione del titolo di una soluzione di NaOH ~ 0.1M
Metodo A
1. Si preparano tre aliquote di circa 30ml standard di HCl
con fenolftaleina come indicatore
2. Si titolano in successione rapida fino al viraggio al violetto
3. Si determina il titolo della soluzione alcalina
Metodo B
1. Si preparano tre aliquote di circa 0.7g di KHC
8
H
4
O
4
standard sciolti con fenolftaleina in 50ml di H
2
O
2. Si titolano in successione rapida fino al viraggio al violetto
3. Si determina il titolo della soluzione alcalina
Preparazione e controllo del titolo di una soluzione: HCl ~ 0.1M
Reattivi:
HCl al 37%, = 1.18g/cm Na
2
CO
3
, sostanza madre
2H
+
+ CO
3
2
CO
2
+ H
2
O
ml in ,
pesare da HCl di 37% al soluzione
pesare da HCl di 37% al soluzione
HCl
pesare da HCl 36.4
1000
0.1
0.1
V
cm
g
g
g
g
g
mol
g
dm
dm
mol
=
=
=
3
3
3
18 . 1
) (
) (
37
100 ) (
) (
1. Si preparano 100ml di una soluzione circa 0.1Min HCl
Preparazione e controllo del titolo di una soluzione: HCl ~ 0.1M
2. Si pesano i grammi di Na
2
CO
3
pre-essiccati, necessari per
neutralizzare le moli di HCl in circa 30ml della soluzione ~0.1M
(3 pesate)
g
dm
mol
dm
mol
g
=
2
1
3
3
1 . 0
1000
30
106
3. Si sciolgono i grammi di Na
2
CO
3
, ogni aliquota in 100ml di
acqua con rosso metile come indicatore
4. Si titola con la soluzione di HCl: al viraggio si porta
allebollizione per allontanare CO
2
, fino alla ricomparsa del
colore giallo
Preparazione e controllo del titolo di una soluzione: HCl ~ 0.1M
7. Ripetere e calcolare il valore medio e la deviazione standard
5. Si titola con cautela fino al primo rosso persistente
ml
mol
g
g 1000
106
) (
2
CO Na
3 2
6. Si calcola il titolo:
= titolo della soluzione di HCl
Equilibri inerenti lacido anidride carbonica, CO
2
CO
2
(g) CO
2
(aq)
atm M
p
aq
K
CO
/ 034 . 0
)] ( [
2
1
= =
2
CO
CO
2
(aq) + H
2
O H
2
CO
3
3
2
10 3 . 1
)] ( [
] [
~ =
aq
K
2
3 2
CO
CO H
CO
2
(aq) + H
2
O HCO
3
+ H
+
M
aq
K
a
7
10 45 . 4
)] ( [
] ][ [
1
+
= =
2
-
3
CO
H HCO
Il sistema HCO
3
-
/H
2
O+CO
2
una soluzione tampone. Allontanando la CO
2
, si elimina
lacido coniugato. La capacit tampone diminuisce, il salto di pH al 2p.e. pi netto.
Il sistema HCO
3
-
/H
2
O+CO
2
una soluzione tampone. Allontanando la CO
2
, si elimina
lacido coniugato. La capacit tampone diminuisce, il salto di pH al 2p.e. pi netto.
-7.0
-6.0
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0
p H
logc
H
2
CO
3
+ CO
2
(aq)
HCO
3
-
H
+
OH
-
CO
3
2-
Diagramma logaritmico relativo dell'acido carbonico
Det erminazioni t it rimet riche
1. alcalinit t ot ale
2. acidit t ot ale
3. acidit di un acet o
4. acidit di un olio
5. . . . . . . .
L' alcalinit t ot ale o st echiomet rica viene convenzionalment e
espressa in mg/ l di carbonat o di calcio. Nelle acque nat urali essa
dovut a fondament alment e agli ioni carbonat o, CO
3
2-
, e
bicarbonat o, HCO
3
-
e, se il pH sufficient ement e elevat o, agli ioni
ossidrile.
Anche gli anioni di par ecchi acidi deboli ( solfur o, bisolfur o,
fosfat o e borat o) e l' ammoniaca possono per reagire con gli ioni
H
+
, ( e quindi cont ribuire ad aument are l' alcalinit ) .
det erminat a per via t it rimet rica.
Per alcalinit t ot ale di una soluzione si int ende la sua capacit di
reagire con gli ioni idrogeno, cio di neut ralizzare gli acidi.
Per acidit pert ant o si int ender la capacit di reagire con le basi e
quindi di neut ralizzare le basi) .
L' alcalinit e l' acidit sono dunque una misura del pot ere
t amponant e dell' acqua nei confront i rispet t ivament e degli acidi e
delle basi.
Alcalinit
-7.0
-6.0
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0
p H
logc
H
2
CO
3
+ CO
2
(aq)
HCO
3
-
H
+
OH
-
CO
3
2-
Se il pH del campione da analizzare relat ivament e alt o
( > 10) l' alcalinit dovut a principalment e agli ioni ossidrile
ed agli ioni carbonat o;
se il pH debolment e basico, oppure legger ment e acido,
l' alcalinit t ot ale dovut a fondament alment e allo ione
bicar bonat o.
Alcalinit
Det erminazione t it rimet rica
Alcalinit t ot ale al met ilarancio
Soluzione st andard di HCl ( 0.02M per acque nat urali) ,
preparat a e st andardizzat a con Na
2
CO
3
I ndicat ore: met ilarancio ( pH di viraggio ~ 3.7)
/ ,
dm mol
V
C V
totale alcalinit
prelevato campione
titolante titolante
=
CO
3
2-
+ HCO
3
-
+ OH
-
+ ..... + 4 H
+
2 CO
2
+ 3H
2
O
Det erminazione t it rimet rica
Alcalinit alla fenolft aleina
Soluzione st andard di HCl ( 0.02M per acque nat urali) ,
preparat a e st andardizzat a con Na
2
CO
3
I ndicat ore: fenolft aleina ( pH di viraggio ~ 8)
/ ,
dm mol
V
C V
ina fenolftale alla alcalinit
prelevato campione
titolante titolante
=
N.B. solo per campioni posit ivi al t est dalla fenolft aleina N.B. solo per campioni posit ivi al t est dalla fenolft aleina ( pH> 8)
CO
3
2-
+ HCO
3
-
+ OH
-
+ ..... + 2H
+
2 HCO
3
-
+ H
2
O
pH=8
Det er minazione t it rimet rica di carbonat i e
bicar bonat i a [ OH
] t rascurabili ( pH< 10)
CO
3
2-
+ HCO
3
-
+ OH
-
+ ..... + 3 H
+
2 CO
2
+ 2H
2
O
[CO
3
2-
] ~ alcalinit alla fenolftaleina
[HCO
3
-
] ~ alcalinit totale [CO
3
2-
]
CO
3
2-
+ HCO
3
-
+ OH
-
+ ..... + H
+
2 HCO
3
-
pH=8
pH=3.7
Det erminazione t it rimet rica
Acidit t ot ale
somma di t ut t i gli acidi cont enut i in un campione
Soluzione st andard di NaOH ( 0.02M per acque nat urali) ,
preparat a e st andardizzat a con ft alat o acido di pot assio
I ndicat ore: met ilarancio ( pH di viraggio ~ 3.7) o fenolt aleina ( pH di
viraggio ~ 8)
/ ,
dm mol
V
C V
acidit
prelevato campione
titolante titolante
=
Dosaggio dellacidit nellCH
3
COOH commerciale
CH
3
COOH + OH
CH
3
COO
+ H
2
O
1. Prelevare 4.0ml di acido acetico commerciale (~ 6% )
di CH
3
COOH presenti in 4ml
volume approssimato di NaOH
2. Diluire a 10ml con acqua ed aggiungere fenolftaleina
3. Si titola con NaOH standard
4. Determinare il titolo dellacido:
(g/ml)
ml
dm
mol
mmol
mmol
mol
g
ml
g
ml
40
1 . 0
4
4
60
1
06 . 0 4
3
=
=
v w
V
mol
g
C V
prelevato
T T
/ % 100
1000
60
=
Determinazione dellacidit dellolio doliva
1. Si diluiscono circa 10g di olio in una miscela 1 : 2 di alcol etilico
ed etere
2. Si aggiungono alcune gocce di fenolftaleina (soluzione alcolica
0.1%)
3. Si titola con una soluzione 0.100Min NaOH
4. Si determina lacidit, come % dellacido oleico, (solitamente
componente al >65% dellolio di oliva):
- V
T
= volume in ml di titolante
- M= titolo del titolante
- MM= peso molecolare dellacido oleico = 282.47gmol
1
p = grammi esatti di olio pesati
100
1000
%
=
p
MM M V
T
COOH
Determinazione dell Determinazione dell acidit acidit dell dell olio d olio d oliva oliva
Categoria Acidit, %
Extravergine < 1
Vergine < 2
Vergine corrente < 3.3
Vergine lampante < 3.3
Vergine raffinato < 0.5
Oliva < 1.5
Sansa di oliva greggio < 2.0
Sansa di oliva greggio < 0.5
Sansa di oliva < 1.5
Alcalinit e acidit at t uali
Si definisce alcalinit
at t uale o [ H
+
] libero,
dissociat o in soluzione
la concent razione degli ioni
OH
-
, ot t enibile misurando il
pH e t enendo cont o del
valore del prodot t o ionico
dell' acqua alla t emperat ura
alla quale il pH st at o
det erminat o.
det erminat a t ramit e pH-
met ro.
N:B: per campioni colorat i si ut ilizza il pHmet ro nel seguire
l' aggiunt a di t it olant e acido o basico fino al pH not o del
viraggio relat ivo alle det rer minazioni st echiomet riche
V
equivalente
I l residuo fisso un paramet ro ut ilizzat o per classificare le acque
in generale. Solit ament e espresso in mg/ l, indica la quant it di
sost anza solida perfet t ament e secca che rimane dopo aver fat t o
evaporare in una capsula di Pt , pre- t arat a, una quant it not a di
acqua precedent ement e filt rat a.
Per det erminare corret t ament e il residuo fisso, dopo
l' evaporazione si riscalda la capsula a 100 C fino a peso cost ant e
e poi si riscalda di nuovo a 180 C nuovament e fino a peso
cost ant e ( eliminando cos i sali di ammonio pi volat ili ed alcune
sost anze organiche) .
Si pu poi riscaldarla ult eriorment e a 500 C dist r uggendo t ut t i i
sali di ammonio, le sost anze organiche ed i nit rat i. I l risult at o si
esprime in ppm oppur e in mg/ l, specificando sempre a quale
t emperat ura ci si riferisce ( residuo fisso a 180 C o residuo fisso a
500 C) .
I n base al suo valore si dist inguono:
acque met eoriche: compreso t ra 10 e 80 mg/ l
acque oligominerali: compreso t ra 80 e 200 mg/ l
acque mediominerali: compreso t ra 200 e 1.000 mg/ l
acque minerali: superiore a 1.000 mg/ l
acque salat e: superiore a 30.000 mg/ l
Residuo fisso
Tit olazioni per precipit azione
rilevazione del punto finale con metodi potenziometrici
rilevazione del punto finale con indicatori (argentometria)
Per la rivelazione del punto di arresto si pu sfruttare:
1. la precipitazione di un sale colorato,
2. la formazione di un composto colorato solubile,
3. l'adsorbimento di opportune sostanze sul precipitato in vicinanza del p.e.
Gli indicatori devono essere aggiunti in quantit opportuna e, anche nel
caso delle titolazioni di precipitazione, conviene eseguire una
titolazione in bianco. Questo per sottrarre il volume di titolante
necessario a fare virare l'indicatore stesso dal volume totale aggiunto
per raggiungere il p.e.
da integrare dal libro di testo consigliato D. Harris, Zanichelli Ed.
1991, Chimica analitica quantitativa, Cap. 9
Titolazione di Mohr
standardizzazione soluzione AgNO
3
Ag
+
+ Cl
AgCl (s) K
s
(AgCl)=1.2 10
-10
M
2
bianco
2Ag
+
+ CrO
4
2
Ag
2
CrO
4
(s) K
s
(Ag
2
CrO
4
)=1.7 10
-12
M
3
giallo giallo rosso
M
K
S
M K S
s
CrO Ag
s AgCl
5
3
5
10 5 . 7
4
10 2 . 1
4 2
= =
= =
meno solubile
Nell'aggiungere Ag
+
ad una soluzione contenente Cl
-
e CrO
4
2-
,
precipita prima il sale con la solubilit pi bassa
Titolazione di Mohr
analisi incognito
1. Determinazione Cl
, Br
, CN
2. Controllo pH con tampone (PO
4
3-
/HPO
4
2-
, eccesso di NaHCO
3
o Na
2
B
4
O
7
10 H
2
O)
(6.5 < pH < 9.0)
- pH < 7
2CrO
4
2
+ 2H
+
2HCrO
4
Cr
2
O
7
2
+ H
2
O
- pH > 7
2Ag
+
+ 2OH
2Ag(OH) Ag
2
O (s) + H
2
O
K
s
Ag(OH) = 2.3 10
-8
M
2
K
s
(Ag
2
O)=3.810
-16
M
3
Una prova sul bianco consente di determinare il volume di titolante minimo da
aggiungere ad una soluzione di cromato in concentrazione uguale a quella della
titolazione perch l'occhio apprezzi la comparsa della colorazione rossa dovuta al
precipitato.
3. Titolazione in bianco in assenza di cloruro
4. Standardizzazione di AgNO
3
con NaCl come sostanza madre
4. Det erminazione del t it olo di una soluzione ca 0. 1M AgNO
3
AgNO
3
+ NaCl AgCl (s) + NaNO
3
1 ) Stima della massa di NaCl da impiegare come standard primario:
30ml 0.1M 58g/mol =174mg
2) Indicatore: K
2
Cr
2
O
4
giallo giallo rosso
Ag
+
+ Cl
AgCl (s) K
eq
= K
s
-1
= 10
10
M
2
2Ag
+
+ CrO
4
2
Ag
2
CrO
4
(s)
3. Titolato: AgNO
3
4. Titolante: NaCl standard
5. Volume equivalente, V
eq
6. Titolazione in bianco (V
b
)
7. Determinazione del titolo:
) (AgNO
) -
(
(NaCl)
/ 58
(NaCl)
3 b eq M V V mol
mol g
g
=
Fe
3+
+ SCN
Titolazione di Volhard: standardizzazione soluzione AgNO
3
Ag
+
+ SCN
AgSCN (s) K
s
=7.1 10
-13
M
2
bianco
La titolazione viene eseguita a pH acidi per evitare la precipitazione di
Fe(OH)
3
. La soluzione di Fe
3+
in SCN
-
si colora di rosso.
La colorazione del complesso visibile a partire da concentrazioni dellordine
di 6,4.10
-6
M. Nelle normali condizioni di lavoro, questo implica luso di una
concentrazione di Fe
3+
in soluzione dellordine di 0,3 M.
La titolazione di Volhard si usa per la determinazione indiretta degli ioni
alogenuro: si aggiunge un eccesso di ioni Ag
+
alla soluzione degli alogenuri e si
titola leccesso di ioni argento. Il metodo utile per titolare gli alogenuri in
presenza di ioni carbonato, ossalato e arseniato, che pure possono precipitare
come sali di argento ma pH neutri.
rosso giallo
FeSCN
2+
Titolazione di Volhard: analisi incognito
1. Si precipita tutto il Cl
con un eccesso noto di AgNO
3
standard
Ag
+
+ Cl
-
AgCl (s)
2. Si separa per filtrazione l'AgCl (pi solubile di AgSCN,
verrebbe spostato)
AgCl (s) + SCN
-
AgSCN (s) + Cl
-
3. Si retrotitola l'eccesso di Ag
+
con KSCN standard in
presenza di Fe(NH
4
)(SO
4
)
2
12 H
2
O/HNO
3
Ag
+
+ SCN
AgSCN AgSCN (s)
4. Quando tutto Ag
+
stato titolato, SCN
-
reagisce con Fe
3+
per formare un complesso rosso
FeSCN
2+
rosso giallo giallo
[Fe(SCN)
2
]
+
Fe
3+
+ SCN
+SCN
-
1. Determinazione di Br
, I
, SCN
, OCN
, AsO
4
3
e, previa
filtrazione, di Cl
, CN
, PO
4
3
, C
2
O
4
2
, CO
3
2
, S
2
, CrO
4
2
,
H
+
2. Retrotitolazione applicabile alla titolazione di Mohr
- AgSCN meno solubile di AgCl
- AgCl (s) + SCN
AgSCN (s) + Cl
- filtrazione o PhNO
2
(immiscibile)
3. Impiego di KSCN come sostanza madre
4. Fe(NH
4
)(SO
4
)
2
12 H
2
O
Tit olazione di Volhard
Titolazione complessometrica
quella basata sulla formazione di un solo ione complesso e con
unelevata costante di stabilit: [M] > 10
6
Me
z+
+ H
2
Y
2-
MeY
z-4
+ 2H
+
Indicatori metallocromici
Metodi per la determinazione del punto finale:
1. Indicatori metallocromici
2. Elettrodo a mercurio: HgY
2
Hg
2+
+ Y
2
3. Elettrodo di vetro:
4. Elettrodi iono-selettivi: pM
Il metallo non deve bloccare lindicatore
(non sempre si opera con EDTA o analoghi, tra i leganti pi forti)
Il pH influisce sulla variazione cromatica
da integrare dal libro di testo consigliato D. Harris, Zanichelli Ed.
1991, Chimica analitica quantitativa, Cap. 14
In
3-
prevale a pH > 12.6
HIn
2-
prevale a 7.3 < pH < 10.6
H
2
In
-
prevale a ? < pH < 5.3
(forma commerciale: sale sodico)
pH=10
rosso sia a pH < 5.3, sia a pH=10 se legato ad un metallo
blu a pH=10 se libero
MeHIn
z-2
+ EDTA
4-
MeEDTA
z-4
+ HIn
2-
N
N
HO
O
-
-O
3
S
O
2
N
H
2
In
-
rosso
HIn
2-
blu
In
3-
arancione
HIn
2-
pK
1
= ?
pK
2
= 6.3
pK
3
= 11.6
NERO ERIOCROMO-T
pH=10
Controllo del titolo di una soluzione di EDTA ~ 0.01M
con ZnSO
4
standard
1. In beuta sono sciolti circa 100 mg di ZnSO
4
con 50 ml di H
2
O
2. Si aggiunge il tampone ammoniacale
3. Si aggiungono alcuni granuli di NET: la soluzione gi si colora
di viola intenso
Zn(NH
3
)
4
2+
aq + HIn
2-
Zn(HIn)
+ 4 NH
3
pH=10
| |
EDTA
Zn
2
V
V Zn
EDTA dell' Titolo
2+
+
=
4. Zn(HIn)
+ Y
4-
pH=10
ZnY
-2
+ HIn
2-
viola incolore incolore blu
Per durezza dell' acqua si i nt ende un val ore che espri me il
cont enut o di sali di cal cio e magnesi o ol t re che di event uali met alli
pesant i present i . General ment e con quest o t ermi ne si int ende
ri feri rsi all a durezza t ot ale;
Ca
+ +
e Mg
+ +
ost acolano l' at t ivit dei det ergent i perch
precipit ano i fosfat i e lauril solfat i, p. es, sot t raendoli al loro ruolo
e, fissandoli come sali sui capi, rovinano pure quest i!
La durezza permanent e espri me i nvece l a quant i t di cat i oni
ri mast i in sol uzi one dopo ebollizione prolungat a.
Durezza di un acqua
La durezza permanent e espri me i nvece l a quant i t di cat i oni
ri mast i in sol uzi one dopo ebollizione prolungat a.
Durezza di un acqua
I sali della durezza sono solit ament e present i nell' acqua
come solfat i, cloruri, nit rat i, carbonat i o bicarbonat i,
che generalment e sono solubili ma per riscaldament o o per
evaporazione precipit ano formando incrost azioni.
La l oro di fferenza, vi st o che per ebol lizi one solo i bi carbonat i
subi scono una t rasformazi one chi mi ca, det t a durezza
t emporanea ed espr i me sost anzi al ment e il quant i t at i vo di
bi carbonat i che preci pi t ano come carbonat i per ebol li zi one
Durezza dell' acqua
La durezza t emporanea quel l a ot t enut a per di fferenza t ra l e
precedent i durezze: espri me sost anzi al ment e il quant i t at i vo dei
sol i bi carbonat i che preci pi t ano come carbonat i per ebol li zi one.
I l t ermi ne durezza t emporanea l egat o ai bi carbonat i
spi egat o dall ' inst aurarsi dell ' equili bri o chi mi co del t i po:
Ca( HCO
3
)
2
CaCO
3
+ CO
2
+ H
2
O
1F = 10 mg/ l
fino a 4F: molt o dolci
da 4F a 8F: dolci
da 8F a 12F: mediament e dure
da 12F a 18F: discret ament e dure
da 18F a 30F: dure
olt re 30F: molt o dur e
Determinazione della durezza dellacqua (1)
Durezza temporanea: carbonati di calcio e magnesio
Durezza permanente: cloruri e solfati
F = 0.010 g (CaCO
3
)/dm
1. Sono posti in beuta 100ml di acqua con alcuni
granuli di NET e tampone ammoniacale
2. Si titola con EDTA standard, Y
4-
CaHIn
+ Y
4-
pH=10
CaY
2-
+ 2 HIn
2-
viola incolore incolore blu
MgHIn
+ Y
4-
pH=10
MgY
2-
+ 2 HIn
2-
3. Calcolo della concentrazione totale dei carbonati alcalini
| |
O H
EDTA 2
2
V
V EDTA
[Me =
+
]
rosso sia a pH < 5.3, sia a pH=10 se legato ad un metallo
per -SO
3
-
MeHIn
z-2
+ EDTA
4-
MeEDTA
z-4
+ HIn
2-
N
N
HO
O
-
-
O
3
S
O
2
N
H
2
In
-
rosso
HIn
2-
blu
In
3-
arancione
HIn
2-
pK
1
= ?
pK
2
= 6.3
pK
3
= 11.6
NERO ERIOCROMO-T
pH=10
4. Sono posti in beuta 100ml di acqua con alcuni granuli di
acido calconcarbonico (reagente di Patton)
5. Si aggiungono 3ml di NaOH 6M: a questo pH precipita
Mg(OH)
2
N N
HOOC OH
SO
3
H
HO
6. Si titola con EDTA standard Ca
2+
(Il primo eccesso di EDTA comincia a ridissolvere Mg(OH)
2
)
7. Calcolo della durezza: F = 0.010 g (CaCO
3
)/dm
| |
g
dm
mol
g
F
010 . 0
09 . 100
V
V EDTA
3
O H
EDTA
2
=
CaHIn
+ Y
4-
pH=13
CaY
2-
+ 2 HIn
2-
rosso incolore incolore blu
Agenti complessanti ausiliari: impediscono la precipitazione
del catione in assenza di EDTA (ammoniaca, tartrato, citrato)
Pb(OH)
2
ridisciolto da NH
3
a pH=10
Agenti mascheranti: impediscono linterferenza di una specie
nella determinazione dellanalita
CN
maschera Cd
2+
rispetto al Pb
2+
F
maschera Fe
3+
rispetto al Cu
2+
OH
maschera Mg
2+
rispetto al Ca
2+
Agenti demascheranti: tiourea, H
2
O
2
TITOLAZIONE REDOX
Le Le titolazioni di ossidoriduzione permettono la determinazione del titolazioni di ossidoriduzione permettono la determinazione del la maggior parte la maggior parte
degli elementi e, nell'analisi organica, di numerosi gruppi funz degli elementi e, nell'analisi organica, di numerosi gruppi funzionali. Sono disponibili ionali. Sono disponibili
ossidanti ossidanti forti forti (permanganato, Ce (permanganato, Ce
4+ 4+
) e ossidanti meno energici (iodio, bicromato, ) e ossidanti meno energici (iodio, bicromato,
bromato, ecc.). Le reazioni a disposizione sono numerose. Per bromato, ecc.). Le reazioni a disposizione sono numerose. Per es es.: .:
5C 5C
2 2
O O
4 4
2 2- -
+ 2MnO + 2MnO
4 4
- -
+ 16H + 16H
+ +
= 2Mn = 2Mn
2+ 2+
+ 10CO + 10CO
2 2
+ 8H + 8H
2 2
O O
I I
3 3
- -
+ 2 S + 2 S
2 2
O O
3 3
2 2- -
= 3I = 3I
- -
+ S + S
4 4
O O
6 6
2 2- -
C C
6 6
H H
5 5
- -N=N N=N- -C C
6 6
H H
5 5
+ 4Cr + 4Cr
2+ 2+
+ 4 H + 4 H
+ +
= 2 C = 2 C
6 6
H H
5 5
- -NH NH
2 2
+ 4Cr + 4Cr
3+ 3+
L'uso di riducenti L'uso di riducenti molto meno frequente in quanto essi possono reagire con molto meno frequente in quanto essi possono reagire con
l'ossigeno atmosferico se non si lavora in atmosfera inerte, per l'ossigeno atmosferico se non si lavora in atmosfera inerte, per esempio sotto flusso di esempio sotto flusso di
azoto. azoto.
Il grado di completezza della reazione, e quindi la sua quantita Il grado di completezza della reazione, e quindi la sua quantitativit tivit , dipende dalla , dipende dalla
differenza tra i potenziali standard (o formali) delle due coppi differenza tra i potenziali standard (o formali) delle due coppie di ossidoriduzione e di ossidoriduzione
coinvolte nella reazione in quanto, come visto coinvolte nella reazione in quanto, come visto
A AV V = RT/nF ln K = RT/nF ln K
eq eq
da integrare dal libro di testo consigliato D. Harris, Zanichelli Ed.
1991, Chimica analitica quantitativa, Cap. 17
Titolazioni di ossidoriduzione
Sono quelle che si basano su una reazione redox tra
analita e titolante
Indicatore redox: composto che cambia colore quando
passa dallo stato ossidato a quello ridotto
FERROINA
In (ossidato) + ne
In (ridotto)
N
N
Fe(III)
3
3+
+ e
-
N
N
Fe(II)
3
2+
Standardizzazione di una soluzione di KMnO
4
con
Na
2
C
2
O
4
MnO
4
-
+ 5 e
+ 8H
+
Mn
2+
+ 4 H
2
O
viola incolore
1. Tracce di MnO
2
precludono luso del permanganato come sostanza madre
(ossidazione dellacqua)
lenta
4 MnO
4
-
+ 2 H
2
O 4 MnO
2
(s) + 3 O
2
+ 4 OH
2. Si pesano con buona accuratezza circa 0.20g di Na
2
C
2
O
4
,
volendo usare
30ml di MnO
4
circa 0.1M
3. Si titola con KMnO
4
circa 0.1M in buretta e riscaldando la soluzione a
70C* in beuta per innescare la reazione: al primo viola tenue deve
seguire lincolore:
2MnO
4
-
+ 5C
2
O
4
2
+ 16H
+
2Mn
2+
+ 10 CO
2
+ 8 H
2
O
4. Gli ioni poliatomici scambiano elettroni meno facilmente a causa
dellingombro offerto dagli atomi legati al metallo
5. Il primo viola tenue persistente indica eccesso di MnO
4
-
6. La persistenza labile per via della autossidazione
2 MnO
4
-
+ 3 Mn
2+
+ 2 H
2
O 4 MnO
2
(s) + 4 H
+
* bisogna tenere presente che a temperature superiori H
2
C
2
O
4
si decompone in: H
2
C
2
O
4
CO
2
(g) + CO(g) + H
2
O
Potrebbero piacerti anche
- 6 - Standardzzazione Di Una Soluzione Di HCL Con Carbonato Di SodioNessuna valutazione finora6 - Standardzzazione Di Una Soluzione Di HCL Con Carbonato Di Sodio4 pagine
- Fondamenti Di Chimica Analitica QuantitativaNessuna valutazione finoraFondamenti Di Chimica Analitica Quantitativa26 pagine
- Chimica Fisica Lezioni Prof. MarrelliNessuna valutazione finoraChimica Fisica Lezioni Prof. Marrelli105 pagine
- Slides Chimica I Equilibrio ChimicoNessuna valutazione finoraSlides Chimica I Equilibrio Chimico69 pagine
- Esercizi Da Vecchi Appelli Di EsameNessuna valutazione finoraEsercizi Da Vecchi Appelli Di Esame231 pagine
- 10b - Calcolo Del PH Di Acidi e Basi Forti e Deboli100% (1)10b - Calcolo Del PH Di Acidi e Basi Forti e Deboli4 pagine
- 2439-20100622-Soluzioni Compito 18 06 10Nessuna valutazione finora2439-20100622-Soluzioni Compito 18 06 104 pagine
- Formulario Chimica Con Elementi FantachimicaNessuna valutazione finoraFormulario Chimica Con Elementi Fantachimica8 pagine
- Chimica Applicata Allambiente Lezione 1Nessuna valutazione finoraChimica Applicata Allambiente Lezione 155 pagine
- ESERCIZI SULLA FORMULA MINIMA E MOLECOLARE (Soluz)Nessuna valutazione finoraESERCIZI SULLA FORMULA MINIMA E MOLECOLARE (Soluz)1 pagina
- La Forza Degli Acidi e Delle Basi: NH + H O NH + OhNessuna valutazione finoraLa Forza Degli Acidi e Delle Basi: NH + H O NH + Oh70 pagine
- Chimica - Reazioni Di Organica by SilvioNessuna valutazione finoraChimica - Reazioni Di Organica by Silvio12 pagine
- Analisi Volumetrica Acido - Base BiolNessuna valutazione finoraAnalisi Volumetrica Acido - Base Biol40 pagine
- Analisi Quantitativa IV Analisi Volumetrica (B J Kakos)Nessuna valutazione finoraAnalisi Quantitativa IV Analisi Volumetrica (B J Kakos)26 pagine
- Quaderno Di Laboratorio: Corso Di Laboratorio Di Chimica Applicata Agli AlimentiNessuna valutazione finoraQuaderno Di Laboratorio: Corso Di Laboratorio Di Chimica Applicata Agli Alimenti104 pagine
- Preparazione e Standardizzazione Di Soluzioni Acido-BaseNessuna valutazione finoraPreparazione e Standardizzazione Di Soluzioni Acido-Base3 pagine
- Chimica Generale + Problemi Svolti Pp.242Nessuna valutazione finoraChimica Generale + Problemi Svolti Pp.242242 pagine