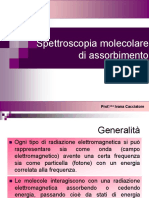Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
281 visualizzazioni4 pagineSTRUMENTALE Spettrofotometria
Questa esperienza descrive l'uso della spettrofotometria per determinare la costante di dissociazione acida (pKa) di un indicatore acido-base, il rosso di metile. Vengono preparate soluzioni a pH noti dell'indicatore e registrati gli spettri di assorbimento. I coefficienti di estinzione e le concentrazioni delle due forme vengono quindi calcolati e utilizzati per determinare il pKa.
Caricato da
Marta MichiCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
281 visualizzazioni4 pagineSTRUMENTALE Spettrofotometria
Questa esperienza descrive l'uso della spettrofotometria per determinare la costante di dissociazione acida (pKa) di un indicatore acido-base, il rosso di metile. Vengono preparate soluzioni a pH noti dell'indicatore e registrati gli spettri di assorbimento. I coefficienti di estinzione e le concentrazioni delle due forme vengono quindi calcolati e utilizzati per determinare il pKa.
Caricato da
Marta MichiCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd