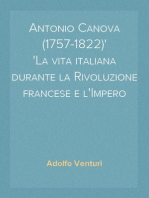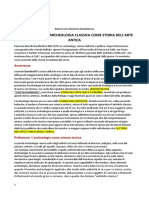Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Arte Romana. Papini.
Caricato da
auro1230Titolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Arte Romana. Papini.
Caricato da
auro1230Copyright:
Formati disponibili
lOMoARcPSD|9887176
Arte romana - Papini
Archeologia e storia dell’arte greca e romana (Università Telematica Internazionale
UniNettuno)
Studocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Capitolo 1 – È mai esistita un’arte romana?
Introduzione
Le arti figurative non erano sentite dai romani come una consuetudine. Essi pensavano che fosse “cosa
d’altri” ed erano molto diffidenti verso l’arte, considerata una perdita di tempo.
Quando nel 212 a.C. il conquistatore di Siracusa M. Claudio Marcello portò a Roma un ricco bottino che
comprendeva anche statue e quadri che emanavano la bellezza e il fascino tipici dell’arte greca, gli fu
rinfacciato di aver riempito Roma di inutili frivolezze.
Le arti greche però avevano conquistato il rustico Lazio molto prima.
Dalla fine del secolo IX d.C. in Italia le ondate di cultura greca furono molte. Le influenze non furono
passivamente subite, ma adattate a tradizioni e a condizioni storiche e sociali degli ambienti ospitanti e
riformulate. Dal secolo IV a.C. Roma entra in contatto direttamente con diversi ambiti greci in Italia
meridionale e in Sicilia e poi in Grecia. Il loro rapporto fu basilare sin dalle origini, tuttavia Roma, città
latina, fu sì grecizzata, ma non greca ed ebbe un’identità composita e plurale.
Quello che troviamo è un’arte fatta di correnti del tutto diseguali, di origine non ben definita, in bilico fra la
ricezione di modelli greci secondo un gusto “neoclassico” e un realismo “popolare” spesso crudo, e che
presenta come conseguenza ultima una rigidità di forme, in apparenza “anticlassica”, dello stile
“tardoromano”.
La concezione artistica romana si trova nell’inclinazione “cronachistica” e in uno spirito più concretamente
terreno che divino, più storico e attuale che mitico, insomma più utilitaristico (come quello espressosi nella
costruzione di acquedotti, ponti, magazzini, terme) che dedito a una fruizione estetica delle opere.
Arte romana per pura convenzione con questo termine vengono identificate le produzioni a Roma ed
entro i confini dello Stato romano e della sua durata nel tempo, in senso cronologico e geografico.
Confini cronologici Al di là delle diverse opinioni degli studiosi, si profila una storia dell’arte, almeno per
Roma e l’Italia, che abbraccia approssimativamente i secoli dalla cultura materiale laziale del secolo X a.C.
sino ai mosaici di S. Vitale a Ravenna (547 d.C. circa).
Confini geografici Dall’Urbe (centro) al vasto territorio dell’impero (periferie).
L’arte romana si fonde con le tradizioni dei vari territori che erano sotto l’impero romano, ma che
conservavano anche le loro tradizioni e i loro costumi (i romani erano tolleranti verso le altre culture, anche
se sottomettevano gli altri popoli).
Sarcofago di Palmyra – Il defunto, rappresentato sul coperchio del sarcofago, indossa vesti partiche, mentre
sempre lo stesso raffigurato su un lato della cassa indossa tunica e toga tipiche dei cittadini romani, ma non
porta il capo velato come essi.
Lenzuolo funebre da Saqqara – il defunto ha un viso incorniciato da una folta acconciatura di moda in età
antoniniana ed è ritratto secondo la tradizione greco-romana, mentre al suo fianco il dio Anubi e la
mummia, nell’iconografia di Osiride, sono raffigurati alla maniera egizia.
1.1 Una lenta riscoperta
Il concetto di arte romana non esisteva prima del IX secolo, in quanto l’arte di quell’epoca era considerata
solamente un segno di decadenza dell’arte greca (- Joachim Winckelmann).
Fu la Scuola di Vienna a rivalutare l’arte romana e a riconoscerle un processo non di degenerazione della
perfezione greca, bensì di sviluppo (- Franz Wickhoff).
Kunstwollen = concetto analitico-filosofico introdotto nei primi anni del 1900 da Alois Riegl. Il Kunstwollen
è la legge sistematica e suprema, il principio regolatore intuitivo, collettivo e anonimo, ricavabile dalla
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
considerazione di un vero e proprio dato artistico, ossia dal fenomeno dell’oggetto come forma e colore nel
piano e nello spazio, indipendentemente dallo scopo utilitario, dalla tecnica e dalla materia prima.
Per Riegl il Kunstwollen degli Antichi progredì in tre stadi: il primo, “tattile”, per una visione da vicino senza
scorci e ombre, con l’accento principale messo su contorni per quanto possibile simmetrici (arte egiziana); il
secondo, “tattile-ottico”, per una visione “normale” a metà tra una da vicino e una da lontano, con un
collegamento delle cose aggettanti con il piano di fondo e con l’introduzione di ombre mai profonde dal
compito prettamente “tattile”, ossia per delimitare le superfici parziali (arte greca, ellenistica e arte del
primo periodo imperiale); il terzo, puramente “ottico” per una visione a distanza, da Costantino in poi, con
un proprio autonomo Kunstwollen completamente positivo e vicino alla concezione di arte moderna, a
conclusione di una fase artistica avviata dagli anni di Marco Aurelio, allorché la superficie delle figure
cominciò a essere scavata a trapano, come visibile nella ritrattistica e soprattutto sui sarcofagi.
Dopo le teorie di Riegl ogni ragionamento sul riconoscimento di una forza specificatamente italica e romana
nonché aliena da influssi greci è cessato poco a poco.
Nel 1964 Ranuccio Bianchi Bandinelli denunciava l’assenza di metodi consoni per affrontare il “problema”
relativo alla storia dell’arte romana per più cause: il suo proverbiale relegamento in una sfera subordinata
alla greca; l’oggettiva difficoltà nel potere ridurre a un discorso logico, quindi storico, un fenomeno
discontinuo e differenziato; la lentezza con cui era stato accolto a livello italiano e internazionale lo sforzo
di rivalutazione compiuto dalla Scuola di Vienna per uscire dagli schemi “neoclassici”; la persistenza di un
generico concetto di decadenza.
1.2 Teorie dualistiche
Le teorie dualistiche individuano una bipolarità all’interno della stessa arte romana, ossia due filoni, con
prevalenza dell’uno o dell’altro o secondo percorsi anche coesistenti ma separati.
1) L’“Arte popolare” per Gerhart Rodenwaldt
Mentre la grande architettura statale fu più “classicistica” (quindi più greca), quella “popolare” rispecchia la
tradizione nazionale non classica come nella resa di ritratti e azioni sulle stele e are funerarie e altre opere
minori. Una corrente priva di eleganza ma colma di potenza espressiva, una sorta di arte provinciale dentro
l’Urbe.
Caratteristiche: frontalità dei personaggi principali; composizioni simmetriche rispetto a un punto centrale;
dimensioni delle figure variate a seconda dell’importanza e non della prospettiva o delle proporzioni
naturali; subordinazione degli elementi di contorno alle figure più importanti; resa con brio dei dettagli di
azioni e oggetti.
2) “Arte plebea” per Ranuccio Bianchi Bandinelli
Simile versione fu poi rivista da Bianchi Bandinelli, che valutò il termine “arte popolare” come impreciso e
ambiguo; per evitare ogni equivoco “idealistico”, nel 1967 gli preferì “arte plebea”, in contrasto ad “arte
aulica” o “ufficiale”, determinazione più critica e storica e non sociologica di un filone promosso da un “ceto
medio” – la plebs – con esclusione di patrizi e senatori.
Tale corrente, per lo più immune alle influenze dei più colti modelli greci, a tratti qualitativamente poco
apprezzabile, ma più autenticamente romana, poté avere per Bianchi Bandinelli un proprio svolgimento
stilistico con connessioni con il passato, il presente e il futuro, ovvero: con la tradizione preromana della
penisola italica; con l’arte provinciale extraitalica; con l’arte ufficiale tardoantica, che ne costituiva una
continuazione e una conseguenza.
L’espressione “arte plebea” ha in genere prevalso su quella di “arte popolare”. Semmai sono state tante le
puntualizzazioni nel tempo come quella che a ragione tende a sfumare ogni facile assimilazione tra “arte
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
plebea” e “arte provinciale”. È inoltre definitivamente compiuto il superamento del dualismo nel senso di
un’esatta separazione tra due correnti autonome. In effetti, sono significative le compenetrazioni tra l’”arte
plebea” e quella ufficiale: singole componenti dell’”arte plebea” possono benissimo infiltrarsi nelle
espressioni figurative più ufficiali. Di conseguenza non sono mancati negli anni tentativi di introduzione di
concetti più neutri come “arte sub-antica” o “stile presentativo”. Eppure sarà difficile disfarsi del concetto
di “arte plebea”: una nozione diventata comoda perché capace di richiamare alla mente alcuni principi
compositivi e bisogni espressivi di uno dei plurimi percorsi dell’arte romana. E sono proprio le teorie
pluralistiche ad avere maggiormente valorizzato le convivenze di più indirizzi, smorzando sia le opposizioni
fra “greco” e “romano” sia le idee di un Kunstwollen unitario.
1.3 Teorie pluralistiche
I blocchi coesi nei singoli periodi dell’arte romana sono un’illusione. In ogni periodo si riscontrerebbe il
fenomeno delle molteplicità tra i poli estremi dell’arte statale e di quella “popolare”, determinate da “stili
di genere” dipendenti dai temi, dal medium adoperato e dai formati delle opere. In ogni periodo domina o
sembra dominare uno “stile d’epoca” risultante dalla predominanza di un determinato “stile di genere”
sugli altri.
Fu Otto Brendel nel 1953 a prendere atto della varietà di libere scelte possibili a espressione di “pubbliche
aspirazioni e di sentimenti privati, di oscillazioni di gusto o di interessi e avversità da parte di artisti”.
Brendel fece propria anche la definizione di “stili di genere”, condizionati dai soggetti delle opere, dalle loro
finalità e importanza nei contesti architettonici nonché dall’appartenenza alle sfere pubblica o privata, la
seconda rivalorizzata anche in considerazione del numero di documenti più caratterizzati da uno schietto
ellenismo.
A quella di “stili di genere” sono subentrate le nozioni del linguaggio figurativo tipologico quale mezzo di
comunicazione visiva e del pluralismo nella scelta dei modelli (greci) destoricizzati, ossia utilizzati per nuovi
contesti romani in modo non per forza condizionato dalle loro origini.
Dall’età repubblicana in poi, a disposizione degli artigiani si trovavano tante composizioni e forme
succedutesi nell’arte greca dalla fine del secolo VI a.C. sino al tardo ellenismo (intorno alla metà del secolo
II a.C.) e poi come congelate in un repertorio canonico non troppo ampio entro cui poter trascegliere a
seconda delle occasioni, dei contenuti e dei valori da esprimere. Quei modelli, simultaneamente disponibili,
potevano variare addirittura su uno stesso monumento, come sull’ara Pacis, assurta oggi a esempio
massimo su cui verificare il linguaggio tipologico.
Da qui derivò la creazione nel mondo romano di un “sistema semantico” rimasto piuttosto stabile nei secoli
e valido in tutti l’Impero, utilizzato spontaneamente nella pratica delle officine e recepito altrettanto
naturalmente nelle abitudini visive degli osservatori.
1.4 Tendenze attuali della storia dell’arte antica
Mentre nella storia dell’arte moderna sin dagli anni Cinquanta del Novecento aveva esordito la storia
sociale dell’arte, nel pensiero di Bianchi Bandinelli negli anni Sessanta e Settanta, come accennato, si era
manifestato il rifiuto di un’archeologia classica intesa essenzialmente come storia dell’arte; donde
l’esigenza di un’indagine dell’opera attenta non solo alla forma, ma anche al contenuto, da correlare a una
più ampia realtà storica e a un determinato gruppo sociale, tanto più per il versante romano, dove a suo
dire – e di altri prima di lui – l’arte sarebbe stata sempre espressione di una situazione sociale o di
un’affermazione politica: giusto, ma si deve aggiungere che quella greca non fu da meno. “Solamente
scoprendo quei nessi economici, politici e quei rapporti ideologici, infatti, l’opera d’arte assume il suo vero
valore storico di testimonianza”.
La storia dell’arte antica è diventata solo una parte dell’archeologia classica. Quest’ultima aspira alla
sistematicità e alla raccolta di ogni dato al fine di ricostruire della storia, dei contesti attraverso il tempo e
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
dei comportamenti degli Antichi. Era proprio così che il grande storico dell’arte viennese Ernst Gombrich la
vedeva. Egli tenne un seminario sulla “tazzologia” in quanto era convinto che la tazzologia pertenesse
all’archeologia perché qualsiasi tazza o coppa può servire come spunto per analizzare una delle
innumerevoli catene di cause ed effetti che alla fine producono l’oggetto che abbiamo davanti, mentre
altre discipline umanistiche, come la storia dell’arte, dipenderebbero da un sistema di valori e da un criterio
di selezione.
La storia dell’arte romana e greca si dedica ora allo studio della produzione di manufatti e immagini quali
strumenti di comunicazione e di rappresentazione/autorappresentazione dei vari tipi di élite e dei cittadini
più comuni nonché all’esame dei loro valori emozionali per ricostruire le mentalità dei committenti e la
recezione dei destinatari contemporanei.
1.5 Le parole di un manuale
Materiali
Sono tanti i materiali, e da tutto il mondo: oro, argento; bronzo, rame, ferro e piombo, colori minerali,
avorio, vetro, argilla, gessi; le pietre preziose che fanno fare follie; i marmi bianchi e colorati poi, dai secoli
II-I a.C. irrinunciabili per i processi di monumentalizzazione di Roma, dell’Italia e delle province.
Sempre maggiori attenzioni sono riservate all’individuazione delle principali cave in Oriente e in Africa,
amministrate soprattutto dalla proprietà imperiale, alla distribuzione, ai prezzi e ai depositi dei marmi nei
luoghi di destinazione. È poi largamente diffuso un approccio archeologico alle opere d’arte che analizza i
processi produttivi tramite l’applicazione di tecnologie (analisi archeometriche). Spesso gli scrittori latini
citano i materiali, che erano uno dei molteplici fattori di apprezzamento delle opere, per lamentare in
prediche moralistiche la diffusione del lusso, in grado di soddisfare le più raffinate forme di piacere per
mezzo di oggetti sopravvalutati e pagati a prezzi eccessivi: la cupidigia di possesso era arrivata a sfidare la
natura artifex, ormai esausta di produrre, e non c’era da meravigliarsi che ogni tanto manifestasse la sua
indignazione spalancandosi o mettendosi a tremare (Plinio il Vecchio XXXIII, 1).
Spazi e insiemi decorativi
Che fossero pubblici o privati, sacri e funerari, interni o esterni, gli spazi di una città e del suburbio, erano
saturi di immagini, distribuite secondo il principio del decor, ossia della congruità con le loro sfere d’uso,
che ne potevano incrementare l’importanza: molti oggetti sembrano di grande valore per il solo fatto di
essere consacrati nei templi, afferma Plinio il Vecchio.
Gli ornamenti costituivano accessori indispensabili degli edifici, che potevano gravare per un terzo o per la
metà sui costi globali di costruzione, tanto da divenire oggetto di un esplicito interesse in chiave giuridica in
relazione ai patrimoni immobiliari: le decorazioni partecipavano alla differenziazione degli spazi e alla
modulazione delle gerarchie interne, come per mezzo dell’impiego dei media più elaborati e dispendiosi a
seconda dell’importanza degli ambienti.
I monumenti testimoni della maestà dell’Impero si trovavano in luoghi comuni e frequentati quali aree
sacre e fori; le loro immagini celebravano il potere degli dei e la gloria degli imperatori, così come altri tipi
di committenze tramite le dediche acquisivano prestigio dinnanzi alla comunità dei cittadini. Le decorazioni
non si trovavano solamente in luoghi pubblici, ma anche nelle ville (luoghi privati) e nelle domus (luoghi
semiprivati).
Per quanto riguarda queste ultime, al loro interno non c’erano solo luoghi deputati all’ozio, agli studi e alle
piacevoli conversazioni. Alcuni ambienti erano destinati alle pratiche cultuali officiate dal pater (sacra
privata rivolti ai Penati e ai Lari); altri di rappresentanza, si aprivano alla folla dei clienti legati al dominus-
patronus per la cerimonia della salutatio (vestibolo-atrio, ali, tablino); in altri ancora si esaltavano le
relazioni sociali con persone appartenenti a una cerchia più ristretta di pari grado (triclini per banchetti);
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
altri infine avevano un grado maggiore di intimità (cubicoli).
Alcune decorazioni anche nelle abitazioni miravano alla memoria e all’honos familiare, come le imagines
degli antenati in cera che, estratte dagli atri, sfilavano per le vie principali dell’Urbe sino al foro Romano.
All’esterno delle dimore e intorno alle loro soglie potevano poi trovarsi le spoglie dei nemici vinti, che a un
eventuale compratore non era lecito staccare: perciò le case continuavano eternamente a trionfare anche
mutando padrone.
Committenti
Il ruolo dei committenti era fondamentale. Senza iscrizioni, però, i monumenti di per sé non possono essere
automaticamente associati a determinati gruppi sociali. Tra i principali committenti a Roma – e altrove –
contarono i re, i condottieri e i politici prima e gli imperatori poi (più avanti nel tempo si aggiunsero papi e
vescovi).
I capitoli cronologici (5-9) delineano quindi una storia dell’arte dal punto di vista per lo più degli imperatori
e dell’élite urbana.
Destinatari
Chi poteva dedicarsi a discorsi sulle arti figurative con competenza? Solo un gruppetto di autentici o
sedicenti intellegentes, specialisti in grado sia di giudicare sia di valutare in termini economici l’ars e
l’ingenium delle opere.
La massa dei fruitori era molto differenziata e variegata – stiamo parlando della sola Roma in età imperiale
di una popolazione stimata di settecentomila-un milione di abitanti e di diecimila circa per una città come
Pompei –, per cui gli sguardi dipendevano non solo dalla diversa appartenenza sociale e cultura, ma anche
dai luoghi: le opere d’arte componevano un sottofondo per processioni, giochi, sacrifici, feste e per le
attività quotidiane più disparate e si potevano guardare in modo ora approfondito, ora veloce e selettivo o
semplicemente non prendere in considerazione. Proprio la moltitudine di opere d’arte e ancora di più i
tanti impegni e affari impedivano all’Urbe la contemplatio e l’admiratio, garantite solo dalla tranquillità dei
luoghi silenziosi, dice Plinio il Vecchio (XXXVI, 27).
Artefici
Abbiamo l’abitudine di chiamare “artisti” gli autori delle opere – ma agli Antichi è estraneo il concetto
sublime di “artista” distinto da artigiano e tanto più la separazione tra il lavoro creativo e quello puramente
manuale – o più di rado persino “Maestri”, ma si tratta più propriamente di artefices (pittori, scultori,
cesellatori e così via). Essi, operanti all’interno di officine di grandezza variabile, prendevano il nome per lo
più dalla materia trattata (argentarius, aurarius, aerarius, eborarius, vitrarius, marmorarius, lapidarius –
raro sculptor, mentre statuarius designa l’artefice di statue in bronzo).
Quella romana è però una storia dell’arte prevalentemente senza nomi: le opere in età repubblicana e
imperiale sono spesso anonime (tuttavia anche per motivi di conservazione), non diversamente dagli
edifici, per i quali è raro conoscere gli architetti, mentre i committenti badavano a mettere in bella mostra
se stessi.
Dalle iscrizioni superstiti gli artefici risultano di varia condizione giuridica: liberi, liberti (frequenti) e schiavi.
La stragrande maggioranza degli artefici (quasi tutti maschi) è etnicamente o linguisticamente greca e
pitture, statue, vasellame in argento e gemme ne trasmettono talora le firme seguite da una forma del
verbo facere o da un altro più tecnico come pingere, sculpere, scribere (ma le iscrizioni sono molto più
spesso in greco). Alcuni artefici del I secolo d.C. firmavano le proprie opere con nomi di artisti famosi come
Prassitele, Mirone e Zeusi.
Iconografie
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Per iconografia si intendono singoli schemi figurativi o intere composizioni, circolanti nello spazio e nel
tempo sia in forma non tangibile, ossia nella mente degli artefici, sia mediante disegni, prontuari grafici e
calchi in gesso.
Stili
Da non confondere con le iconografie, lo stile indica l’habitus formale o la maniera complessiva di eseguire
gli schemi iconografici; ed è una componente che può sia soccorrere nella definizione della cronologia dei
manufatti, della loro origine geografica, delle officine e persino delle mani al loro interno, sia concorrere a
comunicare significati.
Per certe classi di manufatti, o persino per l’intera produzione figurativa (e architettonica) di un periodo, gli
studiosi, sulla scia di Blanckenhagen, credono di potere cogliere uno “stile d’epoca”: un denominatore
comune da intendere come una realtà in grado di lasciare segni ovunque, su marmi, metalli, stucchi,
affreschi e argille e non solo, consentendo di distinguere per esempio un prodotto giulio-claudio da un altro
adrianeo o da un altro ancora severiano.
Gli stili variavano nel tempo e potevano reagire a sperimentazioni precedenti, che si trattasse di costruire
sulle loro fondamenta o di differenziarsi da esse. Ma perché gli stili variavano? Vi incidevano fattori come le
relazioni con i temi e le funzioni degli oggetti nonché con gli intenti e i mutevoli gusti dei committenti; e
mutevoli erano poi anche i gusti delle officine.
Stile poi si abbina di frequente ad aggettivi attinti agli studi di storia dell’arte moderna, come “barocco”
(per i rilievi dell’arco di Tito, per alcune espressioni figurative del III secolo d.C. o per le tendenze pittoriche
del “IV stile”), ma l’aggettivo più usato in assoluto è “classicistico”.
“Classicismo”
I significati di “classicismo” sono differenti a seconda dei manufatti (architettura inclusa). In modo
disomogeneo – al pari della parola “classico”, anch’essa ambigua e sfaccettata –, il termine può indicare tra
l’altro la ripresa, letterale o libera, di precisi modelli figurativi di un periodo ristretto; le composizioni
pacate, equilibrate ed eleganti ricollegabili a quella tradizione, come spesso capita nelle opere di grande
formato; ancora, la ricezione dell’arte greca nella sua totalità; oppure, le forme naturalistiche e organiche
(il che avviene quando si studia il Tardoantico). Sono state rimarcate singole componenti e correnti
“classicistiche”, piuttosto costanti ma non confondibili l’una con l’altra, che distinguono nel tempo le varie
produzioni dai secoli IV-III a.C. passando per i secoli I-II d.C., per la “rinascenza gallienica” del secolo III d.C.
e per quella teodosiana della fine del secolo IV d.C. sino alla conservazione delle immagini di dei ed eroi del
secolo VII d.C. nelle argenterie.
Capitolo 2 – Il sistema delle immagini nell’arte di età romana
Introduzione
Le nozioni di “arte popolare”, “arte aulica” e “stile d’epoca” sembrano ormai prive di senso, nel momento
in cui l’interesse critico è rivolto verso le immagini, verso il loro potere e il loro valore in sé, non come
surrogato delle parole, non strutturate come queste, ma come un mondo a sé stante, con le sue regole che
non sottostanno a quelle della linguistica. Gli elementi formali che le compongono assumono un ruolo solo
se rapportati ai loro modi di comunicazione, e al discorso artistico non giovano termini abusati, che
sembrano creare inutili categorie formali, ma che nei fatti ne nascondono le complessità. La storia può
essere narrata o interpretata. Si possono, quindi, raccontare i fatti così come sono accaduti oppure
analizzarli criticamente a seconda dei punti di vista, per parole e per immagini. Gli eventi sono percepiti, in
tal modo, attraverso un filtro che li manipola, che li può giustificare, o ne può enfatizzare la negatività, a
seconda della logica del potere.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
La “svolta iconica” (iconic turn o pictorial turn) sviluppatasi nel campo della visual culture nell’ultimo
ventennio ha rivendicato il ruolo autonomo delle immagini, mostrando che il mondo a cui dà forma la
parola è assai differente. La visual culture, inoltre, non distingue più tra arte e non arte, tra bello e brutto,
tra significativo e banale, ma prende in considerazione tutto il patrimonio visivo.
L’iconologia, disciplina che indaga e interpreta il significato delle immagini nel loro contesto storico, ha
trasferito la propria esplorazione sul potere che queste hanno di influenzare le abitudini e i comportamenti
umani. È l’inevitabile punto di arrivo di una ricerca che ha le sue origini nel mondo greco, quando le
immagini erano, o volevano essere, una mimesi del vero, e quindi avere una propria vita, come una natura
parallela.
Il mito della nascita del ritratto a opera di una fanciulla di Corinto che, perduta d’amore per un giovane in
procinto di partire per un viaggio lungo e periglioso, dall’ombra dell’amante dormiente proiettata sulla
parete di casa, aveva ricavato un suo disegno a silhouette, è l’espressione diretta del significato dell’arte
per i Greci. La fanciulla aveva “clonato” l’amante per tenerlo per sempre al suo fianco. I grandi artisti ne
erano ben coscienti, e avevano gareggiato con la natura: “clonandola” si potrebbe dire con un termine
entrato di prepotenza nella letteratura delle arti visive degli ultimi anni.
La parola è ormai adoperata per indicare tutte quelle riproduzioni digitali attraverso numerosi media che
hanno alterato completamente i nostri modi di vedere e percepire le immagini; ma è anche termine
metaforico che denuncia un timore sotterraneo, un senso di disagio verso tutto ciò che sembra stravolgere
le nostre vecchie concezioni di copia, imitazione o riproduzione secondo natura. Le immagini appaiono con
una loro vita autonoma, con la capacità di sovrapporsi e di surrogare il reale.
Esempi di clonazione nell’antichità: monete, ritratti, rappresentazioni storiche che sono caratterizzati da
immagini stereotipate, archetipi e ripetizioni in serie. C’è una sola grande differenza rispetto al mondo
contemporaneo: non è rimasta quasi nessuna traccia di una visione alternativa, di una critica al potere
costituito se non, evidentemente, in quelle forme di “damnatio memoriae” (vedi cap. 11.4) che cancellano
– e/o sostituiscono – non solo i tratti facciali dei personaggi caduti in disgrazia, ma cercano di sopprimere
anche la testimonianza della loro partecipazione a eventi epocali – per esempio distruggendo i monumenti
da loro costruiti, o usurpandoli con la semplice erasione del loro nome e la trascrizione su di esso di un altro
nome, del vincitore.
A Roma l’operazione era relativamente facile perché, dalla Repubblica in poi, la rappresentazione degli
eventi storici per lo più non aveva avuto carattere narrativo, ma era sintetizzata in schemi simbolici
reiteranti sempre gli stessi messaggi, attraverso gli stessi mezzi di comunicazione.
Solo così si spiega il riadopero, e quindi la rifunzionalizzazione dei rilievi claudi per l’arcus Novus sulla via
Lata, di quelli adrianei per l’“arco di Portogallo”, o di altri traianei, adrianei e antoniniani per l’arco di
Costantino all’inizio del secolo IV d.C. (vedi capitolo 8-9). In questo caso si trattava di alcuni tra i migliori
imperatori, ma sui rilievi gli eventi storici di cui erano stati protagonisti si erano trasformati in codici
semantici tranquillamente usurpabili da un altro imperatore senza che mutasse il loro significato simbolico
originario, sebbene con un riferimento ad altri eventi storici.
Lo studio delle forme di comunicazione attraverso le immagini ci permette di renderci conto del lavoro
necessario da un lato per comprendere quale messaggio il produttore d’immagini volesse trasmettere,
dall’altro per adeguarsi alla mentalità di lettura del loro destinatario. Un esempio fra tanti: l’arte romana
non rappresenta mai il punto di vista dei vinti, ma solo dei vincitori, anche quando sembra percepirsi nelle
immagini una sorta di simpatia nei riguardi del nemico sconfitto. La partecipazione emotiva alla loro
sofferenza è frutto dell’odierna percezione, che non ha nulla a che fare con quella dei Romani che, invece,
volevano enfatizzare l’ardimento dei nemici per accentuare, forse anche con una punta di esagerazione, la
difficoltà dell’impresa e, di conseguenza, il valore romano.
2.1 Sulle nozioni “stile d’epoca”, “arte popolare/plebea”,” stili di genere”
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
“Stile d’epoca” concetto secondo cui in ogni Stato nazionale ogni periodo storico ha avuto un suo stile
specifico, nel senso che si riconoscerebbe nel linguaggio artistico un inconfondibile denominatore comune
che permette di stabilire la contemporaneità di opere d’arte prive di una sicura cronologia basata su
documenti incontrovertibili.
Insieme con i concetti di “arte aulica” e “arte popolare”, lo “stile d’epoca” era una novità venutasi a
costruire nell’alveo dei crescenti nazionalismi che hanno determinato la storia europea tra i secoli XIX e XX.
A un carattere specifico di un popolo, secondo la visione nazionalista, avrebbero corrisposto forme di
espressione appartenenti a quel popolo e solo ad esso. Si è naturalmente discusso in cosa consistesse tale
denominatore comune, senza potere giungere a una soluzione né convincente né univoca.
Il concetto di Kunstwollen (“volontà artistica”), elaborato da Riegl, contiene in sé, appunto, il senso di un
impulso che, indipendente dall’artista, il quale agirebbe nell’ambito dello “stile d’epoca” senza rendersene
conto, sembra orientare tutte le produzioni di un determinato periodo storico, coinvolgendo anche quelle
anonime artigianali nelle quali, anzi, lo stile appare più evidente.
Il significato, che si perde nel termine italiano, nel quale l’atto di volontà è a carattere più personale,
descrive ma non spiega il fenomeno che, tuttavia, permette a Riegl di giungere alla constatazione che i vari
“stili d’epoca” non sono confrontabili tra loro, né si possono giudicare le opere d’arte di un periodo storico
con il metro di giudizio formale proprio di un altro: ciò ha permesso di rivalutare alcuni periodi dell’arte
romana che, nella logica del giudizio comparativo avente come pietra di paragone l’arte greca di età
classica, erano considerati di decadenza.
“Sfera del vivere” esame dell’opera d’arte giudicata come parte integrante e costitutiva della coeva
Lebenswelt (sfera del vivere) è un nuovo approccio critico in contrasto all’approccio formale considerato
sempre più spesso discutibile e comunque incapace di offrire un giudizio riferito alla mentalità dell’epoca in
cui l’opera è stata realizzata. La novità consiste nell’esame globale non solo di quanto è definibile “opera
d’arte”, ma di tutto quel che ha un rapporto diretto con la visualità e che, prodotto nell’ambiente in cui
l’uomo vive, ne determina l’identità: non solo, quindi manufatti di qualsiasi genere preservati, ma anche la
descrizione, o la memoria, di cerimonie, di rituali, di spettacoli teatrali, di eventi pubblici e privati che
abbiano una forte componente visuale.
“Arte popolare” In un celebre articolo del 1940 l’archeologo tedesco Rodenwaldt aveva definito quelle
che, secondo il suo parere, erano le differenze tra arte greca e romana, e che al giorno d’oggi potrebbero
essere precisate con maggiore proprietà come differenze di mentalità: l’una, pervasa da un talora assillante
naturalismo, tesa a costruire rappresentazioni secondo una ferrea logica organicistica e ipotattica, dove
ogni evento è relazionato all’onnipresente mito; l’altra tendente all’astrazione e al simbolismo.
Gli elementi fondanti dell’”arte popolare” fino al Tardoantico per Rodenwaldt sono: frontalità,
composizione centralizzata, rapporto proporzionale dei personaggi secondo la loro importanza,
separazione della figura principale dalla sua precipua attività, o trasformazione di tale attività ad attributo
della persona. Questi elementi, che sembrano differenziare questo filone dell’arte romana da quella greca,
s’incontrano più facilmente in composizioni di piccolo formato: quanto più è grande il formato, tanto più
greco è il sistema d’insieme, mentre in quello più piccolo si evidenzia in modo esemplare la vitale mobilità
dell’arte romana.
Esempio di opera di “arte popolare” “Rilievo con raffigurazione del trionfo partico di Traiano”, da
Praeneste. Palestrina, Museo Archeologico Nazionale.
(http://www.jobike.it/Public/data/leonardix/20131228232544_4.jpg)
Quasi tutte le figure sembrano voltarsi verso lo spettatore. L’imperatore è sul carro trionfale, con il torso
frontale e la testa girata di tre quarti. Un servus publicus gli pone sul capo una corona gemmata. Il carro,
decorato con una Vittoria alata che regge una palma e una corona, è tirato da quattro striminziti cavalli,
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
proporzionalmente del tutto incongrui. Al fianco di questo, e in parte coperti dalla ruota, sono due littori di
piccola misura. Davanti ai cavalli c’è un giovane di spalle che volge il capo verso Traiano; dietro, in duplice
fila, si contano altri otto littori in veduta frontale, di misura maggiore rispetto a quelli davanti al carro, ma
comunque più piccoli dell’imperatore. Uno solo si gira verso Traiano, ma complessivamente vige una rigida
disposizione paratattica in duplice fila dei personaggi, dei quali è enfatizzata la testa. Seguono altre figure,
di cui due, a rilievo più basso, sono di profilo, volte verso destra. Dietro questo gruppo di teste appare sullo
sfondo un trofeo composto da una tunica alla cui manica è applicata una faretra.
Il rilievo prenestino è una summa di elementi di solito considerati pertinenti all’”arte popolare”: tendenza
verso la frontalità e la composizione paratattica e additiva, sovrano disinteresse nei confronti delle giuste
proporzioni non solo nei corpi visti singolarmente, ma anche nel rapporto tra le varie componenti del
rilievo, scomparsa delle gambe e, in determinati casi, con disorganiche distorsioni degli arti.
Vi si riscontrano, insomma, quei caratteri che nei monumenti pubblici di produzione urbana sono relegati
per lo più alle parti decorative meno evidenti, e che invece in quelli di area municipale s’impongono in
piena evidenza visiva.
“Stili di genere” La teoria dello stile di genere è basata in parte sulla constatazione che opere d’arte
realizzare nel medesimo periodo possano essere stilisticamente assai differenti. Ciò dipende dal fatto che
ogni determinato spazio temporale è multidimensionale, in quanto comprende, nello stesso arco
cronologico, più di una generazione. La “non contemporaneità del contemporaneo”, secondo la definizione
del medievista Wilhelm Pinder, può spiegare perché gli artisti coevi producano, nello stesso arco di tempo,
opere assai spesso così diversificate stilisticamente che, se on se ne conoscesse la cronologia, si direbbero
prodotte a distanza di anni se non di decenni.
Il concetto di “stile di genere” afferma perciò che ogni genere – architettura, scultura, pittura, ma
all’interno dei macro-generi, anche le entità minori, i motivi decorativi nelle architetture, gli stucchi sulle
pareti e sui soffitti delle case, l’importanza gerarchica dei rilievi distribuiti su un monumento – ha per molti
versi un linguaggio proprio e autonomo.
Il “classicismo” augusteo
Il classicismo augusteo, a un’analisi più approfondita, non mostra affatto una forte unità stilistica. Lo stile
“classicistico” per Blanckenhagen è adottato nella maniera più compiuta solo quando dell’opera d’arte, e
del suo soggetto, si vuole enfatizzare l’importanza atemporale. Le restanti opere hanno, invece, forti
componenti non “classicistiche”, e spesso non uno stile unitario, nel senso che l’ago della bilancia si muove
tra le due “bipolarità” dell’”arte aulica” e “popolare”.
Compresenze sull’ara Pacis
Nell’ara Pacis (per la sua descrizione complessiva vedi cap.6) si avverte la presenza coeva di linguaggi
differenziati nella realizzazione del fregio principale con la processione cui partecipano Augusto, Agrippa e i
membri della loro famiglia, e dei pannelli mitologici nella fascia superiore del recinto e del piccolo fregio
con pompa sulle sponde della mensa sacrificale. In quest’ultimo le figure, quasi a tutto tondo sullo sfondo
neutro, non sono tutte isocefale, e si dispongono in fila secondo una distribuzione irregolare (vedi
http://comps.canstockphoto.com/can-stock-photo_csp12674377.jpg). L’effetto d’insieme è assai differente
da quello del fregio principale, nel quale la composizione è più serrata e regolare, il fondo pressoché
coperto dai personaggi, tutti, a esclusione ovviamente di bambini e fanciulli, della medesima misura, che
appaiono spesso come silhouettes schiacciate a parete (vedi
http://foto.museiincomuneroma.it/watermark.php?i=3997).
Vuol dire che nel piccolo rilievo con pompa sacrificale si fossero adottati criteri pertinenti a un altro
“genere”? La risposta di Blanckenhagen è che il piccolo fregio dell’ara Pacis, di misura ridotta e in posizione
meno significativa all’interno del contesto monumentale, si adegua ai modi dell’”arte popolare”, mentre il
rilievo del grande fregio principale, di grande formato, si conforma ai canoni dell’arte statale.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Mentre nel fregio principale le immagini occupano lo spazio senza un vero effetto di profondità, nei
pannelli mitologici i personaggi hanno una maggiore vivacità spaziale. Nel pannello con Enea che sacrifica ai
Penati (vedi http://www.engramma.it/eOS/image/75/75_dolari_2.jpg), la distribuzione delle immagini è su
piani differenti: in primo piano la scrofa, dietro di essa due attendenti al sacrificio in posizione variata, e
ancora dietro la roccia, scavata per lasciare posto alle immagini degli attendenti, sulla quale poggia il
tempio dei Penati, piccolissimo rispetto all’imponenza delle figure umane.
Anche nel pannello con la figura di Tellus (vedi
http://www.engramma.it/engramma_revolution/58/img/006_cent.jpg), nella quale domina un forte
effetto di simmetria, la mucca accovacciata sotto la roccia, la pecora che bruca, persino il canneto sulla
sinistra, sono innaturalmente piccoli rispetto ai tre personaggi principali, la personificazione divina con i
due infanti al centro e le due aure su cigno e su pistrice ai lati, anch’esse a loro volta di misura inferiore
rispetto alla figura principale.
Ebbene, nel piccolo fregio con pompa sacrificale, negli elementi paesistici dei rilievi mitologici, nella
differenza di misura gerarchica tra le figure della medesima composizione, Blanckenhagen avvertiva la
presenza di elementi dell’”arte popolare”, vista come una tradizione sotterranea della cultura figurativa
romana e, prima di essa, di quella etrusca e italica, emergente di tratto in tratto scompaginando il sistema
organico desunto dall’arte greca.
2.2 Sui limiti delle nozioni
Cosa si intende per “genere” nell’arte? Architettura, scultura e pittura sono generi, ma lo sono in egual
modo le loro sottospecie.
Scultura statuaria a tutto tondo, rilievo, stucco;
Pittura pittura di cavalletto, pittura su parete (affresco).
Vi sono poi altri tipi di generi, basati su temi e soggetti.
Rilievo rappresentazioni a carattere pubblico e statale; mitologico decorativo; raffigurazioni ambientali e
paesistiche; battaglie;
Affresco pittura di natura decorativa e scenografica; tema mitologico; tema pubblico; nature morte.
L’“arte plebea”
È ormai chiaro che quando Rodenwaldt parlava di volkstuemliche Kunst non si riferisse a un’arte
effettivamente popolare. Il termine Volk sottolinea un’identità nazionale al di fuori di qualunque
differenziazione sociale. Volk intende tutti i membri di una nazione, non solo gli strati sociali inferiori. Per
evitare qualsiasi fraintendimento, Bianchi Bandinelli coniò il nome di “arte plebea”, termine che non vuole
essere distintivo di una categoria sociale, ma che va inteso nel senso di una classificazione e non nel senso
di un’opposizione sociale polemica verso l’arte ufficiale (che potremmo chiamare “senatoria”).
Eppure qualche motivo di perplessità non manca. Non v’è dubbio che l’”arte popolare” o “plebea” non
sono non può essere inscritta rigidamente nell’alveo di determinate classi sociali, ma non la si può
considerare neppure come stilisticamente unitaria e priva di consistenti differenziazioni a seconda dei
momenti storici e delle componenti formali, come effettivamente avviene.
Determinati modi di rappresentazione possono essere catalogati come partecipi di un medesimo stile detto
“popolare” o “plebeo”? Rodenwaldt stesso ha più volte osservato che gli elementi essenziali dell’“arte
popolare” sono percepibili anche in altre culture figurative del bacino orientale del Mediterraneo, al punto
che non si può affermare con certezza quali siano le possibili interconnessioni, sempre che di
interconnessioni si possa parlare. È difficile, per esempio, stabilire se quegli elementi dell’arte tardoantica
che sembrano desunti dall’“arte popolare” siano un derivato della tradizione autenticamente romana,
oppure un particolare innesti di componenti orientali.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Ulteriori distinzioni
L’“arte popolare non è il mezzo espressivo di uno specifico gruppo sociale di produttori di una specifica
cultura figurativa. I modi formali da loro adoperati non hanno una loro peculiarità socioculturale, ma
devono essere intesi, esclusivamente come un sistema di comunicazione. Donde un ulteriore tentativo di
distinguere, sempre a livello comunicativo, i modi di rappresentazione di uomini di alto rango politico e
sociale nell’ambito dei rituali o delle azioni cui partecipano dai modi di rappresentazione dell’imperatore o
dei più alti membri del senato. Ma la distinzione tra i due sistemi di comunicazione non è così ferrea: il
rilievo di Praeneste può di nuovo essere un ottimo esempio circa la cautela con la quale si dovrebbe fruite
di tali categorie. Se esso è un monumento pubblico, vi è adottato il linguaggio dell’“arte popolare” che
conoscevamo con tale evidenza visuale, data la misura del blocco superstite, solo attraverso monumenti di
privati. Poiché non siamo a Roma, ma a Praeneste, è possibile che l’élite locale non disponesse di un
finanziamento utile ad assegnare l’appalto a una maestranza urbana di primo livello. Per uscire dal dilemma
si dovrebbe supporre – ma è improbabile – che nel rilievo sia raffigurato un privato per il quale, però
sarebbe stato utilizzato uno schema figurativo di alta rappresentanza, destinato agli imperatori, con un
linguaggio formale desunto dalle forme stilistiche presentative.
L’“arte popolare” è in tante culture figurative
Gli elementi basilari dell’”arte popolare” sono schemi figurativi presenti praticamente in tutte le culture
figurative, dall’egizia alla mesopotamica, alla partica e persino in quella greca, pur con diversi linguaggi
formali, ma con un intento simile, a carattere simbolico, di porre in evidenza nel modo più plateale il
protagonista rispetto a tutti i personaggi di contorno.
In tutte queste culture figurative – e, sebbene in casi particolari, anche nella greca – il modo, o uno dei
modi, di rappresentazione rivela una tendenza verso il simbolismo, verso la gerarchia, verso la
semplificazione narrativa secondo sistemi paratattici, verso la visione spaziale secondo una logica
bidimensionale. Nulla lega esperienze talvolta lontanissime nel tempo se non, probabilmente, una comune
propensione per determinate forme di rappresentazione nelle quali le gerarchie religiose e sociali sono
evidenziate con un sistema simbolico che ne afferma l’invalicabilità e l’inviolabilità, in altri termini la
valenza politica.
L’alternativa al sistema rigidamente fondato sul potere di uno o di pochi su tutti nasce e si sviluppa in
Grecia. Qui avviene un autentico sovvertimento, sociale ancor prima che artistico, che comportò nel tempo
l’abbandono di tale concezione politica a favore di una rivoluzionaria visione del mondo che rifiutava
programmaticamente la distinzione tra i cittadini e quindi, in maniera complementare, gli schemi figurativi
a impostazione gerarchica. La concezione organicistica di buona parte dell’arte greca, la sua tendenza verso
il naturalismo anche se piegato nelle maglie di ferrei canoni, si associò a un innovativo sistema politico fino
allora sconosciuto, che poneva il cittadino a misura di ogni cosa. Ciò non impedì, ovviamente, che gli dei e
gli eroi fossero rappresentati più grandi degli esseri umani. È fenomeno comune che anche nelle
decorazioni frontonali, persino nel Partenone, le figure non siano della medesima altezza dal centro agli
estremi del timpano.
“Centro” e “periferia” in Grecia
Quando ci si allontana dal “centro”, in primo luogo Atene, verso le “periferie” del mondo ellenizzato, dove i
regimi politici non erano né a carattere democratico né oligarchico, il sistema figurativo greco scricchiola, e
appaiono soluzioni somiglianti in modo impressionante alla supposta “arte popolare”.
Capitolo 3 – La forma di Roma
Introduzione
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Nell’antichità le opere d’arte assumevano un preciso significato grazie agli spazi dove venivano collocate,
conferendo al contempo un senso specifico a luoghi e monumenti. Questo capitolo vuole fornire una
panoramica sulle fondamentali strutture, architettoniche e non, almeno dell’Urbe, città per antonomasia
già nella coscienza dei Romani, e del suburbium, termine che, per quanto vago, indica il territorio esterno
ma limitrofo e in simbiosi con il centro abitato.
Ciascuna città dell’impero era multiforme, con paesaggi promiscui e con una trama ininterrotta di
compenetrazioni tra componenti diverse e talora antinomiche: pubbliche e private, di rilevanza politica,
economica e giuridico-sacrale, ricche e povere, di elevata o bassa qualità. Topografie cariche di storia,
salvata, rivista e cancellata, dove convivevano continuità, dovute alla permanenza e alla conservazione di
edifici connessi a specifiche tradizioni o memorie, e discontinuità, causate dalle azioni umane (esempio:
sacco gallico 390 a.C.) o da catastrofi come gli incendi (celebre è quello del 64 d.C. sotto l’imperatore
Nerone).
La città cresceva senza sosta, mediante allargamenti e ristrutturazioni di edifici e quartieri anche per mezzo
di enormi quantità di terreno riportato.
Antiche formae
Ai termini di oggi, quali immagine, aspetto, forma, configurazione di luoghi (edifici, città o territori) – al pari
di oggetti, concetti ed esseri viventi – corrisponde la parola latina forma. La forma delle città antiche consta
di un insieme articolato in parti grandi e piccole, ognuna essenziale alla sua comprensione; queste possono
essere descritte da realtà a volte sincrone, a volte invece da intendere in successione nel tempo, ma tutte
funzionali alla restituzione della forma nella sua totalità.
I requisiti di una non-città e quelli di una città
Una non-città non ha uffici di governo, né ginnasio, né teatro, né una piazza, né acque che alimentino
fontane, ma vive in case spoglie, piuttosto simili a capanne montane sull’orlo di un burrone: questo afferma
il periegeta greco Pausania (X, 4,7).
Viceversa, nella descrizione letteraria di un atto di fondazione, nel primo libro dell’Eneide di Virgilio (vv.421-
429), Enea, giunto a Cartagine, assiste alla costruzione di una nascente città. Il brano in pochi versi
condensa le basilari componenti materiali e istituzionali di una compagine urbana: templi, teatri,
roccaforte, mura, uffici di governo e porto (opzionale).
3.1 Il paesaggio naturale
Il fiume Tevere definì il suo attuale corso tra 600.000 e 800.000 anni fa. Il fiume e i suoi affluenti erosero il
tavolato formatosi ad est dalle eruzioni di vulcani laziali attivi a quell’epoca per 70.000 anni, fino a creare
un sistema di colline separate da vallecole; alla sua destra, invece, era una lunga e ripida dorsale.
Secondo i miti dei Romani, la dorsale della riva destra fu la prima zona a essere occupata nell’area della
futura città, da divinità tanto antiche quanto mostruose: vi regnò Giano dalle due facce, dando il nome
all’altura (Gianicolo) e concedendo a Saturno di occupare successivamente il Campidoglio (mons Saturnius).
Dall’archeologia si desume invece che i primi insediamenti stabili sul sito di Roma predilessero il sistema di
alture della riva sinistra, ricche di sorgenti e di materiali da costruzione (argilla, legno e più tardi tufo di vari
generi).
3.2 La nascita di Roma
Dalla metà del millennio II a.C. (età del Bronzo Medio), primi nuclei di insediamenti permanenti si
stabilirono sul Campidoglio, sulla pendice del Palatino verso la valle del foro Romano e più tardi sul
Quirinale (fase preurbana). Il quadro restò immutato fino ai secoli XI e X a.C., quando in tutto il Lazio si
distingue una cultura archeologicamente identificabile rispetto a quelle circostanti, detta “cultura laziale”.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Durante l’età del Ferro si formò un abitato unificato esteso a Palatino, Velia, Celio e alle tre cime
dell’Esquilino – Fagutal, Oppio e Cispio (montes) –, Viminale e Quirinale (colles), che gli archeologi della
protostoria definiscono centro protourbano.
Tra il 775 e il 700 a.C. circa all’abitato furono annessi il Campidoglio, alla cui radice si allestì il primo comizio
con annesso santuario di Vulcano, e la valle tra Campidoglio e Palatino, sede della piazza del foro Romano.
Nello stesso periodo, sulla pendice del Palatino verso il foro, sorse il santuario di Vesta, con la residenza e i
culti regi: ecco la creazione del sistema Palatino-foro-arx (l’altura nord-orientale del monte capitolino) -
Campidoglio (altura sud-occidentale), a formare il centro direzionale della città-Stato.
Nel secolo VI a.C. nuove mura abbracciarono tutte le alture già occupate dall’abitato, includendo per la
prima volta l’Aventino nell’area urbana: dentro e fuori si sviluppò la città repubblicana e poi imperiale.
La leggenda della nascita di Roma
Remo e Romolo, principi gemelli nati nel centro più importante del Lazio – Alba Longa – dall’unione del dio
Marte e della vestale Rea Silvia, dovevano essere abbandonati sulle rive del Tevere subito dopo la nascita
per ordine dello zio materno, Amulio, re di Alba Longa, intenzionato a eliminare futuri pretendenti al trono;
ma i bimbi furono prodigiosamente salvati, allattati da una lupa e allevati da pastori. Diventato ragazzo,
Romolo si vendicò uccidendo Amulio; dopo aver eliminato anche Remo, egli celebrò intorno al Palatino il
rito di fondazione di Roma il 21 aprile dell’anno 753 a.C., data di nascita della città in un luogo deserto
presso la riva del Tevere, cui Romolo dette anche un popolo e una costituzione.
Roma non poté vantare il mito dell’autoctonia come Atene e sin dall’inizio fu una città multietnica. Dopo la
redazione della leggenda si istituì una relazione genealogica tra Romolo ed Enea, l’eroe di Troia che,
fuggendo dalla sua città distrutta, sarebbe giunto nel Lazio con il figlio Ascanio e il padre Anchise nel
territorio laurentino per fondare Lavinium nel punto in cui una scrofa destinata al sacrificio partorì trenta
porcellini.
Enea sposò Lavinia, la figlia del re Latino, re della popolazione locale, gli Aborigeni, e dall’unione tra Troiani
e Aborigeni nacquero i Latini; infine Ascanio fu fondatore e primo re di Alba Longa e capostipite di una
dinastia di re albani, dai quali discesero Romolo e Remo.
3.3 I limiti di curiae, pagi, tribus, vici, Regiones
Età preurbana Prima ancora del grande insediamento unificato datato all’età del Ferro e definito
protourbano, tre comunità avrebbero occupato le alture di Roma: i Velienses, i Querquetulani e i
Latinienses. Queste erano parte di una confederazione latina, formata da populi detti Albenses. I nomi dei
populi permettono di immaginare le alture che potevano costituire il cardine principale di ogni comunità: la
Velia, il Celio (Querquetual) e il collis Latiaris sul Quirinale.
Prima età storica (dalla metà del secolo VIII a.C.) Roma era divisa in trenta rioni, chiamati curiae (“gruppi
di uomini”), mentre tre tribù (Titienses, Ramnes, Luceres) spartivano città e territorio.
Le curiae costituivano una realtà topografica e istituzionale collegata alla prima assemblea politica della
città (i comitia curiata), cui i cittadini maschi adulti partecipavano raggruppati per rione di appartenenza.
All’esterno delle curiae terminava l’apparato protourbano, come poi quello urbano, e iniziava il territorio
suddiviso in distretti rurali (pagi) e limitato da piccoli abitati periferici (oppida).
Circa due secoli dopo la sua nascita (nel corso del secolo VI a.C.), la città-Stato fu rifondata modificando e
ristrutturando natura, forma e distribuzione delle sue partizioni amministrative e giuridico-sacrali. Si
procedette a una suddivisione in quattro tribù urbane – Suburbana, Esquilina, Collina e Palatina – le quali
non si addentravano più nell’agro, ora articolato in tribù rustiche. Il territorio viene suddiviso secondo una
nuova trama di quartieri denominati vicinates, ognuno dei quali aveva al suo interno un piccolo impianto di
culto (talora in forma di sacello) agli incroci delle strade per le divinità protettrici chiamate Lari.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Tale organizzazione, correlata dalla tradizione al penultimo re di Roma, Servio Tullio (578-539 a.C.), rimase
in vigore sino al 7 a.C. Allora Augusto suddivise l’Urbe in XIV Regioni e in quartieri (vici,
duecentosessantacinque nel 71-72, poi in crescita) irregolarmente distribuiti, e sotto la sovrintendenza dei
magistri vici.
La nuova articolazione disegnava le divisioni amministrative urbane in una vasta area che si spingeva
all’esterno delle mura arcaiche in ogni direzione per circa un miglio romano (1480 m). Tredici regioni
includevano la città sulla riva sinistra del Tevere, numerate in ordine approssimativamente antiorario, a
partire dall’area compresa tra Palatino e Celio (I) fino all’Aventino con la pianura di Testaccio (XIII); una sola
includeva la stretta fascia pianeggiante sulla riva destra limitata dal Gianicolo (XIV).
Augusto, novello Romolo, aveva rifondato una nuova e magnificente urbs di marmo (dopo quella
repubblicana prevalentemente in tufo, terracotta e legno), il cui paesaggio era lontanissimo da quello
agreste e rudis delle origini.
3.4 Spazi pubblici e privati
La struttura urbana si può suddividere in due macro-categorie giuridiche: spazi pubblici e privati. In latino
publicus deriva da populus e definisce nei suoi valori semantici essenziali: cose o esseri di proprietà dello
Stato, oggetti creati per conto dello Stato come il denaro o coloro che agiscono in nome e per mandato
della collettività (i magistrati). Viceversa, privatus deriva dal verbo privo – tolgo, libero da qualcosa – e
indica le persone che non rivestono incarichi statali oppure oggetti ed esseri ci proprietà di singoli individui.
I monumenti pubblici erano di varie tipologie e funzioni perché destinati a più attività:
- edifici sacri;
- amministrativi;
- giudiziari (tribunalia, all’interno di determinati punti dei fori imperiali o delle basiliche);
- a uso commerciale (luoghi di mercato come i fori deputati alla vendita di determinate merci);
- per i corpi armati addetti alla sicurezza (castra per soldati e stationes per le coorti dei vigili
deputate a spegnimento e prevenzione degli incendi).
Altre magnificenti costruzioni erano richieste dalle occasioni di allenamento corporeo e da necessità
quotidiane (terme) e dalle tante ricorrenze festive comprendenti ludi teatrali, circensi e gladiatori.
Il circo Massimo fu istituito sin dai Tarquini tra Palatino e Aventino in un’area limitanea attraversata dal
pomerium, mentre l’altro grande circo urbano, il Flaminio, sorse nel 221 a.C. grazie al censore C. Flaminio
Nepote.
Infine le costruzioni pubbliche potevano serbare la memoria dei loro fondatori, eternandone il nome, come
per alcuni horrea publica populi Romani, mentre la prima basilica nel foro Romano prese nome da M.
Porcio Catone, il celebre censore del 184 a.C.
La città era ricca di templi: l’Urbe si identifica con i luoghi di culto, con i riti e con i collegi sacerdotali. Il
numero di templi crebbe nei secoli IV-III a.C. con più di cinquanta esempi, fatti edificare dai comandanti
cum imperio; essi, nella facoltà di scegliere i siti per la costruzione, li votavano e dedicavano in segno di
gratitudine per i propri trionfi con la parte del bottino di guerra loro assegnata, il tutto previa ratifica del
senato. Non stupisce allora che nei templi potessero trovarsi esaltate anche le gesta dei committenti.
Se Augusto, nelle sue Res gestae (20,4) asserisce di aver restaurato ottantadue templi, il panorama sacro
dell’Urbe si arricchì poi sino almeno al quarto decennio del secolo III d.C. specialmente con fondazioni di
templi e luoghi di culto in onore di alcuni imperatori e imperatrici saliti al cielo e divinizzati, come Augusto,
Claudio, Poppea, moglie di Nerone, i Flavi, Traiano e Plotina, Sabina e Adriano, Faustina Maggiore e
Antonino Pio, Faustina Minore e Marco Aurelio, Caracalla.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Oltre alle divinità tradizionali, i patria sacra, risultanti da un’integrazione del pantheon greco e romano
ormai compiuta nel secolo III a.C. e accanto agli dei che impersonavano concetti astratti alle fondamenta
della struttura statale – Clementia, Concordia, Salus, Victoria, Fides, Spes, Honor, Virtus, Mens, Libertas –, il
flessibile sistema religioso romano ammetteva anche plurime divinità “orientali” (i sacra peregrina), talora
riconosciute tra i sacra publica, come Magna Mater, il cui culto sotto forma di simulacro aniconico fu
introdotto negli anni finali della guerra annibalica, nel 204 a.C. Tali dei erano talvolta venerati in strutture
molto peculiari, come i mitrei per il dio indo-iranico Mitra, in gran numero a Roma nei secoli II-III a.C. e
nell’Impero: consistevano in “grotte”, “accampamenti delle tenebre” dotati di podi per riunioni e banchetti
di conventicole, di norma composte da non più di una quarantina di partecipanti.
Tra le proprietà private, oltre agli edifici di utilità pubblica (horrea e balnea) e alle sedi (scholae) di
associazioni (collegia) professionali e cultuali, rientravano le domus, concretamente afferrabili nell’Urbe
almeno dal secolo VI a.C. e attribuibili a determinati proprietari solo in presenza di dati archeologici e di
altre fonti quali le notizie letterarie ed epigrafiche.
Diverse e variamente decorate le parti che le componevano. Dapprima i “luoghi comuni”:
- l’atrio, per il ricevimento della massa dei clienti nella cerimonia della salutatio mattutina;
- il tablino, affiancato da alae, nella parte terminale dell’atrio, sede dell’archivio del dominus;
- il peristilio, un’area centrale a cielo aperto circondata da un quadriportico perimetrale
Seguivano:
- i cubicoli, stanze per riposo e per soggiorno;
- i triclini, per banchetti, dove si raccoglievano gli amici più stretti;
- i saloni di rappresentanza (oecus);
- i balnea.
Ma l’Urbe e le altre città non vantavano solo spaziose dimore signorili. C’era chi, pur potendoselo
permettere, preferiva rinunciare ad arredi troppo sontuosi, come T. Pomponio Attico, proprietario sul
Quirinale di una casa vecchiotta la cui principale attrattiva consisteva nella amoenitas di una silva.
Inoltre v’erano migliaia di isolati o caseggiati convenzionalmente chiamati insulae, parola che in latino
piuttosto indica un’unità di proprietà: il termine insula, al più tardi degli scavi del Novecento a Ostia, è stato
applicato all’edilizia abitativa a carattere intensivo e a più piani, con appartamenti in affitto e destinati a
un’ampia gamma socio-economica.
Spazi e ornamenti
Parte integrante degli edifici erano gli ornamenti (colonne, statue, rivestimenti in marmi preziosi, pitture,
stucchi), da non considerare accessori nell’odierno senso riduttivo, poiché gli insiemi decorativi
esprimevano ciò che la sola articolazione architettonica non poteva fare: per il loro tramite erano assicurati
il pieno potenziale comunicativo e simbolico nonché la definizione delle gerarchie d’importanza dei vani.
Vie, acquedotti, porti e ponti
Completavano l’ossatura fondante della struttura urbana gli elementi che entravano in città dall’esterno,
superando le mura e tutti i limiti fiscali e sacrali che la circondavano e definivano: strade e acquedotti,
considerati tra gli esempi più efficaci e illuminanti della perizia topografica e ingegneristica dei Romani.
Si conoscono i nomi di sole diciotto viae (le strade in entrata e in uscita dalla città) a fronte delle trentasette
porte delle mura Aureliane: la più celebre è la via Appia, strada di fondamentale importanza dal punto di
vista economico, militare e politico, cui si aggiunse il primo acquedotto, l’aqua Appia.
Gli acquedotti, appunto, furono la più recente tra le infrastrutture urbane ad apparire nel paesaggio. Degli
undici, costruiti tra il 312 a.C. e il 226 d.C., ben sette entravano in città: un punto elevato rispetto al resto
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
dell’area urbana, che, potendo contare solo sulla capacità di fare defluire l’acqua dall’alto verso il basso,
permetteva una più facile distribuzione in tutti i quartieri. Spesso gli acquedotti avevano la funzione
primaria di rifornire gli impianti pubblici, come le terme.
Tra le infrastrutture ricordiamo poi i ponti. Spicca il più vecchio, il Sublicius, il cui nome si fa derivare da
sublica, palo, trave di legno, attribuito dalla tradizione al re Anco Marcio nella seconda metà del secolo VII
a.C. quale collegamento tra il foro Boario e il colle del Gianicolo: un monumento considerato sacro, tanto
che la sua custodia fu affidata ai pontefici, e lasciato integralmente di legno.
Il ponte più antico in pietra di cui la struttura è ancora ben visibile è il Fabricius, che, insieme al Cestius,
collegava l’isola Tiberina alle sponde del Tevere.
I porti, infine, erano strettamente necessari per le importazioni di merci e i rifornimenti di grano: oltre a
quelli artificiali sulla costa laziale e campana, Roma aveva un emporio nella zona di Marmorata nella
Regione XIII, sede sin dal secolo II a.C. di grandi magazzini, e un altro nell’area del Campo Marzio.
3.5 Il pomerium, il dazio e il limite del I miglio
Secondo la tradizione miti-storica e antiquaria i Romani concepivano la successione degli atti necessari a
fondare una città dapprima con realtà immateriali (il pomerium) e poi con complementari strutture
materiali (le mura).
La città era una realtà da sancire sacralmente. Il primo atto richiedeva l’allontanamento di presenze
numinose che occupavano l’area prescelta (liberatio) e la sua descrizione compiuta declamandone i limiti
(effatio). In seguito si pregava Giove di acconsentire alla trasformazione di una parte dello spazio in città
(urbs). La volontà del dio era rivelata dalla direzione di volo degli uccelli – e dal settore del cielo dal quale
provenivano – avvistati da un sacerdote (augur) alla fine della notte e prima del sorgere del sole (rito
denominato augurium). In caso di segno positivo, uno specifico settore, già effatus e liberatus, era
all’istante anche inauguratus per diventare una urbs. Il suo limite non erano le mura urbane, ma una
demarcazione immateriale, una cinta simbolica segnalata da cippi posti a intervalli regolari nel terreno: il
pomerium, oltre il quale si estendeva l’ager, effatus e liberatus, ma non inauguatus.
Pomerium limite giuridico-sacrale all’interno del quale non è permesso:
- essere armati;
- seppellire o bruciare cadaveri;
- venerare divinità infere;
- venerare divinità greche o orientali (fino alla fine della seconda guerra punica).
Il primo pomerium, riferito dagli Antichi al fondatore Romolo, era circoscritto al Palatino. In seguito Servio
Tullio allargò il pomerium dal Palatino a tutte le alture della città cinte dalle nuove mura, a esclusione
dell’Aventino e dell’arx. Solo chi conquistava nuove nazioni nemiche, ampliando il territorio di Roma, aveva
il privilegio di spostare il pomerium.
Il pomerium non fu però l’unico limite. Dalla seconda età regia esisteva a Roma l’obbligo di pagare una
tassa sulle merci portate nell’Urbe; il pagamento della tassa avveniva presso trentasette accessi controllati
(stationes), da immaginare su ciascuna delle vie che entravano in città. La cinta daziaria era segnalata da
cippi e coincideva in larga parte con i percorsi dei pomeria del periodo imperiale.
Lungo le strade recanti in città si dislocavano anche santuari posti a un miglio di distanza dalle porte della
città serviana. I luoghi sacri corrispondevano al limite di una zona esterna non inaugurata dal punto di vista
giuridico-sacrale, ma strettamente legata all’urbs piuttosto che all’ager: alcuni diritti del popolo e
prerogative dei magistrati non erano limitati dal pomerium, ma si estendevano al primo miglio, quali il
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
diritto di appello ai magistrati dei tribunali e le competenze di altri magistrati urbani, come gli edili e il
pretore urbano.
3.6 Le mura
Le mura impedivano l’accesso alla città, ne definivano estensione e perimetro e, allo stesso tempo, la
annunciavano a coloro che vi si recavano. Le mura erano fondate secondo un rito che ne sanciva la
sanctitas, che proteggeva sacralmente e decretava l’inviolabilità e l’inamovibilità.
La città-Stato nella forma assunta durante la seconda metà del secolo VIII a.C. aveva il suo centro
direzionale politico-sacrale in parte nell’abitato delle vecchie curiae, in parte nell’area immediatamente
adiacente a esso. Il sistema si trovava all’esterno di una fortificazione che cingeva il Palatino, della quale
sono stati rinvenuti diversi segmenti databili 775-750 a.C. circa: un muro con fondazione in scaglie e massi
di tufo mescolati con terra ed elevato in argilla cruda sorretta da pali lignei; un muro peculiare, perché
ritualmente fondato e ristrutturato con sacrifici umani reali o simulati.
Dal punto di vista della forma della città e delle continuità/discontinuità che ne hanno segnato lo sviluppo,
un fatto è rilevante. Le mura palatine sono incompatibili con l’abitato precedente: tutti i nuclei di capanne o
altre strutture presenti dall’inizio dell’età del Ferro sul suo tracciato, o nelle immediate vicinanze, furono
distrutti e non più ricostruiti.
Il Palatino inaugurato (urbs) non fu l’unica altura di Roma a essere circondata da mura, perché un nuovo
“collis” – il Campidoglio – e un antico mons (la Velia) furono fortificati.
Nel primo caso un tratto di muro si data ad anni di poco successivi a quello palatino in base alla tecnica
edilizia (parametri in scaglie di tufo rosso e riempimento interno in limo) – si protesse così una parte del
cuore del nuovo sistema politico.
Nel secondo, invece, la tradizione ricordava due tratti di un’antica fortificazione del monte – in questo
modo antichi rioni ottennero, si arrogarono o conservarono il privilegio di definirsi rispetto agli altri e di
difendersi.
Con l’estensione dell’area inaugurata alla città, per la prima volta l’intera area abitata fu circondata da
mura.
Nonostante le persistenti obiezioni riguardo l’effettiva esistenza di una fortificazione a Roma già nel secolo
VI a.C. non v’è da dubitare delle “mura Serviane” in età arcaica per ragioni archeologiche e topografiche.
Prima fra tutte: la posizione all’esterno del circuito difensivo di tutti i sepolcreti databili a partire dal secolo
VI a.C.
Per completarle furono incise le pendici dei rilievi ed elevati i cigli delle alture; sul pianoro dell’Esquilino si
scavò un ampio fossato all’esterno del muro, e alle sue spalle si addossò un immane riporto di terreno; si
crearono opere accessorie quali strade parallele al muro, muri di contenimento interno, fognature, ponti
lignei sui fossati: insomma, Roma divenne uno dei maggiori centri fortificati del Mediterraneo.
Dopo circa tre secoli la città iniziò ad inglobare il proprio limite fino ad annullarlo; edifici privati si
addossarono fin dal secolo II a.C. alla cinta muraria, della quale tratti sempre più ampi furono via via
smantellati per dare spazio agli horti.
Nel 271 d.C. popolazioni germaniche insediate oltre il Danubio invasero l’Impero e raggiunsero l’Italia per
essere però respinte da Aureliano. Egli non poté restare in città con le truppe, perché una rivolta
minacciava i confini dell’Impero. Siccome Roma sarebbe rimasta indifesa, l’imperatore in quell’anno dette
inizio alla costruzione di una nuova fortificazione, terminata sotto il successore Probo, nel 279 d.C.: la
muraglia in opera laterizia di mattoni e tegole, merlata e turrita (vedi https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/originals/a2/98/df/a298df89e0bbb7e403aed9956e2f0d92.jpg e
http://4.bp.blogspot.com/-
lv_bRzW1FJk/Tk5I8Sw6KfI/AAAAAAAAH14/bfTYEhoW0yA/s1600/porta_san_sebastiano_4.jpg), era
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
circondata da un fossato e munita di diciassette porte principali e venti minori.
Le nuove mura erano lunghe 19 km e il territorio al loro interno era tre volte più grande del “centro storico”
serviano.
3.7 Gli horti
Almeno dalla fine del secolo III a.C. invalse a Roma l’uso di allestire amene residenze nella fascia periurbana
subito oltre le “mura Serviane”, dove i proprietari potevano godere dei momenti di otium; ciò senza il
bisogno di recarsi nelle ville più distanti nell’agro romano, dove quasi sempre coesistevano la pars rustica
(zona servile e produttiva) e urbana (residenziale), e che conobbero un boom dal secolo I a.C.
Gli horti erano proprietà che, insieme ad alcune più genericamente definite praedia (possedimenti) e alle
aree di utilizzo anche funerario, formavano una cintura di verde. I più importanti si distinguono:
- Sull’Esquilino gli horti di Mecenate, quelli Lamiani, quelli Liciniani, di proprietà dell’imperatore
Gallieno, e gli horti Spei Veteris dell’imperatore Settimio Severo;
- Sul Quirinale gli horti di Cesare;
- Sul Pincio gli horti di L. Licinio Lucullo (console);
- In Campo Marzio gli horti di Pompeo;
- Nel Trastevere gli horti di Cesare, dove fu ospitata Cleopatra durante il suo soggiorno a Roma e
da lui lasciati in eredità al popolo, e quelli di Agrippina Maggiore e poi del figlio Caligola alle pendici
del Gianicolo;
- Nei pressi delle future Terme di Caracalla gli horti del politico, storico e oratore C. Asinio
Pollione.
In età imperiale molti horti appartenevano all’imperatore e alla sua famiglia o venivano acquisiti dal
demanio imperiale dopo la proscrizione o la morte dei proprietari originari.
Gli horti si dividono in due categorie: si sviluppano in aree pianeggianti o sono disposti su pendii, talora con
grande estensione. Tali proprietà erano recintate in vario modo, con muri, siepi o cippi, e alla loro
articolazione contribuivano plurime strutture disseminate nello spettacolare intreccio di natura e
architettura: dimore opulente, impianti sportivi, fontane e ninfei.
Oltre a possedere un proprio statuto religioso, in quanto posti generalmente sotto la protezione di Venere,
gli horti si ubicavano talora in prossimità di anteriori luoghi di culto.
L’arredo di siffatte residenze era magnificente: gli scavi ottocenteschi hanno riportato alla luce decorazioni
architettoniche, rivestimenti pavimentali e parietali nonché sculture di grande pregio (originali greci
compresi). Per limitarsi ad un solo esempio celebre, dagli horti di Mecenate sull’Esquilino proviene il
famosissimo Laocoonte.
3.8 Le necropoli
Sepolcri o intere necropoli non sono da annoverare tra gli elementi del paesaggio urbano, tranne poche
eccezioni: già le leggi delle XII tavole contenevano la codificazione di un divieto di cremare o seppellire
cadaveri in urbe, ovvero all’interno del pomerium. Tale norma riflette un uso risalente all’età del Ferro: a
partire dal secondo quarto del secolo IX a.C., gli individui adulti di entrambi i sessi furono seppelliti solo
all’esterno delle aree abitate.
La posizione delle necropoli ci è utile per capire il cambiamento dei limiti urbani nel tempo:
- X a.C. fondovalle, pendici e sommità di Campidoglio, Quirinale, Palatino e Velia;
- IX a.C. pendice meridionale dell’Esquilino;
- 875-825 a.C. Esquilino e Quirinale; da qui in poi si sviluppano lungo tutti i confini della città
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Più distanti dal perimetro esterno della città si trovavano i cimiteri cristiani e le catacombe, già sviluppati
nel corso del III secolo d.C.
Al secolo V si datano le prime prove archeologiche di sepolture interne alle mura, nel secolo seguente più
frequentemente attestate in aree appositamente organizzate: uno dei segni del tramonto dell’antico
paesaggio urbano.
3.9 La morte dell’antica Roma
Opere che descrivono la Roma del secolo IV d.C. delineano il quadro di una città popolata “a macchie di
leopardo”, effetto di un brusco crollo demografico che poté eliminare il 90% circa degli abitanti rispetto ai
periodi precedenti: era venuto meno il mezzo del loro sostentamento primario, l’annona imperiale che
garantiva il rifornimento di grano (in seguito alla conquista di Cartagine da parte dei Vandali nel 439).
Oltre ai cambiamenti delle strutture sociali ed economiche, per Roma furono anche eventi traumatici, come
le guerre greco-gotiche (535-553 d.C.) ad accelerare i processi di disfacimento delle strutture – ma non in
Oriente, dove si mantenne uno sviluppo economico positivo almeno fino al secolo VI d.C.
Fenomeni archeologicamente rilevabili segnarono la destrutturazione delle città, quantunque i decreti
tardoantichi e gli interventi dei prefetti urbani si sforzassero di tutelare il decoro urbano:
abbandono, spoglio, riconversione di infrastrutture e di monumenti pubblici, non vennero più costruite
domus, o terme o circhi, smantellamento e trasformazione dei templi, cristianizzazione degli spazi.
Capitolo 4 – Usi e destinazioni degli spazi urbani
4.1 Il centro della città
Il forum Romanum fu creato alla fine del secolo VIII a.C. nel momento in cui nell’insediamento dell’età del
Ferro e ai suoi margini si crearono i luoghi pubblici e politici necessari alla prima città-Stato.
Nel corso della seconda metà del secolo VIII a.C. la parte più alta della valle che divideva Palatino e
Campidoglio fu definita stabilendo ai suoi margini due nuovi luoghi di culto dedicati a Vesta, alla radice del
Palatino, e a Vulcano, su quella del Campidoglio, uniti da una strada, la Sacra via. Il centro istituzionale e
sacro della città-Stato, la radura (lucus) e il bosco (nemus) del santuario di Vesta, dea del fuoco sacro, come
mostrano recenti scavi, fu allora creato per poi mutare nel tempo; con il grande incendio del 64 d.C. il
bosco scomparve a favore di una casa delle Vestali annessa al tempio rotondo della dea in cui si
custodivano il Palladio e altri talismani, simboli delle origini e dell’eternità di Roma.
Fine secolo VIII a.C. pavimentazione depressione centrale tra i due colli, ad un’altezza non raggiungibile
dall’esondazione del fiume Tevere; la prima di almeno 14 attestate in seguito.
Presso il santuario di Vulcano si trovava il Comizio, luogo di riunione dell’assemblea delle curiae. Dalla
prima metà del secolo VII a.C., al Comizio si unì una nuova sede del senatus: la curia Hostilia.
Con la seconda età regia (616-509 a.C.) un ruscello che attraversava il foro da nord a sud fu canalizzato, con
la creazione di un’imponente fogna, la cloaca Maxima, mentre i lati della piazza vennero occupati dalle
dimore dei nobili cui il re aveva concesso di abitare nel luogo più importante della città. Le case sul lato sud
erano precedute da tabernae riservate ai macellai. In quest’epoca il foro venne incluso nel pomerium
esteso da Servio Tullio, per cui la nuova assemblea politica di uomini in armi (comitia centuriata) doveva
essere localizzata in Campo Marzio.
Con l’inizio della Repubblica, quando si accese lo scontro tra patrizi e plebei, appaiono i primi grandi
monumenti: il tempio di Saturno (493 a.C.) alla pendice del Campidoglio; il tempio dei Castori (484 a.C.).
Il luogo acquisì poi in dignitas quando i macellai furono allontanati dalla piazza e le loro botteghe sostituite
dalle tabernae argentariae dei banchieri. La piazza divenne il centro di ogni attività connessa al captale e
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
alle finanze. Intanto proliferavano i monumenti pubblici, anche a fine onorario, fondamentali per la
memoria e l’identità di Roma.
L’impegno di Roma nelle prime due guerre contro Cartagine rallentò la realizzazione di nuovi arredi urbani.
Due incendi (213 e 210 a.C.) danneggiarono in modo irreparabile l’area compresa tra Campidoglio, Palatino
e parte delle zone attorno alla Sacra via.
La prima basilica realizzata fu la basilica Porcia fu realizzata sulle pendici capitoline, dietro la curia Hostilia;
fu promossa nel 184 a.C. dal censore M. Porcio Catone al posto di due atria publica e di quattro tabernae.
Nel 179 a.C. la prima basilica sul lato nord della piazza fu costruita dal censore M. Fulvio Nobiliore ed è la
basilica Fulvia/Emilia.
Nel 169 a.C., a una casa e ad alcune tabernae sul lato sud subentrò la basilica Sempronia, eretta su iniziativa
del censore T. Sempronio Gracco; nel 121 a.C. venne costruita per impulso del console L. Opimio la basilica
Opimia alla pendice del Campidoglio, in stretta connessione con il tempio della Concordia, eretto nel 121
a.C. sempre a opera dello stesso personaggio. In quello stesso anno fu anche innalzato il fornix Fabianus, il
primo arco trionfale del foro Romano, al margine del lato orientale. Il termine fornix fu poi soppiantato
dall’uso di arcus dall’età augustea, mentre i primi esempi della classe monumentale risalgono al principio
del secolo II a.C. sul Campidoglio e al foro Boario.
Negli anni turbolenti delle guerre civili alla fine della Repubblica, ciò che restava dell’impianto del foro
sparì. Durante la dittatura di Silla le pedane che costituivano il Comizio vennero pavimentate e al loro
posto fu allestito un lastricato di marmo nero per ricordare il locus funestus dove si sarebbe verificato lo
squartamento di Romolo a opera dei senatori.
Nel 52 a.C. la nuova curia che era stata costruita da Silla bruciò e si dovette attendere il progetto di Cesare,
ultimato da Ottaviano, per ricostruire il nesso tra piazza e sede del senato.
Nel 46 a.C. sul lato meridionale della piazza Cesare inaugurò una basilica (Giulia) a sostituzione della
Sempronia.
Dopo la battaglia di Azio, Ottaviano proseguì i progetti del padre adottivo. Egli inaugurò la nuova curia e un
tempio per il divo Giulio sul lato orientale del foro, vicino al tempio della Concordia (29 a.C.), dove il corpo
di Cesare era stato cremato; furono eletti archi trionfali: quello detto di Azio nel 29 a.C. tra il tempio del
divo Giulio e quello dei Castori e l’altro decretato in occasione della pacifica restituzione ai Romani delle
insegne militari da parte del re dei Parti nel 19 a.C.
Ancora due incendi – 14 e 7 a.C. – imposero la ricostruzione di quasi tutti gli edifici circostanti la piazza.
Dopo vari restauri e ricostruzioni quasi tutti gli edifici vennero dedicati ad Augusto ed alla sua famiglia.
In età imperiale non cambiò molto intorno alla piazza. Sotto i severi al di là di alcuni restauri furono eretti
monumenti funzionali alla rappresentazione e alla legittimazione della loro dinastia.
Età tetrarchica all’età di Massenzio risale il cosiddetto “tempio di Romolo”, un edificio circolare
circondato da due aule absidate lungo la Sacra Via, poi dedicato a Costantino. Fu sempre Massenzio, non a
caso celebrato quale conservator urbis suae, a promuovere a una certa distanza dal foro, sulle pendici
meridionali della Velia, la costruzione di un’enorme basilica, nei pressi del tempio adrianeo di Venere e
Roma da lui totalmente ristrutturato.
L’edificio innovò la tradizione della tipologia della basilica con una sala sostenuta da colonne e coperta da
una capriata in legno: accessibile sia dal lato lungo che dà sulla Sacra via sia da uno stretto vano d’ingresso
a est, aveva una navata centrale coperta da tre grandi volte a crociera, impostate su otto colonne alte quasi
19 m in marmo proconnesio.
Nel 410 d.C., anno del sacco di Roma, la zona presso la curia bruciò, e sono testimoniati diversi interventi di
restauro del complesso, carico di tradizioni patrie, da parte dei prefetti urbani con gli edifici attigui. La
memoria del cuore politico dell’antica Roma era ormai svanita.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
4.2 Le Regioni della città
La città, dal punto di vista urbanistico, non aveva un impianto regolare né, fino all’età imperiale, esistevano
vaste zone caratteristiche da funzioni o tipologie architettoniche specifiche. Dappertutto si susseguivano,
intrecciati gli uni agli altri, spazi privati e pubblici, sacro e profano, aree ed edifici sacri e di carattere
produttivo-commerciale, altri utilizzati per l’amministrazione, monumenti onorari e infrastrutture.
Regio VIII. Forum romanum magnum (fulcro religioso)
La Regione VIII includeva l’area tra Palatino, Campidoglio e la riva del fiume Velabrum, il Campidoglio stesso
con le sue due cime (Capitolium e arx), il foro Romano e l’area tra Campidoglio, foro e Quirinale poi a mano
a mano occupata dal foro di Cesare e dai fori Imperiali (di Augusto, Nerva e Traiano), che una volta
completati, restarono, con qualche eccezione, sostanzialmente immutati. La Regione possedeva edifici e
zone di grande rilievo, quali l’area capitolina con i templi di Giove Ottimo Massimo e altre divinità.
Regio X. Palatium (primo fulcro urbano)
La Regione X, il cui toponimo in particolare dal II secolo a.C. qualifica anche la residenza imperiale,
coincideva con la prima urbs inaugurata, ricca di memorie del fondatore (la casa di Romolo) e della prima
città (auguratorium, murus Romuli, porta Romanula e Mugonia, tempio di Giove Statore).
È il luogo che ha fornito le maggiori informazioni archeologiche sulle fasi relative all’abitato protourbano,
alla città dell’età regia e a quella della prima e media Repubblica. Oltre ai suoi santuari, il Palatino ha
conservato resti delle più prestigiose dimore di Roma fin dal secolo VI a.C. e specialmente nei secoli II e I
a.C.
Anche Ottaviano volle abitare sul Palatino, scegliendo nel 42 a.C. per la propria casa il sito dove Romolo
aveva celebrato il rito di fondazione, di fronte all’Aventino, lungo le pendici meridionali; più tardi egli
acquistò plurime case per trasformare la propria dimora in Palazzo. Nel 12 a.C. egli rese pubblica una parte
della dimora, dove poté risiedere in qualità di pontefice massimo, e dove fu replicato il culto di Vesta.
Nel 3 d.C. la dimora di Augusto, bruciata in un incendio, fu ricostruita a spese pubbliche, mentre il settore
orientale conobbe una ristrutturazione in epoca neroniana e flavia.
In seguito, Tiberio dal 14 d.C. creò una seconda residenza nell’angolo nord-occidentale del colle, la domus
Tiberiana. Caligola riorganizzò il palazzo, estendendolo fino alle pendici settentrionali della collina sino al
tempio dei Castori, dove si trovava il suo vestibolo, e collegandolo con il Campidoglio mediante un ponte.
Se anche Nerone fece costruire per sé una casa che dal Palatino andava all’Esquilino, chiamata Transitoria,
la domus Tiberiana, ripristinata dopo un grande incendio dell’80 d.C., sino ai secoli IV-V d.C., forse per la
vicinanza al foro, restò la parte abitativa preferita dagli imperatori anche dopo l’allestimento, sotto
Domiziano, della domus Augustana, interamente in laterizio, completata nel 92 d.C. e ormai estesa
all’intera superficie del monte.
Uno degli aspetti più decantati dello sfarzoso palazzo di Domiziano è l’organizzazione di magnifici banchetti:
un salone per tale fine è stato individuato nella sala decorata con un’abside opposta all’Aula Regia). A est di
quel settore, 10 m sotto il livello principale, si estendeva l’ippodromo, in realtà una particolare forma di
giardino con un portico un tempo a tre piani, ampiamente rifatto in epoca severiana. Proprio sotto i Severi,
nei secoli II-III d.C., il complesso fu ingrandito a sud (la cosiddetta “domus Severiana”).
Inoltre, recentemente è stato compiuto uno studio dei bolli laterizi delle residenze imperiali, che ha
permesso di riconoscere con esattezza e in dettaglio le singole fasi edilizie, qui solo riassunte.
Regio IV. Templum Pacis
La Regione IV si estendeva dal limite settentrionale del foro Romano – con la basilica Fulvia/Emilia – alla
Velia. Conosciamo poco della regione per via archeologica delle fasi precedenti l’età imperiale, perché nella
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
regione si concentrarono alcuni grandi costruzioni quali: il templum Pacis, il tempio di Venere e Roma, la
basilica di Massenzio; inoltre, quanto restava della Velia fu demolito per la costruzione di via
dell’Impero/dei Fori Imperiali. Sull’alta pendice della collina, in posizione fortificata, sarebbe stata la casa
del re Tullo Ostilio; subito al di sotto, si trovava secondo le fonti il tempio di modeste dimensioni dei Penati,
con i simulacri degli dei troiani portati da Troia da Enea.
Lungo la Sacra via si distribuivano i magazzini delle spezie egizie e arabe costruiti da Domiziano, nell’area
poi occupata dalla basilica di Massenzio.
Altro illustre abitante del quartiere, in giovinezza, fu Ottaviano.
Regio III. Isis et Serapis
La Regione III includeva due delle tre cime dell’Esquilino, i montes Fagutal e Oppius (dove avrebbe abitato il
re Servio Tullio), fino al tracciato della fortificazione arcaica; prende il nome da un santuario della dea
egiziana Iside, del quale si conservano sostruzioni, decorazione e arredi a soggetto egittizzante nell’area
compresa tra le attuali via Labicana e Merulana sulla pendice sud-orientale dell’Oppio.
Nella regione Nerone estese la domus Aurea, che dopo il 64 d.C. riunì Palatino, Celio, Oppio, Cispio e parte
della Velia. Qui sorsero in seguito le Terme di Tito e vi si affiancarono le Terme di Traiano.
L’anfiteatro Flavio fu dedicato nell’80 d.C. al posto dei portici e dello stagno di Nerone, con il ludus Magnus
(palestra e prigione nella quale erano rinchiusi i gladiatori) e altri correlati edifici di servizio (ospedali e una
caserma per un reparto di marinai della flotta di stanza a Miseno che manovravano il grande telo, il
velarium, funzionale a riparare dal sole gli spettatori nell’anfiteatro).
Regio V. Esquiliae
Nella Regione V ricadevano la terza cima dell’Esquilino (mons Cispius) e l’area compresa tra la fortificazione
arcaica e il circuito del I miglio, poi materializzato dalla costruzione delle mura Aureliane. Qui una delle
maggiori necropoli di Roma si sviluppò fin dal secolo IX a.C. lungo le vie Labicana e Tiburtina, il campus
Esquilinus.
Dalla fine dell’età repubblicana si svilupparono nella regione alcuni celebri Horti.
Rientrano anche nella regione alcune celebri domus, come la residenza tardoantica del console Giunio
Basso.
Infine presso la porta Asinaria, nella zona del Laterano, Costantino volle edificare la basilica e il
baptisterium Salvatoris, prima sede per l’attività pastorale ed eucaristica del vescovo di Roma.
Regio II. Caelimonium
Poco è noto della Regione II, il cui paesaggio era dominato dal gigantesco tempio su terrazza che Agrippina
Minore dedicò al defunto marito, l’imperatore Claudio, divinizzato nel 54 d.C., del quale restano pochi
elementi architettonici.
Non lontano doveva sorgere anche il macellum Magnum, il grande mercato alimentare dedicato a Nerone
nel 59 d.C. ripristinato dopo l’incendio del 64 d.C. e noto solo grazie alle raffigurazioni della Forma Urbis
severiana.
Per il resto si conoscono caseggiati di età imperiale e diverse domus aristocratiche.
Regio I. Porta Capena
La Regione I s’incuneava lungo il I miglio delle vie Appia e Latina, tra le pendici del Celio e dell’Aventino
piccolo, in un’area quasi interamente esterna alla fortificazione arcaica, tanto da prendere il nome da una
delle sue porte.
In questa regione rientrano le terme di Caracalla che si trovano nella vicina regione XII. Presso porta Capena
sorgeva il tempio di Honos e Virtus.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Regio XII. Piscina Publica
Nella Regione XII, che prendeva il nome da un grande bacino d’acqua destinato ai bagni pubblici e
comprendeva l’Aventino piccolo, il pianoro a sud-est del monte e la valle sottostante fino alla via Appia,
oltre ai santuari e domus di prestigio.
Tuttavia il tessuto topografico delle due regioni è a stento ricostruibile, e gli edifici principali – Arco di
Costantino, Terme di Caracalla, sepolcri – restano isolati nel paesaggio della città contemporanea.
Regio XIII. Aventinus
Anche nella Regione XIII, estesa dall’Aventino grande alla pianura del Testaccio lungo l’ansa del fiume, sono
pochi i tratti percepibili dell’antica città. Tuttavia si è stati in grado di ricostruire la trama del Testaccio,
articolato in isolati regolari occupati da magazzini; il mons Testaceus, una collina artificiale, una “discarica”
alta 54 m, fu formata tra l’età augustea e la metà del secolo III d.C. da frammenti di anfore da trasporto
scaricate e accumulate dopo essere state svuotate nel vicino porto fluviale.
La cima dell’Aventino (l’arx Aventina) ospitava il santuario di Diana, il santuario federale dei Latini voluto da
Servio Tullio, di cui si scorge parzialmente l’immagine nella pianta marmorea severiana: per statuto era un
asylum, un luogo in cui chiunque, straniero o schiavo, si sarebbe potuto sottrarre all’assedio di un nemico
ricorrendo alla protezione della divinità, in un sito idoneo a tale fine perché fuori dal pomerium.
Sull’Aventino un altro luogo di culto era consacrato al dio della tempesta Giove Dolicheno, dal santuario di
Doliche in Siria settentrionale.
Regio XI. Circus Maximus
Nella Regione XI era compresa la valle tra Palatino e Aventino occupata per intero dal circo Massimo, la cui
origine è attribuita a Tarquinio Prisco o a Servio Tullio.
Nel foro Boario, il nome antico attribuito sia a un’ampia area tra Campidoglio e Aventino sia a una piazza
più ridotta destinata al mercato dei buoi, si trovava l’ara Maxima di Ercole. Nel foro Boario trovavano poi
posto importanti templi tardorepubblicani.
Celebre è poi il tempio di Portuno su un alto podio in lastre di travertino: un tempio ionico tetrastilo
pseudoperiptero ovvero con colonne libere in travertino e tufo in corrispondenza del pronao e semicolonne
addossate all’esterno del muro della cella.
Regio VI. Alta Semita
La Regione VI includeva i due colles Viminale e Quirinale e una fascia compresa tra le “mura Serviane” e
quelle Aureliane. Del Viminale è noto un ampio tratto raffigurato sulla Forma Urbis severiana, con domus
ad atrio, caseggiati e horrea. Sul Quirinale, la cui trama topografica è delineabile con maggiore difficoltà,
sorgevano alcune notevoli costruzioni sacre. Non mancavano esempi di lussuosa edilizia privata, quali le
domus sotto Palazzo Rospigliosi, con un ninfeo tardorepubblicano ristrutturato in eposa flavia con un
mosaico parietale di pasta vitrea.
Degno di nota è il quartiere scoperto a piazza dei Cinquecento, con domus, “insulae” e un impianto
termale.
Regio VII. Via Lata
La Regione VII comprendeva la sommità e la pendice del Pincio verso il Tevere. Anche qui si estendevano
horti, primo tra i quali quello di L. Licinio Lucullo. La stretta fascia pianeggiante, compresa tra le pendici dei
colli e la via Lata, includeva domus, caseggiati, archi onorari.
Regio IX. Circus Flaminius
La Regione IX definiva la pianura, interamente extraurbana ed extramuraria, tra la via Lata, la riva sinistra
del fiume e la pendice del Campidoglio, in un’area destinata ad attività militari, ludi e ricca di templi, teatri,
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
terme, portici e giardini, oltre che di sepolcri onorifici per personalità eminenti come Silla e di strutture per
il culto imperiale.
La pianura era detta campus Martius. Al centro s’impiantò la prima area a uso politico esterna alla città,
l’ovile, destinata alle riunioni della nuova assemblea creata dalla riforma serviana, i comitia centuriata: in
quanto assemblea di uomini in armi i comitia non potevano essere convocati all’interno del pomerium.
Un complesso famoso in Campo Marzio centrale è costituito da quattro templi:
- Il tempio “C” periptero sine postico, è attribuito alla dea Feronia
- Il tempio “A” periptero esastilo nella terza fase, è identificato con quello di Giuturna
- Il tempio “D” senza colonne se non sulla fronte, s’individua, in modo controverso, quello dei Lari
Permarini, divinità protettrici della navigazione
- Il tempio “B” circolare, s’identifica con meno dubbi il tempio della Fortuna di Questo Giorno.
A seguito delle proscrizioni e della morte dei nemici di Cesare e dei seguaci di Marco Antonio, gran parte
delle proprietà in Campo Marzio fu acquistata da M. Vipsanio Agrippa, che, presso l’ovile, promosse diversi
edifici, in parte archeologicamente noti: le terme completate nel 12 a.C. e decorate con notevoli opere
d’arte e un ginnasio; un lago artificiale e un giardino.
A lui, grossomodo al centro del Campo Marzio, si deve anche la costruzione del primo Pantheon, il
santuario dinastico della gens Iulia dedicato nel 25 a.C. e in asse al Mausoleo fatto erigere da Augusto per
sé stesso solo due anni prima; anche il senato onorò Augusto in Campo Marzio settentrionale con la dedica
nel 9 a.C. dell’ara Pacis.
In questa regione si trovano i teatri più famosi dell’Urbe.
Nel resto della Regione si distribuivano caseggiati, domus, tabernae, horrea, complessi per i cavalli e per gli
alloggi dei membri delle fazioni impegnate nell’organizzazione delle gare del circo, moli per le navi che
navigavano o risalivano il Tevere.
Regio XIV. Transtiberim
La Regione XIV occupava l’area della città alla destra del Tevere, limitata dai Monti Vaticani e dalla dorsale
del Gianicolo, comprendendo l’isola Tiberina. Secondo la tradizione Romolo avrebbe acquisito per la prima
volta i territori al di là del fiume, strappandoli alla città etrusca di Veio.
A partire dal secolo I a.C. la Regione si popolò di horti, pur di localizzazione quasi mai suffragata da dati
archeologici: nell’area di quelli di Cesare, Augusto costruì uno stagno artificiale per i combattimenti navali
inaugurato nel 2 a.C. in occasione della dedica al tempio di Marte Ultore. Caseggiati sono stati identificati
lungo la via Aurelia.
Alla fine del secolo II d.C. un’abitazione fu adattata a caserma della VII coorte dei vigili. Non mancavano
residenze di pregio forse pertinenti alle suddette proprietà imperiali: una domus sulle pendici settentrionali
del Gianicolo, con fasi databili tra l’età traianea e i secoli II-III d.C., ha restituito un deposito di marmi
policromi con circa seicento elementi marmorei.
Lungo la riva del fiume si addensavano horrea, banchine e zone di ormeggio per facilitare carico e scarico
delle merci; sparsi nel paesaggio, i mulini sfruttavano il flusso d’acqua degli acquedotti, in particolare per
l’estrazione dell’argilla, nel quartiere cosmopolita, ospitante anche una stabile comunità ebraica, plurimi
erano i luoghi dedicati ai culti “orientali”: gli dei di Siria, Libano, e Egitto.
La costruzione delle mura Aureliane tagliò il quartiere del Trastevere, dividendo l’area della Regione in due
settori; entro le mura, dal secolo IV d.C. comparvero le prime chiese e, in Vaticano Costantino fondò una
seconda basilica sulla tomba del primo apostolo Pietro.
La necropoli vaticana più famosa è appunto quella al di sotto della basilica petrina, sviluppatasi soprattutto
nel secolo II d.C. alle pendici della collina vaticana.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Capitolo 5 – L’italia e Roma dal secolo X al I a.C.
5.1 L’Italia centrale e Roma nei secoli X-V a.C.
Roma divenne un crogiolo di esperienze accogliendo anche artefici e stimoli di varia origine, come suggerito
anche dall’antica letteratura che, pur sommaria, svela i fatti salienti.
Dopo l’età del bronzo finale (1100-120 a.C.), le specificità della “cultura laziale” emergono sin dal secolo X
a.C. con la produzione ceramica e bronzistica nota ai corredi funerari. Dalla fine del secolo IX-VII a.C. si
assiste a un salto qualitativo e tecnologico nella ceramica: alla metà del secolo furono introdotti il tornio
veloce e la decorazione dipinta assieme all’utilizzazione dell’argilla depurata grazie all’apporto di
maestranze eubico-cicladiche. Se la bronzistica dipende da metalli e modelli provenienti dall’Etruria, nel
Latium vetus si sviluppò una produzione di beni di prestigio poi deposti nelle tombe “principesche”.
suddivise in base alla ricchezza dei corredi in membri dell’aristocrazia e in veri e propri dinasti, che
cominciarono dal secolo viii a.C., in coincidenza alla costituzione delle città in forme però non ancora
monumentali dopo una lunga fase preparatoria sin dall’età del bronzo finale.
Le esigenze cerimoniali della committenza emergono particolarmente nella produzione di bronzi laminati e
decorati a sbalzo e nell’introduzione di forme di vasi per nuove abitudini come il vino per il banchetto.
All’età di Numa Pompilio si fanno risalire la prima organizzazione di artigiani in collegi e le prime
testimonianze della bronzistica a Roma a partire dai dodici ancilia, scudi di intaglio sinuoso: si narrava che il
l’artigiano fosse riuscito a fabbricarne undici identici a uno caduto dal cielo per salvare la città da un anno di
pestilenza; le “copie” avevano la funzione di rendere impossibile per un eventuale ladro trovare
“l’originale”.
La Roma dei Tarquini
La nascita di strutture “statali” portò al consolidamento di una compagine urbana tra le maggiori
nell’Occidente mediterraneo, con simili novità:
- regolamentazione delle acque dei fossi e bonifica degli acquitrini;
- canalizzazione della cloaca Maxima;
- prime strade a fondo artificiale;
- utilizzo del foro Romano livellato e pavimentato come luogo di rilevanza politica e religiosa;
- erezione della cinta muraria – mura Serviane;
- investimenti nella costruzione di edifici pubblici come Regia, curia e circo;
- la produzione di laterizi e rivestimenti fittili, in particolare per i teti, laddove le tegole rimangono
riservate a edifici pubblici e a case del ceto medio-alto;
- contemporanea sparizione del lusso privato, ravvisabile nei corredi funerari;
- comparsa di documenti incisi su bronzo o pietra, come cippo del lapis Niger al foro Romano nel
recinto del Comizio;
- monumentalizzazione dei culti e introduzione di forme greche nelle architetture sacre e nelle
pratiche cultuali, accompagnata da un’“ellenizzazione” dell’iconografia degli dei;
- introduzione dei libri sibillini, da Cuna, rotoli di papiro scritti in greco con raccomandazioni rituali
che presupponevano sacerdoti capaci di consultarli.
Nel secolo VI a.C. il tempio si definì come categoria architettonica autonoma.
Templi tuscanici = quelli a tre celle a pianta tendente al quadrato;
Templi etrusco-italici = pianta rettangolare allungata, podio elevato che enfatizza l’edificio elevandolo
dall’area circostante, accesso frontale servito da una gradinata assiale, orientamento verso sud, colonne
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
rade con larghi intercolumni.
Si fanno rientrare nei templi etrusco-italici anche quelli ad alae oppure il periptero sine postico.
Gli edifici inizialmente avevano un frontone aperto, senza timpano secolo IV a.C. e in seguito, i templi
adottarono un frontone chiuso, decorato con soggetti mitologici particolarmente diffusi durante i secoli III-
II a.C. dalla seconda metà del secolo VII a.C. le coperture fatte di strame e paglia furono sostituite da
tetti di nuova concezione, con l’adozione di tegole e decorazioni fittili per templi e residenze gentilizie
monumentali. I fregi figurati raffigurano processioni di carri a carattere trionfale, corse di cavalieri armati e
di bighe/trighe, nonché banchetti, ed esaltano la mentalità eroico-cerimoniale dei gruppi dirigenti anche
mediante l’inclusione di temi mitici ed elementi rinvianti alla sfera ultraterrena.
Architettura domestica: case “ad atrio”
L’architettura in pietra in ambito domestico si diffuse in Etruria meridionale e nel Lazio dalla seconda metà
del secolo VII a.C.
Un nuovo modello residenziale signorile pare comparire a Roma dalla fine del secolo VI a.C. con una serie di
ambienti disposti secondo un asse principale longitudinale. Siccome tale forma, definita “canonica”, è
attestata anche in Etruria circa nello stesso periodo, ciò può significare che la tipologia della domus poté
essere elaborata già almeno alla fine del secolo VI-inizio del secolo V a.C. per poi disseminarsi e
standardizzarsi sempre più nell’ambito dell’insediamento delle colonie di Roma dalla fine del secolo IV a.C..
con l’Urbe nel ruolo di mediatrice.
Arrivano gli “stranieri”
Le più antiche menzioni di artigiani riguardano “stranieri” giunti in Italia centrale nella cornice del
commercio aristocratico, a partire dai tre modellatori dai nomi parlanti, Euchino (dalla buona mano), Diopo
(colui che traguarda) ed Eugrammo (dalla buona pittura), e da un pittore, Ecfanto, i quali verso la metà del
secolo VII a.C. accompagnarono il ricco mercante Damarato, padre del futuro re Tarquinio Prisco.
Sotto il regno di Tarquinio Prisco, da Veio fu chiamato Vulca per la grande statua di culto del tempio di
Giove Capitolino. Non stupisce il riscorso a un Veiente, visto che la città da tempo aveva instaurato rapporti
culturali con l’Urbe tanto da avere accolto anche il culto di Enea come fondatore.
Invece il “Maestro di Apollo” ideò l’intera decorazione coroplastica del tempio nel santuario del
Portonaccio
Poco dopo a Roma i modellatori e pittori Damofilo e Gorgaso (nome di un eroe guaritore della Messenia)
decorarono il tempio della triade plebea sull’Aventino, Cerere, Libero e Libera. Prima di allora le decorazioni
dei templi erano tuscaniche, ossia dovute a maestranze etrusche. Il loro stile rimanda alla Magna Grecia.
A riprova dell’”ellenizzazione” del Lazio arcaico, alla fine del secolo VI a.C., nelle iscrizioni latine la scrittura
cambiò direzione per divenire destrorsa, parallelamente a quanto verificatosi in tutto il mondo greco,
mutamento tanto più significativo giacché in quelle etrusche si usava invece la sinistrorsa.
“Lupa Capitolina”
Sempre alla fase iniziale della Repubblica risale un monumento molto probabilmente pubblico a
celebrazione della saga delle origini. Malgrado la proposta di una sua datazione medievale, ne sono state
rimarcate le tangenze iconografiche e stilistiche con l’arte persiana, filtrate sempre dalla cultura figurativa
ionica. Una terza possibilità è che l’opera sia una copia dei secoli XII-XIII riprodotta attraverso calchi
appunto da un originale etrusco-italico.
Dal secondo quarto del secolo V a.C. in Etruria iniziò un secolo di “crisi”, che provocò un restringimento
delle possibilità rappresentative e dell’esibizione della ricchezza. La cultura figurativa sino alla metà del IV
secolo a.C. accolse le coeve conquiste greche in modo non sistematico, senza sapere o volere abbandonare
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
le soluzioni del passato, tardoantiche prima, “severe” poi, per cui la coesistenza di tante esperienze non
facilita la definizione di chiare sequenze cronologiche.
La critica si è avvalsa della nozione di “attardamento” per descrivere la relazione tra “centro”, il luogo delle
innovazioni (la Grecia), e “periferia”, il luogo del ritardo (l’Italia).
Uno dei fattori che determinò un assorbimento a singhiozzo delle novità greche in Italia fu l’infiacchimento
delle committenze pubbliche, fenomeno che impedì alle officine di aggiornarsi. Neppure Roma nel secolo V
a.C. poté vantare un Partenone, perché non si costruirono templi tra il 484 a.C. e il 431 a.C.
Le cose cambiarono con la ripresa dell’opulenza aristocratica alla fine del secolo V e l’inizio del secolo IV
a.C.
Da Orvieto provengono testimonianze fra le più vistose del “classico” nella coroplastica. A Falerii Veteres
l’avvio intorno al 380 a.C. della più antica ceramica nella tecnica a figure rosse trasse stimolo dalla presenza
di maestranze greche forse attiche e dall’importazione di vasi attici a figure rosse.
Infine nella bronzistica, la “Chimera di Arezzo”, opera votiva di matrice attica, è stata accostata a una
protome leonina fittile dall’officina di Fidia a Olimpia.
5.2 Artigianato e monumenti onorari a Roma e in Italia centrale nei secoli IV-III a.C.
A poco prima della metà del secolo IV a.C. risale la “cista Ficoroni”, scoperta a Praeneste e alta più di 70 cm.
La cista, un contenitore di forma cilindrica destinato a custodire il corredo femminile, ha un’iscrizione che,
quasi quale certificazione di maggiore qualità, la dice eseguita a Roma da un certo Novius Plautios, non
l’incisore, ma il proprietario dell’officina, su una precisa ordinazione di una dama prenestina, la
committente Dindia Macolnia, la quale donò l’oggetto alla figlia.
“DINDIA MACOLNIA FILEAI DEDIT/ NOVIOS PLAUTIOS MED ROMAI FECID“ “Dindia Macolnia (mi) donò
alla figlia / Novio Plauzio mi fece a Roma”
La decorazione figurata a bulino di grande qualità ricalca poi i motivi della grande pittura greca, a cui rinvia
anche il soggetto (un episodio della saga degli Argonauti), e forse della ceramica italiota che svolse un ruolo
intermediario. Infine, le statuette di Libero e dei satiri sul coperchio, oltre a rivelare la popolarità dei
soggetti bacchici in Italia centrale, furono in passato attribuite a un’officina etrusca.
A Roma dalla seconda metà del secolo IV a.C., in seguito alla conquista della Sabinia, si registrano grandi
novità qualitative e quantitative nei monumenti ufficiali e nell’artigianato. Le conseguenze furono: crescita
economica e demografica, processi produttivi volti al profitto con protagonisti i ceti abbienti, apparizione
della moneta, afflusso di manodopera schiavistica. Quelli furono gli anni dell’espansione dell’Urbe, con le
vittorie su Etruschi, Latini e Sanniti; conquiste militari che le consentirono di entrare in diretto contatto con
varie aree geografiche del sud e quindi con altrettante versioni culturali di grecità, come nel caso della
vittoria su Taranto.
Furono inoltre gli anni in cui Roma, diventata padrona dell’Italia, cominciò a dotarsi di più consone
infrastrutture di servizio, riorganizzando gli spazi, come il foro Romano, specialmente nell’area del Comizio,
uno spazio inaugurato che era luogo delle assemblee politiche, di cerimonie religiose e di funzioni
giudiziarie: alla fine del secolo IV a.C. assunse forse una forma circolare ispirandosi a modelli architettonici
greci.
Il Foro Romano, elevato a luogo di rappresentanza civile e politica sul modello dell’agorà greca, guadagnò in
dignitas grazie alla sostituzione delle botteghe dei macellai con le tabernae dei banchieri e alla costruzione
delle basiliche (Porcia e Fulvia/Emilia) funzionali allo svolgimento di attività giudiziarie, finanziarie o
amministrative e atte a ospitare banchieri e commercianti.
L’Urbe diventò anche un centro produttivo (soprattutto di ceramica). L’artigianato in Italia centrale, pur
spezzettato in numerose sfaccettature “dialettali”, in genere fu qualitativamente eccellente anche nelle
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
espressioni più correnti. L’allineamento con la cultura figurativa greca fu raggiunto. Il boom della religiosità
popolare italica e latina portò all’intensificazione della pratica di dedicare nei santuari anche doni in
terracotta: essi consistevano in ex voto anatomici, raffiguranti parti del corpo umano nonché in teste
spesso ricavate da matrici e, più di rado, in statue e busti, raffiguranti per lo più i dedicanti in modi non
personalizzati.
Le tante teste rielaborano, semplificano e impoveriscono motivi formali “prassitelici” e “lisippei”, tra cui
anche la criniera leonina “alla Alessandro”.
Nella documentazione superstite, il frammento di affresco a carattere storico proveniente da una tomba
dell’Esquilino mostra una tecnica “a macchia” presentano invece figure con sicura linea di contorno e
documentano l’acquisizione delle tecniche greche nella riproduzione degli effetti di luce, come nell’uso di
segnare l’ombra dietro gli oggetti appesi alle pareti.
Nei secoli IV-III a.C. l’arte per i Romani fu uno dei mezzi più vantaggiosi per la celebrazione del potere e
della religione statale: la statua di Giove sul Campidoglio è talmente grande da risultare visibile sin dal
santuario di Giove Laziale sulla sommità di Monte Calvo nei Colli Albani.
Sempre in quel periodo si perfezionarono specifiche tipologie rappresentative romane, destinate a lunga
fortuna. Allora l’élite politica e il popolo s’impegnarono nella formazione di una memoria monumentale
negli spazi pubblici mediante la dedica di templi, archi, spoglie di guerra e statue onorarie sul Campidoglio e
al foro Romano, nell’area del Comizio. L’impatto dei monumenti testimoni del potere di Roma poteva
crescere in occasione delle spettacolari processioni funerarie o trionfali in grado di rendere ancora più
vivide le associazioni tra topografia urbana e memoria dei protagonisti della storia precedente e passata.
Persino due personaggi greci, Alcibiade e il filosofo Pitagora, ricevettero delle statue alle estremità del
Comizio: la decisione del senato aderì al responso di un oracolo che aveva ingiunto ai romani di onorare il
più valoroso e il più saggio dei Greci, esempi rispettivamente dei valori cardinali della società romana,
fortitudo e sapientia.
Delle statue onorarie/votive in bronzo che si andavano innalzando in quei decenni resta pochissimo, salvo il
“Bruto Capitolino”. Se ancora è incerto se a plasmarlo fu un etrusco, un campano o un romano, i confronti
con coeve opere greche consentono tutt’al più di stabilire che il ritratto fu prodotto da un artefice in
contatto con le soluzioni del ritratto greco individuale, cui si sommarono formule proprie del bagaglio
figurativo centro-italico, come la chioma appiattita e la barba con ciocche a fiammella.
Nelle processioni trionfali sfilavano le tabulae triumphales, resoconti visivi dei fatti salienti di guerra, che al
termine venivano deposte all’interno di templi o presentate in pubblico in modo permanente.
5.3 Il sacco di Siracusa e l’età delle conquiste nel secolo II a.C.
Anno 212 a.C., presa di Siracusa: un momento di svolta per l’”ellenizzazione” sempre più radicale dell’arte e
dei costumi. M. Claudio Marcello trasferì nell’Urbe statue e quadri in grande quantità in occasione della sua
ovatio del 211 a.C.
Mentre Marcello era orgoglioso di aver abbellito Roma con opere sprigionanti grazia e fascino greci, i più
anziani, conservatori, brontolavano.
Fino a quel momento i templi e in generale tutta l’Urbe erano venivano abbelliti con armi o armature
sottratte ai nemici, ma mai in quantità tali da provocare sgomento. Da quel momento in poi ogni
trionfatore fu quasi costretto a superare anche in questo campo il predecessore per esaltare il proprio
successo, tanto che i loro nomi rimangono associati all’introduzione di determinate mode.
A ogni bottino si accompagnò l’infiltrazione anche del linguaggio figurativo e architettonico greco.
Con l’epoca delle vittorie in Asia Minore di L. Cornelio Scipione nel 189 a.C. l’ottica moralistica delle fonti fa
coincidere l’introduzione della luxuria Asiatica. I Romani nel giro di cinquantasette anni, ossia sino il 133
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
a.C., quando Attalo III di Pergamo lascio a Roma in eredità il suo tesoro, avrebbero imparato ad ammirare e
ad amare l’opulenza straniera.
Insieme alla luxuria e con l’arrivo di artefices orientali si diffusero anche le tematiche asiatiche come le
celtomachie e i più drammatici modelli figurativi che spesso chiamiamo “pergameni”.
Grazie alle diverse vittorie riportate nel mondo greco sino al 146 a.C., anno della distruzione di Corinto e
Cartagine, Roma partecipò a un orientamento già nato nelle corti ellenistiche che aveva portato alla
rivalorizzazione della Grecia e di Atene come centro culturale. È significativo che L. Emilio Paolo avesse
compiuto un periplo della Grecia, visitando anche Atene e pretese che tornassero a Roma con lui sofisti,
grammatici, filosofi, pittori, e personaggi di spicco greci.
Le opere siracusane vengono definite calamitose (infesta) in un discorso pronunciato probabilmente da M.
Porcio Catone, il celebre censore, irritato dai troppi lodatori degli ornamenti di Corinto e Atene e
dall’irrisione delle decorazioni architettoniche in terracotta degli dei romani.
Ciononostante, Plinio il Vecchio sottolinea ancora l’esistenza a Roma e nei municipi di ornamenti fittili sulla
sommità dei templi ammirabili per la rifinitura, l’arte e la solidità, più venerati che se fossero stati d’oro – e
più “innocenti”.
Se dall’inizio del secolo II a.C. in Italia le dimore signorili conobbero l’introduzione del peristilio, un’area
scoperta circondata da un quadriportico perimetrale, tipologia di ascendenza greca già nota dalla seconda
metà del secolo V a.C. ma adottata soprattutto nei palazzi reali dei regni ellenistici. Negli spazi pubblici di
Roma intanto stavano sorgendo i quadriportici, nel circo Flaminio ispirati ai grandi porticati ellenistici e
perfetti per la presentazione delle prede belliche. Roma si stava dotando di strutture da capitale ellenistica
comprese quelle portuali e commerciali.
Intanto stavano mutando volto anche i templi. All’interno della porticus Metelli, quello di Giove Statore fu il
primo interamente di marmo, eseguito da un architetto greco.
Nel linguaggio architettonico si diffusero i medesimi schemi tipologici e ritmi in un’ampia koiné culturale in
grado di abbracciare l’intero bacino del mediterraneo, ma le tante scelte progettuali non furono del tutto
sovrapponibili in ambiente greco e romano, visto il bisogno di adattamenti dettati anche dalle locali
tradizione religiose e/o dalle scelte culturali dei committenti.
Tuttavia il quadro era molto articolato a quei tempi, perché anche architetti romani potevano essere
chiamati presso le corti ellenistiche.
Nei secoli II-I a.C., in Italia centrale nacquero santuari terrazzati con paralleli nel mondo ellenistico, come il
santuario di Asclepio a Co: accanto all’esempio urbano del tempio Magna Mater sul Palatino, il più celebre,
quello oracolare della Fortuna Primigenia a Praeneste fu costruito intorno al 120 a.C. al momento della
riqualificazione della città.
Inoltre, l’edilizia tardorepubblicana adottò l’opera cementizia, costituita da un nucleo di materiale
incoerente legato da malta tra due paramenti lapidei; sostituendosi per lo più all’opera quadrata, questa
permise strutture voltate senza limiti di dimensione, in modo rapido ed economico, con conseguenze anche
sull’organizzazione della forza lavoro ed effetti socio-economici.
5.4 Crisi della Repubblica e “guerre” di monumenti
Ai giorni delle guerre civili nel secolo I a.C. le apparizioni pubbliche dei singoli capifazione (Mario e Silla;
Cesare e Pompeo; Ottaviano e Marco Antonio), appoggiati da divinità come Venere e influenzati dai modelli
regali, si fecero sempre più provocatorie, indebolendo le istituzioni repubblicane.
Pompeo in Campo Marzio aveva costruito il primo teatro permanente in muratura allineando finalmente
Roma non solo con la Grecia ma anche con una pratica già nota in Italia centrale.
Cesare rispose con il progetto di un nuovo foro. L’audace disegno della lex de Urbe augenda del 45 a.C.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
mirava poi ad ampliare il Campo Marzio sfidando la natura con la deviazione del corso del Tevere e ad
aumentare la bellezza e gli impianti della città in modo da rendere Roma in grado di tenere testa alle
metropoli ellenistiche.
Nell’Urbe e non solo proliferavano poi le statue onorarie posizionate nei luoghi più frequentati. Per
esempio, una statua di Cesare in avorio poté sfilare in occasione della pompa circense assieme ai simulacri
degli dei; un’altra fu collocata nel tempio di Quirino con l’iscrizione di dedica e un’altra ancora in
Campidoglio insieme al gruppo dei re, accanto a bruto, colui che aveva liberato Roma da Tarquinio il
Superbo. Davanti al tempio di Venere Genitrice nel foro di Cesare, la sua testa aveva sostituito un ritratto di
Alessandro in sella al cavallo Bucefalo, statua di Lisippo!
Un primo monumento in Campidoglio comprendeva statue di Mario con l’iscrizione celebrativa delle
battaglie vittoriose. Successivamente Silla riuscì ad abbattere tutti i monumenti di Mario. Cesare durante
l’edilità del 65 a.C. iniziò la carriera politica schierandosi con Mario e ripristinando in una notte
segretamente tutte le sue statue in Campidoglio; la mattina dopo tutti accorsero a vedere le nuove statue
rilucenti d’oro e fatte con arte sopraffina.
Anche la ritrattistica continua a riflettere le molteplici opzioni figurative a disposizione degli artefici e le
scelte individuali dei committenti. Stavolta si conoscono alcune riproduzioni di teste identificate con
certezza e un tempo abbinate a statue.
Pompeo aveva una ciocca di capelli appena sollevata sulla fronte e occhi che si muovevano con vivacità,
conferendogli una più dichiarata che effettiva somiglianza con Alessandro Magno: anche uno dei suoi
ritratti cita al centro della fronte il motivo distintivo della chioma di Alessandro, segno del combattente
vittorioso, combinandolo con la faccia carnosa di un uomo di mezza età con fronte corrugata, occhi piccoli e
labbra sottili.
Cesare, nel ritratto quand’era ancora in vita, ha i capelli piatti e il viso smunto con rughe accentuate sul
collo.
Sul volto concentrato di Cicerone, a bocca appena aperta, spicca la fronte altissima, solcata da pieghe.
Fuori Roma, si chiamava Aule Meteli il membro della nuova aristocrazia municipale ritratto con un gesto di
allocuzione nell’”Arringatore”, il bronzo in toga pretesta e scarpe chiuse. Viso e chioma adottano le
medesime formule in voga nella ritrattistica di Delo, dal 166 a.C. sede di un importante porto franco
frequentato da Greci, Orientali e Italici sotto il controllo ateniese.
Nel 78 a.C. non esisteva nell’Urbe abitazione più bella di quella del console M. Emilio Lepido, primo a usare
in casa soglie di marmo di Numidia; la sua dimora però 35 anni dopo non occupava neppure più il
centesimo posto in graduatoria. Gli sprechi innescati dall’aumento di ricchezza sociale inocularono nei
precari equilibri della Repubblica un veleno mortale, cui già Catone il Censore aveva provato a tenere testa
in diverse orazioni in cui egli condannava il lusso abitativo. Di fronte alla publica magnificentia,
irrinunciabile, la privata luxuria fu tanto insopportabile nelle parole dei detrattori quanto inarrestabile,
perché i potenti avevano assoluto bisogno di una casa di rappresentanza consona alle proprie
caratteristiche politiche e sociali, in una parola alla propria dignitas.
Nella tarda Repubblica, le colonne di marmo cominciarono a sostenere i tetti non solo dei templi, ma anche
di atri, peristili o piccole edicole e sono testimoniate dai capitelli ionici recuperabili nei magazzini di musei o
reimpiegati in chiese di Roma.
Capitolo 6 – Secolo I a. C.-secolo I d.C.: dagli imperatori giulio-claudi alla dinastia
flavia
I Romani dichiaravano un grande interesse verso la cultura greca, che dalla seconda metà del secolo II a.C.
in poi divenne basilare per la formazione dei Romani di alto lignaggio. I magistrati più influenti avevano
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
appreso il greco e assumevano maestri greci per i loro figli. Alcuni di loro parlavano correntemente il greco
ed ebbero per la grecità un amore che li spinse a importare a Roma le maestranze greche per la produzione
di spettacoli teatrali e opere d’arte.
In età tardorepubblicana il numero dei Romani e degli Italici ricchi era di gran lunga superiore a quello delle
classi dominanti greche. Erano grandi possidenti, con proprietà sparse con ville inizialmente rustiche,
dedicate al controllo delle attività agricole e in seguito ampliate con l’aggiunta di settori sontuosi destinati
ad abitazione di lusso, con numerosi vani, cortili e peristili, giardini e ninfei.
In città non era consentito avere dimore sfarzose, c’erano polemiche contro il lusso. In campagna era però
concesso e le ville divennero fastose dimore. I proprietari volevano che le loro abitazioni fossero come
dimore degli dei, spiritualmente presenti essi stessi attraverso i loro simboli sparsi ovunque: dalle sculture
che decoravano le stanze e i giardini alle decorazioni ad affresco.
Un altro ambito nel quale il gusto e la mentalità romani hanno prevalso è l’architettura religiosa. In Grecia il
tempio è l’abitazione degli dei e di solito non svolge alcuna funzione se non quella di contenere la statua di
culto e i doni votivi destinati alla divinità. A Roma, al contrario, il tempio non ospita soltanto la statua di
culto del dio, ma è la sede di attività sacrali, è il luogo di incontro di confraternite e di collegi sacerdotali, e
anche spazio alternativo per le riunioni del senato e di altre magistrature politiche.
In età tardorepubblicana la scommessa fu di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze religiose romane e
l’eleganza dell’architettura sacrale greca. Fu così che, pur conservando gli elementi essenziali della
morfologia templare tradizionale, i templi romani tendono ad adeguarsi alle norme degli stili ionico e
corinzio sviluppando lo schema con il colonnato su soli tre lati (periptero sine postico) o con i colonnati
laterali addossati alle pareti della cella (pseudo-periptero sine postico), oppure solo in facciata (prostilo).
6.1 L’architettura a Roma da Augusto a Domiziano
Roma era soggetta di frequente a inondazioni e incendi; per tale motivo quando la città fu ereditata da
Augusto egli tentò di ridurre i fattori di rischio con una serie di provvedimenti, con l’istituzione di numerosi
corpi di sicurezza, tra i quali la figura del curator alvei, incaricato di controllare il corso del Tevere, e le
coorti di vigili del fuoco per proteggere la città dagli incendi.
Con l’aiuto del fidato amico Agrippa, il principe rifornì inoltre la città di idonee risorse idriche, con il
restauro e la costruzione di nuovi e più imponenti acquedotti.
Egli si atteggiò come un nuovo Romolo, rifondatore della città nel segno della pace ristabilita dopo decenni
di guerre civili. Si spiegano così i numerosi restauri di edifici templari fatiscenti da lui compiuti ancora prima
di diventare padrone assoluto dell’Impero. Ottaviano/Augusto si contrapponeva ai suoi predecessori,
accusati di non essere stati capaci di onorare convenientemente gli dei della religione avita, e suggeriva di
essere lui stesso, con la sua opera di pacificazione, il loro emissario.
Il progetto principale previde il ridisegno globale di una vastissima area del Campo Marzio settentrionale,
fino allora pressoché deserta, ma dominata dall’imponente edificio funerario, a carattere dinastico, che
Ottaviano aveva cominciato a costruite sulle rive del Tevere.
Il Mausoleo sovrastava con la sua gigantesca mole tutto il paesaggio urbano dell’area, trasformata a
giardino con boschetti. Il Campo Marzio centrale era legato a memorie romulee, in quanto luogo della
raccolta degli uomini atti alle armi, dove Romolo, proprio a seguito di una perlustrazione dell’esercito,
scomparve. L’area fu monumentalizzata ricostruendo gli edifici civili più importante e costruendone di
nuovi, tra cui il Pantheon e le Terme di Agrippa, il primo grande edificio termale pubblico a Roma.
Nel 10-9 a.C., nello spazio compreso tra Pantheon e Mausoleo di Augusto, fu eretto in onore di Sol un
grande obelisco egiziano proveniente da Eliopoli e, più a oriente, l’altare monumentale, l’ara Pacis.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
L’obelisco era lo gnomone di una meridiana, e il 23 settembre, compleanno di Augusto, la sua ombra
puntava sull’ara Pacis. Un rapporto incrociato tra 23 settembre e 21 aprile (dies natalis di Roma) sembra
potersi scorgere nell’orientamento del Pantheon. È pertanto possibile supporre che solarium, ara Pacis e
Pantheon fossero gli elementi fondanti di un programma simbolico a celebrazione di Augusto come novus
Romulus, rifondatore della città nel segno della pace.
La presenza di Augusto nella città, all’interno delle “mura Serviane”, fu condizionante e finalizzata ad
accentuarne la posizione di uomo del destino, punto di convergenza dell’intera storia romana. Il principe
pilotava così la memoria collettiva in funzione del suo messaggio in apparenza pacificatore. Lo fece
cancellando di su buona parte dei monumenti da lui restaurati o ricostruiti i nomi dei loro primitivi
dedicanti, apponendovi il proprio nome o mutando spesso, come nel circo Flaminio, il loro dies natalis
perché coincidesse con il suo compleanno, il 23 settembre.
Un personaggio come C. Sosio ebbe la possibilità di dedicare il nuovo tempio Apollo Medico, il cui
programma figurativo parla di Ottaviano e delle sue gesta. È in questa fase che s’impone definitivamente la
morfologia del tempio periptero o pseudo-periptero.
In questi templi da un lato compare l’utilizzo sempre più massiccio del marmo in luogo del tufo o del
travertino stuccato, dall’altro i loro interni diventano sempre più fastosi e originali per importazione, nel
tempio di Apollo Medico lo spazio non è neutro, ma ritmato dalla presenza alle pareti di un doppio ordine
di colonne di marmo africano a risalto su podio che ribattono su lesene. La teabeazione del primo ordine
era rettilinea e figurata; tra le colonne una serie di edicole costituiva, con le statue in esse inserite una
complessa articolazione, accentuata da una consistente policromia: oltre alle colonne a risalto di marmo
africano, le edicole avevano colonne, fregi e probabilmente frontoncini di pavonazzetto dalla Frigia, di giallo
antico africano e di portasanta; il soffitto era di stucco dorato. Il pavimento era in opus sectile.
Niente di più lontano da una concezione “classicistica” dell’arte augustea di questi interni che ricordano
piuttosto, con il vivace uso di marmi colorati, l’architettura sacra del Seicento romano.
Ottaviano/Augusto scelse come sede per le sue abitazioni il Palatino, accentuando, nel tempo, il rapporto
simbolico con Romolo che, proprio nella zona oculatamente scelta dal principe aveva la sua primitiva
dimora. La domus di Ottaviano era il risultato dell’acquisizione di più case alle quali non era stato offerto un
assetto architettonico unitario, non una sola abitazione, ma più case collegate tra loro e, a esse connesso, il
grande santuario di Apollo Palatino.
Anche i successori di Augusto non giudicarono utile proporre una sistemazione unitaria del complesso
abitativo palatino finché Nerone, approfittando dell’incendio del 64 d.C., iniziò un capillare lavoro di
rifacimento non più esclusivamente architettonico, ma anche urbanistico, con l’avvio dei lavori di
costruzione della domus Aurea.
Solo Domiziano, però, riuscì a costruire una sede imperiale a carattere unitario sul Palatino.
La Villa della Farnesina, ai bordi del Tevere nella Regione XIV, fu invece costruita secondo le regole delle più
lussuose ville repubblicane, con una grande esedra affacciata sul fiume, peristili, porticati, criptoportici e
ambienti con la più raffinata decorazione ad affresco del “II stile” finale.
Da un punto di vista sia urbanistico che architettonico, i principati di Tiberio, Caligola e Claudio non offrono
novità eclatanti.
- A Tiberio si deve la ricostruzione nel primo decennio del secolo I d.C. del tempio della Concordia e
del tempio dei Castori nel foro Romano;
- A Caligola si deve la dedica del tempio del divo Augusto, situato probabilmente alle pendici del
Palatino, poiché avrebbe dovuto essere scavalcato da un ponte che, secondo un progetto
dell’imperatore, avrebbe collegato la sua dimora palatina con il tempio di Giove Capitolino;
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
- Appartengono all’età di Claudio i resti di alcuni monumenti: di un arco decretato dal senato nel 43
d.C. a seguito delle vittorie in Britannia che celebrava probabilmente il suo decennale di principato,
e di un’ara monumentale con recinto (l’”ara Pietatis”) simile per morfologia all’ara Pacis.
Ben altra situazione venne a crearsi con Nerone, quando nel 64 d.C. un incendio colpì una vasta area del
centro di Roma, dalle pendici del Palatino verso l’Esquilino, coinvolgendo nelle fiamme anche alcuni dei
monumenti più insigni legati alle origini dell’Urbe. Il giovane imperatore ebbe così la possibilità di
riplasmare una porzione notevole della città inserendovi una nuova gigantesca dimora imperiale.
Così nasceva la domus Aurea, da immaginare impostata come un agglomerato di edifici di misura
differente, sparsi entro un vastissimo parco i cui giardini imitavano artificialmente la campagna coltivata
con vigne, zone agricole e pastorizie, vedute lacustri, boschi e foreste. Nerone voleva creare un’enorme
villa suburbana nel cuore stesso di Roma, trasferendo la campagna in città.
La domus Aurea sperimenta articolazioni spaziali interne di grande originalità. Una delle sale principali del
padiglione sul colle Oppio era ottagonale, con una volta a cupola in opera cementizia al cui centro era un
oculus da cui entrava la luce del giorno. Ma la novità nella domus Aurea è il sapiente passaggio da una base
ottagonale a una volta a cupola circolare: una soluzione di cui si sarebbe ricordato Filippo Brunelleschi per
l’immensa cupola di Santa Maria del Fiore.
È tuttavia con gli imperatori della dinastia flavia che l’architettura romana raggiunse uno dei suoi vertici
insieme con l’efficiente miglioramento delle tecniche edilizie che permisero di gettare volte a botte, a
crociera, a padiglione o a cupola di misura ben superiore rispetto a quanto attuato fino allora.
Il Colosseo fu realizzato in parte durante il principato di Vespasiano (i primi due ordini), e completato alla
sua morte dal figlio Tito (gli altri due ordini superiori), mentre a Domiziano si deve la costruzione dell’ampio
reticolo di vani di servizio sottostanti l’arena che, da quel momento in poi, impedì lo svolgimento di
spettacoli di naumachia. Il Colosseo si distingue non solo per l’impressionante misura, ma anche per la
qualità progettuale, sebbene ispirato a modelli teatrali e anfiteatrali preesistenti, come il teatro augusteo.
La struttura è formata da tre ordini di arcate con semicolonne tuscaniche, ioniche e corinzie, mentre il
massiccio attico è scandito da paraste con capitelli corinzi a foglie lisce, tra le quali si alternano una finestra
e un clipeo di metallo; nelle arcate si trovavano centinaia di statue di dei ed eroi. La cavea era a sua volta
distinta in cinque settori dei quali il superiore, l’unico con sedili di legno, era all’interno di un portico
colonnato che ne concludeva l’assetto.
Sempre a Vespasiano si deve la realizzazione del templum Pacis, vasta area recintata con facciata interna a
grandi colonne a risalto di marmo africano, porticati su tre lati con colonne di granito rosa di Assuan, con un
giardino al centro scandito della presenza di sei canali d’acqua circondati da rose. Al centro si trovava il
tempio della Pax Augustea, destinato a contenere, oltre la statua di culto, il bottino della guerra giudaica,
tra cui la celeberrima menorah, la tavola per il “pane della presenza” con i vasi sacri, e le trombe d’argento
sottratti al distrutto Tempio di Gerusalemme.
È negli ambienti della domus Augustana sul Palatino, dove per la prima volta a Roma si tentò di offrire un
assetto unitario ai palazzi imperiali, con una partizione precisa tra ambienti di rappresentanza e di
residenza. La novità è nella varietà morfologica e nella misura eccezionale degli ambienti di rappresentanza,
a partire dall’”Aula Regia”, alta circa 30 m, avente alle pareti trabeazioni e colonne a risalti e grandiose
edicole, anch’esse su due ordini, contenenti sculture colossali in basanite, pietra dal colore simile al bronzo;
la copertura era a capriate di legno, nascoste da un soffitto a cassettoni di stucco.
6.2 La “classicità” augustea
In età ellenistica si erano imposte teorie estetiche che giudicavano inarrivabile il livello raggiunto dai grandi
artisti dei secoli V e IV a.C.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Si vennero a sviluppare canoni di artisti, giudicati non più esclusivamente con il metro tecnico e formale,
ma in quanto ineguagliati nella rappresentazione di determinati soggetti.
Nacque in questa fase il mito di Fidia quale vertice assoluto dell’arte greca, il solo capace di rappresentare
gli dei come erano realmente, e di Policleto oltremodo abile nel rappresentare gli uomini con una dignità
oltre il vero. Sviluppatosi ad Atene, il gusto per forme artistiche dipendenti da modelli “classici” raggiunse
ben presto Roma.
Augusto, impostando le sue regole in base a un codice “morale”, avrebbe perciò precluso la strada verso
più originali e innovative correnti artistiche. Siamo però effettivamente certi che l’arte augustea sia
“classicistica”?
L’ara Pacis consta in un recinto perimetrale che racchiude l’altare su cui i magistrati, i sacerdoti e le vergini
Vestali sacrificavano ogni anno. All’interno, nella parte inferiore del recinto s’individuava la raffigurazione
del tavolato ligneo a delimitazione dello spazio inaugurato dei “templa minora” così come creati dagli
auguri; il registro superiore con festoni e bucrani intervallati da patere e coppe può rimandare alla
decorazione posta sopra la recinzione lignea. All’esterno, il recinto è separato da una fascia a svastica. Nel
registro superiore le scene prevedono a nord e sud un corteo di personaggi storici, che rappresenta
un’unica processione, forse l’adventus a Roma di Augusto accolto dai consoli. Figurazioni mitiche si trovano
poi ai lati delle porte a est (Roma vittoriosa seduta su armi e la figura denominata “Tellus” che rimanda alla
fecondità e alla felicità dell’epoca) e a ovest (sacrificio di Enea a Lavinio alla presenza dei Penati,
allattamento di Romolo e Remo nel Lupercale).
È stato per lungo tempo luogo comune considerare i rilievi figurati della fascia superiore dipendenti da
modelli “classici”, a partire dalla grande processione, nella quale si sono voluti vedere rapporti formali con il
fregio del Partenone.
Il messaggio che l’ara Pacis trasmette non è greco, e forse non è casuale che non ci siano in Grecia
raffigurazioni di processioni pubbliche di magistrati, escluso il caso, anomalo, del Partenone.
Ci sono differenti sfumature tra il grande fregio con processione, il piccolo fregio con pompa sacrificale sulle
sponde dell’altare, nel quale si sono visti elementi dell’arte “popolare” romana, e i pannelli simbolico-
mitologici che, nella loro ambientazione “idillico-sacrale”, derivano dalla tradizione ellenistica.
Ogni soggetto è diversamente impostato secondo schemi figurativi tratti dall’ampio repertorio dell’arte
greca, e non esclusivamente da quello “classico”: ma il risultato ottenuto non ha confronti nell’arte greca.
Lo stile è una costruzione nuova, non “classicistica” nel vero senso della parola. E di certo non nella logica
più imitativa di una parte della produzione “neoattica” tardorepubblicana, ma che suggerisce la formazione
di un nuovo linguaggio “classico”, consono ai temi della comunicazione augustea.
Il nuovo linguaggio si avverte con maggiore tensione nei pannelli simbolico-mitologici e, per altri aspetti,
nel grande fregio a girali di acanto della fascia inferiore del recinto. Mai, nei monumenti ellenistici,
l’ambientazione era stata impostata con tale dovizia di dettagli e con un tale effetto di gradazione del
rilievo. Mai si trova, poi, quella capacità descrittiva degli elementi vegetali. Questa nuova visione, aperta
alle voci della natura, è direttamente legata alla concezione della nuova età dell’oro, uno dei motivi decisivi
augustei.
La medesima formula linguistica si riscontra in una lunga serie di rilievi di diverso formato che dovevano
decorare le pareti di lussuose domus e ville in luogo di affreschi o di dipinti, con raffigurazioni a carattere
ora mitologico, ora pastorale.
Entro questo strato culturale hanno origine i rilievi “Grimani” pertinenti a un ninfeo realizzato nel foro di
Praeneste. In questo caso, sebbene si possa ravvisare anche una derivazione da modelli greci, forse più che
negli esempi precedenti si constata la capacità degli artisti di età augustea di sapere utilizzare spunti della
tradizione per giungere a soluzioni del tutto innovative.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
La cultura augustea, insomma, non è “classicistica”, ma nei suoi momenti più alti modifica i codici artistici
desunti dal lungo percorso della tradizione greca rinnovandone alle fondamenta il significato, e procedendo
così alla costruzione di una nuova forma “classica”.
Naturalmente i Romani in età giulio-claudia fecero largo uso nelle loro dimore di originali greci e di copie da
opere illustri greche, per innestarle però in un differente contesto che ne mutava l’originaria valenza e
funzione. Nei casi più interessanti, l’imitazione diventa emulazione, volontà di realizzare qualcosa che possa
essere di pari livello, se non superiore, sotto il profilo artistico, al modello.
Gli artisti in età romana attinsero da tutto il repertorio figurativo greco, dall’età arcaica fino alla piena età
ellenistica. Come anticipato, i greci stessi, dal secolo V a.C. in poi, non rimasero insensibili al fascino delle
forme arcaiche. Così anche ai Romani è parso in determinati casi che la forma arcaica fosse la più idonea a
rappresentare i principali dei dell’Olimpo. Eppure la componente arcaica, sebbene dominante, è
ridimensionata, quasi minata alle fondamenta, in virtù dell’elaborazione parzialmente naturalistica del
panneggio e del complessivo decorativismo formale.
Nell’ambito di questa tradizione artistica si potrebbero inserire anche il celebre “Spinario” in bronzo e la
Venere dell’Esquilino. In ambedue i casi i corpi derivano da modelli di età ellenistica, ma i volti dipendono
invece, sebbene con formule non coincidenti, da modelli di stile “severo”.
L’arte augustea è il risultato di un impasto di molte componenti di matrice greca, tra le quali quelle di
derivazione ellenistica non sono affatto limitate, dall’esasperato patetismo al sapore bucolico di alcuni
rilievi dell’ara Pacis o, sempre nell’ara Pacis, al corposo naturalismo dei girali. Simili componenti sono
comunque miscelate di modo che il risultato artistico è di profondo controllo e misura.
Durante il secolo I a.C. il gusto per forme patetiche a Roma aveva subìto forse un ridimensionamento con la
diffusione della corrente “neoattica”, ma non era mai stato rimosso del tutto. Un linguaggio tendente al
“barocco” fu adottato per determinati soggetti che la cultura artistica di derivazione “neoattica” non era
capace di rappresentare in modo efficace.
Negli horti del politico e oratore C. Asinio Pollione potevano trovarsi sculture colossali di artisti di Rodi, tra
cui il “Toro Farnese”, una fastosa macchina teatrale in un unico blocco di marmo che nelle figure associa
elementi della più pura tradizione patetica con altri di tradizione “classica” e altri ancora derivati dalla
tradizione “idillico-sacrale”.
6.3 Rilievi di statali a Roma dalla dinastia claudia alla dinastia flavia
Nei pochi rilievi attribuibili a monumenti pubblici degli imperatori della gens Claudia, il linguaggio figurativo
augusteo sembra avere subìto alcune variazioni formali, come nel caso di quelli pertinenti a un grande
altare monumentale e al già citato arco dedicati all’imperatore Claudio. Come sull’ara Pacis, alla quale si
doveva avvicinare anche per le misure, la processione sul fregio principale del recinto dell’altare
rappresentava il ritorno di Claudio a Roma nel 43 d.C., dopo la trionfale campagna bellica in Britannia.
L’imperatore è ricevuto dai principali esponenti del senato che lo conducono, attraverso un percorso tra i
monumenti sacri del Palatino e del foro Romano, rappresentati sul fondo in maniera schematica ma precisa
nei dettagli, come le decorazioni frontonali, fino al tempio di Marte Ultore nel foro di Augusto, dove si
svolge la cerimonia del sacrificio di un toro.
Il confronto con l’ara Pacis permette di riconoscere con maggiore chiarezza l’evoluzione del linguaggio
formale verso una maggiore vivacità d’impostazione delle figure su più piani e verso un loro inserimento
entro un contesto ambientale più articolato, e non più solo su fondo neutro.
Le figure, alte quanto il rilievo, sono pari se non superiori di misura ai templi sul fondo, e l’ambiente è
costruito in chiave più simbolica che naturale. Si avverte comunque un diverso modo di pensare il rilievo,
con il tentativo di offrire un maggiore respiro atmosferico, che avrebbe condotto entro pochi decenni ai
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
risultati dei pannelli sull’arco di Tito.
I frammenti di rilievi attribuii all’arco dedicato a Nerone sul Campidoglio proseguivano lungo il medesimo
percorso.
Di tutt’altro stile sono i pannelli dell’arco sul versante settentrionale del Palatino eretto, come recita
l’iscrizione, per il divo Tito, probabilmente tra l’82 e il 90 d.C.: un monumento dunque di consecratio e non
trionfale. Infatti ambedue i pannelli del fornice raffigurano il trionfo giudaico, senza la presenza di
Vespasiano. Le figure si protendono dal fondo del rilievo con maggiore autonomia e con volumi più corposi,
superando anche lo schema comune della distribuzione secondo file regolari e con una scansione uniforme.
La grande novità rispetto al passato, però, è che i personaggi, a esclusione di Tito sulla quadriga, non
coprono l’intero campo del rilievo, ma poco più della metà, sì che circa un terzo dello spazio superiore è
vuoto, o coperto dai fasci o dal bottino di guerra trasportato in trionfo. Tutto ciò crea un effetto di
maggiore profondità rispetto ai rilievi giulio-claudi e un respiro atmosferico che sembra preludere a un
pieno rinnovamento della concezione spaziale del rilievo: un aggiornamento del linguaggio figurativo che
però l’arte romana seguente, pur applicandolo talvolta, non ebbe il coraggio di attuare fino alle sue ultime
conseguenze.
6.4 La ritrattistica imperiale
Quando Ottaviano giunse a Roma deciso ad accettare l’eredità lasciatagli da Cesare le sue prime forme di
comunicazione in campo artistico si mossero nell’ambito della tradizione consolidata degli ottimati romani,
fortemente influenzata dai modelli patetici di derivazione greco-ellenica.
- I primi ritratti, i tipi “Béziers/Spoleto” e “Lucus Feroniae” mostrano un viso magro e ossuto, occhi
piccoli e infossati, collo piegato di lato e verso l’alto e capigliatura agitata con ciocche a fiammelle
disposte in ordine apparentemente disordinato.
- Anche il terzo tipo ritrattistico – il più diffuso tra i ritratti giovanili e noto come tipo “Alcudia” –
presenta caratteristiche analoghe, sebbene si noti una maggiore distensione dei tratti facciali. I
modelli sono sempre e comunque le immagini tradizionali in toga, proprie del magistrato, quelle in
nudità, quelle loricate, infine, quelle equestri.
A Roma l’accentuazione delle forme “realistiche” dei volti, la cui caratterizzazione in Grecia è più
attenuata, crea un effetto stridente. È probabile che a Roma i ritratti avessero volutamente una
maggiore caratterizzazione, a danno della migliore fusione formale delle teste con corpo giovanili e
atletici.
La battaglia di Azio e la seguente conquista di Alessandria segnano come uno spartiacque nei modi di
rappresentazione di Ottaviano. S’impone contemporaneamente l’uso, che diverrà costante nella
ritrattistica imperiale, di procedere a variazioni iconografiche dell’immagine del principe non tanto come
segno tangibile del passaggio del tempo, quanto come memoria di eventi di particolare significato: la
celebrazione del trionfo, del ritorno a Roma, dei dieci anni e dei vent’anni di principato e così via.
- Agli anni 31 e 29 a.C. è stato di recente attribuito, con buoni argomento, il ritratto tipo “Louvre MA
1280”, nel quale la forte tensione che caratterizzava i ritratti precedenti è assai ridotta.
Gli elementi distintivi del volto, di un uomo però ormai maturo, ci sono ancora tutti, ma vi appare
come una pacata pensosità, un equilibrio, accentuato dalla chioma non più ribelle, ma con una
frangia ben ordinata, a ciocche regolari, che sottolinea l’acquisita coscienza del proprio compito di
pacificazione.
- L’ultimo ritratto (il tipo “Prima Porta”) mostra un fondamentale viraggio. Il volto ridiventa
giovanile, ma perde i tratti fisionomici più dissonanti, attutiti e come piegati nelle maglie di una
visione ammorbidita e regolarizzata. La capigliatura è però assai meno agitata rispetto ai tipi
ritrattistici precedenti e rigidamente sottomessa a uno schema preciso, con il gioco dei ciuffi che si
dispongono con andamento a forbice o a tenaglia sulla fronte.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Si è spesso voluto vedere in questo ritratto un tentativo di adeguamento dell’immagine del principe a
quella del Doriforo di Policleto. Ha contribuito a questa ipotesi la più bella delle statue intere conservate,
l’Augusto dalla Villa Livia a Prima Porta, che mostra il principe loricato in atto di sollevare il braccio come in
procinto di parlare agli astanti. Ponderazione e proporzioni del corpo sembrano derivare dal Doriforo, ma
non certo i tratti caratterizzanti del volto, comunque evidenti, né il tipo di capigliatura, ben lontana dal
sistema a calotta adottato da Policleto.
Tra i tanti ritratti del tipo “Prima Porta”, a parità di schema iconografico ci sono però variazioni formali
anche sensibili. Poiché i ritratti non sono tra loro uniformi, la possibile derivazione dal Doriforo resta un
problema aperto. Comunque sia, il nuovo tipo rientra perfettamente nell’orbita del nuovo linguaggio
“classico” imposto da Augusto.
La tendenza a realizzare ritratti dipendenti da quello dell’imperatore vivente divenne consueta da Augusto
in poi e non solo in ambito privato, ma anche entro la famiglia imperiale, sì che talvolta ci sono stati
autentici fraintendimenti che hanno condotto all’assegnazione a Ottaviano/Augusto di tipi ritrattistici
raffiguranti invece i suoi nipoti.
Al contrario del ritratto augusteo, persiste, nella ritrattistica privata del secolo I a.C., la tradizione
“realistica” tardorepubblicana, ma con forme più ammorbidite. I tratti distintivi dei volti sono descritti con
fine sensibilità, né si coglie in essi, tranne forse che nei rilievi funerari dei cittadini più ordinari, opere di
maestranze meno colte, il sistema di dettagli individuali giustapposti e non organicamente connessi.
Nella ritrattistica imperiale posteriore ad Augusto la caratterizzazione dei volti ha il sopravvento sulla
maggiore semplificazione delle forme. Pur muovendosi lungo il percorso politico da lui avviato, i successori
di Augusto non vollero imitarne l’immagine, preferendo una maggiore personalizzazione dei tratti facciali
secondo le regole del ritratto privato dell’epoca.
Si scosta da questa logica il solo Nerone che, partito da un taglio dei capelli a calotta con frangia, passa a
ritratto nei quali sono accentuati gli elementi più specifici del volto, rotondeggiante e grassoccio, con collo
pronunciato, indizio della volontà, da parte dell’imperatore di costruire una sua immagine personalizzata,
dominata da una nuova e caratteristica acconciatura di capelli con ampia frangia a falcetto sulla fronte, la
“coma in gradus formata”. Questa chioma era invece già divenuta di moda per i bambini dell’età di Claudio.
Nerone, perciò, dichiarava in modo plateale la rottura con gli schemi iconografici fino allora adottati dai
prìncipi giulio-claudi. Egli dava così avvio a una moda poi durata fino all’epoca di Adriano.
Vespasiano volle subito distinguersi dai modi del ritratto neroniano, accentuando per contrasto il
“realismo” dei tratti facciali secondo le regole della ritrattistica tardorepubblicana. Di qui l’accentuata
caratterizzazione, che rasenta la rozzezza, di molti suoi ritratti.
6.5 La decorazione parietale
La storia della pittura sia nella prima età imperiale sia dopo è praticamente la storia della decorazione
parietale di domus e ville romane.
- Dopo il “I stile”, diffuso nel bacino mediterraneo nel secolo II a.C. e impiegato in ambito italico sino
all’inizio del secolo I a.C., il sistema pittorico, con l’avvio del “II stile”, sviluppa fino agli estremi limiti
la costruzione sulle pareti di architetture scenografiche, simili a scenae frontes teatrali, secondo
schemi che, pur partendo da modelli greco-ellenistici, si evolvono rapidamente verso una
magniloquenza più rispondente alle esigenze della rappresentazione romana in ambito privato.
Gli dei, nella maggioranza delle decorazioni del “II stile” non sono presenti al vero, ma tramite i loro
simboli, e in tal modo la scenografia parietale assume anche forte valenza religiosa.
L’impressione che i Romani volessero suggerire nelle loro dimore un’atmosfera quasi sacrale, proponendo
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
illusori ingressi a giardini celesti e santuari posti sotto la tutela divina. Sappiamo anche che le pareti erano
anche il fondo per rappresentazioni a carattere teatrale.
Nelle ultime fasi, il “II stile” sfocia verso un sistema ornamentale che perde sempre di più, come osserva
Vitruvio, il rapporto con reali strutture architettoniche, a favore di capricci della fantasia, verso forme
leggere prive di qualunque concretezza strutturale spesso trasformate in elementi vegetali, entro le quali
s’inseriscono figure leggiadre che “non esistono, non possono esistere e non sono mai esistite”. Secondo
Vitruvio simile decorazione era del tutto da respingere.
Di qui nasce la decorazione della Villa della Farnesina, del “II stile” finale. Gli affreschi sono tra i più alti
raggiungimenti della pittura antica. Le architetture parietali perdono consistenza strutturale e tendono a
diventare pura decorazione a carattere bidimensionale, intervallata dalla presenza di pannelli con
rappresentazioni mitologiche e paesaggistiche. I topia (elementi tipici) della pittura parietale secondo
Vitruvio erano: porti, promontori, spiagge, fiumi, sorgenti, stretti di mare, santuari, boschi sacri, il tutto
popolato da greggi e pastori. Sono quei paesaggi comunemente detti “idillico-sacrali”.
Sono immagini che fanno riferimento alla topothesia che è, appunto, la rappresentazione di un ambiente di
fantasia, di contro alla topographia che adotta strumenti differenti per raffigurare un ambiente reale.
La gamma cromatica non è molto estesa: vari toni del bruno, del verde, dell’azzurro chiaro tendente al
ghiaccio e del giallo, fusi armonicamente entro il dominante colore bianco crema, appena rosato, del fondo.
In queste pitture si rileva ancora un altro fattore compositivo tipicamente romano. La distribuzione dei
singoli elementi si distende in lunghezza e in altezza più che in profondità, e quanto è visto di scorcio, verso
il fondo, è comunque assorbito dalla nebbia che appena lascia intravedere le sagome degli oggetti.
- Da questa temperie culturale nasce il “III stile”, la cui cronologia è stata fin troppo appiattita verso
gli ultimi due decenni del secolo I a.C.
Il “III stile” conduce ai limiti estremi la distruzione dell’effetto illusorio di strutture monumentali
dipinte sulle pareti.
Nella villa di Boscotrecase le parete assomigliano vagamente a quinte teatrali, di solito tripartite, con due
alti elementi laterali, simili a esilissimi padiglioni a torre con cornice superiore, che delimitano uno spazio
centrale dominato dalla presenza di un’edicola. Ogni elemento della composizione è schiacciato alla parete,
di modo che i possibili effetti illusionistici della scenografia sono quasi totalmente annullati.
Nella “sala rossa” della villa le grandi edicole centrali, composte da fragili colonnine ricoperte da motivi
decorativi e floreali, con capitello ionico su cui poggiano semplici cornici a nastro, sono simili a sostegni a
giorno di cartelloni e inquadrano magnifiche vedute “idillico-sacrali” su fondo bianco crema, ulteriormente
delimitate da una spessa fascia nera.
In tale fase compare un nuovo sistema decorativo che sembra sfondare le pareti delle stanze con la
rappresentazione di giardini dietro semplici e basse staccionate. Nulla nell’arte di età augustea esprime
meglio la concezione della nuova “classicità” dell’epoca come la pittura di “III stile”, nella sua squisita
coerenza geometrica, nel suo raffinato decorativismo che diventerà di maniera solo nelle sue ultime
propaggini.
- Il “IV stile” germina dal precedente con un profluvio decorativo che non ha più la misura
“classica” della decorazione augustea. Rispetto agli stili precedenti, non c’è neppure omogeneità di
schemi figurativi, al punto che risulta difficile descriverne le componenti essenziali.
È una pittura che dà il meglio di sé nel dettaglio ornamentale, come i festoni vegetali e i girali che
incorniciano i quadri centrali.
Significativa è la veduta ad affresco di una città spopolata, della quale si scorgono a basso volo d’uccello le
mura, il porto con una darsena laterale, un’acropoli affacciata sul mare, un teatro con un tempio di Apollo,
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
quartieri di abitazioni affiancati alle mura e due piazzali, uno dietro il teatro circondato da case, l’altro, un
quadriportico con un tempio sul fondo alla maniera del templum Pacis. È uno dei rari esempi di pittura
corografica, che nel rappresentare brevi porzioni di territorio con una precisa adesione alla realtà, a
funzione quindi più geografica che artistica, adopera la tecnica della topographia.
Ancora, a un grandioso ninfeo, o meglio ancora a un ambiente destinato forse ad audizioni poetiche e
musicali, un museum, è invece pertinente una parete interamente rivestita a mosaico di tessere in pasta
vitrea con una partizione decorativa di “IV stile”, simile agli affreschi della Casa del Pinario Ceriale a Pompei
o ad alcuni della domus Aurea.
Capitolo 7 – Il secolo II d.C. e i “buoni imperatori”
7.1 Traiano e il “Maestro della colonna Traiana”
Traiano, per aver apposto il proprio nome su ogni edificio, non importa se eretto ex novo o restaurato, fu
malignamente soprannominato “erba parietale”. Dentro e fuori Roma si concentrò su molti progetti:
ampliamento del circo Massimo; potenziamento della rete stradale e dei porti, con conseguente
intensificazione dei traffici e regolarizzazione del flusso di derrate alimentari verso l’Urbe.
Traiano fu anche un imperatore-soldato che avviò una politica imperialistica aggressiva. Due guerre daciche
divennero la principale fonte di finanziamento della costosa politica interna. Grazie al favoloso bottino fu
costruito il foro di Traiano, con la colonna al suo interno, eretta per decisione del senato e del popolo anche
se – ovviamente – fu l’imperatore a sollecitare l’iniziativa: composta da ventinove rocchi monolitici in
marmo di Luni, il suo basamento si sviluppava per 6 m circa e presentava l’altezza straordinaria, con toro e
capitello dorico compresi, di 100 piedi circa.
La colonna è chiamata “coclide” (alla lettera “a chiocciola”) per la presenza di una scala ellittica all’interno e
per lo sviluppo del fregio che lo decorava.
La colonna s’inscriveva nella tradizione già repubblicana della colonna onoraria, qui coronata dalla statua
loricata in bronzo di Traiano. Fu un monumento celebrativo dell’imperatore: sul fregio ricorre quasi
sessanta volte, quasi sempre di profilo e a piedi e per lo più in lorica, in plurimi ruoli, religioso, civile e
militare.
I rilievi disposti “a nastro” costituirono un equivalente visivo dei Commentarii de bello Dacico redatti
dall’imperatore in persona.
L’ornamento della colonna fu frutto di una decisione eccezionale e senza precedenti, in grado di generare
una tradizione viva sino al secolo IV d.C.. Sul fregio a ventitré spire i rilievi narrano, dal basso verso l’alto in
ordine cronologico e con illusione di continuità, lo svolgimento delle campagne militari in Dacia, con
duemilacinquecentosettanta figure.
È ormai un luogo comune degli studi il confronto con il fregio della cella nel Partenone, altrettanto poco
visibile, fuori e dentro il colonnato, per l’elevata altezza e la penombra della stretta peristasi. Qualche
critico vi ha perciò intravisto la libertà di un artista che, sciolto da obblighi verso il committente, lavorò solo
per se stesso, pago delle proprie forme e conscio del fatto che queste mai sarebbero state vedute in modo
adeguato;
Altri vi hanno letto una rappresentazione che non informava, ma esprimeva il fasto e la gloria del principe al
cospetto del cielo e del tempo;
Viceversa, si è anche provato a mostrarne l’effettiva visibilità e la possibilità di lettura quasi totale secondo
assi preferenziali nord-ovest/sud-est.
Ma questo è un problema solo per noi; non lo era per un fruitore antico. La colonna era un monumento
che, leggibile per segmenti grazie anche alla ricorrenza e alla ridondanza delle scene, mirava insieme al foro
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
a impressionare mediante la rappresentazione meticolosa di grandi imprese pietrificate e rese leggendarie,
senza imporre al frequentatore del complesso di girarci ventitré volte intorno.
Per il più o meno dettagliato progetto disegnativo preliminare è stato chiamato in causa l’ingegnere
militare e architetto del foro Apollodoro di Damasco oppure in modo più neutro il “Maestro delle imprese
di Traiano”: per Bianchi Bandinelli una grande personalità responsabile dell’inizio dell’”arte romana” più
tipica e vera.
7.2 Arriva il “Graeculus”: Adriano
Adriano fece costruire innumerevoli opere, con un’organizzazione quasi militare di tutti i mestieri legati
all’edilizia, senza mai fare iscrivere il proprio nome a eccezione che nel tempio dedicato al padre Traiano.
Restaurò il Pantheon. All’interno un profluvio di marmi colorati preziosi: porfido dall’Egitto, giallo antico
dalla Numidia, pavonazzetto dalla Frigia, serpentino dal Peloponneso, verde antico dalla Tessaglia; quanto
ai marmi bianchi, il pentelico fu utilizzato per le cornici, gli architravi e gli archivolti, mentre solo i capitelli
sono in marmo lunense; le colonne monolitiche del portico sono in granito del Mons Claudianus in Egitto.
Ad Apollodoro alcuni specialisti attribuiscono la concezione della struttura perfettamente della cella
circolare dal diametro pari all’altezza della cupola perfettamente emisferica in opera cementizia, articolata
nella calotta interna in ventotto file di cassettoni prospetticamente ristretti verso l’alto.
Adriano ripristinò poi i recinti del voto, la basilica di Nettuno, molti templi, il foro di Augusto, le Terme di
Agrippa, tutte le opere consacrate con i nomi degli antichi fondatori, astenendosi dall’apporre iscrizioni
sulle opere pubbliche.
Fu meno discreto nella fondazione di nuove città, come Adrianopoli in Tracia e Antinopoli in Egitto.
Nell’Urbe simile modestia non era insolita, era semmai stato il “cattivo” Domiziano ad avere rifatto diversi
edifici a proprio nome sopprimendo la memoria dei fondatori.
Adriano fece costruire nell’ager Vaticanus, negli horti di Domizia, un mausoleo diverso da quello di Augusto,
malgrado la coincidenza dei diametri: la struttura, ad aggiornamento della tradizione tipologica ellenistica
dei sepolcri dinastici, constava di un basamento quadrato, di un imponente tamburo cilindrico con peristasi
su podio e di una rotonda centrale chiusa, coronata sulla sommità dalla quadriga bronzea dell’imperatore.
Il mausoleo di Adriano non è altro che l’attuale Castel Sant’Angelo.
Adriano impresse il proprio timbro sull’Urbe, pur tenendosene distante per i continui viaggi in Occidente e
Oriente: ansioso com’era di avere conoscenza diretta delle varie regioni dell’Impero, vi lasciò vari segni
monumentali del suo passaggio.
Egli amò particolarmente Atene, faro della cultura dove risiedé più volte e fu onorato quale “salvatore” e
“fondatore”; addirittura gli fu concesso il privilegio unico di una statua nella cella del Partenone a fianco
della statua fidiaca di Atena Parthénos in oro e avorio.
Tre esempi, benché su piani molto differenti, illustrano la perfetta fusione politico-culturale di componenti
elleniche e romane.
Anzitutto, secondo una tipologia elaborata nella parte greca dell’Impero, nei programmi figurativi delle
statue loricate dell’imperatore le immagini della Lupa Romana si associano all’immagine “arcaistica” di
Atena attorniata da una civetta, l’animale a lei sacro, e dal serpente, che rimanda all’eroe Erittonio. Ad
Atene, l’arco di Adriano combina la formula onoraria romana con il sistema trilitico dell’architettura
ellenica.
Un ulteriore segno della grecofilia di Adriano è ravvisato nella sua barba. Questa, nella ritrattistica non priva
di sporadici precedenti del secolo I d.C. nei volti giovanili e senza sopprimere l’alternativa dei visi imberbi
per i privati, sancì quasi una rivoluzione per la presentazione dell’uomo di potere, destinata a durare sino
ad alcune versioni dei ritratti dei tetrarchi.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Adriano, si legge nella Storia Augusta, portava i capelli arricciati con il pettine e con la barba voleva
nascondere le cicatrici sul viso sin dalla nascita. Un’ulteriore spiegazione è che a barba sia un’elegante nota
di grecità e di valorizzazione di quella tradizione culturale in senso generale da parte di un imperatore
filelleno.
Villa Adriana
Nelle varie parti della villa, ufficialmente denominata “villa Tiburtis” e costruita su un terreno collinoso nel
luogo di un precedente impianto della fine del secolo II a.C., secondo la Storia Augusta Adriano aveva fatto
iscrivere i nomi più rinomati delle province e dei luoghi cui s’ispiravano le architetture come il Liceo (il
ginnasio dove insegnava Aristotele), Accademia (la scuola fondata da Platone), Pritaneo (l’edificio delle più
alte autorità cittadine in Grecia), Canopo (città del Basso Egitto unita ad Alessandria e celebre per un
tempio di Serapide e per le feste pubbliche), Pecile (il portico sul lato nord dell’agorà di Atene), Tempe
(valle del nord della Tessaglia dove si situava l’accesso all’“Elisio” greco). Non una novità, visto che sin dal
secolo I a.C. tra le cerchie più ellenizzate della nobilitas era dilagata la moda di dare nomi greci alle parti
delle volle come procoeton (vestibolo), peristylon (colonnato) o peripteron (edificio cinto da colonne).
Le varie tappe edilizie si delineano in parte grazie ai mattoni bollati. È concepibile un’attività di costruzione
ininterrotta a partire dal 118 d.C. e basata su un progetto unitario dal preciso computo metrico, con una
successione prestabilita delle aree da edificare.
Tra le strutture più celebri ricordiamo il “Teatro Marittimo”, considerato il soggiorno riservato
dell’imperatore, un piccolo padiglione con 25 m di diametro quale cerniera tra più blocchi abitativi e
consistente in un’isola circondata da un canale circolare; l’edificio si articolava come una casa, con la
sequenza canonica e assiale atrio-tablino, affiancata da cubicoli e terme.
A Villa Adriana non sorprende la frequenza di statue da archetipi ellenistici o comunque in un linguaggio
formale affine attinenti alla sfera bacchica. Non poteva essere diversamente, perché immagini del genere si
conformavano benissimo alla decorazione degli spazi ameni di una villa.
I contesti antichi delle sculture di Villa Adriana sono per lo più perduti, salvo eccezioni.
Il “Canopo” era uno spettacolare triclinio estivo, con bolli laterizi del 123-124 d.C., quindi prima del viaggio
di Adriano in Egitto. Questi è costituito da un antro artificiale, ossia un’esedra con nicchie quadrate a
gradini per cascate e altre semicircolari poco profonde; sull’emiciclo s’incurva il catino a spicchi veloidici e
sferici, decorato con un mosaico policromo. Uno stibadio in muratura (letto da banchetto semilunato)
poteva ospitare sino a diciotto commensali, mentre altri erano accolti nei piccoli padiglioni posti a fianco
dell’esedra.
Diverse statue dovevano in origine trovarsi lungo i bordi dello specchio d’acqua. Tra queste si annoverano
copie e riproduzioni, con qualche variante più o meno significativa, di originali greci del secolo V a.C., come
due amazzoni ferite e quattro cariatidi che ricalcano le kòrai della coppia centrale nella loggia dell’Eretteo
sull’Acropoli di Atene. Si aggiungono ornamenti consoni alla vasca, quali due gruppi speculari di Scilla, un
coccodrillo in cipollino e personificazioni di fiumi, quali il Nilo e il Tevere e un terzo non più identificabile.
7.3 Gli Antonini verso la “crisi”
Antonino Pio, mai allontanatosi da Roma se non per spostarsi nelle proprie ville, non fu frenetico nel
costruire. L’attività edilizia degli Antonini nell’Urbe fu più moderata. Oltre ai restauri, furono completati i
cantieri adrianei. Gli interventi degli Antonini si concentrarono nel Campo Marzio centrale, dove il piano
urbanistico fu avviato probabilmente sin da Adriano. Presso Montecitorio si sono rinvenute quattro
strutture di forma quadrata consistenti in un altare al centro di un cortile circondato da un recinto e da una
balaustra con cippi collegati da sbarre di ferro: monumenti indicanti quasi di sicuro il punto in cui furono
cremati i membri della famiglia imperiale, ed eretti dopo la combustione delle loro spoglie, benché non ne
risulti per noi certa l’associazione a un nome specifico.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Antonino Pio, amante della pace, aveva sì condotto campagne militari, ma tramite i suoi legati. L’eco delle
guerre stava però per farsi sentire anche in Italia. I Marcomanni nel 169-170 d.C. riuscirono a oltrepassare il
confine dell’Italia assediando Aquileia: evento tanto traumatico che Marco Aurelio dovette chiamare
indovini da ogni parte, compiere riti stranieri e purificare Roma con sacrifici di ogni genere, celebrando
anche lettisterni con rito romano per sette giorni.
Le imprese belliche furono celebrate sulla colonna in Campo Marzio, con il probabile tempio dei divi Marco
Aurelio e Faustina Minore a ovest, eretta in un più vasto spazio rispetto alla Colonna Traiana, ma non perciò
meglio leggibile, e su una piattaforma dominante di 3 m l’adiacente via Lata.
La nuova colonna è definita centenaria (100 piedi = 29.62 m) e “del divo Marco”. 100 è un numero perfetto
ricorrente nelle lunghezze e nei diametri di vari edifici.
Il fregio a spirale è diviso in due metà dalla figura di Vittoria tra i trofei al centro del lato est, nello stesso
schema della figura sulla colonna Traiana, come si è dedotto, per separare le due spedizioni germaniche.
L’ideatore del progetto concepì un’opera che, come la colonna Traiana, combinava scene topiche con altre
dai più precisi riferimenti a episodi storici, a stento riconoscibili anche per il pessimo stato delle
testimonianze scritte sul periodo, al punto da avere destato la sensazione, poco plausibile, di un ordine non
cronologico.
Con lo stesso marmo (lunense) e l’identico numero di rocchi (17) del fusto, si cercò di superare il prototipo,
la colonna Traiana, tramite una statua di coronamento più grande e con un basamento in origine di altezza
quasi doppia.
Venti sono le spire, stavolta di altezza regolare, e si è calcolato uno stuolo di quaranta/cinquanta scalpellini,
una bella differenza dai sette/dodici ipotizzati per la colonna Traiana. Meno fitte le composizioni: le scene
di combattimento sono non di massa ma ridotte a duelli; rare le note paesaggistiche e architettoniche;
diminuite le scene, centosedici, più profondo il rilievo, 10 cm contro i 4 cm della colonna Traiana.
Per l’imperatore, senz’altro presente almeno 58 volte, è frequente la presentazione frontale, dal che,
esagerando, si è dedotta un’enfasi visiva sulla sua divina maestà e prefigurazione di soluzioni tardoantiche.
Si moltiplicano i quadri di guerriglia, sterminio, esecuzioni, devastazioni di villaggi e maltrattamenti di
donne con i loro piccoli. Furono guerre violente contro nemici selvaggi da punire brutalmente per avere
messo a nudo la vulnerabilità dell’Impero.
All’intensificazione degli effetti patetici corrisponde uno stile in generale più nervoso, sommario ed
espressivo. Questo stile, infrangendo le forme organiche dell’esperienza “classica”, è stato qualificato come
“espressionismo barocco”, uno “Stilwandeln” (cambiamento di stile) per un grande studioso tedesco,
Gerhart Rodenwaldt.
L’uso più diffuso del trapano si stava però imponendo per effetti più ottici che tattili anche in opere della
scultura “ideale” e in altre più monumentali che imponevano maggiore cura del dettaglio, come i grandi
rilievi reimpiegati nell’arco di Costantino celebrativi di Marco Aurelio.
Lo stesso vale per chiome e barbe sui ritratti di imperatori e di privati un po’ in tutto l’Impero, specie a
partire da Marco Aurelio e Lucio Vero. Celebre è un busto di Commodo dove i ricci finemente cesellati
contrastano con la levigatezza porcellanata del viso. Un lavoro splendido, degno di un imperatore detto di
bell’aspetto, con i capelli naturalmente ricci e biondi. Dalla fine del 191 d.C., tra le varie manifestazioni di
quel “commodismo” volto a costruire un principato sempre più autocratico supportato dal favore divino,
l’imperatore si fece chiamare Ercole figlio di Giove; depose il costume degli imperatori per portare una pelle
di leone e trasformarsi, con una clava, in Hercules Romanus – assunse anche altri epiteti straordinari come
Amazonius.
Come nella stilizzazione reale, anche nel busto dei Musei Capitolini, Commodo ha la pelle di leone, clava e
pomi delle Esperidi; completano la simbologia le due cornucopie incrociate, simboli di pace e abbondanza,
e il globo, segno di potere ecumenico, con diversi segni zodiacali.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Le lunghe guerre avevano dissanguato l’erario pubblico. Inoltre, a parte diverse carestie dagli anni sessanta
in poi, un’epidemia di peste si propagò dal 165 d.C. al seguito degli eserciti che avevano combattuto contro
i Parti in Oriente sotto Lucio Vero, per perdurare sino al 178-180 d.C., riprendere nel 187-188 d.C. e
risvegliarsi intorno alla metà del secolo III d.C.
Il secolo si chiuse poi con un grande incendio, che nel 192 d.C. devastò l’area tra foro Romano e Palatino:
andarono a fuoco il templum Pacis e il tempio di Vesta.
I circoli senatori pensarono ad un incendio intenzionale da parte di Commodo, il quale intendeva rifondare
la città quale proprietà personale, ma il 31 dicembre del 192 d.C. fu ucciso.
Capitolo 8 – Il secolo III d.C. e la “crisi” dell’Impero
Secolo III età della “crisi”, della “decadenza”, dell’“angoscia”
Indubbiamente, plurime cause misero in crisi un sistema che aveva saputo resistere a lungo: crisi
innanzitutto istituzionale (scarsa tenuta di governo, difficili rapporti con il senato, enorme potere nelle
mani dell’esercito) e di natura economica, ma anche politica (pressione dei barbari ai confini), religiosa
(declino della religione tradizionale, boom del cristianesimo e delle “religioni orientali”) e demografica
(ondate di pestilenza e carestie). In breve, il secolo III d.C. è ritenuto responsabile dello sgretolarsi
repentino del più imponente impero della storia occidentale.
Senz’altro fu un secolo non uniforme, il secolo dei molti tempi, come di recente definito, e delle molte
varianti regionali. Fu il secolo in cui si succedettero oltre cinquanta imperatori, al governo per un lasso di
tempo che va da ventidue giorni a diciotto anni. Fu il secolo in cui iniziarono a cadere le frontiere
dell’Impero. Fu il secolo di pesanti sconfitte e di importanti vittorie. Fu il secolo della perdita di centralità di
Roma e delle molte sedi imperiali, dapprima scelte come quartieri generali in vista delle battaglie contro i
nemici: Antiochia, Mediolanum, Sirmium, Tessalonica/Salonicco. Fu infine il secolo aperto e chiuso da
notevoli riforme.
La costituzione di Caracalla nel 212 d.C. concesse la cittadinanza romana a tutti i cittadini nati liberi
dell’Impero e ne equiparava i diritti legali. Nel 285 d.C. sarà la volta delle coraggiose riforme
amministrative, governative e fiscali di Diocleziano, con la suddivisione dell’Impero in quattro parti, che,
rette da Augusti e Cesari (la tetrarchia), ne costituirono l’ossatura per i secoli a venire.
Per comodità di analisi, conviene suddividerlo in tre periodi:
- I primi quarant’anni, ai tempi della dinastia di Settimio Severo (192-235 d.C.), si presentano come
continuità dell’epoca precedente e l’Impero degli Antonini;
- Una brusca interruzione segna i cinquanta anni successivi e l’età definita dell’“anarchia militare”
(235-284 d.C.) perché al governo si susseguirono una serie di imperatori-soldati, militari esperti
sollevati al soglio imperiale dai propri legionari;
- I vent’anni finali e l’età tetrarchica (285-305 d.C.), videro un ulteriore cambio di passo.
Mutamento formale dell’arte del III secolo perdita di plasticità, disfacimento della struttura anatomica e
della coesione organica delle forme, passaggio a volumi geometrici e a superfici levigate e astratte, forme
segnate da pesanti linee di contorno e da chiaroscuri fortemente contrastati.
L’idea che una simile evoluzione formale fosse legata a una diminuita capacità delle officine ha portato alla
formulazione del concetto di “decadenza”: niente di più falso. Le officine del periodo non sono affatto
meno capaci di quelle adrianee o antoniniane; semmai, rigettano o rielaborano le forme “classiche” per
sperimentarne altre. Nel 1901 Alois Riegl formulò l’idea di “volontà artistica”, sottolineando il passaggio da
una concezione “tattile” a una “ottica”, da una visione “normale” e ravvicinata a una “a distanza” culminata
nell’età di Costantino ma preparata gradualmente soprattutto a partire dall’età di Marco Aurelio, come
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
riscontrabile nella ritrattistica.
Nel 1970 fu Bianchi Bandinelli a reimpostare la teoria: furono i vari fattori di crisi della società del secolo III
d.C. a portare in pochi decenni all’abbandono delle forme “classiche” a favore dei nuovi linguaggi ad
anticipazione dell’arte bizantina.
Tuttavia le officine a Roma e altrove continuarono a essere fiorenti e di altissimo livello, eredi di una
tradizione di volta in volta riproposta e aggiornata nei contenuti - e in taluni casi superata.
Nei secoli II-III d.C. p l’Africa Proconsolare a fare fronte ai consumi di ceramica da mensa e da cucina,
secondo una dinamica destinata a rafforzarsi nei secoli IV-V d.C. e proprio in Africa Proconsolare nacque un
nuovo imperatore.
8.1 L’ultima dinastia: i Severi
Uomo di bell’aspetto, originario di Leptis Magna, acclamato imperatore a soli 39 anni: nessuno avrebbe
scommesso a quei tempi che Settimio Severo sarebbe stato il capostipite dell’ultima dinastia dell’Impero.
Eppure il suo regno, durato ben diciotto anni, fu il più lungo del secolo. Merito di una politica interna
piuttosto accorta, che tra i suoi punti di forza annoverava la pretesa di ideale continuità dinastica con la
famiglia degli Antonini e una gestione dell’esercito di grande acutezza, mai vista prima di allora.
Settimio Severo attuò una politica di legittimazione dinastica di ampio respiro, culminata nel proclama della
filiazione adottiva da Marco Aurelio: il suo secondo tipo ritrattistico mostra un’accentuata assimilazione
persino dei lineamenti del viso a quelli di Marco Aurelio.
L’innesto sul ramo della famiglia degli Antonini è ancora molto sensibile nel nuovo ritratto, creato dopo il
viaggio in Egitto nel 199-200 (tipo “Serapide”): qui le masse dei riccioli, voluminose e ancora molto
plastiche, sono pettinate sulla fronte con quattro boccoli spioventi che ricordano intenzionalmente la
divinità egizia Serapide; l’erede degli Antonini mescola così la propria immagine a quella dei prìncipi
antoniniani, simultaneamente citando la chioma di un dio. L’intento di legittimazione coinvolgeva
naturalmente tutti i membri della famiglia (moglie e figli).
Novità del secolo le legioni dislocate nell’Impero detennero un enorme potere, come mai prima di allora,
visto che imposero l’elezione al soglio imperiale dei propri comandanti, giungendo persino a eliminarli, se
non più graditi.
Fin dall’inizio del suo principato, Settimio Severo si affrettò a introdurre una serie di importanti e ben viste
riforme riguardanti l’esercito. Furono allora erette in città imponenti caserme, persino in aree a vocazione
residenziale.
Il regno di Commodo aveva visto rovinare l’area centrale della città a seguito di incendi: nel 185-186
Campidoglio, circo Flaminio e Campo Marzio; nel 192 l’area tra il templum Pacis e il Palatino. L’occasione fu
propizia per mettere in campo una politica di risanamento urbanistico.
Così Settimio Severo intraprese una vasta campagna di restauri di “tutti i pubblici templi che erano a Roma
pencolanti per via della loro vecchiaia”.
Ma non solo restauri. Si procedette anche all’erezione di una serie di edifici funzionali (magazzini, terme,
portici) o celebrativi. Così nel foro Romano fu inaugurato un arco a triplice fornice, svettante per più di 20
m di altezza nel punto in cui la Sacra via saliva sul Campidoglio.
L’arco commemorava le battaglie e vittorie sui Parti. Due grandi iscrizioni gemelle in lettere in bronzo
dorato inserite in incavi abbastanza profondi ricordano l’imperatore e i suoi figli che avevano conservato lo
Stato e ingrandito l’Impero.
L’apparato decorativo annunciava, solo sulle fronti, una “teologia della vittoria”: immagini di soldati romani
con prigionieri parti sui piedistalli dell’ordine di colonne applicato; vittorie alate tropeofore e geni delle
Stagioni quali segno della felicitas temporum; personificazioni di fiumi nei fornici minori.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Per il linguaggio formale la decorazione è stata additata come maldestra e talora ritenuta il punto di
abbrivio della supposta decadenza del secolo: figure tozze e tarchiate, perdita complessiva di grazia, scarso
interesse per i reciproci rapporti spaziali delle singole figure o per la notazione degli elementi paesistici.
Inizia il percorso che, appena un secolo dopo, porterà alla serialità ossessiva delle forme geometriche e
cubiche del fregio costantiniano dell’arco di Costantino.
Fu poi celebrata con gran fasto la ricorrenza dei ludi saeculares. Una festa fondata sull’ideologia del tempo
ciclico e del rinnovamento periodico a garanzia dell’aeternitas di Roma: un’occasione propizia per avviare
un’intensa attività edilizia. Sul Palatino, oltre a restauri all’ippodromo-giardino della domus Augustana e
sull’acquedotto, fu ampliata l’area palaziale nel settore verso il circo Massimo; si procedé alla costruzione di
una quinta scenografica in forma di un fastoso ninfeo con giochi d’acqua e fontane.
Sempre tra il 10 dicembre del 203 e il 9 dicembre del 204, banchieri e commercianti di capi bovini votarono
l’erezione di un monumento al numen (forza divina immanente) di Settimio Severo e della sua famiglia,
come recita l’iscrizione incorniciata sulla fronte principale da due piccoli riquadri con Ercole e forse un
genio militare: l’“arco degli Argentari”, un piccolo fornice architravato.
Dal punto di vista compositivo, nei pannelli con i membri della famiglia imperiale si esaspera una tendenza
già riscontrata per Marco Aurelio sulla sua colonna e per Settimio Severo sull’arco: l’inquadratura è
frontale; gli occhi sono distolti dall’azione che le mani compiono, fissi sullo spettatore, che entra così in
campo, divenendo figura con la quale i personaggi instaurano un mutuo dialogo. L’adozione della frontalità
finisce con il trasformare i personaggi in perfette incarnazioni della maestà imperiale, e i gesti compiuti
diventano meri simboli.
Soluzioni iconografiche non dissimili dall’“arco degli Argentari” si riscontrano nel caso di un altro
monumento: l’arco dei Severi eretto tra il 205 e il 209 a Leptis Magna probabilmente dalla comunità
cittadina. Ancora una volta, non un arco trionfale, ma un magnifico tetrapilo onorario, all’incrocio di
importanti assi viari.
La prematura morte di Settimio Severo lasciò alla guida dell’Impero i figli, Caracalla e Geta. I loro ritratti,
negli ultimi anni del regno del padre, sono volutamente indistinguibili uno dall’altro: prevale il concetto
della concordia tra i due. I loro volti inaugurano una nuova moda, seguita per tutto il secolo dagli
imperatori-soldati: barba e capelli molto corti, un enorme distacco dalla tradizione antoniniana.
Una volta eliminato il fratello, Caracalla operò anche un deciso cambiamento d’immagine. Il suo ritratto più
diffuso all’epoca, con oltre quaranta esemplari, lo mostra estremamente energico: il collo, piegato a
sinistra, doveva accentuare nelle sue intenzioni una (inesistente) somiglianza ad Alessandro Magno.
Caracalla si mosse nel settore dell’arredo urbano sulle orme del padre: oltre ai lavori di restauri al Colosseo,
spicca sull’Aventino, la costruzione delle thermae Antoninianae, allora il più grande complesso termale mai
eretto a Roma. L’impianto è celebre anche per la varietà dei pavimenti marmorei e musivi e per la
decorazione statuaria.
Sul Quirinale fu eretto un tempio in onore di Serapide: accessibile da una duplice scalinata monumentale e
inserito in un’area porticata di 17.000 mq, era il tempio più grande di Roma dopo quello di Venere e Roma.
Il successore di Caracalla fu un suo giovanissimo cugino, opportunamente spacciato per suo figlio.
L’adolescente Marco Aurelio Antonino, è a noi noto con il nome Elagabalo, il dio siriano venerato in forme
aniconiche di cui era alto sacerdote.
Durante il viaggio dalla Siria verso Roma, volendo abituare il senato e il popolo ancora prima del suo arrivo,
il principe fece dipingere una sua immagine, molto grande nell’aspetto, che lo ritraeva mentre esercitava in
pubblico le funzioni sacerdotali assieme al simbolo aniconico del dio; il quadro fu esposto in mezzo alla
curia, in alto, così da sovrastare la statua di Vittoria presso cui i senatori offrivano incenso, aromi e libagioni
di vino. Al culto del dio Elagabalo fu riservato un complesso in posizione scenografica nell’angolo nord-
orientale del Palatino e unito ideologicamente alla contigua area dei palazzi imperiali.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Il breve regno del giovane Severo Alessandro si distinse per opere di pubblica utilità: restauro di edifici da
spettacolo di notevole capienza e totale rifacimento delle terme Neroniane.
Frattanto, in città le officine continuavano a fabbricare opere di alto livello, come il ritratto attribuito a
Elagabalo: il volto, intenso, è animato dal contrasto tra le superfici levigate dell’incarnato e la massa ancora
plastica, soffice e compatta dei capelli; le basette sono lavorate per progressivi passaggi di piani, fino a
incidere delicatamente il profilo delle gote.
Il busto di Severo Alessandro presenta alcuni elementi molto seguiti nei decenni a venire: l’uso della “toga
contabulata”, una pettinatura a ciocche fini accuratamente incise a solchi e graffi e una barba cortissima.
Anche la produzione di sarcofagi proseguiva, ma con qualche novità. I miti greci subirono una battuta
d’arresto o diventarono un elemento di contorno. Irruppero i defunti in persona, prima direttamente calati
nelle storie mitiche e poi anche nei panni di magistrati e “intellettuali” o in dimensioni ridotte al busto di
norma entro clipei; dunque il vero protagonista fu il defunto.
Cambiamenti di vario genere interessano anche altri media figurativi, come la pittura: pareti di case e
tombe si svuotarono. Le finte architetture, le figure fantastiche, i grandi quadri mitologici centrali
caratteristici del “IV stile” sono per così dire prosciugati: su pareti dipinte in bianco ne rimane lo schema di
base (edicola centrale e aperture minori ai lati), campito a sottili linee rosse, ma ormai pressoché esanime.
La tavolozza dei colori si restringe: bianco (sfondo), rosso (riquadri principali), verde (reticoli minori),
celeste e azzurro e sfumature di marrone e ocra per i corpi e le ombreggiature delle figurine accessorie e
decorative. Il risultato complessivo è elegante e asciutto, non privo di fantasia: le figure sembrano come
galleggiare su uno sfondo uniforme, decorando i riquadri centrali, le lunette, i sopra-porta, le volte.
8.2 Gli anni dell’“anarchia militare”
Senza contare i Cesari, si succedettero in quest’epoca ben undici imperatori, di norma comandanti militari
di provata esperienza, molto amati dalle truppe.
Nonostante ciò, gli anni che vanno da Filippo l’Arabo (244-249) all’assassino di Gallieno (268) sono quelli in
cui l’Impero vide cadere una a una le proprie frontiere: l’esercito romano subì pesanti sconfitte contro i
Goti, contro i Persiani di Shapur I. Solo con Claudio il Gotico iniziarono anni di riscossa militare, con le
vittorie sui Goti, su Palmira, sul fronte renano e in Oriente.
Molto difficili furono i rapporti con il senato, istituzione che l’ascesa al soglio imperiale dei generali stava
svuotando di ogni autorità (Gallieno arrivò ad eliminare l’esclusiva del senato sul comando militare).
Naturalmente, il potere centrale fu indebolito da una forza del genere nelle mani dell’esercito: non è certo
un caso se, proprio in questo secolo, si videro usurpatori eletti dalle proprie legioni regnare su importanti
province, avvalendosi di organi di senato locali.
È il ritratto di Massimino il Trace a inaugurare la più espressiva galleria di ritratti del secolo. Con una chioma
“a penna”, il suo volto con formule “realistiche”, dai tratti molto irregolari, presenta un’accentuata
ossatura, una marcata contrazione dei muscoli facciali, un profondo affossamento delle orbite oculari, la
barba che invade il collo. L’espressione sembra contratta e poco serena: è un uomo al potere in tempi di
grande instabilità; abissale è ormai la distanza dalle immagini degli imperatori precedenti.
Ritratto di Traiano Decio il volto, dai tratti duri, è dominato da una potente espressione di “ansiosa
incertezza” secondo Bianchi Bandinelli: la struttura anatomica sembra sgretolarsi sotto il movimento dei
muscoli facciali, delle rughe che tormentano l’epidermide, dell’infossamento asimmetrico delle orbite
oculari.
Nel secolo III divengono popolari le stilizzazioni dei defunti come “filosofi” e/o uomini di cultura. Le loro
immagini appaiono sempre più di frequente sulle casse dei sarcofagi, intenti alla lettura o all’insegnamento,
seduti su semplici sgabelli o su alte cattedre, accompagnati dalle spose, da filosofi di professione e talora
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
dalle Muse al completo.
Gli esemplari sono stati correlati per lo più con i membri della classe senatoria smaniosi di presentarsi come
viri docti e distanti ormai dall’esaltazione della carriera militare dell’aristocrazia antoniniana.
Un grandioso esemplare a lenòs (tinozza, forma tipica in origine dei sarcofagi bacchici) è scolpito in un
monolito di marmo greco insulare e decorato con nove figure maschili in toga, barbate e non e da sei figure
femminili superstiti ai fianchi di una coppia di sposi: si conserva in parte la figura virile in “toga contabulata”
in atto di incedere verso sinistra, mentre la donna era effigiata nello schema dell’orante. Le figure si
stagliano ad altissimo rilievo su tutta l’altezza della tinozza.
Un linguaggio formale “classicistico” caratterizza la lavorazione del sarcofago a klìne attribuito
all’imperatore Balbino. I due sposi sono raffigurati sia sul coperchio sia sulla fronte. Qui l’uomo, intento a
offrire un sacrificio su un altare portatile, incoronato da una Vittoria e affiancato da Marte, è raffigurato in
compagnia della moglie con la spallina della tunica che scivola dalla spalla sinistra.
Lo schema iconografico di base, tradizionale, è però innovato dalla raffigurazione della lorica squamata con
sopra il paludamentum, poco adatta alla gestualità sacra.
Uno dei più celebri sarcofagi, il “Grande Ludovisi”, in un blocco unico di marmo proconnesio per un’altezza
complessiva di 2.30 m, fu definito un “capolavoro barocco”. La fronte è decorata con un concitato
combattimento tra Romani e barbari, forse Goti, un recupero di un tema in voga in epoca antoniniana-
protoseveriana ma singolarmente passato di moda in un’epoca tanto caratterizzata dalla presenza militare
nell’Urbe. Senza partecipare direttamente alla battaglia, domina al centro emergendo dal fondo un
cavaliere senza elmo, segnato sulla fronte con un marchio enigmatico a X.
Gli instabili anni dell’anarchia militare furono segnati da importanti provvedimenti in ambito religioso e da
tentativi di repressione del cristianesimo con feroci persecuzioni. Simili repressioni prima di colpire il
cristianesimo, erano state molto rare, e il caso più noto riguarda il culto dei Baccanali a Roma e in Italia nel
186 d.C.
Alcuni editti ordinavano agli abitanti dell’Impero l’esecuzione di sacrifici agli dei, pena la reclusione o la
condanna a morte. Gli dei tradizionali cominciarono a impallidire, a vantaggio soprattutto delle religioni
enoteiste, quelle cioè in cui un solo dio aveva la preminenza su tutti gli altri, sentite come più capaci di
fornire una risposta alle ansie generalizzate dell’epoca.
La circolazione di figure di predicatori di eccezionale caratura, capaci di attrarre folle inaudite. Intorno alla
metà del secolo III, per la comunità romana sono elencati quarantasei presbiteri, sette diaconi, sette
suddiaconi, quarantadue accoliti, cinquantadue tra esorcisti, lettori e sacrestani e più di millecinquecento
vedove e poveri. Il cristianesimo fu insomma capace di proporre una visione radicalmente nuova: una
religione monoteista e salvifica, che, sebbene frantumata in una miriade di comunità locali talora in forte
antagonismo, riuscì a fare dell’adesione spontanea e settaria al suo credo uno strumento di coesione
potentissimo.
Nei decenni iniziali del secolo III i primi temi cristiani sotto forma di immagini concise, apparvero assieme a
temi “neutri” nelle pitture delle catacombe, il cui repertorio di storie dell’Antico e del Nuovo Testamento si
consolidò nel periodo della “piccola pace della chiesa” tra le persecuzioni di Valeriano (257) e Diocleziano
(303-305). Da quegli anni anche le officine dei sarcofagi e delle lastre di loculo iniziarono a ricorrere soggetti
evidentemente cristiani (battesimo, ciclo di Giona).
In particolare in epoca severiana, erano diventati sempre più praticati anche i culti etichettati come
“orientali”, talora radicati a Roma da parecchio tempo: divinità adorate in Egitto, Asia Minore, Siria, Persia,
Tracia, in genere capaci di promettere un percorso salvifico atto a garantire una vita oltre la morte e
l’instaurazione di un rapporto individuale del fedele con la divinità.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Nonostante il fermento religioso, nessuno dei primi imperatori-soldati sembra essere stato interessato alla
costruzione di nuovi edifici sacri in città o a restauri di sacra ormai fatiscenti, né per i culti tradizionali legati
alla storia più antica né tantomeno per le divinità “orientali”. Le spese furono riservate alla costruzione o al
restauro di terme e balnea o del Colosseo, più volte bruciato.
Forse a questa fase di relativa stasi edilizia è da ricondurre il brusco arresto del contrassegno dei bolli sui
laterizi alla fine della dinastia severiana, un uso che riprenderà con Diocleziano.
L’imperatore Gallieno governò dal 253 al 268. Il suo regno si aprì con importanti riforme: il 260 fu
l’anno di un editto considerato un vero e proprio spartiacque, che annunciò la fine immediata della
persecuzione contro i cristiani (voluta dal padre Valeriano), la restituzione dei loro beni e una certa libertà
di culto; nel 263 fu la volta della riforma che assegnò a prefetti di rango equestre la guida dell’esercito,
sottratto in tal modo all’esclusiva del senato.
“Rinascenza” termine che allude al rifiorire delle arti plastiche (ritrattistica e sarcofagi) secondo i canoni
di un “classicismo” un po’ appannato nel secolo III d.C. ma mai del tutto spentosi: la materia torna dunque
plastica, morbida, voluminosa, e i piani levigati, benché non senza effetti coloristici ottenuti attraverso
l’abile uso del trapano.
Sull’Urbe ebbero maggiore impatto i cantieri avviati sotto il regno di Aureliano (270-275). Una nuova cinta
muraria lunga quasi 19 km, alta 7.80 m e in opera laterizia, fu un capolavoro di ingegneria militare: nel
disegno complessivo di una stella a sette punte, il suo tracciato inglobò edifici preesistenti. Dopo la
costruzione delle mura, fu ampliato il pomerio.
8.3 Verso un nuovo ordine: Diocleziano e l’età tetrarchica
Nel 286 l’ascesa al trono del dalmata Diocle, comandante di cavalleria acclamato imperatore dalle sue
truppe (occasione nella quale mutò il proprio nome in Diocleziano) chiuse il cinquantennio dell’anarchia
militare e la stagione di secessioni e rivolte militari quasi ininterrotte. Diocleziano divise formalmente
l’Impero dapprima in due metà, grazie all’associazione di Massimiano quale Cesare e poi Augusto, poi in
quattro parti, con l’aggiunta dei più giovani Costanzo Cloro e Galerio quali Cesari.
L’Italia fu articolata in dodici province, non in continuità con le precedenti divisioni amministrative, e il suo
statuto fu equiparato a quello del resto dell’Impero. Al di sopra delle province erano dodici diocesi, grandi
unità regionali rette da vice-prefetti del pretorio. In definitiva, Roma perse la centralità, con lo spostamento
del baricentro politico-militare verso le frontiere.
I ritratti dei nuovi Augusti e Cesari esprimono il nuovo mondo della tetrarchia: i loro volti si somigliano a
coppie pure senza essere identici, perfetta espressione di una concordia di governo congiunto e, nel loro
mutuo abbraccio, di una fraternità capace di superare le differenze gerarchiche.
I gruppi in porfido alla Biblioteca Vaticana e a S. Marco raffigurano rispettivamente i membri della prima e
forse della seconda o terza tetrarchia. Il primo gruppo presenta ritratti con forte tendenza all’astrazione,
ravvisabile nella forma cubica con grandi occhi spalancati, con pieghe nasolabiali marcate e con corte barbe
nettamente delimitate sulle guance; le teste sul secondo hanno un contorno ovale e forme più
armonizzate.
I volti comunicano una forma di potere imperiale collettivo basato su aequalitas, fraternitas e concordia.
Tutti i regnanti della tetrarchia non avevano legami di sangue. L’abbraccio fu perciò una trovata inedita per
l’arte statale, poiché in precedenza la concordia era stata visualizzata tramite la dextram iunctio.
Nonostante la perdita di centralità di Roma, gli interventi urbanistici di Diocleziano in città furono notevoli.
Fu costruito un nuovo impianto termale, il più fastoso del mondo romano: le terme, costruite sul modello
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
delle thermae Antoniniane ma ora capaci di una ricettività doppia, si estendevano tra Viminale e Quirinale
per una superficie di oltre 13 ha, in un’area densamente abitata che richiese espropriazioni, demolizioni e
modifiche degli assi viari.
Altro notevole intervento fu la risistemazione dell’area centrale del foro Romano, in gran parte interessato
dall’incendio di Carino del 283: oltre che al restauro dei singoli edifici, si provvide alla risistemazione
dell’intera piazza, il cui spazio centrale, ridotto, fu delimitato sui quattro lati da nuove quinte
architettoniche per fungere da palcoscenico del nuovo ordine politico.
Per la decorazione dell’arcus Novus, eretto sulla via Lata, furono riadoperati frammenti di monumenti
claudi, con minimi adattamenti, miranti soprattutto alla trasformazione nei ritratti dei tetrarchi per mezzo
della rilavorazione di barba e capelli, e l’aggiunta di un’iscrizione celebrativa.
Il 24 febbraio del 303, a Nicomedia, Diocleziano emanò un editto che scatenò l’ultima grande persecuzione
contro i cristiani: considerati privi di honos e dignitas, essi poterono così essere sottoposti a tortura e a
qualsiasi tipo di azione legale, privati dei diritti civili e messi a morte, mentre si procedette alla distruzione
delle chiese e all’incendio delle Sacre Scritture.
Come che fosse, almeno in una prima fase l’intento dovette essere quello di morare a una politica religiosa
restauratrice e reazionaria, capace di rafforzare i culti tradizionali e di sradicare il cristianesimo
dall’apparato statale.
Come sede di ritiro dopo l’abdicazione, Diocleziano scelse Spalato in Dalmazia: fu qui eretto in pochi anni
un palazzo di enormi dimensioni, costruito a imitazione di un castrum, con muro di cinta, torrioni e vie
colonnate che partivano dalle quattro porte centrali.
La morte di Costanzo Cloro nel 306 aprì il problema della successione che Costantino e Massenzio vollero
reimpostare su base dinastica. Dopo quasi un ventennio di guerre civili, solo nel 324, con la definitiva
vittoria di Costantino su Licino e la sua proclamazione a unico imperatore, si avviò un’altra epoca.
Capitolo 9 – Secoli IV-VI d.C.: il Tardoantico
Con Tardoantico si può definire quella parte dell’Antichità che, in possesso di caratteri che la distinguono, in
quanto “tarda”, dall’epoca precedente, conserva caratteri sufficienti e qualificanti a definirla come “antica”.
Sembra presupporre due distinte fratture, l’una tra la “piena” e la “tarda” Antichità, l’altra fra la “tarda”
Antichità e il Medioevo.
L’inizio del Tardoantico è fatto coincidere con l’età di Commodo e dei Severi, e la sua durata prolungata ben
oltre il crollo dell’impero d’Occidente, fino all’età di Maometto e di Carlo Magno o persino al secolo X d.C.
Tuttavia, al di là delle differenze tra Occidente e Oriente, non vanno sottovalutate le divergenze regionali
all’interno del territorio dell’Impero, per cui il Tardoantico poté avere una durata diversa a seconda delle
aree geografiche.
Il Tardoantico fu un periodo di continuità e di trasformazioni delle strutture politiche, sociali,
amministrative, economiche e religiose (gradualmente furono proibiti i culti “pagani”, con una
recrudescenza nell’ultimo ventennio del secolo IV d.C.) nonché processi di interazione, adattamento (come
la desacralizzazione o la secolarizzazione di spettacoli pubblici e feste, templi e statue) e lotte politiche tra
cristiani e “pagani”. Quanto alle arti figurative, nessuno oggi osa più ridurle a manifestazioni di “declino”, in
un’età in cui, anzi, alcune produzioni – come la scultura “ideale” – rifiorirono dopo la stagnazione del secolo
III.
9.1 Paesaggi urbani e suburbani
Massenzio, acclamato Augusto a Roma ma dichiarato usurpatore, proseguì l’opera dei predecessori con un
disegno volto a rivitalizzare la città in una fase storica che vedeva invece il trasferimento del potere in altre
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
sedi imperiali; al suo breve regno sono riferibili la ricostruzione del tempio di Venere e Roma, l’edificazione
della basilica Nova, del “tempio di Romolo” sulla Sacra via, le terme verso il circo Massimo e le terme sul
Quirinale. Proprio a Massenzio si è collegato uno straordinario corredo di insegne imperiali dell’inizio del
secolo IV: la straordinaria scoperta consiste in tre scettri e otto punte di lancia, quattro lance da cerimonia
e altrettante attribuite a portastendardi, oggetti realizzati tutti in materiali preziosi.
Costantino, dopo averlo sconfitto a Ponte Milvio nel 312 d.C., appose il proprio nome a opere incompiute
del predecessore, non senza qualche modifica, come con la statua colossale all’interno della già citata
basilica Nova (poi basilica Costantini).
Caratteristiche dell’architettura costantiniana alleggerimento delle masse murarie, rinuncia alle
partizioni orizzontali e alla decorazione architettonica interna (colonne, lesene con capitelli, mensole,
architravi) a favore dell’ornamento mediante opus sectile e mosaici, di spazi inondati di luce grazie a
finestrati più grandi e con terminazioni semicircolari e di articolazioni complesse delle planimetrie.
Incessante fu l’attività edilizia nell’Urbe (e fuori, a Costantinopoli, Antiochia e Gerusalemme) per la nuova
religione cristiana, riconosciuta dall’editto di Milano nel 313 d.C. e divenuta poi a partire da Teodosio
(imperatore dal 379 al 395) unica religione ufficiale: “cristianizzazione” di Roma e “romanizzazione” della
cristianità diventarono da allora strettamente intrecciate. In connessione con il palazzo imperiale, la città
era disseminata di tituli, ossia chiese parrocchiali urbane che prendono il nome dei loro fondatori.
Fra le costruzioni dovute all’iniziativa imperiale spicca il tipo della basilica cristiana: quella di S. Giovanni in
Laterano, insieme al battistero, fu dedicata al Salvatore e costruita ex novo da Costantino sul luogo dei
castra Nova degli equites singulares demoliti per la loro fedeltà a Massenzio.
La politica monumentale di Costantino in favore della Chiesa di Roma si espresse poi nell’erezione di grandi
martyria suburbani. Il più grandioso è la basilica di S. Pietro in Vaticano, completata nel 333 sul luogo della
sepoltura dell’apostolo, a obliterare una necropoli occupata sin dal secolo II da tombe che poterono essere
interrate grazie al ruolo di Costantino quale pontifex Maximus.
Accanto alle basiliche a più navate si affermò anche uno specifico tipo noto come “circiforme” o “a
deambulatorio”, con una planimetria uniformata a quella del circo, in cui le navate avviluppano l’abside
creando un ambulatorio continuo; le basiliche funerarie lungo le vie consolari, costituivano ampi cimiteri
comunitari coperti, atti a ospitare migliaia di tombe.
Il suburbio fu interessato dalle nuove costruzioni in misura superiore rispetto alle zone intramurarie. La
scelta di eludere il centro politico e monumentale della città e di costruire basiliche (o chiese) in zone
decentrate e su terreni di proprietà imperiale è stata talora spiegata con la volontà, da parte della nuova
religione ufficiale, di non creare un aperto contrasto con l’ordine senatorio, ancora legato alla tradizione;
all’opposto, si può immaginare la riluttanza, da parte dei cristiani, a celebrare riti in luoghi troppo
caratterizzati dalla presenza di divinità “pagane”, e/o più semplicemente fu decisiva la prossimità alle
memorie dei martiri, modelli di virtù religiosa.
Spesso in relazione con le basiliche circiformi e talvolta con ville e circhi, sono i grandi mausolei a cupola,
veri e propri sepolcri/templi per una committenza ristrettissima, l’imperatore e i diretti discendenti. I più
antichi risalgono ancora all’età di Massenzio e sono costruiti su due piani, quello inferiore usato come
camera funeraria.
Con l’età di Costantino e dei figli questo tipo di tomba ebbe notevole sviluppo con l’avvento generalizzato
del mosaico nel sistema decorativo della cupola.
Sempre nel suburbio, dalla fine del secolo II e con un incremento dalla metà del secolo III erano ricomparsi i
sepolcri a destinazione collettiva e a intensiva e razionale utilizzazione con l’adozione di un tipo di ipogeo a
corridoio con loculi alle pareti, capace di generare nel tempo e in continuo ampliamento vere e proprie
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
ragnatele su più piani, le catacombe. Ne sono ben studiate le pitture, con decorazioni in “stile lineare”
rosso-verde: i temi degli affreschi abbracciavano il repertorio biblico, i soggetti bucolici, le scene di
banchetto, delle quali sono state esplorate le valenze in bilico tra realtà e simbolo, e riferimenti alle
professioni dei defunti – in particolare dei fossori.
Nei secoli IV-VI d.C. le domus s’inserirono di regola in aree sia private, sia pubbliche, facendo ricorso anche
all’impiego di materiale di spoglio, e sono correlabili sia alla nobilitas di antico lignaggio sia ai nuovi senatori
passati per iniziativa di Costantino da seicento a duemila.
In generale le case sono prive di peristili e dotate, quando lussuose, di cortiletti o portici con fontane e
ninfei, come pure, nelle residenze più grandi, di impianti termali; si moltiplicano le strutture absidate, gli
assi divergenti e le forme poligonali, sia semplici sia polilobate, e circolari, con nicchie ed esedre.
Se nel 403 si registrava un grandioso restauro delle mura Aureliane a opera di Arcadio e Onorio, dopo aver
tolto di mezzo “immensa rudera”, e se gli imperatori già nella seconda metà del secolo IV indirizzavano i
loro rappresentanti a interessarsi al ripristino degli edifici più che alla costruzione di nuovi a spese
pubbliche, il concorso di assedi, saccheggi, e terremoti, produsse effetti disastrosi, non solo dal punto di
vista materiale, ma anche di portata simbolica ed emotiva: l’Urbe aveva smesso di essere invincibile.
È nella seconda metà del secolo V che s’incrementarono i segnali archeologici dell’abbandono dei
monumenti imperiali. Apparvero persino le prime sepolture urbane, dislocate ovunque entro il circuito
murario, con l’invasione di settori pubblici e con conseguente convivenza dello spazio di vivi e morti, un
fenomeno generalizzatosi dagli anni della guerra greco-gotica (535-553).
Quando, all’inizio del secolo VI, Roma fu pacificamente occupata dagli Ostrogoti, il re Teodorico,
consapevole tanto della lontananza del presente dall’esperienza antica quanto della necessità della sua
continuazione, pur risiedendo fino alla morte del 526 a Ravenna, capitale del regno goto, volle preservare le
tradizionali strutture istituzionali e culturali della civilitas romana per la gloria del suo regno e per
l’imitazione dei predecessori.
Al suo tempo fu riattivata una produzione di nuovi mattoni bollati usati nei restauri urbani e recanti il nome
del sovrano seguito da un’espressione di benevolenza (Roma felix). Ma lo sforzo dei re ostrogoti fu di breve
durata, perché interrotto dalla guerra di riconquista dell’Italia condotta da Giustiniano (imperatore
bizantino dal 527 al 565).
9.2 L’età di Costantino (e dei successori): monumenti pubblici e privati
Un monumento chiave è costituito dall’arco di Costantino, dedicato a Roma dal senato e dal popolo
romano presso il Colosseo, in occasione dei decennali dell’imperatore e in memoria della vittoria
conseguita su Massenzio nel 312: un arco a tre fornici, di cui il centrale più ampio, e cono colonne libere
sulla fronte. L’iscrizione di dedica non nomina esplicitamente il nemico, Massenzio, chiamato il “tiranno”, e
quale garante della vittoria chiama in causa una generica suprema divinità o la forza divina immanente in
Costantino.
Secondo un costume già sperimentato, l’arco ricorse sistematicamente al riutilizzo di materiali di spoglio da
monumenti di imperatori precedenti di fama unanimemente riconosciuta: i “buoni” imperatori del secolo II,
Traiano, Adriano e Marco Aurelio. Lo spoglio di edifici più antichi a fini pratici, una prassi regolata
amministrativamente, dalla seconda metà del III secolo e sempre più nel Tardoantico fu sistematicamente
diffuso un po’ ovunque nell’architettura urbana, anche cristiana, non solo quale frutto di una volontà di
risparmio sui costi quanto poi forse anche per una mutata estetica.
La composizione privilegia l’immediatezza espressiva e comunicativa, rendendo anche più agevole una
lettura dal basso e sfruttando convenzioni formali spesso presenti nei fregi minori sui monumenti imperiali,
qui con uso ancora più insistito del trapano: abbandono della concezione naturalistica a profitto di una
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
simbolica e della prospettiva naturalistica a vantaggio di una ribaltata; volti espressivi e sovradimensionati;
tendenza alla rigida frontalità e assunzione di proporzioni gerarchiche delle figure a seconda
dell’importanza.
L’arco si trovava al centro di Roma, lungo la via percorsa dai cortei trionfali; l’iscrizione di dedica nominava
sì Costantino “insigne per trionfi”, ma non si trattò di un vero e proprio trionfo – fu una vittoria riportata in
una guerra civile; perciò, in modo non fortuito, l’apparato figurativo non era di tipo trionfale.
Sarcofagi cristiani
Alle officine dei rilievi dell’arco si deve con probabilità buona parte dell’ingente produzione di sarcofagi
urbani in età costantiniana, dovuta all’ampliarsi della comunità cristiana e allo sviluppo delle relative aree
cimiteriali.
Caratteristico dell’ultimo quarto di secolo è il gruppo di sarcofagi definito “a mura di città”, dove scene di
miracoli o il collegio apostolico con il Cristo in maestà al centro sono collocati sullo sfondo di mura cittadine
che si adattano a decorare l’intera fronte; vi rientra il sarcofago detto convenzionalmente di “Stilicone”.
L’impiego di sarcofagi in porfido nelle sepolture imperiali è testimoniato dalle fonti letterarie e da pochi
esemplari: i più noti sono il sarcofago di Elena dal mausoleo di Torpignattara con scena di battaglia e quello
di Costantina dall’omonimo monumento funerario con eroti vendemmianti; due frammenti rinvenuti a
Istanbul e Alessandria sembrano accreditare l’origine orientale dei manufatti.
Ritratti e colossi imperiali
L’effigie di Costantino segnò una rottura: se dopo Adriano era invalsa l’abitudine di portare la barba più o
meno lunga sui volti maturi, il volto dell’imperatore con lui tornò a presentarsi imberbe e con viso pacato,
senza troppi segni d’età.
Questo tipo di ritratto di Costantino è adottato da un acrolito colossale dall’abside occidentale della grande
basilica di Massenzio. La statua doveva riprodurre a torso nudo l’imperatore nello schema iovio:
l’acconciatura presenta lunghe ciocche che scendono verso la fronte e s’incurvano verso il centro con un
motivo a mandorla; sulle tempie, sulla fronte e sulla chioma sono inconfondibili i segni di lavorazione di un
precedente ritratto, per il quale sono stati avanzati riconoscimenti non univoci.
Il ritratto, dai grandi lineamenti (compreso il naso molto ricurvo), trasmette il distacco ieratico, la forza
spirituale e l’imperturbabile calma del carismatico sovrano, in breve l’immagine di un deus praesens.
Un ritratto identificato con Arcadio, con un ricco diadema gemmato, esprime al massimo l’assorto distacco
dell’imagerie imperale dell’epoca. L’immagine trascendente degli imperatori non fu però monolitica.
Nei primi due secoli dell’Impero i ritratti dei privati non di rado somigliavano nella chioma e nei lineamenti
alle immagini degli imperatori; da Costantino fino all’età di Giustiniano, quelli privati, ora riservati
soprattutto agli alti burocrati, conservano invece forme organiche, la moda della barba e talora una
personalizzazione più accentuata, anche per mezzo di segni d’età, specie ad Afrodisia.
9.3 Il fascino della ricchezza: lo splendore di domus e ville
Nel Tardoantico il dispiego di ricchezza riguardò le dimore dell’élite non solo nell’Urbe, bensì nelle capitali
di diocesi e province e in città comunque sede di amministratori imperiali o in Africa Proconsolare. Le ville si
distinguono per un’ampia varietà tipologica per funzioni e livelli di benessere diversi, malgrado alcune
caratteristiche costanti: un cortile o un peristilio centrale, planimetrie mistilinee, soprattutto nelle sale per
stibadia, l’uso di absidi e cupole e la rilevanza accordata agli ambienti di ricevimento, con un’accentuazione
della spettacolarità cerimoniale dei rapporti tra aristocratici e amici/clienti.
La villa più nota, il Casale di Piazza Armerina (Enna), in Sicilia, si caratterizza per tre disposizioni assiali
diverse, a sottolineare le diverse funzioni dei tre settori: terme a ovest; complesso residenziale a est, con
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
peristilio, “basilica” e ambienti abitativi; gruppo di vani per banchetti a sud-est, costituito dal peristilio
ellittico con la sala triabsidata per stibadia.
In residenze come questa, come in precedenza, ci si dedicava al dulce otium litteratum e philosophicum
senza rinunciare alle funzioni di patroni di fronte ai clienti e agli oneri del negotium.
La villa di Piazza Armerina e altre residenze di lusso in Occidente e in Oriente presentano, con
un’abbondanza ignota ai secoli precedenti, grandi mosaici geometrici e/o figurati. Questi ultimi svelano la
formazione culturale dei proprietari, visto che, così come nella letteratura piena di storie sugli dei ed eroi,
resistono i racconti del mito quali simboli di tradizionale paideìa in grado di dare un tocco di maestosità
epica alle vite dei ricchi, al di là delle immagini bacchiche e marine e anche delle possibili riletture
allegoriche in chiave cristiana di alcune figure, come Orfeo ed Ercole; viceversa, negli spazi domestici
mancano per lo più scene narrative cristiane, e l’unica “cappella” domestica riconosciuta con una certa
sicurezza è in una villa di Lullingston in Britannia.
I mosaici insistono pure sulla messa in scena della vita quotidiana e delle attività del dominus in villa, quali
le cacce come espressione di virtus nonché sulla cattura degli animali per gli spettacoli dell’anfiteatro e sui
giochi circensi offerti con munificenza dagli aristocratici specie in occasione della pretura in quanto prima
tappa nella carriera politica.
Molto diffusi specie in Italia e rispondenti a esigenze di livello e costo differenziati erano i rivestimenti
marmorei in opus sectile, soprattutto pavimentali; ma si affermarono anche quelli più esclusivi sulle pareti,
già in uso in precedenza ma in maniera più limitata e in particolare nelle residenze imperiali.
Alla fine del secolo IV d.C. risale un edificio di Ostia fuori porta Marina, nel quale si riconosce una ricca villa
costiera, rimasta incompiuta. Una grande aula dell’ala settentrionale conserva integralmente
un’eccezionale decorazione: sul soffitto un mosaico in pasta vitrea; sulle pareti marmi policromi con
specchiature geometriche, fregi floreali, gruppi di leoni in atto di azzannare un cerbiatto; l’esedra di fondo
riproduce un prospetto in opera mista di mattoni e reticolato; la pavimentazione era costituita da marmi
preziosi.
9.4 Artigianato di lusso
Nel Tardoantico la lavorazione dei materiali preziosi (oro, argento, avorio, vesti di lusso) acquisì importanza
sempre maggiore per la committenza imperiale, gli alti ufficiali della burocrazia di corte, l’ordine senatorio e
i ricchi più in generale.
Il cofanetto nuziale di Proiecta associa l’augurio di una lunga vita in Cristo alla toletta di Venere e alle
immagini di Nereidi; sulla faccia anteriore Proiecta stessa, seduta e adorna di una collana, tiene nella
sinistra una pisside, mentre una servitrice tende lo specchio verso di lei, e il personale porta gli oggetti
necessari al bagno e alla cura del corpo.
Tra i più significativi rinvenimenti si segnala il “Tesoro di Seuso” che augura appunto a un certo Seuso, forse
un soldato di cavalleria appartenente al popolo degli Alani, il possesso duraturo per sé e per i discendenti
dei “vascula”; il tondo centrale decorato a niello presenta una scena di banchetto all’aperto a conclusione
di una battuta di caccia con una coppia sovrastata dal cristogramma.
Anche il “tesoro” di Kaiseraugst, un suntuoso servizio da mensa associato a monete e a lingotti con il nome
dell’usurpatore Magnezio, doveva essere un dono per un ufficiale di alto rango.
Fra le produzioni di lusso particolarmente apprezzati erano i piatti di largizione, ossia quel vasellame
prezioso in argento e oro con iscrizioni o raffigurazioni in rilievo di personaggi imperiali o ufficiali che
l’imperatore distribuiva a quanti voleva gratificare o quale dono di carattere diplomatico per principi
stranieri.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Ai privati cittadini era vietata la distribuzione dei dittici in avorio, riservati da due decreti emessi nel 384 a
Eraclea sul Mar Nero ai consoli ordinari.
Con “dittico” s’intende una coppia di tavolette (valve) alte una trentina di centimetri, incernierate a libro su
cui si stendeva la cera per la scrittura, ma dal secolo IV al VI i dittici cristiani e “pagani”, in origine almeno in
parte dipinte diventarono un prodotto di lusso.
Al pari degli argenti tardoantichi, i dittici, comunque non sempre agevolmente databili e attribuibili a un
preciso centro di produzione su base stilistica, potevano adottare un linguaggio figurativo “classico”.
Dittico dei Nicomachi e dei Simmachi
Realizzato probabilmente in occasione di un matrimonio che unì le due famiglie ipotesi non accolta
all’unisono perché un uso simile non è provato dalle fonti, per cui altri studiosi hanno pensato a una
circostanza funeraria.
Il dittico sottolinea la tradizionale identità religiosa dei committenti: nella valva dei Simmachi una
sacerdotessa con corona di vite compie un’offerta su un altare forse di Giove, mentre in quella dei
Nicomachi un’altra con due torce abbassate con capelli sciolti e seno nudo, è presso in altare con il fuoco
acceso di Magna Mater; le figure di profilo sono qui molto “classicistiche” in quanto è ancora viva
l’ispirazione a modelli iconografici e stilistici di secolare fortuna.
Un altro dittico dei Simmachi, raffigura in sequenza l’apoteosi probabilmente di un imperatore barbato due
volte con toga di forma “tradizionale”
Un cenno meritano infine i tessuti decorati e le tappezzerie che i rinvenimenti nelle necropoli egiziane,
numerosi grazie alle condizioni di conservazione, hanno fatto etichettare come copti.
Le stoffe, principalmente lana mista a seta, erano tessute sulla base di modelli comuni ai mosaici e alla
pittura; l’uso di tinture sia vegetali che animali permetteva di ottenere un’ampia gamma di colori. I temi
frequenti sono le scene di caccia e mitologiche.
Una delle stoffe più celebri proviene dalla necropoli di Antinoe, dove è stata trovata disposta come uno
scialle attorno al corpo della defunta Sabina; in tela rossa, adorna di galloni e orbicoli (medaglioni), è
decorata con figure e scene mitologiche.
9.5 Alcune “capitali” tardoantiche
Dopo la vittoria su Licinio ad Adrianopoli nel 324, Costantino, divenuto imperatore unico, inaugurò nel 330
sul promontorio collinoso dell’antica Bisanzio, già rinnovata da Settimio Severo, la nuova città dinastica,
Costantinopoli: dopo la sua fondazione nessun imperatore tornò a Roma per farne la propria residenza
permanente. Costruita secondo lo schema e il modello dell’Urbe, la Nuova Roma, articolata in quattordici
Regioni, rivaleggiava con l’antica, come visibile anche su alcune emissioni in bronzo e in argento di
Costantinopoli e non solo.
Alcuni elementi accomunano le residenze degli imperatori tardoantichi: l’ubicazione in una zona marginale,
spesso presso le mura; la facciata come fondale di una grande via monumentale, asse urbano; lo stretto
legame con il circo, dalla forte valenza simbolica; i grandi sepolcri/templi dinastici situati nei pressi della
città.
Molte le fondazioni cristiane già con Costantino a detta di Eusebio, per cui l’imperatore volle “celebrare con
onori superbi la città che prendeva il nome da lui e la rese splendida con molte cappelle, con grandissimi
martyria e con altre costruzioni stupende, alcune nelle zone periferiche, altre all’interno della città: con
esse intendeva onorare la memoria dei martiri e al contempo consacrare al dio di quei martiri la propria
città.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
In precedenza, erano state già fondate diverse “capitali” tetrarchiche, anche effimere (residenze, non
capitali nel senso moderno), sedi di palatia.
- Dopo che nel 286 fu stabilita a Milano (Mediolanum) la residenza imperiale di Massimiano Erculio,
la città fu oggetto di trasformazioni e di un rinnovamento urbanistico, tanto da divenire luogo di
residenza effettiva per molti imperatori. Personaggio di particolare spicco fu Ambrogio, eletto
vescovo della città nel 374, assertore di un modello politico di moderazione e insieme di fermezza
cristiana;
- Treviri fu scelta nel 287 come “capitale” della parte occidentale dell’Impero in occasione della
riforma tetrarchica di Diocleziano. Tra gli edifici più noti, l’“aula palatina” fu costruita da Costantino
nel 310 con funzioni di basilica giudiziaria e di aula per udienze: una vasta sala rettangolare con
abside un tempo ornata di statue e munita di pareti decorate con marmi e alleggerite da due ordini
di finestre arcuate.
- Galerio aveva stabilito la propria residenza a Tessalonica (Salonicco), una delle principali città
dell’illirico e rilevante nodo stradale fra Oriente e Occidente.
Capitolo 10 – Rappresentazioni storiche
10.1 Il rapporto con i modelli greci
A partire dalla fine del secolo XIX gli studiosi moderni, interessati a una definizione più autentica (e positiva)
dell’arte romana, hanno individuato proprio nella narrazione “storica” una delle sue qualità più originali
anche rispetto all’arte greca. Rappresentazioni storiche, accomunate dalla raffigurazione di guerra, vittorie,
istituzioni, cerimonie e riti romani. Anche quando il modello era greco, il contenuto del racconto o del
messaggio era romano.
A partire dal secolo V a.C. immagini storiche furono commissionate dalle pòleis per essere collocate in
templi e monumenti pubblici importanti, come ad Atene sotto forma di due megalografie nella Stoà Poikìle
nell’agorà.
In seguito, le conquiste di Alessandro Magno fecero nascere la ricca tradizione iconografica a cui
appartengono, per esempio, il “sarcofago di Alessandro” da Sidone.
I sovrani ellenistici non furono ritratti solo in battaglia, ma anche in processione, a banchetto, a caccia,
insieme a trofei e a figure allegoriche. L’arte greca aveva dunque già elaborato un proprio repertorio
iconografico, a cui mancarono però la coerenza e l’universalità imposte in età imperiale dalla presenza di un
solo sovrano e di un unico “centro” di elaborazione. Non si trattò soltanto della rappresentazione di eventi
storici in sé, ma anche della creazione di modelli ideologici, compositivi e iconografici, poi adottati anche
nei monumenti romani, naturalmente adeguandoli alle mutate condizioni politiche.
Il pilastro di cui L. Emilio Paolo si appropriò a Delfi per diritto di conquista può essere definito un
monumento di raccordo tra arte greca e romana il pilastro divenne simbolo dell’egemonia romana in
Grecia. Era infatti accompagnato da una iscrizione latina che ne prendeva possesso in nome di Emilio Paolo,
sosteneva la statua equestre dorata del generale ed era completato sulla sommità da un fregio corrente su
tutti i lati e raffigurante una battaglia tra Romani e Macedoni, evidentemente quella di Pidna. Il fregio
mostrava l’esito della battaglia, ma non ne raccontava lo svolgimento reale, al quale alludeva forse solo
l’immagine di un cavallo “scosso” la cui fuga dalle file romane aveva dato inizio al combattimento.
Al tempo di Pidna la tradizione ellenistica delle scene di battaglia era comunque già nota anche in Italia
grazie al tramite delle città italiote e siceliote. In particolare nei secoli III-II a.C. la galatomachia era entrata
anche nel repertorio delle urne e dei sarcofagi etruschi per alludere ai nemici gallici.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
I modelli d’ispirazione, scultorei o pittorici, dalla Grecia o dall’Asia Minore, furono così adattati per ribadire
l’empietà delle popolazioni celtiche, un concetto nato a sua volta in Grecia per condannare i Galati alla
sconfitta, ma facilmente applicabile anche ai Galli nel nuovo contesto della “romanizzazione” della penisola.
Nello stesso periodo i fregi fittili continui iniziarono a ospitare rappresentazioni storiche mutuate dal
repertorio pubblico anche in contesti domestici, come si vede negli atri e nei tablini di alcune ricche domus
della colonia latina di Fregellae, sulle cui pareti erano inserite le lastre di terracotta raffiguranti Vittorie,
trofei e battaglie terrestri e navali.
10.2 Trionfo e cerimonie di Stato in età repubblicana
All’influenza dei modelli greci si aggiunse l’esigenza della nobilitas di documentare le imprese belliche sulle
quali si basava il conseguimento dell’onore del trionfo e di vedere garantita nel tempo la memoria delle
proprie res gestae in ogni possibile contesto. Alla base della tradizione della commemorazione storica
nell’arte romana si trova la pittura trionfale, categoria comprendente i quadri su tavola raffiguranti le
vicende belliche ed esibiti in pubblico durante e dopo i trionfi. Essi svolgevano la funzione insieme
didascalica e documentaria di fornire l’evidenza concreta della vittoria ai cittadini romani. Le immagini,
realizzate spesso a breve distanza dagli eventi, dovevano riprodurre la sequenza e, ove possibile, i siti delle
res gestae e avevano uno scopo prima di tutto informativo, a integrazione dei resoconti scritti dei
comandanti militari.
L’unico documento superstite esempio di pittura trionfale, è un frammento di affresco proveniente dalla
decorazione forse esterna di una tomba. In esso, la costruzione di una narrazione continua derivava da
esperienza ellenistiche, ma lo scopo didascalico/documentario di presentare passo dopo passo e con
strategie compositive chiare l’evidenza della vittoria era n’esigenza romana.
Si affermò rapidamente anche una differente tradizione che mostrava piuttosto il rango o i doveri assolti
dai protagonisti. I monumenti funerari che dovevano presentare l’intera carriera e i meriti pubblici del
defunto, illustravano, oltre alle consuete scene belliche, anche processioni funebri e pubbliche, cortei
trionfali, sacrifici, immagini dei banchetti o dei ludi di solito gladiatori offerti al popolo.
La rappresentazione fedele di una cerimonia poteva quindi costituire il fulcro del programma decorativo di
un edificio, verosimilmente allo scopo di glorificare ancora di più il suo costruttore.
Allo stesso filone appartiene l’“ara di Cn. Domizio Enobarbo. Il monumento, di forma rettangolare, è
decorato su ogni lato da un rilievo inquadrato da pilastrini: tre lastre in marmo microasiatico illustrano un
tema mitologico, il corteo nuziale di Poseidone e Anfitrite, mentre la quarta in marmo pario rappresenta un
tema romano, lo svolgimento di un censimento e del sacrificio a Marte.
I rilievi di soggetto marittimo sono più antichi e giunsero probabilmente a Roma dalla Grecia come bottino
bellico.
L’iconografia, molto scrupolosa nel riprodurre diversi aspetti delle procedure e dei costumi militari romani
del tempo, condivide lo stesso linguaggio di molti rilievi votivi greci ellenistici, caratterizzati
dall’applicazione di una moderata gerarchia delle proporzioni.
La scena riproduce con cura i momenti salienti di una cerimonia di Stato che si ripeteva ogni cinque anni nel
Campo Marzio di Roma. Di per sé il rilievo intendeva rendere subito riconoscibile il rito romano, ma può
essere considerato anche una rappresentazione storica? Per rispondere si deve guardare allo scopo
dell’immagine che non era di mostrare il funzionamento ideale di una cerimonia pubblica, ma di celebrare il
censore stesso, ossia il (probabile) committente del monumento, per mezzo del quale egli intendeva
comunicare che l’edificio in cui la base si trovava era stato da lui realizzato mentre era in carica.
Nel quasi generale naufragio della celebrazione storica repubblicana, risulta preziosa anche la
testimonianza dell’attività dei triumviri monetali che nel corso del secolo I a.C. scelsero spesso di
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
rappresentare le vicende delle proprie famiglie sulle monete coniate in loro nome.
Riconosciamo così molte grandi figure della storia romana, come Numa Pompilio, A. Postumio Albino, M.
Claudio Marcello, M. Emilio Lepido, L. Emilio Paolo e L. Cornelio Silla. Queste immagini documentano
l’esistenza di un ricco patrimonio di scene storiche gentilizie, che perse di attualità in età imperiale,
lasciando però come eredità schemi figurativi e consuetudine a simili narrazioni. Lo stretto collegamento
tra queste memorie familiari e i monumenti pubblici è inoltre documentato dal “fregio” scultoreo della
basilica Emilia.
10.3 La Roma di Augusto: un nuovo inizio
La nascita del principato e il passaggio del potere nelle mani del solo Augusto ebbero un impatto
significativo anche sulla rappresentazione storica, poiché, a poco a poco, il focus della celebrazione si
concentrò proprio sul princeps e sui membri della sua famiglia, riducendo in ambito pubblico la pluralità di
voci esistenti fino all’età delle guerre civili.
Nell’ara Pacis, il fregio raffigurante una processione, decorava entrambi i lati lunghi del recinto esterno
probabilmente l’immagine ideale del ritorno a Roma di Augusto dal viaggio nelle province occidentali il 4
luglio del 13 a.C. Il fregio illustrava chiaramente la posizione dominante della famiglia imperiale. Se infatti
Augusto era raffigurato nella parte più ufficiale del corteo, insieme ai membri dei collegi sacerdotali più
importanti dello Stato, al corteo partecipavano anche tutti i suoi parenti, donne e bambini compresi.
Il loro ingresso nell’iconografia di un rito era una novità rilevante per le immagini storiche ufficiali, ma
l’ambizione di Augusto di fondare una dinastia rendeva i suoi familiari indispensabili anche alla
legittimazione stessa del suo potere, la cui continuità dinastica sarebbe stata garantita proprio da loro.
La solennità del corteo era inoltre enfatizzata anche dalla scelta di un linguaggio formale “alto”, ispirato
all’arte “classica”, che si distingue da quello più didascalico del “piccolo fregio” che correva intorno
all’altare posto all’interno del recinto con gli inservienti e le vittime del sacrificio.
La centralità della figura del princeps e della sua famiglia non fu la sola novità del periodo imperiale.
L’iconografia del trionfo compare spesso nei monumenti augustei pubblici e non, ribadendo l’ineludibile e
necessaria connessione tra la famiglia giulia e la vittoria. In una lastra del fregio si riconosce la quadriga
guidata da Augusto, che portava con sé due bambini identificati con i figli di Cleopatra e Marco Antonio,
Alessandro Helios e Cleopatra Selene: la scena era quindi un’eco immediata di quanto accaduto a Roma,
segno della rapidità con cui l’evento fu celebrato e comunicato.
I monumenti di Stato augustei sopravvissuti sono pochi, ma in alcuni casi i loro contenuti si possono
ricostruire a partire dalle scene storiche rappresentate in altri media di differente circolazione, all’interno
della corte e in ambito privato.
Due tazze d’argento trovare a Boscoreale In una tazza l’importanza del tema trionfale è confermata dalla
rappresentazione del trionfo di Tiberio del 7 a.C. Nella seconda tazza il protagonista di Augusto, raffigurato
due volte: sul campo, mentre accorda la sua protezione ai figli dei barbari, e in un contesto allegorico,
mentre Venere gli offre una statuetta di Vittoria in presenza delle personificazioni delle province,
accompagnate da Marte.
Anche il cammeo noto come “Gemma Augustea” raffigura a sua volta due scene storiche, collegate con
probabilità alla repressione della grande rivolta illirica scoppiata nel 6 d.C.: nel registro superiore Tiberio
scende dalla quadriga per presentarsi in compagnia del suo erede designato Germanico alla dea Roma e ad
Augusto seduto in trono come Giove con lituo (bastone ricurvo degli auguri).
Narrazione versus astrazione
In ogni rappresentazione storica romana è possibile riconoscere la coesistenza di due componenti
variamente amalgamate: una più strettamente narrativa che alludeva a eventi specifici, talora collocandoli
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
in un contesto ben riconoscibile, e l’altra allegorico/simbolica, mirante a descrivere una condizione, una
qualità o una funzione esemplarmente attribuite all’imperatore e perciò eternamente valide e facilmente
svincolabili dal riferimento all’occasione specifica.
La prima componente prevale ovviamente nel filone più narrativo delle rappresentazioni storiche belliche,
mentre la seconda è più forte in quello più strettamente encomiastico-celebrativo riservato alle scene
cerimoniali, ma esse sono di solito intrecciate tra loro.
10.4 Dai Giulio-Claudi ai Flavi: affinamento di un repertorio
Il periodo giulio-claudio perfezionò il sistema delle rappresentazioni storiche identificando sempre più
chiaramente lo Stato con l’immagine dell’imperatore.
In assenza di testimonianze monumentali, sono le monete a provare l’introduzione di nuove iconografie
con cerimonie militari, come il discorso alle truppe (adlocutio), o amministrative, come la distribuzione di
donativi al popolo (congiarium). Nel frattempo il monumento ad arco era stato individuato come l’edificio
più adatto a ospitare rappresentazioni storiche.
Anche il linguaggio compositivo si arricchì grazie ai riferimenti ai luoghi delle cerimonie rappresentate. Al
fregio di un altare realizzato in età claudia a imitazione dell’ara Pacis (l’“ara Pietatis”) e forse per ricordare
un simile ritorno vittorioso dell’imperatore nell’Urbe sono tradizionalmente attribuiti alcuni rilievi
attualmente divisi tra Villa Medici e i Musei Capitolini. La rappresentazione di una processione ha un ruolo
di primo piano, con il fine probabile di legittimare il ruolo di Claudio. Almeno due scene di sacrificio
scandiscono il corteo e si svolgono davanti ai templi dove si era compiuto il rito, fornendo così precisi
riferimenti topografici.
La narrazione della processione risulta così particolarmente fedele alla realtà topografica, un’innovazione
rispetto all’ara Pacis in cui la scelta dello sfondo neutro, coerente con il linguaggio “classicistico”, aveva
invece evitato di ancorare il corteo a luoghi e tempi troppo specifici.
La recente ricomposizione del ciclo di rilievi Medinaceli-Budapest ha consentito inoltre il recupero di un
importante monumento di età claudia raffigurante una sorta di bilancio del regno di Augusti suddiviso in
quattro momenti: vittoria di Azio, il trionfo del 29 a.C., una scena di sacrificio e la divinizzazione,
simboleggiata dal carro sacro del divo Augusto.
L’età flavia proseguì nel segno della continuità con l’età giulio-claudia, continuando a celebrare i trionfi, i
culti di Stato e le qualità militari e civili degli imperatori.
L’arco di Tito, costruito da Domiziano per ricordare il fratello divinizzato, aveva un ricco programma
decorativo. Sull’architrave corre un “piccolo fregio” con una sorta di riassunto del trionfo giudaico del 71
d.C.
Le caratteristiche che spiccano maggiormente sono la paratassi e la frontalità, scelte poco adatte
all’iconografia di una processione, ma funzionali allo scopo divulgativo del fregio.
All’interno del fornice sono invece collocati due grandi pannelli che sviluppano il tema del trionfo
estrapolando i due momenti clou del corteo: Tito su quadriga e passaggio del bottino giudaico. Infine, nella
volta del fornice, è rappresentata l’apoteosi dell’imperatore, resa tramite un’inedita prospettiva dal basso
che mostra in modo assai poco naturalistico ma efficace la testa di Tito mentre si affaccia dal dorso
dell’aquila che lo sta portando in cielo.
I monumenti domizianei sono molto diversi tra loro, sebbene, quando visti nel dettaglio, denuncino lo
stesso “stile d’epoca”: al misurato “classicismo” impiegato per comunicare la solennità e dignità degli
ingressi o partenze imperiali dei rilievi da Palazzo della Cancelleria si oppone nell’arco di Tito un linguaggio
altrettanto alto ma molto più ricco di pathos, “barocco”, evidente specie nella scena del passaggio dalla
porta trionfale che intendeva restituire l’eccitazione della vittoria e la foga con cui si muoveva il corteo,
coinvolgendo anche lo spettatore.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
10.5 L’età di Traiano
I monumenti di età traianea testimoniano più di altri la centralità delle immagini nella comunicazione di
vittorie e provvedimenti imperiali e nella celebrazione dell’imperatore.
- Colonna Traiana l’invenzione della colonna coclide istoriata diede l’opportunità di costruire un
racconto continuo delle guerre, offrendo una versione artisticamente colta della tradizione della
pittura trionfale, trasformata in monumento perenne dalla realizzazione in marmo. Le due guerre
daciche sono presentate rispettando la sequenza annuale degli eventi e indicando molti dettagli
topografici, descrivendo fedelmente costumi, armi e tattiche militari di entrambe le parti.
Per quanto dettagliata, la narrazione si sviluppa introducendo anche molte scene convenzionali che
dovevano aiutare lo spettatore a orientarsi meglio nel racconto.
Un altro aspetto da sottolineare è costituito dalla profondità di campo delle scene, ottenuta con la
prospettiva a volo d’uccello, la rappresentazione simbolica dello spazio per la quale ciò che in un
rilievo si trova più lontano dallo spettatore, e dovrebbe quindi essere posto in secondo piano, è
invece spostato verso il margine superiore, dando l’impressione di essere visto dall’alto.
- Il “grande fregio” di Traiano è un rilievo monumentale reimpiegato in gran parte nell’arco di
Costantino.
Rispetto alla colonna, in cui Traiano era presentato come il “bravo generale” che organizza
l’esercito, lo motiva, lo premia e non mette mai a rischio la sua vita in prima linea, il “grande fregio”
riafferma nello scontro equestre la virtus personale dell’imperatore, paragonandolo ad Alessandro
Magno.
- Il trofeo (Tropaeum Traiani) terzo importante monumento traianeo. La guerra è rappresentata
in una serie di cinquantaquattro metope del fregio dorico sulla sommità del tamburo dell’edificio.
Le metope celebravano la vittoria dacica nel complesso, in modo molto semplificato e influenzato
dalla tradizione locale nella resa delle figure.
Arco di Benevento L’arco beneventano costituisce il culmine del processo di accrescimento della
decorazione figurata dei monumenti pubblici nonché il documento dell’estrema sofisticazione del
linguaggio del panegirico imperale, che intendeva fare scaturire dall’insieme dei vari rilievi, ciascuno con
una scena in sé conclusa e riferita alla biografia del principe, l’illustrazione complessiva della sua politica
provvidenziale dall’inizio del suo regno.
10.6 Continuità e differenze da Adriano a Marco Aurelio
I rilievi urbani si concentrarono su nuovi soggetti: i tondi adrianei raccontavano per esempio un tema
inedito per l’arte ufficiale come quello venatorio, di per sé pertinente al mondo dell’otium, ma adottato da
Adriano quale testimonianza del suo coraggio personale (virtus), del suo amore per la caccia e forse anche
per emulare Alessandro Magno. La cronaca di una caccia multipla si dispiegava in rilievi alternanti le scene
venatorie a quelle di sacrificio, collegate tra loro dalla rappresentazione della stessa presa, prima cacciata e
poi offerta alla divinità. Altro tema che ebbe più spazio fu l’apoteosi degli imperatori defunti.
Il “monumento partico” di Efeso prova che le singole città dell’Impero continuavano a dimostrare la propria
lealtà alla famiglia imperiale, celerandone le imprese mediante rappresentazioni storiche.
Durante il secolo II d.C. anche lo sviluppo di una forma di racconto suddivisa in una serie di rilievi, ciascuno
dedicato a un momento esemplare della narrazione, mostra il prevalere della componente allegorica su
quella più narrativa anche nei resoconti strettamente bellici. Almeno dodici rilievi decoravano in origine un
arco eretto per Marco Aurelio nei pressi della curia Iulia. Otto di questi sono stati reimpiegati nell’arco di
Costantino.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
I rilievi, soffermandosi sulle cerimonie e sulle virtù personali di Marco, inscenavano una sorta di campagna
militare ideale, con tappe ormai prestabilite e in assenza di ogni riferimento a episodi bellici specifici, salvo
forse la designazione del re vassallo, come se la ripetizione di determinate azioni fosse diventata più
importante del singolo e risolutivo a livello militare.
Il peso maggiore della componente allegorico-simbolica si coglie anche nella colonna Aureliana. Nella
nuova colonna coclide le guerre danubiane combattute da Marco Aurelio sono narrate in forma continua,
ma alcune scene esemplari e cerimoniali sembrano talvolta inserite soprattutto per illustrare un ruolo e
virtù dell’imperatore, con minore attenzione allo sviluppo lineare del racconto, privo di quei nessi interni
caratteristici della colonna Traiana, come se si volesse creare un effetto di ridondanza proprio insistendo
sulla ripetizione di determinate azioni.
10.7 Dai Severi al Tardoantico: nuovi linguaggi
La nuova dinastia, bisognosa di legittimazione, diede grande rilievo alla celebrazione delle proprie vittorie, a
Roma, Napoli e nella natia Africa.
Il più importante monumento urbano fu l’arco di Settimio Severo eretto nel foro romano per celebrare la
guerra partica: quattro grandi pannelli furono posti, due per facciata, sui fornici laterali per rappresentare
ciascuno la presa di una città partica nemica. Su questi il racconto procede dal basso verso l’alto e perlopiù
da sinistra a destra e sembra quasi volere trasportare sulla superficie dell’arco il tipo di narrazione continua
spiraliforme adottato nelle colonne coclidi, come se il prestigio di quelle avesse indotto a emularne
l’aspetto. Le scene mettevano inoltre in evidenza l’organizzazione dell’esercito romano rispetto al caos del
nemico.
Nei pannelli dell’arco di Settimio Severo la funzione divulgativa attribuita a queste scene storiche non le
trasformava in reportage della guerra o in fonti documentarie nel senso moderno del termine. La selezione
degli episodi di contorno associati alle grandi scene d’assedio conferma inoltre l’idea che il racconto di una
campagna militare vittoriosa dovesse ormai necessariamente prevedere la ripetizione di alcune situazioni
fisse. La presentazione perlopiù frontale dell’imperatore contrapposta alla massa dei suoi soldati era un
ulteriore effetto dell’accentuazione della componente simbolica già rilevata per l’età aureliana e si
rifletteva sempre di più sulle strategie compositive. Nel periodo dopo i Severi, le testimonianze concrete di
nuove rappresentazioni storiche diminuiscono.
Nel secolo IV d.C. Roma aveva cessato di essere l’unico centro dell’Impero. La suddivisione del potere tra i
componenti della tetrarchia ebbe come esito anche la scelta di nuove “capitali”, oggetto di programmi
edilizi ambiziosi per adeguarle al ruolo di residenze imperiali.
A Tessalonica (Salonicco), intorno al 303 d.C., Galerio fece costruire una sorta di doppio tetrapilo che
serviva da padiglione d’ingresso e di smistamento tra il palazzo e la Rotonda in corso di costruzione. I rilievi
presentano la guerra condotta in Assiria e in Armenia e conclusa nel 298 d.C., alternando episodi specifici,
come la cattura dell’harem persiano, scene ormai tradizionali in questi racconti bellici (battaglie, clemenza
e sottomissione) e altre invece celebrative della tetrarchia nel suo complesso – in particolare il legame tra
Galerio e il suo Augusto, Diocleziano, effigiati insieme in una scena di sacrificio.
In seguito toccherà alla nuova Roma, Costantinopoli, accogliere gli ultimi esempi di monumenti ufficiali
decorati da rilievi storici: la colonna coclide istoriata fu riportata in auge a imitazione di Roma da Teodosio I
e dal figlio Arcadio nell’omonimo foro, ma di entrambe si conservano oggi solo pochi frammenti. Sopravvive
invece il basamento dell’obelisco collocato nell’ippodromo di Costantinopoli nel 390-392 per celebrare la
vittoria di Teodosio I sull’usurpatore Magno Massimo e composto da due basi sovrapposte. Quella
superiore presenta quattro rilievi, nei quali in alto è ripetuta la raffigurazione frontale del gruppo imperiale
isolato in un loggiato o in un palco e fiancheggiato da guardie e funzionari dietro transenne, mentre in
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
basso appaiono barbari inginocchiati oppure spettatori dei giochi accompagnati dall’esibizione di danzatori
al suono di flauti e organi. La base inferiore ospita invece le iscrizioni di dedica e alcune vivaci scene
narrative fedeli alla tradizione più didascalica dei monumenti di Stato.
Capitolo 11 – Ritratti
I ritratti furono moltissimi, sotto forma di statue, erme e busti di vario formato, dal colossale alla miniatura
e in tanti materiali, per non parlare delle immagini a rilievo su monete, sigilli, cammei, gemme e vetri e di
quelle dipinte.
I ritratti si trovavano ovunque: in aree pubbliche, come fori, santuari, ninfei, teatri e terme, negli
accampamenti militari, in spazi corporativi a carattere semipubblico di collegi, in abitazioni e sepolcri.
I ritratti non erano destinati a una fruizione estetica, ma costituivano uno degli onori più adatti a
perpetuare la memoria di uomini benemeriti.
Le dediche offrivano una chance di presentazione pubblica anche a cerchie altrimenti impossibilitate a farlo
per mezzo della statuaria, come soldati, schiavi e liberti, malgrado di norma il testo delle iscrizioni dia solo
scarne indicazioni funzionali sul dedicante e di rado contribuisca a esaltarlo.
Molte sono le opere conosciute, ma ben più gravi le perdite. I quasi trecento ritratti a tutto tondo di
Augusto conservati formano una quota minima dei venticinquemila/cinquantamila ipotizzati.
Ritratti dipinti
Oltre ai ritratti del Fayyum (vedi box 1), è celebre un frammento di affresco in età neroniana proveniente
da Pompei: i probabili abitanti della dimora si presentano, lui come cittadino romano, con il rotolo nelle
mani che sottolinea il possesso della cittadinanza e quindi il livello sociale raggiunti, lei con tavoletta cerata
e stilo alle labbra, probabilmente nell’atto di svolgere attività di computo connesse con l’amministrazione e
l’economia della casa o delle proprietà di famiglia.
Un’officina al lavoro
Alcuni rilievi illustrano i ritrattisti al lavoro: un esempio da Efeso mostra un’officina con un team di
scalpellini, uno intento a lavorare un busto con himàtion (mantello) e un altro davanti a una statua intera
abbigliata allo stesso modo.
Oltre che per gli imperatori e i membri delle loro famiglie, anche per i privati si conoscono casi di plurime
immagini, talora innalzate in uno stretto lasso di tempo in più luoghi nevralgici delle città.
Nelle due sfere del pubblico e del privato le sostanziali differenze per le statue-ritratto riguardavano non
tanto le forme rappresentative ed epigrafiche e i loro obiettivi, quanto la loro visibilità e soprattutto i
committenti.
Nell’Urbe gli spazi pubblici erano monopolizzati dagli imperatori: i membri dell’ordine senatorio e in misura
minore di quello equestre furono onorati nelle loro case o negli horti da membri stretti della famiglia; un
ritiro in una dimensione meno pubblica non ugualmente riscontrabile per senatori, cavalieri o autorità
municipali fuori da Roma.
Era consuetudine chiedere prima del conferimento di un onore se l’omaggiato fosse o meno d’accordo, ed
egli poteva dire la sua su determinati aspetti come il tipo statuario, il luogo di collocazione o il contenuto
dell’iscrizione, benché non sempre la sua volontà fosse rispettata.
Una società ossessionata dalle immagini e dagli onori correlati escogitò dunque una bella invenzione: il
ritratto a insaputa dell’effigiato.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Di statue ce n’erano sin troppe, per cui ogni tanto si doveva provvedere a fare un po’ di pulizia.
Già nel 158 a.C. i censori decretarono di togliere dalle aree intorno al foro Romano tutte quelle dei
detentori di una magistratura che non erano però state collocate per decreto dal popolo o dal senato. Più
avanti, Caligola fece abbattere le statue presenti nell’area del Campo Marzio; in più per il futuro proibì di
erigere in ogni luogo statue o imagines di chiunque fosse ancora vivo senza la sua autorizzazione o il suo
invito.
Dal secolo III d.C., dopo il regno dei Severi, si avverte una riduzione nelle dediche di statue, spesso imputata
a torto a una generale crisi economica e a rivolgimenti sociali. A subire il colpo furono soprattutto le
immagini dei “ceti medi”.
Le dediche di statue negli spazi pubblici, nel secolo IV d.C. un affare riguardante in particolare i membri
dell’aristocrazia senatoria, collassarono in modo brusco specie da 379 d.C. (anno dell’ascesa al trono di
Teodosio I) per non riprendersi più e sparire progressivamente verso i secoli V-VI d.C.
11.1 Volti di cera e ritrattistica repubblicana (secoli IV-I a.C.)
A Roma l’aristocrazia senatoria presentava un’articolazione interna gerarchica, basata sul prestigio di ogni
famiglia (gens) quantificabile in base all’accumulo di onori e prestazioni fornite per la Repubblica. Le
immagini degli antenati, realizzate da uno stampo in gesso approntato più verosimilmente alla morte degli
effigiati, erano uno dei più importanti strumenti nel sistema di rappresentazione della stirpe quale garanzia
della sua prosecuzione biologica, sociale e politica: chiuse all’interno di edicole lignee nell’atrio delle domus
e accompagnate da un titulus con stringato elenco delle tappe fondamentali della carriera, venivano tirate
fuori per i cortei funebri e ornate in occasione di pubblici sacrifici.
Al momento della sepoltura, l’ultimo defunto veniva incluso tra i più autorevoli ed esemplari antenati della
famiglia, presenti sotto forma di immagini nella processione davanti al feretro, in una serie dal rigoroso
ordine cronologico, con l’avo più antico in testa.
Secondo l’autopsia di Polibio, le imagines ritraevano i volti degli antenati con estrema somiglianza nel
modellato e nel colorito.
Dopo l’interramento del corpo e l’espletamento dei riti prescritti, la imago dell’ultimo defunto poteva
finalmente trovare posto nell’atrio, dove erano presenti anche immagini dipinte e ordinate in alberi
genealogici (stemmata).
Lo ius imaginum (diritto alle immagini), non una legge scritta, bensì una consuetudine di casta, spettava ai
discendenti di un antenato che avesse ricoperto una magistratura curule. La prassi conobbe una più intensa
politicizzazione nel corso del secolo IV a.C., con la nascita della nobilitas patrizio-peblea e con la formazione
di una memoria storica monumentale.
Realizzati da locali “ceraiuoli”, i volti in cera a Roma miravano alla maggiore rassomiglianza possibile, non
limitata ai lineamenti. Oltretutto, i più preminenti personaggi in vita erano seguiti da “attori” che, quasi da
controfigure, studiavano a memoria l’andatura e le peculiarità del loro aspetto da ripresentare forse
durante la pompa funebre. I morti potevano tornare a essere tanto vivi, anche grazie a un medium
straordinariamente mimetico come la cera, da non farsi occasionalmente mancare anche la parola.
Le cere erano talmente somiglianti da poter rimpiazzare anche i corpi assenti, come nella prassi del funus
imaginarium a Roma, non esclusiva degli imperatori e documentata sino al Rinascimento nelle cerimonie
del lutto per i sovrani.
Non disporre però di alcun esempio concreto di imagines maiorum in cera provoca molti dubbi sul loro
effettivo aspetto, tanto più che dovevano esisterne diversi tipi, anche sotto forma di busti e figure intere.
Scoperto nel 1852 ma ancora non ben studiato, si conserva al Museo Archeologico Nazionale di Napoli un
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
volto pieno in cera con porzione del collo di un giovane uomo con occhi in vetro da una camera sepolcrale
di Cuma, adattato a uno scheletro trovato acefalo; nei secoli II-III a.C., l’Italia, l’Egitto e l’Africa
settentrionale hanno restituito parecchi volti in gesso di natura per lo più funeraria, consistenti sia in
maschere funebri a occhi chiusi sia in ritratti a occhi aperti di uomini, donne e bambini.
Siccome poco spazio doveva essere lasciato alla schematizzazione, alla convenzione e alla formalizzazione
prevalenti nella maggior parte degli altri modi di rappresentazione, le effigi in cera sono state a più riprese
ricondotte a una dimensione magico-religiosa o declassate nella categoria della non-arte.
Arte o meno, in un clima di perenne campagna elettorale e di concorrenza come in età repubblicana, i
Romani avvertirono con forza il bisogno della presentazione del volto individuale.
Specie nella prima metà del Novecento le imagines maiorum hanno svolto un ruolo nel dibattito sulle
origini del ritratto romano. Queste ultime, con un “verismo” da plastico cartografico in visi grinzosi dalla
mimica accigliata e ammonitrice, avrebbero esaltato gli ideali di semplicità rustica e di scontrosa durezza
degli anziani, come severitas, gravitas, constantia, dignitas: un equivalente visivo della loro autorevolezza in
una società gerontocratica.
Vista l’impossibilità di dimostrare cin sicurezza una derivazione diretta dei ritratti dalle immagini in cera,
Ranuccio Bianchi Bandinelli vide in queste ultime comunque la matrice “ideologica” e il fondamento del
“ritratto romano tipico”, incline a una potente caratterizzazione personale.
Tuttavia le imagines maiorum in cera poterono influire almeno sul modo in cui sin dal secolo IV a.C. gli
uomini di potere vollero vedersi rappresentati nei ritratti a tutto tondo. L’urgenza di un volto dai tratti
inconfondibili nella ritrattistica dovette, come inevitabile, misurarsi con le forme e i modelli irradiati dalle
effigi dei grandi dinasti, condottieri e pensatori greci, per cui solo dall’aspetto è impossibile distinguere un
greco da un romano; quell’urgenza poté avere almeno due conseguenze che in parte permettono di
cogliere un’“idea romana del ritratto”.
1. Anzitutto poté contribuire al suo affrancamento dalle tradizioni estetiche normative spesso
informanti il ritratto greco e rese poi accettabile il raggiungimento di una “verità” senza
l’ossessione della “bellezza”.
2. Si poté poi smorzare la dipendenza da stretti vincoli tipologici rispetto all’imagerie dinastica e
cittadina del mondo greco. Tra i dinasti ellenistici s’incontrano tanti volti lisci e giovanili, dalle folte
e mosse chiome con teste energicamente rivolte di lato, sulla falsariga di Alessandro Magno.
Sin qui si è parlato di un’esigenza di preservazione dell’individualità tanto ben ottenibile nelle cere da non
potere restare senza conseguenze almeno sui principi costitutivi della ritrattistica in bronzo e in marmo
della Repubblica. Si possono però cogliere più concreti riflessi delle prime sulla seconda almeno nell’uso di
determinate formule ritrattistiche? Per rispondere, bisogna prima figurarsi l’aspetto delle imagines
maiorum: uomini in là con l’età, dai quaranta in su, immaginabili con sguardi impassibili e ammonitori,
senza pathos e a bocca chiusa, un po’ come sul “togato Barberini”.
Poiché il ricordo che l’uomo lascia di sé è importantissimo, Plinio il vecchio in una tirata moralistica lamenta
come la perdita di valore della personalità individuale si rivelasse ai suoi giorni principalmente nella
preferenza conferita alla materia preziosa più che alla propria immagine, alla quale si rinunciava anche a
favore di quella altrui.
11.2 Il ritratto in epoca imperiale (secoli I-VI d.C.)
Dal primo periodo imperiale, specie a Roma, le possibilità rappresentative dell’élite si restrinsero a causa
degli imperatori, onnipresenti con i loro palazzi luoghi ed edifici di culto, sepolture e statue. Augusto
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
riassunse nella hall of fame del suo foro gli avi e i protagonisti dell’intera storia romana, presenti sotto
forma di statue in marmo accompagnate da elogia e offerte come modello ai propri concittadini.
Il riconoscimento dei volti di imperatori, imperatrici, principi e membri della famiglia imperiale, oltre che
dai contesti archeologici, dalle iscrizioni e dalle rappresentazioni storiche, è stato per lo più reso possibile
dai confronti con quelli presenti di profilo sulle monete (ben datate); le incertezze persistono per gli
imperatori effimeri del secolo III e poi per alcuni del IV d.C. I ritratti erano replicati in tantissimi esemplari,
dalla cui trama, costitutiva di un tipo, si ricava il modello comune. L’accostamento delle repliche consente
di ottenere un’idea dell’archetipo perduto alla base, in gesso, cera o terracotta, affidato a un artista di
corte, approvato dall’imperatore, rapidamente diffuso per mezzo di calchi e riprodotto con fedeltà specie
nelle proporzioni del viso, nella linea del profilo e nei motivi della chioma grazie al metodo della traslazione
dei punti come nella scultura “ideale”.
I tipi creati prima dell’assunzione del potere e durante il governo degli imperatori, che oggi recano nomi
convenzionali, sono ben distinguibili specie nei secoli I-II d.C. Augusto ne vanta cinque, Traiano sei, Adriano
otto, Marco Aurelio quattro, per non parlare dei nove di Faustina Minore in connessione con le nascite dei
tanti figli.
Le singole elaborazioni successive con un restyling più o meno radicale, concernente in particolare
l’acconciatura, paiono coincidere con eventi di rilievo come: ascesa al potere, matrimonio, nascite nella
famiglia imperiale, ritorno da campagne militari, trionfo, decennali del regno e così via.
L’esame di ogni opera da parte degli studiosi verte in particolare sulla chioma e sul preciso conteggio delle
ciocche; ben più della faccia, per gli Antichi specchio del carattere, è proprio lo studio della capigliatura a
offrire comodi criteri per la definizione dei tipi. Se gli archeologi sono diventati tanto sensibili alle
acconciature, lo erano anche gli imperatori, tanto nei ritratti quanto nella realtà. Domiziano, bello in
gioventù, ma con il tempo frustrato dalla calvizie e poco incline a scherzarci su, divenne tanto ossessionato
dalla cura dei capelli da scrivere sull’argomento un trattato dedicato a un amico con lo stesso “problema”;
Otone, anch’esso calvo, portava una parrucca tanto ben fatta e perfettamente sistemata che nessuno se ne
accorgeva.
Mimiche e chiome, insieme, rispondevano a una strategia di comunicazione, perché l’ascesa al potere e la
conferma nel ruolo dipendevano anche dalla costruzione dell’immagine, ieri come oggi.
Caracalla, smanioso di assomigliare ad Alessandro Magno, aveva fatto innalzare numerose statue di se
stesso, tra cui alcune, risibili, fatte di un solo corpo con un’unica testa a due facce: da una parte la sua,
dall’altra quella del Macedone.
Con le chiome si poteva volere enfatizzare la continuità con l’imperatore precedente a fini legittimanti,
come nel secondo tipo del ritratto di Settimio Severo, molto simile per acconciatura a Marco Aurelio; o
distaccarsi nettamente dal predecessore, come Vespasiano, la cui calvizie ostentata spicca ancora di più di
fronte alla chioma affettata di Nerone.
Ritratti di privati
Come gli imperatori, i privati potevano essere raffigurati più volte, grazie allo stesso modello realizzato da
officine di eccellente qualità.
Come distribuire i privati in griglie cronologiche? A parte il discrimine generale dell’indicazione di pupilla e
iride con il trapano, una novità riscontrabile dal 130 d.C. circa in poi e il taglio dei busti, di dimensioni
sempre più grandi, le datazioni si possono ricavare dall’esame stilistico. Parecchi ritratti privati di ogni età
rivelano, per fortuna, grandi affinità con quelli degli imperatori e, nel caso di personaggi femminili, delle
imperatrici, non limitate alla chioma, ma estese fino alle componenti del volto e alle formule mimiche.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Può però accadere che si continuassero a riproporre mode del vicino passato, come per l’acconciatura di
Nerone in voga sino all’età adrianea. Il fenomeno s’intensificò specie sotto Traiano: la moda dei “piccoli
Traiani” realizzati in officine non di prima qualità persistette per l’intero secolo II d.C.
Nella ricerca, l’aspetto in parte uniforme dei privati durante il governo di un dato imperatore è ora
battezzato con il termine inglese di “assimilated portraiture” e tedesco di “Bildnisangleichung”. Perché il
desiderio di imitare? Il volontario conformismo figurativo rispondeva a una moda, con l’accettazione del
“grandi” quali modelli, per cui, senza uno specifico attributo o la conoscenza del contesto di rinvenimento,
gli archeologi a volte riescono a stento a distinguere tra honorati privati e imperatori.
In che misura gli antichi volti scolpiti e dipinti si avvicinavano oggettivamente agli effigiati?
Nell’arte greco-romana, ritrattistica e somiglianza sono sinonimi.
Non era affatto semplice creare un ritratto che conservasse la somiglianza secondo natura (similitudo ex
vero), tanto più quando si dovevano eseguire quelli di personaggi del passato basati su una imago già
disponibile, compiendo di conseguenza un’imitazione di un’imitazione: ciò era esattamente quel che
accadeva pure con i visi degli imperatori, duplicati anche in luoghi che non li videro mai dal vivo.
Non sorprende che le descrizioni antiche e in particolare le annotazioni di Svetonio sull’aspetto fisico degli
imperatori all’interno delle loro biografie non possano essere del tutto sovrapponibili ai ritratti, visto che gli
intenti di un testo e delle immagini divergono, quantunque entrambi i “generi” condividano il fatto di non
puntare a descrizioni oggettive e fotografiche: per il biografo, la bellezza, pur mai “idealizzata”, appartiene
ai migliori imperatori, mentre la laidezza morale implica anche quella fisica. Secondo lui Augusto aveva il
naso sporgente in alto e ricurvo in basso, un tratto in effetti ricorrente sui tre tipi chiamati “Alcudia”,
“Louvre MA 1280” e “Prima Porta”; inoltre il suo viso emanava calma e serenità, altra peculiarità ben
ravvisabile specie sul tipo principale e di maggiore successo per tutta l’età giulio-claudia, il “Prima Porta”,
appunto.
Alla somiglianza potevano concorrere anche i colori. I marmi erano colorati, ed è un peccato che solo pochi
esemplari con tracce di pigmenti, rivalorizzate anche tramite analisi tecniche, abbiano consentito almeno
ricostruzioni pur discutibili, come per un ritratto di Caligola alla Ny Carlsberg Glyptotek di Copenhagen, con
residui di nero su capelli, sopracciglia, ciglia e pupille e con tracce di colore tra il rosa e il rosso su bocca e
ghiandole lacrimali nonché lungo i margini delle palpebre.
I ritratti non documentavano in modo pedissequo il trascorrere degli anni e, se tenevano conto del fattore
temporale, era semmai per negarlo ringiovanendo i volti, come poteva capitare alle effigi postume.
Anche le iscrizioni collegate alle statue tacciono sull’età degli effigiati, malgrado eccezioni, come a Volubilis,
capitale della provincia di Mauritiana Tingitana. Qui parecchie epigrafi sulle basi di statue dedicate
(postume) dai parenti stretti nel foto e in altri luoghi di rilievo precisano l’età dei membri di famiglie
municipali prematuramente scomparsi (sotto i venti o venticinque anni), in quanto la immatura mors aveva
loro impedito di rivestire le cariche pubbliche previste dalle aspettative sociali; indicare l’età equivale in tal
caso ad addurre una sorta di scusante per imprese e benemerenze non compiute.
Al conseguimento della somiglianza nella ritrattistica si frapponevano altri ostacoli, e determinate classi di
individui.
Le donne esigevano dai pittori di risultare più belle di quanto fossero. Maggiore esattezza era però ricercata
nella resa delle loro acconciature, denotanti l’amore per il luxus.
Infine, talora non si raggiungeva la somiglianza semplicemente perché i ritratti erano mal eseguiti.
Somigliante o meno, la ritrattistica sino al secolo III d.C. inoltrato mantenne un aspetto naturalistico. Un
tramonto della coerenza organica a favore di modi più astratti si verificò dalla fine del secolo III d.C. e in
particolare a partire dal ritratto pacato di Costantino, un modello poi vincolante per i successori, a fatica
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
distinguibili l’uno dall’altro. Di qui la riduzione dei tratti più personalizzati e la trasformazione dei volti in
maschere immobili e imperturbabili dalle grandi superfici lisce e dai grandi occhi spalancati, con il
progressivo viraggio verso forme semplificate e schematizzate, anche nelle chiome.
Alla testa era affidato il compito di esprimere la personale identità di un effigiato; ciò spiega sia la
popolarità della raffigurazione abbreviata a erma o a busto, formato facilmente maneggevole, sia la
disinvolta pratica ben documentata in epoca imperiale di aggiungere una nuova testa a vecchie statue.
11.3 I corpi dei ritratti e i tipi statuari
Le statue erano ancora più distanti dalle individuali caratteristiche dei corpi e si attenevano a un ristretto
ma flessibile vocabolario di vestiari, schemi iconografici e gesti, che assieme agli attributi contribuivano a
visualizzare rango e ruoli degli effigiati, con disparati gradi di aderenza ai costumi reali.
La toga, appropriata per le immagini negli spazi civili, in particolare fori, assurse a costume nazionale e a
segno dello stato cittadino romano, indossata sopra la tunica, un indumento non marcato usato in modo
invece esclusivo dagli schiavi e dal “popolino”; il mantello fu invece un simbolo di grecità e paideìa; ma gli
imperatori anche in Oriente, nelle statue portavano sempre la toga. Le toghe erano dotate di complementi
cromatici per segnalare il livello sociale degli onorati: una magistratura era indicata dai clavi (strisce di color
porpora), e si conoscono anche esempi dove il colore rosso ricopre tutta la toga.
In età imperiale la toga prevede quali componenti caratterizzanti balteus, umbo, sinus e lacinia.
Dai secoli II-III le statue togate conobbero modifiche nella parte superiore, con una fascia rigida che
attraversa orizzontalmente il petto formando la “toga contabulata”.
Un costume sempre calato nella realtà era quello della statua con lorica, corta tunica e paludamentum
affibbiato (mantello generale), consona alla rappresentazione di individui dotati di comando militare,
imperatori e membri della famiglia imperiale e della più alta élite; la lorica nei tipi a corazza anatomica e a
corsetto cilindrico, poté trasformarsi in medium figurativo per ricevere una ricca decorazione a rilievo.
Le statue equestri, mutuate dal mondo greco, erano un massimo onore, e nell’Urbe solo gli imperatori
potevano riceverne una. La statua equestre era concessa invece nei municipi e nelle colonie a personaggi di
rango equestre o senatorio.
Plinio il vecchio sottolinea l’uso romano e militare della corazza, contrariamente all’abitudine greca che non
prevedeva alcuna copertura del corpo; ma anche le statue nude, definite “achilee” sul modello degli efebi
nei ginnasi, furono apprezzate dai Romani. Le immagini maschili in nudità integrale o parziale, a differenza
della toga, non possedevano un equivalente nella quotidianità pubblica dei cittadini romani. Le statue
maschili nude miravano semmai a enfatizzare il carisma fuori dall’ordinario degli effigiati nei santuari, negli
spazi civili e nei contesti funerari: corpi dunque giovani e perfetti con teste individualizzate di ogni età,
discrepanza che può essere fastidiosa solo per la sensibilità di oggi. Ad ogni modo, le statue nude furono di
sicuro utilizzate dai gruppi di potere di Romani e Italici sin dal secolo II a.C., in Italia centrale così come
nell’Oriente greco, e poi da imperatori e privati; solo i tipi in posa seduta e mantello intorno alle gambe,
nell’habitus di Giove, diffusi specie dall’età di Claudio ed evocanti l’idea di un’assoluta regalità, servirono
quasi esclusivamente per qualificare gli imperatori nel ruolo di dominatori del mondo al pari del dio
supremo.
I corpi nudi o seminudi degli uomini potevano spesso riprendere gli schemi dei tipi statuari greci di divinità
o eroi giovanili con l’aggiunta di mantelli militari e armi.
L’associazione con espliciti attributi divini per imperatori e imperatrici e, di riflesso, per i privati in ambito
pubblico e funerario e più di rado nelle abitazioni non presupponeva una divinizzazione o un’eroizzazione,
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
ma aveva il vantaggio a livello visivo di potenziare al massimo l’elogio commemorativo delle qualità degli
effigiati tramite paragoni mitologici.
Le donne, senza possibilità di carriera nei termini di cursus honorum e con ruoli limitati nella vita pubblica,
non avevano costumi indicativi del rango a parte la stola per le matrone romane, equivalente della toga ma
meno diffusa, tanto da sparire quasi del tutto verso la fine del secolo I d.C. Le loro immagini, assieme agli
attributi, esprimevano le qualità paradigmatiche di spose e madri quali fecunditas, castitas, pulchritudo,
pietas, gravitas e modestia; anch’esse potevano sfruttare i tipi statuari greci con chitone e mantello.
11.4 Il rapporto delle immagini con gli effigiati
Le immagini meritavano rispetto, perché il legame con il referente era fortissimo, tanto da manifestarsi
anche sotto forma di solidarietà. Tra tutti gli imperatori fu Tiberio a preoccuparsene maggiormente.
Le statue erano nelle intenzioni destinate a durare per l’eternità, ma, una volta entrate nel flusso delle
cose, potevano essere riusate, rilavorate, rimosse, rubate, danneggiate o abbattute e mutilate.
Fu Commodo a togliere la testa al cosiddetto “colosso di Nerone” e a sostituirla con la propria nonché a
dare alla statua una clava e un leone bronzeo ai piedi, con un’iscrizione che lo esaltava quale vincitore di
migliaia di gladiatori.
In età imperiale divenne sempre più intenso l’uso del riciclo e della rilavorazione di vecchi ritratti e basi, un
fenomeno controllato dalle autorità civiche e riguardante anche i materiali architettonici, cui nell’Urbe si
ricorse in modo sistematico specie dalla fine del secolo III d.C.
Diversa la procedura della “damnatio memoriae” degli imperatori caduti in disgrazia, che investì Caligola,
Nerone, Domiziano e Elagabalo – viceversa quelli “buoni” potevano essere divinizzati dopo la morte.
L’azione violenta spesso si limitò ai volti di sculture e figure a rilievo o sulle monete e all’eliminazione del
nome da iscrizioni e papiri.
Capitolo 12 – Ornamenti greci a Roma
Dopo la conquista di Siracusa e la celebrazione di una ovatio nel 211 a.C., M. Claudio Marcello fece
collocare le opere d’arte predate nel doppio tempio di Honos e Virtus presso porta Capena, ossia due
divinità astratte che impersonavano concetti cardinali del linguaggio politico romano, utilizzandole come
ornamenta della città.
Quella dell’arrivo delle opere siceliote a Roma e della loro collocazione pubblica fu considerata nella
storiografia posteriore una data simbolica per descrivere il processo di appropriazione della cultura
figurativa greca da parte romana.
Secondo Livio la presa di Siracusa segnò l’inizio stesso dell’ammirazione dei Romani per le opere d’arte
greche così come della mancanza di ogni freno alla spoliazione degli sconfitti, il momento a partire dal
quale ci si permise indistintamente di predare tutti gli edifici sacri e profani.
All’incirca un secolo più tardi, Plutarco presentò il saccheggio di Siracusa in una luce del tutto positiva,
perché per suo tramite la grazia dell’arte greca avrebbe ingentilito e raffinato i Romani, descritti di nuovo
come incompetenti d’arte al tempo di Marcello. I due storici rileggono quel lontano evento alla luce delle
proprie convinzioni, ma concordano comunque sul fatto che le opere d’are siceliote ebbero un impatto
molto più significativo dei bottini precedenti, dovuto alla loro qualità più che ai parametri fino ad allora
dominanti nella valutazione della preda.
Il bottino di Siracusa offrì probabilmente di più e di meglio e secondo Plutarco a Roma suscitò reazioni
contrastanti, con il popolo favorevole a Marcello e l’aristocrazia ostile.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Il saccheggio di Siracusa può essere ritenuto un episodio decisivo perché riunì due aspetti molto importanti
del complesso legame tra il mondo romano e l’arte greca: la pratica della spoliazione, di fatto a lungo la
modalità privilegiata di raccolta a Roma dei capolavori artistici greci, e la collocazione pubblica come
ornamenta urbis delle opere giuntevi.
12.1 Il saccheggio dell’arte greca
Alla vittoria di Marcello seguirono molte altre guerre nel corso delle quali i generali romani fecero incetta di
opere d’arte e le trasportarono in patria, mostrandole prima al popolo durante le processioni trionfali e poi
facendole collocare negli edifici costruiti con i proventi del bottino.
Il fenomeno si placò solo in età imperiale, quando, dopo il trionfo di Ottaviano nel 29 a.C., i nuovi arrivi di
capolavori greci furono sempre più spesso frutto di acquisti più o meno coatti o di ruberie imposte con
violenza alle città greche, senza che vi fosse più un legame diretto con vittorie militari ed eventi bellici.
I capolavori greci giunti a Roma in età repubblicana appartenevano dunque spesso al bottino: nel momento
in cui una città nemica si arrendeva, a seconda della formula con cui ciò avveniva, il comandante romano
acquisiva il diritto di confiscare anche le sue opere d’arte. Solo di rado la spoliazione fu totale, come a
Corinto e Cartagine.
Le comunità greche naturalmente non accettarono di buon grado tali furti di pitture, statue e tanti altri
oggetti di lusso; esse cercarono per quanto possibile di opporvisi legalmente, di solito contestando il diritto
stesso del generale romano alla spoliazione perché le condizioni della resa non avrebbero incluso o
consentito il saccheggio.
Dei sentimenti dell’opinione pubblica greca si fece portavoce Polibio. Egli prese spunto ancora una volta dal
saccheggio di Siracusa per criticare con forza la politica di spoliazione romana adottata dai Romani perché li
danneggiava senza che essi ne traessero vantaggi reali.
Il secondo argomento applica a Roma l’antico modello della tryphé (lusso) come causa della corruzione
morale e della decadenza e caduta degli stati, ma la parte più interessante del ragionamento è la prima,
dato che documenta il sentimento reale dei Greci e invita i Romani a tenere conto anche del punto di vista
degli stranieri in visita nell’Urbe.
12.2 Selezione ed esposizione a Roma
Altro aspetto da considerare è proprio l’impiego delle opere d’arte una volta giunte a Roma.
Nel mondo romano la nozione di ornamenta era prima di tutto giuridica e applicabile a ogni cosa che
abbelliva il luogo in cui era esposta. Rispetto a una città anche un edificio poteva rientrare nella categoria
degli ornamenta, ma di solito il termine era riferito alle sculture o ai quadri facenti parte dell’arredo
inamovibile di uno spazio pubblico o privato. Degli ornamenta non facevano parte solo le opere dei grandi
artisti greci, ma anche altre, tra cui le statue onorarie, ritenute una categoria di ornatus adatta alla
decorazione dei fori, ossia agli spazi politici per eccellenza. Agli ornamenta propriamente detti non
appartenevano invece le statue di culto, i simulacra, che svolgevano una funzione diversa all’interno di un
edificio sacro, ossia quella di rendere presente la divinità. Di solito i generali trionfatori evitavano di
impadronirsene, a meno di non procedere nella evocatio (prassi con cui si mirava a privare la città nemica
della divinità tutelare).
La congruenza tra ornamenta e collocazione era un principio importante, proclamato anche da Vitruvio, per
il quale si doveva sempre rispettare la convenienza tra tipo statuario e funzione dei luoghi.
L’importanza dell’adeguatezza del soggetto condizionava del resto anche personaggi come Cicerone: dalla
sua corrispondenza si apprende che al progetto di arredare gli ambienti delle sue ville a imitazione dei
ginnasi greci si confacevano le immagini di Muse, Atena, Hermes ed Eracle e non i temi bacchici o bellici.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
La selezione degli ornamenta e del loro contesto poteva basarsi anche su dimensioni e materiali, sulla
predilezione per un determinato linguaggio artistico o perché certe opere dilettavano più di altre.
Anche la fama dell’artista o semplicemente la squisitezza del linguaggio formale potevano rendere congrui
gli ornamenta.
A partire dal I secolo a.C. conosciamo l’esistenza di vere e proprie gallerie di opere d’arte.
Il teatro di Pompeo
Per ornare il grande complesso formato da teatro e portici, fu interpellato come consulente un intenditore
come T. Pomponio Attico, che si occupò specificamente della compositio delle statue, ossia della loro scelta
e disposizione. L’arredo, frutto non solo di spoliazioni ma commissionato anche a scultori contemporanei,
comprendeva personificazioni di popoli sconfitti, temi bacchici nel giardino e una ricca pinacoteca,
sistemata nel porticato.
Giardino e portici ospitavano statue di donne celebri, suddivise per categorie (poetesse, etère, donne dalla
fecondità straordinaria). Alcune opere dovevano illustrare aspetti della personalità pubblica di Pompeo,
come l’imitatio Alexandri nel caso del quadro del pittore ateniese Nicia con il sovrano macedone; un
quadro del grande Polignoto ebbe probabilmente un posto di spicco davanti alla curia. I monumenta
Pompeiana danno un’idea dell’ampiezza e della diversificazione dell’impiego degli ornamenta nei maggiori
edifici di Roma; in questo senso saranno un modello per l’allestimento degli altri grandi edifici porticati di
età imperiale.
12.3 Il dibattito sulla collocazione pubblica o privata delle opere d’arte
L’arrivo a Roma degli ornamenta fece nascere anche un serrato dibattito sulla loro collocazione privata o
pubblica, segno che anche la tendenza alla fruizione domestica degli oggetti d’arte si affermò molto
rapidamente. Sebbene nel caso delle statue e dei quadri facenti parte del bottino fosse evidentemente
interesse del trionfatore fare sfoggio di magnificentia publica e assicurare memoria della sua vittoria
tramite la loro dedica come ornamenta urbis, lo stesso M. Claudio Marcello tenne per sé in casa una
preziosa sphaera siracusana, e M. Acilio Glabrione fu accusato di avere fatto lo stesso. Nella prima metà del
secolo II a.C. Catone il Censore fu probabilmente il primo a prendere posizione in proposito, in alcune sue
orazioni, di cui restano però solo un argomento e pochi frammenti, nei quali egli condannava la sottrazione
per uso privato di parte del bottino dal bene pubblico e denunciava in particolare la collocazione nelle case
delle statue di divinità, usate come suppellettile.
La condanna di Catone non arrestò il “collezionismo” privato. Le opere d’arte non giungevano più solo
come preda di guerra, ma erano moltiplicate dalle copie e rielaborazioni prodotte dalle officine greche
contemporanee. Esisteva un ricco mercato dell’arte, a cui attingeva chi voleva vivere “alla greca” in Italia.
La fruizione pubblica degli originali greci trasformati in ornamenta civici era ritenuta ormai un privilegio del
popolo romano. Disporre statue nei luoghi pubblici faceva guadagnare una buona reputazione.
Toccò a M. Vespasiano Agrippa trarne le conclusioni e lo fece in un discorso, pronunciato forse nel 33 a.C.,
quando era edile curule, in cui sostenne la necessità di rendere di proprietà pubblica le statue e i quadri
onde sottrarli all’esilio nelle ville.
Tuttavia l’intervento di Agrippa, accompagnato da un ampio dispiegamento di capolavori soprattutto nel
Campo Marzio, fu il segno di un atteggiamento concretamente favorevole alla collocazione pubblica delle
opere d’arte, approvato evidentemente dallo stesso princeps; questi riservò di fatto a se stesso e alla sua
famiglia la gestione degli ornamenta, trasformandoli in instrumentum regni, come aveva fatto con il
trionfo, che era stata anche l’occasione per eccellenza per impadronirsene, almeno nella forma più
onorevole per un romano.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Il popolo di Roma si era ormai abituato ad ammirare le opere d’arte come ornamenta e non era disposto a
perdere questo privilegio, come scoprì a sue spese Tiberio, quando, all’inizio del suo principato, da raffinato
intenditore decise di trasferire al suo “appartamento” privato il celebre Apoxiyòmenos di Lisippo dallo
spazio antistante le Terme di Agrippa. Nonostante l’imperatore avesse già predisposto la sostituzione
dell’opera di Lisippo con un’altra statua (una copia?), nell’intento di evitare proteste, lo spostamento di un
capolavoro riconosciuto da un luogo dove poteva essere visto da tutti a uno spazio privato provocò
l’indignazione civica che si manifestò in teatro mediante ostinate grida di disapprovazione del popolo,
finché l’imperatore non si rassegnò a restituirlo.
In effetti, era il popolo a essere maggiormente danneggiato dalla decisione di Tiberio, poiché non aveva
altro modo di ammirare i capolavori greci se non come ornamenta di edifici pubblici.
La sottrazione violenta delle statue dai luoghi pubblici fu da allora una qualità caratteristica degli imperatori
“tirannici”, come Caligola e soprattutto Nerone.
In seguito, le notizie sulla collocazione pubblica di nuovi ornamenta diminuiscono, mentre aumentò
semmai la preoccupazione per la loro salvaguardia. Con l’affermazione del Cristianesimo, nel corso del
secolo IV d.C., la sconsacrazione dei templi portò al loro abbandono e spesso alla distruzione delle satue di
culto. Non è raro però che queste fossero semplicemente rimosse e rifunzionalizzate da simulacra a
ornamenta.
Molti cristiani colti infatti non avevano problemi ad accettare le immagini “pagane”, purché non fossero più
oggetto di venerazione.
Il possesso dei capolavori dell’arte greca continuò inoltre a qualificare i grandi centri urbani, come si deduce
dal loro impiego anche a Costantinopoli.
La nuova capitale imperiale non poteva infatti mancare di ornamenta adeguati. Le statue di culto, ormai
classificate come semplici ornamenta furono spostate a Costantinopoli e collocate con grande attenzione ai
contesti, proprio come era avvenuto nella Roma tardorepubblicana e imperiale, e fecero della città l’ultimo
“museo” della scultura greca almeno fino al sacco crociato del 1204.
Capitolo 13 – Copie e rielaborazioni di modelli greci
Il fenomeno cui gli studiosi hanno dato il nome di “copistica” poteva avere in epoca imperiale declinazioni
estremamente differenti. Le officine mettevano a disposizione di committenti e acquirenti un vasto
patrimonio di tipi statuari che talora riproducevano fedelmente e in serie originali greci e talaltra li
citavano, rielaboravano o ricreavano liberamente, impiegando comunque schemata o “stili” ispirati all’arte
greca. I committenti cercavano statue che fungessero da ornamenti di edifici pubblici o privati,
selezionandole in base soprattutto ai soggetti e talvolta al loro pedigree.
13.1 “Critica delle copie” e “scultura ideale”
La consapevolezza che molte delle statue trovate a Roma nel corso dei secoli e celebrate come capolavori
nelle collezioni formatesi a partire dal Rinascimento non erano opere originali dei grandi scultori greci noti
bensì sculture “romane” si affermò solo con difficoltà e lentezza nella cultura antiquaria.
Già all’inizio dell’Ottocento la maggioranza degli studiosi era però ormai consapevole di trovarsi di fronte a
copie, scoperta gravida di conseguenze: ci si convinse infatti che queste potessero essere utilizzate per
ricostruire le opere d’arte greche originali quali erano ispirate, il che causò disinteresse per le ragioni stesse
della loro produzione.
Attraverso una meritoria opera di classificazione di artisti e tipi statuari. Sfruttando l’assemblaggio di calchi
di copie diverse, nella seconda metà dell’Ottocento e all’inizio del Novecento furono ottenuti risultati
notevoli, come il riconoscimento del Doriforo di Policleto.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
I frutti di questo metodo di investigazione furono sviluppati nella prima metà del Novecento da Georg
Lippold, che alle copie in senso stretto e alle loro varianti, aggiunse un ampio ventaglio di possibilità di
rielaborazione e ricombinazione che permettevano di allontanarsi dall’originale. Quest’ultimo poteva infatti
essere trasformato per mezzo dell’introduzione consapevole di alcuni elementi nuovi ma coerenti
(“Umbildung”), che non impedivano comunque l’identificazione del modello, oppure diventare oggetto di
un processo di riformulazione o reinvenzione di un nuovo tipo statuario, che poteva contaminare più
modelli fra loro (“Neuschoepfung”) ed era a sua volta in grado di produrre copie e varianti e di diventare
un’opera illustre al pari di quelle greche del passato.
Studi più recenti hanno abbandonato l’idea che dietro ogni scultura in età imperiale vi fosse un preciso
archetipo greco. Un primo passo è stato riconoscere che in gran parte della scultura “ideale” le frequenti
riprese “arcaistiche”, “severizzanti” e “classicistiche”, spesso riconoscibili anche per la fusione di tratti
stilistici dissonanti, non erano determinate dalla volontà di replicare o citare uno specifico archetipo greco,
ma dal proposito di riprodurre una determinata temperie formale, perché ogni specifico linguaggio era
sentito come particolarmente adatto a esprimere i valori più appropriati al gusto del tempo, ai contesti o al
soggetto raffigurato.
Un passo ulteriore nella riconsiderazione della “critica delle copie” è rappresentato dalla tendenza a
mettere in parallelo il modo di procedere dei copisti con varie forme di imitazione classificate dai retori
latini, ossia intepretatio, imitatio e aemulatio. Solo il primo procedimento sarebbe adatto a descrivere una
copia fedele all’archetipo, mentre i due concetti di imitazione ed emulazione indicherebbero due diversi
gradi di libertà di azione e di originalità dell’artefice, che nel primo caso produrrà in sostanza
“Umbildungen” e nel secondo “Neuschoepfungen”, facendo così sfoggio di una maggiore creatività in grado
di superare i limiti della tradizione.
Chiave di volta del sistema sarebbe il concetto di decorum, ossia di appropriatezza dell’opera rispetto al
contesto, principio che poté spingere gli scultori a rinnovare gli originali greci mediante il procedimento
dell’emulazione e i committenti a richiedere e ad apprezzare le innovazioni perché più adatte ai nuovi
contesti, nei quali di fatto repliche fedeli e rielaborazioni furono spesso impiegate insieme, senza
distinzione proprio perché selezionate in funzione dei valori espressi.
Sia le copie stricto sensu di capolavori sia le numerose rielaborazioni o ricreazioni in stile facevano del resto
parte dello stesso fenomeno di appropriazione cosciente della tradizione greca.
Si dovrebbe semmai distinguere la ricerca dello stile personale dei grandi scultori greci, un traguardo
troppo ambizioso almeno a partire dalla documentazione esistente, da un obiettivo difficile ma
perseguibile, come la ricostruzione di quali tipi statuari facessero parte del repertorio noto agli scultori in
età imperiale.
13.2 Storia e contesti
Tra i secoli III e II a.C., si sviluppò una letteratura critica che individuò negli scultori “classici” i maestri da
imitare o ai quali rifarsi, creando le premesse di un fenomeno consapevolmente imitativo. Uno degli
esempi più antichi è la statua in marmo dell’Atena Parthénos collocata nella biblioteca di Pergamo
all’interno del santuario di Atena Nikephòros, chiaramente ispirata all’opera crisoelefantina fidiaca, ma
molto ridotta di scala e realizzata con una tecnica meno costosa. Il regno di Pergamo sembra quindi essere
stato all’avanguardia in questo campo. Anche le officine attiche furono subito molto attive: nelle firme degli
artisti l’etnico athenaios era un marchio di qualità, e non è poi un caso che parecchie sculture nell’agorà e
sull’Acropoli di Atene, mete per eccellenza dei viaggiatori antichi in Attica siano state replicate.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
I carichi dei relitti di Mahdia e Anticitera illustrano la vitalità del commercio di opere d’arte tra i secoli II e I
a.C., comprendente originali greci più antichi, ma anche opere nuove realizzate appositamente per il
mercato romano. Le officine erano ancora dislocate nel mondo greco, ma ormai lavoravano per esportare
verso l’Italia.
Negli stessi anni, mentre le officine greche rifornivano i collezionisti romani, avvenne anche in Italia un vero
e proprio salto di qualità nella produzione scultorea.
Il nome più celebre è quello di Pasitele che, attivo nella prima metà del secolo I a.C., fu un artefice versatile
e colto, in quanto conoscitore della storia dell’arte greca e dei suoi capolavori e autore di un trattato
(perduto) in cinque libri sui “nobilia opera” in tutto il mondo.
Pasitele e la sua “scuola” non furono però copisti in senso stretto, visto che essi preferirono semmai
rielaborare i modelli greci, spartendo con le officine di copisti l’indispensabile familiarità con la coroplastica,
necessaria per plasmare matrici, bozzetti e calchi, pronti per essere usati anche per realizzare sculture in
marmo e in bronzo ed eventualmente per essere venduti a caro prezzo ad altre officine.
A partire dalla seconda metà del secolo I a.C. le ville dell’aristocrazia romana cominciarono ad accogliere
programmi decorativi sempre più complessi per accompagnare l’otium dei proprietari ansiosi di “vivere alla
greca”, come nella Villa dei Papiri a Ercolano; l’arredo, messo in opera in gran parte nel 40-30 a.C.,
costituisce un caso esemplare sia per ricchezza e qualità artistica delle sculture sia per l’ambizione
“intellettuale” della loro composizione. Nel programma decorativo convivono copie fedeli, varianti e libere
rielaborazioni. Nel peristilio rettangolare possiamo verosimilmente riconoscere delle repliche nelle statue
dei corridori pronti a scattare, nel satiro ebbro e in quello addormentato; sono invece ricreazioni
“severizzanti” le cinque statue in bronzo con peplo e un’Atena “Pròmachos” “arcaistica” in marmo.
In ogni caso copie e rielaborazioni furono quindi accostate indistintamente per illustrare i temi legati a
otium e negotium che caratterizzano la decorazione della villa, segno di quanto sia appunto difficile
separare, almeno nei contesti d’uso, le copie fedeli dalle varianti o dalle creazioni “in stile”, comunque
esposte con pari dignità.
Le statue della Villa dei Papiri sono utili a illustrare anche il processo di decontestualizzazione delle opere
illustri greche, adattate a funzioni e significati nuovi, decisi dai committenti.
E proprio nei nuovi contesti poterono dare un’ulteriore spinta a modificare i modelli per ottenere un
adattamento migliore.
La seconda metà del secolo I a.C. è l’epoca in cui molte officine greche si trasferirono o aprirono filiali in
Italia, spesso in Campania dove trovarono le committenze più ricche. Nacquero anche officine specializzate
in copie derivanti da modelli “classici”, frutto delle richieste del mercato romano, interessato soprattutto al
repertorio figurativo attico; non bisogna però dimenticare l’attività di scultori come i rodi Atanadoro,
Agesandro e Polidoro, capaci di usare un linguaggio ricco di pathos sia per realizzare sculture
probabilmente del tutto nuove sia per rielaborare o replicare modelli celebri adattandoli a nuovi contesti,
come avvenne nella grotta di Sperlonga. I bisogni di Augusto in funzione della trasformazione monumentale
di Roma orientarono comunque in senso soprattutto “classicistico” le scelte del repertorio di tipi statuari,
che, prima di diffondersi anche nei contesti privati, fu impiegato sia nell’arredo di nuovi edifici pubblici sia
nelle statue onorarie.
In età augustea il processo di appropriazione della scultura greca consentì la realizzazione di nuovi e
autorevoli “nobilia opera” destinati a essere replicati a loro volta. Nel foro di Augusto l’esempio più
significativo è la statua di culto di Marte Ultore realizzata per il tempio dedicato al dio e costruita grazie a
un’attenta selezione dei modelli. La statua di culto del tempio augusteo s’ispirava chiaramente a modelli
attici del secolo IV a.C. nel tipo di corazza anatomica, nel panneggio del mantello intorno alle spalle e
nell’immagine barbata ed elmata del dio, che, scelta per alludere al suo ruolo paterno rivalutato da
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Augusto, si distaccava così dalla tradizione iconografica ellenistica che preferiva raffigurare Marte giovane e
imberbe. L’atteggiamento stesso del dio e il tipo di elmo decorato da una sfinge citavano invece l’Atena
Parthenos di Fidia nell’intento sia di costruire l’immagine di Marte nel linguaggio formale più elevato
proprio delle statue di culto sia, forse, di attribuire al simulacro un ruolo analogo a quello della dea ad
Atene.
Villa Adriana a Tivoli
A partire dall’età augustea sono spesso le ville imperiali a offrire una documentazione eccezionale del
repertorio a disposizione degli scultori.
Tra tutte emerge naturalmente Villa Adriana a Tivoli, la cui decorazione vide uno straordinario sforzo anche
produttivo per realizzare le migliaia di statue impiegate. Si ritiene che nell’arredo scultoreo della villa vi sia
stata una supervisione unitaria che spiega la coerenza delle scelte generali, e che le officine abbiano di
norma rifinito le opere sul posto, visto che le lavorazioni tengono sempre conto della collocazione finale
prevista.
Lo studio dell’arredo è molto importante anche perché consente di riflettere sulle modalità espositive delle
sculture, sulle loro associazioni reciproche e in particolare sul fenomeno della reduplicazione, una formula
di attenzione ben attestata fin dalla prima età imperiale che implicava la collocazione di più repliche o
varianti dello stesso modello nello stesso ambiente.
La ricostruzione di contesti e programmi decorativi è dunque fondamentale per capire le ragioni stesse del
favore di cui godevano queste sculture. A Tivoli, per esempio, all’illustrazione del tema del ginnasio
partecipavano due repliche del Discobolo di Mirone e un gruppo eclettico raffigurante Apollo mentre
insegnava a Giacinto proprio il lancio del disco creando così uno stretto legame tematico e forse anche un
vero e proprio racconto, almeno se si tiene conto del collegamento stabilito in età imperiale tra il Discobolo
e Giacinto.
Altro spazio di grande interesse è l’area del Canopo, dove lungo il bacino si trovavano da un lato quattro
cariatidi copie delle korai dell’Eretteo e due sileni canefori da modelli ellenistici e dall’altro tre
personificazioni fluviali, due tipi di amazzoni dal celebre “concorso” di Efeso e le figure di Mercurio e di un
eroe guerriero replicanti il medesimo tipo statuario con attributi variati. Probabilmente l’insistenza sul
tema del doppio, enfatizzato dalla presenza dell’acqua in cui le statue si riflettevano, si collega, oltre
all’amore per la simmetria, anche a un gusto per le figure retoriche e la ridondanza che s’inquadra bene nel
periodo della nascente Seconda Sofistica.
Non erano solo le ville ad accogliere programmi decorativi basati sui “nobilia opera”. Nel corso dell’età
imperiale teatri e ninfei, con le loro facciate scenografiche, ginnasi, terme e biblioteche cominciarono a
ospitare moltissime sculture tratte dallo stesso repertorio di domus e ville e variamente ricombinate tra
loro sfruttando nicchie e porticati.
In particolare nell’arredo scultoreo dei teatri si riconosce un progressivo incremento quantitativo e
qualitativo delle copie. Dopo avere riprodotto un repertorio legato perlopiù al mondo bacchico o al culto
imperiale, nel corso del secolo II d.C. alcuni teatri cominciarono a offrire quasi delle piccole antologie dei
“nobilia opera” più celebri, come Doriforo e amazzoni.
I “nobilia opera” si trovavano in questo caso a fare da contorno, collocati per esempio sul pulpitum o tra le
colonne del fronte scena, come nella fase adrianea del teatro di Corinto. L’ampia presenza di dei ed eroi
potrebbe essere collegata all’importanza assunta dal pantomimo nei ludi. Anche le terme presentavano
arredi scultorei ricchi e ambiziosi, nei quali prevalevano il mondo di Venere per il legame con l’acqua e
quello del ginnasio per la presenza delle palestre; e anche qui non mancavano gli imperatori.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Un caso estremamente interessante di reduplicazione e di attenzione alla scelta della collocazione e
all’appropriatezza del soggetto al contesto è rappresentato da due grandi statue di Ercole in riposo nelle
thermae Antoninianae. La decorazione dell’edificio era caratterizzata proprio dalla colossalità delle sculture
e dal gusto per le iterazioni dei capolavori. La parte più impegnativa dell’arredo scultoreo fu riservata ai
cortili porticati delle palestre segnalandone l’importanza nella gerarchia degli spazi. I due tipi di Ercole
furono affidati a due differenti officine: l’Ercole “farnese”, alto 3.17 m, dipendente da un originale di
Lisippo, firmato dallo scultore Glicone di Atene e ripreso anche in un capitello figurato, e l’Ercole oggi al
piano terreno della Reggia di Caserta, ritenuto derivante da un archetipo tardo ellenistico, in cui la roccia su
cui si appoggia la clava è sostituita dalla testa del toro di Creta. Essi furono collocati esattamente nei due
intercolunni laterali del passaggio tra il frigidarium e la palestra ovest; così le statue mostravano a chi
passava i punti di vista più efficaci, frontale e posteriore, senza indurre gli osservatori a soffermarsi troppo
sui fianchi, ossia il punto più debole degli originali.
13.3 Prassi scultorea
L’importanza attribuita alle copie richiedeva fedeltà nel processo di produzione. Anche un solo errore
poteva costringere all’abbandono di un intero blocco di marmo. Gli scultori ellenistici e imperiali avevano
perciò elaborato metodi affidabili e piuttosto veloci, benché tecnicamente complessi, per ottenere una
copia dell’originale. Il procedimento si basava in primo luogo sul possesso dei calchi degli originali da
copiare, preferiti alle repliche in marmo per la maggiore maneggevolezza, e poi sul riporto dei punti dal
modello alla copia mediante una forma di triangolazione.
Nelle copie i punti di misurazione presi non erano moltissimi, e il resto era affidato all’occhio e all’abilità
dello scultore, anche se calibri e altri strumenti potevano aiutare a rispettare le distanze esatte.
Proprio la libertà di una parte del procedimento faceva quindi sì che le copie fossero di qualità diversa,
facendo anche affiorare, oltre alle capacità personali degli artigiani, gli “stili d’epoca”, riconoscibili anche
nel confronto con la ritrattistica contemporanea e nella lavorazione di panneggi, occhi, sopracciglia e
ciocche.
La copia augustea in marmo del Doriforo di Policleto dimostra che era possibile riformulare un celebre
originale realizzato in bronzo anche in altri materiali, il che comportava comunque diversi adattamenti nel
passaggio da un materiale all’altro e in particolare l’inserimento di sostegno strutturali di fianco ai piedi e
puntelli per esempio tra il corpo e le braccia o i panneggi.
La scultura romana, come quella greca, era policroma. Ciò vale anche per la scultura “ideale” e recenti studi
hanno dimostrato l’importanza del colore come elemento sia di riproduzione dell’aspetto degli originali in
bronzo sia di diversificazione reciproca nelle repliche in marmo.
Stendere i colori sul marmo non era l’unica strategia per ottenere la policromia, poiché si potevano usare i
marmi colorati, scelti anche per la preziosità o per l’elemento di novità così introdotto nella replica di un
originale greco. Spesso la policromia era accentuata dall’utilizzo della tecnica del piecing, con l’esecuzione a
parte di testa, braccia e piedi, realizzati in marmi candidi, contrapposti al colore scuro del marmo bigio
morato usato di solito per il corpo.
Accanto alle copie in scala, esiste una vasta serie di riproduzioni in piccolo formato realizzabili più
liberamente dallo scultore e con meno difficoltà tecniche, il quale vi introduceva spesso varianti rispetto
agli originali. Esse riprendevano comunque opere illustri, come il Discobolo, il satiro in riposo e l’Afrodite
Cnidia di Prassitele e anche celebri statue troppo colossali per potere essere copiate in identiche
dimensioni come l’Atena Parthenos di Fidia.
Queste riproduzioni erano inoltre eseguite anche in materiali pregiati (dal cristallo di rocca all’avorio) di
modo che il loro possesso fosse un simbolo di status e di gusto raffinato offerto soprattutto a un pubblico di
ricchi collezionisti. Altre statuette, di qualità inferiore, erano spesso usate nel culto privato.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
13.4 Copie in pittura e mosaico
La pratica di copiare i capolavori del passato riguardava anche la pittura. Inoltre a Roma collezioni
pubbliche di capolavori di pittura greca non mancavano e neppure le occasioni per predisporre delle copie.
Le notizie sulla presenza concreta a Roma di molti illustri quadri greci hanno fatto quindi pensare che i
programmi decorativi di “III” e “IV stile”, che tra l’età augustea e flavia trasformarono molti ambienti
domestici in finte pinacoteche, con almeno un quadro al centro di ciascuna parete, ospitassero a loro volta
copie di originali, noti grazie ai cartoni circolanti presso le officine dei pittori.
I pittori conducevano spesso anche un complesso lavoro di rivisitazione di iconografie, fatto di citazioni e
mescolanze. Il loro scopo era soprattutto quello di ricreare per lo più mondi mitici ed eroi (greci) fuori dalla
realtà, mentre l’introduzione di varianti nello scenario o l’inserimento e la rimozione delle figure potevano
servire a soddisfare o il gusto delle officine o il bisogno del committente di avere una versione più
personalizzata di un’iconografia nota.
Capitolo 14 – Arti decorative
Il concetto di “arti decorative” è qui usato per comprendere varie categorie di oggetti di marmo e di bronzo
con una predominante funzione ornamentale. Nei secoli II-I a.C. il contatto con i regni ellenistici dà impulso
a un radicale rinnovamento del volto di Roma, ove s’intraprendono ambiziosi progetti edilizi che richiedono
un adeguato arredo, consono al nuovo ruolo assunto dalla città.
Alla crescente magnificenza urbana fa riscontro la penetrazione del lusso negli spazi domestici, che si
manifesta fra l’altro nella consuetudine di decorare le dimore con costosi manufatti. La smisurata
concentrazione nella capitale di beni di lusso dall’oriente stimola negli ottimati il desiderio di emulare il
fasto dei palazzi ellenistici.
Una nave naufragata a largo di Mahdia (Tunisia) intorno all’80-70 a.C. trasportava un carico di ricchezza e
varietà non comuni, comprendente elementi architettonici e opere decorative di marmo, sculture di
marmo e di bronzo, pezzi di antiquariato, fra cui rilievi votivi e iscrizioni d’epoca classica, mobili di marmo e
di bronzo, suppellettile e vasellame di bronzo. La nave, partita dal Pireo, faceva rotta verso il porto
dell’Italia, sicché il carico documenta quali articoli di lusso fossero prodotti dalle officine greche al passaggio
dal secolo II al I a.C. per soddisfare le esigenze della facoltosa clientela romana.
14.1 Manufatti “neoattici”
Nella letteratura specialistica sono etichettate come “neoattiche” alcune classi di manufatti marmorei
d’arredo prodotte in officine altamente qualificate. Il concetto di “neoatticismo” fu introdotto
nell’ottocento per designare una corrente figurativa che, sorta ad Atene intorno alla metà del secolo II a.C.,
prende a modello l’arte attica di epoca classica per la realizzazione di sculture a tutto tondo, altari, basi,
rilievi e opere decorative destinati per lo più al mercato di Roma e dell’Italia centrale.
La fabbricazione di candelabri, vasi, are, rilievi, puteali e trapezofori “neoattici” si avvia alla fine del secolo
II-inizio del I a.C. e raggiunge l’apice in età cesariano-augustea; già nei primi decenni del secolo I d.C. si
registra un calo, cui segue una ripresa nell’età di Adriano; l’interruzione definitiva si colloca fra la seconda
metà del secolo II e l’inizio del III d.C., allorquando si verifica una riconversione produttiva delle officine
ateniesi specializzate in beni di lusso, che da allora si dedicano alla fabbricazione di sarcofagi.
Il repertorio tematico è molto vario ma altamente standardizzato e include divinità, eroti, Horai, Vittorie,
ninfe, personaggi del corteo bacchico, immagini mitologiche, sacerdoti e sacerdotesse, personificazioni,
animali, motivi vegetali.
Gli scultori trascelgono dall’intero patrimonio dell’arte greca tipi iconografici, motivi e forme adeguati al
contenuto della rappresentazione, li reinterpretano e li combinano in composizioni sempre nuove, spesso
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
giustapponendo iconografie e stili appartenenti a epoche diverse.
Caratteristico è il procedimento di tradurre a rilievo celebri archetipi statuari, ovvero di estrapolare dai
contesti originari singole figure per poi riproporle isolate o all’interno di una nuova scena.
Il relitto di Mahdia ha restituito gli esemplari più antichi di candelabri marmorei, che raggiungono
un’altezza di quasi 2 m e constano di tre parti separate e assemblate con perni di ferro:
1. Base a tre lati poggiante su zampe teriomorfe che incorniciano un elaborato ornato vegetale;
2. Fusto scandito da cespi acantini e modanature;
3. Coronamento a forma di bacino baccellato.
La tettonica del monumento, pur conservando la suddivisione nelle tre componenti fondamentali, conosce
nel tempo numerose varianti, indizio dell’invettiva delle officine, che dall’età augustea avviano una
produzione in serie per rispondere alla domanda del mercato enormemente accresciutasi.
Fra gli arredi marmorei più costosi si annoverano, accanto ai candelabri, i vasi istoriati, non di rado con
dimensioni considerevoli. La forma più diffusa è il cratere, a calice o a volute.
I crateri a calice s’impostano su un alto sostegno scanalato; la convessità della vasca alla base del recipiente
è sottolineata da baccellature, le pareti del calice si concludono con un labbro estroflesso, ornato da un
kymation ionico e l’attacco delle anse a ferro di cavallo è segnato da teste barbate di sileno. Sulle pareti si
snoda una decorazione figurata a rilievo, talora delimitata in alto da un tralcio vegetale; in alcuni esemplari
l’intero corpo del vaso è avvinto dall’elastica tensione di girali acantini.
Nei crateri a volute è canonica la tripartizione del corpo, la parte inferiore e la spalla ornate da baccellature
e la zona mediana da un fregio figurato; il collo basso e largo, coronato da un labbro svasato scandito da
kymatia, è impreziosito da un tralcio vegetale e affiancato dalle anse a volute, sorrette da lunghi colli di
cigno.
Il carattere bacchico dei crateri, implicito nella loro funzione originaria e ribadito dalla prevalente tematica
dei fregi, valeva a richiamare l’atmosfera del banchetto e a sacralizzare gli spazi, trasformando un giardino
o una corte a peristilio in un locus amoenus.
Nella categoria dei beni di lusso rientrano anche altari e basi caratterizzati da una ricca decorazione a
rilievo, che li trasforma da oggetti d’uso in manufatti sontuosi, dalla forte valenza ornamentale. In assenza
di iscrizioni o di dati di rinvenimento risulta sovente difficile distinguere fra un altare, votivo o funerario, e
una base: si utilizza in tal caso il termine “ara”, che in latino possiede entrambi i significati.
Indipendentemente dalla funzione, le are si presentano di forma rettangolare o, più spesso, circolare, con il
corpo racchiuso entro modanature alla base e alla sommità e ravvivato da rilievi che si distribuiscono sulle
quattro fasce o si sviluppano intorno al cilindro.
Secolo I a.C. nella fase iniziale le are sono fabbricate in maggioranza nelle stesse officine responsabili
della realizzazione di candelabri, vasi e puteali e si avvalgono del medesimo repertorio figurativo, dominato
da scene bacchiche e da teorie di divinità olimpiche.
Età imperiale la produzione acquisisce una maggiore autonomia e si verifica un mutamento delle
tematiche, che ora si rapportano più specificamente a singole divinità o gruppi di divinità.
Rilievi
A partire dal I secolo a.C. conosce una notevole fioritura nelle officine “neoattiche” la produzione di rilievi
decorativi finalizzati all’arredo di domus e ville dell’aristocrazia. I rilievi hanno dimensioni variabili e sono
spesso circondati da cornici modanate, assumendo così l’aspetto di pregevoli quadri marmorei.
Puteali
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
I manufatti di arredo più diffusi sono le vere di pozzo o di cisterna a forma circolare, che assommano al
valore esornativo una ben precisa funzione pratica. Sotto il profilo strutturale prendono a modello gli altari
circolari affermatisi nel mondo egeo dal tardo secolo III a.C. e constano di uno zoccolo quadrato, un cilindro
con modanature alla base e alla sommità e talvolta una lastra di copertura; l’interno è cavo. Puteali
marmorei sono stati ritrovati in atri e peristili di ville lussuose ma anche in santuari, terme e piazze
pubbliche.
Tavoli e trapezofori
Il carico del relitto di Mahdia comprende alcuni piani di tavolo. In effetti, alla fine del secolo II a.C. tavoli di
marmo, costituiti da un piano rettangolare o circolare poggiante su uno o più sostegni, diventano una
componente essenziale dell’arredo delle domus aristocratiche.
Per la loro realizzazione ci si avvale di un’amplissima gamma di materiali: calcari locali, riservati agli
esemplari più modesti, marmi bianchi, greci e italici, nonché molteplici qualità di marmi policromi greci
microasiatici e africani.
Molto comuni sono i tavoli a tre o quattro supporti a zampa ferina, decorati alla sommità da teste, in
generale di animali, emergenti dal cespo di acanto;
diffusi sono poi i monopodia, il cui piano è sorretto da un unico sostegno centrale, che può essere cilindrico
e scandito da scanalature o a pilastrino, innestato in una base e spesso coronato da un’erma.
Ma il tipo più popolare ed elaborato di sostegno è quello consistente in due lastre sui cui lati brevi sono
modellate figure grottesche, solitamente grifoni, mentre su uno o entrambi i lati lunghi si sviluppa un
ornato vegetale o figurato a rilievo.
I tavoli di marmo sono innanzitutto oggetti utilitaristici e in quanto tali adibiti a differenti funzioni in
contesti sia sacri sia profani. In templi e santuari erano usati nello svolgimento di pratiche cultuali e per
sorreggere le offerte votive; nelle botteghe servivano all’esposizione delle merci; eccezionalmente sono
documentati in piazze pubbliche.
All’interno della casa erano distribuiti in ambienti diversi, dove fungevano principalmente da piano di
appoggio per l’esibizione di vasellame di bronzo, argenterie, vetri.
Avevano inoltre un ruolo nel culto domestico, in connessione con i larari. La fabbricazione su vasta scala di
tavoli marmorei inizia intorno al secolo II a.C. in officine aventi sede ad Atene, il maggior centro di
lavorazione, Delo e Pergamo; in età imperiale Atene conserva la sua posizione egemone, ma nel corso del
secolo I d.C. la produzione si incrementa anche a Roma e in numerose officine centro-italiche.
14.2 Altri manufatti in marmo (e terracotta)
Officine
Vasche, labra, pilastri istoriati, rilievi differenti per forma, dimensioni e contenuto della rappresentazione
sono prodotti in grande quantità in officine localizzate in netta prevalenza a Roma e in area centro-italica.
Marmi
Accanto ai marmi bianchi, a partire dall’età augustea si assiste a un impiego sempre più diffuso di marmi
colorati, favorito dallo sviluppo di un sistema di sfruttamento imperiale delle cave che rende accessibili a un
pubblico più vasto attraenti manufatti in pietre policrome.
Terrecotte
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
L’uso della terracotta, materiale per secoli prediletto in ambiente romano-italico, continua invece per un
genere di lastre architettoniche ornate a rilievo, dette convenzionalmente Campana. Le lastre
componevano fregi destinati a rivestire le pareti esterne o interne di edifici pubblici e privati, funerari ma
soprattutto residenziali, ubicati precipuamente a Roma e in Italia centrale.
Vasche e labra
Dal punto di vista tettonico si distinguono tre tipologie:
1. Vasche di forma oblunga con corpo semicilindrico, concluso da cornici modanate e collocato su
sostegni;
2. Vasche di sagoma allungata, con lati brevi ricurvi e pareti svasate verso l’alto, usualmente ornate da
una coppia di anelli, più di rado da una coppia di teste feline o da gorgòneia;
3. Vasche costituite da un bacino di forma circolare, poco profondo, sorretto da un unico supporto
centrale;
Le vasche dei primi due tipi erano impiegate essenzialmente come bacini di fontane istallate in edifici
pubblici come pure in dimore private, dove concorrevano all’allestimento decorativo di atri, peristili e
giardini, a volte in associazione con vasche circolari.
I labra possedevano invece una più articolata destinazione funzionale, variabile a seconda del contesto
espositivo. Nell’ambito di templi e santuari avevano una funzione votiva oppure lustrale, risultando adibiti a
rituali di purificazione, mentre nelle terme pubbliche e nei bagni privati servivano per abluzioni ed erano
collocati normalmente nel calidarium.
Uno dei labra più antichi è venuto alla luce in una domus alle pendici del Palatino identificata con quella di
M. Emilio Scauro e si data alla metà del secolo I a.C.
In età augustea appare una classe di sostegni decorativi destinata a riscuotere notevole successo. Si tratta
di lesene e pilastrini a sezione rettangolare istoriati con ornati vegetali, che snodano in girali ovvero si
dispongono simmetricamente ai lati di un elemento centrale, formando un motivo detto a candelabro, che
viene codificato dalle paraste finemente cesellate che incorniciano i pannelli esterni dell’ara Pacis.
Nell’ornato domina l’acanto, con cui talora si mescolano la vite, l’edera, l’olivo e altre specie vegetali; non
di rado il fogliame è popolato da animaletti. Pilastri e lesene vegetali s’incontrano sia sulle facciate sia negli
spazi interni di edifici pubblici, come pure in ambito privato, nel campo dell’architettura domestica e
funeraria.
“Oscilla”
Classe di rilievi destinati a una collocazione sospesa, che sono documentati in cinque varianti morfologiche
(circolari, a pelta, rettangolari, a clipeo, a siringa) e mostrano di solito una decorazione scolpita su
entrambe le facce, essendo visibili su ambedue i lati; in alcuni esemplari il lato secondario è liscio e poteva
forse essere dipinto.
Il repertorio figurativo riprende schemi iconografici standardizzati di matrice “neoattica” e appare
riconducibile a due precipui ambiti tematici, la sfera bacchica e il mondo del teatro, evocato dalla frequente
rappresentazione di maschere; ricorrono inoltre scene e motivi “di genere”, nonché immagini di divinità e
personaggi mitologici.
Il loro utilizzo più comune è attestato in ambiente domestico quali componenti dell’arredo di atri colonnati,
peristili e giardini porticati, come vediamo sempre nel peristilio della Casa degli Amorini Dorati, con
“oscilla” circolari, ritmicamente alternati a maschere marmoree, appesi agli architravi in corrispondenza
degli intercolumni.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Rilievi con maschere
Nel peristilio della Casa degli Amorini Dorati sono esposti anche otto rilievi con maschere, quattro montati
su pilastrini, quattro inseriti in una parete del portico. Tale classe gode di una certa fortuna
nell’allestimento dei giardini a peristilio di domus e ville, dove rilievi con maschere potevano anche essere
appesi ad architravi, al pari degli “oscilla”, con i quali sono strettamente imparentati, sicché si ritiene che
fossero lavorati nelle stesse officine.
La composizione si adegua ad uno schema fisso: entro un paesaggio roccioso sono raffigurate due o più
maschere in veduta di tre quarti, rivolte le une verso le altre e attorniate da motivi sussidiari, per lo più
attributi bacchici e strumenti musicali.
Rilievi paesistici
Sui rilievi con maschere compaiono come elementi accessori alberi, rocce, recinti sacri, sacelli, altari,
thymiateria, pilastri votivi, erme di Priapo, ciste e cortine, un ricco campionario di motivi atti a creare
l’atmosfera di un paesaggio “idillico-sacrale”.
Gli stessi motivi ritornano in una classe di rilievi definiti paesistici o bucolici, sui quali un paesaggio naturale
o costruito fa da sfondo alle scene figurate costituendone parte integrante.
Il repertorio tematico privilegia scene di vita campestre, proiettate in un’aura religiosa: pastori con greggi,
vecchi contadini che si recano al mercato, attività eroiche o cultuali ambientate in santuari rurali, animali;
spesso protagonisti delle raffigurazioni sono Bacco o personaggi del suo seguito.
I rilievi sono stati scoperti soprattutto in contesti domestici, dove erano innestati nelle pareti come
quadretti marmorei.
“Rilievi mitologici di lusso”
Si tratta di un numero ridotto di lastre affini per materiale, dimensioni monumentali, formato a rettangolo
allungato, chiuso da cornici modanate, contenuto e funzione, che sono venute alla luce in larga
maggioranza a Roma e dintorni. L’impaginato compositivo delle lastre è contraddistinto dalla collocazione
in primo piano di figure dal vigoroso aggetto plastico, che agiscono sullo sfondo di uno scenario naturale,
fatto di rocce e alberi frondosi, o animato da edifici, per lo più di carattere sacro.
Le lastre, di eccellente livello artistico, s’indirizzano a una clientela colta, in grado di decifrare il contenuto
delle raffigurazioni, in qualche caso identificabile con la stessa famiglia imperiale: un ciclo di rilievi proviene
infatti dal palazzo domizianeo sul Palatino, mentre quelli “Spada” appartenevano probabilmente all’arredo
di una residenza adrianea.
14.3 Manufatti di arredo in bronzo
La conquista dell’Oriente ellenistico determina l’introduzione a Roma di mobili e suppellettili di bronzo, che
cominciano a circolare dagli inizi del secolo I a.C., come testimonia, fra l’altro, il carico del relitto di Mahdia.
Bronzi corinzi
Richiestissimi da intenditori e “collezionisti”, disposti a sborsare cifre esorbitanti per possederli, erano
specialmente i bronzi corinzi, la cui lega peculiare sarebbe stata creata dalla casuale mescolanza del bronzo
con l’oro e l’argento in occasione della distruzione di Corinto nel 146 a.C.
Le officine bronzistiche avevano sede dapprima ad Atene e in alcune isole dell’Egeo, in particolare a Delo;
verso la metà del secolo I a.C. alcune succursali s’impiantano a Roma e in Italia.
Letti tricliniari
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Una componente irrinunciabile dell’arrendamento del triclinio erano i letti, la cui struttura portante di
legno era formata dalle zampe tornite, dal telaio e da una sorta di spalliera (fulcrum), che poteva essere
reduplicata su entrambe le sponde. Sul telaio e sui fulcra venivano applicate lastrine di bronzo decorate ad
agemina, un intarsio di laminette di argento e rame sapientemente connesse a comporre motivi
ornamentali e figurati.
La produzione di letti tricliniari di bronzo s’interrompe nel secolo III d.C.; ampiamente apprezzati in Italia e
nelle province, i letti erano fabbricati in officine al cui interno lavoravano differenti specialisti: falegnami,
bronzisti, cesellatori.
Tavoli
Numerose pitture parietali con scene di banchetto illustrano la consuetudine di collocare davanti a ogni
letto tricliniare un tavolino a tre zampe che sostiene il vasellame da mensa; al centro era posto un tavolo
più grande per l’appoggio dei piatti da portata. Negli esemplari più semplici il piano circolare del tavolo è
retto da zampe ferine, ma col tempo i sostegni assumono conformazioni sempre più ricche e complesse,
frutto dell’inventiva e della mirabile perizia tecnica degli artigiani.
Suppellettili per l’illuminazione
Nelle dimore aristocratiche è comune la presenza di candelabri in bronzo, che constano di tre elementi: una
base a tre piedi ferini, un lungo fusto liscio o scanalato, un coronamento per lo più a calice, culminante in
un piattello finalizzato al sostegno delle lucerne.
La massima espressione del lusso è rappresentata dai lychnouchoi, porta lucerne con le sembianze di
eleganti giovanetti, stringenti nelle mani tralci di vite muniti di perni per l’innesto delle lampade.
Capitolo 15 – Arti suntuarie
Secondo Plinio il Vecchio fu l’Asia sconfitta che per prima introdusse il lusso in Italia: nel suo trionfo su
Antioco III di Siria, del 189 a.C., L. Cornelio Scipione Asiatico fece sfilare a Roma 1400 libbre di vasellame in
argento cesellato e una quantità ancora maggiore in oro.
Alla metà del secolo II a.C. gli incontri tra i Romani e i prodotti di lusso provenienti dal Mediterraneo
s’intensificarono a tal punto da determinare un drastico cambiamento nelle abitudini e nello stile di vita
degli ordini più alti e poi più in generale dei cittadini benestanti.
I trionfi e le conquiste che seguirono per tutto il secolo II a.C. sono tutti episodi che contribuirono alla
formulazione di un nuovo e diverso atteggiamento del cittadino romano verso il lusso.
La condanna morale del lusso
I termini latini luxus/luxuria hanno origini rurali e indicano la vegetazione spontanea, che non dà frutti e
cresce in modo indisciplinato, tanto da compromettere il raccolto. Negli scrittori della tarda Repubblica il
disprezzo per questa “erbaccia” si trasmette alla luxuria, intesa come amore per il lusso. La passione per gli
arredi, le suppellettili, i monili preziosi e la ricerca di uno stile di vita opulento diventarono il bersaglio di
una severa condanna, che non tardò a individuare nel rifiuto del tradizionale sistema di valori basato sul
mos maiorum l’inizio della decadenza di Roma. Della luxuria si criticavano soprattutto la mancanza di
misura e l’assenza di produttività.
I testi ci dicono che dall’età repubblicana e fino al Tardoantico la condanna verso il lusso rimase pressoché
unanime e che, per prevenire i pericoli di uno stile di vita estraneo agli usi romani, si giunse ad inasprire i
divieti contro ogni forma di eccesso.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Che cosa si intende con arti suntuarie? “arti suntuarie” è una locuzione dai limiti estremamente fluidi,
cui appartengono molti oggetti marmorei e bronzei già incontrati nel capitolo precedente; qui si parlerà di
alcune categorie di manufatti in materiali preziosi sinora poco discussi e spesso rubricati sotto le “arti
minori”, una definizione non adeguata per l’eccellenza e per i livelli della fruizione, talvolta limitata a
cerchie ristrette.
15.1 Argenti
Se al principio del secolo III a.C. si poteva essere espulsi dal senato per il solo fatto di possedere più di 10
libbre di argento, i numerosi “tesori” di argenterie dalle città vesuviane dimostrano che la tarda Repubblica
e la prima età imperiale la disponibilità di oggetti in argento aveva raggiunto, anche nei centri minori,
considerevoli proporzioni: il “tesoro” recuperato nella Villa della Pisanella presso Boscoreale, che
comprende un servizio da mensa completo, pesa 30 chili e quello della Casa del Menandro a Pompei,
trovato ancora impilato in una cassa di legno in un ambiente sotterraneo della domus, è composto di ben
centodiciotto argenterie da tavola per un totale di 24 chili.
L’apparecchiatura del banchetto era parte essenziale di uno stile di vita divenuto, dopo le campagne in
Oriente, sempre più sofisticato, al punto che per tutta l’età imperiale la maggior parte degli oggetti in
argento venne destinata all’arredo della tavola, sotto forma di vasellame per bevande e cibo.
Ben documentato è poi l’uso dell’argento per gli oggetti della toeletta personale come specchi, spilloni,
cofanetti e contenitori porta-profumi.
Le argenterie erano una diffusa forma di tesaurizzazione. Il peso, espresso in libbre, è spesso inciso sui
singoli oggetti e nel caso dei servizi da tavola è indicato il suo totale.
I grandi piatti da parata tardoantichi, distribuiti dagli imperatori agli ufficiali e ai funzionari di alto rango in
occasione di particolari anniversari del regno e noti come missoria o “piatti di largizione”, avevano un peso
fisso, corrispondente alla libbra e ai suoi multipli, che ne faceva dei sostituti ai donativi in denaro.
Fin dalla tarda Repubblica si scatenò una vera e propria caccia alle opere firmate da cesellatori rinomati e
con un pedigree eccezionale. Su quattro coppe dalla Casa del Menandro le firme in greco di Apelle
intendevano evocare il nome di un celebre artista del passato, ma la differenza stilistica e tecnica tra gli
esemplari fa pensare a delle firme false, aggiunte per accrescere il valore commerciale dei pezzi.
Attestata anche dalle fonti è la pratica di recuperare rilievi di antica fattura per inserirli come medaglioni
(emblemata) al centro di coppe o piatti.
Argenti come doni diplomatici
Due tazze di età augustea trovate nel corredo di una tomba principesca a Hoby, nell’isola di Laaland in
Danimarca, sono probabili doni per un capo locale, secondo una pratica ben documentata anche da Tacito.
L’uso del vasellame in argento come donativo per i capi barbari è attestato anche da una coppa di età
augustea trovata a Meroe, in Sudan, nella piramide del re Amanikhabale, decorata con un’inconsueta scena
di processo civile presieduto dallo stesso Augusto, mentre tutti i personaggi indossano abiti romani.
La preferenza per i temi mitologici
Diffusissimi nell’argenteria, come più in generale nell’imagerie domestica, sono i riferimenti a Bacco e al
suo corteggio di satiri e baccanti, maschere teatrali e strumenti musicali, che esaltano le virtù del vino e dei
piaceri del banchetto. Eccezionali sono invece, tra gli argenti, le due tazze dal “tesoro” di Boscoreale con
soggetti legati alle imprese di Augusto e del giovane Tiberio.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Le conoscenze sull’argenteria romana si basano essenzialmente sui rinvenimenti delle aree vesuviane
(perlopiù argenteria da mensa), che comprendono oggetti databili fino all’età flavia, e sui ritrovamenti
occasionali dei “tesori” occultati, soprattutto nelle aree di confine (argenti vari), a partire dalla seconda
metà del secolo III d.C., quando più concreta divenne la minaccia di invasioni barbariche, e gli equilibri
politici si fecero più instabili.
Tesoro di Marengo
Esso ha restituito un gruppo di argenti diverso dal solito: manca del tutto il vasellame da mensa, e almeno
parte dei pezzi sembra provenire dall’arredo di un sacello per il culto imperiale, come suggerisce anche un
busto in argento, a grandezza naturale, di Lucio Vero.
Nel caso di occultamento al principio del secolo V d.C. le condizioni e la natura dei rinvenimenti, malamente
schiacciati e spezzati per essere fusi, possono spiegarsi con un tardo episodio di distruzione e saccheggio di
un santuario imperiale.
La maggior parte dei “tesori” sepolti a partire dal secolo III d.C. proviene dalla Gallia, una delle regioni più
colpite dalle invasioni barbariche.
Quanto alla tecnica di fabbricazione, va segnalato il progressivo rarefarsi, alla fine del secolo IV d.C., della
fusione a stampo entro matrici, a vantaggio di una ripresa della lavorazione a sbalzo e a incisione, frequente
fino a tutto il secolo I d.C. ma caduta in disuso nei secoli centrali dell’impero.
Tipiche della toreutica tardoantica sono anche la decorazione a niello, un solfuro d’argento di colore nero
inserito all’interno di incassi appositamente predisposti, così da creare una decorazione a intarsio, e la
doratura “a fuoco”, ottenuta spalmando un amalgama di oro fuso e mercurio, che tende a sostituire quella
“a foglia”, in cui una sottile foglia d’oro veniva fissata all’argento tramite martellatura.
15.2 Avori
Per l’enorme valore di mercato e per le difficoltà di approvvigionamento della materia prima questo fu un
bene di lusso tra i più ricercati, tanto che nel Tardoantico il suo uso fu riservato, per legge, all’imperatore e
ai dignitari più importanti.
L’avorio giungeva a Roma soprattutto dall’Africa, ma già in età augustea venivano sfruttate anche le risorse
provenienti dall’India.
Per soddisfare la continua richiesta di manufatti in avorio, gli intagliatori specializzati facevano ricorso a
diversi surrogati, come le ossa di grandi mammiferi, i denti di ippopotamo, di cinghiale o di tricheco.
Il principale centro di lavorazione nel Mediterraneo era Alessandria d’Egitto, e alle officine alessandrine o a
maestranze egiziane vanno ricondotte alcune classi di materiali, con motivi decorativi tipici già del
repertorio tolemaico, come le tessere da gioco in avorio, trovate a Pompei e in altre aree della penisola, in
Grecia, in Asia Minore e a nord delle Alpi, che adattano al ristretto campo circolare scene nilotiche, figure
grottesche o di divinità alessandrine.
S’ispirano a modelli del mondo ellenistico i letti, rivestiti in avorio e diffusi prima in Italia centrale e poi in
Italia settentrionale e nelle province soprattutto tra il secolo II a.C. e la metà del secolo I d.C.
Essi riprendono, tanto nella tipologia quanto nei motivi figurativi di prevalente carattere bacchico.
Molto più diffuse e ben documentate archeologicamente sono le imitazioni in osso, per una clientela meno
abbiente ma ugualmente desiderosa di sfarzo. Gli studiosi hanno individuato due principali tipologie di letti
in osso
1. Il tipo con gli elementi della spalliera decorati a bassorilievo e con le gambe rivestite da elementi
cilindrici alti e slanciati deriva probabilmente da modelli in avorio: gli esemplari di questa categoria
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
sono diffusi in tutto l’Impero, dal Mar Nero all’area germanica, e provengono sia da contesti
abitativi che da sepolture.
2. Un secondo tipo, con gli elementi del fulcrum decorati ad altorilievo e le gambe caratterizzate da
torniture più tozze e massicce, potrebbe, invece, derivare da modelli in bronzo: si tratta di letti a
destinazione funeraria, attestati di rado fuori dall’Italia e provenienti soprattutto dall’area centrale
della penisola. Lo stile sommario e corsivo dei rilievi, affiancati in modo ripetitivo e persino
monotono, ha suggerito una possibile produzione centro-italica che rielabora in forme più
semplificate e autonome i modelli ellenistici.
Bambole da corredi funerari
Nel resto dell’Impero, la documentazione di oggetti in avorio resta piuttosto sporadica per tutti i secoli II e
III d.C., a parte statue e statuette “ideali” e iconiche di vario genere.
Di grande interesse sono le bambole in avorio attribuite a officine egiziane e scoperte in alcuni corredi
funerari soprattutto a Roma e dintorni.
Dittici e avori tardoantichi
Dalla metà del secolo IV d.C. la fortuna dell’avorio riesplose nei dittici per membri della famiglia imperiale e
dignitari di alto rango.
La tavola in cinque lastre, denominata “Barberini”, della prima metà del secolo VI d.C., raffigura un
imperatore loricato (Giustiniano?) su un cavallo rampante mentre viene incoronato da una Vittoria.
Le immagini rappresentate sulla tavola sono pertinenti a una tradizione consolidata a esaltazione
dell’imperatore trionfante, che qui si associano a simbologie cristiane: il trionfo dell’imperatore avviene
sotto la benedizione di un Cristo imberbe entro clipeo sorretto da Vittorie, nel quale s’inscrivono i segni
cosmici del sole, della luna e di una stella: gli unici personaggi raffigurati in modo frontale e intagliati con
cura raffinata sono Cristo e, ovviamente, l’imperatore.
15.3 Gemme e cammei
Con le conquiste romane in Oriente arrivarono a Roma anche intere “collezioni” di pietre preziose,
intagliate in materiali rari provenienti dalla penisola arabica (topazio), dall’India (sardonica, ametista,
berillo), dall’Egitto (diamante, diaspro, smeraldo).
L’arte di intagliare le pietre in negativo, nelle gemme, o a rilievo, nei cammei, e cioè la glittica, si avvalse
delle maestranze specializzate giunte a Roma dall’Asia Minore e dall’Egitto al seguito dei conquistatori.
Dall’età augustea le rotte marittime tra l’Egitto e l’India si fecero più intense, così da garantire un più facile
approvvigionamento di materie prime.
Le gemme venivano poi incise anche con varie immagini di modo che a costituire il pregio fosse ora l’arte,
ora il materiale; e il valore più alto era dato ai diamanti, alle perle dell’India e dell’Arabia, agli smeraldi, agli
opali e alle sardoniche. Ma non erano questi i soli usi delle gemme.
Persino le pareti delle dimore di alto livello potevano essere fastosamente ornate di gemme.
Uno dei principali centri di produzione e di smistamento di gemme e cammei fu Aquileia, dove gli scavi
dell’abitato hanno restituito eccezionali quantità di pietre semilavorate e blocchi ancora grezzi.
Gli influssi stilistici e le tecniche tipiche dell’arte ellenistica giungevano qui attraverso l’Adriatico, ma le
officine glittiche dovettero presto diffondersi in tutto l’Impero, anche in centri minori come Pompei.
Le gemme romane derivarono dal mondo ellenistico la funzione principale di sigilli personali. A imitazione
dei dinasti orientali anche gli alti magistrati romani e gli imperatori facevano incidere in anelli-sigillo il
proprio ritratto o i simboli del potere.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Oltre ai ritratti e ai segni politici, l’ampio repertorio tematico, con differenti intensità a seconda dei periodi,
prevede, scene di miti greci e saghe “romane” (come la fuga di Enea da Troia), singoli eroi e divinità, eroti e
personaggi del corteo bacchico o marino, temi legati alla paideìa (filosofi), scene pastorali ed erotiche.
Alcune gemme con figure di origine orientale ed “egittizzanti” e iscrizioni che si confrontano con i testi
magici dei papiri egiziani erano poi utilizzate come amuleti: erano incise per essere viste direttamente in
positivo e non, come avviene di solito, in negativo. Il principale centro di produzione delle gemme magiche
era probabilmente Alessandria.
Cammei
A differenza delle gemme incise, i cammei solo di rado vennero usati come sigilli personali, e perciò il loro
ritrovamento in contesti funerari, come simbolo di riconoscimento dei defunti, è poco documentato.
Ottenuti, in prevalenza, con la lavorazione di pietre policrome o zonate, e cioè costituite da strati di diversa
composizione e tonalità come la sardonica, l’agata, l’onice, il calcedonio, i cammei richiedevano una tecnica
di esecuzione più difficile e costosa dell’intaglio: l’abilità dell’artefice consisteva, oltre che nella raffinatezza
del rilievo, anche nella capacità di sfruttare i diversi strati di colore per ottenere contrasti cromatici che
evidenziano i dettagli, facendo emergere dal fondo le figure.
In età giulio-claudia, i cammei furono intesi come creazioni di particolare prestigio, non più destinate a un
pubblico generico ma riservate all’ambito della corte e di una ristretta élite.
“Cammei di Stato” pietre di dimensioni talvolta eccezionali decorate con complessi temi politici, tra cui
quello della continuità dinastica.
Il tema della legittimazione dell’erede al trono è centrale nei due maggiori “cammei di Stato”. Già si è
parlato della “Gemma Augustea”, un’onice a due strati attribuita all’officina di Dioscuride (cap.10).
Nel “Gran cammeo di Francia”, ricavato da una sardonica indiana a cinque strati e di dimensioni mai più
superate (31x26.5 cm), il messaggio è molto più complesso, tanto più che risulta non esente da dubbi il
riconoscimento dei singoli personaggi.
La scena si distribuisce su tre registri.
• In quello inferiore, come nella “Gemma Augustea”, si concentrano barbari sconfitti e trofei militari,
simbolo del dominio militare romano;
• In quello centrale sono probabilmente ritratti i membri viventi della famiglia di Tiberio;
• Quello superiore è riservato alla sfera celeste e agli antenati defunti: tra questi è ben individuabile il
divo Augusto, con corona radiata e scettro.
Per la delicatezza dell’intaglio e la preziosità della pietra i cammei non dovevano essere esposti al pubblico,
ma conservati come oggetti “da camera” all’interno dei palazzi.
Cammei come gioielli
Dopo il regno di Caracalla la committenza dei grandi “cammei di Stato” si riduce drasticamente, fino a
scomparire, ma per tutto il secolo III d.C. si registra l’improvvisa fortuna di una produzione minore di
carattere seriale, standardizzata nei motivi figurativi e di fattura più sommaria. I cammei furono ora
utilizzati soprattutto come gioielli, di preferenza come orecchini e pendenti, e i temi preferiti erano quelli
più adatti a un pubblico femminile, come le dee, le personificazioni beneauguranti, gli eroti e le teste
femminili ispirate ai ritratti delle principesse.
15.4 Le ambre
Nella graduatoria degli oggetti di lusso l’ambra si collocava subito dopo i vasi di cristallo di rocca, amatissimi
dai Romani.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Siccome l’ambra non aveva alcuna funzione pratica, il suo utilizzo venne condannato con tanta durezza: il
prezzo davvero esagerato raggiunto dall’ambra, tanto che una statuetta si scambiava con due o tre schiavi
in buona salute, scandalizzava Plinio il Vecchio non meno dell’inutile attività estrattiva della materia prima,
che comprometteva gli equilibri della natura al solo scopo di procurare un godimento temporaneo fine a se
stesso.
L’ambra è una resina fossile che ha origine dalla secrezione di piante ad alto fusto, simili al pino, ormai
estinte. Da Ercolano e Pompei provengono pezzi di ambra grezza o oggetti semilavorati che attestano
l’attività di intagliatori locali, probabilmente da identificare negli stessi gemmarii incisori delle gemme e
delle pietre dure.
Oltre all’ambra baltica le officine campane si avvalevano anche di quella siciliana, una rara varietà presente
presso la foce del fiume Simeto e per questo nota come simetite.
15.5 Un patrimonio figurativo comune
la circolazione degli artigiani, ‘esistenza di album di disegni e le facili condizioni di trasporto degli oggetti di
lusso favorirono anche la diffusione degli schemi figurativi, che si trasmettevano identici non solo
all’interno di una stessa classe di manufatti, ma anche di altri oggetti.
Le scoperte, nel sito dell’antica Memfi in Egitto e a Begram, in Afghanistan, di numerosi calchi in gesso
ricavati, per lo più, da prodotti della toreutica ellenistica, confermano l’uso e l’ampia circolazione di
intermediari tecnici, come matrici, “cartoni” e appunto gessi, utilizzati come campionari per la clientela e
come modelli per copie e adattamenti anche in materiali come oro, argento pietre dure, marmo.
Proprio il commercio di matrici e calchi in gesso di manufatti toreutici fu uno dei principali vettori di
trasmissione delle iconografie, adattabili a vari soggetti anche quando identiche.
Capitolo 16 – La ceramica
Rispetto a vetro, metalli, marmo e a tutti gli artefatti in materiali deperibili o volatili, la ceramica non si
altera, non si degrada, non è riciclabile e, alla fine del suo ciclo di vita, è una presenza costante in qualsiasi
contesto di ritrovamento. La sua indistruttibilità fa sì che il vasellame da mensa, da dispensa, da cucina
suppellettile da illuminazione, anfore da trasporto e gli altri numerosi utensili e arredi fittili, siano, in
quanto prodotti (valori d’uso) e merci (valori di scambio), tra i pochi “originali” della vita economica
trasmessi dall’Antichità.
Gli studi da fine Ottocento-inizio Novecento hanno in prevalenza interessato le ceramiche fini da mensa, le
lucerne o le suppellettili con qualche valenza decorativa, frutto di un artigianato mirante anche a una certa
qualità. Dovendo rispondere ai continui cambiamenti del gusto degli acquirenti, questo tipo di vasellame
evolve rapidamente sul piano tecnologico, morfologico, formale e decorativo, consentendo di collocare le
singole produzioni con precisione nel tempo e nello spazio.
Altra presenza ricorrente è la presenza di bolli e graffiti che danno conto dei centri di produzione e degli
operatori a vario titolo impegnati nella manifattura e della loro condizione sociale.
Più conservatrici sul piano della tipologia sono le “ceramiche comuni”, normalmente sprovviste di
decorazioni, di rivestimenti, in sostanza prive di qualità estetiche.
Rispondendo a usi pratici, come quelli del contenere, del versare, del conservare, del cuocere, questo tipo
di vasellame è stato generalmente attribuito, nei diversi luoghi di ritrovamento, a officine “locali”.
Le anfore
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Le anfore offrono un’importante testimonianza dell’avvenuto trasporto prevalentemente marittimo o
fluviale di generi alimentari di prima necessità e della capacità di alcune zone del Mediterraneo di attivare
un’agricoltura e un’industria conserviera rivolte ai mercati.
I relitti hanno permesso di ricostruire le rotte più frequentate; le stratigrafie di molte città hanno fornito
indicazioni sulle qualità e sulle quantità dei consumi di determinate merci secondo precise periodizzazioni;
le fornaci in Italia e nelle province hanno dato un’idea delle potenzialità delle campagne e degli impianti dei
derivati della pesca di creare un surplus destinato all’esportazione, mentre i bolli, i graffiti, le iscrizioni
dipinte hanno consentito di identificare alcuni dei protagonisti della catena che dalla produzione dei beni
raggiungeva i luoghi del consumo.
Che cos’è la ceramica romana?
“Romanizzazione”, acculturazione, assimilazione sono i termini che indicano i modi con i quali Roma ha
imposto, con la forza e con l’emulazione, ad altri mondi e ad altre culture, un sistema di vita e valori; ma usi
e costumi romani si sono mescolati e integrati con quelli di altri popoli in possesso di ben consolidate
tradizioni ceramiche, dagli Etruschi nell’Italia centrale ai Greci nell’Italia meridionale, ai Punici della Sicilia e
dell’Africa settentrionale, ai Celti a nord delle Alpi. Esiste perciò una ceramica di Roma-città e una ceramica
romana, in cui l’aggettivo indica forme e classi nuove introdotte in seguito a commerci o conquiste, in
contrasto con le ceramiche di origine locale. Più banalmente, il termine, se assunto in senso descrittivo,
designa la ceramica di datazione romana.
16.1 L’età arcaica e la prima età repubblicana (secoli VI-V a.C.)
Una notizia attribuisce a Numa l’istituzione delle prime associazioni professionali di artefici e operai
secondo una precisa gerarchia (flautisti, orafi, falegnami, tintori, cuoiai, conciatori, fabbri, vasai, più un
ultimo corpo ospitante le arti rimanenti).
Nel clima di fervida creatività, con movimento di oggetti e maestranze, confluiscono esperienze greche sia
dirette (anche mediante l’importazione di prodotti di pregio quali la ceramica corinzia e attica) sia mediate
dal mondo etrusco confinante. Tra i ritrovamenti la stragrande maggioranza delle centinaia di migliaia di
manufatti riportati in luce negli scavi urbani è certamente di produzione “locale”: dal vasellame in impasto
grezzo, in impasto chiaro sabbioso e in argilla figulina, al vasellame fine (bucchero romano, vernice nera),
dagli utensili (pesi da telaio) alla suppellettile domestica (bacili, bruciaprofumi) e alla variegata serie di
oggetti dedicati nei santuari e nelle tombe.
16.2 L’età mediorepubblicana (secoli IV-III a.C.)
Sotto il profilo artigianale e artistico esistono in questi due secoli alcune discontinuità. Il nostro punto di
osservazione è costituito dalla ceramica fine da mensa, ora rappresentata da vasellame ricoperto da
vernice nera (ceramica da simposio per eccellenza, un prodotto di medio lusso).
1. La data di un primo fondamentale cambiamento coincide con gli ultimi anni del secolo IV e si
collega alla fine dell’esportazione massiccia della ceramica attica in Occidente e alla diffusione di
vasellame a vernice nera non originario dal Mediterraneo orientale.
2. Una seconda cesura si verifica verso la metà del secolo III a.C., dopo la prima guerra punica, quando
si assiste a un ripiegamento su se stesse delle zone produttive di ceramica a vernice nera, con una
proliferazione di officine anche di qualità, ma dai circuiti commerciali abbastanza ristretti.
3. Gli anni dopo la seconda guerra punica registrano una terza rottura, riflessa nell’esplosione della
“Campana A” di Neapolis, città greca alleata di Roma fin dal 326 a.C.
Rispetto al passato, il secolo IV a.C. presenta anche a livello ceramologico un salto di qualità con la nascita a
Roma di officine di ceramica fine nella tradizione della ceramica a figure rosse, e nella tradizione della
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
ceramica attica a vernice nera, progressivamente assente dai mercati.
L’unica ceramica fine largamente esportata al di fuori dell’Italia è prodotta dall’officina o meglio da un
insieme di officine note sotto il nome di “Gruppo dei Piccoli Stampigli”.
I prodotti sono soprattutto forme aperte rivestite da una vernice nera, lucida, brillante e caratterizzate sul
fondo da piccoli bolli (stampigli) all’inizio molto elaborati (palmette, rosette, più di rado elementi figurati).
Alle stesse officine sono attribuiti anche i “pocola deorum”: coppe, piatti o brocche, sui quali è sovradipinta
la dedica a una divinità (seguita dalla parola pocolom, vaso) o con eventuale apposizione in bianco, in giallo,
in rosso di una decorazione figurata.
“Coppa di Eracle”
Ai decenni dopo la metà del secolo III a.C. si assegna la produzione delle “Heraklesschalen”: in tale
categoria rientrano vasi di forme diverse, sempre a vernice nera, che portano impresso sul fondo un bollo
raffigurante Eracle, e coppe ugualmente a vernice nera, a di qualità mediocre, che hanno sul fondo una “H”,
anch’esse da collegate al culto dell’eroe-dio.
16.3 La tarda Repubblica (secoli II-I a.C.)
Dopo il 200 a.C. dobbiamo lasciare Roma, perché è la ceramica a vernice nera di Neapolis (“Campana A”) e
quella dell’Etruria di Cales (“Campana B”) a diffondere quantità enormi di vasellame da mensa in Gallia, in
Spagna, nel Nord-Africa, e – con circuiti più ridotti e volumi più contenuti – quella della Sicilia (“Campana C”
da Siracusa e dintorni).
“Campana A”
Le officine localizzate a Neapolis conoscono un’esplosione produttiva dopo la seconda guerra punica. Il
salto impressionante di scala si unisce alla nascita di forme diverse da quelle adottate in passato e
all’assoluta standardizzazione del vasellame, con una ripetizione monotona e quasi obbligata di forme e
schemi decorativi.
“Campana B”
Dagli inizi del secolo II a.C. la “Campana B” è prodotta in Etruria, a Cales e in una certa quantità di imitazioni
(“B-oidi”) che denotano il successo del vasellame a pasta calcarea e con vernice nera o bluastra, brillante;
una produzione che tende a imporsi sui mercati italici e transmarini.
I vasi “a pareti sottili”, così chiamati per la sottigliezza del corpo ceramico, sono attestati dagli inizi
del secolo II a.C. nell’Italia centrale tirrenica e si distingue per forme lontane dalla tradizione ellenistica.
Gli antecedenti vanno cercati nei vasi per bere dell’Italia settentrionale preromana e della Gallia, mentre il
tipo più basso e panciuto ricorda vasi analoghi a vernice nera dell’Etruria.
Roma conserva ancora un ruolo a livello sia di esportazione degli oggetti sia di modelli nella produzione
delle lucerne. Si tratta del tipo chiamato “biconico dell’Esquilino” dal luogo di ritrovamento, realizzato al
tornio, con corpo biconico e becco allungato con estremità rettilinea, verniciato di nero, generalmente
privo di anse o con piccole prese laterali, il primo ad essere fabbricato nell’Italia centrale, nel Lazio e a
Roma. Coevo è un altro tipo con corpo cilindrico o globulare con le medesime caratteristiche del becco e
con prese laterali in “Campana A”.
Il ritardo con cui l’Italia centrale inizia a utilizzare le lucerne per l’illuminazione (e quindi l’olio d’oliva come
mezzo) rispetto al mondo greco, ove esse erano già presenti dal secolo VII a.C., si spiega con la presenza di
fonti alternative, come il sego, la cera d’api e il legno per fabbricare torce e con la volontà di non disperdere
un bene prezioso per l’alimentazione come l’olio.
16.4 L’età augustea e la prima e media età imperiale
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Nell’età augustea le province esportano verso il centro, in contrasto con il “miracolo economico” del
periodo precedente = emancipazione delle province rispetto al centro sia nella produzione che nello
sviluppo tecnologico.
Dall’età antoniniana sino alla fine del secolo V d.C. l’Italia non produrrà, se non per uso locale o regionale,
ceramica fine, sostituita sui mercati dalle sigillate galliche, orientali e, infine, africane, così come olio e vino
solo per autoconsumo.
La “rivoluzione” implica anche la “globalizzazione” della domanda e dell’offerta: la città riceve i beni più
preziosi del mondo intero, dall’India, dall’Arabia Felice, da Babilonia. È l’Urbe a distribuire ricchezza e
opulenza negli aurei anni degli Antonini, tempi in cui nessuno poteva prevedere a quale epilogo sarebbe
andato incontro quel mondo, poiché – nelle conquiste e nella floridezza – oltre non era possibile spingersi.
Ostia diventa con Claudio e poi con Traiano il porto di Roma. All’asse Puteoli/Alessandria, lungo il quale si
era orientato il traffico marittimo repubblicano, subentra quello Roma/Cartagine, riflesso dall’emergere di
forze incentrate su un modello diverso di produzione (famiglie di coloni su grandi latifondi; agricoltura
estensiva e promiscua, volta a produrre grandi quantità di mercanzie di derrate per il mercato e per la
domanda fuori del mercato; qualità sostituita dalla quantità). Un modello pervasivo che si generalizza,
omologando le più diverse realtà, tra le quali l’Italia stessa. Diventa così possibile parlare di
“meridionalizzazione”, ossia dello spostamento delle forze produttive e commerciali da un blocco
geografico (Spagna, Italia, Gallia) a un altro (Africa settentrionale).
La terra sigillata italica: prima (relativa) novità
L’età augustea e protoimperiale sono dominate da una classe di vasi che dall’uso di punzoni per la sua
decorazione prende il nome di terra sigillata italica, caratterizzata da un repertorio morfologico originale e
da una brillante vernice rosso-corallina.
La vernice rossa non è una novità, in quanto altri centri del Mediterraneo avevano già sperimentato
tecnologie capaci di restituire a cottura un rivestimento di questo colore.
Seconda novità
Scompaiono quasi tutti i centri che avevano realizzato ceramica a vernice nera. Solo per Arezzo è possibile
provare il passaggio dalle vernici nere a quelle rosse (sigillata aretina o arretina).
Le officine, tutte urbane e concentrate in poche aree e con una produzione destinata a una massiccia
esportazione, consistono nei casi di maggiore successo in stabilimenti medio-grandi, con elevato numero di
lavoranti e alto grado di specializzazione nella suddivisione dei compiti.
Per prime nascono le forme lisce. Le decorazioni nella produzione liscia sono ad appliques (piccoli rilievi in
argilla modellata) con motivi vegetali, animali, mitologici sull’orlo, o “à la barbotine”. In età augustea inizia
la produzione di calici, coppe su alto piede, bicchieri decorati a matrice: una controforma contiene sulle
pareti interne in negativo, tratti da punzoni singoli, i motivi figurati e ornamentali che si traferiscono a
rilievo all’esterno del vaso nella fase della modellazione al tornio.
In seguito, l’impiego in Italia di matrici nella fabbricazione dei vasi era quasi del tutto scomparso, mentre in
altri ambienti la possibilità di riprodurre in migliaia di esemplari lo stesso manufatto, unita a quella di
valorizzare il prodotto con decorazioni raffinate a imitazione del vasellame in metallo, ne aveva
determinato il successo.
La sigillata aretina e i temi
A eccezione della lupa con i gemelli e le corse circensi, i cicli figurati sono in gran parte mitologici, di volta in
volta confrontati nella storia degli studi con opere di artisti tardoclassici, con la toreutica attica del secolo IV
a.C. e persino con la pittura.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Intorno al 60 d.C. la produzione in alcune aree prosegue con la sigillata tardo-italica liscia, ma il repertorio
morfologico si restringe a un numero ridotto di tipi, la bollatura è meno attestata, la qualità delle vernici e
degli impasti è talvolta modesta e le decorazioni sono in genere “à la barbotine” o a rilievo applicato. La
produzione a matrice riprende solo dopo l’80 d.C. (sigillata tardo-italica decorata), assumendo dal
repertorio della Gallia Meridionale (sigillata sud-gallica) un tipo di grande coppa carenata e un secondo tipo
di grande coppa emisferica e modificando i suoi registri decorativi a imitazione di quest’ultima classe: fregi
a festone, ad arcate, a metope, sotto e dentro i quali compaiono soggetti figurati e non, ricavati da punzoni
spesso ripetuti più volte e affastellati prescindendo dal loro valore semantico. Il decoro è sciatto, e i bolli
sono apposti sul fondo del vaso in planta pedis o in una mezza luna, più raramente sulle parti esterne.
La diffusione è unicamente marittima. La fine della produzione intorno alla metà del secolo II d.C. è stata
spiegata con la “concorrenza” delle classi ceramiche provinciali. Eppure, il crollo non riguarda solo le
sigillate, ma anche altre classi di materiale e si accompagna nella seconda metà del secolo II d.C. alla
scomparsa dai contesti mediterranei dei prodotti dell’agricoltura intensiva sviluppatasi nell’Italia centrale
tirrenica a partire dalla tarda Repubblica.
Bicchieri, boccalini, piccole coppe, tazze in età augustea assumono forme di derivazione metallica e
decorazioni “à la barbotine” con motivi eleganti e raffinati, incisioni a rotella e a pettine, costolature, decori
ottenuti attraverso la sabbiatura, inserimento di perle in pasta vitrea.
I centri di produzione dalla metà del secolo I a.C. sono distribuiti ora su quasi tutta la penisola, disponendo
di mercati locali e regionali e, a seconda della posizione geografica delle officine, di mercati esteri
preferenziali.
I bicchieri di Aco
Classe intermedia tra le terre sigillate e la ceramica “a pareti sottili”. Prendono il nome dal ceramista più
noto, derivati anch’essi da matrici: bicchieri di forma troncoconica caratterizzati da una decorazione a
rilievo che consiste in triangolini lungo il corpo del vaso, in racemi vegetali, in archetti inscriventi figure di
amorini e così via. Prodotta in quantità considerevoli in età proto- e medio-augustea in Italia settentrionale,
è esportata su vasta scala in Gallia, negli accampamenti militari sul Reno, in Belgio, Carinzia, Spagna e in
proporzioni minori anche in Arabia sud-occidentale, Palestina, Asia Minore.
Le lucerne
Nel periodo augusteo in Italia nuovi tipi di lucerna vengono prodotti in quantità senza confronto con i
gruppi dell’età tardorepubblicana. I nuovi tipi sono accomunati da un becco triangolare affiancato da volute
e dall’espansione – a danno della spalla – del disco, che diventa il luogo di motivi decorativi eleganti. Si
creano lucerne a più becchi; si cura la decorazione anche delle anse che bilanciano il peso della vasca, come
avviene nelle lucerne in metallo; le firme dei ceramisti sono incise sul fondo a stilo, a mano libera.
Con l’età flavia si delinea la tendenza all’autonomia delle province dalle importazioni dall’Italia, con
progressivo scadimento decorativo.
Tra il 60 e il 75 d.C. circa si afferma nell’Italia settentrionale un tipo di lucerna a canale di chiara origine
metallica, bollato a rilievo sul fondo. Le officine più attestate esportano i loro prodotti nei principali centri
dell’Europa centro-orientale e dell’area danubiana, innescando un ampio processo di imitazione.
Dalla metà del secolo III d.C., benché le produzioni locali continuino a essere attive ma anonime, sul
mercato romano cominceranno ad arrivare i primi tipi di lucerne africane, destinate a un grande successo
nel Tardoantico.
La terra sigillata gallica
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
In epoca imperale la produzione di terra sigillata, cioè di ceramica fine da mensa dalla vernice rossa più o
meno brillante, coinvolge tutte le province, dalla Spagna all’Oriente, ognuna con propri mercati
preferenziali.
La terra sigillata gallica è strettamente collegata alla produzione italica e diffusa tra il secolo I e la metà del
II d.C. in Italia e a Roma in particolare, e a quella africana, la più rappresentativa dalla media età imperiale
fino al Tardoantico.
L’attività manifatturiera inizia nella Gallia meridionale e centrale alla fine del secolo I a.C. con la produzione
liscia; quella decorata a matrice appare intorno al 30 d.C. Il successo dei manufatti di Arezzo e il trapianto di
officine e maestranze italiche in Gallia hanno dato avvio prima a imitazioni e poi a un autonomo sviluppo di
manifatture “indigene”.
Il mondo decorativo gallico si muove all’interno di un peculiare immaginario, che si segnala per l’assenza
del racconto: i motivi sono disposti, come sulla tardo-italica, su più registri all’interno dei quali prevale una
partizione sia orizzontale sia verticale costituita da elementi vegetali e floreali distribuiti in una sorta di
horror vacui.
Le officine, ubicate in aperta campagna o nei pressi di piccoli villaggi, al contrario delle produzioni finora
trattate, tutte urbane, sono veri e propri agglomerati ceramici, oggi si direbbe di tipo cooperativistico, con
decine di fornaci talvolta di enormi dimensioni, capaci di produrre 30mila/40mila vasi a infornata, estesi per
chilometri, nelle quali piccoli artigiani indipendenti si associano al fine di ripartire costi e guadagni.
La terra sigillata africana
Tra l’80 e il 90 d.C. fa la sua comparsa sui mercati occidentali un’altra classe di ceramica fine da mensa
destinata a un grande avvenire.
I vasi, rivestiti da una vernice rosso-arancione, del tutto simile al colore dell’argilla, brillante in una prima
fase e poi via via sempre più opaca, ruvida al tatto, hanno decorazioni a rotella sul bordo e sulle pareti, più
raramente “a la barbotine”, e tra l’età antoniniana e la prima metà del secolo III d.C. a rilievo applicato con
motivi di gusto locale.
16.5 Il secolo III d.C. e il Tardoantico
Alla “globalizzazione” della prima e media età imperiale succede in Occidente una definitiva
regionalizzazione delle produzioni ceramiche, unita al consolidamento dell’autoconsumo dei beni primari,
mentre è l’Africa Proconsolare che provvede ora a fare fronte ai consumi di ceramica da mensa e da cucina,
occupando con la produzione della sigillata “C” fette di mercato sempre maggiori.
È in questo periodo che l’Africa diventa autonoma da Roma anche nel campo dell’architettura e della
decorazione architettonica, combinando tradizioni indigene, occidentali e microasiatiche. Contestualmente,
tra i secoli II e IV d.C. si registrano un incremento numerico dei senatori africani noti dalle fonti letterarie e
epigrafiche e un aumento di senatori romani con possedimenti in Africa.
Una novità intorno alla metà del secolo IV d.C. contribuisce a dare un nuovo impulso alla produttività
africana. La diffusione del vasellame fine africano in questo periodo non riguarda infatti solo Roma e
l’Occidente, ma comincia a investire in quantità apprezzabili anche l’Oriente, ove si affianca alle sigillate
focesi e cipriote che ne riprendono tipi e decorazioni. Determinante è la fondazione di Costantinopoli nel
330 d.C., che dà origine a un secondo polo di attrazione delle merci africane e alla nascita di un asse
Cartagine/Costantinopoli, destinato a durare per secoli. Sul piano della cultura materiale si registra un
incremento massiccio della produzione e della circolazione delle ceramiche fini ed utilitarie e delle anfore
africane, con cambiamenti di rilievo e probabilmente anche di scala nelle aree d’origine.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Sul fronte storico-artistico, accanto agli oggetti d’uso e alle derrate, viaggiano cartoni e maestranze, in
particolare i mosaicisti dall’Africa, la cui presenza in Italia è stata supposta nelle lussuose residenze
tardoantiche; la vivacità creativa del periodo si trasmette alla decorazione architettonica degli edifici
pubblici e privati. La storia dei decenni centrali e della seconda metà del secolo V d.C., con l’invasione
vandala nell’Africa settentrionale, che si conclude con la presa di Cartagine nel 439 d.C., e la nascita degli
stati romano-barbarici, offre nuovi scenari. Quella che può apparire una continuità di produzioni ed
esportazioni, deve confrontarsi, soprattutto a partire dall’ultimo periodo vandalo e poi dalla riconquista
bizantina del 533 d.C., con i “cambiamenti strutturali” politico-istituzionali, con le trasformazioni dei regimi
di proprietà e della fiscalità, con l’andamento demografico dell’Occidente, con lo sviluppo di altre fonti di
approvvigionamento nel contesto Mediterraneo e con i “mutamenti di scala” della domanda e dell’offerta.
La sigillata africana “C”
Il successo di questa produzione si lega all’espansione dell’arboricoltura in età traianeo-adrianea anche
nelle zone più aride della Tunisia centrale.
La sigillata “C” si distingue dalla “A” e dalla “D” non solo per l’eleganza dei vasi, ma anche per l’impiego
frequente e con risultati pregevoli, accanto a forme lisce, di decorazione a rilievo applicato e a matrice. La
“C” esordisce infatti già alla fine del secolo II d.C. con una serie di vasi a rilievo applicato (“El Aouja”),
prevalentemente chiusi, dalle pareti sottili e dal colore della vernice arancione brillante. Le decorazioni, a
volte delimitate da elementi architettonici o vegetali, s’ispirano alla mitologia, alla vita quotidiana, ai giochi
del circo e dell’anfiteatro e ai culti più vari. Si tratta della produzione qualitativamente migliore di tutta la
sigillata africana. La scarsa esportazione, dovuta alla fragilità dei manufatti e alla difficoltà di trasporto delle
forme chiuse, determina il prevalere nel corso del secolo III d.C. delle forme aperte, più facilmente
smerciabili e più idonee a essere decorate.
L’argilla fine e la vernice brillante o opaca del secolo III d.C. è sostituita tra la fine del secolo e quello
successivo da una pasta meno depurata e da una vernice opaca di colore arancione. All’inizio i motivi,
distribuiti sul fondo e sugli orli a tesa, sono costituiti da elementi singoli, inquadrati come nella produzione
di El Aouja da motivi vegetali o architettonici, mentre dalla metà del secolo IV d.C. si affermano le
composizioni unitarie con raffigurazioni anfiteatrali, teatrali, circensi, mitologiche, e dalla fine del secolo i
soggetti biblico-cristiani.
La terra sigillata “D” e la fine del mondo antico
Intorno al 300 d.C. inizia la produzione dei grandi piatti, delle coppe e delle scodelle in sigillata “D”, ancora
documentata alla fine del secolo VII d.C. Si distingue dalla “C” per le pareti più spesse e dall’argilla meno
depurata, dalla “A” per la superficie liscia e un colore del rivestimento rosso scuro, steso solo all’interno dei
vasi e sull’orlo. Il repertorio tipologico, del tutto nuovo, ha un autonomo patrimonio tecnico (l’uso di
cassette impilabili nelle fornaci per proteggere i vasi durante la cottura) e decorativo, con la comparsa nel
300-320 d.C. dei motivi di stampo.
La decorazione a stampo è la nota dominante della sigillata “D”: secondo un’evoluzione stilistica e tematica,
l’iniziale repertorio di motivi ornamentali riuniti secondo rigidi schemi compositivi prevede il tipo della
stella formata da rami di palma e una disseminazione di cerchi concentrici, reticoli a scacchiera, stelle,
rosette, che trovava confronto sui vetri incisi nella seconda metà del secolo V d.C. fanno seguito la croce
monogrammatica, il cristogramma e piccoli animali con significato liturgico, alternati con motivi vegetali e
geometrici; nel secolo VI d.C. prevale l’iconografia cristiana, con motivi apposti senza una precisa regola
compositiva. Alla fine di questo secolo la decorazione a stampo scompare.
Le lucerne
La tecnica a matrice non è solo appannaggio della sigillata “C”, ma interessa altri manufatti africani in argilla
rossa: i vasetti per oli profumati e le brocche antropomorfe dei secoli II-III d.C., realizzate nelle officine di
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
lucerne dei Saturnini e dei Pullaeni; la ceramica detta di Navigius dal nome del ceramista più noto,
specializzata nella fabbricazione di brocche a forme di teste maschili e femminili nonché di bottiglie
decorate con motivo di vario genere.
Due sono le forme principali prodotte in sigillata.
La prima, con numerose varianti, presenta un corpo ovoide, un disco leggermente concavo unito al becco
da un canale, una spalla convessa e Il un’ansa verticale piena o forata percorsa da scanalature che si
prolungano sulla spalla e sul fondo, su cui sono apposti motivi decorativi o lettere isolate.
La seconda forma (l’”africana classica”), prodotta dall’inizio del secolo V d.C. al VII, ha il corpo e il disco
rotondi, un lungo becco prominente e una spalla piatta e larga su cui si distende un numero vasto di motivi
geometrici a matrice vegetali e figurati in serie o alternati; l’ansa piena è posta obliquamente sul disco, il
fondo è anulare con rari bolli incisi.
In generale le lucerne della Tunisia centrale sono caratterizzate da una pasta fine con “vernice” liscia di
colore arancio chiaro, una decorazione molto accurata, con motivi ben disegnati di piccole dimensioni;
quelle della Tunisia settentrionale hanno un’argilla più grossolana, “vernice” rosso-mattone e decori più
grandi. Sul disco sono scene mitologiche, bibliche e cristiane.
Il vasellame in sigillata per i sette secoli di produzione è anonimo. Le più grandi e principali officine non si
situano di norma nei centri urbani o periurbani, ma in villaggi, ville e fattorie sparsi nei territori dell’interno.
Ciò darebbe credito all’ipotesi che la sigillata africana sia un fenomeno produttivo legato alle campagne
piuttosto che alle città e sia cioè di carattere rurale. Sembra inoltre che gli impianti nelle città avvengano in
epoca tarda e in edifici in rovina e in abbandono. Se è certa l’esistenza di una forma di artigianato urbano
autonomo dai processi produttivi dell’agricoltura, è altrettanto certo che la diffusione della ceramica
africana è da collegare ai prodotti agricoli.
Si è talora accennato ai rapporti tra la ceramica e gli argenti, gli ossi lavorati, gli avori e i vetri per la forma
dei recipienti, la scelta delle figurazioni, gli schemi decorativi, e ai collegamenti con pitture e mosaici;
rapporti che però non si traducono quasi mai in pedisseque imitazioni, piuttosto in equivalenze; del resto,
la decorazione a stampo appare un’originale invenzione degli artigiani africani, in parte debitrice di antiche
tradizioni locali di natura popolare.
Capitolo 17 – Il vetro
Il vetro antico è in genere considerato una classe di materiale il cui studio richiede grande specializzazione.
Questa convinzione, da superare, è in effetti giustificata da una serie di motivi. Negli scavi il vetro non è
molto comune, perché anche nell’Antichità veniva riciclato; data la sua fragilità è quasi impossibile trovare
esemplari più o meno interi, a meno che non si tratti di contesti funerari; le caratteristiche del materiale e
le forme, spesso prodotte in centri diversi, non consentono in genere di risalire all’area di origine, al
contrario di quanto avviene per la ceramica, definibile attraverso argille, vernici e repertori tipologici.
17.1 Componenti del vetro e organizzazione della produzione
Tecnologia
La miscela delle materie prime dalle quali si otteneva il vetro, rimasta invariata tra la fine del millennio I a.C.
e buona parte del millennio I d.C., prevedeva due componenti principali: la silice, presente in natura nelle
sabbie e il natron, un minerale naturale composto da sodio, necessario ad abbassare la temperatura di
fusione della sabbia, altrimenti troppo alta per la tecnologia antica, e a conservare il vetro nello stadio di
viscosità che ne consentiva la lavorazione.
Il vetro grezzo, ottenuto dalla fusione di sabbia e natron, veniva colato in lingotti o, una volta raffreddato,
spaccato in blocchi informi e avviato nei siti che, dovendo semplicemente rifonderlo per dargli una forma
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
finita, con l’eventuale aggiunta dei componenti necessari a colorarlo o a decolorarlo, non necessitavano di
grandi impianti.
Da questa breve introduzione emergono alcuni elementi che sono alla base della produzione vetraria
antica:
- la presenza di pochi centri specializzati = officine primarie;
- la grande diffusione di piccoli impianti dotati di strutture più semplici per la realizzazione degli
oggetti = officine secondarie;
- l’esistenza di una rete commerciale complessa destinata al trasporto di materiale grezzo.
Se dunque l’installazione delle officine primarie fu condizionata dalla presenza della materia prima, quelle
secondarie poterono impiantarsi dovunque vi fossero le condizioni e le esigenze per avviare un’attività
artigianale.
Nell’Antichità, così come oggi, il vetro veniva riciclato: questa prassi aveva un grande vantaggio economico
e tecnico, in quanto l’aggiunta di materiale già lavorato consentiva da un lato di risparmiare sulle quantità
di vetro grezzo e contribuiva dall’altro ad abbassare la temperatura di fusione.
17.2 Origini
Le officine del Mediterraneo orientale e del Vicino Oriente rappresentarono non solo la fonte principale di
vetro grezzo: in Oriente, ad Alessandria, a Rodi, sulla costa levantina e all’interno erano anche le officine
secondarie, grandi e famose produttrici di oggetti finiti. Solo all’inizio del millennio I d.C. le officine
occidentali avviarono una consistente produzione autonoma. La tecnologia della produzione vetraria e la
varietà delle tecniche decorative raggiunsero l’apice in età imperiale.
Le più antiche testimonianze archeologiche sulla lavorazione del vetro risalgono al millennio III a.C. Non si
tratta ancora di recipienti, ma di piccoli monili e intarsi che imitano le pietre preziose.
I recipienti più antichi
Si tratta di forme chiuse, di piccole dimensioni, destinate a contenere cosmetici, unguenti e profumi, che in
mancanza di un repertorio specifico imitano la ceramica coeva, ma sono impreziositi dall’elemento della
policromia. Il procedimento con il quale erano realizzati consisteva nel plasmare, all’estremità di un’asta
metallica, un nucleo di sabbia, argilla e sostanze organiche, della forma grosso modo corrispondente alla
parte interna del recipiente, e nel rivestirlo poi omogeneamente di vetro monocromo, al quale venivano
applicati filamenti di colori diversi, spesso sagomati a zig-zag. La lavorazione si concludeva con l’aggiunta
dell’orlo, del fondo e delle anse, e con l’estrazione della massa interna.
17.3 Le grandi innovazioni in età ellenistica
A partire dal secolo III a.C. si moltiplicarono i centri produttori e si diffuse un nuovo repertorio di forme, di
maggiori dimensioni, derivate da prototipi in argento e in ceramica. Cambiò anche la tecnica che,
utilizzando matrici, consentiva una produzione più veloce e la realizzazione di esemplari anche complessi. Il
vetro è in genere decolorato intenzionalmente, ma non mancano esemplari dai colori vivaci o con
decorazioni dipinte. Anche l’oro è usato, o come pigmento, o in forma di lamina sottilissima, racchiusa tra
due strati di vetro. Comparve in questo periodo anche il vetro policromo, ottenuto assemblando sezioni di
canne con motivi e colori diversi.
Secolo II-I a.C. --- Officine dell’area costiera siro-palestinese. Qui cominciarono ad essere fabbricate coppe
dal profilo molto essenziale, conico e poco più tardi emisferico, prive di decorazioni, eccetto scanalature e
costolature. La loro realizzazione era facile e tanto veloce da non richiedere, secondo le stime, più di uno o
due minuti.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Dalla metà del secolo II a.C. l’impiego del vetro si diffuse anche nei mosaici, consentendo di ottenere una
gamma cromatica molto più ampia rispetto a quella possibile con pietre e ceramica.
17.4 La rivoluzione in età augustea e lo sviluppo della produzione a Roma e in Occidente nella prima età
imperiale
Anche nel campo della produzione vetraia l’età di Augusto segnò una svolta epocale. L’artigianato e il
commercio, favoriti dal lungo periodo di pace, videro allora un’espansione senza precedenti, mentre la
conquista dei regni ellenistici determinò un afflusso in Occidente di artigiani esperti anche nella lavorazione
del vetro, portatori di una tradizione che aveva reso famosi i centri dell’Oriente e dell’Egitto.
Nel corso di pochi decenni il patrimonio, e gli impianti vetrari si diffusero in Italia e nelle province
occidentali, in un processo di emancipazione delle “periferie” che caratterizzò tutta l’economia antica.
Da Strabone, il geografo d’età augustea, si apprende che nelle officine di Roma erano avvenute innovazioni
nel campo dei colori e della semplificazione dei processi esecutivi, tali da ridurre di molto il costo del vetro.
I vetri che Strabone avrebbe potuto vedere erano quelli tipici del suo tempo, eseguiti con il metodo della
semplice matrice: le coppe, con o senza costolature, di derivazione ellenistica, ma ora realizzate con colori
smaglianti; i servizi da mensa ispirati alle argenterie e alla sigillata italica contemporanee; i vasi eseguiti
nella tecnica del vetro mosaico, anch’essa di eredità ellenistica.
Il vetro cammeo
Si tratta di un vetro per lo più a due strati di colore contrastante, probabilmente lavorato secondo la tecnica
della glittica, asportando lo strato superiore per creare raffigurazioni che risaltavano sul fondo scuro:
celebri sono il “vaso Portland” o il “vaso blu” con eroti vendemmianti dalla nicchia di una camera sepolcrale
a Pompei.
Il vetro cammeo è molto raro: se ne conoscono attualmente poco meno di quattrocento esemplari e si
stima che la produzione abbia superato di poco il migliaio. Per il 90% almeno degli esemplari noti si può
infatti ricostruire una provenienza romana.
Gli studi più recenti suggeriscono che la produzione abbia avuto una durata molto breve, dal 15 a.C. al 25
d.C. circa, svolgendosi in poche e piccole officine altamente specializzate.
In vetro cammeo si realizzarono anche pannelli, destinati forse a essere inseriti nelle pitture parietali come
pìnakes o, piuttosto, a essere esposti in modo che la luce li attraversasse, per fare risaltare il colore del
vetro di fondo.
Materiale versatile per eccellenza, il vetro cominciò ora ad avere un ruolo importante anche in architettura.
Infatti, con l’inizio dell’età imperiale si diffuse il vetro da finestra che, consentendo una maggiore
introduzione di luce negli edifici pubblici e privati, determinò certamente non solo un notevole
miglioramento nella qualità della vita, ma anche la possibilità di valorizzare i volumi e gli apparati decorativi
degli interni.
I grandi edifici termali di età imperiale disponevano dunque di ampie superfici vetrate, con lastre inserite in
telai di legno fissati alle murature; il problema della dispersione di calore nelle sale riscaldate era risolto con
sistemi di doppi vetri. Per realizzare una lastra di vetro veniva colato su un supporto, in genere con bordi
rialzati, spianato con spatole e poi tagliato secondo la forma e le dimensioni volute. A partire dal secolo III
d.C. la tecnica della soffiatura, introdotta anche nel caso del vetro da finestra, rese le lastre più sottili e
quindi anche più trasparenti.
La scoperta, forse avvenuta per caso, che un bolo di vetro allo stato viscoso potesse espandersi se
s’introduceva aria al suo interno, fu davvero clamorosa, e certo il suo autore non sapeva che avrebbe in
qualche modo cambiato la storia, determinando un’ulteriore espansione della produzione vetraia.
La tecnica consisteva nel soffiare entro cannucce di vetro chiuse all’estremità ed esposte a una fonte di
calore. Il bulbo così formato veniva poi staccato dal resto della cannuccia.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Le prime produzioni realizzate con tecniche evolute di soffiatura comparvero simultaneamente in Oriente e
in Occidente, testimoniando la rapidità e la facilità con cui le idee, gli artigiani e i loro prodotti potevano
diffondersi ormai entro i confini dell’impero.
Oltre alla soffiatura del tipo descritto, definibile “a canna libera”, all’inizio del secolo I d.C. le officine della
costa siro-palestinese misero a punto un’altra tecnica, consistente nel soffiare il vetro all’interno di una
matrice: un procedimento non semplice, che richiedeva abilità da parte sia del soffiatore sia dell’esecutore
delle matrici, composte da più parti.
Le forme, in genere dai colori vivaci, sono molto articolate e cariche di valenze simboliche: bottigliette,
unguentari e bicchieri prendono l’aspetto di grappoli d’uva, pigne, teste di Medusa, datteri resi in modo
molto realistico, questi ultimi in particolare preziosi equivalenti dei frutti che si donavano all’inizio dell’anno
come simbolo di dolcezza.
La tecnica della soffiatura a matrice fu recepita anche dalle officine occidentali, capaci di realizzare
soprattutto bicchieri con nodosità, allusivi alla clava di Ercole e coppe con raffigurazioni di spettacoli in
esemplari trovati specie in Gallia, Germania e Britannia: corse di carri al circo Massimo, scene di venationes
e duelli tra quattro coppie di gladiatori.
17.5 Le produzioni della media e tarda età imperiale
Dal secolo II d.C. le produzioni in vetro soffiato si sostituirono quasi del tutto a quelle eseguite a matrice,
che nell’articolazione denunciavano un’ispirazione al vasellame metallico. Un’eccezione è costituita da un
gruppo di vasi da mensa, prodotti alla fine del secolo I d.C., realizzati a matrice in veto completamente
decorato e resi più preziosi da sfaccettature a intaglio che creano effetti di luce.
Vetri incisi
La decorazione incisa figurata era ancora rara nel secolo III d.C., al contrario di quella geometrica, diffusa in
tutto l’Occidente, che utilizzava sfaccettature di forma diversa variamente disposte sulle pareti dei vasi. Alle
officine renane e a quelle egiziane si attribuiscono le prime realizzazioni di vetri incisi con scene figurate a
carattere mitologico; nel secolo V d.C. le officine renane arricchirono il loro repertorio con scene di caccia,
tanto amate anche nel repertorio dei mosaici, o di genere e bibliche.
Nel corso del secolo IV d.C. i vetri incisi realizzati nell’Urbe erano prodotti suntuari che, come argenti e
avori, potevano divenire mezzi di diffusione di immagini pregnanti per committenze di alto livello. A Roma
erano attive almeno due officine che attingono al repertorio sia cristiano sia “pagano”. La prima officina
realizza i contorni delle figure con intagli lineari e ne campisce l’interno con abrasioni che rendono opaca la
superficie; la seconda procede con asportazioni dai contorni più sinuosi, di ampiezza e profondità diverse,
che creano un effetto chiaroscurale.
Vasi “a gabbia”
Alle élite tardoantiche erano destinati anche altri capolavori dell’arte vetraria: i diatreta o vasi “a gabbia”,
oggetti di lusso la cui funzione principale sembra fosse quella di lampade a sospensione. Erano ottenuti con
una tecnica “a giorno”, intagliando e levigando un vetro di notevole spessore, fino a fare risaltare sullo
sfondo la decorazione. Questa finisce per rivestire la parete come una sorta di rete, alla quale resta fissata
soltanto mediante piccoli elementi di raccordo, disposti in modo da non essere visibili.
Tra i vasi “a gabbia” rinvenuti in Italia ricordiamo la coppa “Trivulzio”, scoperta nel 1680 in un sarcofago e
ornata di un’iscrizione (“Bevi, vivrai molti anni”). Il più spettacolare fra i diatreta è la “coppa di Licurgo”,
dove una scena complessa subentra alla più comune decorazione geometrica. Oltre alla difficoltà e alla
bellezza del lavoro di intaglio, il vaso ha una particolare proprietà ottica che lo fa apparire di colore
cangiante e simile a una pietra preziosa: verde alla luce riflessa e rosso alla luce trasmessa. Tale
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
caratteristica è dovuta alla presenza di minime quantità di argento e, in misura ancora inferiore, di oro.
Sulla funzione della coppa si discute ancora molto, ma è probabile che essa troneggiasse su una mensa,
“semplicemente” come una grande pietra preziosa, durante i banchetti di alto livello.
Vetri “a sandwich”
Tra le produzioni tardoantiche più distintive figurano anche i fondi d’oro o vetri “a sandwich”, così definiti
perché presentano una decorazione eseguita su foglia d’oro, protetta fra due strati di vetro. I fondi,
appartenenti in origine a recipienti di forma prevalentemente aperta, venivano ritagliati in modo da
assumere l’aspetto di un disco. Se ne conoscono attualmente intorno ai cinquecento esemplari.
I soggetti, tra i quali predominano quelli cristiani, abbracciano pure simboli ebraici e il repertorio profano/
“pagano”, trovando confronti in altri media e ripetendosi con la variazione di composizioni e schemi.
Nonostante l’apparenza, non doveva trattarsi di oggetti particolarmente pregiati e destinati a una clientela
esclusiva, poiché si utilizzava una quantità d’oro trascurabile, il libello artistico non era molto alto, e la
tecnica non richiedeva grande abilità.
Verso la semplificazione
A partire dal secolo V d.C. le produzioni di lusso, appena esaminate nelle loro manifestazioni più note,
scomparvero progressivamente in Occidente. In questo periodo nacquero alcune forme particolari, che
rappresentano veri fossili-guida per i secoli tra il Tardoantico e il primo Medioevo: lucerne e calici. Riempite
d’acqua e olio di ricino, le lucerne in vetro permettevano di economizzare sul combustibile e producevano
una luce molto più intensa rispetto a quelle in ceramica.
Per l’illuminazione delle chiese si usavano anche elaborati supporti circolari di metallo che dovevano
formare vere e proprie corone luminose, producendo un grande effetto scenografico.
I calici erano utilizzati sia come recipienti che come lampade. Le lucerne a sospensione e soprattutto i calici,
che comparvero a Roma nell’avanzato secolo V d.C. per restare la forma in vetro più comune ancora nel
secolo VIII d.C., ebbero una grandissima diffusione e furono prodotti in Occidente e in Oriente.
17.6 Il vetro come elemento decorativo in architettura (e altri usi)
1970 – porto dell’antica Corinto. Qui furono rinvenuti oltre cento pannelli ancora imballati, depositati in un
edificio dell’area portuale nel quale era in corso una ristrutturazione non ultimata a causa di un evento
sismico. I pannelli erano realizzati con lastrine di vetro di forma e colori diversi, come nel più comune opus
sectile in marmo. La decorazione parietale che è stato possibile ricostruire consiste in una serie di
personaggi (figure mitologiche, di divinità, di filosofi e poeti) racchiusi entro cornici e alternati a vedute
paesistiche con scene palustri alla base: la superficie totale copriva oltre 150 mq.
I pannelli di Corinto rappresentano l’esempio più spettacolare di una decorazione esclusivamente in vetro,
ma l’uso di lastrine e di cornicette vitree associate ad altri materiali risaliva molto indietro nel tempo e
continuò a essere testimoniato anche dopo il Tardoantico negli edifici ecclesiastici.
Anche l’impiego di pastiglie in vetro con la faccia inferiore piatta e quella superiore convessa è
documentato nella decorazione di elementi architettonici, pareti e mobili; se ne ipotizza l’applicazione
perfino su abiti e tessuti.
La diffusione del vetro in tutti gli strati sociali li rese tanto comuni da consentirne in età imperiale l’utilizzo
anche come pedine: giocare con pedine di vetro al ludus latrunculorum e al ludus duocecim scripta, una
sorta di precursori degli scacchi e del backgammon, sarebbe stato forse impensabile in epoche anteriori.
Capitolo 18 – Pittura
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Parlare di pittura romana equivale perlopiù a parlare di pitture murali. Eppure, i Romani apprezzavano
molto i quadri da cavalletto (tabulae), specie dei grandi artisti greci, a tal punto da esporli negli spazi
pubblici quali ornamenti urbani e nelle pinacoteche private.
L’apprezzamento per le tabulae traspare dalla realizzazione a parte nella tecnica dell’affresco di quadri
figurati applicati in un secondo momento nel campo della parete entro telai di legno.
Le conoscenze sulla pittura parietale sono legate principalmente alla scoperta, iniziata con le grandi
campagne di scavo del Settecento e dell’Ottocento, delle città di Pompei e Ercolano, la cui drammatica fine
avvenuta nel 79 d.C. sotto le ceneri del Vesuvio ha garantito la conservazione di interi apparati decorativi di
ambito pubblico e privato.
18.1 Pittura italica: dall’età regia all’età mediorepubblicana
Pitture ritenute “anteriori alla fondazione di Roma” esistevano ed erano apprezzate ancora al tempo di
Plinio il Vecchio. Le nostre conoscenze relative alla pittura italica antecedente alla “romanizzazione” si
basano principalmente sulle testimonianze di ambito funerario, e in parte anche domestico, di area etrusca,
campana e apula, che denotano una stretta connessione con la tradizione figurativa greca, in particolare
con la ceramografia.
18.2 Tra la tarda età repubblicana e il principato di Augusto: dall’imitazione strutturale all’illusionismo
architettonico
Il più antico schema decorativo individuato sulle pareti degli edifici campani e definito “I stile” riproponeva,
con caratteristiche proprie, una moda diffusa da tempo nel bacino mediterraneo, consistente nel
riprodurre, in spazi interni, i preziosi rivestimenti litici che ornavano l’esterno di templi ed edifici pubblici
attraverso l’articolazione di modanature tridimensionali in stucco o schemi geometrici a linee incise
(pannelli, bugne, zoccoli, cornici e architravi). La pittura aveva pertanto la funzione complementare di
ricoprire le superfici stuccate con motivi che imitavano l’aspetto di crustae marmoree e di svariati tipi di
pietre.
L’esistenza di decorazioni parietali simili già dalla fine del secolo V a.C. in Grecia e Asia Minore, Egitto e
Russia ne testimonia le origini greco-orientali, mentre l’acquisizione in Italia centrale rientra nel fenomeno
dell’“ellenizzazione” intensificatosi nel secolo II a.C.
L’incontro con gli ambienti locali determinò tuttavia la formazione di caratteri peculiari, con differenze
riscontrabili anche tra una località e l’altra della penisola. Sono principalmente proporzioni e rapporti
dimensionali a cambiare: all’originario plinto sormontato da fregio, strutturale o figurato, il gusto italico
preferisce uno zoccolo più alto che giunge all’incirca fino ad un terzo della parete, dividendola in tre registri
orizzontali. Compaiono inoltre con maggiore frequenza elementi verticali che rompono l’assetto orizzontale
tipico del gusto greco.
Benché subordinati all’assetto strutturale, non mancano motivi decorativi e figurati come cubi prospettici,
drappi o elementi vegetali quali tralci e ghirlande. Sono presenti anche figure umane o antropomorfe in
forma libera su bugne e ortostati o entro fregi. Il limite cronologico d’uso dello “stile strutturale” si può
collocare all’inizio del secolo I a.C.
Proprio ai decenni iniziali del secolo I a.C. risalgono le decorazioni del Capitolium di Brescia e della Casa dei
Grifi sul Palatino i più antichi esempi di “II stile” o “stile architettonico”. Questi, pur replicando
l’organizzazione tripartita e gli elementi diffusi negli schemi strutturali, attestano un importante
mutamento: mezzi esclusivamente pittorici subentrano ad aggetti e solcature in stucco nella suddivisione
della parete.
La rapidità del mutamento si spiega con una specifica esigenza delle domus, caratterizzate da un dispiego di
simboli politici e ostentazione di lusso; di qui la necessaria differenziazione degli ambienti per accogliere da
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
un lato i pari del dominus, cui erano destinate innovazioni decorative rese possibili dall’impiego dei più
duttili mezzi pittorici, e dall’altro i subalterni, cui si riservavano invece composizioni più conservatrici.
Verso l’apertura della parete
Nel cubicolo 16 della Villa dei Misteri a Pompei, lo sguardo può spingersi ben oltre il confine dell’ambiente
mediante l’apertura, per ora limitata alla zona superiore della parete, di vedute su uno spazio esterno, dove
si erge, sullo sfondo blu del cielo, un edificio circolare. Gli elementi architettonici riprodotti, seppur non
privi di motivi ornamentali, sono solidi e illusionistici, perché in grado di ingannare l’occhio dello spettatore.
Gli affreschi della villa di Poppea a Oplonti e del cubicolo “M” nella villa di P. Fannio Sinistrore a Boscoreale
mostrano l’evoluzione estrema della tendenza illusionistica: elaborate architetture e ampie vedute di città
smaterializzano del tutto la parete in aperture e prospettive senza precedenti nella produzione pittorica
greca o italica.
Verso la chiusura della parete
Nel corso di pochi anni l’illusionismo architettonico conosce un’improvvisa battuta d’arresto, come
documentano le pitture nelle proprietà dell’imperatore Ottaviano sul Palatino: il podio di sostegno delle
colonne, ancora esistente, diventa una superficie da decorare e la zona mediana della parete, con aperture
limitate agli spazi laterali o superiori, si struttura attorno a grandi quadri centrali con paesaggi “idillico-
sacrali” o temi mitologici, che assumono un ruolo preponderante nella composizione. Alle prospettive di
villa Oplonti subentra una graduale tendenza a chiudere di nuovo la superficie della parete accentuandone
mano a mano l’aspetto ornamentale.
Alle forme quadrate dei lacunari che ricoprivano uniformemente l’intera superficie, subentrano losanghe,
cerchi inscritti, poligoni. L’introduzione di sfumature pastello su fondo bianco attenua i forti contrasti delle
pareti, caratterizzate da colori accesi esaltati dal trattamento “a specchio”, delle superfici, lisce e dipinte
con pennellate leggere e di grande finezza.
18.3 Dall’età augustea all’età claudia: un raffinato “manierismo”
Le pitture della casa di Ottaviano preannunciano il decorativismo della prima età imperiale, entro cui si
colloca il “III stile” o “stile ornamentale”.
Le pareti della villa a Boscotrecase sono una raffinata espressione dell’epoca. Sullo zoccolo del cubicolo 16,
che forti contrasti coloristici separano nettamente dalla zona mediana, crescono esili piante o poggiano
nature morte; le articolazioni del basamento si dissolvono in linee e figure geometriche come piccoli rombi
con fiore centrale; una sovrapposizione di due sottili bande, antica reminiscenza del piano di attesa dei
podi, evocati dalle coppie di linee verticali in corrispondenza delle partiture soprastanti, lo delimita
superiormente. Il registro mediano è scandito da colonnine con fusto a corteccia di palma e infiorescenze o
ricoperte da miniaturistici collarini e pseudo-gioielli. Candelabri vegetali campiscono il registro superiore.
Gli effetti disegnativi hanno preso il sopravvento su quelli pittorici. Le scelte cromatiche si orientano in una
duplice direzione: forti contrasti tra tinte sature da un lato, fondo neutro e colori pastello dall’altro.
I quadri mitologici, apparsi già, in formato diverso, sul finire del “II stile”, si moltiplicano a partire dalla
piena età augustea, con una non casuale collocazione al centro delle pareti, ad altezza di sguardo. I soggetti
scelti consentono di traslitterare il quotidiano nel linguaggio poetico dei miti con dei ed eroi greci,
all’insegna di valori come pietas, pudor, virtus e otium.
Anche su volte e soffitti il tradizionale sistema a cassettoni si smaterializza in cornici puramente decorative
di linee e filettature, appiattendosi su fondi spesso monocromi in bianco o nero che perdono ogni
credibilità strutturale e si tramutano talvolta in veri e propri tappeti floreali, “reticoli” e tralci vegetali.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
In tale periodo un posto di rilievo spetta alle decorazioni pittoriche sia di sepolcri singoli, come la piramide
Cestia, sia di sepolture collettive, come i colombari. Nonostante la funzione ne condizioni inevitabilmente
gli schemi dispositivi, soggetti e scelte stilistiche sono gli stessi della decorazione domestica.
18.4 Da Nerone ai Flavi: eclettismo e massificazione
“Manierismo” ornamentale e riscoperta architettonica nelle sue più svariate forme costituiscono il binario
sul quale si muove la produzione pittorica dei decenni centrali e finali del secolo I d.C. Molte sono tuttavia
le varianti che si sovrappongono a tale schema, al punto che più volte la pittura di tali anni è stata definita
eclettica; lo stesso Mau, parlando genericamente di “IV stile” o “ultimo stile pompeiano”, denunciò tra
l’altro la difficoltà nell’estrapolarne tratti peculiari univoci. Inoltre, la sola pittura non è più sufficiente a
soddisfare il gusto delle committenze più elevate, che si rivolgono spesso all’uso di altri materiali, in
particolare del marmo. Nella domus Aurea, la combinazione di marmo e dipinti diventa strumento di
gerarchizzazione delle stanze e di distinzione funzionale: mentre agli ambienti più importanti si riserva un
rivestimento parietale in opus sectile, l’intonaco dipinto decora i vani secondari come corridoi e
criptoportici.
Tappezzerie e schemi architettonici
Disposti in sequenze ripetitive e monocromatiche che lasciano trasparire il fondo uniforme, i bordi
delimitano frequentemente i pannelli della zona mediana e disegnano lo schema decorativo sostituendo
talvolta cornici e bande su pareti, volte e soffitti. In una sorta di horror vacui, esili figurine, pìnakes,
ghirlande e motivi vegetali completano l’esuberante repertorio ornamentale.
Nella composizione della parete, agli elementi di continuità con la pittura di “III stile” si aggiungono
rielaborazioni del repertorio “architettonico” della tarda Repubblica: lo zoccolo può essere variamente
decorato da forme geometriche con bordure e racemi, ciuffi di piante e animali; la zona mediana può
strutturarsi architettonicamente attorno a un’edicola affiancata da vedute prospettiche e arricchita da
pannelli appesi a mo’ di drappi o appiattirsi in sequenze lineari e paratattiche di campi con decorazione
centrale; nella zona superiore, alle architetture, talvolta organizzate come prolungamento della parte
mediana, si alternano motivi “a carta da parati” che richiamano le decorazioni di soffitti e volte.
I forti contrasti tra i toni caldi di giallo, rosso, nero e oro sanciscono il predominio dell’effetto pittorico su
quello disegnativo, soprattutto nei soggetti figurati. Sia nelle “nature morte” e nei paesaggi sia nei più
complessi quadri a tema mitologico, rapidi colpi di pennello, concepiti per una visione da lontano, esaltano
gli effetti luministici delineando forme e volumi in maniera compendiaria.
Decorazioni di volte e soffitti
Articolate e variabili sono anche le decorazioni di volte e soffitti, dove “grottesche”, bordi di tappeto e
motivi vegetali di andamento curvilineo disegnano schemi “centralizzati” a incastri concentrici attorno a un
elemento mediano, talvolta enfatizzati da altri diagonali.
Più eterogenee le pitture “popolari”, con soggetti peculiari e con un linguaggio figurativo senza particolari
finezze, ma di chiarezza espressiva, che si serve di formule come la proporzione gerarchica e la prospettiva
ribaltata. Queste pitture, di esecuzione ora sommaria e affrettata ora più accurata, possono decorare
ambienti interni o facciate esterne di domus, tabernae, lupanari e sepolcri, e illustrano momenti di vita
quotidiana spaziando da temi religiosi, ai ludi, passando per episodi di cronaca, mestieri e scene erotiche.
18.5 Interludio: dopo Pompei
Tra l’età flavia e antoniniana l’Italia centrale vede esaurirsi il suo predominio quale centro di produzione e
di irradiazione culturale ed importa dalle province marmi colorati, che tendono a sostituire la pittura nei
contesti di prestigio delle classi egemoni. L’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. decreta il tramonto di Pompei e
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
dei centri vesuviani, e il seppellimento dei loro edifici comporta per gli studiosi una forte riduzione della
documentazione della pittura parietale romana. Si assiste al progressivo sviluppo di una tendenza
semplificatrice, che ricalca gli schemi compositivi del secolo I d.C. con riprese dalle quali traspare spesso
una mancanza di invenzione. Le innovazioni pittoriche si riscontrano nella decorazione dei soffitti e delle
volte. Quanto alla tecnica pittorica, i consueti tre strati sovrapposti di cui si componevano gli intonaci
tendono a diventare solo due; si usano materiali più economici, e le superfici appaiono raramente
interessate da una levigatura accurata e da una lucidatura.
18.6 Il secolo II d.C.: la semplificazione del “IV stile”
Gli elementi del “IV stile” continuano con un sistema che prevede una zona mediana sottolineata da
colonne e dall’inserimento, sempre meno frequente, di “quadri” di grandi dimensioni al centro e nelle parti
laterali; permane anche la tripartizione della parete in uno zoccolo inferiore, una fascia mediana principale
ed una superiore.
In questo periodo continuano ad apparire scorci architettonici combinati con pannelli, ma scade
l’impostazione illusionistica, e le stesse vedute non di rado sono collocate su fondi uniformi nella cui
neutralità si esaurisce la suggestione prospettica. Fondamentali sono le testimonianze di Roma e di Ostia.
All’inizio del secolo II d.C. Ostia vede un’intensa attività edilizia e una profonda trasformazione dell’assetto
urbano all’indomani dell’apertura del nuovo porto traianeo. A Ostia, come a Roma, si afferma un’edilizia
intensiva con fabbricati a più piani (detti “insulae”) per soddisfare le esigenze di una popolazione in
continuo aumento.
L’impostazione scenografica e le architetture ricordano esempi di “IV stile”, pur con reminiscenze di “II” e di
“III stile”.
Dall’area del porto fluviale di S. Paolo a Roma provengono affreschi databili alla metà del secolo II d.C., con
una decorazione ispirata a temi marini.
La pittura funeraria
La progressiva diffusione del rituale di inumazione nel corso del secolo II d.C. comporta una diversa
organizzazione degli spazi sepolcrali, compresi quelli destinati a essere dipinti. La pittura e i rilievi in stucco
giocano un ruolo significativo nelle volte e nelle lunette, recuperando quell’abbinamento tra i due generi
diffuso nelle case dell’ultimo periodo di vita di Pompei.
18.7 Il secolo III d.C.: “stile lineare” (e non solo)
In questo periodo si afferma prepotentemente lo “stile lineare” (rosso e verde), un sistema decorativo che
si caratterizza come un’estrema semplificazione dei più complessi schemi tradizionali; le sue origini
risalgono agli ambienti secondari delle case pompeiane ed ercolanesi di “IV stile”, caratterizzati da pannelli
a fondo bianco senza ricerca di profondità, di rapida esecuzione e a basso costo.
Lo “stile lineare” si ritrova in termini molto simili nella prima metà del secolo III d.C. a Roma su via Labicana
nell’ipogeo degli Aureli e nella decorazione delle catacombe cristiane, in particolare nelle volte in cui si
organizza generalmente attorno a un medaglione centrale.
Mentre a Roma e a Ostia predomina lo stile lineare, nelle province occidentali e orientali riscuote grande
successo anche la decorazione a motivi ripetitivi, che evoca la carta dipinta o la tappezzeria (“wallpaper
pattern” o “tapetenmuster”), occasionalmente comparsa in Italia nelle pareti e nei soffitti di “IV stile”. Si
tratta di rivestimenti in cui sono giustapposte forme geometriche, quadrangolari, esagonali o arrotondate e
decori vegetali o floreali stereotipati.
Dura Europos: l’incontro tra Occidente e Oriente
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Tra le più tarde del “tempio di Bel” a Dura Europos si distingue, sul muro settentrionale di un pronao, una
scena di sacrificio di un ufficiale romano, il tribuno Giulio Terenzio, identificato come tale da un’iscrizione
latina, dietro il quale su più file sono disposti gli omini della sua coorte, compreso un vessillifero sacerdote;
nella parte sinistra del quadro in basso le due Tychai dalle teste turrite e nimbate di Palmira e Dura
Europos, in alto le statue della triade palmirena. Sono poi soprattutto le pitture della celebre sinagoga di
Dura Europos che segnano l’incontro di due tradizioni, occidentale e orientale, costituendo un rilevante
ciclo di immagini bibliche in contrasto con il presunto carattere aniconico della religione ebraica.
Un gruppo di pitture di fine secolo II-inizio III d.C. è legato a un culto orientale molto radicato nel mondo
romano, quello del dio Mitra, all’interno di “grotte”, “accampamenti delle tenebre” dotati di podi per
riunioni e banchetti di conventicole.
18.8 Il Tardoantico verso la cultura bizantina
Accanto a un incremento nell’uso di decorazioni imitanti i lussuosi rivestimenti in marmo, alla fine del
secolo III e all’inizio del IV d.C. la pittura recupera modi tradizionali, compresi trompe l’oeil e megalografie.
La coesistenza di temi “pagani” e cristiani, non sorprendente nella Roma del secolo IV d.C., è ben
documentata anche in pittura, anzitutto nell’ipogeo di via Dino Compagni, pur se in spazi distinti. Se la
maggior parte delle scene dipinte nei molteplici cubicoli rimanda spesso a cicli di episodi dell’Antico e
Nuovo Testamento che convivono con episodi salienti delle fatiche di Ercole.
Dalla seconda metà del secolo IV d.C. il codice prevalse sul rotolo, sostituendo quasi del tutto e divenendo il
tipo di libro comune. Fu così destinata a un notevole successo la soluzione di abbinare al testo scritto
l’illustrazione mediante la miniatura, che poteva occupare la pagina intera a differenza che nei rotoli,
costituendo così una fonte rilevante per ricostruire anche l’arte pittorica.
La “cappella sistina del secolo VIII d.C.”
Nella rimodellazione cristiana degli spazi del foro Romano risalta la chiesa di S. Maria Antiqua, che conobbe
varie decorazioni tra i secoli VI e VIII, ben ricostruibili soprattutto sulla parete absidale: si tratta della
“parete palinsesto”, così chiamata per analogia con la pratica amanuense di riadoperare lo stesso foglio di
pergamena per scritture successive e caratterizzata da una stratificazione di ben sette intonaci dipinti.
Capitolo 19 – Mosaico
Il termine “mosaico” presenta un’etimologia incerta; richiama moûsa e sembra derivare dal latino
musivum, “opera degna delle Muse”, trattandosi di quel tipo di rivestimento applicato alle grotte dedicate
alle Muse o alle ninfe (ninfei e fontane).
In generale, il mosaico è un tipo di decorazione con piccoli elementi più o meno regolari (di marmo, o di
pietra, di pasta di vetro o di terracotta) giustapposti e fissati saldamente per mezzo di un legante su uno
strato di intonaco e formanti esternamente una superficie più o meno liscia, per lo più decorata con motivi
geometrici, vegetali o figurati. Questi piccoli elementi assumono presso i Romani il nome di abaculi,
tesserae o tessellae.
19.1 I mosaici pavimentali in Italia
I precedenti dei pavimenti a mosaico sono costituiti dai mosaici a ciottoli colorati con rappresentazioni
figurate, riferibili ai secoli V e IV a.C., e rinvenuti in vari centri della Grecia.
Il ricorso a sottili liste di piombo, inserite nel sottofondo, consentiva di ottenere un disegno di contorno più
netto nei profili dei volti, o in altri particolari interni. Veri e propri indicatori dell’agiatezza dei committenti, i
mosaici sono realizzati alla stregua di composizioni pittoriche e riprendono spesso temi mitologici tratti
dallo stesso repertorio.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
In Italia l’uso di pavimenti a sassolini con raffigurazioni di tipo pittorico è attestato alla fine del secolo IV a.C.
a Mozia in Sicilia, dove un mosaico presenta un grifo e una pantera che assalta un toro, e ad Arpi nell’antica
Daunia che ne ha restituito uno a ciottoli con animali e motivi geometrici. Dall’impiego di ciottoli naturali si
passò all’uso di quelli squadrati e infine di tessere appositamente tagliate.
I tipi più comuni di pavimenti in tutto il Mediterraneo erano costituiti da quelli cementizi, termine con il
quale s’intendono quei rivestimenti caratterizzati da una miscela di legante e aggregati litici o fittili, noti a
livello letterario con i nomi di cocciopesto, battuto o signino.
Particolarmente diffusi erano i cementizi che, in base all’impasto della pavimentazione, si definiscono a
base fittile; il loro pregio principale consisteva nell’impermeabilità e nella particolare compattezza e
resistenza al deterioramento.
Il fondo, di colore rosso, era ravvivato da uno strato sovrapposto di stucco pure rosso ed era spesso
decorato da tessere bianche e talvolta nere, allettate nel battuto e disposte liberamente o a formare
disegni diversi, fra cui punteggiati, meandri, reticolati.
Su suolo italico i pavimenti cementizi si diffondono dalla fine del secolo IV-inizio del III a.C. fino al principio
del secolo I d.C. circa, fino ai primi due secoli dell’Impero.
Ricorrendo al binomio caro ai Romani di utilitas/decor, in un primo tempo è l’utilitas a prevalere sul decor;
ci si preoccupa infatti che la propria abitazione sia costruita a regola d’arte, ma non si bada troppo alla sua
decorazione. Quando i Romani vennero in contatto con i diversi aspetti della cultura e dell’arte greca,
rimasero affascinati anche dagli arredi; furono perciò importati emblemata da diverse officine greche e
furono chiamati a operare mosaicisti di origine greca.
Con il termine di emblemata si definiscono i pannelli eseguiti in officina, allettati su una lastra di travertino
o di terracotta e poi inseriti al centro di pavimenti in tessellato o cementizio; spesso essi rappresentano la
trasposizione nella tecnica musiva della pittura da cavalletto.
Quando un emblema, o genericamente un tessellato, è realizzato con tessere minutissime dal forte effetto
pittorico, si è soliti definire tale tecnica come vermiculatum come se fosse formato da minuti “vermi”
colorati.
La casa del Fauno a Pompei
Un cospicuo campionario di mosaici figurati, affiancato a una decorazione parietale in “stile strutturale”, è
testimoniato a Pompei dalla Casa del Fauno, lussuosa dimora degna di un principe che, verso la fine del
secolo II a.C. nella sua seconda fase edilizia, per articolazione e per estensione è raffrontabile ai grandi
complessi palaziali dell’Oriente ellenistico. Dalle stanze affacciate sull’atrio provengono emblemata in
vermiculatum con l’unione erotica di un saturo e una menade. Le sale da pranzo presentano temi bacchici
connessi al vino e “nature morte” o raffigurazioni relative al cibo. I due triclini della Casa del Fauno sono
ricoperti da emblemata con Bacco fanciullo in groppa a una tigre che beve vino da un cantaro e con una
fauna marina con pesci e al centro la lotta tra un polpo e un’aragosta, e il secondo di questi soggetti
accomuna mosaico e pittura, a ennesima testimonianza della diffusione di modelli comuni.
Il tablino della dimora è decorato in scutulatum, pavimento ottenuto dalla giustapposizione di rombi di
travertino, ardesia e calcare verde, a creare un motivo di cubi prospettici.
Nell’ambiente più prestigioso della casa, l’esedra che si apre sul primo peristilio con un prospetto a due
colonne corinzie con capitelli in tufo stuccati e dipinti di splendida fattura, una soglia con paesaggio nilotico
dà accesso al celebre mosaico con una battaglia di Alessandro Magno sul re persiano Dario III, con figure a
grandezza naturale.
Pavimenti in opus sectile
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Nella tarda età repubblicana, gli ambienti di rappresentanza delle residenze vedono l’uso anche di
pavimenti (o rivestimenti parietali) pregiati in opus sectile, o sectilia pavimenta, costituiti da lastrine di
marmi di colore diverso ritagliate e utilizzate in composizioni geometriche, vegetali o figurate.
Il tessellato
I più antichi pavimenti in tessellato risalgono al secolo II a.C. e sono ornati di motivi punteggiati o lineari,
desunti dal repertorio dei cementizi, oppure di scaglie di pietre colorate e marmi, proprie dello scutulatum;
con queste due tecniche coesiste il tessellato. Il repertorio dei motivi decorativi può considerarsi formato
nel periodo che va dal secolo II all’inizio del secolo I a.C., quando i pavimenti musivi appartengono a edifici
le cui decorazioni parietali corrispondono allo “stile strutturale” e alla fase iniziale del “II stile”.
La villa dei Volusii Saturnini
Un importante complesso di mosaici tardorepubblicani è stato rinvenuto nella villa dei Volusii Saturnini,
famiglia appartenete all’ordine senatorio, a una trentina di chilometri da Roma, ove eleganti pavimenti
della fase originaria degli anni 60-50 a.C. sono spesso caratterizzati da effetti policromi tridimensionali: una
soglia con cassettonato divide un campo bianco con piccoli rombi a tappeto dall’altro campo con reticolato
di losanghe.
Il mosaico bianco-nero
Ben presto la decorazione in bianco-nero prende il sopravvento per ragioni che agiscono in maniera
complementare: motivi di ordine economico, poiché è lecito supporre che, impiegando due soli colori e il
calcare più frequentemente del marmo, i costi fossero inferiori, e che, essendo la posa delle tessere per la
composizione della trama in linea di massima più semplice, fossero richieste maestranze meno qualificate.
Dall’ultimo secolo della Repubblica, i mosaici in bianco-nero si diffondono in concomitanza con gli inizi del
“II stile” pittorico per predominare fino alla seconda metà del secolo II d.C. nella decorazione dei pavimenti
della quasi totalità degli ambienti di case e ville, delle aule all’interno di basiliche e delle sale termali.
Nel periodo più antico del mosaico in bianco-nero, definito severo, il tessellato bianco può costituire
l’intero pavimento, adornato da una semplice fascia di cornice a tessere nere, oppure un disegno si estende
a tutta la superficie pavimentale. Appaiono frequenti i riquadri centrali e le ampie fasce che ornano le
soglie delle stanze a mo’ di tappeti e che nei cubicoli simulano gli scendiletto.
Fra i motivi decorativi sfruttati per ricoprire tutto il pavimento, figurano le crocette disposte in filari
orizzontali o verticali, il reticolo di rombi, il cancello, le squame, semplicemente delineate o bipartite in
bianco-nero, e tanti altri ancora, anche più complessi. Elementi a meandro, a onde correnti, a treccia
creano le fasce di contorno di campi bianchi. Il successo del bianco-nero risulta particolarmente fecondo in
quanto genera una incredibile varietà di combinazioni a partire da un numero limitato di elementi di base
che, variando il modulo, offrono effetti visivi del tutto diversi. Un nuovo gusto è documentato dagli ultimi
decenni del secolo I a.C. per tutto il secolo I d.C., associandosi alle decorazioni parietali della fase finale del
“II”, del “III” e del “IV stile”: gli ornati constano di varie combinazioni di un solo elemento moltiplicato a
tappeto. Ne scaturiscono le composizioni ad alveare di esagoni, le stelle di rombi e quadrati, gli ottagoni e i
quadrati e le varietà dei triangoli.
Verso la metà del secolo I d.C. i mosaicisti abbandonano la sobrietà distintiva delle fasi anteriori e tendono
ad affollare di ornamentazioni e riempitivi i campi decorati, ora estesi spesso a tutta la superficie del
pavimento. Il fondo bianco del mosaico è di gran lunga prevalente nel disegno ornamentale eseguito in
tessere nere; poco frequenti sono gli ornamenti campiti in nero, mentre rari sono quelli delineati in bianco
su fondo nero. Nello stesso periodo in Italia il gusto per la policromia è in netto regresso, e l’uso delle
tessere colorate è limitato per lo più a quei motivi che nella tarda Repubblica avevano conservato una
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
tradizione policroma, quali rosette, trecce e riempitivi di vario genere; ma in altre aree del mondo antico,
come l’Oriente e l’Africa settentrionale, il mosaico policromo conosce un’esuberante fioritura.
Una tappa fondamentale nell’evoluzione del mosaico in Italia è attribuita al periodo adrianeo, intorno al
120-130 d.C., quando fa la sua comparsa un nuovo stile, detto “fiorito”, che, persistente sino all’età di
Antonino Pio, si esprime con un repertorio ornamentale fondato sulle linee movimentate e curve e su
ornati vegetali stilizzati e arabeschi.
Un’ampia documentazione di tale stile è offerta dai pavimenti degli “Hospitalia” di Villa Adrianea.
Le zone destinate ad accogliere i letti presentano mosaici con fini motivi geometrici che si rifanno a un
repertorio più antico, mentre il centro dell’ambiente è occupato da motivi rettilinei o arabescati disposti a
creare nitide composizioni simili a delicati ricami a larghe maglie. Fioroni ordinati a raggiera intorno a un
rosone centrale sono spesso circondati da leggere corone tangenti tra di loro e formano una decorazione di
grande estensione.
Abbiamo testimonianze dell’utilizzo della tecnica del bianco-nero in piazza dei Cinquecento a Roma, a Ostia
nella zona del porto e dell’emporio in alcune insulae e nelle terme.
I pavimenti musivi in contesti funerari possono prevedere soggetti che si prestano anche a una lettura
simbolica facilmente decifrabile, come il ratto di Proserpina, diffuso anche su urne, are e sarcofagi, dove
costituisce il secondo gruppo più consistente con immagini mitiche.
Il mosaico bianco-nero dai Severi al secolo III d.C.
I pavimenti dell’epoca dei Severi segnano un mutamento di gusto e stile nel panorama del mosaico, i cui
decori in bianco-nero tendono ad assumere una fisionomia particolare: appaiono prediletti i fondi neri, ma
sono ampiamente diffusi anche gli ornati campiti in nero su fondo bianco, e si afferma il gusto per i
contorni curvi, sinuosi e movimentati, mentre nelle pitture parietali è in auge lo “stile lineare” rosso e
verde. Fra i motivi geometrici in bianco-nero, comunque limitati nel corso del secolo III d.C., predominano
pelte, squame, bipenni, mentre si dà vita ad altri come dischi, sinusoidi, doppie asce, sagome di vasi,
elementi polilobati, che riempiono il campo con pesanti macchie nere su fondo bianco.
Sono molto amate nel secolo III d.C. le composizioni centralizzate, che si ritengono derivate dall’imitazione
di coperture a volta con apertura nel mezzo e che sono documentate con grande varietà di tipi; fra questi si
segnalano gli schemi “a medaglioni”, o quelli in cui, intorno a un tondo centrale, si dispongono altri campi
circolari formati dall’intrecciarsi d due o più nastri. Nel repertorio floreale si rilevano esiti opposti: un più
accentuato naturalismo dei decori vegetali accanto a un progressivo impoverimento e irrigidimento degli
elementi compositivi. Altro aspetto caratteristico del mosaico dell’epoca è l’inserzione, all’interno di un
complesso ornato vegetale, di figure desunte dal repertorio bacchico o da quello delle cacce.
La ripresa del mosaico policromo
Il periodo segna anche la crescente diffusione dell’uso del mosaico policromo. Un’innovazione nelle
redazioni musive è rappresentata dall’impiego esclusivo o prevalente di tessere di materiali marmorei e di
pietre dure in luogo di quello calcarei o silicei usati tradizionalmente nel mosaico comune, sia monocromo
sia policromo. I temi dei “nuovi” mosaici policromi erano lotte tra gladiatori, cacce, catture e animali
esotici.
I mosaici delle ville tardoantiche della Sicilia
I pavimenti musivi della Sicilia tardoantica sono riconducibili a maestranze operanti nei grandi centri
dell’Africa settentrionale, nel momento in cui era una delle regioni, almeno nella parte occidentale
dell’Impero, economicamente e culturalmente più avanzate. La villa del Casale di Piazza Armerina ha
restituito un complesso di mosaici pavimentali senza precedenti (3500 mq) in cui è possibile ravvisare uno
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
stretto rapporto tra decorazione musiva e funzione, abitativa o “cerimoniale”, dei diversi ambienti, a
partire dal vestibolo decorato con una scena di salutatio, mentre, nel settore termale, il frigidarium nelle
absidi metteva in scena le attività reali che vi si potevano svolgere e al centro il mondo fantastico di un
corteo marino con nereidi, centauri, tritoni ed eroti, consoni al contesto. I pavimenti delle stanze “dei
bambini”, con le raffigurazioni di ragazzi e uccelli in mezzo alla vegetazione, presentano analogie talmente
strette con le immagini della Casa dei Cavalli di Cartagine da avvalorare non solo l’attività di officine
africane itineranti, ma anche l’utilizzazione degli stessi cartoni.
Il complesso “teodoriano” di Aquileia
Una testimonianza importante per valutare l’arte musiva dei primi decenni del secolo IV d.C. è costituita dai
pavimenti del complesso paleocristiano della città di Aquileia in Friuli, detto “teodoriano”, perché opera del
vescovo Teodoro. Si tratta di una committenza che risponde alle necessità dei nuovi luoghi di culto cristiani.
L’edificio consiste in una costruzione, costituita da due aule parallele, i cui pavimenti sono interamente
mosaicati, collegate fra di loro da una terza, trasversale, pavimentata a cocciopesto.
Nelle due aule i pavimenti sono divisi in quattro sezioni o campate ricoperte da tappeti a motivi geometrici
e vegetali, che non presentano differenze rispetto ai pavimenti destinati a edifici privati o civili a uso
pubblico.
19.2 I mosaici pavimentali nelle province dell’Impero
La media età imperiale vede la nascita e lo sviluppo delle “scuole” provinciali; ogni scuola si richiama alle
proprie tradizioni figurative ed esprimere tendenze di gusto locale con conseguenti esiti stilistici assai
diversificati. Nelle regioni entrate nell’orbita romana, dalla Britannia all’Africa, i pavimenti musivi sono
realizzati in un primo momento da squadre di maestranze itineranti venute dall’Italia; successivamente,
appresa la tecnica, nascono nuove officine.
Nelle Gallie, i primi pavimenti decorati tra la fine del secolo I a.C. e il secolo I d.C. portano
inequivocabilmente il marchio di Roma e dell’Italia. Il mosaico gallo-romano si distingue a partire dagli inizi
del secolo II d.C., soprattutto nella media valle del Rodano, mostrando una predilezione per le forme
geometriche, in particolare il reticolato, e per riempitivi policromi di inesauribile fantasia.
In Britannia sono particolarmente significativi i mosaici del “palazzo” di Fishbourne nel Sussex, una villa che,
senza pari di grandezza e lusso in quella provincia, è stata considerata sede del re locale, ricompensato con
la cittadinanza romana per le sue simpatie romane; gli esemplari più antichi, databili intorno al 75 d.C.,
attribuiti ad artefici forse dalla Gallia, sono per lo più in bianco-nero, ma non manca qualche esemplare
policromo, mentre a partire dal secolo II d.C. il complesso subisce modifiche e le stanze sono pavimentate
da mosaici policromi figurati.
Anche nella penisola iberica i pavimenti musivi si sviluppano in base alle influenze provenienti dall’Italia: nel
secolo II d.C. sono prevalenti quelli in bianco-nero, ma si diffonde il gusto anche per una limitata policromia
con fasce colorate in pavimenti in bianco-nero o con quattro colori, bianco, nero, rosso e giallo. In seguito
all’età imperiale si rileva un forte influsso delle officine africane, in particolare nella decorazione musiva
delle ville di secolo IV d.C.
Nell’Africa settentrionale, dopo la conquista romana, l’influsso di artigiani italici è documentato da uno
scarso numero di mosaici in bianco-nero, ma è dall’inizio del secolo II d.C. che le officine si impiantano
soprattutto nei centri costieri della provincia proconsolare, poi anche nell’interno, dando vita
progressivamente alla feconda e creativa “scuola” africana. Nei mosaici pavimentali prevalgono l’uso della
policromia e un intenso senso del colore che trova i mezzi tecnici per esprimersi nella varietà dei marmi
locali e delle paste vitree. Ai ricchi motivi floreali e ornamentali si aggiunge, almeno alla fine del secolo II
d.C., l’elaborazione di grandi scene figurate: scene mitologiche, lavori agricoli, cacce, circhi e anfiteatri.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Anche in Grecia la comparsa delle scene policrome figurate si pone nella media e tarda età imperiale.
In Siria e nelle province orientali il mosaico policromo prospera anche in relazione all’uso diffuso dei
tappeti, di cui i mosaici sono intesi come una sostituzione e un complemento. Gli splendidi mosaici
pavimentali degli edifici pubblici e residenziali di Antiochia, sede del governatore romano della Siria, e delle
ville del sobborgo di Dafne documentano l’ininterrotta attività delle officine fino alla fine del secolo IV d.C.
e offrono informazioni sulla vita cittadina, sui costumi, sulla cultura e sulla religione degli abitanti, talora
con scene su uno sfondo che evoca le scenografie teatrali.
19.3 I mosaici parietali e su volte
Mosaici parietali e su volte non hanno precedenti nell’arte greca e costituiscono una decorazione tutta
romana, che ha una lunga storia prima di approdare agli alti raggiungimenti nelle absidi e nelle navate delle
chiese tardoantiche e bizantine. La loro origine deriverebbe dal costume di decorare con conchiglie,
pomice, concrezioni marine, scaglie di marmo e pezzi di vetro grotte e ninfei delle ville e dei giardini della
tarda età repubblicana.
Nella prima metà del secolo I d.C. la tecnica, che si giova dell’uso di tessere di vetri e di altri materiali,
diviene comune in ninfei, fontane, sacelli, larari e ambienti sotterranei.
A Roma i mosaici parietali, della seconda metà del secolo I d.C. rappresentano una scoperta archeologica di
grande valore. Si tratta di un’opera estesa per quasi 16 m lungo una parete e scavata fino a una profondità
di 2 m, in un vano alto circa 13-14 m, attiguo a un ninfeo con abside anch’essa decorata a mosaico. La
straordinaria qualità della decorazione – una struttura a nicchie e colonne in cui s’inseriscono vari
personaggi – lascia ipotizzare che il mosaico appartenesse a un ambiente interno di un edificio di
eccezionale livello;
successivamente si rilevano decorazioni musive su volte nei secoli II e III d.C., spesso in edifici collegati con
l’acqua, innanzitutto balnea, terme e mitrei.
A Roma, nella necropoli sotto la basilica Vaticana e la tomba di S. Pietro, il sepolcro dei Marcii, di età
protoseveriana, presentava in facciata, ai lati della porta, due emblemata musivi realizzati direttamente su
un bipedale. L’insieme delle immagini risale a una fase di ristrutturazione della tomba nella seconda metà
del secolo III d.C., in un momento in cui il repertorio dell’arte cristiana si sta formando, e attesta la presenza
di un gruppo familiare aderente al cristianesimo.
Il secolo IV d.C. segna l’avvento generalizzato del mosaico nel sistema decorativo della cupola dei grandi
mausolei, mentre le pareti sono generalmente rivestite da lussuose lastre marmoree di opus sectile.
Durante i secoli IV e V d.C. la produzione musiva parietale e delle volte trova piena espressione, oltre che a
Roma, a Napoli e a Ravenna e in Oriente, per raggiungere nel secolo VI il più alto sviluppo qualitativo.
Capitolo 20 – Decorazione e arredi dei sepolcri
Necropoli – sistemi strutturati autonomi che rispecchiano la società non come è, ma come essa si vuole
rappresentare, fornendo molte informazioni sull’insieme socio-economico, culturale e ideologico di una
collettività. L’arredo interno ed esterno dei sepolcri, oltre alle decorazioni pittoriche e musive, comportò
anche più specifiche produzioni in marmo.
Monumentum e sepulcrum. L’epigrafia funeraria ricorre principalmente a questi due termini per indicare il
singolo monumento funerario.
“Hominem mortuum in urbe neve sepelito neve urito” = Né si seppellisca, né si bruci un cadavere in città
Così sancisce la legge della decima delle XII tavole: la prescrizione, nata verosimilmente in conformità a
esigenze igienico-sanitarie, allontanava le sepolture degli individui adulti dagli spazi dei vivi.
Non si potevano seppellire i cadaveri all’interno del pomerio, simbolico confine di natura sacrale e giuridica,
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
ma la prescrizione non sempre fu rispettata; furono comunque previste eccezioni per diversi “eroi”
repubblicani.
All’epoca repubblicana si poteva ancora scegliere tra inumazione, cremazione e imbalsamazione; dal secolo
II a.C. fu molto diffusa la cremazione, mentre dall’inizio del secolo II d.C. si affermò il rito dell’inumazione.
20.1 Le produzioni dei secoli I-II d.C.
Roma, secolo VIII a.C., quadrante est della città adibito a necropoli (Regione V). Una porzione non piccola di
suolo pubblico fu adibita alla cremazione e al seppellimento di poveri e condannati a morte: sono i puticoli,
pozzetti comuni, probabilmente in cilindri di terracotta chiusi da un coperchio.
Fin dall’età mediorepubblicana sono presenti importanti sepolcri individuali di alto livello. Alcune delle più
ricche gentes preferirono farsi seppellire in monumenti eretti in aree di loro proprietà, spesso nei pressi di
templi.
Al I miglio della via Appia, venne alla luce nel 1780 un mausoleo funerario ipogeo scavato in un banco di
cappellaccio. L’interno si articolava in un sistema di gallerie disposte secondo uno schema quadrangolare,
con un corridoio a braccia intersecate e precedute da un piccolo vestibolo: la camera funeraria poté
accogliere nel tempo oltre una trentina di sarcofagi (ne conosciamo solo nove), posti intorno al sarcofago,
in posizione assiale rispetto all’ingresso, del fondatore L. Cornelio Scipione Barbato, console del 298 a.C.
La tomba si apriva con una facciata monumentale su alto podio in blocchi di tufo, a imitazione di un
prospetto architettonico. Il livello più antico sembra avere presentato un motivo dipinto a onde correnti di
derivazione ellenistica; gli altri strati offrono frammenti di scene di combattimento e di trionfo con figure
impostate su alto zoccolo rosso.
La produzione dei rilievi, definiti “a cassetta” per la forma sovente rettangolare, s’inquadra alla fine del
secolo II a.C. e l’età augustea. Questi ripetevano volti, gesti e attributi di individui di famiglie di ingenui di
non elevato lignaggio e di liberti, desiderose di ascesa sociale e prestigio. Su un totale di almeno 270 rilievi
“a cassetta” prodotti a Roma, 77 conservano l’iscrizione con le generalità dei defunti. Gli uomini si
presentano di norma con la toga sopra la tunica; le loro spose indossano tunica, stola e palla, indumenti
adatti a sottolinearne la pudicitia; i figli sfoggiano spesso la bulla, un grosso ciondolo circolare indossato al
collo contenente amuleti, esclusivo dei cittadini nati liberi.
Nel momento in cui smisero di produrre i rilievi a cassetta, le officine si specializzarono nella fabbricazione
su grande scala di are funerarie: nella sola Roma ne sono state rinvenute oltre 700.
L’assenza costante di decorazione sul retro può implicare la possibilità della collocazione contro parete, che
non esclude però una disposizione più libera al centro delle strutture, coperte o a cielo aperto che fossero.
Le are, per lo più in forma di parallelepipedi con pulvini e volute o frontoncini di coronamento e di
dimensioni piuttosto contenute. Erano acquistate di norma da un congiunto e non prevedevano il
reimpiego da parte di generazioni successive.
La produzione raggiunse l’apice tra l’età flavia e quella protoadrianea. Eppure il repertorio di immagini
diverge da quello prediletto appena qualche decennio dopo dai sarcofagi: sono rare le raffigurazioni di
divinità singole e pressoché assenti gli episodi del mito. Bacini iconografici privilegiati sono piuttosto la
sfera rituale o raffigurazioni riguardanti i defunti in prima persona.
Le effigi dei defunti, spesso nella forma abbreviata di busti inseriti entro clipei, medaglioni vegetali o
conchiglioni, occupano il piccolo triangolo del frontoncino o il centro della fronte, compaiono poi
riferimenti alle loro professioni.
Fabbricate in ambito urbano, le urne di marmo presentano forma rettangolare o cilindrica. La decorazione
prevede ornamenti vegetali, porte che configurano l’urna quale dimora del morto o quale tempietto,
raffigurazioni dei defunti per lo più sotto forma di busti in miniatura, loro immagini in coppie a figura intera
nel gesto della dextrarum iunctio e segni emblematici.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
A partire dalla metà del secolo I a.C. si diffuse per qualche generazione a Roma e in alcuni centri campani,
l’uso di sepolture collettive per membri di collegi o di associazioni professionali, capaci di una notevole
recettività: sono i columbaria, complessi semi- o interamente ipogei, alle cui pareti erano serie multiple di
filari di nicchie, sovrapposte le une alle altre, destinate a contenere le urne o le olle con le ceneri.
Dall’età tardoflavia uomini e donne iniziarono a farsi raffigurare nudi riprendendo in modo esplicito schemi
e attributi di divinità ed eroi. I modelli prescelti furono per le donne soprattutto Venere, Cerere, Diana,
Fortuna, Igea, Minerva e Spes – Ercule, Esculapio, Mercurio, o, più di rado Bacco, Attis o Ganimede per gli
uomini.
La moda dei tempietti funerari, nella tipologia di prostili, esplose a partire dall’età traianea, in Italia e in
Occidente. Le tombe presentavano di norma elevati in laterizio, lungo le principali arterie di traffico o
all’interno delle ville.
Risulta molto ben studiata la necropoli di Porto all’Isola Sacra, sorta direttamente ai lati di via Flavia a nord
di Ostia, in uso tra la fine del secolo I e il IV d.C.: i primi edifici si datano al momento della fase del lento ma
più deciso passaggio tra il rito della cremazione e quello dell’inumazione. Le strutture più monumentali
sono in maggioranza a cella quadrangolare, a due piani, coperte a botte o provviste di terrazza; all’interno
arredo in mosaico pavimentale, pitture parietali e rivestimenti in stucco. La scelta del rito funerario si
rifletteva sull’articolazione dello spazio interno: nicchie su vari registri nel caso di olle contenenti le ossa dei
cremati o arcosoli ricavati nelle pareti e piani ricavati al di sotto del pavimento, atti a ospitare sarcofagi e
casse fittili degli inumati; ma talora i due sistemi coesistevano all’interno dello stesso edificio.
Le iscrizioni testimoniano come tutte le tombe monumentali di Porto fossero sepulchra familia, destinati al
fondatore, ai membri della famiglia e spesso pure ai loro liberti.
La necropoli fu soprattutto utilizzata da quelli che chiamiamo convenzionalmente “ceti medi”: le iscrizioni
nelle facciate degli edifici ricordano i nomi dei proprietari, i loro testamenti e talora le norme per l’utilizzo
dei sepolcri.
Tomba dei Valeri nella necropoli vaticana
La più grande delle tombe familiari (chiamata “H”) nella necropoli vaticana sotto la basilica e la tomba di S.
Pietro, fu costruita dal ricco liberto C. Valerius Herma per sé, moglie, figli, liberti e liberte e i loro
discendenti. Progettata per contenere 170 persone, è arrivata ad ospitarne 250.
Il sepolcro, con una facciata che imita un prospetto templare e dotato di un cortile antistante, fu eretto
subito dopo la metà del secolo II d.C.; un terrazzo superiore garantiva lo svolgimento di riti e banchetti
funebri. Diversi riti di sepoltura, la cremazione fu utilizzata per i membri meno importanti della famiglia.
20.2 Secoli II-IV d.C. (e rinascite “post-antiche”): i sarcofagi
La progressiva sostituzione della cremazione con l’inumazione incentivò dall’età traianea-adrianea la
fabbricazione su grande scala di sarcofagi litici: a oggi se ne conoscono più di 15mila sino all’epoca
costantiniana, e i dati sono parziali.
Già alla prima età imperiale risalgono i primi esperimenti, per lo più urbani. I non moltissimi esemplari a
cassa liscia con angoli interni brevi stondati presentano, quale unico elemento decorativo, un’incorniciatura
semplice modanata sui quattro lati; ancora rari in questa fase i temi mitologici strettamente legati all’aldilà.
Dal secolo II d.C. tende a prevalere la forma a basso parallelepipedo, la cui base è molto più allungata
rispetto all’altezza: in questi esemplari le immagini sono caratterizzate da figure distribuite sulla superficie
in modo chiaro e separate da spazi. Con il passare del tempo si assiste allo sviluppo in altezza delle casse; le
figure si disporranno su più piani sovrapposti in intricati rapporti reciproci. Durante il secolo III d.C.
comparve un nuovo tipo di cassa, piuttosto alta e con angoli arrotondati: è la lenòs.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
Anche le tipologie dei coperchi potevano variare. Spesso sul coperchio era previsto l’inserimento di un
pannello epigrafico con l’indicazione delle generalità dei defunti.
La maggior parte dei sarcofagi era adorna di ornamenti non narrativi (semplici ghirlande e festoni o più
economiche strigilature). Infine i sarcofagi marmorei potevano accogliere più di un defunto e furono
perfino sovente riutilizzati, semplicemente riattualizzandone ritratti o dati onomastici.
A seconda dei periodi, si registrano novità e abbandoni nella selezione dei soggetti. Nelle prime casse dal
130-140 d.C. predominano le ghirlande, al di sopra delle quali si possono succedere vignette con scene
mitiche. In seguito prevalgono le scene mitologiche, suscettibili di una lettura analogica, atta a trasformare
le vecchie storie mitiche in exempla mortalitatis.
Molto attestate sono poi le “visioni di felicità”: i festosi cortei marini e bacchici, con oltre 400 esemplari
ciascuno, dagli inizi del secolo II alla fine del III d.C.
Dalla prima metà del secolo III d.C. divenne sempre più frequente la sostituzione del volto dell’eroe mitico
con il ritratto dei defunti e dei congiunti: un chiaro espediente per innestare su di loro le virtù eroiche,
stabilendo un legame ancora più diretto con miti per lo più centrati sulla morte e sull’amore.
Dall’inizio del III secolo d.C. si registra un graduale abbandono dei soggetti mitologici. Spazio sempre
maggiore fu allora lasciato alle Stagioni e alle scene bucoliche.
Le officine urbane adattarono le produzioni alle nuove mode, passando dalla manifattura di stele, rilievi e
are a quella di sarcofagi monumentali: quelli scolpiti direttamente a Roma non furono però gli unici a
circolare in città.
Le lavorazioni avvenivano a tappe: la sbozzatura nei pressi della cava, la rifinitura nei depositi (in Grecia o in
Asia Minore) e, infine, piccoli interventi di ritocco e completamento nel luogo di collocazione finale.
Una delle manifatture più eleganti e costose fu quella attica. Concepiti per essere decorati sui quattro lati, a
differenza degli esemplari di produzione urbana, in particolare con miti vari, talvolta fianchi e retro non
furono mai completati: segno che, una volta a destinazione, i sarcofagi furono utilizzati senza fare ricorso al
personale specializzato.
Intorno alla metà del secolo III d.C. un sarcofago attico fu decorato su ben quattro lati con scene della vita
di Achille; le figure, dal linguaggio formale “classicistico” per modellazione e superfici levigate, sono tanto
fitte da fare quasi scomparire il fondo del rilievo: sul coperchio, gli sposi sono sdraiati su kliné.
Intorno al 150 d.C. fu scolpito il sarcofago di Velletri. Eccezionali sono sia l’impiego di tre blocchi unici di
marmo differenti (pentelico per il basamento e lunense per la cassa), sia la selezione di più miti offerti sulle
quattro facce e legati alla morte, all’aldilà e alle speranze di salvezza dei defunti, sia la stessa disposizione
delle figure: i due registri, con partizione architettonica a imitazione delle scene teatrali, si affollano di
personaggi con altri elaborati ad hoc per l’occasione.
Dalla prima metà del secolo II d.C. prese avvio anche la produzione dei sarcofagi asiatici di grandi
dimensioni. Il tipo principale, prodotto a Docimio in Frigia in marmo docimeno bianco a cristalli fini, dalla
metà del secolo II al 260-270 d.C. circa, ha spesso un’articolazione architettonica con cinque nicchie sui lati
lunghi, scandite da colonnine corinzie tortili e ospitanti per lo più figure mitologiche negli intercolumni; il
coperchio è dapprima a doppio spiovente, in seguito prevalentemente a kliné.
Tra l’età antoniniana e la prima metà del secolo III d.C. si avviò la produzione di lastre marmoree per la
chiusura di loculi nelle necropoli di Roma, Ostia e Porto che, imitando la fronte dei sarcofagi, ne
costituivano una versione più economica sfruttata anche da personaggi di origine libertina.
Insieme agli ipogei privati e alle catacombe, dalla prima età severiana ricomparvero monumenti singoli che,
come quelli tardorepubblicani, si affacciavano lungo le principali vie consolari.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
lOMoARcPSD|9887176
A Roma e dintorni si affermò allora la tipologia dei sarcofagi monumentali all’aperto e innalzati su
basamenti o alti podi: scelta che enfatizzava la sepoltura rispetto all’area circostante. Uno degli esemplari
più noti è la “tomba di Nerone”, un sarcofago con acroteri enormi su un alto podio in cortina di laterizi
eretto sulla via Cassia.
Ancora per tutto il secolo IV d.C. andò avanti la produzione di sarcofagi decorati. Si eclissarono i miti,
mentre continuarono le immagini “profane”, benché più diradate, come le scene bucoliche, di caccia e di
rappresentanza. Sui sarcofagi cristiani la professione di identità non è più nei termini di stato sociale ma di
fede.
La produzione dei sarcofagi a Roma s’interruppe dopo il primo terzo del secolo V d.C.
A cambiare furono evidentemente mentalità e bisogni: il desiderio di nuove forme d’inumazione, nelle
immediate vicinanze delle tombe dei martiri, gli “eroi” cristiani il cui culto fu particolarmente promosso da
papa Damaso, nelle catacombe o nei pressi dei luoghi delle celebrazioni eucaristiche, ridusse in modo
drastico il bisogno dell’inumazione entro le casse marmoree.
Costantinopoli e Ravenna costituirono fulgide eccezioni; manifattura e uso dei sarcofagi a rilievo vi sono
attestati fino il secolo VI d.C.: la presenza dell’imperatore e degli alti funzionari influì sulla persistenza
dell’ormai secolare tradizione.
Ben più di altri materiali, i sarcofagi sono stati decisivi per le “rinascite” dell’arte romana nella cultura
figurativa moderna. Riutilizzati già a partire dal secolo X d.C. come sepolture di imperatori, furono
addirittura il modello di artisti di grande fama tra il 1200 e il 1500 alle prese con il riadattamento delle più
efficaci formule iconografiche antiche, destinate a nuova fortuna.
esempi: Nicola Pisano pulpito di Siena, Giotto nella Cappella degli Scrovegni, Raffaello nella Deposizione alla
Galleria Borghese.
Scaricato da Martina Baudini (flor_12_ct@hotmail.it)
Potrebbero piacerti anche
- Il Cinquecento: Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 48Da EverandIl Cinquecento: Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 48Nessuna valutazione finora
- Arte Italiana e AnticaDocumento38 pagineArte Italiana e Anticabenefactor56100% (1)
- Arnold Hauser - Storia Sociale Dell'arte - Vol 1bDocumento84 pagineArnold Hauser - Storia Sociale Dell'arte - Vol 1bCosmina-Ruxandra Marcu100% (4)
- Storia Del Diritto Romano XII Edizione PDFDocumento788 pagineStoria Del Diritto Romano XII Edizione PDFEdwin RoncancioNessuna valutazione finora
- Il Seicento - Arti visive (53): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 54Da EverandIl Seicento - Arti visive (53): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 54Nessuna valutazione finora
- L Ottocento - Arti visive (65): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 66Da EverandL Ottocento - Arti visive (65): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 66Nessuna valutazione finora
- Archi e Volte in Zona SismicaDocumento47 pagineArchi e Volte in Zona SismicaFabioNessuna valutazione finora
- Contemporanea: Appunti di storia dell’arte dal Neoclassicismo a oggiDa EverandContemporanea: Appunti di storia dell’arte dal Neoclassicismo a oggiNessuna valutazione finora
- Arte Settecento - NovecentoDocumento72 pagineArte Settecento - NovecentoBrienne R FrobisherNessuna valutazione finora
- Storia Dell'Arte Contemporanea - Manuale Con ImgsDocumento57 pagineStoria Dell'Arte Contemporanea - Manuale Con Imgsbarba000Nessuna valutazione finora
- L'antica Roma - Le città, l’esercito e gli imperatoriDa EverandL'antica Roma - Le città, l’esercito e gli imperatoriValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- CiceroneDocumento20 pagineCiceroneVincenzo TrittaNessuna valutazione finora
- Arte Romana Zanker PDFDocumento18 pagineArte Romana Zanker PDFEnza Di SistoNessuna valutazione finora
- Il Novecento - Arti visive (71): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 72Da EverandIl Novecento - Arti visive (71): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 72Nessuna valutazione finora
- Antichità - La civiltà romana - Arti visive: Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 15Da EverandAntichità - La civiltà romana - Arti visive: Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 15Nessuna valutazione finora
- Tritemio - de Septem SecundeisDocumento21 pagineTritemio - de Septem SecundeisAnonymous FaJ8Z8f100% (1)
- Codice Topografico Della Città Di Roma-Vol1Documento408 pagineCodice Topografico Della Città Di Roma-Vol1Basil LouriéNessuna valutazione finora
- Arte e Archeologia Del Mondo Romano Riassunto Torelli Menichetti GrassigliDocumento42 pagineArte e Archeologia Del Mondo Romano Riassunto Torelli Menichetti GrassigliValeria Ioviero100% (2)
- Arte Romana Zanker PDFDocumento18 pagineArte Romana Zanker PDFSakura95100% (1)
- Castelnuovo Ginzburg Centro e PeriferiaDocumento106 pagineCastelnuovo Ginzburg Centro e Periferiaguamaradei100% (2)
- Dionigi Di Alicarnasso - Le Antichità Romane Vol.2Documento415 pagineDionigi Di Alicarnasso - Le Antichità Romane Vol.2leonardo7804Nessuna valutazione finora
- Neoclassicismo Di HonourDocumento9 pagineNeoclassicismo Di HonourElisa ManuzzatoNessuna valutazione finora
- Ipsam Nolam Barbari Vastaverunt. L'Italia e Il Mediterraneo Occidentale Tra Il V Secolo e La Metà Del VI.Documento196 pagineIpsam Nolam Barbari Vastaverunt. L'Italia e Il Mediterraneo Occidentale Tra Il V Secolo e La Metà Del VI.MiciagiallaNessuna valutazione finora
- Arte Romana - M. PapiniDocumento6 pagineArte Romana - M. PapiniNicoNessuna valutazione finora
- Genesi e Caratteristiche Del Linguaggio Neoclassico EuropeoDocumento3 pagineGenesi e Caratteristiche Del Linguaggio Neoclassico EuropeoJaime Vigliano GirandoNessuna valutazione finora
- RIASSUNTO La Storia Dell'arte. Dal Barocco All'art Nouveau, Vol.4Documento36 pagineRIASSUNTO La Storia Dell'arte. Dal Barocco All'art Nouveau, Vol.4Rebecca BattistiNessuna valutazione finora
- Neoclassico e Romantico W M SDocumento3 pagineNeoclassico e Romantico W M Samina saidiNessuna valutazione finora
- LEZIONE 3 - ARTE GRECA I ParteDocumento11 pagineLEZIONE 3 - ARTE GRECA I Partenoidea666Nessuna valutazione finora
- Stilul RenascentistDocumento89 pagineStilul RenascentistION GĂNGUȚNessuna valutazione finora
- Neoclassicismo Hugh Honour Riassunto CompletoDocumento33 pagineNeoclassicismo Hugh Honour Riassunto Completo678ojyhdsfdiopNessuna valutazione finora
- NeoclassicismoDocumento9 pagineNeoclassicismoEragon BromsoonNessuna valutazione finora
- Cronologia Della Storia Dell' ArteDocumento42 pagineCronologia Della Storia Dell' ArteRosangelaNessuna valutazione finora
- Il Barocco Nelle ArtiDocumento6 pagineIl Barocco Nelle ArtiRodrigo Cássio OliveiraNessuna valutazione finora
- L'arte Nel RinascimentoDocumento30 pagineL'arte Nel RinascimentoSuzana E PepaNessuna valutazione finora
- Il Linguaggio Dell Arte Romana Di TonioDocumento30 pagineIl Linguaggio Dell Arte Romana Di TonioMic SNessuna valutazione finora
- Metodologia Della Storia Dell'arteDocumento32 pagineMetodologia Della Storia Dell'arteIrene FarinelliNessuna valutazione finora
- A arte egea.PDFDocumento460 pagineA arte egea.PDFsilveira_manuelNessuna valutazione finora
- NEOCLASSICISMODocumento19 pagineNEOCLASSICISMOThomas MorelettiNessuna valutazione finora
- Tema Di Diploma 1Documento15 pagineTema Di Diploma 1game gameeNessuna valutazione finora
- Introduzione all'arte Contemporanea: Appunti e commenti per un percorso sull'arte contemporaneaDa EverandIntroduzione all'arte Contemporanea: Appunti e commenti per un percorso sull'arte contemporaneaNessuna valutazione finora
- Piranesi - Catalogo D'arteDocumento18 paginePiranesi - Catalogo D'arteClaudioParisiNessuna valutazione finora
- Maniera Le Vite De' Più Eccellenti Pittori, Scultori e ArchitettoriDocumento10 pagineManiera Le Vite De' Più Eccellenti Pittori, Scultori e ArchitettoriSilvia AntoniNessuna valutazione finora
- Pittura Vascolare GrecaDocumento6 paginePittura Vascolare GrecaClaudia ZanardiNessuna valutazione finora
- ARTE GRECA Dalle Origini Alletà ArcaicaDocumento11 pagineARTE GRECA Dalle Origini Alletà ArcaicaMaria FrancescaNessuna valutazione finora
- Riassunto Manuali V-VI Di Arte ContemporaneaDocumento88 pagineRiassunto Manuali V-VI Di Arte ContemporaneaFrancesca PalazzoNessuna valutazione finora
- La Storia Dell'arteDocumento8 pagineLa Storia Dell'artecamillaNessuna valutazione finora
- NeoclassicismoDocumento17 pagineNeoclassicismoPaola ArcifaNessuna valutazione finora
- Lempatia Delle Immagini Caravaggio e LaDocumento4 pagineLempatia Delle Immagini Caravaggio e LaKhaoula TabitNessuna valutazione finora
- Viaggio Nell'arte ContemporaneaDocumento8 pagineViaggio Nell'arte ContemporaneanathalieNessuna valutazione finora
- NEOCLASSICISMODocumento2 pagineNEOCLASSICISMOmilena buttiglioneNessuna valutazione finora
- Storia Dell'arte ContemporaneaDocumento85 pagineStoria Dell'arte ContemporaneaRelais BorghettoNessuna valutazione finora
- Arte NeoclassicaDocumento20 pagineArte NeoclassicaEmanuela SotaNessuna valutazione finora
- Nostalgia Di Niente - ChiodiDocumento17 pagineNostalgia Di Niente - Chiodi543tgfdthjfbfgj56754Nessuna valutazione finora
- Antonio Canova (1757-1822) La vita italiana durante la Rivoluzione francese e l'ImperoDa EverandAntonio Canova (1757-1822) La vita italiana durante la Rivoluzione francese e l'ImperoNessuna valutazione finora
- Estetica Di Leonardo-L.venturi PDFDocumento23 pagineEstetica Di Leonardo-L.venturi PDFION GĂNGUȚNessuna valutazione finora
- 1 Architecture History and TheoryDocumento95 pagine1 Architecture History and TheoryFerdinando GattoNessuna valutazione finora
- Dal Neoclassicismo Fino Ai Giorni NostriDocumento59 pagineDal Neoclassicismo Fino Ai Giorni NostriGiovanni ArenaNessuna valutazione finora
- Il NeoclassicismoDocumento3 pagineIl NeoclassicismoMoon KnightNessuna valutazione finora
- ArcheologiaDocumento26 pagineArcheologiafloranoceraNessuna valutazione finora
- Il NeoclassicismoDocumento4 pagineIl NeoclassicismoSara VerniNessuna valutazione finora
- La Storia Della Storia Dell'arte RiassuntoDocumento72 pagineLa Storia Della Storia Dell'arte RiassuntoBeatrice FerriNessuna valutazione finora
- L'arte Etrusca: Modifica Modifica WikitestoDocumento9 pagineL'arte Etrusca: Modifica Modifica WikitestoSilvia AntoniNessuna valutazione finora
- Su Piranesi Tafuri 1989Documento13 pagineSu Piranesi Tafuri 1989joseph knetchNessuna valutazione finora
- Il Neoclassico e CanovaDocumento4 pagineIl Neoclassico e CanovaGaia MaglianoNessuna valutazione finora
- Paradoxa TeoriaDocumento2 pagineParadoxa Teoriamatteo libertiNessuna valutazione finora
- Diritto RomanoDocumento43 pagineDiritto RomanodsgaNessuna valutazione finora
- L'Anfiteatro Flavio (Colosseo) Turismo RomaDocumento1 paginaL'Anfiteatro Flavio (Colosseo) Turismo RomaALEXANDRA COMȘANessuna valutazione finora
- Roma CartagineDocumento3 pagineRoma Cartagineliclic :DNessuna valutazione finora
- 03 TacitoDocumento5 pagine03 Tacitovitofilos3Nessuna valutazione finora
- Dinastie Giulio-Claudia e FlaviaDocumento4 pagineDinastie Giulio-Claudia e FlaviaMatteo Di MassaNessuna valutazione finora
- Miseno e La Flotta Romana - ABCDocumento6 pagineMiseno e La Flotta Romana - ABCMaria Rosaria BrunoNessuna valutazione finora
- Liguri ApuaniDocumento39 pagineLiguri ApuaniMax BergerNessuna valutazione finora
- Giulio Cesare - Commentarii de Bello GallicoDocumento188 pagineGiulio Cesare - Commentarii de Bello GallicoDavide Morra100% (1)
- Rivista Italiana Di Numismatica Vol. 6 (1893)Documento548 pagineRivista Italiana Di Numismatica Vol. 6 (1893)Simone CertelliNessuna valutazione finora
- Greci e Romani Turisti in EgittoDocumento59 pagineGreci e Romani Turisti in EgittoFrancesca Iannarilli100% (1)
- Moroni. Dizionario Di Erudizione Storico-Ecclesiastica Da S. Pietro Sino Ai Nostri Giorni. 1840. Volume 58.Documento328 pagineMoroni. Dizionario Di Erudizione Storico-Ecclesiastica Da S. Pietro Sino Ai Nostri Giorni. 1840. Volume 58.Patrologia Latina, Graeca et Orientalis0% (1)
- Terrore e Terrorismo in Epoca Romana: Due Articoli Per Approfondire L'approccio Del Mondo Classico A Un Tema AttualeDocumento14 pagineTerrore e Terrorismo in Epoca Romana: Due Articoli Per Approfondire L'approccio Del Mondo Classico A Un Tema AttualebertamoonNessuna valutazione finora
- Roma MonarchicaDocumento2 pagineRoma MonarchicaMariannaCaneNessuna valutazione finora
- Botteri Questioni Di Emilio Paolo IndexDocumento24 pagineBotteri Questioni Di Emilio Paolo IndexMiddle Republican HistorianNessuna valutazione finora
- Cariche Pubbliche RomaneDocumento9 pagineCariche Pubbliche RomaneKiyara Rosheli Urala LiyanageNessuna valutazione finora
- LivioDocumento6 pagineLivioSalvatore BellaviaNessuna valutazione finora
- La Legione RomanaDocumento3 pagineLa Legione RomanamsdfliNessuna valutazione finora
- TeodoricoDocumento2 pagineTeodoricoȘtefaniaChirúNessuna valutazione finora
- ISA (Gesu) Profeta Dell'IslamDocumento77 pagineISA (Gesu) Profeta Dell'IslamGovorUlemeNessuna valutazione finora
- 1 - Il Tesoro Di Marengo Da Uno Scavo Sen PDFDocumento10 pagine1 - Il Tesoro Di Marengo Da Uno Scavo Sen PDFCavicchioli CristinaNessuna valutazione finora
- Alessandro SeveroDocumento4 pagineAlessandro Severoapi-306853524Nessuna valutazione finora
- Giulio CesareDocumento13 pagineGiulio CesaremimmoneasdasdNessuna valutazione finora