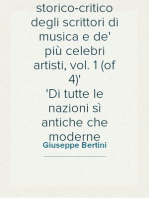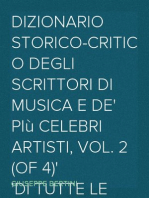Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Il Barocco Nelle Arti
Caricato da
Rodrigo Cássio OliveiraTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Il Barocco Nelle Arti
Caricato da
Rodrigo Cássio OliveiraCopyright:
Formati disponibili
IL BAROCCO NELLE ARTI
Il Seicento si apre con il genio tragico di Shakespeare, con il romanzo di Cervantes
e con il madrigale di Monteverdi, e nel suo svolgimento vede l’affermarsi di aspetti
culturali imponenti e contrastanti, quali il trionfo del Cattolicesimo controriformistico
e i primi decisivi passi della scienza sperimentale.
L’architettura e le arti figurative in genere rappresentano l’ambito entro il quale l’uso
del termine “barocco” detiene la sua più indiscussa validità. Esse appaiono, infatti,
stilisticamente più omogenee rispetto alle contemporanee manifestazioni letterarie
europee, inoltre manifestano con chiarezza le loro fonti ideologiche, essendo diret-
tamente collegate con le esigenze della Controriforma cattolica nel suo momento
più trionfalistico: il carattere decorativo ed esteriore di alcune manifestazioni
delle arti barocche va, infatti, ricondotto ad una cosciente volontà di persuasione
emotiva, ottenuta attraverso effetti suggestivi. Proprio attraverso il Barocco, la
Chiesa cattolica vuole dare di sé l’immagine di una potenza vittoriosa e trionfan-
te, presa a modello dalle grandi corti cattoliche europee.
Allo scadere del Settecento comincia a circolare la parola barocco, in un’accezione
negativa, ed è applicata a coloro che, come Francesco Borromini (1599-1667) e
Pietro da Cortona (1596-1669), sovvertono le regole classiche dell’architettura. La
successiva rivalutazione del valore del Barocco si deve a critici quali Alois Riegl e
Heinrich Wollflin1, che tendono ad identificare nel concetto di barocco tutto un seco-
lo multiforme ed inquieto. In realtà, il Barocco, quale si viene formando soprattutto
a Roma verso il 1630, per opera di una creativa generazione di artisti, non è che –
come si è detto – una delle componenti artistiche del secolo, caratterizzata da un’ac-
cesa esuberanza fantastica e da un’inquietudine sentimentale che ha origine nella
fastosa esibizione esteriore; la accompagna un desiderio di imprevisto, di stupefa-
cente, un nascente sentimento di infinito, che il mondo dell’epoca condanna in filo-
sofi e scienziati come Bruno, Campanella e Galileo, ma che viene esaltato dagli arti-
sti negli immensi affreschi di cupole e di soffitti decorati sfarzosamente. Tuttavia,
accanto a questo “Barocco”, nel Seicento c’è pure la meditazione antimanieristica
dei Carracci (Agostino, 1557-1602; Annibale, 1560-1609; Ludovico, 1555-1619) e lo
spirito “profano” di Caravaggio (Michelangelo Merisi, 1571 ca. – 1610). C’è inoltre
un fitto scambio di forme artistiche in Europa, grazie a personalità come Rubens,
Bernini, Rembrandt, Velázquez, che confrontano le esperienze accumulate attraver-
so i viaggi e la circolazione delle proprie opere; Roma, soprattutto, indiscussa capi-
tale artistica dell’epoca, ospita per lunghi periodi artisti francesi, fiamminghi, tede-
schi e spagnoli.
1. Si vedano, tra gli altri, i seguenti contributi: A. Riegl, Problemi di stile. Fondamenti di una storia dell’arte ornamentale,
Feltrinelli, Milano, 1963; H. Wollflin, Rinascimento e Barocco: ricerche intorno all’essenza e all’origine dello stile baroc-
co in Italia, Vallecchi, Firenze, 1988.
© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS Vol. 2 - CaP. 1 - IL BARoCCo nELLE ARTI 1
L’arte barocca Giulio Carlo Argon
Giulio Carlo Argan, storico e critico dell’arte contemporaneo, tra i più celebrati nel mondo, nei suoi studi sulla
storia dell’architettura, inaugurati nel 1938, ha approfondito in particolare il Barocco e l’età contemporanea,
pubblicando, tra gli altri, i saggi F. Borromini (1952), L’Architettura barocca in Italia (1957), Immagine e per-
suasione, Saggi sul barocco (1986), L’arte barocca (1989). La sua attenzione si è rivolta in più direzioni (pittu-
ra, scultura, architettura), mirando sempre ad una contestualizzazione storica dell’opera d’arte in esame. Il suo
discorso storico-critico abbraccia un vasto intervallo, dall’arte dei secoli passati fino alla contemporanea,
come testimoniato dalle due edizioni della sua Storia dell’arte italiana (1968-1988), da cui sono tratti i brani
che seguono, e saggi quali Da Hogart a Picasso – L’arte moderna in Europa (1983), L’arte moderna –
Dall’Illuminismo ai movimenti contemporanei (1988).
I passi riportati analizzano rispettivamente una delle caratteristiche precipue delle arti figurative barocche, e
cioè l’utilizzo di forme espressive facili e di sicuro effetto, al fine di sollecitare il coinvolgimento emotivo dei
fedeli (non si deve dimenticare come il Barocco sia spesso al servizio dell’ideologia controriformistica, e
debba quindi assolvere questa funzione di incitamento e persuasione), e le peculiarità dell’architettura di
Francesco Castelli, detto il Borromini (1599-1667) architetto di enorme fama e capacità, operante a Roma nel
periodo in esame.
L’arte barocca
La questione religiosa ha un aspetto sociale: infatti la disputa è tra la fede individua-
le dei protestanti e la fede collettiva o di massa propugnata dalla Chiesa. La cultura
è una via di salvezza, ma tutta l’umanità deve salvarsi, non soltanto i dotti.
Bisogna dunque che la cultura penetri in tutti gli strati della società; bisogna che ogni
5 attività umana, anche la più umile, abbia un’origine culturale e un fine religioso. La
tecnica dell’artista, come quella dell’artigiano e dell’operaio, non è fine a se stessa:
qualsiasi cosa si faccia, si fa ad maiorem Dei gloriam, cioè l’opera degli uomini
accresce la gloria, il prestigio di Dio sulla terra. Per questo il Barocco diventa presto
uno stile e passa dalla sfera dell’arte a quella del costume, della vita sociale, e dà
10 figura, carattere, valore di bellezza naturale e storica insieme alle città, cioè all’am-
biente della vita sociale e politica.
Le poetiche barocche riprendono, rivalutano e sviluppano la concezione classica
dell’arte come mimesi o imitazione; l’arte è rappresentazione, ma lo scopo della rap-
prentazione non è di meglio conoscere l’oggetto che si rappresenta, bensì di impres-
15 sionare, commuovere, persuadere. A che cosa? A nulla di preciso: né la verità di fede
né la bontà di una concezione politica si possono dimostrare od imporre con un
dipinto o un edificio. L’arte è il prodotto dell’immaginazione e il suo fine precipuo
è di insegnare a esercitare l’immaginazione. È importante perché senza immagina-
zione non v’è salvezza. Proporsi la salvezza significa ammettere che salvezza è pos-
20 sibile, immaginarsi salvi: significa cioè immaginarsi al di là della contingenza della
realtà quotidiana. L’immaginazione è superamento del limite: senza l’immaginazione
tutto è piccolo, chiuso, fermo, incolore; con l’immaginazione tutto è vasto, aperto,
mobile, colorito. Non è tale in sé, bensì nel soggetto che si accosta alla realtà, e ne
compie l’esperienza, con la capacità di vedere al di là della cosa in sé, di metterla
25 in relazione con altre cose e col tutto di situarla in uno spazio e in un tempo più
vasti.
L’arte barocca non aggiunge nulla alla conoscenza oggettiva o positiva della natura
e della storia: per indagare la natura c’è ormai una scienza, per ricostruire e spiega-
re le vicende del passato c’è una storiografia. L’artista si interessa della natura e della
30 storia solo in quanto il pensiero della natura e della storia gli permette di oltrepas-
sare i limiti del reale, di estendere l’esperienza al possibile.
2 Vol. 2 - CaP. 1 - IL BARoCCo nELLE ARTI © ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS
L’immaginazione, che viene ora riconosciuta come la facoltà che produce l’arte, è
molto diversa dalla fantasia o dal capriccio. L’immaginazione ha un fine: persuade-
re che qualcosa di non-reale può diventare realtà. [...]
35 Vi sono vari modi di persuadere: presentando la prova, dimostrando con argomen-
ti, trascinando con l’enfasi del discorso. Perciò nell’arte del Seicento un’acuta eviden-
za realistica si accompagna quasi sempre alla figurazione immaginaria: si rappresen-
tano i cieli aperti alla visione del santo, ma si precisa con estrema acutezza la qua-
lità del tessuto della sua veste, la luce che batte sugli oggetti che ha accanto. E la
40 fattura artistica è sempre rapida, sicura, piena di estro e di calore, magari simulati:
accompagnata sempre da un ampio, eloquente gestire.
Per la vastità dei suoi assunti ideologici e la molteplicità delle sue funzioni, nonché
per la composizione della società a cui si rivolge, l’arte del Seicento presenta una
larghissima gamma di fenomeni fortemente differenziati. Poiché non si tratta più di
45 realizzare forme che abbiano un valore assoluto ed eterno, ma di agire sull’animo e
la gente, si ammette che vi siano vari modi di esprimersi e di persuadere, si delinea-
no perciò diverse tendenze che, non corrispondendo più a diversi schemi di inter-
pretazione della realtà ma soltanto a diversi atteggiamenti e modi di essere e comu-
nicare, possono facilmente combinarsi o intrecciarsi. La necessità di delimitare un
50 campo così vasto, nonché di rispondere alle richieste di una società sempre più stra-
tificata, determina la distinzione di diversi generi artistici, a cui corrispondono altret-
tante categorie di specialisti.
L’origine della pittura di genere risale alla necessità di documentare con il vivace rea-
lismo dei particolari la verosimiglianza delle visioni dell’immaginazione: perciò
55 all’inizio, la pittura di genere si contrappone alla pittura di storia e tuttavia la inte-
gra, ponendo in seno all’arte stessa il rapporto di particolare e universale, di reale e
ideale. Si isolano poi i diversi generi: il ritratto, la natura morta, il paesaggio, la scena
di vita quotidiana o di costume; e ciascun genere si suddivide in sottospecie a cui
corrispondono diverse categorie di specialisti, sicché si avranno pittori di prospetti-
60 ve e di rovine, di fiori, di pesci, di strumenti musicali, di battaglie o di scene di costu-
me. Il fenomeno dei generi, come fenomeno di specializzazione in senso tematico
e tecnico, non è tuttavia soltanto della pittura: non è dissimile in architettura la distin-
zione tra i diversi tipi di edifici religiosi pubblici e privati in rapporto alle diverse
funzioni e alle richieste di una clientela sempre più differenziata per cultura, gusti,
65 possibilità economiche. L’attività degli specialisti non dà luogo a classi incomunican-
ti; non di rado diversi specialisti intervengono nella medesima opera, come quando
il paesaggista dipinge lo sfondo di un quadro di storia o il figurista le macchiette in
un quadro di paesaggio, etc. L’arte è concepita come una grande impresa sociale, a
cui ciascuno collabora secondo le proprie specifiche competenze.
da Storia dell’arte italiana, vol. III, Sansoni, Firenze, 1968
© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS Vol. 2 - CaP. 1 - IL BARoCCo nELLE ARTI 3
L’ultimo Borromini
Quando, nel 1646, [Borromini] viene incaricato di restaurare in tutta fretta la basili-
ca di San Giovanni in Laterano [...], sfrutta tutta la luminosità del vano per dar valo-
re ai diaframmi chiarissimi delle pareti e alla decorazione elegantissima che li ador-
na [...]. Non dissimile dalla soluzione luministica in chiaro della basilica lateranense,
5 è quella dell’esterno di Sant’Agnese in Piazza Navona (1652-1657): con la fronte cava
che sembra cedere alla pressione del grande spazio della piazza, alla cui estensione
in lunghezza fa contrasto lo slancio della cupola inquadrata, sulla fronte, dai due
campanili.
L’eleganza, la purezza del ritmo crescono col crescere della tensione interna. Il suo
10 lungo tormento si avvicina all’epilogo: il restauro di San Giovanni rimasto a mezzo
lo amareggia, la ripresa trionfale dell’attività del Bernini col favore di Alessandro VII
lo umilia. Poiché gli si impedisce di compiere l’opera che doveva essere il suo capo-
lavoro, si dà a ricomporre entro bizzarre, preziose cornici i frammenti delle antiche
tombe della basilica: per la prima volta opere d’arte del medioevo vengono messe
15 in valore, non già come reliquie o documenti di storia religiosa, ma per il fascino
che emana dal loro accento arcaico, desueto. Altre volte evoca forme esotiche, come
nella raffinatissima porta dell’Accademia di San Luca, o motivi classici rari, addirit-
tura anomali, come nel campanile di Sant’Andrea delle Fratte: quasi col gusto amaro
di dichiararsi fuori della storia, di porre l’arte al di sopra del tempo, come espressio-
20 ne di una spiritualità che può essere di ogni uomo, quale che sia la sua cultura.
L’edificio non deve essere una rappresentazione dello spazio né la forma allegorica
di concetti religiosi o politici: è un oggetto che l’artista costruisce con quel che di
meglio ha in sé, non importa se nella sua cultura o nella sua fantasia; e che espri-
me soltanto questa difficile scelta del meglio, come un’offerta probabilmente inutile
25 ma anche per questo più pura. [...]
L’ultima opera del Borromini è la facciata della prima chiesa che aveva costruito, San
Carlo alle Quattro Fontane. È contemporanea al colonnato berniniano, la forma più
unitaria e globale di tutta l’architettura barocca; ed è, all’opposto, la forma più fram-
mentaria, discontinua, antimonumentale. È concepita come un oggetto, un arredo,
30 un reliquario; è collocata all’estremità della strada, rompendo a bella posta la sim-
metria del quadrivio delle Quattro Fontane. Alta e stretta, nasconde completamente
il corpo della chiesa; e non si raccorda, anzi spicca dalla parete della strada. È pro-
prio l’opposto di quello che aveva fatto il Bernini poco più avanti, nella stessa via,
con la chiesa di Sant’Andrea. La piccola facciata, con la sua triplice flessione, con lo
35 sbalzo delle colonne a cui fa riscontro lo scavo delle nicchie, il fitto ornato, il frazio-
namento continuo del piano, sembra non aver altro scopo che quello di portare in
alto l’ovale con l’immagine o la reliquia, che rompe il coronamento dell’edificio e lo
conclude con un bizzarro, elegantissimo fastigio. È veramente l’ultimo gesto della
lunga polemica antiberniniana, che passa qui dal piano architettonico, all’urbanisti-
40 co. Non la rappresentazione architettonica dello spazio, ma l’edificio come fatto
umano che accade nello spazio; non la contemplazione dell’universale, ma il parti-
colare vissuto con intensità estrema; non la città come immagine unitaria dei supre-
mi poteri divini ed umani, ma la città come luogo della vita, in cui l’esperienza reli-
giosa s’intreccia con quella del lavoro quotidiano. Non sorprende perciò che le idee
45 architettoniche e urbanistiche del Borromini abbiano avuto, anche fuori d’Italia,
un’irradiazione maggiore di quelle del Bernini: infatti, se non manifestano l’autorità
spirituale della Chiesa e dello Stato, interpretano ed esprimono l’aspirazione spiri-
tuale dell’individuo e della comunità.
da Storia dell’arte italiana, Sansoni, Firenze, 1968
4 Vol. 2 - CaP. 1 - IL BARoCCo nELLE ARTI © ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS
L avoro sul testo
1. Riferendoti a quanto scritto nei brani di Giulio Carlo Argan, contrassegna con V (vero) o F (falso)
ognuna delle affermazioni riportate qui di seguito, motivando sinteticamente le tue scelte in max 5
righe per ogni quesito:
Il Barocco è una rivoluzione culturale in nome dell’ideologia cattolica.
Lo scopo della rappresentazione artistica barocca è quello di conoscere il più approfonditamente
possibile gli oggetti riprodotti.
Nell’ambito dell’arte secentesca si delineano varie tendenze.
La facciata della chiesa San Carlo alle Quattro Fontane di Borromini costituisce la forma più uni-
taria e allo stesso tempo più frammentaria di tutta l’architettura barocca.
2. Svolgi una tua personale ricerca su un monumento di Borromini citato dal brano di Giulio Carlo
Argan; sull’argomento scrivi ed intitola opportunamente un saggio breve che dovrà essere corredato
da appropriato materiale fotografico o iconografico.
L’estetica del Barocco Ernesto d’Alfonso
e Danilo Samsa
Si propone ora la lettura di un brano di due stimati critici contemporanei che considerano le particolarità del
Barocco da un punto di vista prettamente architettonico. Lo sperimentalismo dell’arte barocca è visto, dai due
autori, non tanto come risultato delle esigenze persuasive della Chiesa controriformistica, quanto come auto-
noma reazione alla compostezza e alla stasi classicistica del Cinquecento.
Alcuni travolgimenti storici avvenuti sul finire del Cinquecento determinano nelle arti
figurative e nell’architettura la ricerca di un’altra interpretazione dell’antichità: una
reazione al classicismo della compostezza, della stasi come natura della perfezione,
comporta l’insorgere di un nuovo concetto di ragione. In Europa, tra il 1618 e il
5 1648, avvengono le devastazioni della guerra dei Trent’Anni, che terminano con il
crollo dei tentativi di realizzare un grande Stato cattolico europeo sotto la guida spi-
rituale della Chiesa; il papato reagisce creando una città trionfale e controllando più
direttamente gli aspetti della vita pubblica: vengono messi al bando gli uomini delle
nuove scienze e della nuova filosofia. Nell’anno 1600 muore sul rogo Giordano
10 Bruno, nel 1632 Galileo Galilei abiura dinanzi al tribunale del Sant’Uffizio. La popo-
lazione diminusce del 16-20% e inizia un periodo di carestia; la coscienza della
morte, la consapevolezza della propria umana finitudine, la sensibilità tragica danno
origine al barocco. Il sentimento della precarietà della vita si manifesta come ansia
conoscitiva, come tendenza allo sperimentalismo: è il periodo in cui l’artista inter-
15 preta il soggetto rappresentato in autonomia dall’idea di rivelazione del bello idea-
le, da realtà e ragione esterne alla propria creazione artistica. Le discipline del sape-
re incominciano a separarsi e a definire le loro specificità di metodo. La dimensio-
ne dell’infinito, che si rende intelligibile nelle intuizioni in campo scientifico, in
architettura si manifesta come infinita rottura del limite della forma e dello spazio,
20 come superamento della prospettiva del modello cubico e ordinativo – ben rappre-
sentato negli edifici di Brunelleschi –, come rottura dei punti fermi, che viceversa
ora si moltiplicano in una ricerca di spazio dinamico. Il tema del movimento come
dinamica coesistenza degli opposti, il tema della luce come nuova legge ordinativa
dello spazio e della materia – come elemento che rivela senza distinzione bello e
25 non bello, luminosità e tenebra contemporaneamente –, il tema del meraviglioso –
come coinvolgimento dell’individuo – spettatore nell’opera –, rappresentano la natu-
© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS Vol. 2 - CaP. 1 - IL BARoCCo nELLE ARTI 5
ra del barocco, fenomeno di cui è impossibile fornire una definizione unitaria.
Attraverso lo stupore, la meraviglia che viene suscitata nel visitatore, si stabilisce il
livello della comunicazione: l’oggetto architettonico si impone all’attenzione e forni-
30 sce emozione, cosicché l’esperienza cinestetica, che si compie nello spazio, coinvol-
ge i sensi. A tali fini è esibita la grande sapienza tecnica e costruttiva. Le opere pro-
dotte a Roma sotto i pontificati di Urbano VIII, Innocenzo X, Alessandro VII (opere
di Bernini, Borromini e Pietro da Cortona) rappresentano il nucleo centrale del pas-
saggio tra tradizione e rinnovamento alla scala della forma e dello spazio.
35 L’aristocrazia romana in tali periodi diviene, insieme alla Chiesa, il committente della
nuova arte negli edifici sacri e nei palazzi, che si moltiplicano. Palazzo Barberini, ini-
ziato nel 1626 da Carlo Maderno e portato a compimento da Bernini, segna una inno-
vazione tipologica del palazzo, in quanto presenta la scomparsa del cortile come spa-
zio introverso ed elemento distributivo dell’edificio quattro-cinquecentesco; è costrui-
40 to sull’asse longitudinale del percorso che dall’esterno della città conduce all’interno
dell’edificio stesso.
da Architettura, Mondadori, Milano, 1994
L avoro sul testo
1. Sintetizza in venti righe il contenuto informativo del brano.
2. Rispondi, in non più di dieci righe, ai seguenti quesiti a risposta singola riguardanti il brano:
a. Quale rilevanza sugli sviluppi artistici hanno gli accadimenti storici avvenuti sul finire del
Cinquecento?
b. In che modo si manifesta nel Seicento il sentimento di precarietà della vita?
c. Come è risolto architettonicamente il concetto di infinito?
d. Quali altri temi caratterizzano l’espressione artistica barocca secondo i due autori del brano?
3. Rileggi attentamente le risposte ai precedenti quesiti e utilizzale come scaletta-base per una breve rela-
zione orale che terrai alla classe sul seguente argomento:
L’estetica del Barocco.
P roposte di lavoro
1. Ricerca in biblioteca o su Internet informazioni e raffigurazioni di opere architettoniche, scultoree e
pittoriche di Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) e di Francesco Castelli, detto il Borromini (1599-
1667), artisti-chiave della civiltà barocca romana.
Scrivi quindi un saggio che evidenzi le peculiarità dell’arte di entrambi e le differenze, anche tempe-
ramentali, che furono alla base dell’insanabile rivalità esistente tra i due artisti.
2. Nella musica l’adozione della categoria “barocco” è piuttosto controversa, soprattutto perché può risul-
tare arduo impiegarla a proposito di fenomeni come il melodramma, caratteristico del Seicento, ma
nato da un’esigenza di semplificazione melodica, lontano da ogni concettosità e bizzarria. Innegabile
è, in ogni caso, lo straordinario sviluppo della musica nel Seicento: si ricerchino notizie riguardanti
l’opera di Monteverdi o di Frescobaldi e si dimostri, in una relazione scritta compresa tra le 2 e le 4
colonne, come per la musica non si possa assolutamente parlare di decadenza.
3. Con Caravaggio si fa strada uno spirito “profano”, moderno, nel senso che egli rifiuta fieramente tutto
ciò che non studia gli aspetti più immediati della realtà quotidiana; ricerca informazioni sul pittore, sui
suoi rapporti col Barocco, reperisci le riproduzioni di alcune sue opere significative (quali le tele
Bacchino malato, Conversione di San Paolo, Decollazione del Battista e altre) e prepara oralmente una
mini-conferenza per presentarle e illustrarle alla classe, in un tempo compreso fra i 15 e i 20 minuti.
6 Vol. 2 - CaP. 1 - IL BARoCCo nELLE ARTI © ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS
Potrebbero piacerti anche
- Riti Egizi 2 2016 PDFDocumento377 pagineRiti Egizi 2 2016 PDFMauroCerulli100% (1)
- Fascicolo Sinottico - Vol. I, II, IIIDocumento45 pagineFascicolo Sinottico - Vol. I, II, IIIsankaratNessuna valutazione finora
- La danza e l'agitprop: I teatri-non-teatrali nella cultura tedesca del primo NovecentoDa EverandLa danza e l'agitprop: I teatri-non-teatrali nella cultura tedesca del primo NovecentoNessuna valutazione finora
- Richard Wagner Lopera Darte Dellavvenire 1963 RizzoliDocumento151 pagineRichard Wagner Lopera Darte Dellavvenire 1963 RizzoliBianca SavoNessuna valutazione finora
- Appunti Di Storia MedievaleDocumento97 pagineAppunti Di Storia MedievaleCaruso GiovanniNessuna valutazione finora
- 1224 Michelangelo Ita PDFDocumento36 pagine1224 Michelangelo Ita PDFMaribel Sainz CachoNessuna valutazione finora
- Editoria Musicale 05Documento48 pagineEditoria Musicale 05jacob richardsonNessuna valutazione finora
- Fegato PancreasDocumento67 pagineFegato PancreasSergio100% (1)
- Diapositive - Il Gioco Musicale Nel 400 e 500Documento72 pagineDiapositive - Il Gioco Musicale Nel 400 e 500Marco SuraceNessuna valutazione finora
- NonvogliodiventareunosciamanoDocumento43 pagineNonvogliodiventareunosciamanoAlessandro RotaNessuna valutazione finora
- MICHELANGELODocumento45 pagineMICHELANGELOWicked_KnightNessuna valutazione finora
- DAHLHAUS, C., Che Significa e A Qual Fine Si Studia La Storia Della MusicaDocumento13 pagineDAHLHAUS, C., Che Significa e A Qual Fine Si Studia La Storia Della MusicaJavier RodriguezNessuna valutazione finora
- Storia Della Musica - Il MelodrammaDocumento8 pagineStoria Della Musica - Il MelodrammaMiriana ScivoliNessuna valutazione finora
- Tesina 8Documento15 pagineTesina 8Lorenzo MatteiNessuna valutazione finora
- Perez - Musica e Spiritualità (2002)Documento24 paginePerez - Musica e Spiritualità (2002)g.vadala5761Nessuna valutazione finora
- L'Eugubino. Speciale Studiolo - Inconnu (E)Documento40 pagineL'Eugubino. Speciale Studiolo - Inconnu (E)olocesNessuna valutazione finora
- BASILE - Asor Rosa 1970 PDFDocumento5 pagineBASILE - Asor Rosa 1970 PDFGian Vittorio CermelliNessuna valutazione finora
- Il Medioevo (secoli XIII-XIV) - Letteratura e teatro (35): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 35Da EverandIl Medioevo (secoli XIII-XIV) - Letteratura e teatro (35): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 35Nessuna valutazione finora
- Arte Romanica 321 PDFDocumento34 pagineArte Romanica 321 PDFlenciopNessuna valutazione finora
- Contro L'illuminismoDocumento654 pagineContro L'illuminismoCarlos Francisco Villalba TalaveraNessuna valutazione finora
- 20 Vedute Di Napoli Dal 400 Al 700Documento23 pagine20 Vedute Di Napoli Dal 400 Al 700carminuccioNessuna valutazione finora
- Paolo Spinicci - Il Mondo Della Vita e Il Problema Della CertezzaDocumento85 paginePaolo Spinicci - Il Mondo Della Vita e Il Problema Della CertezzaStefano PisanoNessuna valutazione finora
- Il PentameroneDocumento4 pagineIl Pentameronedavis2a100% (1)
- Umanesimo e RinascimentoDocumento5 pagineUmanesimo e Rinascimentosofia100% (1)
- Rocconi Ed, La Musica Nel'impero Romano PDFDocumento180 pagineRocconi Ed, La Musica Nel'impero Romano PDFFotis AnagnostopoulosNessuna valutazione finora
- Dizionario storico-critico degli scrittori di musica e de' più celebri artisti, vol. 1 (of 4) Di tutte le nazioni sì antiche che moderneDa EverandDizionario storico-critico degli scrittori di musica e de' più celebri artisti, vol. 1 (of 4) Di tutte le nazioni sì antiche che moderneNessuna valutazione finora
- Arte PreistoriaDocumento40 pagineArte PreistoriapapidescNessuna valutazione finora
- Dizionario storico-critico degli scrittori di musica e de' più celebri artisti, vol. 2 (of 4) Di tutte le nazioni sì antiche che moderneDa EverandDizionario storico-critico degli scrittori di musica e de' più celebri artisti, vol. 2 (of 4) Di tutte le nazioni sì antiche che moderneNessuna valutazione finora
- Valtellina 1987 - La Cronaca Del DisastroDocumento24 pagineValtellina 1987 - La Cronaca Del DisastroISPRO100% (2)
- Sartori AbDocumento454 pagineSartori AbAndrea MonardaNessuna valutazione finora
- La Seconda PratticaDocumento17 pagineLa Seconda PratticaShirley Fideles FigueiredoNessuna valutazione finora
- Galli Fasoli My Music Verifiche 10Documento4 pagineGalli Fasoli My Music Verifiche 10ileana perosaNessuna valutazione finora
- 21.0 Bach e HandelDocumento8 pagine21.0 Bach e HandelMarco PorcelluzziNessuna valutazione finora
- 5 Arte Romanica GoticaDocumento29 pagine5 Arte Romanica GoticaAnonymous tdWshEkNessuna valutazione finora
- Pen Tamer OneDocumento498 paginePen Tamer Onetoto100% (1)
- Henry Purcell Dinko Fabris, Antonella GarofaloDocumento220 pagineHenry Purcell Dinko Fabris, Antonella GarofalochiaradezuaniNessuna valutazione finora
- 8-A Paleocristiano PDFDocumento17 pagine8-A Paleocristiano PDFlenciopNessuna valutazione finora
- 9a Arte RomanicaDocumento35 pagine9a Arte RomanicaLuca BallauriNessuna valutazione finora
- Musiche MassonicheDocumento3 pagineMusiche MassonichePippo Il Peggiore CrisciNessuna valutazione finora
- Storia Del TeatroDocumento14 pagineStoria Del TeatroFilippo Salaris IolaoNessuna valutazione finora
- FAVARO La Categoria Del BruttoDocumento5 pagineFAVARO La Categoria Del BruttoMarco LombardiNessuna valutazione finora
- Rampi - Il Canto Gregoriano Oce Della ChiesaDocumento12 pagineRampi - Il Canto Gregoriano Oce Della ChiesayuppeteNessuna valutazione finora
- AmletoDocumento4 pagineAmletoGreta GentileNessuna valutazione finora
- Italia, Potenza globale?: Il ruolo internazionale dell'Italia oggi.Da EverandItalia, Potenza globale?: Il ruolo internazionale dell'Italia oggi.Valutazione: 2 su 5 stelle2/5 (1)
- Tesina: La NaturaDocumento36 pagineTesina: La NaturaFrancesco AnastasioNessuna valutazione finora
- Analisi Concerto Op.15Documento2 pagineAnalisi Concerto Op.15Simone LongoNessuna valutazione finora
- Sinfonie Di BeethovenDocumento7 pagineSinfonie Di BeethovenAlessio TiezziNessuna valutazione finora
- Acropoli AteneDocumento67 pagineAcropoli Atenegambaro5286Nessuna valutazione finora
- Beghelli Che Cosa Dicono Travature VivaldianeDocumento4 pagineBeghelli Che Cosa Dicono Travature VivaldianeMyriam TokerNessuna valutazione finora
- I Mozart, come erano - Volume 1: Una famiglia alla conquista dell'EuropaDa EverandI Mozart, come erano - Volume 1: Una famiglia alla conquista dell'EuropaValutazione: 3 su 5 stelle3/5 (1)
- Ittero OstruttivoDocumento43 pagineIttero Ostruttivoapi-3733154100% (1)
- Strumenti Popolari U Friscalettu Come FarloDocumento5 pagineStrumenti Popolari U Friscalettu Come FarloanovasoinotnaNessuna valutazione finora
- Novelle Volume Secondo - Antin CechovDocumento152 pagineNovelle Volume Secondo - Antin CechovClaudia Tagliaferri0% (1)
- Scisma Dei 3 CapitoliDocumento16 pagineScisma Dei 3 CapitolibrunomorabitoNessuna valutazione finora
- 3 ArteRomana PDFDocumento40 pagine3 ArteRomana PDFNunzia Imperiale ForteNessuna valutazione finora
- 11a Rinascimento PDFDocumento39 pagine11a Rinascimento PDFXev the jokerNessuna valutazione finora
- Arte BizantinaDocumento20 pagineArte BizantinaSabina Salvatore RolloNessuna valutazione finora
- AllaScopertadeiSuoniPerduti EbookDocumento150 pagineAllaScopertadeiSuoniPerduti EbookJohnny100% (1)
- Martinelli - MD.Otiti MedieDocumento19 pagineMartinelli - MD.Otiti MedieMartinelliMD100% (1)
- Cantanti ItalianiDocumento5 pagineCantanti ItalianiHacia la LuzNessuna valutazione finora
- Leggere Unita Casellato SullamDocumento152 pagineLeggere Unita Casellato SullamaldogiovanniNessuna valutazione finora
- Ludwig Van BeethovenDocumento29 pagineLudwig Van BeethovenRocco MangioneNessuna valutazione finora
- Storia Dell'arte ContemporaneaDocumento22 pagineStoria Dell'arte ContemporaneaugglorNessuna valutazione finora
- 1683 3298 1 PB PDFDocumento12 pagine1683 3298 1 PB PDFRoberto ArezzoNessuna valutazione finora
- 40a-S QUIRINO e L'insediamentoDocumento66 pagine40a-S QUIRINO e L'insediamentoliquentiaNessuna valutazione finora
- Tradizione ItalicaDocumento18 pagineTradizione Italicamassimo78Nessuna valutazione finora
- Saper Vedere La Citta - Zevi BrunoDocumento441 pagineSaper Vedere La Citta - Zevi BrunoGiuseppe FabbriNessuna valutazione finora
- La Nascita Della Società Moderna PDFDocumento14 pagineLa Nascita Della Società Moderna PDFSanto DumotNessuna valutazione finora
- LA LEGGE DI SAZIETA Corrado Ricci e LartDocumento47 pagineLA LEGGE DI SAZIETA Corrado Ricci e LartMatteorm83Nessuna valutazione finora
- Risposte EcampusDocumento5 pagineRisposte EcampusGiovanni ScognamiglioNessuna valutazione finora
- Bibliografia Di ZangheriDocumento13 pagineBibliografia Di ZangheriBr17isNessuna valutazione finora
- Qadesh 01Documento3 pagineQadesh 01flaNessuna valutazione finora
- Librogame S Land Magazine Anno 6 Numero 1 57Documento2 pagineLibrogame S Land Magazine Anno 6 Numero 1 57prodocevanoNessuna valutazione finora
- La MacedoniaDocumento3 pagineLa MacedonianicolasgueraNessuna valutazione finora