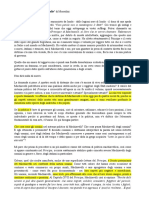Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Machiavelli
Caricato da
Chiara CigliuttiCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Machiavelli
Caricato da
Chiara CigliuttiCopyright:
Formati disponibili
NICCOLO’ MACHIAVELLI (1469-1527, Firenze)
Di famiglia borghese ebbe una formazione umanistica e orientata verso i classici latini e il senso materialistico.
Machiavelli riprende il filone dell’umanesimo civile che sollecita l’intellettuale all’impegno politico attivo:
fondatore della scienza politica moderna, i cui principi base emergono ne Il Principe.
Missioni diplomatiche. Esiliato all’Albergaccio a San Casciano dopo il ritorno dei de’ Medici. Ritornato in libertà inizia
un periodo di produzione letteraria e studi, Il Principe, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio e commedie. Dediche ai
de’ Medici gli revocano l’interdizione di ricoprire cariche pubbliche. Medici cacciati e regime repubblicano restaurato,
Machiavelli viene esonerato da ogni incarico politico, accusato di aver collaborato coi Medici.
! Rivoluzione trattato => forme del saggio: l’autore espone una sua verità individuale assumendosi consapevolmente le
responsabilità. Fondato sulle conoscenze delle leggi naturali e della storia fornite da esperienze e letture classiche.
Scandalo nella spregiudicatezza e nell’anticonformismo: autorità del proprio testo sulle proprie idee e scrittura.
Nella morale: il principe può essere giudicato in base al successo della propria azione politica fine giustifica mezzi.
Vita politica strettamente legata ai suoi scritti:
- ufficiali, legazioni e commissarie
- non ufficiali, matura il pensiero politico, fornisce informazioni e consigli, conserva ricordi e riflessioni teoriche.
Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, scritta a più riprese tra il 1513 e il 1518.
Serie di riflessioni e appunti sui primi dieci libri della storia latina scritta da Tito Livio ne Ab Urbe condita, che
costituiscono i fondamenti di una moderna teoria politica basata sul modello utopico romano.
Interrotto per scrivere Il Principe, fortemente legate, partono dalla stessa idea per diramarsi in direzioni diverse:
- Il Principe pone il problema di fondare uno stato partendo dalle virtù del principe e il conseguente saper regnare.
- I Discorsi affrontano la durata e la continuazione di uno stato già esistente.
Per Machiavelli le uniche forme di stato accettabile sono:
- il principato, monarchia “illuminata” o “limitata”, potere nelle mani del principe e dell’aristocrazia.
- la repubblica, modellata sull’esempio dell’antica Roma, con equilibrio interno, tra forze politiche e classi sociali.
Riflette su altri poteri e forme di stato con ogni conseguente degenerazione: tirannia, oligarchia o anarchia.
Riprende la teoria dell’anaciclosi (da Tito Livio e Polibio), il ciclo della vita degli stati e la ricorrenza ciclica delle forme
di governo, lo stato visto come un corpo organico e un’entità biologica. anaciclosi tesi per il suo pensiero
nascita, affermazione, sviluppo e ampliamento, decadenza e morte.
La decadenza dello Stato può essere contrastata in due modi.
- prendendo a modello gli ordini repubblicani dell’antica Roma e nel modo in cui vennero accettati e istituzionalizzati i
conflitti sociali ed equilibrati i poteri delle classi fondamentali.
- sapendo riconoscere i momenti di crisi dello Stato e sapendo ritornare alle origini.
Il Proemio al primo libro
L’autore spiega perché ha deciso di comporre l’opera: dal momento che i libri di Tito Livio non sono andati perduti
permettono di riflettere sulla storia romana e di prenderla a modello. Il progresso dipende dallo studio del passato per
conoscere il presente e applicare il criterio dell’imitazione. Fondamenti ideologia naturalistica e antistoricista.
La storia del passato rivela la condizione eterna dell’uomo e le costanti del suo comportamento.
Sembra che i principi contemporanei si siano dimenticati degli esempi antichi perché non conoscono la storia: traggono
godimento dall'ascoltare queste storie dimenticandosi che possono imitare.
Machiavelli si pone come innovatore e fondatore di una nuova teoria politica basata sulla spregiudicatezza
La fortuna e l’uomo
Fortuna entità astratta ed esterna all’uomo che lo condiziona, imprevisti del caso e indole innata (cauta o impetuosa).
Ha successo colui che riesce ad adeguarsi di continuo al variare di tempi e casi.
Repubblica: volontà collettiva, stabile in quanto la fortuna non dipende da un unica persona, ma lenta nell’adeguarsi.
Principati: dipendendo da un'unica fortuna e da unica indole, difficilmente modificabile: cadono facilmente in rovina.
Rapporto tra la vita di uno stato e gli imprevisti collegati al mutare dei tempi e della sorte.
Dell’arte della guerra, scritto non ufficiale che affronta il problema dell’utilità e dell’organizzazione dell’esercito.
Mercenarie non uniti da spirito patriottico e senso di appartenenza, ragionano egoisticamente e per convenienza.
Lo stato deve basarsi su “armi proprie”, esercito popolare che dipenda dal potere politico, dal senso di appartenenza
sia tra loro che con lo stato: importanza dello stesso ideale politico! Modello romano: la questione militare è politica.
Il Principe, in una lettera a Francesco Vettori annuncia di aver finito un opuscolo, De principatibus, e di volerlo dedicare
a Giuliano de’ Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico (dopo la su morte dedicato a Lorenzo Piero de’ Medici).
quando l’opera si diffonde in volgare prende il nome di Principe.
Forma del trattato, in ventisei capitoli con titolo in lingua latina.
Quattro sezioni tematiche:
- I-XI: diversi tipi di principato: ereditari,misti, nuovi, civili o ecclesiastici.
Stati ereditari facilmente conservabili, il principe si manterrà al potere a meno dell’intervento di forze straordinarie. La
conquista di principati del tutto nuovi si può realizzare o con armi proprie e grazie alle virtù del principe o con armi
altrui e fortuna. Prende anche in considerazione i principati governati con la crudeltà: la condanna della crudeltà non è
giudicata dal punto di vista etico ma dal punto di vista della diminuzione del consenso conseguente.
- XII-XIV: problema delle milizie mercenarie o proprie.
Armi proprie garantiscono la sicurezza dello stato. Armi mercenarie inutili e pericolose, si è obbligati alla fortuna.
Necessità di premunirsi rispetto all’imprevedibile e al costante modificarsi della realtà corrente.
!- XV-XXIII: comportamenti e virtù che si addicono al principe per governare, comportamento ideale.
Rovescia la tradizione etica del tempo per richiamare la verità effettuale, non ideale.
Liberale o parsimonioso? Parsimonia, soddisfa tutti a lungo termine, valutazione sull’efficacia effettiva: liberale significa
sperperare e soddisfare solo pochi.
Crudeltà o pietà? La pietà può generare disordini e divenire dannosa. Bisogna avere equilibrio e usare la crudeltà per
creare timore nei sudditi nella giusta proporzione per non sfociare e incorrere nell’odio. “Pietosa crudeltà”
Machiavelli sostiene la politica come realtà centauresca e che non è possibile sempre mantenere la parola data: uomo
e bestia, volpe e leone riconoscimento della violenza e dell’inganno necessari.
Prudenza nello scegliere collaboratori e uomini di fiducia che non dovranno mai sostituirsi alla virtù del principe.
- XXIV-XXVI: decadenza italiana ricondotta a cause umane e sociali (principi italiani sperano che gli occupanti stranieri
facciano rimpiangere ai sudditi il loro governo e il consenso mancato), problema del rapporto tra fortuna e virtù,
esaminazione della situazione italiana ed esortazione finale rivolta alla casata dei Medici.
auspica all’unità nazionale italiana e alla liberazione degli stranieri.
Linguaggio: misto di espressioni popolaresche e colte risultati latineggianti più emulazione aspetto dialogico.
“Procedimento dilemmatico” o disgiuntivo: espone quello di cui parla poi argomenta con una successione di frasi
principali collegate tra loro da congiunzioni avversative o disgiuntive (aut-aut latino).
classificazione antitetica ad albero, contrapposizioni binarie, procedendo con l’eliminazione progressiva di un
elemento della coppia per proseguire con il ragionamento su un singolo elemento a sua volta diramato.
Ideologia del principe, principi del suo pensiero esposto: realismo o utopia?
- osservazione della realtà nel suo essere e nel suo divenire concetto di verità effettuale, indagare la verità umana,
collegamento logico tra realtà e l’effetto che scaturisce.
- situazione di crisi della geopolitica italiana soluzione estrema = fondazione di una nuovo stato unito seguendo le
forme moderna dei grandi stati europei e quindi superare i particolarismi dell’eredità feudale.
- trascende l’aspetto religioso => visione materialistica e naturalistica della realtà e concezione laica dello stato.
- possibilità dell’uomo di progettare e trasformare la realtà sociale. ! problema del rapporto tra politica e morale.
La lettera dedicatoria: rapporto tra l’intellettuale e il potente interlocutore.
Fa dono a Lorenzo De’ Medici del trattato: si augura che possa piacere e intervenire a sollevarlo dalla cattiva sorte.
L’opera è piccola per la sua magnificenza ma spera che la possa accettare così da comprendere le sue conoscenze.
Lo invia con un animo benevolo e di sottomissione e augura che possa trarne insegnamento per il suo operato e che la
sua attività da regnante sia dominata dalla fortuna. L'obiettivo è spiegare l’argomento e le caratteristiche del trattato.
Non ha badato alla forma, essendo il contenuto di gran lunga più importante della sua veste letteraria.
Tipi di principato e modi di acquistarli: incipit, primo capitolo.
Machiavelli procede nell’analisi in modo dilemmatico e antitetico, mettendo in risalto la necessità della scelta.
Nella sua brevità enuncia tutti temi del trattato operando una prima distinzione tra repubbliche e principati.
Machiavelli mostra la sua originalità nella presentazione della materia e nello stile con cui la tratta.
La “verità effettuale”: inizio della trattazione delle qualità desiderabili per il principe.
La realtà effettuale è la conoscenza della realtà empirica e delle sue leggi concrete.
La verità effettuale è la realtà concreta delle cose, oggetto della politica che deve guardare a come esse sono e non a
come si vorrebbe che fossero. “Verità”= come si deve vivre, non come si dovrebbe.
Il principe non può avere comportamenti ideali legati alla morale, deve agire guardando gli effetti concreti che produce
secondo le necessità, senza pregiudizi idealistici. Respinto il catalogo di qualità o vizi da perseguire o evitare.
A un principe buono ma politicamente sconfitto Machiavelli preferisce un principe vincente, disposto a non essere
buono ma capace di salvaguardare il potere suo e il benessere dello Stato.
Il capitolo si divide in due paragrafi: nel primo parla di metodo e principio dove rivendica l’originalità del suo pensiero,
nel secondo considera la questione applicandola al caso specifico,concreto e particolare.
Il leone e la volpe: animalità e lotta politica
Ribaltata la concezione di lealtà e fedeltà nei confronti dei cittadini vincente l’astuzia e la consapevole malafede.
Il principe deve possedere la componente dell’uomo, confronto di idee e diplomazia, e quella di bestia, la violenza.
Doppia metafora di volpe, astuzia, e leone, forza: solo usando entrambe si può governare adeguatamente, anche senza
necessariamente tenere la parola data (necessario saper mascherare la volpe).
Metafora del centauro, indispensabile saper mediare tra le due facce per raggiungere i fini politici d’interesse.
Cause della decadenza italiana: critica ai principi italiani e all’intera situazione politica basata sulla verità effettuale.
Lessico chiaro e crudo, precisione nell’elencare cause e responsabilità, giudizi e valutazioni netti e chiare.
Nella prima parte lamenta l’incapacità dei principi di muoversi in maniera attiva per difendere il loro paese, una delle
cause è l’appoggiarsi sui talloni quando si trovano in periodi di pace, non facendo “nulla”.
Nella seconda parla di regnanti che non hanno saputo tenere il potere (Federico d’Aragona perde il regno schiacciato
dalla contesa di Francia e Spagna; Ludovico il moro perde il ducato di Milano per l’infedeltà dei mercenari svizzeri).
Nella terza parte troviamo il nucleo centrale cioè l’incapacità di saper agire dei principi che sperano che siano gli altri a
fare qualcosa in modo che loro possano tornare al potere. ! irrimediabile declino politico.
La fortuna: rapporto tra il singolo, principe e fortuna.
Talvolta anche lui sostiene impossibile prevedere e dominare gli eventi, è inutile affaticarsi per modificare la realtà.
! fortuna fiume rovinoso gli uomini previdenti devono disporre per tempo argini e ripari.
La fortuna è straordinariamente mutevole mentre la natura è immodificabile.
Nonostante ciò dichiara esplicitamente la preferenza per l’azione impetuosa piuttosto che rinunce e cautele.
Fortuna-donna: vinta da chi è giovane, coraggioso, deciso, da energia e audacia, piuttosto che dalla circospezione.
La fortuna è la forza direttamente opposta alla capacità che ha il principe di governare.
1- tra fortuna e virtù il conflitto è perenne, uomini inclini a rassegnarsi di fronte al potere della fortuna.
2- diversi modi con cui ci si approccia alla fortuna.
L’esortazione finale: exhortatio
Resoconto chiaro e delineato dell’opera e del suo scopo finale: incita la casata dai Medici all’impresa della liberazione.
Si apre con una fiduciosa valutazione delle condizioni presenti: favorevoli a rendere degno di onore un principe nuovo.
Inizialmente descrive la situazione di crisi italiana, la sua forte necessità di redenzione, continua con la denuncia della
debolezza delle milizie italiane e infine troviamo l’esortazione che auspica all’unione dell’Italia come nazione.
Conclude l’intera opera con la canzone all’Italia di Petrarca che riprende la tradizione umanistica del tempo ed
enfatizza la speranza in questa unione italiana.
Potrebbero piacerti anche
- NICOLODocumento2 pagineNICOLOtommasorella19Nessuna valutazione finora
- Niccolò Machiavelli (1469-1527)Documento7 pagineNiccolò Machiavelli (1469-1527)susanna boktorNessuna valutazione finora
- MacchiavelliDocumento18 pagineMacchiavelliLiam HidalgoNessuna valutazione finora
- Macchiavelli, Guicciardini e TassoDocumento24 pagineMacchiavelli, Guicciardini e TassoGiulia FedeleNessuna valutazione finora
- Niccolò MachiavelliDocumento6 pagineNiccolò MachiavelliJoseph990Nessuna valutazione finora
- Slides MachiavelliDocumento63 pagineSlides MachiavelliNapoletano GiannaNessuna valutazione finora
- Niccolò MachiavelliDocumento31 pagineNiccolò Machiavellimilazzovito16Nessuna valutazione finora
- Nicolò MachiavelliDocumento3 pagineNicolò MachiavelliTestNessuna valutazione finora
- Letteratura Italiana IV AnnoDocumento78 pagineLetteratura Italiana IV AnnoicaroheartNessuna valutazione finora
- Niccolò MachiavelliDocumento2 pagineNiccolò MachiavelliginoNessuna valutazione finora
- Niccolo MachiavelliDocumento2 pagineNiccolo MachiavelliFrancesco MoracaNessuna valutazione finora
- Niccolò MachiavelliDocumento3 pagineNiccolò MachiavellibaktusNessuna valutazione finora
- Il Principe Di MachiavelliDocumento5 pagineIl Principe Di MachiavelliMatteo CocoNessuna valutazione finora
- MachiavelliDocumento5 pagineMachiavelliSelene BaccinelliNessuna valutazione finora
- Niccolo MachiavelliDocumento5 pagineNiccolo Machiavellilau lauNessuna valutazione finora
- MacchiavelliDocumento4 pagineMacchiavelliMario CaredduNessuna valutazione finora
- Mussolini - Preludio Di MachiavelliDocumento3 pagineMussolini - Preludio Di Machiavellisebatorres7Nessuna valutazione finora
- Machiavelli - Appunti VariDocumento10 pagineMachiavelli - Appunti VariMastromauroNessuna valutazione finora
- Appunti: Leviatano T.HobbesDocumento28 pagineAppunti: Leviatano T.Hobbesfedro.schmidtzulianNessuna valutazione finora
- Italiano - MachiavelliDocumento5 pagineItaliano - MachiavelliTeodora ManeaNessuna valutazione finora
- NICOLÒ MACCHIAVELLI CompletoDocumento4 pagineNICOLÒ MACCHIAVELLI CompletoMichele MiloneNessuna valutazione finora
- Niccoló MachiavelliDocumento2 pagineNiccoló MachiavelliFrancesca PaganiNessuna valutazione finora
- MACHIAVELLIDocumento7 pagineMACHIAVELLIYllka KosumiNessuna valutazione finora
- Niccolò MachiavelliDocumento18 pagineNiccolò MachiavelliAndrea BoglioneNessuna valutazione finora
- MacchiavelliDocumento17 pagineMacchiavelliAlexofCatarinaNessuna valutazione finora
- Machiavelli Per I RagazziDocumento19 pagineMachiavelli Per I RagazziDarius RadulescuNessuna valutazione finora
- Dottrine PoliticheDocumento120 pagineDottrine Politicherossettigiovanni95Nessuna valutazione finora
- Letteratura Italiana CompletoDocumento32 pagineLetteratura Italiana CompletoAlessia Di BartoloNessuna valutazione finora
- Appunti Sul Principe Di MachiavelliDocumento10 pagineAppunti Sul Principe Di MachiavellismataloneNessuna valutazione finora
- Niccolò MachiavelliDocumento3 pagineNiccolò MachiavelliMarzia Di LecceNessuna valutazione finora
- Il Principe - Niccolò MachiavelliDocumento31 pagineIl Principe - Niccolò Machiavelliaurora leonardoNessuna valutazione finora
- MachiavelliDocumento12 pagineMachiavelliMarta GallucciNessuna valutazione finora
- Appunti Di Storia Della Filosofia Politica (Acocella) PDFDocumento35 pagineAppunti Di Storia Della Filosofia Politica (Acocella) PDFDario CositoreNessuna valutazione finora
- MACHIAVELLIDocumento9 pagineMACHIAVELLIGaia VerduraNessuna valutazione finora
- 21 La Polis Dopo Il Rinascimento 25 06 06Documento6 pagine21 La Polis Dopo Il Rinascimento 25 06 06marcosabatiniNessuna valutazione finora
- Storia Delle Dottrine Politiche - SidDocumento37 pagineStoria Delle Dottrine Politiche - Sidgiorgio.g53Nessuna valutazione finora
- Concezione Politica Di MacchiavelliDocumento7 pagineConcezione Politica Di MacchiavellikrezimNessuna valutazione finora
- Niccolò MachiavelliDocumento5 pagineNiccolò MachiavelliGler GrimaNessuna valutazione finora
- Confronto Machiavelli-GuicciardiniDocumento1 paginaConfronto Machiavelli-GuicciardiniNicolò Gino CoratoNessuna valutazione finora
- Il Principe Di MachiavelliDocumento3 pagineIl Principe Di Machiavelligiuliaricchi01Nessuna valutazione finora
- Appunti Italiano MACHIAVELLIDocumento2 pagineAppunti Italiano MACHIAVELLIDenisa GrigoreNessuna valutazione finora
- Risposte ItalianoDocumento1 paginaRisposte ItalianoKafkaNessuna valutazione finora
- De Robertis - Note Sull'antropologia Di Giovanni Pico e Niccolo' Macchiavelli PDFDocumento9 pagineDe Robertis - Note Sull'antropologia Di Giovanni Pico e Niccolo' Macchiavelli PDFPaola VerdiNessuna valutazione finora
- Letteratura 4Documento15 pagineLetteratura 4Ramona MemishevaNessuna valutazione finora
- La Trattatistica PoliticaDocumento7 pagineLa Trattatistica PoliticasasysavNessuna valutazione finora
- Storia Delle Dottrine PoliticheDocumento65 pagineStoria Delle Dottrine PoliticheElio FerraraNessuna valutazione finora
- 18 Capitolo, Principe, MachiavelliDocumento3 pagine18 Capitolo, Principe, MachiavelliVeronica RossiNessuna valutazione finora
- Il Pensiero Politico Di Machiavelli Di G. SassoDocumento2 pagineIl Pensiero Politico Di Machiavelli Di G. SassoFet38ganlyNessuna valutazione finora
- Macchiavelli e Guicciardin1Documento1 paginaMacchiavelli e Guicciardin1giacob100% (3)
- Il Pensiero Politico Di MachiavelliDocumento4 pagineIl Pensiero Politico Di Machiavelliliceovirgof100% (2)
- Pensiero/Riassunto Di MachiavelliDocumento4 paginePensiero/Riassunto Di MachiavelliKnabodinalioNessuna valutazione finora
- GuicciardiniDocumento2 pagineGuicciardiniIlaria Di CapuaNessuna valutazione finora
- Machiavelli e GuicciardiniDocumento11 pagineMachiavelli e GuicciardiniLmpus Anna100% (1)
- Appunti Storia Delle Istituzioni Politiche e SocialiDocumento127 pagineAppunti Storia Delle Istituzioni Politiche e SocialiArianna LicataNessuna valutazione finora
- Biografia Niccolò MachiavelliDocumento2 pagineBiografia Niccolò MachiavellirapheliosssNessuna valutazione finora
- Parte 2Documento1 paginaParte 2Enrico SbaragliaNessuna valutazione finora
- Franco Venturi - Utopia e Riforma Nell'illuminismo (Riassunto)Documento14 pagineFranco Venturi - Utopia e Riforma Nell'illuminismo (Riassunto)fedeg94Nessuna valutazione finora
- Pedagogia Del '900Documento2 paginePedagogia Del '900Chiara CigliuttiNessuna valutazione finora
- Sviluppo Del LinguaggioDocumento1 paginaSviluppo Del LinguaggioChiara CigliuttiNessuna valutazione finora
- The Brain - DickinsonDocumento1 paginaThe Brain - DickinsonChiara CigliuttiNessuna valutazione finora
- MANZONIDocumento4 pagineMANZONIChiara CigliuttiNessuna valutazione finora
- Riforma Protestante e ControriformaDocumento4 pagineRiforma Protestante e ControriformaChiara CigliuttiNessuna valutazione finora
- MarinoDocumento1 paginaMarinoChiara CigliuttiNessuna valutazione finora
- Direzioni e Momenti Principali D'inerziaDocumento1 paginaDirezioni e Momenti Principali D'inerziaMarco SulcisNessuna valutazione finora
- Riassunti Inferno Divina CommediDocumento18 pagineRiassunti Inferno Divina CommediPietro BologniniNessuna valutazione finora
- Beato Pier Giorgio Frassati - Stampa 4,1 - 2,3Documento4 pagineBeato Pier Giorgio Frassati - Stampa 4,1 - 2,3TreSacriCuori di Gesù, Maria e GiuseppeNessuna valutazione finora
- Scheda Armi Sine RequieDocumento2 pagineScheda Armi Sine RequieDavy02100% (1)
- Art de La Guerre - Traduzione Italiana - Versione 3Documento79 pagineArt de La Guerre - Traduzione Italiana - Versione 3pippobaudo100% (1)
- Cristal 10Documento17 pagineCristal 10Vale46 RossiNessuna valutazione finora
- Movimenti Ginnico SportiviDocumento25 pagineMovimenti Ginnico Sportivigrass7stopNessuna valutazione finora