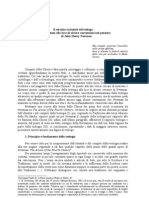Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
D'Onofrio - Storia Del Pensiero Medievale - RIASSUNTO
D'Onofrio - Storia Del Pensiero Medievale - RIASSUNTO
Caricato da
ramon2799Titolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
D'Onofrio - Storia Del Pensiero Medievale - RIASSUNTO
D'Onofrio - Storia Del Pensiero Medievale - RIASSUNTO
Caricato da
ramon2799Copyright:
Formati disponibili
lOMoARcPSD|11702785
Riassunto Manuale D' Onofrio
Storia della filosofia medievale (Università degli Studi di Torino)
StuDocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE!
!
Agostino!
!
Vita e Opere!
Agostino nasce nel 354 a Tagaste e riceve un’educazione letteraria e retorica, senza
apprendere tuttavia il greco. Conduce un’esistenza dissipata e si avvicina al
manicheismo, una religione dualistica, nella quale confluivano elementi di origine
persiana, ma soprattutto elementi gnostici, anche cristiani: il nucleo della dottrina era il
riconoscimento di due principi divini antitetici, il regno della luce e il regno delle tenebre.
Nel 382 decide di trasferirsi a Roma, seguito dal figlio e dalla madre, dove insegna
retorica, riscuotendo parecchio successo. Il prefetto Simmaco lo designa professore di
Retorica a Milano, dove Agostino si reca e assiste alle prediche del Vescovo Ambrogio,
che lo spronano a leggere la Bibbia. Nel 385 decide di farsi catecumeno e inizia a
leggere le opere di Plotino e Porfirio. Nel 386 avviene la conversione. Nell’aprile del 387
riceve il battesimo a Milano da Ambrogio e prende la decisione di tornare in Africa a
condurre una vita cristiana di meditazione; durante il tragitto di ritorno muore la madre
Monica, fervente cattolica che ha giocato un ruolo di rilevante importanza nella
conversione di Agostino. Nel 391 si reca a Ippona dove è fatto prete per aiutare il
vescovo della città Valerio. Nel 396 è nominato Vescovo di Ippona, in seguito alla morte
di Valerio. Verso il 397 inizia la composizione della sua opera più originale, le
Confessioni, scritta in 13 libri. Agostino si concentra inoltre nella battaglia contro il
Pelagianesimo, contro il quale scrisse numerose opere. Nell’agosto del 430 Agostino
muore, colpito da una violenta febbre. La produzione letteraria di Agostino è immensa:
comprende un densissimo epistolario e più di 600 sermones. In seguito alla conversione
Agostino si è dato a uno studio intenso delle Scritture. Oltre alle Confessioni, un’altra
sua opera molto importante è il De Civitate Dei, opera apologetica in 22 libri redatta tra il
412 e il 426!
!
Il problema del male !
a) l’adesione al manicheismo: sin dalla lettura giovanile dell’Ortensio di Cicerone,
Agostino si chiede perchè noi uomini siamo soliti fare il male e la sua adesione al
manicheismo deve essere letta come un tentativo di cercare una risposta a questa
domanda. Il manicheismo afferma che il male è un principio ontologico, dal quale
tuttavia è possibile affrancarsi. !
b) il rifiuto del manicheismo e il contributo di Ambrogio: il manicheismo non lo soddisfa
però pienamente in quanto secondo Agostino non è possibile che Dio subisca
mutamenti e addirittura soffra. Si convince allora, grazie anche alle prediche di
Ambrogio, che non possono esistere due principi contrapposti: la divinità è per
giunta unica, incorruttibile e incorporea. !
c) da dove deriva il male?: ma se Dio è il Bene ed è l’unico principio, da dove deriva il
male? In un primo momento, durante gli anni della conversione, la risposta di
Agostino è vicina alla soluzione del neoplatonismo. Secondo il neoplatonismo, tutto
ciò che è è Bene e proviene da Dio, tuttavia c’è una scala gerarchica dei beni che
va dal Sommo Bene a ciò che è soltanto corporeo. Il male quindi non è altro che
mancanza di bene e non è ontologicamente autonomo. Una metafora esemplifica
questa visione: il male sta all’essere come la cecità sta alla vista. !
d) quand’è che compiamo il male?: Agostino risponde che si compie il male
ogniqualvolta dirigiamo la nostra volontà verso un bene temporale, ossia quando
Pagina 1 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
amiamo un bene che è inferiore al Sommo Bene come se fosse il Sommo Bene: è
dunque nella volontà umana da ricercare il “principio” del male, in quanto essa può
scegliere liberamente di non dirigersi verso Dio. !
e) perchè l’uomo è libero?: Agostino si chiede inoltre perchè Dio abbia dato libertà
all’uomo e la sua risposta è che senza la libertà non sarebbe possibile azione retta
da parte dell’uomo. Ma come è compatibile ciò con la prescienza propria di Dio?
Agostino risponde che Dio prevede la nostra azione, ma la prevede come dovuta
alla nostra volontà. Dio prevede dunque la volontà come in nostro potere e pertanto
la sua prescienza non ci sottrae la libertà. !
!
Ricerca della verità e interiorità!
La conversione al cristianesimo non significa in Agostino abbandono della filosofia, ma
fiducia di poter proseguire l’indagine intellettuale con l’aiuto di Dio e la felicità risiede
nella sapienza, nel vivere in conformità alla ragione. LA SAPIENZA, secondo Agostino,
È CONSEGUIBILE, DIFFERENTEMENTE DA QUANTO PENSANO GLI SCETTICI.!
a) L’argomento vs lo scetticismo: nello scritto “Sul libero arbitrio” Agostino si interroga
sul fondamento della certezza: tu sai di esistere e di ciò non puoi dubitare, perchè
se tu non esistessi, non potresti neppure essere ingannato, compendiata nella
celeberrima frase “si fallor, sum”: se m’inganno, esisto e ho la certezza di esistere.
Ogni dubitare presuppone l’esistenza e la vita, dunque il dubbio scettico
sull’esistenza viene a dissolversi. Quest’argomentazione ha la peculiarità di cercare
la garanzia della verità e della certezza non nel mondo esteriore, bensì
nell’interiorità. !
b) la verità: entro di sè l’uomo ricava un nocciolo di verità, del quale non può
ulteriormente dubitare. La verità non è soltanto proprietà delle proposizioni, che
sono molte. Essa è una e immutabile, è la parola di Dio. Essa è eterna e continua a
sussistere anche nell’ipotesi che il mondo vada distrutto. !
c) il ruolo del linguaggio: Agostino si interroga anche sul ruolo del linguaggio che è
strumento per insegnare e ricordare. In seguito al peccato originale, tra Dio e l’uomo
si è creato un divario tale che potrà essere ricucibile soltanto attraverso la Parola di
Dio, che si è manifestata nella Sacra Scrittura attraverso le parole, che sono dei
segni. !
!
Illuminazione e dialogo con Dio!
!
a) verità vs anima: la verità è eterna, mentre l’anima umana è una sostanza immortale,
indipendente dal corpo, ma non eterna. !
b) Dove si trova la verità? La verità è qualcosa che l’anima trova dentro di sè; “Noli
foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas”. !
c) il ruolo dell’illuminazione: infatti ATTRAVERSO L’ILLUMINAZIONE, ossia l’irradiarsi
della parola divina, L’ANIMA VIENE CONDOTTA AL RAGGIUNGIMENTO DELLA
CONOSCENZA OGGETTIVA. Proprio grazie a questa luce interiore, l’anima può
recuperare, in un processo di reminiscenza, le verità immutabili, le cosiddette
“regole eterne” e, riprendendo la concezione platonica, Agostino mostra che le idee
esistono nel Logos come modelli della creazione delle cose. !
d) Dio e l’anima: Agostino si prefigge lo scopo di conoscere Dio e l’anima, ma la
ricerca di uno è indisgiungibile da quella dell’altro. Infatti si tratta di un itinerario che
conduce dall’anima a Dio. LA DIVINITÀ POSSIEDE LA VERITÀ E ILLUMINA GLI
UOMINI NELLA LORO RICERCA.!
Pagina 2 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
e) l’interiorità: emerge dunque l’interiorità, ossia la dimensione costitutiva della filosofia
di Agostino, che è quello spazio entro il quale l’anima può rivolgersi direttamente a
Dio. IL PENSIERO DIVENTA DIALOGO INTERIORE TRA L’UOMO E DIO. “Il nostro
cuore è inquieto finchè non riposi in te”. Dio ha fatto l’uomo per sè e quindi il cuore
dell’uomo non troverà pace finchè non riposerà in Dio. !
!
Il problema del tempo!
a) Un nuovo modo di vedere il tempo: Agostino analizza in una prospettiva nuova,
rispetto alla tradizione classica, il problema del tempo. Viene affrontato
nell’undicesimo libro delle Confessioni. !
b) Dio non è nel tempo, ma lo crea: Agostino ritiene innanzitutto che Dio non sia nel
tempo: ne è al di fuori. Dio abita l’eternità, che è una simultaneità, un esser tutto
presente, a differenza del tempo che è fluire incessante. Con la creazione delle
cose Dio crea anche il tempo, che quindi non esiste prima della creazione. !
c) il presente non ha estensione: il tempo esiste come presente solo a condizione di
tramutarsi immediatamente in passato e di non essere ancora futuro. Il presente
infatti non ha estensione e si dà continuamente il tradursi del futuro nel passato. !
d) il tempo e l’interiorità: la novità introdotta da Agostino è aver compreso che bisogna
guardare nell’interiorità di se stessi per cogliere la vera realtà del tempo. Le tre
dimensioni del tempo sono dunque le tre dimensioni presenti nella nostra anima:
eventi passati, presenti e futuri sono tre “presenti” nella nostra anima. !
e) il tempo come distensio animi: il tempo è quindi una “distensio animi”, un distendersi
dell’anima. CIÒ CHE VIENE MISURATO DALL’ANIMA NON SONO LE COSE NEL
LORO TRASCORRERE, MA L’AFFEZIONE CHE ESSE LASCIANO E CHE
PERMANE NELLA NOSTRA ANIMA ANCHE QUANDO SONO TRASCORSE. Le tre
dimensioni dell’anima sono: il ricordo, il prestare attenzione a qualcosa, l’attesa. In
conclusione si può dire che se non ci fosse l’anima, non ci sarebbe il tempo. !
!
L’anima e la trinità!
a) ragione e fede: la ricerca di Dio coinvolge l’intera dimensione affettiva dell’uomo e
avere fede significa amare Dio; tra i due poli della razionalità e della fede non esiste
alcun tipo di contrasto. Agostino cita le parole del profeta Isaia: “se non crederete,
non intenderete” e proclama il celebre “credo ut intelligam et intelligo ut credam”. !
b) la tripartizione dell’anima: L’esperienza che l’anima fa di sè nella propria interiorità
consente di raggiungere conoscenze che possono illuminare la natura stessa di Dio
e in questa esperienza di sè è riscontrabile una tripartizione di memoria, intelligenza
e volontà, alla quale corrisponde una tripartizione tra essere, sapere e amare. Esse
non sussistono indipendentemente l’una dall’altra, ma sono ciò che sono in virtù
delle relazioni reciproche intercorrenti tra esse. !
c) l’analogia parziale dell’anima con Dio: l’unità dell’anima nell’insieme delle sue
articolazioni dinamiche risulta essere immagine di Dio stesso, uno e trino: Padre,
Figlio e Spirito Santo, tre persone che hanno un’unica essenza, quella divina.
TUTTAVIA L’ANALOGIA TRA L’ANIMA UMANA E LA TRINITÀ DIVINA È
SOLTANTO PARZIALE, PERCHÈ MENTRE NELL’UOMO LE TRE FUNZIONI NON
SONO TRE PERSONE, IN DIO VI È UNA SOLA SOSTANZA CHE SI ARTICOLA IN
TRE PERSONE. E la creazione del mondo stessa è opera comune delle tre
persone, non soltanto del Logos. Occorrerebbe concludere che a incarnarsi è la
stessa trinità, ma su questo punto Agostino arresta la sua indagine, riconoscendo
che la questione è oscura.!
Pagina 3 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
!
La predestinazione e la grazia!
a) vs la libertà del volere: progressivamente Agostino viene accentuando l’accusa di
superbia contro i filosofi, soprattutto stoici, ma anche platonici, che hanno preteso di
raggiungere la virtù e la felicità secondo le proprie forze. Secondo Agostino la
volontà umana non gode di completa libertà, rinnegando le sue posizioni precedenti
circa l’assoluta libertà della volontà. Infatti il peccato originale di Adamo ha
contaminato la natura umana e pertanto l’uomo non è in grado di redimersi da sè. !
b) l’incarnazione di Cristo e il ruolo della Chiesa: in questo senso è centrale
l’incarnazione di Cristo, da cui infatti dipende la redenzione degli uomini e la vera
felicità sarà possibile solo nella resurrezione finale. Nell’opera della redenzione, la
Chiesa svolge una funzione di mediazione tra l’uomo e Dio ed è una comunità
universale che deve accogliere anche i peccatori, differentemente dal
pelagianesimo che propugnava una comunità di eletti. La salvezza dell’uomo
dipende dalla grazia concessa da Dio. !
c) polemica vs pelagianesimo: Agostino s’impegna nella battaglia contro il
pelagianesimo. Pelagio sosteneva che il peccato di Adamo non avesse corrotto il
libero arbitro dell’uomo tanto che a suo avviso la perfezione sarebbe quindi
raggiungibile attraverso la realizzazione di opere buone, indipendentemente
dall’intercessione della grazia divina. Secondo Agostino invece la volontà deve
essere salvata dalla grazia di Dio per diventare libera dal peccato, in quanto l’uomo
non è libero di non peccare: libero è allora soltanto colui che è chiamato dalla grazia
divina alla vera libertà, che consiste nel sottomettersi al bene. La vita felice diventa
un bene indipendentemente dai meriti dell’uomo, perchè se così non fosse, Dio non
sarebbe chiamato in causa nella questione della salvezza. !
d) grazia e predestinazione: la dottrina della grazia è strettamente dipendente dalla
dottrina della predestinazione: è Dio infatti che stabilisce coloro che si salveranno e
coloro che saranno dannati. Tuttavia il singolo non è certo della sua salvezza o
meno. Ciò contribuisce a far assumere un atteggiamento combattivo, interpretando
ogni atto deliberato, da parte di Dio, di misericordia per l’eletto e di condanna per il
reprobo. !
!
Le due città e la storia!
1- Nello scrivere la città di Dio Agostino mira a mostrare la superiorità del cristianesimo
rispetto a tutte le altre forme di cultura puramente umane. 2- Al centro dell’opera vi è il
tema della provvidenza divina: è Dio che fa nascere e perire gli imperi; 3- Agostino
elabora una teologia della storia dove le vicende storiche dipendono dall’ordinamento
voluto da Dio e l’intero corso della storia può essere inteso come carico di significati, che
il credente potrà comprendere soltanto parzialmente. !
a) la visione lineare: Agostino ritiene che la storia abbia una durata limitata e che la
sua epoca sia ormai vicina alla fine. Infatti, al contrario della visione ciclica degli
stoici, la vicenda storica ha un andamento lineare, il quale sfocia in un evento finale
ultraterreno, che dà senso a tutto quanto precede. IL FILO ROSSO DELLA STORIA
È DATO DALLA LOTTA TRA IL BENE E IL MALE, CHE SI COSTITUISCONO IN
DUE REGNI. I due regni coesistono, intrecciati e confusi tra loro. Questa distinzione
si traduce in quella tra due città: la città di Dio e la città terrena. La prima è costituita
dagli uomini giusti, che vivono secondo lo spirito; la seconda dagli uomini ingiusti,
che vivono secondo la carne. L’appartenenza a ciascuna delle due città dipende
soltanto dalla grazia divina. !
Pagina 4 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
b) la città terrena: la città terrena non deve essere identificata con lo Stato, ma
piuttosto è quella che venera i falsi dei e non vive secondo i veri valori, dove agisce
la libido dominandi, il desiderio del potere che imprigiona gli uomini. Agostino
ravvisa in Caino il capostipite della città terrena. !
c) la città di Dio: la città di Dio è invece la Chiesa di quanti vivono secondo Dio. Non
coincide numericamente con tutti quanti fanno parte della Chiesa visibile; non a tutti,
infatti Dio elargisce la sua grazia. La Chiesa sarà di puri solo nel giorno del Giudizio
Universale e il cittadino del regno di Dio non potrà mai realizzare pienamente il
desiderio umano fondamentale: il desiderio di pace. Solo la resurrezione finale
apporterà la risoluzione di ogni tensione e di ogni conflitto, tra carne e spirito e tra
uomo e uomo. Il bene trionferà completamente soltanto alla scomparsa della storia,
“nel sabato che non ha sera”. !
!
1. Vera philosophia: la sintesi di fede e ragione !
D'Onofrio inizia la sua introduzione alla storia del pensiero medievale citando l'Omelia di
Giovanni Scoto Eriugena sul Prologo del quarto Vangelo. 1- In essa troviamo una lettura
dell'episodio biblico in cui alla notizia della resurrezione di Cristo Giovanni e Pietro
corrono entrambi verso il sepolcro: Giovanni è più giovane, e quindi corre più veloce di
Pietro, ma una volta arrivato al sepolcro si ferma e aspetta Pietro. 2- Giovanni
rappresenta l’intelligenza, mentre Pietro rappresenta la fede. E perciò, poichè è scritto
“se prima non avrete creduto, non potrete comprendere” è necessario che la fede
penetri per prima nel monumento della Scrittura, e che poi, seguendola, entri anche
l’intelletto, il cui accesso è reso possibile proprio dalla fede. La ragione naturale deve
essere attivata sia prima dell’atto di fede per giustificarlo, sia successivamente per
consolidarne i contenuti. !
a) I filosofi pagani: difatti i filosofi pagani, non avendo potuto conoscere la Verità, hanno
percepito con preoccupazione i ripetuti fallimenti delle proprie indagini e delle
contraddizioni sistematiche tra scuole; addirittura Cicerone, sulla scia degli Accademici,
apprese la necessità di assumere una posizione probabilistica, persuaso che il vero
fosse destinato a rimanerci oscuro, giungendo così a pensare che compito della filosofia
fosse solamente quello di escogitare norme pragmatiche per orientarsi nella società. Ma
una filosofia ridotta a mero supporto metodologico per l’orientamento pratico tradisce le
sue originarie intenzioni e le sue aspirazioni di verità, rimanendo dunque inautentica. !
b) La Vera Philosophia: la Vera Philosophia è per Agostino infatti solo quella dei cristiani,
i quali HANNO COMPRESO INNANZITUTTO QUALE SIA VERITÀ PER POI
CONSOLIDARLA CON GLI STRUMENTI DELLA RATIO, e a questo proposito Scoto
Eriugena scrive che “la vera philosophia è la vera religio, e che la vera religio è la vera
philosophia”, dato che la Verità è una e una sola, e che una vera religione e una vera
filosofia non possono che sostenere le medesime tesi. !
c) L’atto fondante dell’età medievale: L’atto fondante dell’età medievale si risolve nella
scelta di portare pregiudizialmente il pensiero ad aderire a una “parola” la cui
attendibilità è verificabile soltanto sulla base di quanto essa stessa afferma, e di
muovere di qui alla ricerca delle ulteriori conoscibilità possibili. La ragione speculativa
medievale conosce in partenza la propria meta, coincidente con la Rivelazione, ma è
suo compito 1) perseguirne la dimostrabilità, 2) approfondirne il significato ed 3)
evidenziarne le possibili conseguenze.!
!
2. Sana doctrina: l'oro degli Egiziani e la moneta del re
a) San Paolo: Quando san Paolo, secondo il racconto di Luca, incontra i saggi di Atene,
Pagina 5 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
nonostante l'ilarità che le sue parole producono negli uditori, si compe il primo innesto
della Rivelazione sulle tronche ricerche della scienza umana. E quando Paolo
raccomanda il consolidamento della fede in una “sana doctrina”, sta proponendo di
organizzare la comprensione del dato rivelato in una struttura disciplinare, il che
autorizza il cristiano ad attingere dagli insegnamenti della sapienza antica per
organizzare questa struttura disciplinare.!
b) Teologia cristiana e filosofia antica: 1) L’interdipendenza tra il cristianesimo e la
filosofia antica è reperibile sin dal prologo del Vangelo di Giovanni: Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ
λόγος. Lόγος è ciò che si identifica e si incarna nella Seconda Persona divina, Cristo, il
Figlio. 2) All’affinamento di questo nucleo concettuale hanno poi contribuito i predicatori
dei primi secoli, che si sono impadroniti del linguaggio filosofico per dialogare con gli
esponenti delle scuole pagane e controbatterne le accuse di ignoranza e superstizione.
3) Poi i protagonisti della tradizione speculativa patristica hanno fissato gli elementi
portanti della terminologia dogmatica di contro i vari tentativi di razionalizzazione eretica.
4) E ancora, davanti alla crisi dell'Impero il cristianesimo ha bisogno di fondarsi con
ancora più vigore per resistere in quanto comunità a fronte di un'invasione che sembra
in grado di cancellare ogni traccia di civiltà: i pensatori del tempo si trovarono dunque ad
attingere alle scuole antiche e a trarne gli insegnamenti più adatti allo scopo. Ciò in
alcuni casi portava al timore di preferire i classici al Vangelo (Girolamo sognò Cristo
stesso che lo rimproverava per questo). LA SCIENZA PAGANA VIENE DUNQUE VISTA
COME ANCILLA THEOLOGIAE, OVVERO COME SERVA DELLA VERA
CONOSCENZA. !
c) l’oro degli egiziani: Vi è un episodio biblico che ben rappresenta il rapporto tra scienza
pagana e cristianesimo: l’oro degli Egiziani rubato dagli Israeliti prima di partire per la
terra promessa allude al diritto da parte dei seguaci di Cristo di impadronirsi delle arti
pagane: dopo aver rubato l'oro agli Egiziani, chi usa tale ricchezza per soddisfare le
illecita aspirazioni conosctive della razionalità forgerà l’icona idolatrica del vitello d’oro,
mentre chi la purifica e la riversa nella vera sapienza per comprendere la Rivelazione
ubbidisce alla legge divina. Nell'ottica medievale, dunque, l'anteporre aspirazioni umane
al mistero della fede non potrà che condurre all'errore. !
d) la moneta del re + Boezio: I filosofi greci, secondo lo pseudo-Dionigi, credono di
possedere la moneta del re, ma non hanno invece nient’altro che un’ingannevole ombra.
A tal proposito Boezio, dal carcere, scrive la Consolatio Philosophiae, in cui la Filosofia
gli si presenta con il vestito lacero e logoro, dicendo che la colpa sarebbe dei piccoli
filosofi pagani, che, dopo averle strappato un pezzo del vestito, sono andati in giro per il
mondo sostenendo di essersi impadroniti di tutta la verità. Boezio era stato condannato
a morte da Teodorico, re degli Ostrogoti, per la sua ricerca della verità in termini
puramente filosofico-razionali, a scapito dunque della fede: egli riteneva di aver trovato
la chiave per la verità nella dottrina neoplatonica. !
e) l’obbiettivo del neoplatonismo e la gnoseologia di Proclo: la scuola neoplatonica, nata
a partire dalle Enneadi di Plotino, come strumento di opposizione alla nuova dilagante
religiosità, SI PROPONEVA DI ASSICURARE UN RITORNO DI AUTONOMIA E
STABILITÀ SULLA BASE DI UNA SINTESI CONCORDISTICA DELLE MIGLIORI
DOTTRINE ELABORATE DALLE GRANDI CORRENTI FILOSOFICHE DEL PASSATO,
gravitante intorno al nucleo dell’insegnamento metafisico di Platone. La gnoseologia di
Proclo, neoplatonico del V secolo, sarà importante per il pensiero medievale; la sua
dottrina riprende la tripartizione propria della dottrina gnoseologica platonica in aisthesis
(il senso empirico), diànoia (la ragione dialettica, che opera le distinzioni e le mediazioni
dell'intelletto) e nous (l'intelletto, capace di cogliere la verità mediante un'intuizione
Pagina 6 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
totalizzante) e di qui sviluppa la tesi secondo cui NELLA NOSTRA MENTE SI
PRODUCONO DIVERSE RAPPRESENTAZIONI DI UNO STESSO OGGETTO, CHE
SONO VERE NELLA MISURA IN CUI SI ATTENGONO AL PROPRIO ORGANO DI
RIFERIMENTO, ma che non lo sono più quando pretendono di avere valore conoscitivo
totale. Le opinioni dei filosofi sono state in contraddizione perchè, pur essendo legate
all’incompiutezza del sapere dianoetico, hanno preteso di valere come se fossero state
portatrici di una visione perfetta della realtà. !
f) i cristiani e il neoplatonismo: facendo propria la tripartizione neoplatonica della
conoscenza, i “nuovi” filosofi cristiani propongono invece una subordinazione delle
ricerche umane alla Bibbia, forti del loro strumento in più rispetto ai neoplatonici. La
ragione dianoetica, lasciandosi guidare dalla verità rivelata, diventerà partecipe di una
manifestazione totale del vero, che le sarà facile esplicitare in forme comunicabili. !
!
3. Sacra eloquia: Parola di Dio e sapere umano
a) il principio della tradizione per constrastare gli eretici: per contrastare l'eccessiva
libertà nell'interpretazione dei testi da parte degli eretici, il magistero ecclesiastico ha
fondato il principio della tradizione, che stabilisce che vengano riconosciute attendibili
tutte le interpretazioni dei testi che non hanno elementi di discordia con i grandi autori
del passato e con le formule sancite dalle assemblee conciliari. !
b) il requisito affinchè un insegnamento sia catholicum: Nella prima metà del V secolo
tale principio del tradizionalismo è stato formalizzato in una formula da Vincenzo di
Lèrins: il requisito fondamentale che un insegnamento deve possedere per essere
catholicum, ossia universale, è di essere stato “creduto dovunque, sempre e da tutti”.!
c) “consensus unanimis patris e principio del magisterium ecclesiae”: il che vuol dire che
ogni progresso speculativo deve essere riconosciuto in quanto concorde con
l’insegnamento dei Padri (consensus unanimis Patrum) e con l'insegnamento della
tradizione ecclesiastica universale (principio del “magisterium Ecclesiae”). !
d) la sapientia dei padri: LA SAPIENTIA DEI PADRI VIENE VISTA COME UNA SORTA
DI AMPLIAMENTO DELLA RIVELAZIONE, DELLA QUALE OFFRE, CON IL
SUPPORTO DELLA RAZIONALITÀ, LA PRIMA ATTENDIBILE CHIARIFICAZIONE
ESPLICATIVA. !
e) fissazione del canone: L’autorevolezza dei Padri andava in qualche modo fissata in
un canone. Nel VI secolo he origine la serie di disposizioni della Chiesa riguardo i testi
da proibire, ad esempio il decreto “De libris recipiendis et non recipiendis”. !
f) come può l’uomo parlare di Dio? Il rapido ampliamento dei testi permessi, tuttavia,
accentuava l’urgenza da parte degli intellettuali umani di formulare un giudizio preciso
sulla capacità significativa delle parole umane, in particolar modo come l’uomo può
parlare di Dio. Emblematico come termine di riferimento è il corpus areopagiticum che
ebbe grande diffusione durante il medioevo; il trattato sui Nomi Divini, una delle opere
del corpus, pone l'accento sulla questione del linguaggio per poter distinguere, e
mostrare come complementari, la teologia affermativa (o catafatica) e la teologia
negativa (o apofatica). Quella affermativa attribuisce al divino tutti i termini che
compaiono nel testo biblico, mentre quella negativa fa riferimento al carattere di
indicibilità della divinità. L'autore arriva quindi alla teologia mistica, in cui, dopo la
reciproca confutazione di teologia affermativa e negativa, solo un abbandono mistico
alla luce accecante di Dio permette la migliore acquisizione possibile della Verità.
L’anima viene dunque innalzata verso la sublimità del vero per poi ridiscendere sul piano
dianoetico più ricca di verità, organizzandosi in forme espressive mediante le quali
Pagina 7 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
comunicare con la comunità dei credenti. Questa comunicazione teologica è il
fondamento su cui si basa la costruzione della Christianitas.!
!
4. Divina dispositio. L'ordine del creato
a) la struttura metafisica dello pseudo-Dionigi: Lo pseudo-Dionigi Aeropagita aveva
proposto una descrizione del creato come un’ordinata discesa progressiva di gradi di
esistenza dalla potenza creatrice. La conoscenza del divino viene distribuita dalle nove
schiere angeliche, divise in tre triadi, ai vescovi, anch'essi chiamati angeli, e da questi
ultimi poi promulgata, con maggiore dispersione, ai successivi gradi della scala
sacerdotale. Vi sono tre operazioni gerarchiche, che presiedono al processo di
DISTRIBUZIONE E RICONDUZIONE SACRALE DELL’ESSERE AL SUO PRINCIPIO
DIVINO: purificazione (liberazione dal contatto immondo con il molteplice), illuminazione
(azione d’induzione conoscitiva che orienta i gradi inferiori delle scale verso la bellezza)
e perfezione (l'attualizzazione di tutte le potenzialità creaturali). !
b) completamento della visione neoplatonica: Il corpus areopagiticum introduce nel
mondo cristiano la teoria neoplatonica del descensus gerarchico del molteplice dall’Uno.
Il cristianesimo aggiunge però alla concezione neoplatonica qualcosa di inconcepibile
nel mondo greco: la creazione dal nulla. Nell'ottica cristiana, l'atto liberamente creativo di
Dio, in un istante senza tempo, costituisce un completamento teoretico della derivazione
di ogni cosa dall’Uno, mentre l'escatologia cristiana dà compimento ai due momenti della
dialettica neoplatonica, la discesa (pròodos) e la conversione (epistrophé) come fasi di
un processo universale, partecipato da tutto il creato. Il rapporto tra Dio e la creazione si
risolve in una compiuta metafisica dell’ordine, che si connette direttamente con
l’immagine del Logòs introdotta dal Prologo del quarto Vangelo.!
c) il problema del male: questo schema consente anche di spiegare il male, che non è
altro che una riduzione della perfezione divina che si dissipa man mano che si scendono
i gradi della scala dell'esistente: tutto ciò che è creato da Dio ex nihilo è buono, anche se
imperfetto. !
d) il contributo di Porfirio e Calcidio: Un contributo importante alla descrizione dell’ordine
del creato viene dato da Porfirio e Calcidio. Porfirio di Tiro, diretto discepolo di Plotino,
ha schematizzato nelle Isagoge la struttura formale della discesa metafisica del reale: il
cosiddetto “albero di Porfirio”. Mentre il commento di Calcidio al Timeo ha assicurato al
mondo cristiano un’accurata visione cosmologica. I tre principi platonici (il demiurgo, gli
esemplari e le creature) sono visti come le tre persone divine: il Padre, il Figlio e lo
Spirito Santo. !
e) integrazioni: saranno poi il neoplatonismo arabo e il platonismo ebraico di Avicebron
ad arricchire questo complesso sistema di descrizioni dell’ordine cosmico.!
!
5. Christiana institutio. Le due biblioteche: litterae humanae e litterae divinae
a) Rapporto scriptura-natura. Durante il periodo medievale viene a instaurarsi il binomio
scriptura-natura. Se da un lato l'esegesi biblica non può prescindere dalla corretta
osservanza delle leggi della natura, conosciute nei secoli attraverso le regole introdotte
da una razionalità tutta umana, dall'altro lato la scienza deve necessariamente fare i
conti con la fides, regula ultima della propria veridicità. !
b) Virgilio e Cassiodoro: secondo un'immagine di Virgilio Grammatico (anonimo vissuto
tra VII e VIII secolo), i fedeli devono ordinare i propri libri (cioè la propria conoscenza) in
due differenti biblioteche, separando così le scienze dalla teologia dei christiani
Pagina 8 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
philosophi (la Bibbia e i Padri). Anche Cassiodoro, articolando le sue Institutiones in due
serie parallele di trattazioni sistematiche, separa gli ambiti in Institutiones divinarum
litterarum (la scienza della Rivelazione) e Institutiones humanarum (o saecularum)
litterarum, segue lo stesso principio. !
c) Agostino e le 7 arti liberales: è Agostino a testimoniare per primo l’avvenuto fissarsi
delle sette arti liberales, che si spostano in senso progressivo a partire dalle realtà più
visibili fino a quelle meno visibili, al vertice dei quali si colloca il definitivo possesso della
filosofia. Queste discipline ben presto si raggruppano in due parti, la prima delle quali
(trivio) è orientata alla comprensione e allo studio delle regole del linguaggio umano e
della sua capacità di esprimere il vero, mentre la seconda (quadrivio) riguarda la
descrizione rigorosamente quantitativa della struttura intima dell'esistente.!
d) Il trivio, l'insieme delle ars dicendi, si articola in:!
!
⁃ grammatica: lo studio delle norme che regolano l'uso della lingua latina e i fondamenti
del significato del linguaggio;!
⁃ logica (o dialettica): l'ars artium poiché ad essa spetta il fondamentale compito di
dettare le regole che servono a discernere il vero dal falso e che vengono utilizzate da
tutte le altre scienze;!
⁃ retorica: lo studio degli elementi formali che costituiscono il discorso atti a persuadere
l'ascoltatore o il lettore.!
!
e) Il quadrivio, invece, in quanto scienza della quantità, assume il ruolo che nell'antichità
era stato della fisica, ossia studiare l’armonia del creato. Si divide in:!
⁃ aritmetica: lo studio del numero in sé;!
⁃ geometria: lo studio del numero esteso nello spazio;!
⁃ musica: lo studio teorico delle relazioni tra suoni;!
⁃ astronomia: lo studio del numero nello spazio e nel tempo, cioè nel movimento.!
f) la tecnica della glossa: a partire dai classici di ogni disciplina (Donato e Prisciano per
la grammatica, Aristotele per la Logica, Cicerone per la retorica, Euclide per la geometria
e così via) si consolida la tecnica della glossa, ossia il commento al testo che, partendo
da una postilla a margine, può diventare esso stesso un testo. Si diffondono compendi
delle arti liberali, tra i quali quelli di Marziano Capella e di Isidoro di Siviglia. Le arti sono
infatti essenziali per comprendere il testo biblico, formato da parole, argomentazioni,
forme retoriche e costanti rimandi alla numerologia e all'ordinamento del mondo visibile. !
g) nascita della teologia: si avverte inoltre l'esigenza di sottoporre anche i testi teologici
alla stessa sistematizzazione riservata agli autori classici. La stessa dottrina dei Padri
viene antologizzata; accanto ai libri sacri troviamo una serie di commenti che formano
una lettura continua della Bibbia. Questa tendenza si sviluppa fino a quando, nel XII
secolo, si diffonde nelle scuole lo studio degli stessi autori che avevano commentato i
testi biblici: la disciplina che così viene a crearsi assume il nome di THEOLOGIA =
L’ELABORAZIONE METODOLOGICA DELLA CONOSCENZA DELLA FEDE. Il sapere
teologico svilupperà uno specifico oggetto d’indagine, nonchè un’accurata metodologia.!
h) i piani della teologia: sono diversi i piani su cui la teologia si articola: 1- il piano logico-
descrittivo, argomentativo, deduttivo e definitorio; 2- il piano della spiritualità interiore,
che coinvolge i fedeli tramite la preghiera e la liturgia in genere; 3- il piano
dell'espressione poetica, che tocca l'intimità emotiva dei fedeli; 4- il piano simbolico, in
Pagina 9 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
cui lo studio del testo è foriero di significati. Tutti questi piani non sono distinti gli uni
dagli altri, bensì coesistono e si intersecano.!
!
6. Regula sermonis e lex pulchritudinis. Dal molteplice all'unità: filosofia del
linguaggio ed estetica
!
a) Filastrio: nel Genesi troviamo il racconto della torre di Babele: in principio tutti gli
uomini comunicavano e si comprendevano reciprocamente, e solo dopo che la loro
arroganza li ebbe portati a innalzare la torre furono puniti con la moltiplicazione dei
linguaggi. Un vescovo italiano del IV secolo, Filastrio di Brescia, annovera in un
elenco di eresie coloro che interpretano quel racconto pensando che tutti gli uomini
parlassero una sola lingua. Filastrio sosteneva infatti che in origine fossimo in grado
di comprendere ogni lingua (senza con questo parlare tutti la stessa), dono divino
che ci venne poi negato dopo l'empietà babelica. Il motivo di questo allontanamento
di Filastrio nei confronti delle tesi più gettonate sarebbe da cercare nel contesto
geopolitico di un impero che si sfalda: affermare che già prima disponessimo di un
linguaggio unico porrebbe su un piano inferiore il ruolo della Chiesa nell'unificare i
popoli sotto la propria guida.!
b) La filosofia del linguaggio e l’unità linguistica: la filosofia del linguaggio più di altre
discipline si occupava, nel Medioevo, di avvicinare umano e divino, ovvero parole
umane e verità rivelata. In questo contesto, l'unità linguistica è fondamentale per la
diffusione del messaggio: da qui l'inammissibilità delle traduzioni della Bibbia in
lingue diverse dal greco e dal latino. Per quanto riguarda il greco, tradizione vuole
che settantadue traduttori abbiano lavorato in celle separate alla traduzione, per poi
constatare, al termine del lavoro, che le interpretazioni erano le medesime, opera
evidente dello Spirito Santo. Per quanto riguarda il latino, invece, ci si è basati sulla
traduzione di Girolamo. Latino e greco saranno le uniche due lingue ammesse nelle
funzioni istituzionali. !
c) le arti del trivio: le regole delle arti del trivio sono accolte non come strumentazioni
servili, bensì come riflesso della legislazione cosmica imposta dal Lògos, come
leggi eterne della natura e il compito del filosofo sarà quello di studiare il rapporto
tra res, intellectus e voces (condizionate materialmente e storicamente) per
comprendere quello tra ordo rerum, ordo idearum e ordo verborum. !
d) le parole come signa: le parole sono, per lo studioso medievale, i più efficaci signa
che conducono l’intelligenza alla comprensione delle verità immutabili. !
e) anche le immagini sono signa: ma è ogni opera della creazione divina a rimandare
al significato ultimo del Verbo: tutte le creature sono immagini di un esemplare, e tra
le creature l'uomo è la più privilegiata. Dunque dalla semantica delle parole,
l’organizzazione medievale del pensiero umano si estende spontaneamente alla
semantica delle COSE-IMMAGINI, RICONOSCIUTE TUTTE COME TRACCE
PORTANTI DI VERITÀ SUPERIORI. Mai come nella sapienza medievale la bellezza
è stata cercata e vista nel particolare, nell'oggetto, nella contemplazione del mondo
visto come ordine universale. La bellezza si nasconde dietro l’apparenza delle
superfici corporee. !
f) le leggi eterne della bellezza e il compito del filosofo: Nell’anima troviamo le eterne
leggi della bellezza di cui parla Agostino. Leggi, queste, che presiedono anche
all'armonia delle forme geometriche, dell'architettura, dei colori. IL FILOSOFO
MEDIEVALE DEVE FARSI “ARTISTA”, RICOMPORRE QUESTE LEGGI ETERNE.!
Pagina 10 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
g) Ambrogio: secondo Ambrogio la vera bellzza è essere ciò che si deve essere. Solo
in questa decenza, in questa appartenenza ordinata a un complesso, diventa
possibile ammirare “nella singolarità delle parti l’avvenenza misurata,
nell’insieme la piena convenienza della forma complessiva”. Una sola e
medesima è la legislazione primordiale che governa l’intima efficacia semantica
delle parole pensate e la godibile armonia delle forme visibili.!
!
7. Lex vitae, disciplina morum. La filosofia pratica nel Medioevo
!
a) definizione di giustizia: la giustizia, nel mondo medievale, è l'accordo del singolo con
l'ordinata armonia complessiva del cosmo. E l’ anima corrotta e deturpata dal
peccato, quando la volontà trasgredisce, torna ad apprezzare, con l'aiuto di Cristo
Redentore, il giusto ordinamento del mondo. !
b) il parallelo tra pagine e atti: la condotta morale è come un libro, di cui i singoli atti
sono le parole. Ruperto di Deutz propone proprio questo parallelo tra i giudizi morali
e le parole scritte di un testo quando afferma che “le coscienze saranno come dei
libri aperti”. E gli atti virtuosi saranno quelli che ricongiungeranno il visibile
all'invisibile, mentre quelli immorali saranno quelli che distoglieranno l'anima
dall'equilibrio delle realtà spirituali, facendola sprofondare nel turbine dei desideri
terreni. !
c) San Paolo + Agostino: Per il cristiano medievale, è il Vangelo a ricoprire il ruolo di
guida spirituale e di fonte di risposte. A tal proposito San Paolo ha scritto che Gesù
avrebbe portato al mondo una nuova “legge di ordine spirituale, portatrice di vita (lex
spiritus vitae)”, mentre Agostino ha scritto che “l'intera vita di Gesù è una disciplina
etica (disciplina morum)”. Questo non conduce ad un integralismo etico riguardo alla
vita activa, al contrario induce ad un approfondimento delle questioni etiche.!
d) influenza dell’etica degli antichi: la riflessione sulla vita pratica veniva attinta in
principio dagli autori di lingua latina, successivamente viene scoperta l’Etica
Nicomachea che viene utilizzata per affrontare con rigore i temi sollevati
dall'applicabilità dei precetti cristiani. La “vita beata” di cui parla Cicerone riguardo
all'uomo “probus”, ovvero colui che rispetta le leggi della propria comunità, in ambito
cristiano non può che coincidere con la “beatitudo”, la condizione di vita ultraterrena
eternamente felice riservata agli uomini retti. La risposta certa delle promesse della
fede coincide con l'esito finale dell'impegno morale dei filosofi. La Rivelazione se da
un lato ha esplicitato i segreti della natura, dall’altro ha fissato in comandamenti
rigorosi gli orientamenti etici della sapienza pagana. !
e) conoscenza di sè stessi: inoltre conoscere se stessi, precetto tanto importante per
la filosofia antica, nell’universo medievale acquista il significato di conoscere il
proprio posto nel creato e il fine per cui Dio ha voluto crearci. !
f) struttura ascensionale: La moralità ha una funzione ascensionale, che riflette in
ambito pratico la struttura gerarchica dell’universo medievale. L’ascesa è garantita
da una condotta morale che orienti la coscienza alla contemplazione del Bene:
questa condotta è costituita a partire dal rispetto delle leggi naturali fino al rispetto
delle volontà divine presenti nella Rivelazione, entrambi dettati da un desiderio
insopprimibile di santità. !
g) le virtù: all’interno di questo sistema ascensionale, è decisivo il ruolo delle virtù,
disposte in una completa scala armonica necessaria all'uomo per la realizzazione
della propria natura (quid est) e quindi del compito per cui è stato creato (ad quid
factus est). Nel Medioevo sono comparsi numerosi scritti in cui si propone un elenco
Pagina 11 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
delle virtù a stampo porfiriano, cioè ad albero, disposte in una scala di valori.
Questo lavoro conduce i pensatori a raggruppare le virtù nello schema platonico, già
noto ai Padri, delle quattro virtù a cui tutte le altre si rifanno: prudenza, temperanza,
giustizia, fortezza. !
h) l’ambito politico: ma il perseguire l’unità e il Bene non è soltanto prerogativa del
singolo individuo. Infatti questa ricomposizione all’unitarietà del Bene ha orientato
anche gli ideali politici del mondo medievale. Vi è una costante aspirazione ad
attuare sulla terra, mediante la realizzazione di unanimitas dei fini, la pace ideale
che regna nei cieli, così che la societas medievale è globalmente avviata al
superamento del modello dualistico di una città dell’uomo contrapposta per interessi
e finalità all’inalterabile perfezione della città di Dio. Si può concludere affermando
che l’amare in Dio gli altri esseri umani e negli altri esseri umani Dio è la regula
aurea della sapienza pratica medievale. !
!
Boezio e la sapientia!
!
a) obbiettivo: Il programma filosofico di Severino Boezio (giustiziato da Teodorico nel
524/525 d. C. ca.) consisteva nel tracciare un percorso completo della filosofia a lui
precedente, in ogni sua articolazione, dalla logica alla metafisica. L'obbiettivo che si
era infatti prefissato (come leggiamo nel secondo commento al De interpretatione di
Aristotele) era di tradurre tutte le opere platoniche e aristoteliche e mostrare in
maniera inequivocabile che le loro teorie, contrariamente a quanto sostenuto dai
più, mostrassero una sostanziale concordia di fondo. Progetto, questo, non inedito:
già i neoplatonici e i cristiani influenzati dal neoplatonismo (fino ad Agostino)
avevano tentato di mostrare l'inconsistenza di un contrasto tra i due filosofi. Per
Boezio, invece, il progetto ha una portata decisamente più ampia, in quanto si
inserisce nel recupero dell'intero patrimonio filosofico: ricostruire il possesso di una
sapientia non frammentaria e certa, significa contrastare la perdita di certezze che il
contesto storico causava. !
b) Consolatio philosophiae: Nella Consolatio Philosophiae Boezio racconta di aver
ricevuto in visita la stessa Filosofia personificata: una donna con un vestito
meraviglioso, ornato con una scala (che fa riferimento alla gerarchia delle scienze)
ma con alcuni lembi strappati da coloro che, tentando di trascinarla con sé,
pensavano di entrare così in possesso di tutta la Verità. Dopo aver cacciato le
Muse, false consolatrici, poiché l'arte non può fornire un vero conforto, la Filosofia si
siede accanto al suo discepolo. ELLA NON È UNA FILOSOFIA, MA È LA VERA
FILOSOFIA, una sapienza unitaria ed indistruttibile, come la veste (ossia la Verità)
di cui si ammanta la Filosofia.!
c) differenziazione delle discipline: le opere giovanili di Boezio, pur essendo
scarsamente originali, lasciano intravedere quello che sarà il contenuto delle opere
della maturità: il comune esito delle ricerche filosofico-scientifiche è sì il
raggiungimento della Verità, ma comunque seguendo sempre i percorsi propri di
ogni disciplina. Le singole scientiae descrivono i diversi percorsi che conducono la
mente ad accostarsi alla Verità.!
d) la logica: ma di incalcolabile valore sono gli scritti sulla logica. Partendo dalla
traduzione dell'Organon e arrivando a testi propri sul sillogismo, la logica boeziana
ha avuto un'influenza immensa nella storia del pensiero medievale, oltre ad essere
stata l'unico ambito in cui il progetto di riconciliazione filosofica tra Platone e
Pagina 12 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
Aristotele abbia avuto compimento. Essa propone una sintesi di logica aristotelica,
logica stoica e logica neoplatonica. !
e) gli universali: La concezione della conoscenza vera come ascesa dalle apparenze
sensibili all’immutabilità dei principi eterni guida Boezio nell’affrontare la domanda
sulla natura di queste essenze primordiali. Egli introduce così le nozioni filosofiche
fondamentali che poi saranno chiamate nel XII secolo universali. Secondo Boezio,
LA VERA COMPRENSIONE DELLA REALTÀ IN SÈ È SEMPRE UN SAPERE DI
ORDINE TEOLOGICO: infatti eterna e immutabile è la natura delle cose, perseguita
da ogni ricerca umana nei diversi ambiti della loro manifestazione alla mente creata.!
f) gli opuscola sacra, il 3 (la bontà delle creature) e l’1 (metodo teologico): i dubbi
sull’adesione di Boezio al cristianesimo scaturiscono soprattutto dall’assenza nella
Consolatio e nelle opere logico-scientifiche di riferimenti espliciti alla Bibbia. Ma
Boezio è autore anche di cinque opuscola sacra, brevi trattati teologici. Il terzo degli
Opuscola, il De Hebdomadibus, è una trattazione puramente razionale, senza alcun
riferimento alla fede, di un problema di ordine teologico: com'è possibile, si
domanda Boezio, che le creature siano buone, senza per questo essere buone in
sé, dato che, se lo fossero, sarebbero Dio? Seguendo un metodo assiomatico,
l'autore parte da alcuni princìpi di per sé noti, come la distinzione tra esse, il vero
essere, e id quod est, cioè i singoli enti, e, procedendo mediante deduzione, arriva a
trarre la seguente conclusione: le creature non sono buone intrinsecamente o in
quanto partecipi della sostanza divina, ma devono la loro bontà all'atto determinante
e necessitante della volontà di Dio. Nel primo degli Opuscola, invece, per indicare la
natura del metodo specifico del sapere teologico naturale riprende la dottrina
neoplatonica della tripartizione gerarchica delle facoltà conoscitive: sensibilità
(sensus), ragione discorsiva (ratio) e intelletto noetico (intellectus), e assegna
quest'ultimo alla teologia come metodo più adeguato, il più elevato. Per provare a
cogliere l'oggetto divino, per lui incommensurabile, l'uomo deve far ricorso alle sue
più elevate capacità, ovvero deve far ricorso all'intelletto noetico. !
g) Il compito della filosofia: Questo è dunque IL FINE PIÙ ALTO DELLA FILOSOFIA:
AVVICINARSI ALLA VERITÀ MEDIANTE L'INTELLETTO, PER POI RITORNARE
ALLA RAZIONALITÀ E ARTICOLARE CIÒ CHE SI SCOPRE IN DISCORSI.!
h) antinomie: nella Consolatio, il filosofo esprime una serie di antinomie filosofiche.
Questi contrasti non sono altro che il risultato dell'originario conflitto tra conoscenza
mediata e discorsiva (ratio) e conoscenza immediata ed intuitiva (intellectus), e,
dato che il vero è uno e medesimo nonostante le diverse prospettive, la Filosofia
invita il seguace a compiere lo sforzo di elevarsi alla sommità dell'intelligenza divina,
il cui risultato non può che essere la vera felicità della vita eterna. !
i) accogliere la Rivelazione: L’ultima fase del processo di perfezionamento della
sapientia consiste nell'accogliere la Rivelazione cristiana, scritta secondo le regole
discorsive della ratio e rivelatrice di una verità piena. La Scrittura dunque porta
l'uomo oltre ciò che sarebbe capace di fare con le sole proprie forze: la scientia fidei
consiste nel liberare la ragione dalle rappresentazioni mentali condizionate dalla
sensibilità e nel far accogliere dalla ragione stessa i misteri della fede di per sé
incomprensibili. !
j) parlare di Dio: Nel De Trinitate, Boezio, per mettere al riparo i fedeli dalle influenze
degli eretici, inserisce i caratteri della Trinità nelle categorie aristoteliche: per quanto
riguarda Dio, che non è una sostanza come le altre, bensì una sovra-sostanzialità, i
nomi teologici attribuitigli (come “grande” o “buono”) sono significativi della sua
Pagina 13 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
soprannaturalità, ovvero Dio è considerato buono in maniera superiore, grande in
maniera superiore e così via.!
k) il quinto opuscolo: infine nel quinto opuscolo, la congiunzione di umano e divino in
un unico soggetto, impossibile per la logica razionale, viene illuminata da una
definizione rigorosa dei termini implicati nella sua formulazione, natura e persona. Vi
saranno in Cristo due naturae, contro il monofisismo di Eutiche, e una sola persona,
contro Nestorio.!
!
Il sesto secolo e Giovanni Filopono!
!
Nel VI secolo, se nel mondo latino i pensatori erano impegnati a difendere le radici
classiche e l'avvento del cristianesimo a fronte di un tramonto spirituale dovuto alla
situazione politica, nell’area greca del Mediterraneo le istituzioni imperiali governavano
con relativa stabilità. La vita culturale si caratterizzava come una continuazione delle
radici greco-romane, con la coesistenza di diritto romano, teologia cristiana e filosofia
greca classica. Queste tendenze tendono a fondersi, ma l'equilibrio tra le varie posizioni
non può che essere minacciato da polemiche interne. Nel 529 Giustiniano emana infatti
gli editti di restrizione che portano alla chiusura della scuola neo-platonica. !
a) Alessandria: mentre ad Alessandria, dopo l’assassinio di Ipazia da parte di fanatici
sostenitori del patriarca Cirillo, si stabilisce un clima di tolleranza e di coesistenza
tra le scuole di pensiero. !
b) Giovanni Filopono: Ad Alessandria tra i tanti studiosi vi sono anche Enea e Giovanni
Filopono. Il primo è autore di un trattato sull’immortalità dell’anima dove difende
alcune fondamentali tesi cristiane sulla base di un sincretismo di filosofie elleniche;
Giovanni il Grammatico, detto Filopono (amante della fatica) ha invece scritto
numerosi commenti alle opere fisiche e logiche di Aristotele, oltre ad aver composto
scritti matematici, trattati teologici, due trattati filosofici De aeternitate mundi e un De
opificio mundi, esegesi scientifico-razionale del racconto della creazione. Sua
grande ambizione è RIVEDERE IN CHIAVE CRISTIANA I GRANDI PENSATORI
DEL PASSATO, in particolare Aristotele. Ad esempio, l'idea di creazione ex nihilo,
che non era pensabile per i Greci in quanto non deducibile dall'esperienza, ma
rivelata dalla Scrittura, è inseribile nella fisica aristotelica ed è fondamentale per
risolvere alcune aporie lasciate insolute dai pensatori greci. L'eternità del mondo è
confutata su base aristotelica, perché se il mondo è finito nello spazio allora è finito
anche nel tempo, dato che la temporalità è la sua vita stessa; Dio poi non è da
considerare motore immobile ma provvidente energia motoria che presiede a tutta
la vita del creato. !
c) l’eresia di Filopono: i limiti oltre cui non è lecito spingersi nell'ermeneutica dei dogmi
cristiani non erano ancora ben definiti: Giovanni, identificando l'ousìa con la physis,
arriva a pensare la natura come genere universale, e dunque, poiché ogni individuo
non può che partecipare di una natura soltanto, si avvicina al monofisismo. Questa
è l'accusa rivoltagli da Leonzio di Bisanzio, teologo neoplatonico, che critica la
tendenza eretica di Filopono. !
!
Riforma istituzionale e rinascita culturale e religiosa!
a) il consiglio di Alcuino: Un episodio ben illustra il ruolo degli intellettuali al seguito di
Carlo Magno: dopo aver conquistato la Sassonia, Carlo impone il battesimo ai pagani,
minacciando con la pena di morte gli oppositori. Allora Alcuino scrive una lettera al re
suggerendogli non di imporre con la spada, ma di educare al cristianesimo i popoli
Pagina 14 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
sottomessi: “l'uomo può essere costretto al battesimo, ma non alla fede”. Secondo
Alcuino, Carlo dovrà costruire scuole nei paesi germanici e inviare sapienti che vi
insegnino le arti e la filosofia così da illustrare loro le parole della Scrittura. Solo
educando l’uomo alla verità del Vangelo sarà possibile dare vita a un regno terreno
veramente cristiano. !
b) Admonitio generalis: Carlo attua una riforma dell'Impero mediante una serie di editti
(capitularia), tra cui ricordiamo l'Admonitio Generalis, cercando di promuovere e
regolamentare gli istituti scolastici e favorire l’educazione dei monaci ed ecclesiastici. !
c) riscoperta della cultura classica: La restaurazione dell’impero è strettamente legata al
realizzarsi di una rinascita della cultura e della religione, inizialmente fiorita sul recupero
della cultura classica. Il rifiorire della cultura non è dovuto ad un'improvvisa riscoperta
del suo valore, ma è il risultato dell'intensificazione del processo di recupero del passato.
Vengono infatti riprese le opere dei più importanti filosofi pagani: l'Aristotele del De
interpretatione e delle Categorie, Porfirio e Proclo, Donato e Prisciano per la
grammatica, oltre i grandi classici della retorica e della letteratura latina. Tali letture sono
finalizzate alla conoscenza e alla comprensione della Bibbia. Aumenta vertiginosamente
il numero di scritti sacri e profani presenti nelle biblioteche di abbazie e monasteri, e
Carlo apre una schola palatina presso la sua corte itinerante. I monotoni manuali tardo-
antichi vengono rielaborati in rapide successioni di domande e risposte, mentre la forma
del dialogo è quella prediletta per comporre i nuovi compendi di sapienza liberale.!
d) l’unificazione: Gli uomini di lettere che passano alla corte di Carlo Magno si sono
formati nelle più regioni remote d’Europa. Dunque il mondo colto carolingio scaturisce
dalla confluenza di molteplici tradizioni. Tuttavia bisogna poi raggruppare queste diverse
tradizioni in un nuovo sistema: necessarie saranno l’unificazione linguistica, con la
correzione e la diffusione del latino ecclesiastico; l’unitarietà grafica, con l’introduzione
della minuscola carolina; la divulgazione di un comune testo della Bibbia; e una forzata
diffusione della regula di Benedetto in tutte le comunità monastiche. !
e) il compito dell’imperatore: compito dell’imperatore è quello di formare una comunità di
credenti nella quale si avveri la coincidenza del regnum con l’ecclesia, ossia
dell’organismo politico romano-carolingio con il corpo mistico della tradizione apostolica.!
!
Giovanni Scoto Eriugena!
!
a) la conoscenza delle fonti antiche: L’Eriugena traduce gli scritti dello pseudo-Dionigi
e altre importanti opere patristiche greche: possedeva infatti una buona padronanza
del greco antico, cosa che rende già di per sé il suo pensiero originale rispetto ai
suoi contemporanei. Oltre alla cultura greca, Giovanni aveva un'ottima conoscenza
dei Padri latini, come Agostino, Ambrogio, Girolamo, Gregorio Magno, Ilario di
Poitiers, e inoltre non mancavano alla sua preparazione opere come il Timeo e i
classici di Cicerone, Virgilio e Plinio. !
b) Il Periphyseon: nella sua opera maggiore, il Periphyseon (un lungo e articolato
dialogo tra un Nutritor e un Alumnus), Giovanni Scoto intende esplicitare ogni
manifestazione della verità che l'intelligenza creata incontra nello studio delle realtà
visibili e di quelle invisibili. Ogni verità raggiungibile dall'uomo non è altro che una
manifestazione del divino, di per sé inconoscibile e impenetrabile, che si esplicita in
infinite rivelazioni (teophaniae), la più compiuta delle quali è certamente la
Rivelazione che Dio ha fatto della propria verità nella Sacra Scrittura. !
c) opera filosofica e teologica: Il sistema elaborato da Scoto Eriugena dunque non può
che essere teologico e filosofico ad un tempo, sostenuto dalle informazioni del testo
Pagina 15 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
sacro, necessarie nel viaggio verso la verità, al termine del quale non vi sarà più un
mero credere, bensì un pieno intelligere. !
!
!⁃!La natura e le sue divisioni!
!
a) il concetto di natura: Fin dall'inizio del Periphyseon, l'autore sostiene che una sola
parola identifichi tutte le cose che sono e tutte le cose che non sono, ossia la totalità
di ciò che è pensabile: natura. La natura è un genere. In quanto genere, secondo i
precetti aristotelici, non può essere definito, perché non può essere collocato in un
sovrainsieme maggiore. Dunque il genere dovrà essere diviso in più specie
(formae), e poiché è un compito assai arduo per l'uomo individuare rigorose
distinzioni all’interno di un concetto che deve includere tutto ciò che è vero, bisogna
ricorrere al contributo informativo proveniente dalla Rivelazione cristiana. !
b) il contributo della Sacra Scrittura: In essa infatti si trova il concetto di creazione, che
sancisce una differenza logica e reale tra gli oggetti considerati. Vi sono, dunque,
quattro naturae:!
!
!1.!La natura che non è creata e crea, Dio, causa incausata;!
!2.!La natura che è creata e crea, le idee eterne, gli esemplari, i modelli a cui si
rifanno gli esseri molteplici;!
!3.!La natura che è creata e non crea, le creature, causate e non cause;!
!4.!La natura che non è creata e non crea.!
!
La quarta natura, logicamente necessitata dalla quadripartizione, è di più difficile
comprensione, poiché dovrebbe essere qualcosa di estraneo al tempo creato, il punto di
arrivo della storia, quando Dio sarà soltanto Dio. !
c) tripartizione delle facoltà conoscitive: in riferimento, seppur non esplicito, alla
tripartizione platonica delle facoltà conoscitive dell'uomo, Scoto Eriugena sostiene che vi
siano tre diverse forme di conoscenza, mediante il quale il soggetto coglie, con diversi
gradi di verità, un medesimo oggetto. La prima è soggettiva, dunque non
sufficientemente rigorosa, mentre la seconda è regolare e simmetrica in quanto fondata
sulle norme della logica, e la terza è di ordine sovralogico, una sorta di “contemplazione
intelligibile della totalità”. Proprio questa terza forma, l'intelletto superiore, è riuscita a
cogliere all'inizio dell'indagine speculativa il concetto di natura. Sarà poi la dianoia a
dover esplicare logicamente i contenuti e le conseguenze delle quattro divisioni. !
!
!⁃!Conoscibilità e predicabilità di Dio!
!
a) Che cos’è Dio? Dio, la prima natura, è eterno ed immutabile, in quanto principio non
derivato da altro, dunque in lui non vi è nulla di accidentale. Non si può però
neanche predicarne una sostanzialità, poiché l'uomo, parlando di sostanza, non può
parlare di qualcosa che non sia sottoposto all'influenza degli accidenti. Dunque non
si può parlare di Dio, né come simile né come dissimile: è qui evidente il richiamo
alla teologia negativa dello pseudo-Dionigi. !
b) la teologia superlativa: TUTTAVIA LA RIVELAZIONE HA PARLATO AGLI UOMINI DI
DIO NEL LORO LINGUAGGIO, come lo stesso pseudo-Dionigi insegna. E' quindi
opportuna una teologia affermativa, sulla base della Scrittura, vista però sempre in
chiave metaforica. Si giunge così ad una sintesi delle due posizioni, che potremmo
chiamare teologia superlativa, che si realizza predicando di Dio i nomi che ne
Pagina 16 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
esprimono le perfezioni correggendoli con l’aggiunta di prefissi come plusquam o
super: Dio, dunque, è super-buono, è più che buono, ecc. !
c) Inserire Dio nelle 10 categorie: Sulla scia di Agostino e Boezio, egli prova ad inserire
Dio nelle dieci categorie aristoteliche, senza riuscirvi: questo significa che, in ultima
analisi, non vi è un significato qualitativo (non è veramente buono), quantitativo (non
è veramente grande), di azione (non ama veramente) o di relazione (non è
veramente Padre). La perfetta sapienza dunque non è altro che una non-
conoscenza, una divina ignoranza. !
d) Forme a priori del soggetto: D’altra parte è evidente, secondo l’Eriugena, come non
sia possibile alla nostra intelligenza fare a meno della predicazione categoriale se
vuole veramente, anche nel discorso teologico, esprimere e comprendere qualcosa.
L’Eriugena nota difatti che non c’è nulla cui l’intelligenza umana possa accostarsi
adeguatamente senza collocarlo entro coordinate spazio-temporali: come dice la
Scrittura Dio è “semper et ubique”. Tuttavia tale situazione può essere estesa anche
alle altre categorie, che sono tutte forme a priori di organizzazione della capacità
conoscitiva del soggetto. In linea con la gnoseologia neoplatonica, i termini che
predicano qualcosa di Dio sono necessari non perché richiesti dalla natura di Dio
ma perché necessari per il soggetto, che altrimenti non avrebbe modo di conoscere.
Pertanto, Dio è sì buono e grande ma non in sé, bensì per noi che lo conosciamo. !
!
!⁃!Conoscibilità delle creature: la triade sostanziale!
!
a) la conoscibilità delle cose: Nessuna res è conoscibile in sé, nella sua profonda
substantia, ma solo conoscibile a partire necessariamente dalle categorie che il
soggetto instaura per conoscerla: la verità sostanziale delle cose sussiste soltanto
nella mente eterna di Dio.!
b) la seconda natura: la seconda specie di natura, quella che è creata e crea, è sia
Dio, in quanto pensiero divino creatore, sia creatura, in quanto le idee sono l'essere
vero e immutabile che presiede a ogni manifestazione. Eriugena considera le idee
come qualcosa in più che semplici modelli: per il filosofo irlandese sono esse stesse
creatrici e produttrici di realtà, “coeterne” al Verbo. !
c) la triadicità nelle creature: Per comprendere il rapporto tra Dio, cause mediatrici
della creazione e creature, Eriugena recupera Massimo il Confessore, secondo cui
in ogni res creata vi è una triade di componenti metafisiche, universale vestigio della
manifestazione trinitaria del divino: una sostanza (ousìa), una potenza (dynamis) e
un atto (energeia). All'uomo queste componenti appaiono come distinte e
differenziate, per cui ogni sostanza sembra passare da una infinita serie di
incompiute potenze a una infinita serie di attuazioni soltanto parziali. !
d) l’uomo: La terza specie di natura, dunque, quella che è creata e non crea, si
manifesta in maniera frantumata, e persino quando l'uomo cerca di conoscere se
stesso non ottiene nient'altro che qualche frammento della propria ousìa. Nella
mente di Dio, invece, tutte le res sono nozioni perfette ed eterne, in un'entelécheia,
un'attualità perfetta, un'armonia di atto e potenza. La terza natura è puro fenomeno.
Tuttavia anche ciò che è puramente fenomeno è una teophania, una manifestazione
di Dio, e ogni fenomeno è ingannevole solo in quanto il soggetto lo considera come
il manifestarsi di qualcosa di singolo, di separato da Dio e di autosussistente come
singola res.!
!
!⁃!Creazione e processio: l'Esamerone eriugeniano!
Pagina 17 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
!
La storia dell'opera divina si articola in discesa (processio) da Dio alle creature e ritorno
(reditus) dalle creature alla causa originaria. I sei giorni della creazione sono raccontati
da Eriugena in un Esamerone affrontato con una prospettiva scientifica, fisiologica e
astronomica. Dal momento che la Scrittura è foriera di infiniti significati, egli accoglie
interpretazioni diverse ma per questo motivo tutte veridiche, da Basilio ad Agostino, per
poi arrivare alla propria.!
!
!1.!Il primo giorno, la creazione della luce, consiste nella discesa dalle cause agli
effetti;!
!2.!Il secondo giorno, la collocazione del firmamento tra le acque superiori e
quelle inferiori descrive l'apparizione dei quattro elementi, dello spazio e del
tempo che divide creature spirituali e creature corporee;!
!3.!Il terzo giorno, l'emergere della terra arida allude alla composizione delle
forme con la materia;!
!4.!Il quarto giorno, la creazione dei pianeti è utilizzata da Eriugena per proporre
il proprio sistema astronomico che prevedeva la rotazione dei pianeti intorno al
Sole mentre questo gira intorno alla Terra;!
!5.!Il quinto giorno, la moltiplicazione delle specie corporee racconta l'apparire
dell'accidentalità;!
!
a) l’antropologia eriugeniana: Nell’esegesi del sesto giorno, Eriugena presenta la propria
antropologia. Essa è dominata dalla concezione dell'uomo come creatura centrale nel
cosmo, il fine dell'opera divina, verso il quale tutta la realtà creata tende. La conoscenza
dell'uomo è la più completa e complessa di tutte le creature: in questo senso l'uomo è
immagine di Dio, poiché la sua intelligenza è fondata sull'archetipo del Verbo. Mentre
però in Dio le creature sono colte nella perfezione ideale della loro entelecheia, la
conoscenza umana è solo un’immagine potenziale di quella divina.!
!
- il peccato originale e l’interruzione del processo creativo!
!
a) la libertà umana: l’uomo era stato posto al centro della creazione per presiedere al
proprio processo di risalita a Dio: il suo compito era di risalire a Dio dal mondo per
raggiungere in Lui la perfetta conoscenza del mondo. Ma il compimento di tale
percorso era possibile soltanto come esito di una autonoma scelta della volontà
creaturale. Il peccato originale, però, interrompe questo processo e fa sì che l'uomo,
e con lui tutto il creato, devi dal proprio percorso e dalla realizzazione della
similitudo Dei.!
b) Adamo ed Eva: Nell’esamerone dell’Eriugena Adamo è il simbolo dell'intellectus,
inviato da Dio a contemplare la verità del creato dietro la promessa di poter gustare
i frutti dell'albero della Vita, che è il Verbo stesso. Ma Eva, la conoscenza inferiore,
si lascia travolgere dalle apparenze fantastiche della sensualità, il cui simbolo è il
serpente, che la invita a cogliere il frutto della Scienza del bene e del male: IL
FRUTTO RAPPRESENTA LA CONFUSIONE CONOSCITIVA ORIGINARIA CHE È
ALL’ORIGINE DELL’IMPERFETTA SCIENTIA NATURALE DEGLI UOMINI ed Eva,
trascinando con sé Adamo, l'intelletto, fa precipitare l'anima umana nella falsa
fenomenologia dell'accidentalità. Eva dovrà partorire con fatica e dolore i conceptus,
figli dell'attività dell'anima, mentre Adamo dovrà lavorare la terra, l'ousìa, la vera
sostanza delle cose, coperta dalle spine dell’apparenza, che non consentono più
Pagina 18 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
all’intelletto di accostarsi alla verità delle essenze primordiali. Essendo però lo
stesso Adamo l’uomo universale, la punizione cela ma non preclude affatto la
promessa della redenzione e del reditus dell'uomo all'immutabile verità divina.!
!
!⁃!La redenzione del peccato e il reditus!
!
a) l’incarnazione di Cristo: la via per il riavvicinamento dell'uomo a Dio è l'incarnazione
di Cristo, il Verbo, attraverso un atto d'amore totalmente gratuito. Si rende così
possibile l'inversione del processo di discesa da Dio, cosicchè l’umanità diventa in
grado di ripercorrere in senso inverso i gradi di questa discesa. !
b) la quarta natura: riferendosi alla quarta natura l’Eriugena non poteva che usare una
formula negativa, in quanto ristabilimento dell'autentico ordine della conoscenza.
Essa si realizzerà alla fine dei tempi: non sarà creata perché sarà il ritorno del
creato a Dio, e non sarà creante perché Dio sarà “tutto in tutte le cose”. !
c) La resurrezione del corpo di Cristo ha anticipato la condizione di ogni corpo al
momento extrastorico del Giudizio Universale, ovvero la condizione di un corpus
spirituale, in cui la corporeità non si annulla ma torna alla propria originaria
perfezione di autentica sostanzialità. Libera dalle scorie della molteplicità, l'anima
dell’uomo si unirà al proprio corpo. L’uomo si unirà dunque al Verbo nel compimento
di tutte le potenzialità creaturali, nell'entelécheia che lo stesso Paolo riservava ai
risorti. !
d) diversi cammini terreni: La redenzione avverrà in diversi gradi, a seconda dei
cammini terreni: la beatitudini saranno piene ma comunque diverse, in base al
merito. Tutti saranno avvolti dal trionfo della luce divina nel sabato eterno che
concluderà la storia della creazione, anche se per i dannati trovarsi in tale
condizione sarà ragione di tormento. !
!
!⁃!Oltre la teologia!
!
a) l’incomprensibilità della conclusione della storia: la conclusione della storia
universale viene vista da Eriugena e da tutta la tradizione teologica come
necessaria ma incomprensibile: solo il deificato può comprendere la deificazione.
Ma nello svolgersi della storia creaturale, IL CONCORSO DELLA RIVELAZIONE E
DELLA CRITICA FILOSOFICA CONSENTE AI RICERCATORI DEL VERO DI
AVVIARSI VERSO LA COMPRENSIONE DEL MISTERO. !
b) gli scritti della maturità: In tre suoi scritti della maturità Giovanni Scoto ha offerto
elementi utili per chiarire il ruolo del sapere con cui l’uomo si sforza di anticipare con
la comprensione teologica i contenuti della visione beatifica comune. In una di
queste opere, ossia nel commento al primo trattato dello pseudo-Dionigi, le
Expositiones in Hierarchiam coelestem, Giovanni Scoto illustra le divere possibili
gradazioni della conoscenza creaturale del divino, che è necessariamente
imperfetta. A) A un primo livello la parola divina si esprime affidandosi ai significati
naturali del linguaggio. B) Tuttavia, la Scrittura si esprime anche in modo alogico,
capace di sollevare le menti al di sopra dell’immediatezza del significato letterale:
espressioni simboliche, parabole, allusioni anagogiche elevano l’intelligenza del
creato verso altezze spirituali mistiche. C) Al di sopra della stessa fruizione del testo
rivelato, si colloca la comprensione del divino riservata alle intelligenze angeliche,
che colgono intuitivamente la verità. D) Per una suprema concessione divina, però,
per un uomo mortale è stato possibile elevarsi fino alla visione con cui Dio
Pagina 19 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
contempla se stesso e in se stesso tutte le cose: questo privilegio è stato concesso
a Giovanni l'evangelista, che, trascendendo ogni condizione creaturale, ha potuto
cogliere non solo la visione beatifica comune (propria dei beati nel reditus generalis
e delle visioni estatiche dei santi), ma è stato perfino elevato alla visione di Dio in
Dio, comprendendo così completamente la divinità del Verbo. Il volo ultraceleste di
Giovanni, aquila spirituale, lo ha portato a fissare i propri occhi nel sole della
divinità, per poi tornare sulla terra ad annunciare che “il Verbo si è fatto carne”.!
!
Il confine tra arti liberali e teologia! ! !
!
INTRO: A cavallo tra il X e l’XI secolo nell’Italia settentrionale si sviluppa una tendenziale
rivendicazione da parte dei maestri delle arti liberali a svincolare la pratica delle arti
liberali dalla esclusiva funzione propedeutica al perfezionamento della conoscenza
teologica. !
a) Anselmo di Besate: tra i fautori di questa rivendicazione troviamo Anselmo di
Besate, detto il Peripatetico. 1- In un'opera intitolata Rhetorimachia, l'autore
sosteneva di essere esentato, grazie al proprio sapere, dal difendere la verità, per
dimostrare che il cugino calunniatore esercitava la magia nera. Dietro l'ironia si cela
una forte consapevolezza della separazione degli ambiti: l'arte della retorica infatti
non consiste nel difendere il vero, compito della dialettica. 2- Anselmo sembra voler
stilare un manifesto dell'autonomia delle arti nel racconto di un sogno: portato in
paradiso, le sue spoglie sono oggetto di una contesa tra le anime di suoi parenti
beati, che volevano trattenerlo con loro nella felicità eterna, e le arti del trivio, che
reclamavano il suo ritorno tra i viventi temendo di perdere il loro miglior discepolo.
Proprio quando le tre fanciulle erano sul punto di avere la meglio sui sancti Anselmo
si sveglia, contento di non aver dovuto compiere tale scelta. !
b) Adalberone: negli stessi anni, Adalberone, vescovo di Laon, ha come
preoccupazione non tanto la rivendicazione dell'autonomia delle arti liberali, bensì il
FISSARE I LIMITI SPECULATIVI DI CIASCUNA DISCIPLINA, senza sconfinare nei
misteri della fede. Ad esempio Adalberone nel Carmen ad Rotbertum regem fa
sfoggio di una grande padronanza degli strumenti della retorica tanto da mostrare
quanto si possa attraverso questi fornire descrizioni surreali della realtà, in quanto
compito della retorica non è certamente il conseguimento della verità. Ricondotte
entro i propri limiti, le arti liberali devono mettersi al servizio della conoscenza
teologica, sempre però nel rispetto della verità dei dogmi, cosa che Adalberone, nel
Summa fidei, mette in evidenza mostrando che L’ESPOSIZIONE DEI CONTENUTI
DELLA RELIGIONE CRISTIANA È SOSTENUTA ANCHE MEDIANTE IL RICORSO
AD ARGOMENTAZIONI LOGICHE, ma soltanto in misura parziale. Nell'ottica
ottimistica del platonismo carolingio cresce una critica nei confronti della pretesa
dell'intelligenza umana di poter ricostruire e padroneggiare l'opera divina. !
c) la tripartizione delle scienze: era convinzione comune, ai tempi, che le scienze
utilizzassero strumenti diversi: dividendosi, secondo Notkero Labeone, detto il
Tedesco, in fisica, etica e teologia; le prime due utilizzano gli strumenti della ragione
naturale e del linguaggio umano, mentre la terza, approcciandosi ai misteri della
fede, non necessita del supporto della ratio discorsiva, bensì si fonda, per
contemplare e rappresentare i propri oggetti, sull'intuizione superiore e sovra-
razionale dell'animo umano. !
!
La disputa sull’eucaristia: Berengario di Tours e Lanfranco di Pavia!
Pagina 20 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
!
a) interpretazione spiritualistica del mistero: Berengario di Tours è stato oggetto di
critiche riguardo alla disputa sul mistero eucaristico, in quanto sostiene
un'interpretazione spiritualistica del mistero. Ovvero poichè nel mondo della
corporeità nessuna trasformazione è possibile senza senza un divenire della
sostanza di ciò che muta, non essendoci nell’eucaristia alcuna trasformazione
sostanziale, ci si deve assestare su un radicale spiritualismo eucaristico. Il pane e il
vino presenti sull’altare sono, secondo Berengario, esenti da qualsiasi mutevolezza. !
b) il realismo eucratistico: Il realismo eucaristico, opposto all’interpretazione di
Berengario, era invece efficace sia per l’impatto devozionale che produceva nelle
menti dei fedeli, sia come arma contro l’immoralità dei sacerdoti indegni e quindi
non era tollerabile che venisse attaccato. Berengario venne dunque a più riprese
condannato in una serie di concili tra il 1049 e il 1079 e fu costretto a rinnegare la
propria dottrina. !
c) Lanfranco di Pavia, coinvolto nella polemica, sosteneva che la verità riguardo
all'eucaristia fosse reperibile nel Vangelo, senza ulteriori interpretazioni. Tuttavia,
anch'egli decise di porsi sul piano del suo avversario Berengario, ossia su quello
della disputa dialettica su base logico-scientifica. Lanfranco articola il suo intervento
su due piani:!
!
1 sostenendo che anche i Padri conoscessero la logica, egli rimprovera a
Berengario di averla anteposta alla fede – il mistero è tale perché non è
conciliabile con i preconcetti logico-filosofici dell'uomo;!
2!non bisogna indagare il come del dogma, affidato all'onnipotenza divina, ma
cosa esso enunci – Berengario ha ragione a sostenere che un avvenimento del
genere non può avvenire in natura, ma questo non vuol dire che Dio non possa
farlo.!
!
d) transustanziazione: Lanfranco sostiene che il miracolo consiste in un'alterazione della
realtà naturale. In natura, la sostanza, in sé non percepibile dai sensi che possono
percepire solo gli accidenti, non muta. Nell'eucaristia, invece, si trasformano le sostanze
del pane e del vino mentre i loro accidenti rimangono immutati. Questa posizione di
Lanfranco verrà ripresa da Tommaso d'Aquino con la precisazione del concetto di
“transustanziazione”, e verrà considerata ufficialmente accettata. !
!
Pier Damiani!
!
a) il rapporto con le arti liberali: Pier Damiani rientra nel novero di filosofi che
contrastarono la pretesa delle arti liberali di determinare la presenza del divino
nell’ordine del creato. Le arti liberali servono per leggere correttamente la Scrittura
come lo sono per orientare l’umanità nella natura, ma devono poi tacere dinanzi al
disvelarsi del vero divino.!
b) riforma della Chiesa: Dedicò tutta la sua vita alla riforma della Chiesa, in virtù di
quella santità la cui ricerca era da lui indicata come dovere di ogni monaco. !
c) sancta simplicitas: Egli sosteneva che ci si poteva salvare soltanto rivestendosi
della pura stoltezza del credere, la sancta simplicitas: soltanto rifiutando i dubbi
della razionalità naturale e accettando senza discutere le formule e le nozioni
imposte dalla Scrittura il credente potrà avere una risposta al quesito riguardo alla
verità. !
Pagina 21 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
d) Sua costante preoccupazione era stabilire, mediante quelle stesse discipline di cui
condannava l'abuso, i limiti della capacità conoscitiva dell'uomo. !
e) De Divina Omnipotentia: tuttavia egli è un sottile conoscitore di quelle stesse arti
liberali che contesta. Nel De divina omnipotentia, partendo dall'espressione
iperbolica di Girolamo secondo cui neanche Dio sarebbe in grado di ripristinare la
purezza di una vergine caduta, il cui significato è in realtà se Dio sia in grado o
meno di cancellare la realtà di un evento passato, facendo sì che non sia stato, Pier
Damiani dimostra l'impossibilità della ragione di raggiungere con le proprie leggi
ambiti infinitamente al di là delle proprie possibilità. La mente sa di non poter
rispondere di no ad una domanda sull'onnipotenza divina, ma sente di non poter
rispondere di si a causa delle proprie leggi. Ma le contraddizioni sono solo apparenti
in quanto sono contraddizioni solo nel nostro sistema logico. Dio infatti non
soggiace alle regole del nostro pensare. Si arriva allora a dei paradossi: l'unico
limite all'onnipotenza divina è volere il male, poiché nel momento in cui Dio lo
volesse l'oggetto di questa sua volontà sarebbe il bene. Allo stesso modo, Dio può
l'impossibile, perché Egli ha stabilito cosa sia possibile e cosa no, e se volesse ciò
che è impossibile in quel momento stesso ciò che è impossibile diventerebbe
possibile. !
f) l’incommensurabilità tra Dio e le creature: Le domande sull'onnipotenza divina sono
sbagliate, non formulabili. Pier Damiani infatti afferma che l’intelletto umano è
impossibilitato a commisurarsi con l’onnipotenza divina. La nostra ragione funziona
bene per quanto riguarda il nostro mondo e il nostro creare, ma non per quanto
riguarda Dio, di fronte al quale non può che fare un passo indietro. !
!
I moderni contro gli antiqui:!
Roscellino di Compiègne!
1- Roscellino di Compiègne porta alle estreme conseguenze la demolizione del
platonismo come fondamento del sapere. 2- Verrà criticato da Anselmo d'Aosta e Pietro
Abelardo a causa del suo radicale nominalismo, secondo cui gli universali non sono altro
che l’emissione del suono (“flatus vocis”) proveniente dalla bocca di chi pronuncia parole
come “uomo”, e a causa della sua dottrina trinitaria che, fondata su una dottrina logica,
lo portava a sostenere una pericolosa posizione triteistica. 3- Tutto ciò che sappiamo sul
suo pensiero viene dagli scritti dei suoi avversari: di suo abbiamo solo un'epistola ad
Abelardo.!
a) le accuse a Roscellino: Roscellino, secondo i suoi detrattori, non può che incorrere
nell'errore: se infatti non si riesce a comprendere l’unità dei singoli uomini nella
specie “uomo”, come si potrà comprendere che tre persone diverse sono unificate in
un'unica divinità in cui sussistono contemporaneamente? Allo stesso modo non
riuscendo ad ammettere nient’altro oltre agli individui, come si potrà ammettere che
l'individuo Cristo sia il risultato della congiunzione di due nature, umana e divina?
Anziché sostenere una sola res, si dovrà sostenere che ci sono tres res. Roscellino
è dunque per Anselmo un “eretico della dialettica”, poiché il suo errore proviene
dalla logica, e per Abelardo uno “pseudochristianus”. !
b) la difesa di Roscellino: Roscellino, rispondendo nell'Epistola, sostiene di star
interpretando in maniera ortodossa la verità cristiana, e che la sua sia l'unica
conclusione che non porti a sostenere che il Padre e lo Spirito Santo abbiano
sofferto in croce con il Figlio. Affermando che la ragione umana non può
rappresentarsi il divino se non in tre res distinte, vuole sottolineare l'incapacità di
Pagina 22 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
esprimere un giudizio sull'ineffabilità dei misteri teologici, sempre in virtù della
differenza incolmabile tra i piani. !
c) riformista radicale: Considerando il grande impegno di quest'ultimo nel
rinnovamento morale del clero, è possibile accostare Roscellino ai riformisti radicali
come Pier Damiani od Otlone di Sant’Emmeran, convinti che fosse necessario
liberare la teologia dagli schematismi dialettici dei filosofi. Questo allineamento si
conferma anche nella sua concezione puramente strumentale della logica,
contrariamente ad una posizione platonico-agostiniana, che vede nelle arti liberali
un riflesso intellettuale dell'ordine necessario stabilito da Dio. !
d) antiqui vs moderni: Tra il secolo XI e secolo XII si esprime infatti una contraddizione
tra antiqui, che difendevano la possibilità di una collaborazione tra fede e ragione, e
moderni, che “non credono se non a ciò che possono comprendere per mezzo di
indagini sensibili” e hanno come obiettivo la difesa della fede dalle prevaricazioni del
pan-logismo platonizzante. !
e) teologo intransigente: A guardare bene la figura di Roscellino si può concludere
affermando che non è stato un avventato razionalista, ma un teologo radicale:
secondo Roscellino LA NATURA RERUM NON È CONTROLLABILE MEDIANTE
GLI SCHEMI ORGANIZZATIVI E DEDUTTIVI DELL’INTELLIGENZA, MA È INVECE
FONTE DI CONTINUI STIMOLI PER UN’OSSERVAZIONE SCIENTIFICA
EMPIRICO-DEDUTTIVA. Roscellino appare dunque un pensatore più complesso di
quanto non si sia creduto: da una parte competente e coerente maestro di arti
liberali, dall'altra l'intransigente defensor fidei, avverso a qualsiasi imposizione di
schemi mentali antropomorfici alla libera volontà di Dio. Come in Pier Damiani,
l'affermazione dell'assoluta onnipotenza divina è il solo principio che consente di
spiegare i misteri della fede. !
!
Anselmo d’Aosta!
!
a) l’opera: La prima opera di Anselmo è il Modello di meditazione sulle ragioni della
fede, inviato a Lanfranco di Pavia, suo maestro, che non potè che nutrire dubbi
sull’opera dell’allievo: difatti nell'opera Anselmo riflette in maniera puramente
razionale sulle verità della fede. Il trattato è un'indagine sulla natura del Dio cristiano
mediante dimostrazioni concatenate in maniera da far scaturire dall'una la necessità
dell'altra, senza però alcun riferimento all'autorità della Scrittura o dei Padri. !
b) “sola ratione”: Anselmo procede “sola ratione”, pur premettendo, all'inizio dell’opera,
che le affermazioni del testo sarebbero state in accordo con le verità della fede.!
c) la risposta a Lanfranco: Anselmo rispose al richiamo del maestro invitandolo a dare
alle fiamme il suo opuscolo, ma solo dopo aver verificato che le sue tesi non fossero
in accordo con le esposizioni dottrinali dei Padri, in particolare Agostino. Lanfranco
non ordinerà la distruzione dell’opuscolo e, su consiglio di Ugo di Lione, Anselmo
modificherà il proprio titolo in Monologion, che significa “riflessione”, “dialogo
interiore”. La stessa sorte toccherà ad un secondo opuscolo, La fede in cerca di
intelligenza, diventato poi Proslogion, cioè “dialogo”. !
d) I cambi di titolo esprimono la differenza formale delle due impostazioni: il primo
un'esposizione di percorsi mentali, il secondo un dialogo spirituale con Dio stesso,
entrambi senza far dipendere la sistemazione logica delle verità teologiche dalla
fede (etsi Deus non daretur), pur presupponendola.!
!
!⁃!La verità come rectitudo dell'intelligenza alla fede.!
Pagina 23 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
!
a) il progetto complessivo: nell’aprire il suo libretto intitolato De veritate, Anselmo
precisa la sua nozione di verità, mettendo in risalto il suo progetto complessivo: far
emergere, consolidare e chiarire la profonda necessità logica delle verità di fede. !
b) Che cos’è vero: per lui “vero” è tutto ciò che gode di una rectitudo formale, ossia
che è esattamente nel modo in cui è corretto che sia. 1- Il “vero” uomo è colui che è
uomo nel modo in cui Dio ha stabilito che lo sia; 2- una proposizione è vera quando
esprime correttamente l’accordo tra il pensiero e la res corrispondente. !
c) Definizione di dialettica: a tal proposito, per Anselmo, LA DIALETTICA È LA
SCIENZA DELLA RECTITUDO DELLE COSE CONOSCIUTE, in quanto garantisce
l’assoluta corrispondenza tra la res, l’intellectus e la vox che la rappresenta. !
d) Il progetto teologico anselmiano: l’obbiettivo del progetto di Anselmo consiste nel
perseguire fino in fondo il tentativo dell’intelligenza umana di parlare di Dio. Tuttavia
la ragione umana è limitata e finita, dunque non è in grado di assegnare un
significato compiuto alla parola Deus. Un intellectus tanto perfetto da potersi
rappresentare tale res coinciderebbe con la mente divina, cioè il Verbo, che è il
pensiero con cui Dio conosce tutto. !
e) Credo ut intelligam e viceversa: Ciononostante, una volta compiuto l'atto di fede, la
ragione creata è in grado di comprendere a partire dal credere (credo ut intelligam)
e di riconoscere la rectitudo delle argomentazioni su Dio, cioè la corrispondenza tra
esse e la verità che le è resa nota dalla fede. Per questo motivo la ragione può
anche distaccarsi dalla fede, senza utilizzarla per dimostrare ciò che è dimostrabile
secondo la sola ragione, e che non è altro che la verità di fede (intelligo ut credam).!
f) Il metodo anselmiano: il metodo anselmiano della “sola ratio” consiste nel procedere
nella comprensione dei contenuti della fede mettendo la fede tra parentesi. Ciò che
la ragione porta non è mai contraddittorio rispetto alla fede, ma sempre
complementare. !
!
!⁃!!Il Monologion, modello di meditazione sulla verità di Dio !
!
a) L’obbiettivo dei due opuscoli: l’obbiettivo dei due opuscoli (il Monologion e il
Proslogion) di Anselmo è comprendere la rectitudo della parola Deus. In entrambi i
casi le mosse vengono prese dalla percezione di una verità superiore, ossia dalla
nozione corrispondente al nome stesso di Dio, per passare dalla comprensione del
suo significato alla definizione delle ulteriori verità particolari in esso incluse. Si può
parlare con un lessico di molto posteriore ad Anselmo, di procedimento a priori. !
b) le quattro dimostrazioni (a partire dalle categorie aristoteliche): Il primo modo
consiste nel mostrare come la rectitudo della parola Deus sia nel suo essere
supremo oggetto del nostro desiderio. Noi non desideriamo le cose in sé ma il loro
essere buone. Desideriamo dunque ciò che le fa essere buone, ossia il bene. E se
lo cerchiamo in tutte le cose è perché esso esiste e tutte le cose sono
imperfettamente buone, mentre esso soltanto è il bene più grande, ovvero il bene in
sé. Il supremo bene esiste e non ha bisogno di altro per essere desiderato, ed è
Dio. Un secondo modo per comprendere la rectitudo di Dio è il seguente: tutte le
cose hanno una grandezza, quindi conoscendole noi conosciamo l'essere grande.
Ciò che fa essere grandi le cose, analogamente a ciò che le fa essere buone, è la
grandezza in sé. Questa è ciò che c’è di più grande e pensabile, e dunque è anche
ciò che di migliore e pensabile, ed è Dio, perché fa essere le cose grandi e migliori.
In entrambe le argomentazioni ANSELMO PARTE DALLA CONOSCIBILITÀ DEL
Pagina 24 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
FINITO COMPRENDENDO CHE TALE CONOSCIBILITÀ NON SAREBBE
POSSIBILE SE NON IN VIRTÙ DI UNA VERITÀ SUPERIORE DA CUI
SCATURISCE. Anselmo, in queste due dimostrazioni, inizia dalla percezione nel
creato dei primi due gruppi delle categorie aristoteliche che determinano i modi di
apparire delle sostanze: la qualità, la cui migliore predicabilità è il bene, e la
quantità, la cui migliore predicabilità è la grandezza. La mente è ascesa dalla
predicazione per aliud, ossia dalla predicazione di una qualità o quantità
riconoscibile come tale per il riferimento a una qualità o quantità superiore, alla
predicazione per se, quella della qualità in sè e quella della quantità in sè, tali da
coincidere con la sostanza divina. La terza argomentazione indaga il terzo gruppo di
categorie aristoteliche, la relazione. Ogni cosa è nella misura in cui qualcosa lo fa
essere, e dunque è in relazione con qualcos'altro che è, oppure nulla lo fa essere,
ovvero è senza relazioni con qualcos'altro che è. Ciò che è senza relazione è
l'essere in sé (per se), cioè Dio: le cose sono in quanto partecipazioni dell'essere
vero. La quarta argomentazione parte dalla considerazione che la relazione sussista
non solo tra sostanze ma anche tra le qualificazioni. Anselmo afferma che in natura
è possibile scorgere diversi gradi di dignità (ad esempio un cavallo è superiore a un
albero e un uomo è superiore a un cavallo) ma che senza un grado massimo non
sarebbe possibile orientare in alcun senso la gerarchia: questo grado massimo è
Dio, la perfezione per se. !
c) La rectitudo della parola Deus: la rectitudo della parola Deus comporta in primo
luogo la sua esistenza, che non è altro che il primo degli attributi della natura più
alta e perfetta di tutte. Si dovranno poi predicare di Dio tutti i termini che esprimono
le perfezioni nelle creature, rinviandola a qualcosa di superiore. Da questo deriva la
cascata sistematica di attributi assegnati a Dio, tra cui “giustizia suprema”, “bontà
suprema” e così via, qualità presenti nel mondo ma espresse alla massima potenza
in Dio. !
d) La natura di Dio: 1- Dio è ingenerato, perché il suo esistere non può dipendere per
aliud da una causa preesistente; 2- è eterno, perché non può essere subordinato a
una misurazione spazio-temporale; 3- infine non è molteplice né corruttibile in
quanto non è materia né forma. 4- E le cose, prima di esistere, erano in Dio, ossia
erano nel Verbo, la mente eterna che ne progettava l’esistenza.!
!
!⁃!Il Proslogion, dalla fede all'intelligenza della verità di Dio!
!
a) unum argumentum: 1- Nel Proslogion Anselmo aspira a ricondurre la conoscenza
di Dio ad un atto di puro pensiero, immediato. Un unum argumentum,
autosufficiente e in grado di fornire alla mente umana un concetto perfettamente
corrispondente alla natura di Dio. !
b) l’intuitività noetica dell’argumentum: Si racconta che Anselmo ebbe l’intuizione
dell’unum argumentum ripetutamente durante la notte tanto che per trascriverlo, e
dunque non dimenticarlo, dovette svegliare il suo copista. L’episodio ben evidenzia
la condizione di intuitività noetica in cui la comprensione dell’argomento si genera,
antecedente alla traduzione discorsiva con cui esso diventa argumentatio.!
c) la formulazione: L’argomento di Anselmo è puramente razionale ed è valido in sé e
deve essere accettato anche da chi non ha fede. L’argomento è il seguente: “Noi
crediamo che tu sia 'qualcosa di cui non è possibile che sia pensato qualcosa di
maggiore”. Anche l'insipiens però deve ammettere che “ciò di cui non esiste nulla di
più grande” esiste almeno nell'intelletto. Ma non può esistere soltanto nell'intelletto,
Pagina 25 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
perché si potrebbe pensare a qualcosa che è anche in re che a questo punto
sarebbe maggiore del qualcosa pensato come esistente solo nell’intelletto, ossia ciò
di cui non si può pensare il maggiore è ciò di cui si può pensare il maggiore. Il che è
contraddittorio. Dunque esiste qualcosa di cui non può essere pensato nulla di
maggiore, tanto in intellectu quanto in re ed è Dio. La coincidenza di Deus con quo
maius è una perfetta espressione di teologia negativa, che impone di ammettere
che Dio possieda tutti i maggiori gradi di perfezione, convinzione che per Anselmo
viene dalla fede. !
d) differenze tra monologion e proslogion: mentre nel Monologion Anselmo seguiva un
percorso che portava ad affermazioni positive riguardo alla natura di Dio, nel
Proslogion segue una via negativa e apofatica, per cui Dio, se è veramente Dio, non
può non esistere. !
e) la critica di Gaunilone: Un monaco di nome Gaunilone scrisse il Liber pro insipiente,
non certo per dimostrare che Dio non esiste, ma per dimostrare che non è possibile
sfuggire al dubbio, alimento e non ostacolo per la fede. Gaunilone sostiene che la
mente umana sia in grado di riconoscere solo le verità a lui provenienti per mezzo
dell'esperienza, e che nella mente non vi siano res ma solo parole e significati. Per
dimostrare come l'avere qualcosa in intellectu non comporti che quel qualcosa
esista in re introduce la nozione di un'isola leggendaria, piena di tutte le perfezioni e
di cui non si può pensare nulla di più perfetto (anche se in realtà Gaunilone si
esprime con “maius omnibus”) senza però che questa esista. La mente può
raffigurarsi l'isola con un concetto chiarissimo, senza doverne però ammettere
l'esistenza. Sostanzialmente, PENSARE L'ESISTENZA DI QUALCOSA NON
SIGNIFICA CHE ESSA ESISTA. !
f) la controrisposta di Anselmo: Anselmo ribatte sostenendo che Gaunilone si è
espresso in maniera impropria: l'esistenza di Dio è sì implicata dalla sua
pensabilità, ma vale anche il contrario. Gaunilone poi non non ha considerato
che il disconoscimento della verità è possibile per, appunto, un insipiens, non
informato dalla Rivelazione. Gaunilone, invece, essendo cristiano, avrebbe dovuto
ammettere l'ordine logico voluto da Dio: dal momento che non è stato in grado di
compiere lo sforzo per arrivare alla comprensione dell'argumentum, Anselmo è
costretto a ribattere secondo gli strumenti della dialettica. La Responsio diventa così
una lunga concatenazione di argomentazioni che portano all'inevitabile conclusione
che è logicamente impossibile unire il soggetto “Deus” con il predicato “non est”.!
!
!
!⁃!Il sistema della verità cristiana!
!
Intro: Le opere della maturità di Anselmo, De Veritate, De libertate arbitrii, De casu
diaboli, tutti e tre completati tra il 1080 e il 1085, l'Epistola de incarnatione Verbi contro
Roscellino, De conceptu virginali, De processione Spiritus Sancti, fino al Cur Deus homo
(iniziato nel 1095), hanno come obbiettivo L'ANALISI CONCETTUALE DEI PRINCIPALI
TEMI DELLA FEDE, successivamente al riconoscimento dell'esistenza di Dio e dei suoi
principali attributi. !
a) rapporto tra mente divina e mente umana: Anselmo nota che, essendo il pensiero
con cui Dio conosce se stesso unico e compiuto, il tentativo umano di elaborarne
una rappresentazione comprensibile con il concorso di ragione e fede conduce
inevitabilmente a un’esposizione organica, composta da momenti diversi, ma in
definitiva unitari. Il rispetto delle norme della scienza rende il pensiero umano e il
Pagina 26 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
linguaggio che lo esprime capaci di godere di una rectitudo sufficiente nei confronti
degli oggetti naturali finiti; la fede garantisce l'estensione di tutto questo a ogni
ambito che Dio ha stabilito che debba essere vero e necessario, che dunque l'uomo
può e deve conoscere, inclusi i misteri rivelati. Questo spiega come mai Anselmo
abbia combattuto con tale energia il nominalismo di Roscellino in un'ottica
comprensiva di fede e ragione ad un tempo.!
b) l’errore di Roscellino: 1- Roscellino, come Gaunilone, sbagliava nell'escludere una
rectitudo dei pensieri e delle parole umani, e così facendo escludeva la possibilità di
avere una scienza riguardo alcun ambito, men che meno quello teologico. Se tutte
le formulazioni logico-linguistiche vere fossero soltanto convenzionali, i pensieri
umani non potrebbero mai essere dotati di rectiudo, ossia corrispondere al modo di
essere vero e immutabile delle idee divine e della realtà che esse governano. 2- La
ragione umana deve utilizzare solo elementi logicamente determinati, la cui
rectitudo sia stata determinata da passaggi precedenti e che siano così divenuti un
corretto riflesso della verità eterna dei significati nella mente di Dio. Il Verbo infatti,
dicendo la natura divina, è una locutio che gode di una rectitudo assoluta.!
c) Compito della teologia è dunque quello di reperire le necessarie rationes, i principi
eterni della verità, che assicurino la corrispondenza oggettiva del pensiero umano
tanto alla eterna volontà divina nel Verbo, quanto alla descrizione della verità
rivelata che ne offre la Scrittura su dettatura dello Spirito Santo.!
d) Il problema del male è uno dei primi a venire analizzato da Anselmo. Quale realtà e
quale rectitudo può avere ciò che non è voluto da Dio? Allo stesso modo, quale
necessità può avere la sua causa? Attuando un capovolgimento dell'argomento del
Proslogion, Anselmo dimostra che il male non esiste perché non è pensabile e
perchè non è reperibile nel Verbo divino alcun necessaria ratio della sua realtà.
Infatti il male, cioè ciò di cui si può sempre pensare qualcosa di migliore, è privo di
qualsivoglia rectitudo, cioè ad esso non può corrispondere alcuna realtà voluta da
Dio, e di conseguenza non può esistere. Sia il nihil che il malum sono entrambi
concetti vuoti, e pronunciando “nulla” e “male” non si esprime positivamente un
concetto ma se ne nega il positivo corrispondente. !
e) Dio non è causa del male: Dio, in tutto questo, non è causa del male, ma fa sì che
perdurino le conseguenze del peccato, l'attuarsi della non-rectitudo, in maniera
dunque diversa da quello che Dio ha stabilito. La libertà è posta da Dio in quanto la
libera scelta del giusto porta al bene, mentre la libera scelta dell'ingiusto porta al
non-bene: !
f) che cos’è la libertà: De libero arbitrio Anselmo afferma che la libertà non è la
possibilità di peccare o meno, ma la possibilità di realizzare o meno,
volontariamente, le perfezioni nel mondo.!
!
!⁃!Il Cur Deus homo, dalla fede all'intelligenza del mysterium di Cristo!
!
a) intro: Anselmo si domanda quali siano state le ragioni che hanno spinto Dio ad
attuare la redenzione del genere umano. Per dimostrare che anche il mistero
centrale della fede cristiana, l'Incarnazione, possa risultare razionalmente coerente
in un sistema teologico, Anselmo scrive il Cur Deus homo, che ha ricevuto il plauso
quasi universale dei contemporanei. !
b) il procedimento: Come nelle prime opere, l'autore cerca di evidenziare le rationes
del mistero dell’Incarnazione, mettendo la fede tra parentesi, mediante passaggi
puramente mentali. !
Pagina 27 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
c) le ragioni dell’incarnazione: L’uomo si è allontanato da Dio con un atto di libera
scelta, non realizzando così la propria rectitudo. Tale rottura, però, essendo Dio il
Bene, non poteva essere permanente. Dio, volendo riparare il disordine causato dal
peccato, ha voluto che il perdono fosse domandato da qualcuno che partecipasse
alla natura contaminata dal peccato. Ma nessun uomo avrebbe mai potuto ottenere
il perdono per una colpa commessa liberamente in opposizione alla volontà divina.
Solo un uomo che fosse anche Dio avrebbe potuto impetrare il perdono per
l'umanità: dunque l'incarnazione di Cristo era necessaria. La redenzione
dell'umanità non poteva non avvenire (perché Dio vuole il bene), e non poteva
avvenire in altro modo. La scelta di Dio, però, pur essendo necessaria, era libera,
perché libertà per Dio significa attuare la propria volontà. Il mediatore non sarebbe
potuto essere un angelo perchè questo avrebbe determinato un assoggettamento
dell’umanità al suo liberatore.!
!
!!!! Pietro Abelardo!
!
Intro: Abelardo utilizza il termine teologia in un significato nuovo: il termine entra infatti
nel lessico fondamentale del pensiero occidentale e va a designare LA
COMPRENSIONE INTELLETTUALE DELLA VERITÀ RIVELATA DA DIO AI SUOI
PROFETI, conservata nel dettato dei libri sacri e tramandata dalla tradizione
ecclesiastica. La vera theologia dei cristiani costituisce una possibile alternativa
all'indagine puramente razionale sul divino, sempre incompiuta e inadeguata. !
a) diffusione della gnoseologia neoplatonica: Abelardo si allinea ai princìpi gnoseologici
del neoplatonismo, dopo Boezio e Giovanni Scoto, e li diffonde: poichè infatti non sono i
modi della conoscenza ad adeguarsi alla natura dell'oggetto, ma, al contrario, è l'oggetto
che si fa conoscere in modi diversi a seconda della facoltà conoscitiva che lo coglie, così
la teologia può nascere dall’illuminazione con cui Dio consente all’uomo di ascendere
alla sua visione della verità, seppur in modo imperfetto. Per cui, se da un lato è vero che
una data cosa viene percepita in maniere differenti, è anche (e soprattutto) vero che
quella data cosa è una. !
b) la conoscenza di Dio è terrena: Abelardo arriva così a sostenere che la conoscenza
del divino sarà sempre e soltanto creaturale (terrena disciplina, terrena philosophia), ma
non falsa, semplicemente non ancora vera in senso proprio poiché non ancora
compiuta. Il desiderio di conoscenza di Dio potrà essere esaudito completamente solo
da chi si affida alla grazia della Rivelazione, che comunque senza l'impegno
dell'intelligenza non potrà dar frutti. La ratio produce infatti la fides in qualcosa che
ancora è dubbio.!
!
!⁃!Gli universali e la verità del conoscere!
!
a) che cosa sono gli universali? 1- Gli universali sono, al tempo di Abelardo,
fondamentali non solo da un punto di vista logico, ma anche da un punto di vista
gnoseologico, perché permettono di distinguere una conoscenza scientifica vera da
una falsa. 2- Abelardo conduce le sue lezioni sulla base del commento boeziano
all'Isagoge di Porfirio, all'inizio del quale l'autore pone tre domande: gli universali
esistono, e dunque sono realtà? Se esistono, sono separati dagli individui? Se sono
separati dagli individui, sono conoscibili a prescindere da essi? Dalla risposta a
queste tre domande conseguono la giustificazione e la possibilità di una
conoscenza umana. Abelardo si colloca, in questo senso, nella via antiquorum,
Pagina 28 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
ossia si allinea ad un realismo diametralmente opposto al nominalismo sostenuto da
Roscellino di Compiègne. !
b) Il pericolo del nominalismo 1- infatti non si ferma al problema della sussistenza di
generi e specie, ma si estende alla stessa corrispondenza tra parole e realtà e
dunque alla veridicità di ogni possibile scienza, dalla logica alla teologia. 2- I
nominalisti sbagliano quando negano che la dialettica sia scienza di qualcosa di
reale: essa è infatti scientia veritatis e non scientia vocum, che è invece la
grammatica; la dialettica tratta del reale, e più precisamente di ciò che è immutabile.!
c) critica al realismo di Guglielmo: d’altra parte, Abelardo è ben consapevole che le
posizioni realiste del suo maestro, Guglielmo di Champeaux, sono sempre
sottoposte a critiche. Gugliemo di Champeaux sosteneva che gli universali fossero il
sostrato ontologico degli individui, una res spirituale, non soggetta all'accidentalità e
superiore in grado ai corpi nella gerarchia dell'essere. Se la specie è sostrato
sostanziale degli individui, il genere lo è della specie. Abelardo critica questa
posizione poiché una res non può essere predicata di altre res. !
d) la quarta domanda: Abelardo aggiunge una quarta domanda alle tre di Porfirio: gli
universali continuerebbero ad esistere anche se cessassero di esistere i soggetti?
La risposta è necessariamente affermativa, poiché sarebbe sempre vera, se non
esistessero più rose, l'asserzione “non esistono più rose”.!
e) definizione degli universali: Abelardo si trova quindi in armonia con la concezione
platonico-agostiniana della DIALETTICA COME RICOMPOSIZIONE INTERIORE
DEL VERO STABILITO DA DIO. 1- l’universale è la vera realtà della relazione tra
soggetto e oggetto, quando l’intellectus corrisponde allo status in cui esteriormente
la res si trova. 2- La verità ultima degli universali è per Abelardo, come per Agostino,
Boezio e Anselmo, la realtà delle idee divine, riprodotte dalla mente che elabora i
propri oggettivi intellectus delle res create. !
!
!⁃!Veri logici e veri philosophi!
!
a) difesa della logica e rapporto con la fede: In risposta a chi lo criticava per aver usato
la logica a sostegno dei dogmi cristiani, Abelardo ribatte che se la logica è scientia
allora si occupa della veritas, non meno della fede, che è essa stessa produttrice di
scientiae. E se sono veridiche allora logica e fede non potranno mai contraddirsi.
L'uso della dialettica in teologia è dunque non solo lecito ma indispensabile, perché
permette di guidarla e di integrarla, nell'ottica di una finalità comune, la conoscenza
di Dio. !
b) l’etica: Se è vero che Abelardo è stato, dopo Boezio, il secondo fondatore della
logica medievale, è anche vero che è stato il primo autore occidentale a giustificare
esplicitamente l'etica, andando oltre lo studio approfondito dei Vangeli, per fissare
dei princìpi che assicurino l'adesione alla legge di Cristo. Il titolo dell'opera dedicata
è Ethica ovvero Scito te ipsum, conosci te stesso. Per evitare il peccato, ovvero il
porre come proprio fine se stesso anziché Dio, bisogna riconoscere la bontà della
legge divina. Il princìpio consiste non nella forma dell'azione ma è invece
nell'intenzione che orienta un'azione che si determina la responsabilità di un
individuo. Uccidere è male, ma solo se è volontario, così come avere la volontà di
uccidere senza però farlo è comunque peccato. !
c) L'intenzionalità è sostanzialmente simmetrica all'intellectus, in quanto la bontà di
un'azione dipende dalla sua intenzionalità secondo i dettami della legge divina,
mentre la verità di un'asserzione dipende dal suo conformarsi allo status
Pagina 29 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
dell'oggetto di cui tratta l'asserzione. La conoscenza dell'uomo è inadeguata quanto
la bontà delle sue azioni, in quanto in entrambi gli ambiti si tende all'ideale, senza
però poterlo realizzare. Come però nessuna azione non può non orientarsi nei
riguardi del Bene, così nessuna conoscenza non può non orientarsi nei riguardi del
Vero. !
d) indagine logica della Sacra Scrittura: nel momento in cui Dio si è rivelato, la logica è
stata autorizzata ad indagare la lectio scritturale. Le parole della Bibbia, in quanto
significanti e soprattutto in quanto vere, producono nel soggetto un intellectus.
Tuttavia l’oggetto in questione è di difficile comprensione per le capacità limitate
dell’intelligenza umana; è dunque necessario applicare al testo sacro una solida
metodologia ermeneutica.!
e) sic et non: Nella sua opera Sic et non Abelardo propone proprio la teorizzazione di
questa metodologia; in essa troviamo una raccolta di sententiae scelte e accostate
per far risaltare palesi casi di contraddizione tra le tesi dei Padri su un medesimo
argomento. L'obbiettivo dell'opera è invitare l'intelligenza del lettore a superare
metodicamente il contrasto, elevandosi su un piano ermeneutico superiore, dove la
molteplicità delle opinioni dovrà risolversi nell'indubitabile unitarietà del vero.
L'interprete dovrà seguire delle regole, come esplicitato nel prologo:!
!1)!verificare correttezza ed autenticità dei testi;!
!2)!tenere conto delle possibili variazioni di pensiero di un autore;!
!3)!verificare la presenza di eventuali polisemicità;!
!4)!qualora da questi esami non emergano contraddizioni, l'interprete,
considerando che anche quello dei Padri è un tentativo imperfetto di
comprendere la perfezione della Scrittura, sarà autorizzato ad introdurre la ratio
dialettica, e grazie al metodo dialettico presentato nei trattati di logica, questa
azione sarà per quanto possibile necessaria e rigorosa.!
!
-!!La scuola di San Vittore!
!
Intro: Fondata nel 1108, non lontano da Notre-Dame, da Guglielmo di Champeaux, la
scuola di San Vittore era aperta anche ad un pubblico ecclesiastico esterno: questo
significava rappresentare la possibilità di una sintesi tra competenze profane e filosofia
del clero secolare. !
a) l’intuizione dei filosofi pagani: Ugo di San Vittore, il primo successore di Guglielmo,
sosteneva, nella raccolta “Sententiae de divinitate”, che i grandi pensatori, Platone
in testa, abbiano potuto “percepire” con la sola razionalità la verità del mistero
trinitario. E' qui presente dunque l'idea che la Verità crisitana sia già stata intuita, pur
senza essere compresa per via di una non ancora sopravvenuta Rivelazione, da
tutta la storia delle humanarum litterarum. !
b) il dono divino della filosofia: secondo Ugo, dopo la cacciata dal paradiso, l’uomo ha
perso i doni che gli avrebbero consentito di realizzare la perfezione a cui era stato
predestinato, cadendo nell’ignoranza del bene. Dio tuttavia ha donato all'uomo la
filosofia per permettergli di ritornare alla propria originaria condizione. Filosofia che
si divide in: Theoretica, Pratica, Mechanica e Logica, quest’ultima assicura la
metodologia corretta per ogni acquisizione del sapere. Le discipline inferiori
vengono messe al servizio delle finalità più alte della conoscenza, per cui anche le
discipline profane sono da considerare utili per la comprensione della verità divina.
Nel “didascalicon” dice “omnia disce, perché un giorno ti accorgerai che nulla è
superfluo”.!
Pagina 30 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
c) il concetto di signum: Determinante è l’insegnamento di Agostino secondo cui le res
possono e devono diventare signa, indicatori visibili delle realtà invisibili e affinché
questo possa avvenire bisogna indagare nel campo della parte più alta della
filosofia teoretica, la teologia naturale o “mondana”.!
d) La teologia naturale: dopo il peccato l'anima non è più in grado di vedere la natura,
se stessa e Dio, dunque “la fede è necessaria per credere le cose che non si
vedono”. La teologia naturale può però anticipare la fede e giustificarla grazie
all'intervento dell'illuminazione divina, di cui Ugo è informato da Agostino.
L’illuminazione si attua quando l'uomo contempla la propria somiglianza con le cose
superiori. Al contrario l'uomo si serve della propria somiglianza con le cose sensibili
nella conoscenza della natura. !
e) chi è l’uomo? Secondo Ugo l'uomo, a metà tra spirituale e materiale, è il principale
sacramentum, la prima manifestazione del divino. La prima forma della conoscenza
è l'autocoscienza, la cognitio sui: da essa, l'uomo è in grado di risalire al divino,
mediante le prove a posteriori, dalla propria contingenza alla necessità, dalla
disposizione delle cose alla sapienza ordinatrice, dal movimento all'immutabilità. !
f) La creazione appare a Ugo come una realtà organica in continuo perfezionamento,
che il Creatore conduce dal Chaos originario all’ordine compiuto mediante la
presenza operante continua dello Spirito Santo tra le cose finite. !
g) la teologia divina: a un certo punto si fermano le capacità della teologia mondana e
si fa necessaria la subordinazione del capire al credere. Da qui si passa alla
teologia divina, che descrive una conoscenza organizzata e compiuta della fede,
fondata sulla Rivelazione. L'esegesi biblica è un elemento costitutivo del sapere
teologico, e di questo è dimostrazione il fatto che essa sia stata un esercizio
fondamentale nel progetto di studio di tutti i maestri della scuola di San Vittore. Il
teologo si serve delle arti liberali, essenziali per consentirgli la comprensione del
testo scritturale. La penetrazione del significato mistico della Scrittura conclude il
percorso conoscitivo dell’anima con l’avvio di una visione intuitiva ed estatica del
divino, atto supremo di partecipazione alla Verità. !
h) gli altri esponenti della scuola di San Vittore: Andrea di San Vittore si concentra
prevalentemente sulla comprensione storico-letterale della Scrittura, e alcune sue
proposte esegetiche suscitano perplessità all’interno della stessa comunità. Anche
altri maestri, come Riccardo di San Vittore, hanno aderito alle posizioni del loro
maestro Ugo, tra cui l'idea di una gerarchizzazione scalare delle scienze quale
strumento per realizzare l'intelligenza della fede, raccomandata da Anselmo.
Riccardo, ricordando il Monologion e il Proslogion, nella sua opera De Trinitate,
espone alcune prove dell'esistenza di Dio, premettendo che la nozione di Dio viene
dalla fede: egli sostiene che se Dio esiste si deve attribuirgli ciò che c'è di migliore, e
tra le virtù la migliore è l'amore, e Dio deve amare, ma amare è sempre amare altro
e amarlo quanto se stesso, e da qui bisogna ammettere una trinità di persone, in
quanto le prime due sono necessarie per giustificare l'amore che Dio prova per se
stesso e la terza per giustificare l'amore con cui Dio ama quanto se stesso ciò che
da Lui è derivato. Infine, Goffredo di San Vittore perviene ad una considerazione
ottimistica dell'antropologia umana, celebrando positivamente l'armonia psico-fisica
e la potenza delle virtù naturali, etiche ed intellettuali, il merito della cui scoperta
attribuisce, sulla scia di Abelardo e di Ugo, ai migliori filosofi dell'antichità, tra cui
Socrate e Seneca. !
!
Gilberto di Poitiers, detto Porretano!
Pagina 31 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
!
un commento dialettico alla teologia boeziana !
!
a) le eresie: Gilberto nacque intorno al 1080. Giovanni di Salisbury lo ricorda come
dotato di un ingegno finissimo e grande innovatore in campo teologico. Nel 1148
venne convocato da Bernardo di Clairvaux al concilio di Reims dove, in presenza
del pontefice Eugenio III, fu costretto a ritirare quattro proposizioni estratte dai suoi
scritti, considerate ereticali, e fu invitato a desistere dall'insegnamento. !
b) Gilberto interprete di Boezio: assumendo come maestro Boezio, Gilberto, nel
Commento ai cinque Opuscola Sacra, sostiene che Boezio sia stato il teologo più
attento e preciso, poiché, con il solo intento di impedire il diffondersi di eresie, ha
proposto nei suoi libri illustrazioni ragionevoli fondate sulle norme delle arti liberali.
Gilberto propone se stesso come un lector nei confronti di un auctor come Boezio,
non in veste di recitator, ripetendone le dottrine, ma in veste di interpres, ossia
approfondendo i contenuti dei suoi scritti servendosi dei suoi stessi strumenti.
Gilberto fa sì che il contributo di Boezio all'interpretazione della fede sia accessibile
a tutti, senza fraintendimenti o mistificazioni. !
c) una metodologia rigorosa: Gilberto si sottomette ad una metodologia rigorosa,
ricavata da Boezio stesso, che definì la questione della Trinità una “quaestio
lungamente dibattuta”. 1- Gilberto scrive che si ha una quaestio ogni volta che deve
essere risolta una contraddizione tra due tesi. 2- Una delle due tesi è sempre
sbagliata perché contiene al suo interno un’ambiguità semantica che deve essere
individuata ed eliminata. 3- Il metodo per risolvere la contradictio consiste
nell’effettuare la distinctio, mediante la quale si evidenzia l’appartenenza delle due
tesi a diversi loci, diversi ordini semantici e argomentativi. 4- Tale distinctio consente
di evidenziare quale delle due tesi sia quella corrispondente al contesto specifico in
cui sono state avanzate, e vada quindi riconosciuta come veridica. Strategia
importante perché chiarisce come l’ambito di conoscenze relativo ai contenuti della
fede possa essere aperto all’indagine e all’approfondimento razionale purché
adeguatamente supportati da una strumentazione corretta. Le conclusioni
ovviamente dovranno essere in accordo con ciò che è già esplicito nella
Rivelazione.!
!
il metodo della transumptio teologica !
a) Cos’è la transumptio? La terminologia logica è portata ad assumere una valenza
deviata dalle sue originali finalità quando viene adattata al sapere teologico. In
ambito teologico i termini vanno usati transumptive, ossia ad un livello superiore. La
Transumptio consiste nel prendere in prestito un termine da una scienza inferiore e
utilizzarlo, variando il significato di partenza, per esprimere oggetti della teologia. In
teologia il termine “persona” ha un significato diverso da quello in altri ambiti, e
quindi non è sbagliato considerare tre personae senza per questo essere obbligati
ad ammetterne la sussistenza come tre realtà individuali e separate: se la tradizione
autorizza l'uso di questa parola è perché il suo significato è quello che meglio si
adatta a esprimere l'enigmaticità del mistero, senza per questo esaurirla; è
essenziale per il teologo determinare con chiarezza l’oggetto e l’estensione della
propria disciplina. !
b) la divisione delle discipline: Boezio aveva diviso la filosofia teoretica in: scientia
naturalis, mathematica e theologia, i cui campi di indagine sono rispettivamente la
natura, le forme immutabili e non separabili e l'unica forma immutabile ma separata,
Pagina 32 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
ossia Dio. A ciascuna una specifica ratio, che Boezio indica con gli avverbi:
rationabiliter, disciplinaliter, intellectualiter. Nel caso della teologia non essendo
adeguata la strumentazione, bisogna ricorrere agli strumenti delle scienze inferiori.
Si incorre negli errori degli eretici quando non si tiene conto della transumptio
necessaria per parlare positivamente del divino, ovvero l’eretico utilizza la
metodologia atta a indagare le realtà naturali per parlare del divino. !
c) la critica ad Anselmo: si noti il costante tentativo di precisare gli strumenti del
discorso teologico ed è implicita la polemica nei confronti della concezione
anselmiana secondo cui il linguaggio teologico è sempre univoco in quanto vero e
immediatamente significativo della realtà che esprime. !
!
la realtà del singolare e la composizione ontologica!
!
a) la realtà degli universali: per quanto riguarda gli universali, Gilberto non li considera
come modalità di conoscenza, ma veri e propri modi di essere di qualcosa di reale,
collocati nel grado mediano della complessa gerarchia ontologica che unisce la
creazione a Dio. La soluzione delle tre domande di Porfirio sugli universali parte
dalla premessa che essi esistono. !
b) tutto è singolare: Gilberto sostiene che tutto ciò che esiste come reale è singolare, e
dunque distinto da altro; così non soltanto gli individui ma anche gli universali sono
singolari, e ovviamente anche Dio. 1- In cima alla scala dell'essere c'è la substantia
simplex, 2- poi la sostanza universale, la base metafisica di ogni cosa, che Gilberto
chiama dividuum, cioè ciò che è divisibile, partecipabile; 3- infine la sostanza
individuale e indivisibile (individuum) che, essendo razionale nell’uomo, prende il
nome di persona; caratteristica dell’individuo è quella di essere irripetibile, l’id quod
est (riprendendo la terminologia boeziana), il non conforme ad altro, risultato
dell’incontro di una materia con una forma. !
c) le forme nativae: Ciò che determina l’individuo è proprio quella forma, possibile tra
le altre, che orienta il modo di essere della materia dell’individuo. Questa forma
prende il nome di quo est, che viene definita in assonanza con il platonismo, forma
nativa, ovvero che ha in sé la conformità, quel carattere che nell’individuo evidenzia
la sua somiglianza con altri individui. Le forme nativae sono singole realtà
universali, sussistono negli individui che da esse derivano e non sono da essi
distinti, riproducendo modelli superiori per diventare a loro volta modelli delle realtà
inferiori. !
d) le sincerae substantiae: le idee divine invece, denominate sincerae substantiae,
sono gli universali eterni e non si distinguono dal pensiero e dalla volontà di Dio. La
teologia dovrà trascendere tutte le forme create per fissare lo sguardo sull’essere
semplice di Dio e delle forme esemplari nel suo Verbo.!
!
la distinctio trinitaria!
a) la deitas: il teologo per comprendere la natura di Dio deve utilizzare il linguaggio
scientifico attinto dalle discipline inferiori, operando una transumptio. Dio è un id
quod est, una singolarità assolutamente semplice, ossia in tutto e per tutto uguale al
quo est che lo fa essere Dio. Come il linguaggio fisico distingue uomo da umanità, il
linguaggio teologico deve distinguere Deus da deitas: Dio è Dio perché l'essere Dio,
la deitas, lo fa essere Dio. Questo vale anche per il Figlio, che è Figlio, perché la
deitas lo fa essere figlio, e per lo Spirito Santo, che è Spirito perché la deitas lo fa
essere Spirito. LA DIVERSITÀ DEI MODI SIGNIFICANDI CORRISPONDE A UNA
Pagina 33 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
DISTINZIONE DEI NOSTRI MODI INTELLIGENDI, MA NON A UNA EFFETTIVA
DISTINZIONE DEL MODUS ESSENDI DIVINO, dal momento che tali distinzioni
appartengono a una necessità funzionale del nostro modo imperfetto di parlare di
Dio. Tuttavia la questione teologica gilbertiana non deve essere assimilata alla
posizione di Roscellino, il quale considerava il discorso teologico come opzionale e
variabile: anzi Gilberto s’impegna ad assicurare una metodologia rigorosissima al
discorso teologico. !
b) la teoria di Prisciano: il pensiero umano può comprendere l’essere di qualcosa
soltanto grazie a una distinzione logica tra ciò che è predicato e ciò di cui si predica,
come la teoria di Prisciano insegna. In questo modo la mente umana è in grado di
capire che la sostanza divina è una sola ed è la stessa in tutte e tre e le persone:
solo in teologia l'id quod est e il quo est coincidono. Se così non fosse, verrebbe
meno la possibilità per l’uomo di ritenere distinte le tre persone. Vi è dunque
un’ascesa della mente dal livello della ratio discorsiva a quello intuitivo e diretto
dell’intelligentia, il solo in grado di poter “parlare” di Dio. !
!
La scuola di Chartres!
!
a) lo studio della natura: 1- Si sviluppa a partire dalla dottrina dell’esemplarismo divino
un altro filone di indagine, più orientato verso lo studio della natura, considerata
come l'altro libro, oltre alla Bibbia, scritto da Dio e messo a disposizione degli
uomini. 2- Anziché attraverso la corrispondenza con l'ordo verborum, il legame tra
ordo rerum e ordo idearum viene indagato mediante il filtro della conoscenza delle
entità naturali, fondata sulle arti del quadrivio. Accanto alla logica, infatti, le scienze
matematiche forniscono una ulteriore struttura formale del sapere, attraverso cui è
possibile stabilire il legame tra le cose create e l'intelligenza creatrice. !
b) La rimozione dell'integumentum o involucrum, del velo, della “buccia” che riveste le
apparenze sensibili e che cela le forme quantitative eterne che presiedono
all'ordinamento del creato, è parte fondamentale per una formulazione esaustiva
della vera philosophia. !
c) l’importanza dei filosofi pagani: Gli stessi grandi filosofi dell'antichità sono stati in
grado di sollevare l’integumentum con il solo ausilio della razionalità, ma, non
riuscendo con essa ad esplicare il risultato delle loro ricerche, sono ricorsi ad
immagini allusive. Questo giustifica l'interesse nutrito per i testi degli antichi, in
particolare per il Timeo di Platone tradotto e commentato da Calcidio. Nel dialogo il
filosofo greco riesce ad intuire e a rappresentare qualcosa della vera natura di Dio,
un architetto (demiurgo) sapiente che, ispirandosi a modelli eterni (formae aeternae
o primordiales), plasma la natura in maniera ordinata. Sotto l'integumentum,
mitologico, di questo racconto, il credente, informato dalla verità superiore della
Scrittura, potrà attingere dalla dottrina di Platone alcune idee filosofiche preziose
per passare alla comprensione dell’altro integumentum, teologico, che vela nel libro
del Genesi le più incomprensibili profondità dell’opera creatrice divina. Altri testi
importanti per questo motivo sono il commento di Macrobio al Sogno di Scipione
oltre i lavori di altri autori classici inclusi Virgilio e Ovidio: tutte queste opere sono
considerate foriere di dottrine cosmologico-teologiche, mascherate sotto il velo della
mitologia pagana.!
d) i signa: L’intera realtà visibile viene considerata dalla scuola di Chartes portatrice di
quei signa che per Agostino erano racchiusi solamente nella Rivelazione cristiana.
In quest'ottica, elementi vegetali, animali, astronomici cooperano con i simboli della
Pagina 34 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
liturgia cristiana nell'evocare tracce dell'efficacia di Dio nel mondo vivente, da Lui
creato.!
!
Bernardo di Chartres e le formae nativae!
!
a) Bernardo, filosofo platonico: Bernardo, uno dei più importanti maestri di arti liberali
del XII sec, venne chiamato dal Vescovo Ivo a insegnare alla scuola di Chartres.
Avviò la riflessione all’interno della scuola sul problema dell’esemplarismo, tentando
una mediazione tra l’elemento ontologico e quello teologico implicati entrambi nella
dottrine del realismo delle essenze. Di Bernardo non abbiamo scritti, solo
testimonianze di Giovanni di Salisbury, che lo descrisse quale “il più perfetto tra i
platonici del nostro tempo”. !
b) le forme nativae: Egli utilizzò il termine formae nativae, traendolo da Calcidio nel
commento al “Timeo” di Platone, per indicare le forme nella loro congiunzione con la
materia, distinguendo 1) le idee divine, increate ed eterne, assolutamente separate
dalla materia; 2) le idee create, “non del tutto coeterne” e non del tutto identiche con
il divino. !
c) Prisciano: Per spiegare questa dottrina riprese Prisciano, il quale affermava che in
ogni predicazione sono sempre compresi due elementi, la sostanza e la qualità.
Partendo da questo, Bernardo indicava in alcuni nomi, come “albedo”, “bianchezza”,
la capacità di esprimere la qualificabilità della sostanza senza farla ancora entrare in
commistione con essa, e li paragonava ad una fanciulla ancora vergine; il verbo che
ne indica l'azione, in questo caso “albet” (“biancheggiare”), sarebbe come una
vergine al momento di entrare nel talamo; infine, l'aggettivo qualificativo e qualificato
“album” (“bianco”) è la qualità unita alla sostanza, corrotta come la vergine che si è
unita all'uomo. !
d) distinzione tra potenza e atto: Questa spiegazione introduce una nozione importante
per la concezione naturalistica della scuola di Chartres, la distinzione tra potenza (la
perfezione ideale) e atto (la contaminazione con la materia): ciò è importante perché
spiega il divenire naturale delle cose finite e la loro derivazione da Dio senza per
questo compromettere l'immutabilità del creatore. IL DIVENIRE È L'ATTUAZIONE
NELLA PARTICOLARITÀ DELLA POTENZIALITÀ ORIGINARIA DELLA FORMA,
C H E R E S TA I N C O N TA M I N ATA I N S È , I N Q U A N TO N O N P E R D E
NELL’ATTUAZIONE CON LA MATERIA LA PROPRIA NATURA DI PURA
POTENZIALITÀ, che è un riflesso dell’immutabilità delle eterne idee divine. Dunque
la dottrina dell'esemplarismo chartriano formulata da Bernardo chiarisce come ogni
creatura visibile sia un involucrum di una realtà superiore in essa nascosta.!
e) i tre ingenii: secondo Bernardo l'uomo è dotato di tre forme di ingenium: l'ingenium
advolans, inquieto e vivace, che con la stessa facilità con cui acquisisce le
conoscenze altrettanto facilmente le abbandona correndo in cerca di altri stimoli;
l'ingenium infimum, materialista e pigro, incapace di sollevarsi all'altezza del vero; e
infine l'ingenium mediocre, che usa la conoscenza come base per poi sublimare le
proprie capacità, quello adatto per il filosofo. !
f) nani sulle spalle dei giganti: Bernardo sosteneva che gli intellettuali del suo tempo
fossero “nani sulle spalle di giganti”, per sottolineare il fatto che se si è in grado di
guardare più lontano dei maestri del passato è perché proprio questi ultimi ci
sostengono e ci permettono di sapere di più. Questa immagine esemplifica
compiutamente l'umanesimo degli chartriani. !
!
Pagina 35 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
Guglielmo di Conches e la philosophia mundi!
!
Allievo di Gilberto Porretano, le sue idee erano conformi a quelle di Bernardo nel
ricercare nei maestri del passato dei precedenti della dottrina cristiana. Venne accusato
da Guglielmo di Saint-Thierry di aver interpretato la creazione “secondo i principi della
fisica”. Forse per sottrarsi a tale ostilità, tornò nella natia Normandia dove fu precettore
di Goffredo Plantageneto, destinato a salire sul trono d'Inghilterra con il nome di Enrico
II. Scrisse 3 trattati sistematici e commenti agli autori antichi. !
a) l’importanza del mito platonico: nella sua opera principale “philosophia mundi” è
dominante l’intento programmatico di sollevare l'integumentum del mito platonico
per raggiungere una corretta spiegazione scientifica dell’origine del cosmo,
accordarla con la Genesi e scoprire quanto gli enunciati dei filosofi possono essere
armonizzabili con le parole dei profeti. !
b) l’oggetto dell’indagine fisico-matematica: secondo Guglielmo l'oggetto dell'indagine
fisico-matematica non potevano essere i princìpi puri di origine divina, ma le formae
nativae che chiama causae secundae, ossia strutture matematiche efficaci sul
mondo fisico. !
c) la capacità causativa della natura: la natura secondo Guglielmo è dotata di una
specifica capacità causativa che deriva dalla volontà divina ma che è da Dio
distinta, cosicchè Dio rimane incontaminato. L'immagine usata da Platone nel Timeo
per esprimere questa potenza auto-organizzativa della natura è quella dell'anima
mundi. Riprende quindi Boezio nel differenziare eternità (Dio, le cause divine) e
perpetuità (le cause seconde e la materia) per evitare di confondere Dio e la stessa
anima del mondo con il creato. !
d) LA CONOSCENZA DELLA NATURA È ESPLICITAMENTE FINALIZZATA A
PRODURRE UN’INTELLIGENZA COSMOLOGICA DEL DIVINO CAPACE DI
CONFORTARE LA VERITÀ DEL DOGMA RIVELATO, da non intendersi come
un’alternativa al sapere cristiano.!
e) la visione del creato: riprendendo la dottrina aristotelica dei quattro tipi di cause
possibili, Guglielmo enuncia la sua visione del creato:!
!1)!La causa efficiente, prerogativa della persona del Padre, la causa prima che
fa sì che tutto ciò che è ed è stato sia e sia stato;!
!2)!La causa formale, il Verbo, che palesa la sovrapponibilità delle idee
platoniche con l'Intelletto divino; ?!
!3)!La causa finale, lo Spirito Santo in quanto Bontà divina perseguita da tutto il
creato;!
!4)!La causa materiale, che, non potendo essere caratterizzata come divina,
consiste con ciò che è effettivamente materiale, ossia i quattro elementi. !
f) il rapporto tra philosophia mundi e theologia: tra philosophia mundi e theologia
non c'è mai contraddizione ma feconda continuità. Il fatto che i filosofi antichi
considerassero impossibile la creazione ex nihilo da un punto di vista naturale
conferma la loro competenza, in quanto effettivamente non è possibile in natura,
proprio perché non essendo stati informati dalla Rivelazione, non erano in grado
di comprendere che la causalità divina sia superiore ad ogni legge fisica e logica.
Tuttavia la scienza può chiarire, mai contraddire, la verità della fede, proprio
perchè quello della fede è un altro ordine di verità rispetto a quello della scienza. !
!
c)Teodorico di Chartres e la physica della creazione!
Pagina 36 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
Teodorico, allievo di Bernardo, divenne Cancelliere della scuola di Chartres dopo
l’abbandono di Gilberto. La tipica metodologia chartriana (rivisitazione e collegamento
della riflessione teologica con le testimonianze dei filosofi del passato) ritorna anche in
Teodorico e nel suo tentativo di spiegare più dettagliatamente i sei giorni della creazione. !
a) La filosofia naturale è appunto a suo parere la sola prospettiva corretta per
comprendere il rapporto tra la Creazione e il suo Creatore. Nella sua indagine
Teodorico riprende anche da testi magico-esoterici come i trattati di Ermete
Trismegisto, forte della convizione che la sapienza umana sia il risultato della
somma dei progressi compiuti dalla ragione nella comprensione scientifica della
natura. !
b) no differenze metodologiche tra le scienze: a differenza di Gilberto Porretano, egli
tende a ridurre le differenze metodologiche tra le scienze, sostenendo che siano
tutte esplicitazioni dell'unica veritas divina e subordinate a un unico comune
procedimento argomentativo. !
c) Il metodo di Teodorico consiste in due momenti, la compositio, mediante la quale si
riconduce il molteplice all'unitarietà del vero, e la resolutio, che segue l’articolarsi
dell’unità primordiale lungo una graduazione dei principi intermedi, fino agli individui. !
d) le rationes primordiali: Posta l’impossibilità di giungere fino al principio divino,
obiettivo finale della ragione si risolve nelle rationes primordiali, cause formali che
presiedono all’intera articolazione dell’essere reale e alle quali deve essere
ricondotta ogni verità riconoscibile dell’intelligenza umana.!
e) dimostrazione dell’esistenza di Dio: Teodorico, nell'Hexameron, dimostra
razionalmente, da un punto di vista squisitamente matematico, l'esistenza di Dio:
come il molteplice presuppone il semplice, i numeri presuppongono l'unità e così
via, così l'universo si risolve in un universale rinvio di ogni esistenza al principio
indistinto e immutabile di cui tutto è partecipazione, l’Uno, che produce l'infinità dei
numeri e dunque “non ha alcun limite alla sua potenza”. Tutte le cose sono in Dio in
quanto unità, e questo giustifica l'esistenza in Dio delle idee, modelli eterni di tutto il
reale. L'UNITÀ MOLTIPLICATA PER SE STESSA PRODUCE ANCORA L'UNITÀ, E
D U N Q U E L A M O LT E P L I C I T À I N D I O N O N È A LT R O C H E U N I T À
ESPONENZIALE. !
f) la trinità: L’unità identica a se stessa è il Padre, la conoscenza della molteplicità
nell'unità è il Figlio e la presenza operante dell'unità nella molteplicità è lo Spirito
Santo. Il Padre è la potentia, il Figlio è la sapientia e lo Spirito Santo è l'anima mundi
in quanto principio della formazione del molteplice. !
g) vs la deitas di Gilberto: Teodorico è tra i partecipanti del concilio di Reims che ha
condannato Gilberto e rifiuta la distinzione tra Deus e deitas difesa dai Porretani, in
quanto la semplicità divina è garantita dal fatto di essere non formata da altro, e
dunque non è possibile alcuna distinzione tra formato e formante. L’esistere di Dio
è il puro atto di essere, “ego sum qui sum”, che esprime in sé l’identità assoluta
logica e ontologica di esse e quod est.!
!
Teologia e spiritualità cistercense: Bernardo di Clairevaux!
Intro: Storicamente noto per l'energia profusa nel reclamare la seconda crociata contro i
Turchi, Bernardo di Chiaravalle fu un uomo considerato alla stregua di un papa per la
sua rilevanza come guida spirituale. 1- Per lui, L'OBBIETTIVO DEL SAPERE È LA
SALVEZZA DELL'ANIMA: l'opinione è foriera di dannazione e l'errore più grave è
distaccarsi dalla verità della Rivelazione. 2- Molte sue opere testimoniano l'impegno per
la riforma ecclesiastica. !
Pagina 37 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
a) la pietas: Secondo Bernardo non c’è possibilità di vera fede senza amore per
l’oggetto del credere e non c’è altro oggetto d’amore più degno di essere amato
della verità rivelata. La sintesi di amore e fede non può che risolversi in una
riconduzione radicale di tutti i saperi e le aspirazioni umane alla pietà religiosa, che
è l'unico tramite di congiunzione dell'uomo alla Verità. !
b) inutilità delle scienze: tutto ciò che non conduce alla verità superiore della Bibbia
non è necessario alla salvezza e può tradursi in un danno per l'anima, se distrae
dalla vera scientia, lo studio della Bibbia, dei Padri e della tradizione della Chiesa.
La ragione deve chiarire ed esporre, non indagare. Secondo lui ogni sforzo di
formulare “nuove” questioni teologiche è nocivo e improduttivo; infatti “non
dobbiamo cercare contese di parole” poiché tutto ciò che si deve fare è interpretare
la Bibbia e chiedere lumi ai Padri, poiché “non siamo certo più saggi di loro”. !
c) interesse per la mariologia: Bernardo si interessò molto alla mariologia; i dogmi
mariani sono da lui penetrati nella loro intima verità non per tentarne chiarificazioni
concettuali, ma per presentare la Vergine come modello assoluto della vita
monastica. Maria è stata depositaria e custode di tutte le virtù che accostano
l’uomo, attraverso il perfezionarsi dello stato monastico, alla condizione della
beatitudine eterna.!
d) il culmine della conoscenza teologica: la conoscenza teologica si risolverà in uno
stato di contemplazione mistica della verità che soltanto la fede fa comprendere e
interiormente rivivere nell’anima del credente. Al termine del raggiungimento delle
virtù monastiche, è promesso all’anima l’incontro diretto con l’oggetto della sua
speranza. E il traguardo sarà la totale disponibilità dell’anima a godere dell’oggetto
amato e fondersi con esso, a essere deificata. !!! !
!
Giovanni di Salisbury!
a) il probabilismo: la proposta filosofica di Giovanni di Salisbury consiste nel dare nuova
vita, nel mondo cristiano medievale, al probabilismo filosofico raccomandato da
Cicerone. Di particolare rilievo è la considerazione che tale proposta sia emersa come
esito di una lunga esperienza formativa giovanile in cui l'autore ha avuto modo di
assaporare l'insegnamento di quasi tutte le figure di maggior rilievo nel panorama
intellettuale del dodicesimo secolo. Allievo di Guglielmo di Conches e di Teodorico di
Chartres, ammiratore di Gilberto di Poitiers e di Bernardo di Chiaravalle, fu segretario di
Tommaso di Canterbury prima che questi fosse assassinato. Esiliato in Francia a Reims,
durante la fase più accesa del contrasto tra Enrico II e la Chiesa, nel 1176 è stato
nominato vescovo della città di Chartres, dove è rimasto fino alla morte. !
b) riforma dei principi: a causa delle sue drammatiche vicende biografiche, Giovanni si
concentrò molto sul versante etico-pratico della riflessione filosofica, componendo così il
Polycraticus, dedicato a Becket: un manuale per l'educazione e la riforma morale dei
principi terreni, ispirato alla solida concezione etico-politica che deriva dalla sapienza
pratica cristiana. Come obbiettivo dell'intera attività intellettuale umana Giovanni pone il
perfezionamento pratico. !
c) la logica tende al verosimile: prendendo le distanze da tutti coloro che considerano
compito della logica assicurare il possesso di conoscenze incontrovertibili sulla base di
prove (probationes) necessarie, Giovanni considera la logica e la scienza tanto più vere
quanto più riconoscono che il proprio compito consista nell'avvicinarsi ad una
probabilitas, una verosimiglianza di qualcosa che non potrà mai essere colto in maniera
definitiva (“MI RITENGO SODDISFATTO SOLO DA CIÒ CHE È PROBABILE”). !
Pagina 38 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
d) la polemica vs cornficientes: la sua polemica è aspra anche e soprattuto nei confronti
dei cornificientes (seguaci di un maestro non meglio identificato chiamato con lo
pseudonimo di Cornificio) che, sostenendo l'insufficienza della logica, riducono, secondo
Giovanni, l'efficacia del linguaggio ad un semplice formalismo verbale, facendo leva,
cioè, sull'incapacità delle parole di rispecchiare le cose reali. Giovanni vede messa a
rischio anche la stessa moralità: per contrastare i cornificientes, Giovanni si pone al
seguito dei suoi maestri, da Anselmo ad Abelardo, da Gilberto agli chartriani, e attacca
battaglia in difesa della teologia cristiana. DIFENDERE LA LOGICA SIGNIFICA
DIFENDERE LA CAPACITÀ SIGNIFICANTE DEL LINGUAGGIO, e per farlo è
necessario comprenderne la vera natura: la logica per essere rigorosa deve svilupparsi
fino a ricoprire l'intera conoscenza delle regole della costruzione del discorso. Giovanni
amplia il proprio orizzonte mediante l'Organon aristotelico, i Topica e gli Analitici
Secondi. (?)!
e) la concezione aristotelica della dialettica: Giovanni intuisce che il termine dialectica è
stato snaturato a tal punto da essere esteso all'intero campo di significato della logica,
mentre in origine indicava solo una delle tre possibili articolazioni dell'arte della
dimostrazione, ovvero la scienza della dimostrazione probabile, che si occupa della
correttezza formale di un'argomentazione senza considerarne la corrispondenza con la
realtà; Aristotele aveva inoltre individuato la scienza della dimostrazione necessaria
(l’apodittica), che studia il ragionamento non soltanto dal punto di vista della correttezza
ma anche della veridicità; e la scienza della dimostrazione imperfetta, (la sofistica) che
insegna come l'errore nasca dalla trasgressione delle regole dell'apodittica. !
f) la distinzione di Giovanni: Giovanni distingue la prima articolazione, quella della
scienza dell'argomentazione probabile, in rhetorica e dialectica. L’argomentazione
probabile dialettica è così distinta da quella retorica, ed è legittimamente considerabile
come argomentazione probabile che tende al vero, pur non essendo mai in grado di
raggiungerlo in forma definitiva. La distinzione di Giovanni implica che tutte le ricerche
umane sulla verità delle res dovranno essere regolate solo dalle leggi della dialectica in
senso stretto, che, essendo scientia probabilis, fa sì che la scienza del reale sia sempre
scienza del probabile. !
g) la questione degli universali: Un esempio della vanità di ogni argomentazione che
pretenda di essere necessaria, dove il necessario è noto solamente a Dio, è dato per
Giovanni dalla questione degli universali: è infatti per lui un falso problema, per cui “si è
già sprecato più tempo di quanto i Cesari ne abbiano impiegato per conquistare il
mondo”, in quanto la presunzione umana di ipostatizzare in un'entità metafisica come
“concetto”, “immagine” o “voce” ciò che è soltanto per noi un oggetto di intellezione, un
atto della mente con il quale ci sforziamo di accostarci alla verità, in sé eterna ed
immutabile, non può che portare ad una verità mutilata. La questione degli universali è,
insomma, priva di soluzione. Dunque le risposte ad ogni quesito non potranno che
essere incomplete, e questo vale per ogni singola quaestio (?): quale sia la natura
dell'anima, cosa sia la vita eterna, quale sia il modo di essere degli angeli, e gli stessi
misteri della fede sono tutti problemi destinati a rimanere nella loro premessa
misteriosità e insolubilità. !
h) l’importanza della fede: la fede cristiana, corroborata dalla Rivelazione, si pone in una
posizione intermedia tra la scienza umana e la scienza divina. Per questo motivo, però,
la scienza della Rivelazione è la regina delle scienze, perché consente agli uomini di
conoscere adeguatamente le verità che solo Dio conosce. Solo lasciandosi guidare dalla
fede, l'intelligenza umana può passare dall'universo concettuale alla ratio e contemplare
finalmente le rationes divinae di ogni cosa. !
Pagina 39 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
!
L'incontro con il pensiero greco-arabo ed ebraico!
La storia del pensiero medievale in fondo è la storia delle tante translationes studiorum,
che potremmo considerare come un'unica translatio continua. A partire dai lavori di
Boezio, la cui traduzione di Aristotele ha consegnato ai secoli successivi l'unico contatto
diretto con questo filosofo, il più grande avvenimento culturale avviene a partire dal
tredicesimo secolo, ed è stato l'esito di precedenti translationes di sapienza filosofica,
avvenute in epoche diverse, prima sotto la civiltà sasanide (224-651), l'ultimo impero
persiano pre-islamico, e poi nella cultura islamica stessa. !
a) l’esodo degli ultimi neoplatonici nei territori islamici: dopo la chiusura della scuola di
Atene per ordine di Giustiniano, nel 529, gli ultimi neoplatonici (come Simplicio o
Damascio) trovarono rifugio nella città mesopotamica di Harran, dove continuano i propri
studi, specialmente su Aristotele e Platone. Con la conquista araba della Siria e della
Persia, l'Islam viene a contatto con questi filosofi pagani e si avvia una fervida opera di
traduzione, spesso con il doppio passaggio dal greco al persiano e dal persiano
all'arabo. Quest'opera si estese anche ad altri ambiti, come l'astronomia, la matematica
e la medicina. Tuttavia questo sapere rimase riservato ad una élite di studiosi, a causa
della diffidenza con cui veniva vista la contaminazione della verità rivelata e una
sapienza estranea. Nel mondo islamico si viene a creare una profonda differenza tra la
riflessione filosofica e i contenuti della fede, diversamente da quanto avvenuto nel
mondo latino in cui i due aspetti si compenetrano e si completano l'un l'altro, tant'è che il
nome arabo per la ricerca razionale, falsafa, risulta grecizzante, per marcare questa
differenza: intelligere e credere sono dunque profondamente separati.!
!
La teologia islamica o kalām!
!
a) il kalam: Dal momento che la religione professata da Maometto si presenta come
accessibile a tutti e non interpretabile, il nome di “teologia” islamica risulta
inappropriato: la fede infatti non è complicata da misteri che possano suscitare
dubbi nei fedeli. Il sapere teologico islamico, che ha il nome di kalām, è un'apologia
della verità rivelata e della Legge in essa contenuta e il suo principale oggetto è la
pura comprensione del fondamento dell'unità divina, tawḥīd. Essa prevede
dimostrazioni ed argomentazioni fondate non su strumenti esterni ma solo sul testo
sacro: nata in un paese, l'Arabia, privo di una tradizione culturale, la fede islamica si
è sviluppata in maniera autonoma. !
b) il confronto con le altre religioni: Il rapporto del kalām con le altre religioni è marcato,
da un punto di vista strettamente culturale, da una predisposizione al confronto.
Religione universale, come il cristianesimo e a differenza dell’ebraismo, è
caratterizzata fin dall'inizio da un totalitarismo politico in cui il regime temporale è
indistinto dalla guida spirituale. La jihād (che letteralmente significa l'impegno
personale nella diffusione della Parola) è vista effettivamente come una “guerra
santa”, la quale deve però favorire le condizioni socio-politiche per la conversione, e
non ottenerla necessariamente con la forza. Nei confronti delle Genti del Libro (ahl
al-kitāb), considerati cattivi credenti ma superiori ai politeisti, lo stato musulmano si
atteggia a una relativa tolleranza, purché si accetti di essere sottomessi da un punto
di vista anche giuridico e di non esercitare proselitismo. In un primo momento
questo si è tradotto in una conversione di massa, per poi stabilizzarsi in una relativa
autonomia per i non-islamici. !
Pagina 40 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
c) difesa della propria fede: Il confronto con la mentalità speculativa dei teologi cristiani
e la necessità di difendere la propria fede da infiltrazioni eterodosse ha però spinto i
pensatori islamici ad approntare un sistema di giustificazioni teoriche del kalām:
questo ha portato i teologi musulmani a guardare con interesse agli strumenti
intellettuali non-religiosi che risultassero utili ai propri scopi, e così, dopo la
grammatica e il diritto, si incontrano la logica e la metafisica. !
d) i Mu’taziliti: I teologi che per irrobustire le proprie tesi si servirono coraggiosamente
di strumenti di riflessione provenienti da contesti estranei al Corano presero il nome
di Mu’taziliti, e costituirono un ampio movimento, attivo soprattutto nel corso del IX
secolo. I Mu’taziliti diedero un contributo notevole alla traduzione del kalam in un
organico sistema di conoscenze; furono intransigenti contro i letteralisti, ancorati
ad una lettura semplice del testo e contrari alla sottigliezza speculativa. !
e) al-Ash’ari: Date le tensioni che questo atteggiamento speculativo provocò, fino ad
arrivare all'estinzione dei Mu'taziliti, alcuni teologi moderati, come al-Ash'arī, il vero
fondatore della dottrina teologica dell'Islam ortodosso, favorirono una mediazione
tra l'ortodossia radicale e alcune posizioni del Mu'tazilismo. L'opera principale di al-
Ash'arī, Chiarimento dei princìpi della religione, è una sapiente mediazione tra il
letteralismo “esagerato” e le rigidità dei Mu'taziliti: secondo al-Ash’ari, gli attributi di
Dio sono reali, ma non sono della stessa natura di quelli umani, e il Corano è Parola
increata ed eterna di Dio, ma la sua manifestazione storica, in lettere e inchiostro, è
creata. !
f) la vita di Al-Ghazali: grande esponente del pensiero teologico medievale è Al-
Ghazālī, nato nella Persia orientale; dopo un periodo giovanile di scetticismo, fu
docente a Baghdad, eremita contemplativo in Siria e pellegrino in Palestina e in
Arabia, per poi ritirarsi da eremita nella città natale di Tus, dove è morto in fama di
grande santità. !
g) il kalam per Al-Ghazali: Per lui il fine ultimo di ogni attività umana, kalām incluso, è
la pura contemplazione estatica. Il kalām è per al-Ghazālī la conoscenza che ha per
oggetto Dio, in sé, nei suoi attributi, nelle sue azioni, nei suoi profeti, e che si fonda
su ciò che al riguardo ha insegnato Maometto. Il kalām è inutile per i credenti, che
hanno già la fede per essere salvati, e per gli eretici, per i quali la discussione
razionale alimenta solo l'ostinazione: la sua utilità vale per coloro che hanno
bisogno di mettere al riparo la fede dai dubbi intellettuali. Ha dunque un valore
curativo, come esposto nell'opera significativamente intitolata La vivificazione delle
scienze della religione. Tuttavia, al-Ghazālī, forte della convinzione che la parte più
importante della fede sia lo “svelamento”, non comunicabile attraverso libri o lezioni,
rimase contrario ad un kalām fondato su indagini razionali. !
h) l’autodistruzione dei filosofi: La sua opera più famosa è l'Autodistruzione dei filosofi,
in cui polemizza con coloro che considerano la falsafa non uno strumento ma
autonoma conoscenza di verità; al-Ghazali riconosce che la filosofia dei Greci porta
a conclusioni non conciliabili con le verità della religione. Riprendendo un principio
giuridico arabo, secondo cui ogni testo che contiene all’interno una contraddizione è
evidentemente falso, polemizza contro le tesi tra loro discordanti dei filosofi. Nel
libro analizza criticamente venti questioni riguardanti i tre problemi metafisici, ossia
l'anima, il mondo e Dio, e dimostra che la filosofia dei Greci è incapace di
corroborare la fede in quanto giunge a conclusioni da essa totalmente inconciliabili,
mostrando come i temi della filosofia siano invece di spettanza della religione.!
!
la formazione della Falsafa, da al-Kindi ad al-Farabi!
Pagina 41 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
!
a) il sincretismo della filosofia antica: Il principale lavoro svolto dai cultori della filosofia
nel mondo arabo è stato quello di elaborare una lettura sincretistica delle
informazioni provenienti da molteplici fonti greche antiche. I filosofi arabi
conoscevano bene Plotino e Proclo e il Timeo platonico ha favorito anche nell'area
islamica il germogliare dell'idea di una distinzione tra il mondo visibile e il mondo
degli universali. Attraverso il De Anima, proposto da Alessandro di Afrodisia, gli arabi
hanno tratto l’idea della possibilità di INNESTARE LA PSICOLOGIA ARISTOTELICA
A L L’ I N T E R N O D E L L A C O N C E Z I O N E G E R A R C H I C A , D I M AT R I C E
NEOPLATONICA, DELLA DISTRIBUZIONE COSMICA DELLE INTELLIGENZE
CELESTI CHE SI TRASMETTONO LA CONOSCENZA DI GRADO IN GRADO,
IDENTIFICANDO L’INTELLETTO AGENTE DI CUI PARLA ARISTOTELE CON
L’ULTIMA INTELLIGENZA SEPARATA, unitaria per tutti gli intelletti umani, distinta
dai loro intelletti personali e non sottoposta al divenire. Risulta, quindi, una singolare
armonizzazione tra pensiero di Aristotele e pensiero di Platone. !
b) al-Kindi: La maggior parte delle traduzioni di testi neoplatonici proviene dal gruppo
di studiosi guidato da al-Kindi. Lo scritto principale di al-Kindi si apre con
un’apologia della falsafa mirante a evidenziarne la natura di sapere unitario e il suo
scopo è quello di delineare, con l’aiuto della speculazione classica, le fondamentali
conseguenze ragionevoli dell’affermazione teologica del tawhid. !
c) al-Farabi: altro grande filosofo è al-Farabi che ha proseguito il lavoro di
esplicitazione dell’unitarietà di fondo del pensiero filosofico greco; si concentra in
particolare sul problema della spiegazione dell’origine del mondo. Il suo capolavoro
è il trattato sulle Opinioni degli abitanti della città perfetta, orginale rilettura della
Repubblica platonica adattata alla concezione politico-religiosa dell’Islam. !
d) La natura di Dio: Nel pensiero di al-Farabi il Dio-pensiero di Aristotele si fonda
mirabilmente con il Dio-Uno dei Neoplatonici, che in quanto pensiero autosufficiente
non deve pensare altro per essere pensiero, ma sarà pensiero della sua propria
essenza. Il pensiero-unità di Dio produce le molteplici unità derivate. E mentre
l’essenza di Dio è semplicemente e totalmente esistente in atto, tutti gli esseri
derivati esistono in atto solo realizzando in modo sempre incompiuto la loro
essenza: si ha la prima enunciazione della distinzione di essenza ed esistenza.!
e) la derivazione delle cose da Dio: prima realtà creata è l’Intelletto primo, sostanza
immateriale che si distingue da Dio in quanto pensiero che accoglie in sè la
pensabilità di altro da sè, e dunque la possibilità del molteplice. Ogni intelligenza
inferiore a Dio pensa la propria essenza e nel farlo pensa Dio da cui essa deriva,
ma in quanto pensa Dio il suo stesso pensiero diventa principio di emanazione e dà
origine a una ulteriore sostanza intellegibile, che le è inferiore. Vi è dunque un
gerarchico distribuirsi di una serie di perfezioni decrescenti, come esito del
successivo allontanarsi dalla Causa prima, da parte di ulteriori effetti
dell’attività intellettiva; gli intelletti pensano e danno vita ad altri intellegibili e
muovono le sfere celesti. L’ultimo effetto è la materia. !
f) i vari intelletti: anche l’intelligenza umana è sottoposta a una simile degradazione
dinamica dell’efficacia conoscitiva; al-Farabi distingue nell’anima intellettiva:
l’intelletto possibile o passivo, inteso come disponibilità dell’anima a conoscere;
l’intelletto in atto, come operazione di acquisizione di nuove conoscenze; e
l’intelletto acquisito che traduce in rappresentazioni intellegibili e affida alla memoria
tali atti di conoscenza; subordina il funzionamento di queste facoltà all’efficacia di un
intelletto agente o attivo separato, che è l’ultima delle intelligenze separate e agisce
Pagina 42 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
su tutte le anime umane come comune causa efficiente del loro conoscere. Questa
dottrina garantisce l’oggettività della conoscenza vera acquisita dalle singoli menti
umane ed è giustificazione dell’immortalità delle anime individuali, in quanto, a
differenza dell’intelletto passivo, l’intelletto in atto e l’intelletto acquisito sono realtà
intellegibili, non corruttibili. !
!
Metafisica e teologia: Avicenna (Ibn Sīnā)
a) il libro della guarigione: Avicenna è conosciuto nel mondo latino per la sezione
dedicata alla Scienza delle cose divine nel suo Libro della guarigione, tradotta con il
titolo di Metafisica di Avicenna, e notevole importanza per la storia delle scienze ha
avuto anche il suo Canone di Medicina. Il Libro della guarigione è una grandiosa
enciclopedia filosofica e scientifica, una parafrasi degli scritti dei falāsifa, in particolare di
Aristotele. !
b) il passaggio dal non essere all’essere: Avicenna si trova ad affrontare una grande
questione metafisica, ossia il passaggio dal non essere all’essere delle cause
secondarie. Avicenna introduce in teologia la distinzione tra potenzialità e attualità
aristotelica: se Dio è la causa prima, Egli è essere necessario, e quindi necessariamente
in atto. La creatura invece è “ciò che acquisice essere da altro”, e dunque non è
necessariamente in atto. La differenza tra essenza ed esistenza riguarda le creature ma
non Dio: e queste sono caratterizzate da una quiddità-possibile. Dio, non avendo una
quiddità diversa dal suo essere, non ha un genere superiore di cui può essere predicato
e dunque non rientra in alcuna categoria o opposizione. !
c) la definizione di Dio: come i suoi predecessori al-Kindī e al-Fārābī, anche Avicenna
considera Dio puro atto di pensiero: se tutto ciò che non è materia è intelletto, ciò che
necessariamente è puramente non-materia necessariamente è puramente pensiero che,
non dipendendo da alcun oggetto esterno, è unico oggetto della propria intellezione. Dio
non è soggetto a scissioni, al contrario è il termine ultimo del desiderio di tutte le cose. A
differenza di Aristotele, però, Avicenna sostiene che Dio conosca ogni cosa in sé, e non
sia disinteressato come sostenuto dallo Stagirita. Come e meglio ancora che in al-
Fārābī, l'aristotelismo si sposa con il neoplatonismo: Dio non ha “deciso” di creare:
l'emanazione è tanto inarrestabile quanto incondizionata. !
d) la discensione gerarchica: L’essere necessario è il grado supremo dell’essere che per
sovrabbondanza di sè effonde bene, ossia dona l’essere a tutte le cose che sono. La
molteplicità tuttavia non deriva direttamente da lui, ma dal suo primo effetto, un Intelletto
puro, necessario, che produce un secondo Intelletto creato che guardando Dio si vede
necessario, ma, essendo anche possibile, è in grado di relazionarsi all’altro, generando
un'Anima prima, a cui è sottoposto un corpo celeste che si muove di movimento perfetto,
ossia circolare. Questo corpo tende all'Anima, e si genera così, discendendo i gradi
gerarchici, una progressione di intelligenze che conoscendosi dapprima come
necessarie e poi come possibili producono anime e corpi celesti che si muovono verso
le prime. Questa architettura cosmica di mediazioni causali è costituita da dieci intelletti
successivi che generano ciascuno un'anima e un corpo, fino all'ultima emanazione,
quella che governa il cielo della Luna e la cui Intelligenza è l'Intelletto attivo separato,
che fa passare da potenzialità ad attualità le imperfette intelligenze inferiori degli
individui umani. Infine, i corpi visibili sono unicamente possibili e per nulla necessari,
destinati a dissolversi.!
!
L'accordo di filosofia e religione: Averroè (Ibn Rushd) !
Pagina 43 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
Averroè, vissuto in terra iberica, prende le mosse da Avicenna, sostenendo che fosse
necessario spogliare l'opera di Aristotele da ogni contaminazione platonistica e
neoplatonistica, come invece non aveva fatto, secondo lui, Avicenna, che non aveva
rispettato i confini tra teologia e filosofia. Averroè è sostanzialmente un concordista
riguardo fede e ragione, tra comprensione del Corano e analisi razionale della realtà
creata: questo accordo dipende dal riconoscimento reciproco dei rispettivi campi di
azione. !
a) divisione degli uomini: egli divide gli uomini in: fedeli, affascinati dalla retorica;
teologi, che dimostrano in maniera logicamente corretta, ma si limitano a partire
dalle sole parole del Corano; filosofi che invece realizzano vere dimostrazioni che
danno certezza. I falāsifa sbagliano quando intervengono su questioni non
determinabili scientificamente, in particolare riguardo alle dottrine sulla salvezza
ultima dell'uomo. Allo stesso modo, i seguaci del kalām non fanno il proprio mestiere
quando si sostituiscono ai filosofi riguardo alle verità naturali: il fine perseguito da
Dio è condurli al rispetto della sua volontà, non abolire, sostituendole, le indagini
della loro razionalità. I teologi piegano la parola rivelata in favore delle proprie
aspirazioni, senza poterla spiegare scientificamente, e da qui vengono a crearsi le
catastrofi del mondo umano come l'intolleranza, il fanatismo, le guerre di religione.
Ai filosofi spetta il compito di portare la ragione alle conclusioni determinate
necessariamente pemettendo agli uomini di convivere in pace. !
b) il contributo di Aristotele e le sue tesi: Aristotele, per Averroè, ha portato la
razionalità ai suoi massimi livelli, e per questo il suo dire è secondo solo al Corano.
Tuttavia, ha sostenuto anche posizioni gravi, contrarie alla verità della religione:
l'affermazione dell'eternità del mondo e la negazione dell'immortalità individuale.
Razionalmente parlando, Aristotele ha ragione nel dire che, dato che tutto ciò che
esiste, esiste a partire da altro, non possiamo risalire ad un primo momento, dunque
il mondo è eterno. Inoltre scientificamente è assurdo ammettere l’immortalità
dell’anima: la conoscenza individuale avviene nell’uomo grazie all’efficacia
dell’intelletto agente, separato e unico che si concretizza nell’attuazione di un
intelletto speculativo; nella misura in cui è contaminato dall’immaginazione
sensibile, tale intelletto speculativo è mortale. !
c) rapporto tra fede e ragione: dimostrata la veridicità scientifica delle tesi aristoteliche,
Averroè passa a sostenere che queste tesi solo in apparenza contraddicono la
Scrittura: infatti, la vera scienza e la vera teologia non sono mai contrastanti.
L'uomo, pur avendo riconosciuto come necessarie alcune verità, deve accettare la
fede, per la sua salvezza: SE LE VERITÀ SCIENTIFICHE CONTRASTANO CON
LA RIVELAZIONE È PERCHÉ DIO HA UNA CONOSCENZA DELLA REALTÀ
SUPERIORE A QUELLA DELL'UOMO. SE LA RAGIONE NON RAGGIUNGE
ALCUNE CONCLUSIONI È PERCHÉ LA VERITÀ È INESAURIBILE O PERCHÉ
L'UOMO NON È IN GRADO DI INDIRIZZARLA CORRETTAMENTE. Il pensiero di
Averroè consta dunque di tre dottrine specifiche: la necessità dell'essere; l'eternità
del mondo, corollario della dottrina della necessità dell'essere, il cui ordine non può
essere infranto; la dottrina dell'intelletto, per cui Averroè separa dall'uomo sia
l'intelletto attivo, reso divino già da al-Kindī e da Avicenna, sia l'intelletto potenziale,
unico per tutti gli uomini. La sua dottrina fu erroneamente interpretata come una
“doppia verità”.!
!
Il pensiero teologico e filosofico ebraico
Nonostante la diaspora, la comunità ebraica è riuscita a mantenere una base teorica
Pagina 44 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
grazie alla solidità della cultura rabbinica: un elemento fondamentale di coesione è stata
la redazione, a partire dal III secolo d. C., del Talmud, una illustrazione articolata della
Legge ebraica, la Torah, nel suo insieme e nelle sue applicazioni nella vita quitidiana. !
a) la prima fase + Sefer Yezirah: nella prima fase della speculazione talmudica, i
rabbini si sono astenuti da speculazioni sul divino, sulla creazione e sul destino del
mondo, per concentrarsi sull'aspetto giurisdizionale e narrativo della lettera della
Scrittura. Una prima riflessione sulla creazione si trova nel Sefer Yezirah, il Libro
della creazione, in cui sono esposte le 32 Vie della sapienza, princìpi formali che
traducono negli effetti l'atto divino, costituite simbolicamente dall'insieme delle
ventidue lettere dell'alfabeto ebraico e dalle dieci Sefirot, numeri primi mistici
corrispondenti alle dieci “parole” o “frasi” pronunciate da Dio nella Genesi. Le
trentadue vie sono i cardini dell'universo creato, poiché sono ciò che Dio ha scelto
per comunicarsi agli uomini: come la Bibbia è composta da lettere e numeri, così
l'universo è governato e organizzato da questi princìpi eterni, emanati da Dio. Il
Libro della creazione introduce nella riflessione teologica ebraica un primo
segno dell'aspirazione ad armonizzare i procedimenti con cui la ragione
studia la realtà e i misteri della Rivelazione. Come per l'Islam, l'approfondimento
razionale è necessario per attuare una difesa della fede dalle difficoltà dovute alla
diaspora e all'incontro con l'Islam stesso. !
b) Avicebron: la più importante testimonianza del platonismo teologico ebraico è un
dialogo tra Maestro e Discepolo, intitolato il Libro della fonte della vita, in latino Fons
vitae, scritto da Avicebron, in età moderna identificato con un poeta di Saragozza,
Shelomoh ibn Gebirol. La sua produzione poetica è esplicitamente di ispirazione
religiosa, mentre il Fons vitae è privo di citazioni bibliche, dunque è una
glorificazione di Dio puramente razionale. La materia universale e la forma
universale sono le prime creature, dalla cui unione scaturiscono tutte le realtà
composte: l'Intelletto, l'Anima, divisa in razionale, animale e vegetativa, e la Natura.
Questa concezione assume in Avicebron il nome di ilemorfismo universale: ogni
sostanza diversa da quella divina è il risultato dell'unione della forma universale e
della materia universale. La Volontà di Dio è la fonte della vita, la realtà ultima a cui
tutto tende. !
c) Mosè Maimonide: altro grande pensatore ebraico, nonchè medico e giurista presso
la corte di Saladino, fu Mosè Maimonide che scrisse in arabo e vide quasi
immediatamente tradotta in ebraico il suo libro La guida dei perplessi. I “perplessi”
sono gli interpreti della Bibbia che, avendo studiato le opere dei filosofi, non sanno
orientarsi nella costruzione della propria fede: in loro aiuto l'autore appronta una
sintesi di tradizionalismo talmudico, teologia rabbinica e riflessione filosofica greco-
araba, il cui scopo è educare i credenti a non perdere di vista i princìpi della
fede, ascendendo verso il significato allegorico del testo sacro. La premessa
necessaria ed indimostrabile di tutto il pensiero umano è che la Torah sia un dono
certo, libero e assoluto di Dio, storico in quanto compiuto sul monte Sinai. Tutto ciò
che la ragione può fare segue da questa premessa fondamentale: anziché fare
filosofia per poi sforzarsi di concordare le proprie conclusioni con la Bibbia,
OCCORRE FAR SCATURIRE LA FILOSOFIA DALLA BIBBIA. In sostanza,
“Aristotele non si è ingannato per tutto ciò che esiste al di sotto del cielo della Luna”,
ossia non sbaglia riguardo ciò che rientra nel suo ambito di competenza, la realtà
fisica visibile. Tuttavia la ragione naturale è debole, e deve farsi guidare dalla
Bibbia, utilizzando le conoscenze da essa derivata per verificare ogni passo
compiuto: Maimonide inserisce nella teologia negativa ogni considerazione
Pagina 45 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
scientifica sulla realtà della divinità. Al culmine della scala delle scienze c'è la
filosofia, in grado di intuire “l'esistenza dell'Essere primo che dà esistenza a tutto ciò
che esiste”: al di sopra di sé, la filosofia trova il proprio coronamento, che coincide
con l'inizio dell'ascetismo e della vera vita religiosa, poiché, conoscendo Dio, l'uomo
è in grado di amarlo.!
d) La Cabbala: con Maimonide la speculazione filosofica ebraica tocca il suo vertice, e
come alternativa a questa emerge sempre più la tradizione mistico-esoterica della
Qabbalah. La Cabbala, i cui inizi sono testimoniati dalla stessa composizione del
Libro della creazione, è una tradizione in senso proprio, cioè una dottrina trasmessa
nei secoli che ha come centro le singole lettere della Scrittura e soprattutto i Nomi di
Dio: la creazione, la contemplazione mistica, il ruolo dell'uomo nell'ordine cosmico
sono tutti temi scaturiti dalla sapienza di Mosè e degli altri profeti. Questa tradizione
è poi mutata per incalcolabili interferenze gnostico-magiche, fino a stabilizzarsi in un
modello classico, scritto probabilmente da Moseh di Leon nel XIII secolo. Questo
modello è un commento mistico al Pentateuco, da cui emergono i precetti
fondamentali che accompagnano l'uomo nell'unione con Dio. Grazie alla sua forte
valenza simbolica, la Cabbala ha resistito, essendo opposta ad ogni speculazione
razionale, al peso del tempo e ha continuato nei secoli ad ispirare gli esegeti.!
!
L’introduzione del pensiero greco e arabo-ebraico in Occidente: le traduzioni
latine!
1- La “marea crescente dell'aristotelismo” è stata in realtà un complessissimo intreccio di
relazioni e influssi, all’interno del quale le dottrine scavalcavano i confini politici e
religiosi delle diverse civiltà, il cui flusso crescente inizia dalla metà del dodicesimo
secolo, intensificandosi nei decenni di passaggio tra il dodicesimo e il tredicesimo secolo
e continua poi lungo tutto l’arco del tredicesimo. 2- I traduttori, dapprima in Sicilia, poi in
Spagna e in Francia meridionale, riversarono i propri lavori nelle biblioteche di tutta la
latinità, di modo che il nuovo sapere non fosse solamente filosofico o teologico, ma
fosse invece un sapere scientifico complesso, costituito tanto da opere originali quanto
da commenti. !
a) Toledo: in particolare da Toledo il lavoro di traduzione è ampio: molteplici sono le
traduzioni letterali dall’arabo, utilizzando la tecnica di collaborazione di due persone,
uno che traduceva dall’arabo al volgare, uno dal volgare al latino colto. Partendo
dalle opere di al- Kindī e al-Fārābī, si arriva fino ad Alessandro di Afrodisia e
Avicenna, le opere del quale insieme al “Fons vitae” di Avicebron furono tradotte da
Domenico Gundislavi. !
b) Gerardo da Cremona + Michele Scoto: tra i tanti traduttori forse il più influente fu
Gerardo da Cremona, che tradusse opere greche, arabe ed ebraiche completando
la traduzione latina dell'Organon e mostrando così ai lettori che Aristotele proponeva
una teoria della scienza come rigorosa dimostrazione a partire da premesse
necessarie e avente sempre oggetti universali. Infine, dopo le traduzioni del Menone
e del Fedone, tuttavia non circolati in maniera significativa, lo scozzese Michele
Scoto traduce i commenti di Averroè. Grazie alle opere di traduzione, il sapere
circola e si compenetra nonostante le diverse aree di provenienza e confessioni
religiose, creando così un florido terreno di confronto per gli studiosi di quei secoli.
Si intensificano inoltre i contatti diretti con l’Occidente Greco e i viaggi a
Costantinopoli di intellettuali filosofi e traduttori latini in cerca di testi originali.!
Pagina 46 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
La nascita delle Università!
a) Parigi: 1- Il nome di universitas studiorum risale all'inizio del secolo XIII per indicare
una realtà, all'inizio propria della città di Parigi, in cui il confluire di diversi istituti
diede vita ad una sorta di città scolastica e in cui la diversificazione delle
competenze dei maestri diede vita a diverse facultates (“possibilità” di scelta). Tra le
varie facoltà troviamo la Facoltà delle Arti liberali, di Diritto, di Diritto canonico, di
Medicina e di Teologia, ciascuna con i propri testi di riferimento (Aristotele,
Giustiniano, Graziano, Ippocrate, Il liber sententiarum del Lombardo). 2- L’università
era una istituzione fortemente comunitaria, in cui le iniziative personali erano assai
ridotte. Il Cancelliere era l'autorità principale, rappresentante del vescovo nella
scuola, e i suoi compiti principali erano quelli di tutelare lo svolgimento regolare
della didattica ed equilibrare i dissidi interni.
!
b) gli scontri del 1200: In seguito a scontri, nel 1200 Filippo Augusto stabilì che gli
studenti e i docenti delle scuole di Parigi dovessero essere giudicati solo da autorità
vescovili o universitarie, e nel 1215 si arriva alla solenne approvazione dei primi
statuti ufficiali dell’Università di Parigi da parte del cardinale Roberto di Courçon,
legato di Innocenzo III. Influenti saranno anche Oxford, da cui si staccherà
Cambridge, come Padova da Bologna, e Napoli (la prima fondata dal potere civile) e
anche nel resto d'Europa vengono aperte numerose università. !
c) lo studium curiae: Nel 1245 Innocenzo IV apre lo studium curiae, specificatamente
dedicato allo studio della teologia. Lo studente medio entrava verso i 14-15 anni
obbligatoriamente nella Facoltà di arti liberali, che frequentava per quattro anni, al
temine dei quali i migliori venivano promossi al grado di baccalaureatus e potevano
tenere lezioni integrative e decidere nelle quaestiones; il grado più alto della
formazione era comunque la Teologia, al termine del cui studio il maestro riceveva
la licentia ubique docendi, ossia di insegnare in qualsiasi Università del mondo
cristiano.
Philosophi e Theologi!
1- Gli scontri sulla legittimità del proprio insegnamento scaturirono dall'incontro della
Facoltà di Teologia con quella delle Arti, a cui va aggiunto che fu quest’ultima la prima
depositaria dei nuovi testi provenienti dalla sapienza greco-araba. 2- Il risultato di questo
processo fu una riapertura, più drammatica, del problema del rapporto tra fede e
ragione. !
a)La pretesa degli artistae: 1- Poiché gli stessi artistae fecero un salto di qualità nelle
ricerche scientifico-filosofiche è evidente che per questo motivo si sentirono autorizzati a
sconfinare con le proprie indagini dall'ambito della natura a quello del soprannaturale. 2-
Gli artistae si sentirono inoltre autorizzati a imporre le regole fondamentali che ogni altra
disciplina, compresa la teologia, è tenuta a rispettare se vuole che ai suoi enunciati
venga riconosciuto valore scientifico.!
b)la risposta dei theologi: Si spiegano così le prime plateali prese di posizione dei
theologi, non soltanto riguardo le nuove fonti della scienza e del corpus aristotelico, ma
in particolare nel metodo di utilizzo di queste fonti. Nel 1210 fu vietato l'utilizzo, sotto
minaccia di scomunica, dei libri di filosofia naturale di Aristotele, per poi, con Roberto di
Pagina 47 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
Courçon, nel 1215, vietare anche la Metafisica, senza però proibire l'insegnamento delle
arti liberali: l’obbiettivo della censura non era l'aristotelismo in quanto tale, ma solo il suo
utilizzo in ambito teologico. Come conseguenza dei propri studi di arti liberali, tutti i
maestri di teologia conoscevano quelle discipline, e faticavano ad allontanarsene. !
c) l’ammonimento di Gregorio IX: nel 1228 papa Gregorio IX richiamava i teologi a non
“travalicare i confini fissati dai Padri”, invitandoli a “ricondurre tutte le dottrine a quella
regina” e a non comportarsi come teophantes, ciarlatani che spacciano vane opinioni sul
divino. La ripetuta censura dei testi aristotelici, in seguito riadottati ma solo dopo
un'epurazione dei concetti erronei, fornisce un quadro chiaro di quale fossero i pensieri
di chi aveva a cuore la cultura cristiana. I teologi cristiani aspiravano sì ad una
distinzione tra gli ambiti, ma comunque inseriti in una scala gerarchica, al cui vertice non
può che trovarsi la teologia. !
d) gli scontri del 1229: 1- nel 1229 ci fu una sospensione delle lezioni dovuta a scontri
tra cittadini e studenti, al termine della quale tutto il corpo docenti si unì per la libertà di
insegnamento. 2- Per risolvere la questione lo stesso Gregorio IX invitava i docenti a
fornirsi di propri strumenti: si fecero strada l'idea della fondamentalità della lectio biblica,
principio di ogni ulteriore acquisizione del sapere; l'idea, diffusa da Gilberto e dai
porretani, che in ambito teologico dovesse venire attuata una transumptio dei termini; e
l'idea, di origine abelardiana, che i contenuti della fede potessero essere organizzabili in
una struttura architettonica sistematica.!
I primi maestri secolari
Con “maestri secolari” si intendono quei maestri laici, non appartenenti a ordini
monastici. !
a) la rivalità con i mendicanti: per fronteggiare la rivalità ideologica dei Mendicanti, i
quali miravano a ricondurre i principi ispiratori della loro forma vitae nella
sistemazione del sapere teologico, si impegnarono per realizzare una sintesi tra
fede e ragione nell'ottica di una salvaguardia della coerenza interna dei propri
insegnamenti. !
b) l’importanza della fede: L’innesto della speculazione filosofico-scientifica nel
programma universitario veniva considerato imprescindibile per un percorso di
conoscenza finalizzato al possesso di un sapere sistematico. Guglielmo di Auxerre
approfondisce una teoria di Simone di Tournai, il quale affermava che in Teologia il
principio fondante della vera conoscenza è una “fede che genera razionalità”.
Guglielmo, partendo dall'affermazione di Paolo secondo cui la fede sarebbe un
“argumentum delle cose che non appaiono”, ritiene che convertire gli haeretici e
orientare i simplices siano parti costitutive di un discorso teologico, contrapposto a
quello della filosofia e finalizzato ad un maggiore avvicinamento dell'anima credente
ai misteri divini. !
c) Il loro merito: Il merito dei secolari parigini è di aver portato la concezione antica
della razionalità, posta al servizio della fede, alle nuove precisazioni metodologiche
divenute necessarie in seguito all'apparire di nuove e ancora indomate suggestioni
filosofiche: la ragione ha la possibilità di esporre le grandi problematiche del
pensiero cristiano, fornendo nuove soluzioni in base agli allora recenti sviluppi degli
strumenti filosofici.!
Pagina 48 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
b)La teoria dei trascendentali!
La storia del termine transcendentalia, nonostante lo stesso termine comparve poi per la
prima volta alcuni anni più tardi nella Summa del domenicano Rolando da Cremona,
riguarda molti pensatori della scolastica, tra cui ricordiamo Guglielmo di Auxerre,
Guglielmo di Alvernia, vescovo di Parigi, e Filippo il Cancelliere. 1- Quest’ultimo è stato il
primo a trattare questo tema in maniera sistematica, sostenendo che i trascendentali
siano le “condizioni concomitanti dell'essere”, le nozioni più alte e universali: sia i più alti
tra i nomi divini sia i più generali tra i nomi creaturali. 2- I trascendentali CONSENTONO
ALLA MENTE DI ACCEDERE ALLA COMPRENSIBILITÀ DI CIÒ CHE SIGNIFICA
L’ESSERE. 3- Sono transcendentalia perché rappresentano il confine ultimo della
conoscibilità, al di là del quale c'è, appunto, la trascendenza, ossia l'inconoscibile. Per
Filippo i trascendentali sono ens, unum, verum e bonum; Guglielmo introduce anche il
pulchrum, di derivazione cosmologica dallo pseudo-Aeropagita; essi sono i termini ultimi
e il punto di arrivo di ogni astrazione umana. Guglielmo di Auxerre sostiene la necessità
di pensare l'esse puro come unum, e dalla sua identità con se stesso bonum, e
dall'identità tra unum e bonum fa derivare il verum. 4- In questo modo i maestri secolari
dimostravano che i trascendentali sono presupposti da ogni verità di fede, e quindi
condizionano ogni comprensione della Rivelazione: essi diventano il raccordo tra
teologia, etica e filosofia teoretica; difatti senza la corretta conoscenza dei trascendentali
non è possibile alcuna ulteriore conoscenza particolare. !
I maestri francescani di Oxford: Roberto Grossatesta!
a) l’indagine naturalistica in Inghilterra: In Inghilterra, come già si era visto con
Giovanni di Salisbury, l'attenzione spesso veniva indirizzata verso i limiti della
ragione rispetto alla fede, coniugata con la mancanza di proibizioni riguardo i libri di
Aristotele. Questo ha favorito fin dai primi anni del Duecento il prosperare di una
cultura più improntata all'ambito fisico-naturalistico e della ricerca scientifica
piuttosto che alla dialettica delle Università continentali. !
b) la definizione di scienza degli analitici secondi: in questo ambiente gli intellettuali
entrano a contatto con la definizione di scienza degli “analitici secondi” di Aristotele,
reso più accessibile dalla traduzione dall’Arabo della parafrasi di Temistio da parte di
Gerardo da Cremona: avviata dall'acquisizione di dati sperimentali attraverso i
sensi, deve riguardare i dati universali e non gli accidenti delle singole res, deve
essere deduttiva ed essere una conoscenza per causas. !
c) Il primo commento latino agli Analitici Secondi di Aristotele risale a Roberto
Grossatesta, nel 1230. Roberto, vicino ai francescani senza però entrarne mai a far
parte, corregge l'osservazione aristotelica che la conoscenza si basa sempre sui
dati forniti dalla sensazione, sostenendo che l'Intelletto divino possiede una
conoscenza eterna senza essere sottoposto a esperienza. E' quindi opportuno
superare, integrandola, la posizione aristotelica. Poiché Aristotele aveva ragione a
sostenere che la sola conoscenza certa sia relativa all'universale, è necessario
trasporre ogni sensazione su un piano universale mediante l'astrazione. !
d) vs aristotele e dottrina dell’illuminazione: anziché basarsi sulla dottrina aristotelica
dell'intelletto agente, secondo cui l’intelletto agente astrae in modo univoco per tutti
gli intelletti particolari la forma dei dati sensoriali, il cristianesimo offre una soluzione
Pagina 49 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
più semplice e condivisibile: l'astrazione dei dati empirici deriva dall'illuminazione
divina, e la verità di ogni nozione dipenderà dalla propria partecipazione alla Verità
degli ideali eterni che risiedono nell'Intelletto divino. Tuttavia è insostenibile una
posizione per cui le intelligenze creaturali partecipino dell'indicibile perfezione di Dio. !
e) la matematica: tramtite tra Dio e l’esperienza sensibile: Questo tramite conoscitivo
tra l’illuminazione divina e l’esperienza sensibile è offerto, secondo Grossatesta,
dalla matematica. In matematica ogni dato sensibile viene astratto ad un livello
perfettamente informativo sulla natura dell'oggetto ma rigoroso e necessario. Solo in
matematica, dunque, l'oggetto è il risultato della confluenza tra esperienza e
astrazione consentita dall'illuminazione divina. Ogni conoscenza scientifica deve
essere ricondotta ad una formulazione matematica, che ne assicuri certezza e
necessità. La matematica è vera perché porta sia un'illuminazione informativa, ab
intra, cioè che deriva dal creato, sia un'illuminazione formativa, ab extra, cioè che
deriva da Dio. !
f) la dottrina della luce: 1- sia nel suo Hexaemeron sia nell'esplicito Tractatus de luce,
Roberto sostiene che la luce sia la prima forma di tutte le cose ed è anche principio
di essere; 2- la sua creazione è stata il primo atto compiuto da Dio e da essa ha
avuto inizio la discesa matematicamente ordinata del resto di ciò che è stato creato.
3- Nella semplicità dell’atto luminoso si distinguono tre momenti: la lux, che esprime
la realtà dell'essere, lo splendor, che la diffonde e il fervor, che la riflette
distinguendola dalla sua fonte; 4- è una sostanza semplice e inestesa che si
diffonde per sua propria virtù secondo leggi geometriche e si unisce al secondo
principio, suo opposto, la materia prima, dando realtà all’alterità; con la creazione
del firmamento essa ha dato origine a spazio e tempo e ha segnato i confini
dell’universo. 5- Secondo Roberto, poiché conoscere significa partecipare alla luce
divina, Dio stesso è conoscibile come luce.!
g) il contributo della scienza teologica: se la Rivelazione informa dell'Incarnazione il
lettore, il quale la accetta per fede, Roberto, ispirandosi al Cur Deus homo, sostiene
che la scienza teologica vada più a fondo e comprenda che essa sia stata da
sempre predeterminata nella volontà di Dio, il quale desiderava di unirsi all'uomo fin
dalla creazione di quest'ultimo. Facendo dell'uomo il centro dell'universo, lo ha reso
il suo principale oggetto d'amore, degno di accogliere una persona divina per
portare alla massima espressione la presenza del Creatore; tornando alla Scrittura,
il teologo verifica la presenza dell'Incarnazione in ogni luogo.!
Alberto Magno!
Filosofia aristotelica e teologia cristiana!
La riflessione di Alberto Magno è caratterizzata da 1- un'aspirazione alla
sistematizzazione completa di tutti i migliori risultati del pensiero umano e 2- al
raggiungimento di una coerente e solida metodologia scientifica, comune ai diversi
ambiti. !
a) divulgare Aristotele: in particolare, il suo lavoro si è concentrato nel “rendere
intelligibile Aristotele ai Latini”: egli è infatti uno dei primi, e di questi senza dubbio il
più importante, a ritenere il corpus aristotelico (incluso il Liber de causis apocrifo)
Pagina 50 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
non come un deposito di idee a cui attingere, bensì come un'espressione compiuta
dell'organicità stessa del sapere filosofico, dotata di una propria metodologia, la
logica. Nonostante questa concezione sistematica della filosofia sia orientata da
un’interpretazione ancora neoplatonizzante, favorita dall’influenza di Avicenna,
Alberto è convinto che proprio tale sistematicità sia il pregio fondamentale del
pensiero di Aristotele. !
b) prima studia teologia e poi filosofia: Alberto rappresenta una strana inversione di
tendenza riguardo all’andamento ufficiale degli studi: dapprima maestro di Teologia,
si dedica alla filosofia solo in seguito al suo trasferimento in Germania, da lui
considerata come propedeutica essenziale al sapere teologico. Nel 1259 la dottrina
aristotelica venne imposta come un iter di preparazione al sapere teologico. Alberto
non rinnegherà tuttavia mai il collocarsi della sapienza teologica quale punto di
arrivo di ogni evoluzione intellettuale umana.!
Il sistema filosofico della realtà!
a) La metafisica e la logica secondo Alberto sono entrambe filosofie dei princìpi primi:
mentre la logica, però, li presenta come premesse e contenitori formali delle
successive articolazioni del discorso vero, la metafisica ha il compito di far
comprendere alla ragione le leggi immutabili che governano l’ordine naturale,
esplicitandole come cause naturali senza fare riferimento alla volontà divina. !
b) statuto e limiti della filosofia: la filosofia è presentata da Alberto come indipendente
dal confronto con la fede e ha il dovere di proporsi come scienza vera e autonoma.
Concordemente con Averroè, egli sostiene che effettivamente secondo le leggi della
natura il movimento non ha mai avuto inizio e non avrà mai fine. Gli ambiti sono
dunque autonomi, ma anche separati. La filosofia deve però ammettere i propri
limiti, riconoscendo che un'entità divina possa causare fenomeni per i quali le leggi
della natura si interrompono, di modo che l'universo possa aver avuto un inizio ed
essere posta una fine al movimento, naturalmente inarrestabile. !
c) la realtà del miracolo e il rifiuto delle tesi di Avicebron: ammettendo la possibilità del
miracolo come una interruzione esterna (e non una alterazione come voleva
Lanfranco) della necessità naturale, Alberto consente che l’autonomia della filosofia
sia salvaguardata e che sia messa al riparo dall’errore teologico. Rifiuta l'idea di
Avicebron di un radicale volontarismo divino, che svaluta il sistema di cause
seconde su cui si fonda l'universo di Aristotele. Ma rifiuta soprattutto l'ilemorfismo
universale, poiché scade facilmente nell'immanentismo. Alberto è dunque in grado
di correggere filosoficamente la filosofia, attraverso una critica razionale.!
d) La teoria albertina dell'essere è di carattere neoplatonico; nel “De causis et
processu universitatis” la creazione è considerata un processo di emanazione in cui
le parole-chiave sono quelle di fluxus e di processus. Al vertice del suo sistema,
Alberto pone in Dio l'esse identico al quod est (riprendendo la terminologia
boeziana), ossia Dio è essere originario ma anche ente, e per questo è puro
intelletto e volontà operante. La causalità prima viene trasmessa al creato da una
gerarchia ordinata di cause seconde, intelligenze celesti e, contrariamente a quanto
sostenuto da Avicebron, immateriali. !
Pagina 51 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
e) l’inchoatio formae: per spiegare come avvenga la trasmissione senza alcuna
modificazione del causante, Alberto introduce una specificazione della potenzialità
di Aristotele: l'inchoatio formae, ossia tutta la natura è orientata a realizzare, a
partire dalle proprie potenzialità, una forma dovuta alle cause superiori. Dio
comunica le forme al creato ma non è responsabile del modo in cui vengono
recepite dalla materia. GLI INFLUSSI FORMALI PROVENIENTI DALL’ALTO SONO
INFATTI IN SÉ NECESSARI, MA LA DIVERSA DISPONIBILITÀ DELLE
IMPERFEZIONI MATERIALI LI RECEPISCE E PERCIÒ LI RENDE EFFICACI IN
MANIERA DEL TUTTO IMPREVEDIBILE E CONTINGENTE. !
f) L’universo: L’universo è un sistema di dipendenza dalla causalità di una forma
superiore che agisce in assoluta libertà. La totalità dei rapporti causali è chiamato
fatum.!
L’antropologia e l'ascesa della conoscenza!
a) la dottrina dell’anima: l’uomo è inserito nei processi causali del fatum. L’anima
vegetativa è in potenza nella virtus formativa del seme paterno e viene ad atto per
effetto degli agenti naturali, poi a sua volta l’anima sensitiva è in potenza in quella
vegetativa e si svilupperà non appena il feto avrà formato gli organi adatti. Tuttavia,
la funzione intellettiva non può derivare, come le altre funzioni, soltanto dalla
potenzialità della forma del proprio corpo, perché è dotata di libertà di conoscere e
di agire; di conseguenza la sua formazione in atto è dovuta all'intervento
dell'Intelletto primo, divino, che irradia nell'anima la propria luce. L'anima dunque è
in parte dipendente e in parte autonoma dalle diverse funzioni della corporeità.
L’anima, essendo unita al corpo, che la immerge nell’accidentalità spazio-temporale,
non può contemplare direttamente le forme, come fanno le intelligenze superiori.
L’intelletto agente dovrà dunque sollecitare nell’anima una disponibilità
rappresentativa interiore a ricevere le forme e ad attuarle in atti intellettivi particolari:
questa sua recettività si chiama intelletto passivo.!
b) l’intelletto attivo singolare: Alberto prende le distanze dalla concezione averroistica
dell’intelletto attivo quale universale, optando per una correzione teologica
ammettendo il possedimento di un intelletto attivo singolare, come parte operativa
dell’anima individuale. Conseguente sarà un importante risvolto etico: Alberto invita
gli uomini a liberare progressivamente l'intelletto passivo dai limiti della corporeità
per orientarsi verso quello attivo: solo progredendo dal corporeo all'intellegibile puro
delle forme, da qui alle sostanze separate e infine alla Causa prima potrà arrestarsi
il desiderio di sapere. !
c) il fine della conoscenza: l’esito finale di questa ascesi filosofica è una vera e propria
copulatio dell'anima con Dio. L’antropologia albertina si chiude con una perfetta
coincidenza di scienza filosofica e sapienza religiosa, nel compimento mistico di una
conoscenza che dovrà risultare perfetta sotto tutti e due i punti di vista. Ma tale
compimento è subordinato a un concedersi dell’Intelletto divino.!
Il sistema della verità teologica!
Pagina 52 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
a) Il primo compito del teologo è per Alberto capire in quale modo la discesa della
Verità nell’anima dal principium della fede possa essere considerata come
un’acquisizione di conoscenza inalterabile, come una scientia. !
b) i subiecta della teologia: secondo Alberto ogni scienza è dotata di un proprio
subiectum, inteso come sostrato o contenuto. Per quanto riguarda la teologia,
quest'ultima ha, come subiectum, in primo luogo Dio stesso (subiectum speciale), in
secondo i credibilia, ossia tutto ciò che è oggetto del credere (subiectum
specialiter), e infine, in senso ancora più ampio (subiectum generaliter) la teologia
tratta di tutte le res e i signa contenuti nella Rivelazione. !
c) lo statuto della teologia: a differenza della metafisica in Teologia la causa prima sarà
sia causa efficiente sia fine ultimo. Nonostante la molteplicità di contenuti, la
teologia è scientia una in quanto Dio è causa unica, inizio e fine, e la circolarità del
vero che ne scaturisce assicura una perfetta sistematicità, adattandosi anche allo
schema descensio-reditus, fondamento delle teorie patristiche. !
d) conoscenza della fede = conoscenza del logos: La conoscenza della fede è per
Alberto la conoscenza del Logos, ed è quindi principio di una vera e propria logica
della verità, che consente ai credenti di essere i veri philosophi, il cui fine naturale è
di congiungere l’intellectus umano con il Logos (“doctrina ad perfectionem
intellectus ordinata). !
e) teologia come scientia affectiva: tuttavia non avendo un oggetto conoscibile in
quanto tale come subietcum, ma essendo il suo contenuto un fine verso cui tutto
tende, la teologia sarà una scienza pratica, e soltanto in secondo luogo speculativa,
determinata dal suo essere pratica. Dio sarà conoscibile nella visione beata non
come essenza ma come fine dell'orientamento dell'affetto di ogni creatura. La
contemplazione mistica, esito dell'illuminazione proveniente dalla grazia e al di
sopra della filosofia, orienta e porta a compimento l'intera concezione del sapere di
Alberto.!
Bonaventura di Bagnoregio!
a) cos’è la teologia? Secondo Bonaventura, la teologia è un discorso su Dio, in cui
tutto si risolve in Dio e la manifestazione della sua Verità, la Scrittura, è secondo Dio
e ha Dio come fine. Come insegna Agostino, la verità in sé è Dio, e dunque la
teologia, la scienza di Dio, è la scienza della verità in sé. !
b) i compiti della teologia: la fondazione della teologia di Bonaventura vuole mostrare
come non sia più procrastinabile la missione del vero teologo, ovvero quella di
ricondurre gli uomini dalla sapienza mondana alla sapienza cristiana. Troppi uomini
infatti si sono allontanati da Cristo e dalla sua verità. Il procedimento razionale della
scienza teologica ha un triplice scopo: 1) confondere i nemici della fede 2) ristorare i
credenti deboli 3) dare diletto a coloro che sono già perfezionati nel credere.!
La scienza teologica come reductio ad unum e il suo fondamento scritturale
!
Pagina 53 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
a) reductio ad unum e reductio ad concordiam: 1- Bonaventura da Bagnoregio fu
francescano. Questa scelta è una vocazione che lo spinge costantemente a
dedicare tutto il proprio impegno al servizio dell’ideale della pace universale. 2- La
teologia viene considerata lo strumento più alto per avvicinare gli uomini alla Verità,
per operare la reductio ad unum del sapere e delle volontà. L’Unum è Cristo, che
unisce umano e divino. Prerogativa entro quest’ottica è la reductio ad concordiam,
la riduzione della molteplicità delle tesi all’armonia della Sacra Scrittura. L’unica
certezza difatti a cui si può affidare il teologo è la veridicità della Sacra Scrittura. Per
verificare la validità di una tesi sarà dunque necessario mostrarne la coerenza o la
disarmonia con l'intero sistema della sapienza cristiana. !
b) le quattro dimensioni della Scrittura: a questo proposito la Scrittura si pone come
chiave di lettura della Verità, che è Una, nelle quattro dimensioni della croce, come
afferma San Paolo: lunghezza (la storia sacra), larghezza (le parti di cui si compone
la Bibbia), altezza (le gerarchie pseudo-dionisiane) e profondità (i sensi della
Scrittura: letterale, allegorico, morale e anagogico). !
c) la triadicità delle res: a proposito del senso letterale Bonaventura riprende una
teoria dello Pseudo Dionigi, il quale definisce la più evidente traccia di unitarietà del
vero nella universale composizione di ogni cosa in un’unità di essenza, potenza e
atto. !
d) Il subiectum della teologia è Dio secondo l’essenza, Cristo secondo la potenza, e
l'opera di redenzione secondo l'atto. Una buona metodologia scritturale serve per
facilitare l’accesso della razionalità. !
e) la sintesi tra ragione e fede: il programma di sintesi speculativa tra ragione e fede di
Bonaventura ha come fine principale quello di portare la mente a comprendere
l’efficacia del messaggio salvifico notificato dalla Rivelazione.!
La teologia come determinatio distrahens
1- La meta a cui aspira la teologia è la scientia Christi, come riflesso speculare nella
mente umana della “scienza che ha Cristo”. 2- La lettura mediata del testo biblico ne è il
punto di partenza. !
a) differenze tra lectio e determinatio: nonostante lectio e determinatio abbiano lo
stesso oggetto, ovvero il vero rivelato, la lectio biblica ha come scopo l'illustrazione
ai credenti del vero rivelato, mentre la determinatio teologica ha come scopo una
comprensione scientifica che va oltre la pura enunciazione del credibile, poiché lo
trasforma in un intelligibile per merito della grazia e della ragione umana. !
b) la teologia come determinatio distrahens: il sapere teologico si propone come una
determinatio quodam modo distrahens della Rivelazione, dove distrahens ha il
significato di “ciò che conduce altrove”, cioè la teologia conduce all’intelligibile,
dominio conoscitivo altro rispetto al credibile: se nella lettura della Bibbia il credibile
rimane tale, nella scienza teologica il credibile viene trasformato in un oggetto di
conoscenza intellettuale. !
c) rapporto tra Rivelazione e teologia: nonostante l’intellegibile appartenga a un ordine
altro rispetto al credibile, nell’ ordine epistemologico è proprio la Rivelazione,
Pagina 54 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
fondata su una certezza che eccede ogni razionalità, ad avere il primo posto. La
Rivelazione è “subalternans”, mentre la teologia è subalternata.!
Dalla scientia alla sapientia
a) Le varie scienze: 1- le scienze sono tanto più degne quanto più incidono
nell'esistenza dell'uomo e nella possibilità per quest'ultimo di conquistare la felicità.
L'unica scienza che soddisfi pienamente questo requisito è la scientia Christi, che sola
può essere chiamata sapientia. 2- Le scienze che presumono di poter condurre le
proprie indagini indipendentemente dalla teologia introducono nel sapere la
diversificazione degli obbiettivi e dunque un'imperfezione nei risultati, dal momento che
vanno a contraddire l'unum che irradia la verità.!
b) L’aspirazione conoscitiva dell’uomo: La conoscenza perseguita dai filosofi è
necessariamente imperfetta proprio perchè l’uomo, in seguito al peccato originale, è
stato condannato a una conoscenza indiretta e frammentaria del vero; tuttavia si sente
spinto a realizzare quella conoscenza piena di deiformità che è promessa con la
beatitudine (“carens omni deformitate et habens plenam deiformitatem”); ed essendo
incapace di leggere il liber naturae, non può non leggere il liber scripturae per cogliere la
verità superiore in essa contenuta. Comprendere da filosofo la reale natura dell'uomo
comporta il non poter non essere teologo.!
c) teoria dell’illuminazione: Bonaventura riprende la teoria dell’illuminazione di Agostino
che gli permette di accogliere e perfezionare la dottrina filosofica sulla funzione
dell’intelletto agente, la cui funzione diventa dunque quella di recepire grazie a una
informazione illuminativa superiore e fare proprie le regole fondanti della conoscenza dei
dati particolari. L’illuminazione garantisce l’oggettività della conoscenza, e l’intelletto
agente e quello possibile non sono due sostanze separate, ma due distinte disposizioni
dell’anima.!
d) la filosofia deve essere subordinata alla filosofia: La filosofia può essere riconosciuta
come portatrice di verità, ma solo quando accetti di essere ridotta alla superiore unità
della teologia. Se la filosofia viene abbandonata se stessa, come dimostrato dagli
averroisti che proponevano molteplici “veri” in contrapposizione gli uni con gli altri, la
filosofia è foriera di errori. LA FILOSOFIA HA UN RUOLO SERVILE: prima deve essere
giudicata e corretta dalla fede, solo in seguito sarà strumento utile per rinforzare la fede
stessa. Il sapere profano, in generale, è utile solo se è a disposizione della Scientia
Christi e la vera filosofia, quella francescana, è una critica teologica della ragione.
“L’anima vorrebbe descrivere tutto il mondo entro di sè” ma senza la luce unificante di
Cristo non è in grado di cogliere neanche la verità di una singola cosa.!
e)Platone-Aristotele-Agostino: secondo un famoso passaggio del Christus unum
omnium magister, Bonaventura ritiene che Platone abbia colto l’infinità della verità
trascendente, demolendo il linguaggio della scienze. Aristotele ha ristabilito questa via,
abbandonando tuttavia la via superiore. Entrambi i due aspetti collimano in Agostino, il
migliore espositore della Bibbia.!
d)La teologia speculativa!
a)Le otto Quaestiones disputatae de mysterio Trinitatis propongono, nel più rispettoso
utilizzo della struttura formale della disputa scolastica, un'esemplificazione della
Pagina 55 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
metodologia teologico-speculativa di Bonaventura. La ricerca è in questo luogo affine ad
Anselmo: BONAVENTURA CERCA INFATTI LE RATIONES NECESSARIAE CHE
SOGGIACIONO ALLA FORMULAZIONE DEL DOGMA. Nella prima quaestio
Bonaventura riassume nella sua forma più sintetica, autentica ed essenziale,
l'argomento a priori di Anselmo: “si Deus est Deus, Deus est”. Nella seconda affronta il
tema dell'unità di Dio, dimostrando che non è incompatibile con la trinità; nella terza la
semplicità, nella quarta l'infinità, nella quinta l'eternità, nella sesta l'immutabilità e nella
settima la necessità. Infine, nell'ottava quaestio Bonaventura mostra come fede e
ragione costituiscano un circulus intelligibilis, una circolarità intelligibile. !
b) la nozione di primitas: la teologia speculativa di Bonaventura ha come base un
fondamento intellettivo: la nozione di primitas divina. LA PRIMALITÀ DIVINA È
L'ESISTENZA DELL'ESSERE CHE NON SI PUÒ PENSARE CHE NON SIA CIÒ CHE
È: in Dio coincidono esse ed esse aliquid, presupposto di comprensibilità della
distinzione, invece, di questi due aspetti ontologici in tutte le cose che sono dopo Dio.
Non si può conoscere se non ciò che partecipa in modo imperfetto della primalità
dell'essere perfetto. Questo è infatti la prima forma che l’intelletto agente riceve
dall’illuminazione divina e l’uomo può così riconoscere l’essere nell’altro e in se stesso, e
riconoscerlo come compresenza di triadicità esistenziali: essenza, potenza e atto. Nella
primalità si giustificano anche le successive proprietà divine, trattate nelle otto
quaestiones. !
c) il termine di ogni desiderio nella primitas e il liber vitae: e sempre nella primalità
l’intelligenza finita riconosce anche il termine di ogni suo desiderio. Dunque al liber
naturae della razionalità e al liber scripturae della fede si aggiunge per l’intelligenza
credente il liber vitae, in cui si riconosce che la perfezione divina non è uno stato
acquisito ma una forza che si realizza eternamente in un dinamismo vivente che non
cessa mai. Il liber vitae è coincidenza di intelligenza e fede. !
e)La reductio teologica della filosofia e l'itinerarium della teologia!
a) descensio e reductio artium: nella descensio filosofica verso il molteplice sta il
massimo pericolo, in quanto si perde l'unità del sapere propria dell'ordinamento
divino. La reductio artium (nel senso di riconduzione delle scienze alla teologia) è
l'esatto opposto della descensio: si tratta di ritornare alla condizione naturale
dell'uomo antecedente al peccato di Adamo. !
b) la molteplicità delle scienze: le scienze sono molte perchè la luce divina
diffondendosi nella creazione produce vari riflessi. Le scienze non sono però luci
distinte provenienti da fonti diverse: riconducendo le discipline alla scienza del vero
in sé si scoprirà che hanno avuto la stessa origine comune. Lo sforzo di
ricomposizione del Vero, di per sé naturalmente insostenibile, è facilitato tuttavia
dalla manifestazione della Verità stessa, prima in tutta la natura e poi nella Scrittura. !
c) l’ordinamento delle luci: le luci cominciano così ad ordinarsi. La luce esteriore
conduce allo studio delle arti meccaniche; la luce inferiore è la luce dei cinque sensi
e fa conoscere i corpi non per servirsene ma per comprenderli; la luce interiore è la
conoscenza filosofica, che indaga le cause e formula i princìpi delle discipline; la
luce superiore sgorga dalla verità salvifica della Sacra Scrittura. !
Pagina 56 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
d) L’Itinerarium costituisce, a partire dal racconto dell'esperienza della stessa visione
del Serafino che aveva toccato Francesco, una sorta di guida spirituale per il fedele
che voglia raggiungere il godimento mistico dell'estasi. Si tratta di un percorso
articolato in sei fasi raggruppate a due a due:!
1) luce esteriore (extra nos): il primo grado è il sensus, il secondo è l’imaginatio; la
conoscenza di Dio è descritta come vestigium.!
2) luce interiore (intra nos): il terzo grado è la ratio, il quarto è l’intellectus; la conoscenza
di Dio è descritta come imago.!
3) luce superiore (super nos): il quinto grado è l'intelligentia, mentre il sesto è la visione
della Trinità (in ipsa luce); la conoscenza di Dio è descritta come similitudo.!
Al di sopra di ogni conoscenza si compie il rapimento dell'anima, in cui l’intelletto
conclude la sua opera e raggiunge la requie.!
Tommaso d’Aquino!
Le indagini di Tommaso riguardano la conoscenza e la possibilità per l'uomo di
raggiungerla: poiché la verità è una adequatio rei et intellectus, il vero è sempre in
relazione a qualcosa. Si tratta, secondo Tommaso, di capire cosa sia conoscibile
semplicemente con l'utilizzo della ragione naturale e cosa sia conoscibile grazie ad
un'intervento esterno.!
a)Magister in sacra pagina !
1- Tommaso è nato a Roccasecca dalla famiglia dei conti d’Aquino intorno al 1225. Nel
1244 Tommaso entra nell’ordine dei domenicani, seppur osteggiato dalla famiglia; è
allievo di Alberto Magno dapprima a Parigi e in seguito diverrà suo collaboratore
seguendolo anche a Colonia tra il 1248 e il 1252. Definito scherzosamente “bue muto di
Sicilia”, dovuto al suo carattere taciturno e alla sua mole imponente, Alberto avrebbe
profetizzato che il muggito della sua dottrina sarebbe presto risuonato in tutto il mondo.
2- Nella sua produzione teologica oltre ai numerosi commenti è importante la produzione
di summae. !
a) l’importanza della cultura biblica: la cultura biblica è la ragione stessa di esistenza
della teologia, ne offre e delimita il contenuto, ne è il fine ultimo ed essenziale e non
assicura soltanto un’ispirazione generale. La collocazione della lectio biblica a
fondamento della speculazione teologica giustifica l’importanza decisiva che
Tommaso accorda al senso letterale, esplicitamente confermata anche nella prima
quaestio della Summa theologiae. Tutte le opere di Tommaso, dagli opuscoli su temi
specifici alle summae, sono fondate su una solida conoscenza della Scrittura:
quest’ultima è utile perché illumina l'intelligenza, è dolce all'udito, scalda il cuore,
orienta l'agire morale. !
b) lettura della Bibbia attraverso le quattro cause aristoteliche: nel prologo del
commento ai Salmi Tommaso sottolinea la funzionalità della lectio biblica a
fondamento dello studio teologico fondandosi sulla teoria aristotelica delle quattro
cause: la materia è l'opera di salvezza, la causa efficiente è Dio stesso, la causa
Pagina 57 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
finale è la preghiera e la forma distingue la Rivelazione dal discorso teologico. Verso
l’inizio del 1252 il Generale dei Domenicani Giovanni il Teutonico chiede ad Alberto
Magno di segnalare un giovane teologo meritevole di poter essere nominato
baccelliere sentenziario a Parigi. Alberto fa il suo nome. A settembre ha inizio il suo
incarico e nel giro di 3 anni sarà poi nominato Magister in Sacra Pagina.!
b)Sancti e philosophi!
a) l’utilizzo di autorità filosofiche in teologia: 1- la prima grande sintesi teologica di
Tommaso è lo Scriptum super Sententiis, che anticipa alcune tra le principali tesi
delle opere successive. Uno degli elementi che caratterizzano la novità del suo
lavoro è l’utilizzo, all’interno della discussione teologica, di autorità filosofiche: le
citazioni da Aristotele sono numerose volte più presenti di quelle da Agostino o dallo
pseudo-Aeropagita. 2- Il contributo filosofico alla teologia è importante non solo per
individuare categorie o formulare metodologie, ma anche per condurre un'analisi
razionale della realtà, giungendo così a soluzioni diverse per origine ma compatibili
tra loro. La tecnica della quaestio garantisce questo procedimento. 3- I philosophi
sono, accanto ai sancti, i Padri e i teologi del passato, una fonte legittimata di
pensiero per chi voglia costruire un sapere autenticamente teologico. Tuttavia, non
è lecito “utilizzarli” a seconda delle occasioni, per comodità, senza così rispettare
l'organicità di un sapere compiuto.!
b) nuova fondazione della metafisica: poiché il teologo cristiano ha la certezza della
verità che viene dalla Rivelazione, Tommaso non può non impiegare i propri sforzi in
una nuova fondazione della metafisica. Dunque non una rivalutazione né un
mero utilizzo: la metafisica va rifondata, di modo che possa assicurare un solido
sistema di verità acquisite con le sole forze della razionalità naturale ma comunque
in accordo con l'altra verità che il filosofo cristiano ha a disposizione. Per essere
autenticamente teologo, Tommaso sente l’imporogabile necessità di essere anche
autenticamente metafisico; e sente la necessità di portare a compimento
l’organizzazione del vero razionale, così da poter aprire un fruttuoso dialogo con le
certezze della fede. !
c)I princìpi della metafisica: essere ed essenza!
Allo stesso periodo dello Scriptum super Sententiis appartengono due opuscoli filosofici,
il De principiis naturae e il De ente et essentia. !
a) il De principis naturae: il primo può essere considerato come uno scritto
preparatorio al secondo. E' un'esposizione compendiaria sulle chiave ermeneutiche
introdotte da Aristotele per spiegare l’essere e il divenire delle cose: le coppie di atto
e potenza, sostanza e accidente, materia e forma, genere, specie e individui, le
quattro cause. Bisogna risolvere queste molteplici strutture in un'ulteriore
distinzione, precedente tutte le altre, di modo da arrivare alla Causa prima di cui
parla la teologia. !
b) Il De ente inizia con l'avvertimento di Aristotele secondo cui “da un piccolo errore
iniziale segue sempre un grande errore alla fine”: siccome, secondo Avicenna, i
primi concetti dell'intelletto sono l'ens e l'essentia, bisogna evitare di commettere
errori trattando questi due concetti per non causarne di più gravi in seguito.!
Pagina 58 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
⁃ L'essentia è la verità di ciò di cui si predica l’essere. Coincide sempre con una
definizione, se questa definizione è vera.!
⁃ L'esse è ciò di cui si predica tale definizione;!
⁃ L'ens è ciò che esiste ed è qualcosa (est et est aliquid) ed è l'essentia in atto.!
Ens ed essentia sono presenti in qualunque sostanza: le sostanze si dividono in semplici
e composte. Le sostanze composte sono costituite da forma e materia, e dunque la loro
essentia comprende sia forma sia materia. !
c) l’individuo: non sempre la combinazione di materia e forma costituisce un individuo,
ma soltanto quando la materia è signata quantitate, ossia quando una determinata
quantità di materia comporta nella composizione con la forma l’attuazione dell’ens. Sia
Socrate, sia l’uomo sono una essentia, ma solo Socrate è una quiddità determinata in
atto, cioè un ens. !
d)le intelligenze separate e l’anima: l’anima e le intelligenze sono invece chiamate da
Tommaso sostanze separate; nonostante alcuni, come Avicebron, sostenessero che
anche l’anima e le intelligenze separate fossero costituite da forma e materia, Tommaso
nega che la capacità intellettiva sia affetta dalla materia, altrimenti non sarebbe in grado
di cogliere l'universalità. Ma non sono neanche forma pura, perché altrimenti sarebbero
Dio: dunque le sostanze separate sono il risultato di una composizione di forma ed
essere, e la loro essenza sarà solo la forma. Come le intelligenze, l’anima è determinata
in quanto è composta di essentia ed esse; ma, a differenza delle intelligenze, L’ANIMA È
INDIVIDUATA PERCHÈ IL SUO ATTO DI ESSERE È PREDISPOSTO A REALIZZARE
L’ESSENZA SOLTANTO IN UNIONE CON UN CORPO INDIVIDUALE. E una volta
dissolto il corpo, l’anima mantiene la propria individualità.!
e) Dio: 1- Nessun ens è dotato di esse che realizzi pienamente la propria essentia, a
parte Dio: Egli è ens in forma totale e assoluta, senza alcuna potenzialità irrisolta e
possiede tutte le perfezioni che possono essere realizzate in atto nell’essere. L'essenza
di Dio non è altro che il suo essere. 2- Di conseguenza Dio non è l'essere universale che
fa essere le altre cose, poiché è essere che realizza tutta la sua essenza in atto e non
ha bisogno di aggiungere alcunché al suo essere.!
f) gli accidenti: Tommaso passa poi a studiare l'essenza degli accidenti: dato che anche
di essi viene predicata una definizione, devono avere un'essenza. Nella definizione
dell'accidente, però, deve venire inserito anche qualcos'altro, poiché l'accidente esiste
sempre in quanto inerisce a una sostanza. Quindi ogni definizione di un accidente sarà
incompleta: l'essere di un accidente è una determinazione esistenziale in atto,
un'esistenza, non un'essenza: l'accidente non è ontologicamente autonomo.!
d)Filosofia e teologia: dai commenti a Boezio alla Summa contra Gentiles!
Tra il 1256 e il 1259 Tommaso scrive le Quaestiones quodlibetales, le Quaestiones
disputatae de veritate e i due importanti commenti a Boezio: il Super Boetium De
Trinitate, articolato per quaestiones, e l'Expositio libri Boetii De Hebdomadibus. !
Pagina 59 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
a) metafisica e teologia: Nel Super Boetium De Trinitate Tommaso, seguendo Boezio,
evidenzia la distinzione tra metafisica, ma anche scientia divina, e teologia
propriamente detta, la sacra doctrina, ossia la teologia cristiana. La metafisica,
campo del filosofo, ha come subiectum l'ente in quanto ente; non tratta la divinità
come tale, perché il suo essere è inconoscibile, ma coglie i principi primi della verità
tramite i loro effetti, gli enti conoscibili del mondo sensibile, chiamati principiati.
Dunque ci sono due teologie: 1- una è la metafisica studiata dai filosofi, in cui le
cose divine sono princìpi dei suoi subiecta e non il subiectum. 2- L’altra è invece
quella che considera le cose divine come subiectum di essa in quanto scienza,
fondata sulla fede. La teologia dunque può essere o filosofica o fondata sulla fede.
Nel secondo caso, Tommaso deve dimostrare che essa sia scienza nonostante sia
fondata sulla Scrittura, ossia non sulla ragione, e che sia comunque compatibile con
l'epistemologia aristotelica. Ma che sia necessariamente una scienza è data dal
fatto che ha un oggetto suo peculiare: ossia la realtà divina in quanto principio, a
partire dal suo essere principio.!
b) La Summa contra Gentiles, composta a Orvieto nel 1261, è un dialogo con
esponenti di altre religioni, indicati come Gentiles: il genere del dialogo con le altre
religioni nasce con Anselmo, il quale credeva possibile l’elaborazione di un modello
di razionalità teologica coincidente con le necessariae rationes che giustificano la
Rivelazione cristiana. L’opera di Tommaso è volta a convincere i Gentiles
dell'opportunità della conversione e a consolidare la fede di chi già ne è in
possesso. !
c) i tre scopi della filosofia: la filosofia ha un triplice scopo: 1- dimostrare le
anticipazioni della fede, ossia tutte le cose che possiamo dire di Dio mediante la
ragione naturale, come il fatto che esista, che sia uno, ecc; 2- rendere note per
mezzo di similitudini le cose proprie della fede; 3- resistere a tutto ciò che viene
detto contro la fede. La fede presuppone la conoscenza naturale e Tommaso
distingue “ea quae sunt fidei” da “ea quae sunt philosophiae” e poi tra quest’ultime
individua in particolare “ea quae sunt preambula fidei”, nozioni filosofico-naturali
propedeutiche rispetto alla fede e alla teologia, condivisibili da tutte le intelligenze
umane. L’INTENTO DELL’OPERA È DUNQUE QUELLO DI COMPRENDERE
RAZIONALMENTE LE STESSE VERITÀ IN CUI CREDONO I CRISTIANI. !
d) divisione della Summa contra Gentiles: la Summa si divide in quattro parti, di cui le
prime tre, dedicate rispettivamente a Dio in sé, al rapporto tra Creatore e creato e
infine alla relazione tra Dio come Bene e la vita morale, aprono la strada alla quarta,
in cui sono affrontati direttamente i misteri della Rivelazione. Se la ragione ha
anticipato la fede nelle prime tre parti, nella quarta non basta più e si fa superare
dalla fede, come nell'allegoria dell’Eriugena di Matteo e Giovanni. Dall'esistenza di
Dio sgorgano tutte le altre condizioni della sua conoscibilità: se è motore è
immobile, se è immobile è eterno, se è eterno è privo di potenzialità, se è privo di
potenzialità è privo di materia, se è privo di materia è puro spirito, se è puro spirito è
privo di passività. !
e) parlare di Dio per via analogica: come insegna lo pseudo-Dionigi, sia il discorso
rivelato, sia quello filosofico possono parlare di Dio soltanto presupponendo una
radicale alterazione del valore semantico originario dei termini che utilizzano. Dal
momento che sussiste una qualche somiglianza tra Dio e le cose che giustifica la
Pagina 60 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
possibilità stessa di argomentare sulle perfezioni divine a partire dal creato, è
necessario concludere che ogni denominazione divina è sempre e soltanto di
valenza analogica. L'analogia consiste nel predicare uno stesso nome di cose
distinte: è sano un corpo, è sano un cibo o è sana una medicina. La stessa parola
viene utilizzata per motivi diversi, sempre però in riferimento alla salute. Allo stesso
modo si parla di Dio riferendosi ad uno stesso significato complessivo, ma senza
presumere che la parola possa avere lo stesso significato particolare. !
e) tra Roma e Parigi, aristotelismo vontro l’averroismo: angelologia e
antropologia!
a) il de unitate intellectus: Nel 1270 Tommaso pubblica il De unitate intellectus, dove la
razionalità viene messa al servizio della fede per correggere gli errori dei cattivi
filosofi, ossia la concezione averroista dell’intelletto come sostanza separata e la
conseguente vanificazione dell’immortalità dell’anima. !
b) una nuova dottrina antropologica: Tommaso elabora una dottrina antropologica che i
suoi stessi contemporanei celebreranno come nuova, anche se profondamente
ispirata al pensiero aristotelico. Questa dottrina è coerentemente fondata sui temi
portanti della sua metafisica: la materia signata come principio di individuazione, il
rifiuto dell’ilemorfismo universale e la composizione universale di essere e atto di
esistenza.!
c) angelologia: nell’esposizione della Summa theologiae Tommaso affronta il problema
antropologico, secondo l’ordine proprio della teologia, partendo dall'opera dei sei
giorni e dal fatto che la creazione degli angeli ha preceduto quella degli uomini. 1-
Dato che il fine ultimo della creazione è l’assimilazione delle creature al Creatore,
questo fine deve realizzarsi in tutte le sue attuazioni; e poiché l'intelligenza non è
una funzione del corpo, devono esistere entità in grado di redire a Dio per mezzo di
un'intelligenza assolutamente spirituale, ossia gli angeli. 2- Gli angeli sono la miglior
testimonianza della ordinata gerarchia divina che fa sì che esistano tutte le possibili
forme di partecipazione creaturale alla sua perfezione. 3- Gli angeli sono dotati di
intelletto e volontà, e composti da essenza ed esistenza: se appaiono, come nei
racconti biblici, in forme sensibili e visibili, è solo perché gli uomini fanno intervenire
la propria capacità immaginativa. !
d) antropologia: Tommaso passa poi a parlare dell’antropologia: l’uomo è dotato di
un’anima, di una sostanza spirituale che permette la conoscenza, condivisa solo
con gli angeli. Le operazioni dell'anima non sono corporee, e dunque il soggetto che
le compie deve essere incorporeo: infatti L'ANIMA UMANA, COME GLI ANGELI, È
UNA FORMA SUSSISTENTE. !
e) l’anima come forma sostanziale dell’uomo: Poichè l’intellezione è diversa in ciascun
individuo umano (“hic homo intelligit”), è necessario che ogni anima entri in
composizione con il corpo individuale. Contro gli averroisti e l'intelletto collettivo,
Tommaso sostiene che, dato che ciò che rende uomo l’uomo è l'attività intellettiva,
se ci fosse un solo principio di intellezione ci sarebbe un solo uomo, e poiché l'uomo
è individuo per il corpo, il principio intellettivo è presente in ciascun uomo, ed è la
forma che fa essere la sostanza “uomo”: l'anima è la forma sostanziale dell'uomo. !
Pagina 61 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
f) Anima e corpo: Anima e corpo non sono due sostanze accidentalmente unite ed
esistenti anche quando sono separate, ma sono i principi costitutivi dell’unitaria
sostanza individuale esistente in atto. Le diverse facoltà dell’anima sono potenze di
un’unica forma. Senza questa unicità e complessità della forma l'uomo non sarebbe
individuo, se venisse cioè considerato come corpo a sé stante a cui viene aggiunta
in seguito l'anima. L'unione di anima e corpo avviene nel ventre materno. E
l'astrazione, opera dell'intelletto agente, è ciò che consente all'anima di elaborare gli
universali. !
g) l’immortalità dell’anima: l’immortalità individuale dell'anima è fondata sulla capacità
della forma intellettiva di conoscere le forme indipendentemente dalle
rappresentazioni corporee di queste forme, conoscibili durante la vita terrena:
quando si separa dal corpo morto, l'anima continua a conoscere, ormai direttamente
gli esemplari, cosa non possibile prima per via del proprio legame con la corporeità.
Poiché la finalità delle creature è compiere la perfezione divina e poiché la
perfezione dell'anima comprende anche il corpo, la condizione di separazione di
corpo e anima è innaturale e troverà un punto di arresto nella resurrezione dei corpi.
L'antropologia di Tommaso raggiunge qui un livello elevatissimo di coniugazione di
fede e ragione, in cui la resurrezione dei corpi, apparentemente inaccettabile
filosoficamente, risulta un corollario della dottrina aristotelica dell'anima.!
f)La Summa Theologiae e la “teologia dell'Esodo”
La ragionevolezza di alcuni dogmi, come quello della resurrezione dei corpi, raggiunta
mediante l'analisi filosofica, consolida in Tommaso la certezza della convergenza di
verità razionale e verità teologica. !
a) i limiti dell’intelligenza: tuttavia è evidente anche che l'accostamento dell'intelligenza
alla fede abbia i suoi limiti, cosa che testimonia la necessità di completare la
conoscenza naturale con la Rivelazione.!
b) i preambula fidei: Riguardo poi i preambula fidei, ossia le dimostrazioni razionali
sulla natura di Dio, Tommaso è certo che una corretta collaborazione, nel rispetto
reciproco della rispettiva autonomia possa portare ad una conoscenza piena ed
appagante: le prime Quaestiones della Summa Theologiae mirano a evidenziare
proprio questo rapporto. !
c) struttura della Summa Theologiae: la Summa Theologiae è così strutturata: Prima
pars: Dio, la sua natura, la Trinità, la creazione e il creato; Secunda pars (divisa in
Prima secundae e Secunda secundae): la relazione tra le creature e Dio, la
beatitudine, le passioni, i peccati e le virtù; Tertia pars: redenzione e grazia
(ultimata, a causa del decesso di Tommaso, da amici e discepoli con l'ultima parte
riguardo alla escatologia e alla resurrezione finale, come da progetto di Tommaso).
La Summa di Tommaso si sviluppa nel rispetto del modello della disputatio:
quaestio, obiectiones, responsio. !
d) le cinque vie: la prima parte della Summa tratta di Dio secundum quod in se est: la
filosofia, riguardo ai preambula, è in grado di dimostrare l'esistenza di Dio
scientificamente, e Tommaso lo mostra, con le sue cinque viae, nella seconda
quaestio della prima parte, in una sezione chiamata “utrum Deus sit”.!
Pagina 62 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
Le cinque vie sono le seguenti:!
1) La “manifestior”, la più evidente, è la via del moto: ogni cosa che si muove passa
dalla potenza all'atto, dunque non può muoversi da sé, ma è sempre mossa da qualcosa
che è già atto; non si può retrocedere all'infinito perché se non ci fosse un primo motore
non ci sarebbe neanche un secondo motore; è razionalmente necessario dunque che ci
sia un motore non mosso, che sia solo atto e non potenza, e tale è Dio.!
2) La via della causa efficiente: tutte le cose sono sottoposte alla causa efficiente di
qualcos'altro, ma nessuna può essere causa efficiente del proprio essere; anche qui non
si può retrocedere all’infinito perchè se non ci fosse una causa prima non ci sarebbe
neppure una causa media, dunque è necessario ammettere che ci sia una causa prima
e questa è Dio.!
3) Possibile e necessario: alcune cose sono possibili, cioè possono essere o non
essere. Ma se tutto fosse solo possibile bisognerebbe ammettere un momento in cui non
c'era nulla; ma l'essere scaturisce solo dal qualcosa, dunque qualcosa di necessario c'è.
Le cose necessarie possono avere la propria necessità da altro o da se stesse, e se
esistessero solo cose necessarie da altro si ricadrebbe nel regresso all’infinito, dunque è
necessario ammettere che ci sia qualcosa di necessario da sé, cioè Dio.!
4) I gradi delle cose: Le cose sono più o meno vere, buone etc. Il più e il meno sono tali
se si riferiscono all'allontanarsi o all'avvicinarsi a qualcosa che è il massimo modo,
dunque c'è qualcosa che è massimamente buono, vero etc. Ciò che è massimo in
ciascun genere è la causa dell'appartenere a quel genere delle cose che vi
appartengono, allora l'ente massimo è la causa dell'essere, dunque Dio è causa
dell'essere.!
5) Il governo delle cose: tutte le cose create seguono un fine, lo scopo della propria
natura, la compattezza in una pietra o il calore nel fuoco; Le cose prive di conoscenza
tendono a un fine perché qualcuno, dotato di conoscenza, le orienta, come una freccia
che raggiunge il bersaglio perché qualcuno la scocca; l'arciere supremo, dotato di
intelligenza, è Dio.!
Questo è il massimo a cui la ragione giunga da sola: dimostra che Dio esiste, dunque,
ma non ce lo fa conoscere. Può, ancora, predicare di Dio dei termini secondo
quell'analogia già indicata nella Summa Contra Gentiles. La teologia di Tommaso viene
vista come una “Teologia dell'Esodo”, cioè in riferimento al passaggio dell'Esodo in cui,
alla domanda su chi fosse Dio risponde: “Ego sum qui sum”. Un nome che più che
svelare nasconde e che rende evidente la nostra incapacità di formulare giudizi compiuti
sull'oggetto della ricerca teologica. La frase è semplice quanto oscura: è evidente la
connessione tra soggetto e oggetto ma la conoscenza di essi è velata forse
impenetrabilmente. Tommaso scrive che il nome di Dio è il massimo dei nomi perché
indica l'essere stesso, è universale, con-significa ogni cosa.!
g)La teologia come scienza!
a) è possibile la teologia come scienza? La domanda ultima a cui Tommaso deve dare
risposta è la domanda sul subiectum della teologia, sul suo perché e sul suo essere
scienza. E' possibile una scienza del credibile? In quale misura è poi possibile
Pagina 63 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
chiamarla scienza? Queste domande son importanti perché dalla loro risposta
dipende la possibilità di inserire la teologia nel novero aristotelico delle scienze. La
scientificità della teologia si articola, per Tommaso, in: 1) ricerca del principio
fondativo; 2) subalternazione della teologia; 3) specificità del metodo. Tommaso sa
che è scienza solo ciò che concerne verità universali e che queste verità sono
regolate e sancite dal rispetto delle regole che Aristotele ha posto per definire una
scienza come tale. Tuttavia, solo la matematica e la logica non includono elementi
tratti dall'esperienza: tutte le altre discipline sono legate al particolare, dunque
bisogna variare il modello di scienza perfetta. !
b) la fede come principio fondativo della teologia: come i tre princìpi logici che
dominano la logica aristotelica, in teologia la funzione di elementi per se noti viene
svolta dagli articoli di fede. La fede ricalca il ruolo che nelle altre discipline spetta ai
princìpi fondativi, il che equivale a dire che la fede è il principio fondativo della
teologia. !
c) La subalternazione è, in logica, quella regola per cui da una proposizione di una
data ampiezza, considerata vera, se ne ricava una di ampiezza minore, che sarà
ancora vera: ad esempio, “alcuni uomini sono mortali” è subalterna a “tutti gli uomini
sono mortali”. Così la teologia è subalterna alla luce che viene da una verità
superiore.!
d) Particolarità del metodo teologico: il metodo della scienza teologica dunque sarà
singolare e ad essa ristretto: le sarà perciò lecito utilizzare procedimenti non
utilizzati in altri ambiti (come la metafora o l'allegoria). Inoltre teologia il particolare
non è il singolare, ma l'esemplare: un avvenimento eccezionale e unico come un
miracolo non è universale in un senso fisico-attuale, ma in un senso esemplare,
come universali sono gli esempi nelle discipline morali. !
e) La sacra doctrina è dunque una scienza pratica, in quanto influisce
sull'orientamento etico degli uomini, dopo il suo essere una scienza speculativa. La
teologia infine è la sola disciplina che si fonda sulla Rivelazione. Qui si evidenzia la
differenza tra teologia sacra e teologia filosofica: ambedue hanno per oggetto Dio,
ma la seconda non parte dai presupposti di fede. Il subiectum della teologia,
comunque, rimane in tutto e per tutto Dio. !
f) il mistero dell’eucaristia: Il rapporto tra la teologia e le altre scienze è dato dalla
spiegazione che Tommaso dà del mistero dell'eucaristia: in occasione di un
miracolo, ossia di qualcosa che va contro le leggi scientifiche della razionalità, la
scienza non deve spiegare come esso possa accadere, ma cosa effettivamente
accada. Così, nel caso dell'eucaristia, non mutano gli accidenti del pane e del vino,
ma muta la sostanza, e anche se questo è fisicamente impossibile, la scienza deve
spiegare cosa succeda in questo fenomeno, che Tommaso chiama
transustanziazione. Dunque considerare la teologia come una scientia fa sì che la
filosofia possa fornire un aiuto razionale allo studio del divino, senza però per
questo pretendere di sostituirsi alla fede, il principio fondativo della scienza
teologica.!
Pagina 64 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
Enrico di Gand e i maestri secolari
a) I fondamenti teologici del pensiero di Enrico di Gand
!
a) rifondazione dell’epistemologia cristiana: L’opera teologica di Enrico si propone
come tentativo di fondare l'epistemologia cristiana su una base totalmente diversa
da quella aristotelica, in linea con ciò che veniva sostenuto dai maestri secolari del
tempo (seconda metà del XIII secolo). Questa posizione risulta contrapposta ad
entrambi gli Ordini dei Mendicanti: da un lato ai domenicani, con Tommaso, con la
sua concezione di scienza teologica in quanto tale perché subordinata ad un
principio superiore, dall'altro ai francescani, con la loro idea di teologia come
sapientia superiore alla scienza naturale. !
b) critica dello schematismo applicato alla Rivelazione: La critica di Enrico a Tommaso
fa leva sull’ingiustificato condizionamento delle possibilità conoscitive assicurate
dalla Rivelazione a schemi mentali che sono a essa estranei. Le deduzioni
teologiche non hanno bisogno, sostiene Enrico, di fondatezza argomentativa.
Confrontare i dati teologici con quelli delle scienze naturali porterebbe all'errore
inoltre i fedeli: la loro attendibilità non può dipendere dalla compatibilità con i dati
scientifici, poiché in realtà dipendono unicamente da un sistema che trova in se
stesso la propria giustificazione, quello della fede in Dio. !
c) Dio come oggetto e soggetto della teologia: Dio dunque è sì l'oggetto della scienza
teologica, ma è anche il soggetto, perché fa sapere e sa ciò che deve essere saputo
su se stesso. E' la teologia a tornare regina disciplinorum, ossia la regola su cui si
basa la veridicità delle altre discipline, orientandole e determinandole. !
d) il compito della teologia: il problema fondamentale di Enrico di Gand diventa allora
sostanzialmente quello di riuscire a portare la teologia al livello degli uomini, ossia di
condurre, mediante la Rivelazione, la conoscenza che Dio ha di sè e della verità a
essere praticabile e praticata da parte dell’intelligenza umana. !
b) La composizione “intenzionale” dell'essere!
a) Critica a Tommaso: Enrico, per attuare una ricostruzione dell’intera architettura della
scienza teologica, deve descrivere più accuratamente che cosa sia l'essere. Questa
tematica viene affrontata nella nona quaestio del suo primo libro Quodlibet,
disputato nell’inverno del 1276. La distinzione metafisica di esse per se ed esse per
aliud è emersa nel pensiero dei primi secolari. Con intenti chiarificatori, Tommaso ha
poi creduto di correggere questa impostazione iniziale con l’introduzione di essenza
ed ens, ossia di essenza in sé ed essenza in atto. Enrico critica Tommaso per la
possibilità di intendere i due concetti come due res separate, l'una necessaria e
l'altra possibile: questo porta ad un necessitarismo deterministico che limita la
libertà divina e umilia le creature, che alla luce della vera metafisica cristiana
devono invece essere concepite come res dotate di piena dignità ontologica, una
per una volute da Dio come esito singolare e irripetibile della sua onnipotenza. !
b) la distinzione dell’essere: la composizione dell’essere va dunque intesa non come la
differenziazione di qualcosa che è in modo autentico e di qualcosa che è soltanto in
modo derivato e secondario, ma come la distinzione di due maniere entrambe
Pagina 65 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
autentiche di essere: l'essere in sé, Dio, e l'essere come Dio ritiene che sia giusto
che sia, il creato. Dio è l'essere che è per il solo fatto di essere (aliquid quod est
ipsum esse), mentre le creature sono perché l'essere viene loro attribuito (aliquid cui
convenit esse). In Enrico di Gand l'essere dunque non è univoco, bensì ha due
modi, altrettanto validi, di essere inteso, diversamente da tutta la tradizione. Ma se
non è reale, la distinzione di essenza ed esistenza è soltanto un’operazione di
ordine conoscitivo, ossia è una distinzione intenzionale: è l’intelletto che separa due
percezioni dirette del contenuto essenziale della res come sue note costitutive.
Infatti anche nel momento della creazione Dio pensa l'essenza e l'esistenza di ogni
creatura come due intentiones, pensando così prima l'essenza e poi portando ad
atto l'esistenza con la propria volontà creatrice.!
c) La dottrina della conoscenza e la illustratio specialis !
Per conoscere la verità delle cose create l’intelletto umano deve poter cogliere
direttamente la corrispondenza della loro essenza con l’idea divina da cui essa deriva.
Affinché l'uomo possa conoscerle è dunque necessario un intervento divino: Enrico di
Gand dunque giustifica filosoficamente la dottrina dell'illuminazione, che non è, come
ritengono i francescani, una funzione regolativa del pensiero umano, ma un
orientamento aprioristico della conoscenza e dell'agire umani, consentito da una mistica
congiunzione dell’anima con il verbo: Enrico le dà il nome di illustratio specialis e la pone
a fondamento di un assoluto realismo conoscitivo, in cui interiormente si verifica sempre,
grazie all'intervento divino, la convergenza di nozione della cosa sensibile e nozione
dell'essenza di quella cosa. Ogni scienza è tale nella misura in cui nel suo specifico
ambito di conoscenze è assicurata dall’illustratio specialis la coerenza tra le verità da
essa formalizzate nell’intelletto e la legge eterna degli universali divini.!
d) La scienza teologica e la nuova epistemologia cristiana!
1- Enrico spiega, con la dottrina della illustratio specialis, il motivo dell'inadeguatezza dei
criteri epistemologici dell'aristotelismo, fondati sull'astrazione e quindi validi solo per le
scienze naturali. 2- La teologia, invece, è una scienza aperta da un'illuminazione
superiore, e dipende interamente dalla fede nella Rivelazione, in cui è il subiectum
stesso della scienza, Dio, a darsi. In questa particolare condizione, il dato acquisibile a
posteriori (il dato scritturale) e quello acquisibile a priori (la nozione che Dio ha di se
stesso) coincidono con certezza, perché è Dio stesso a fornirci il primo. 3- La teologia è
la regola di tutte le inferiori acquisizioni di conoscenza scientifica, in quanto assicura
coerenza e veridicità a tutte le scienze inferiori; essa è superiore alla fede, perché
integra il credere con un intelligere garantito dalla illustratio specialis; La teologia è
dunque una scienza assolutamente veridica, non differenziata dalla conoscenza
scientifica, inserita in uno schema valevole in entrambi i sensi: da un lato illumina le
conoscenze inferiori orientandole verso la verità dei suoi oggetti finiti e particolari,
dall'altro la sua conoscenza è predisposta dalle stesse scienze inferiori che illumina. LA
SCIENZA TEOLOGICA HA IL COMPITO DI RENDERE INTELLIGIBILIA I CREDIBILIA
DELLA FEDE (come vuole Bonaventura) e permette all’uomo di partecipare della verità
divina. La teologia è “simpliciter speculativa” come secondo Aristotele soltanto la scienza
divina può essere. !
Egidio Romano, maestro degli Agostiniani!
Pagina 66 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
a) ripresa delle tesi di Agostino: il progetto filosofico di Egidio Romano consiste nella
fondazione di un sapere autenticamente agostiniano ma reso solido dalla ragione
filosofica, che Tommaso ha contribuito in maniera essenziale a rendere compatibile
con la fede. Agostino va dunque confrontato con le nuove prospettive filosofiche con
le quali il vescovo di Ippona non aveva potuto confrontarsi. Si tratta dunque di
rivalutare l'esasperato aristotelismo confrontandolo con l'esemplarismo
platonizzante che sta alla base della filosofia di Agostino. !
b) essenza ed esistenza: per Egidio, essenza ed esistenza sono effettivamente due
vere e proprie res, la cui unione non produce una effettiva unità, ma una
congiunzione “per accidens”. Ma ridurre le essenze agli esemplari eterni e le
esistenze agli effetti che ne partecipano sarebbe banalizzante: poiché la
commistione di essenza ed esistenza è un connotato di ogni singola creatura,
dunque considerare la prima come qualcosa di eterno e necessario è fuori luogo. !
c) E' la gnoseologia di Egidio, tuttavia, la componente più importante della sua opera.
Per lui, la conoscenza vera è il giudizio sulla composizione reale di essenza ed
esistenza in ogni essere. Ma l'uomo non può conoscere questa composizione, può
solo rappresentarne diversi gradi di manifestazione, in quanto solo Dio può
conoscere pienamente l'esistenza dell'essenza. Nell’uomo, il cui conoscere muove
sempre dall’esperienza del singolare per passare all’astrazione dell’universale, LA
PERCEZIONE DELL’EFFETTIVO ESISTERE DELL’ESSENZA È POSSIBILE
SOLTANTO ATTRAVERSO LA MEDIAZIONE DEL SENSO CORPOREO: dunque è
impossibile per l’uomo cogliere la composizione effettiva di essenza ed esistenza in
una determinata res. !
d) la concezione dell’anima: Egidio si discosta dalla dottrina aristotelica dell'anima per
avvicinarsi a quella platonico-agostiniana. L'anima si articola in molteplici facoltà, ed
è la forma del corpo perché ne porta ad attuazione le molteplici potenzialità. L'anima
è composta da tre facoltà dominanti: anima vegetativa, anima sensitiva (che
comprende senso comune, immaginazione, fantasia, memoria, ecc.) e anima
intellettiva (che comprende intelletto attivo e passivo). Ciascuna facoltà è in grado di
esprimere un giudizio peculiare sulla composizione reale dell’essere, la cui veridicità
è comunque realitiva, legata all’ambito specifico in cui viene espresso. Ogni atto
conoscitivo ha a che fare con la medesima realtà, ma coglie in essa diversi modi di
presenzialità dell’essenza nell’esistenza. Non vi è, contro Tommaso, un punto
d'arrivo in cui si conosca attualmente la res, né vi è, contro Enrico, un presupposto
aprioristico proveniente dall'alto. Rifiutando l'illuminazione e riconducendo la
conoscenza all'intelletto attivo Egidio recupera la vera gnoseologia agostiniana: IL
MEDESIMO OGGETTO APPARE IN DIVERSE FORME A DIVERSE FACOLTÀ
DELL'ANIMA. !
e) i limiti delle scienze: come per i singoli atti conoscitivi, anche le scienze non
possono raggiungere una conoscenza piena, e così neppure la metafisica o la
teologia, poiché si rifanno tutte alle capacità conoscitive ridotte del conoscente.
Egidio sostiene l'erroneità di pretendere di fare di Dio il subiectum della teologia,
come se fosse una res conoscibile. !
f) la teologia: Dio è il fine irraggiungibile di un costante impulso di conoscenza: la
teologia, che accompagna e orienta questo impulso, è dunque una scientia
Pagina 67 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
affectiva. Inoltre è sia speculativa sia pratica. Dio non è l'oggetto di una scienza
finita in senso aristotelico. la natura di scienza affectiva colloca d’altra parte la
teologia al di sopra di tutte le altre scienze e ne proietta senz’altro gli esiti in una
prospettiva escatologica, in quanto solo nella beatitudine l’amore per Dio potrà
giungere a un grado di compimento tale da colmare i limiti propri della conoscenza. !
L'aristotelismo degli artistae e la condanna del 1277!
⁃ Il dibattito e le condanne
Il dibattito riguardo alla spregiudicatezza intellettuale dei colleghi delle arti caratterizza
la produzione di buona parte degli scritti dei docenti della Facoltà di Teologia tra gli
anni 60 e 70 del Duecento. !
⁃ a) le tesi degli artistae: Gli artistae conducevano dimostrazioni che sfociavano in
posizioni inconciliabili con la Rivelazione: l'eternità del mondo, la creazione tramite
intermediari, il fatalismo inconciliabile con la Provvidenza, la negazione
dell’immortalità dell’anima e della resurrezione dei corpi. A partire dalla metà del XIII
secolo, dunque, cominciano a presentarsi le prime preoccupazioni, soprattutto
riguardo al monopsichismo avverroista, fino ad arrivare alle esplicite denunce di
Bonaventura e Tommaso. !
⁃ b) Sigieri di Brabante: in questo contesto emerge l'opera di Sigieri di Brabante. Sigieri
sosteneva che l'intelletto possibile, con cui l'uomo pensa, non è forma del corpo come
lo sono l'anima vegetativa e l'anima sensitiva, perché altrimenti sarebbe incapace di
separarsi dalle immagini sensibili. L'intelletto possibile dunque è separato dal corpo
ed è universale in quanto comune a tutti gli individui. !
⁃ c) la condanna del ’70: nel 1270 Stefano Tempier, vescovo di Parigi, con un decreto
vietava l'insegnamento di 13 tesi di ispirazione averroistica, riguardanti tre temi:
eternità del mondo, determinismo e negazione della Provvidenza, unicità dell'intelletto
umano. La condanna riguardava in particolar modo l'attività didattica degli artistae, i
maestri di arti liberali, propugnando l'idea che vi fossero alcuni ambiti riservati soltanto
allo studio dei teologi. Allo stesso modo, però, cercava di contrastare la tendenza di
alcuni teologi a manifestarsi troppo aperti nei confronti di alcune posizioni, in
particolare dell’aristotelismo. !
⁃ d) la ritrattazione di Sigieri: tra il 1272 e il 1273 Sigieri pubblicò un De anima
intellectiva in cui, manifestando un certo rispetto per l’autorità di Alberto e Tommaso,
rivedeva parzialmente la propria psicologia. !
⁃ e) la condanna del ’77: Papa Giovanni XXI, al secolo Pietro Ispano, incaricò Stefano
Tempier di stilare una lista degli errori commessi dagli artistae: il 7 marzo 1277 il
vescovo pubblicò una lista di 219 proposizioni considerate erronee che se professate
avrebbero portato alla condanna per eresia. La condanna era rivolta a tutti gli artistae
che “ardiscono travalicare i limiti spettanti alla loro Facoltà”, affermando una generale
contraddizione tra verità della fede e verità filosofiche. Erano inoltre condannati il De
amore di Andrea Cappellano, sull'amor cortese, ossia extraconiugale, e altri libri di
geomanzia e negromanzia.!
⁃ Il sistema di pensiero degli Aristotelici delle Arti!
Pagina 68 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
⁃ a) Il sistema filosofico di Sigieri è un programma di integrale recupero del metodo e
delle articolazioni del modo di pensare aristotelico, intenzionalmente perseguito senza
mai subordinare gli esiti ad alcuna verifica di compatibilità con i contenuti della
Rivelazione. Al vertice del suo sistema c'è Dio, la causa prima, la cui esistenza è
dimostrata secondo vie a posteriori prese in prestito da Tommaso. L’effetto immediato
del divino è un principio puramente intellegibile ed è la prima di una complessa
gerarchia di intelligenze inferiori che attuano l’efficacia produttiva della prima causa
funzionando da intermediari. Ogni intelligenza, in quanto immateriale, è unica nella
sua specie e individuata dalla sua stessa quiddità. Sigieri esclude altre forme di
composizione ontologica, come essenza ed esistenza, sovrabbondanti rispetto alla
semplicità della pura legge della causalità naturale. Tutto ciò che accade nell'universo
creato è un effetto necessario: tuttavia entra in gioco anche la contingenza che
scaturisce dall’impotenza naturale della materia a ricevere efficacemente le forme
necessarie provenienti dalle sfere superiori. !
⁃ L’uomo: L’uomo è libero solo per la debolezza delle capacità di giudizio della
razionalità. L'anima è la forma del corpo e il suo compito massimo è vivificarlo: il
grado massimo dell’anima è quella cogitativa che entra in contatto con l'ultima
intelligenza separata, l'anima intellettiva, che comprende intelletto passivo e intelletto
attivo. !
⁃ b) Boezio di Dacia: un altro averroista latino, oltre a Sigieri, fu Boezio di Dacia,
anch'egli maestro della Arti di Parigi. Le sue opere filosofiche vertevano specialmente
sull'eternità del mondo e della specie umana e sulla possibilità di conseguire la
beatitudine in vita mediante l'esercizio delle virtù etiche.!
⁃ La “doppia verità” e le distinzioni epistemologiche degli artistae!
a) gli aristotelici non operano il confronto con il dato rivelato: Gli aristotelici delle Arti
rivendicano il diritto a operare con la pura razionalità senza mai subordinare gli esiti
a imposizioni esterne alle esigenze della scienza. Dal silabo di Tempier traspare la
preoccupazione che verità per rivelazione e verità per dimostrazione possono
comparire contraddittorie, ma questa posizione però non trova riscontro negli scritti
di Sigieri o di Boezio. !
b) Sigieri e il dato rivelato: Sigieri invitava, nel commentare il De anima, a rimettersi, in
caso di incertezza, alla verità della fede: ad esempio, dal momento che nessuna
argomentazione risulta decisiva, come già Tommaso sosteneva, nel decretare se il
mondo sia eterno o meno, occorre rimettersi al dato di fede. !
c) Boezio e il dato rivelato: Boezio si spinge oltre: egli infatti sostiene che non c'è
nessuna contraddizione tra verità di fede e verità dimostrata; ciò che può essere
solo oggetto di fede non può essere indagato con la ragione, mentre ciò che viene
indagato con la ragione va rispettato come tale nel suo ambito. Ha ragione il
credente che dice che il mondo ha avuto inizio, ma ha anche ragione il naturalista
che dice che questo non è possibile secondo le leggi naturali: il mondo ha avuto
inizio semplicemente perché Dio, al di sopra delle leggi naturali, ha voluto così. Le
conclusioni di ciascuna scienza devono essere relative esclusivamente alla natura
dell’oggetto che le è peculiare, in quanto proprio tale natura determina il suo metodo
Pagina 69 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
e i suoi percorsi dimostrativi. Non dunque una doppia verità, ma il riconoscimento di
diversi ordini di verità. !
Ruggero Bacone!
Un nuovo punto di vista nel panorama teologico, reso arido dalle continue controversie
di scuola, è Ruggero Bacone. Inglese, francescano spirituale, nato nel 1214, il suo
programma teoretico consiste in una totale reformatio di tutti gli ambiti della conoscenza
cristiana: filosofia, scienza e teologia. Ruggero identificava sette peccati nella teologia a
lui contemporanea:!
1) l'introduzione del metodo filosofico, proprio degli artistae, nelle trattazioni teologiche;!
2) l'ignoranza delle vere scienze utili allo studio della Scrittura (greco, ebraico,
matematica, retorica, ecc.)!
3) l'ignoranza generale che inonda gli studiosi contemporanei;!
4) la sostituzione del libro delle Sentenze alla Bibbia; !
5) la corruzione del testo sacro!
6) l'incapacità di produrre una corretta esegesi biblica;!
7) la mancanza di una vera eloquenza, sostituita dalla verbosità dei sermoni universitari.!
In primo luogo è errato aver fondato il sapere sull'astrazione, che, pur essendo utile,
allontana chi conosce dalla verità immediata di un oggetto comunicata dai sensi. Un
altro errore consiste nel pensare l'esistenza degli universali e della forma e della materia
universali. Dall’errore primordiale del peccato originale sono scaturiti i tre principali
offendicula sapientiae: il falso principio dell’auctoritas, la comoda regola della traditio,
l’ignava adesione alla communis opinio. !
Secondo Ruggero, l’autentica epistemologia aristotelica è stata difesa da Grossatesta,
che considerava la scienza sperimentale l'unica vera scienza, mediante l'immediata
razionalizzazione dei dati sensibili. Questo capovolgimento epistemologico inserisce
Ruggero nella corrente dei francescani di Oxford, tra cui Grossatesta. !
a) il ruolo della tecnica: il filosofo secondo Ruggero è dominus experimentorum,
capace a un tempo di compiuta osservazione empirica e di diretta traduzione di
essa in capacità tecnica. La scienza e la tecnica servono tanto per portare l'uomo
verso il suo eterno fine, la salvezza eterna, quanto per ricucire lo strappo causato
dalla presunzione di Adamo e partecipare nuovamente alla perfezione della scienza
divina. Questo è il fine della rifondazione epistemologica di Ruggero: ovvero si deve
attuare un’onnicomprensiva riconduzione dell’intelligenza umana entro i termini del
metodo sperimentale, “porta e chiave di tutte le scienze”. !
b) il ruolo della matematica: la matematica, la più generale tra le specie, pone
direttamente l’intelligenza a contatto con il modus essendi in sé delle cose. Sulla
Pagina 70 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
matematica si fondano le successive elaborazioni: ottica, astronomia e l’etica, che
ha come scopo la felicità dell’uomo. !
c) i limiti della scienza morale: ma proprio nella scienza morale la razionalità assapora
la coscienza dei propri limiti e l’incapacità di ricongiungere l’uomo con la pienezza
del conoscere divino: l’apprendimento dell’impossibilità di comprendere e
conseguire la vera felicità è l’esito di questo percorso. !
d) la teologia: la teologia viene definita regina delle scienze, proprio perché è garantita
nelle sue certezze dalla veridicità divina, finendo così con l’estendere la propria
giurisdizione sull’intero edificio. Inoltre è autenticamente intuitiva e congiunge le
proprie premesse con le proprie conclusioni. !
e) il ruolo della Scrittura: da una corretta penetrazione della verità della Scrittura dovrà
muovere i primi passi la nuova sapienza umana. Le scienze filosofiche e il diritto
canonico offrono gli strumenti complementari al sapere teologico, oltre che la
conoscenza dell’Ebraico e del Greco e la comprensione del contesto giuridico-
storico della narrazione. Il perfezionamento conoscitivo, con simmetria inversa ai
sette peccati della Teologia delle scuole, è una scala di 7 gradi fino all’ascesi
mistica.!
Giovanni Duns Scoto
a)theologia in se e theologia in nobis
Soprannominato Doctor Subtilis, Duns Scoto fonda un nuovo sistema di pensiero
destinato a fare scuola e diventare punto di riferimento di un’ampia corrente speculativa.
Svolge il magistero teologico a Parigi tra 1305 e il 1306, quindi si trasferisce a Colonia.
Le sue opere sono tutte legate alla didattica universitaria. Fin dal prologo dell’Ordinatio,
Scoto si concentra sulla frattura che si è creata tra la scienza naturale, rigorosa ma
incapace di affermazioni assolute sulla realtà ultima degli oggetti conosciuti, e la
conoscenza di ordine soprannaturale. !
a) i limiti della teologia: secondo Scoto in teologia si cerca di conoscere l’essenza di
Dio che è perfetta in quanto infinità, e di conseguenza soltanto a un intelletto
increato una tale essenza risulta naturalmente nota. “Sub ratione deitatis” l’essenza
divina è proporzionale soltanto all’intelletto divino; !
b) la distinzione in teologia: vi è dunque da fare una distinzione tra la theologia in se, la
conoscenza che Dio ha di se stesso, per noi allora incomprensibile, e la theologia in
nobis, la nostra conoscenza relativa di Dio che il nostro intelletto è idoneo a
ricevere. La theologia nostra si orienta verso Dio come al corrispondente del
concetto dell’ens infinitum, ossia il concetto di essere preso nella sua purezza e
semplicità massima, sotto la modalità dell’infinito. Dovrà essere inoltre considerato
come portatore di tutte le perfezioni.!
c) differenti modalità di presenza dell’oggetto di fronte al soggetto: su questa base si
presuppone di poter considerare l’oggetto identico per entrambe le teologie, ma le
modalità di presenza dell’oggetto di fronte al soggetto saranno antitetiche: evidente,
esistenzialistica, intuitiva in Dio; astratta, negativa, indiretta nell’uomo.!
Pagina 71 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
d) L’ASPIRAZIONE DELLA TEOLOGIA DOVRÀ ESSERE LA COMPRENSIONE
DELL’OGGETTO INFINITO CON LA MASSIMA ESTENSIONE DELLA SUA
PENSABILITÀ IN QUANTO TALE. Non attraverso la via analogica di Tommaso, ma
attraverso la Scrittura. Teologia che, informata dalla Rivelazione sulle perfezioni
dell’essere infinito, potrà ora coglierle come oggetti di una conoscenza che saprà
essere dimostrativa e argomentativa, agendo distintamente dalla Rivelazione ma
senza mai contraddirla. La theologia nostra non è la fede, anche se dalla fede si
alimenta necessariamente per poter sussistere quale conoscenza.!
b)teologia e filosofia!
a) distinzione tra filosofia e teologia: si fa qui necessaria un’ulteriore distinzione (oltre a
quella tra teologia in nobis e teologia in se): quella tra la teologia e la filosofia.
Mentre la metafisica pretende di conoscere l’essere come oggetto determinato, la
cui verità è sostenuta dai principi primi della logica e da rapporti necessari di causa
e di effetto, collocandolo all’interno di un ordine naturale considerato come perfetto
e in sé chiuso, la teologia invece considera l’essere come orientato verso a un fine,
che non sarà visibile all’interno della natura, perché non potrebbe porlo altrimenti
come fine ultimo. !
b) il contributo della Rivelazione e la potentia oboedentialis: questo impone ai teologi il
loro aprirsi all’indispensabile acquisizione di una conoscenza supplementare della
verità, che va oltre quella naturale della metafisica. La Rivelazione, funzionante
come un’illuminazione globale, ha il compito di supplire l’inadeguatezza delle
capacità naturali, permettendo all’uomo di spingersi oltre, ovvero mette in atto la
potenza passiva dell’intelletto umano con una informazione attuativa di ordine
soprannaturale. Scoto dà a tale potenza passiva il nome di potentia oboedentialis,
ossia capace di divenire ciò che Dio vuole o vorrà che essa diventi.!
c) lo statuto scientifico della teologia!
c) Le proposizioni teologiche sono complexiones, ovvero proposizioni costruite dalla
congiunzione di termini concettuali e l’intelletto umano può avere conoscenza dei
singoli termini che le costituiscono, ma non potrà mai avere una conoscenza del
loro significato in quanto proposizioni. La theologia nostra allora si risolverà
nell’analisi strumentale dei contenuti di ogni complexum formulato nella Rivelazione,
compiuta con il supporto delle categorie logiche. !
d) il contributo della Rivelazione: la conoscenza scaturita dalla Rivelazione consente di
conoscere anche al di sopra dei phantasmata provenienti dalle percezioni sensibili,
che sono la causa produttiva delle intellezioni naturali astratte. Questo incremento di
conoscenze dato dalla Rivelazione è inesauribile, posta l’inesauribilità dell’oggetto di
conoscenza. La teologia, attraverso la Rivelazione, diventa così portatrice di una
conscenza del tutto diversa da quella della metafisica, che può spingersi a una
accezione generalissima e vaga dell’essere infinito. LA TEOLOGIA NOSTRA SI
COLLOCA SUPRA FIDEM SED INFRA VISIONEM e ha come oggetto Dio in quanto
rivelazione conoscibile dall’uomo. !
Pagina 72 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
e) la theologia in se non è scientia: Per quanto riguarda la teologia in se Scoto esclude
che possa essere considerata scienza in quanto in essa non vi è possibile alcun
incremento di conoscenza. !
f) la theologia come sapientia: Per quanto riguarda la possibilità che la theologia
nostra sia scientia, Aristotele vietava che la scienza potesse includere la
conoscenza del contingente; tuttavia riprendendo l’Etica Nicomachea, se scientia
significa piuttosto un sapere vero contrapposto all’opinione, allora la conoscenza dei
contingenti in teologia dovrà essere accolta come un elemento integrativo
imprescindibile. Meglio ancora, riprendendo Agostino, le teologia è sapientia, in
ragione del fatto che conduce l’intelletto umano a partecipare della certezza e della
nobiltà dell’oggetto conosciuto. La peculiarità della teologia emerge dalla sua natura
pratica e soteriologica, al di sopra di quella conoscitiva. La teologia orienta la
volontà dell’uomo verso il Sommo Bene e ha come esito la salvezza della
redenzione e l’acquisizione della vita eterna. Dunque è certamente più sapienziale
che scientifica.!
d)metafisica e teologia: univocità dell’essere!
a) oggetto e limiti della metafisica: Dun Scoto riconosce che la filosofia abbia pieno
diritto a giudicare l’ambito di conoscibilità naturale dell’essere. Negli ultimi decenni
del XIII secolo venne sottratta qualsiasi pretesa della filosofia di formulare giudizi
sulla felicità ultraterrena, restituendo così piena validità alle questioni filosofiche
sulla speculazione naturale. Dun Scoto riprende Avicenna, per il quale l’oggetto
della metafisica è l’essere in quanto essere, in quanto assicura alla metafisica uno
statuto scientifico distinto e peculiare. La metafisica potrà anche parlare di Dio ma
senza essere portatrice di preambula fidei e senza dover essere sottoposta al vaglio
della regula fidei; potrà ad esempio dire che Dio razionalmente è prirum rerum
omnium principium. !
b) il rifiuto di Tommaso e Agostino: rifiutando sia la tesi Tomista basata sull’astrazione,
sia quella di Agostino sull’illuminazione, Dun Scoto rivendica che prerogativa della
metafisica è conoscere un oggetto che le è sempre e immediatamente noto, in ogni
suo atto di intellezione. !
c) l’essere: l’essere è coestensivo alla ragione, tutto ciò che la ragione conosce è
essere e la ragione può conoscere tutto ciò che è. L’essere di conseguenza è
univoco. La via analogica non è possibile perché non si ha realmente conoscenza
dell’essenza divina e si rischierebbe di introdurre in Dio analogiche imperfezioni.
Inoltre non consente l’argomentazione per via sillogistica. L’essere è colto dalla
metafisica scotiana in tutta la sua univocità, rappresentata dal piano logico, fisico e
metafisico. Si estende dunque a tutto ciò che è ed è il concetto primo dell’intelletto.!
e)l’essere infinito!
Se l’essere univoco comprende le proprietà più generali sia dell’essere finito che di
quello infinito, allora l’esplorazione metafisica degli attributi di Dio dovrà direttamente
puntare sulla considerazione stessa dell’ens infinitum (a priori). !
Pagina 73 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
a) dimostrazione dell’esistenza di Dio: l’esistenza di Dio non è una verità evidente,
perchè se lo fosse sarebbe anche indimostrabile. Invece la sua esistenza è una
nozione conseguente alla sua concepibilità come infinito, e dunque dimostrabile. 1-
Innanzitutto si deve verificare la pensabilità di tale concetto e valutarne il senso, 2-
quindi esaminare fino a che punto sia razionalmente evidente la possibilità della sua
esistenza e 3- infine riconoscerne, come razionalmente evidente, la necessità. !
b) la pensabilità del concetto di ens infinitum: la sua concepibilità implica la
coincidenza in esso di tutte le possibili predicazioni positive che scaturiscono dalla
sua infinità: eterno, immenso, ecc. Non solo l’infinità non ripugna all’intelligibilità
dell’essere, ma anzi essa consente di ammettere l’essere infinito come l’intellegibile
più perfetto. !
c) possibilità della sua esistenza: proprio tale perfetta intelligibilità sostiene il secondo
momento, che consiste nell’interrogarsi sulla possibilità della sua esistenza. La sua
pensabilità significa pensarlo come causa efficiente assoluta, fine ultimo e
perfezione: tre momenti distinti di un unico processo che parte dalla pensabilità
relativa dell’essere finito che scopre di doverla subordinare alla pensabilità assoluta
dell’essere infinito. Ad esempio l’esistenza di graduabili perfezioni rinvia in modo
persuasivo alla perfezione in sommo grado. !
d) necessità della sua esistenza: terzo momento dell’argomentazione: tale essere
infinito esiste necessariamente? Dun Scoto non prende in considerazione le vie di
San Tommaso e propone un nuova via, suggerendo di procedere per viam
eminentiae: basta pensare all’infinita varietà degli intelligibili che il nostro intelletto
trova progressivamente conoscendo, per scoprire che se essi sono veri è perché
sono tutti pensabili e pensati in un intelletto perfetto infinito; oppure si pensi
all’infinita verità dei fini. !
e) “coloratio Anselmi”: si arriva a una “coloratio Anselmi”, ovvero valorizzare
l’Argumentum sottoponendolo a un perfezionamento formale, perché l’essere
infinito è veramente infinito se si dimostra la sua pensabilità come essere infinito, e
tale pensabilità consiste esattamente nella sua non-contradittorietà. Proprio perché
è pensabile come sommo infinito, e in quanto tale come punto d’arrivo delle
aspirazioni conoscitive dell’intelletto, questo primo non sarebbe pensabile come tale
se non avesse l’essere attuale, perché non può ricevere una causa da qualcos’altro.!
f)il volontarismo divino e le sue conseguenze: realtà e conoscibilità dell’essere
finito
a) L’essere finito esiste soltanto perché la causa infinita lo fa essere sic et nunc nella sua
immediatezza e irripetibilità. Così sparisce tutta l’articolata gerarchia delle cause
seconde. La causa divina, essendo infinita, deve essere assolutamente libera e
onnipotente e porta le cose a passare dalla loro pensabilità nell’intelletto divino alla loro
realtà storica dove sono possibili come effetti di una infinita liberissima volontà. !
b) le due legislazioni: Dio ha fissato nell’universo due legislazioni: la potentia ordinata,
che corrisponde alle leggi naturali, tramiti del volere di Dio; quella absoluta, che riflette il
suo volere in modo assoluto e diretto. In quanto absoluta è condizionata soltanto da se
stessa, soltanto dal principio di non contraddizione, ed è il principio causale di qualsiasi
Pagina 74 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
evento alternativo all’ordine del creato. Ogni determinazione dell’essere dipende dal
fatto che Dio la vuole. !
c) l’haecceitas: questo radicale volontarismo divino fa sì che l’unica determinazione
possibile dell’essere finito nella sua realtà è il suo essere finito stesso, voluto come tale
dal Creatore, che fa essere ogni cosa particolare nel modo in cui è; i discepoli di Duns
Scoto utilizzeranno il termine haecceitas, ossia la differenza individuale di ogni creatura,
conoscibile dall’uomo come oggetto di una intuitiva percezione della singolarità. !
d) la conoscenza intuitiva: la conoscenza intuitiva è sufficiente al riconoscimento
dell’esistenza presente della cosa singolare, superiore a quella astrattiva con la quale
l’intelletto tenta di cogliere una natura communis presentandola in forma di species,
senza curarsi rispetto alla sua esistenza o meno. !
e) nuova concezione della scienza: Duns Scoto può dunque capovolgere il paradigma
scientifico inaugurando una nuova concezione di scienza, orientata a una
considerazione probabilistica ma intenzionale e possibile dei fenomeni; OGGETTO DI
QUESTO TIPO DI SCIENZA SARANNO LE RELAZIONI DI COMPOSSIBILITÀ TRA LE
RES ESPRESSE MEDIANTE PROPOSIZIONI COMPLESSE LA CUI EVIDENZA È
SOSTENUTA DALLA SEMPLICE INTUIZIONE. In questa nuova concenzione della
natura contingente l’entità materiale ha una sua predisposizione a essere formata da
tutte le possibili forme che entrano in combinazione con essa. Le diverse forme possono
essere sottoposte a misurazione all’interno del composto, i cui elementi costitutivi sono
distinguibili perchè rispondono a definizioni diverse e svolgono funzioni diverse, ma non
sono distinti in modo reale perchè la loro realtà è qualcosa di unico e inseparabile. Tra
gli elementi costitutivi di ogni cosa c’è una distinctio formalis.!
g)la distinctio formalis e le sue conseguenze: l’eterna predestinazione di Cristo
La dottrina della distinctio formalis è stata utilizzata e sottoposta a elaborazioni in ambito
teologico; l’impossibilità per il nostro intelletto di rappresentare e comprendere l’ente
infinito trova un primo soccorso proprio nel delinearsi di una distinctio formalis tra le
perfezioni divine, che pur essendo un’unica realtà rispondono a distinte definizioni
formali. Ma questa distinctio viene estesa anche alle operazioni divine ad extra, cosicché
non comporta alcuna alterazione dell’unità divina il fatto che il Verbo si relazioni
formalmente in modo particolare alla Creazione. La Creazione è una conseguenza della
predestinazione di Cristo, infatti il Mondo viene creato allo scopo di accogliere il Verbo
che si distingue formalmente dalle altre due persone in quanto caratterizzato dal perfetto
relazionarsi ad extra dell’amore divino. Il Verbo incarnato scende in terra anche per
correggere l’orientamento deviante della storia umana causato dal peccato di Adamo. La
stessa Maria certamente è esente dal peccato in quanto predestinata ad accogliere il
Cristo.!
h) la volontà umana e la sua libertà!
La volontà umana, il cui fine è raggiungere Dio, agisce con autentica libertà a partire
dalle informazioni conoscitive provenienti dall’intelletto. L’atto volontario è il modo
autonomamente razionale di una potenza capace di scegliere tra oggetti distinti e anche
opposti; non vi è alcuna dipendenza necessaria dalla sfera intellettiva, perché nel suo
tendere al bene infinito attraverso beni particolari non è obbligata a rispettare una
graduatoria imposta dall’intelletto nel riconoscimento di una maggiore o minore dignità
Pagina 75 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
fra essi. L’intelletto non è in grado di riconoscere quidditivamente l’essere infinito e
quindi di confrontare con esso i beni finiti. !
Anche sul piano morale vi sono due legislazioni: la legge naturale corrispondente alla
potentia ordinata, e la suprema legge divina corrispondente a quella absoluta. La
Rivelazione guida la volontà nel suo perfezionamento: dal rispetto della legge naturale
(perseguire sempre il bene) a quello della legge divina, che aiuta l’uomo con normative
superiori (il decalogo e il comandmento dell’amore a Dio e al prossimo) a orientarsi nella
scelta dei beni particolari. Solo la Rivelazione può mostrare la loro maggiore o minore
coerenza con il Bene supremo.!
Gugliemo di Ockham
a) Il “Venerabilis Inceptor”
Definito “Venerabilis Inceptor” poichè non ha mai conseguito la licenza magistrale in
teologia, tenne lezioni allo studium generale francescano di Londra dal 1321 fino al 1324
quando fu convocato ad Avignone per difendersi dall’accusa di eresia da parte di
Giovanni Lutterell, il quale aveva composto un “Libellus contra doctrinam Guglielmi”,
denunciando grave devianze dottrinali: Guglielmo sottraeva infatti ogni oggettività al
fondamento universale dei giudizi scientifici, ridotti a vuote strutture mentali prive di
corrispondenza con la realtà naturale. La difesa di Guglielmo verteva sul rimprovero ai
suoi avversari di fare cattivo uso delle regole logiche. Ad Avignone l’incontro con Michele
da Cesena fu determinante ai fini della sua conversione all’ordine degli Spirituali e alla
causa della povertà apostolica. Nel 1328 contestualmente al verdetti di eresia di 7 degli
articoli incriminati, Ockham fuggiva con i confratelli più coinvolti e raggiungeva
l’imperatore Ludovico il Barbaro a Pisa, seguendolo poi a Monaco. In questa città spese
quasi un ventennio nell’elaborazione di un’ampia trattatistica teologico-politica sulla
povertà e sul confronto fra potere pontificio e imperiale. Morì nel 1347.!
b) La teoria della verità: notitia intuitiva e notitia abstractiva, termine incomplexum
e complexum preposizionale!
La sua riflessione logica parte dal presupposto che il fondamento della corrispondenza
tra il significare mentale e il significato extra-mentale è da ricercare nella corrispettiva
singolarità dell’elemento concettuale atomico. Lo studio della Logica comincia con quello
dei significanti, immediati e semplici, nel quale va ricercata la condizione di
corrispondenza tra pensiero, linguaggio e realtà. !
a) la teoria della conoscenza: Guglielmo comprende, come Duns Scoto, come soltanto
l’intuizione possa essere preliminare a ogni acquisizione del sapere. Ma a differenza
di Scoto ritiene che non soltanto è evidenza intuitiva la percezione diretta della
presenza esterna dell’oggetto, ma anche i propri atti interiori, le operazioni
intellettuali e i moti immediati dell’anima. E in questa sfera dell’interiorità intuitiva
primeggiano i principi primi logici: A è A; A è diverso da -Non A; Oltre A e -Non A non
è possibile un terzo. Dai principi primi scaturiscono per via deduttiva anche
proposizioni universali necessarie, oggetto immediato della scienza ed evidenti; !
b) differenza tra intuizione e astrazione: secondo Ockham è intuitiva ogni apprensione
semplice che permette di sapere se una cosa esiste, mentre è astrattiva una
conoscenza che prescinde dall’esistenza o meno dell’oggetto in questione. La
Pagina 76 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
differenza tra i due tipi di conoscenza riguarda soltanto l’habitus da parte del
soggetto di cogliere l’oggetto, non la diversità dell’oggetto. !
c) incomplexa e complexa: Quando la conoscenza intuitiva ha a che fare soltanto con i
termini logici incomplexa (ossia non ancora congiunti in proposizioni), la sua
capacità di essere vera è esclusivamente relativa alla semplice connotazione
significativa del soggetto, non ancora alla sua realtà. La conoscenza dei complexa
richiede invece anche l’assenso e le proposizioni saranno vere quando saranno
confermate dal riconoscimento intuitivo della sua corrispondenza con la realtà
esterna. Sono vere tutte le proposizioni singolari necessarie, quelle universali
necessarie, quelle singolari contingenti, non vere quelle universali contingenti,
prodotte dalla conoscenza astrattiva non più supportata dai quella intuitiva.
!
c) la dottrina della suppositio e il nominalismo
La possibilità umana di formulare un discorso scientifico, ossia corrispondente alla
realtà, è subordinata a una valutazione della capacità significativa dei termini all’interno
delle proposizioni che possono pretendere di essere vere. !
a) la teoria di Pietro Ispano: Pietro Ispano distingueva termini categorematici, capaci di
esprimere autonomamente un significato compiuto, da quelli sincategorematici,
incapaci di stare da soli. Quando un categorematico viene inserito in una
proposizione, è necessario specificare per quale delle tante cose di cui è predicativo
svolga la funzione di significare, ovvero di essere messo al posto di qualcosa per
indicarlo (supponere pro) e si distinguono vari tipi di suppositiones. Ockham esclude
tutte le suppositiones improprie, secondo le quali il termine è usato con finalità
indiretta. !
b) le tre forme di suppositio: indvidua tre forme di suppositio proprie: materialis,
quando il termine sta a significare la sua stessa materialità grafica, vocale o verbale;
personalis, quando il termine sta per ciò che esso è chiamato a significare, quando
il termine sta per il suo significato; simplex, quando il nome non sta per il suo
significato naturale e primario, ma tende a esprimere qualcosa di comune alle cose
che rientano nel suo significato personale, e che è diverso da ciò che esse sono
(es. l’uomo è una specie). Semplice è dunque la supposizione che fa corrispondere
al termine una proprietà logica, che si presenta come aliquid commune alle cose
significate, ma non è tali cose. Ne segue che quando nella proposizione il termine
svolge una suppositio personalis, a esso corrisponde qualcosa di reale, mentre
quando svolge una suppositio simplex, a esso corrisponde sì qualcosa, ma mai una
res, bensì sempre un puro prodotto del pensiero. Dalla simplex alla personalis si ha
una discesa verso la concretezza. !
c) gli universali: L’universale è tale soltanto nell’anima, dunque non ha realtà, ma
quando, con la suppositio personalis, viene utilizzato per indicare qualcosa fuori
dell’anima, allora significa la realtà di tutti gli individui concreti. Fuori dell’anima non
esiste alcun prodotto dell’anima. L’universale non è altro che un’intentio che
orienta il conoscente verso la somiglianza tra due o più cose. Per l’intelletto è
evidente soltanto l’oggetto singolare, intuitivamente colto come legato al predicato
dell’esistenza, e solo a esso può dare il proprio assenso riconoscendone la realtà
extramentale. Quello che verrà poi chiamato “nominalismo” è la vera propria
Pagina 77 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
affermazione di un primato dell’individuo, che opera un taglio netto nei confronti del
rigido ordinamento esemplaristico.!
d) il primato dell’individualità e i “rasoi di Ockham”!
La logica è lo strumento per conoscere l’opera di Dio. Non si danno se non res singolari,
con proprietà individuali, contingenti, che costituiscono un mondo aperto a molteplici
possibilità. Questa logica porta Ockham a un’innovativa concezione dell’essere tale da
demolire le elaborazioni scientifiche e metafisiche che l’hanno preceduto. Quest’opera di
demolizione prende il nome di “rasoi di Ockham” e si tratta di due principi che lo hanno
costantemente guidato nella sua riforma del pensiero umano e dunque governano la sua
m e t a fi s i c a c o m e l a s u a t e o l o g i a : I L P R I N C I P I O D E L L’ A S S O L U T E Z Z A
INCONDIZIONATA DELL’ONNIPOTENZA DIVINA E IL PRINCIPIO DELL’ECONOMIA.
Poichè Dio può tutto e poichè Dio è il Sommo Bene “frustra fit per plura quod potest fieri
per pauciora” e poi questo enunciato è corredato da numerosi altri, tra cui ad esempio
“non si deve porre alcuna pluralità se non è necessario”. Il più conosciuto è certamente il
seguente: “entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem”!
e) la nuova concezione della scienza!
La scienza non può più essere concepibile come l’esito di un’adaequatio rei et
intellectus, ma è sempre soltanto la formulazione di un discorso sulla verità delle
proposizioni. E verità e falsità dipendono soltanto dalla relazione della proposizione con
il modo di essere della cosa. La scienza nasce dall’assenso alla verità di una
proposizione e si ha scienza solo nel caso di proposizioni singolari. Tuttavia la scienza
non concerne i singolari in quanto mutevoli, ma le intenzioni dell’anima che suppongono
per le cose corruttibili, ossia universali che suppongono per i singolari. Gli universali
restano comunque meri prodotti della mente. Si dovrà distinguere tra le scienze reali,
che risultano da termini che suppongono per realtà extramentali, e le scienze mentali,
che risultano da termini che suppongono per concetti e altre intenzioni della mente. La
scienza deve avere carattere di necessità e procedere per via deduttiva. !
f) la teologia come sapienza!
Ockham si domanda se sia possibile costruire una scienza del divino, che rispetti le
medesime regole vigenti per le scienze naturali. Ockham rifiuta la proposta scotista di
considerare scienza la theologia in se. Mentre invece la theologia nostra, che è l’unica
teologia possibile, è esclusivamente ricondotta a dipendere dalla conoscenza della
Rivelazione. La domanda inziale si risolve in quella se sia possibile avere una
conoscenza evidente del dato rivelato; è chiaro che le verità della Rivelazione non sono
evidenti nè per se, nè per experientiam. Inoltre per il principio di economia è impossibile
che Dio abbia proposto all’uomo come oggetto di fede qualcosa che potrebbe essergli
noto in modo evidente anche per altra via. Vi sono tuttavia per il credente, oltre le
conoscenze offerte dalla Rivelazione, conoscenze di ordine teologico che possono
essere riconosciute come necessarie. Sono predicazioni teologiche posteriori alla fede,
che supponunt pro Deo, dicono cioè qualcosa di dicibile su Dio. La teologia, non è
comunque scienza, ma è qualcosa di più della scienza stessa: è una conoscenza di
ordine sapienziale. Dio non è conoscibile da parte degli uomini, tuttavia l’uomo ha avuto
in dono la Sacra Scrittura, che sola indica le vie per parlare veramente di Dio, e per dare
al termine Dio una capacità suppositiva esplicabile in un discorso sul suo significato. !
Pagina 78 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
lOMoARcPSD|11702785
g) la libertà della fede!
Al radicale volontarismo della sua teologia fa da contraltare un altrettanto incisivo
volontarismo morale che pone al centro l’uomo come atomo indivisibile mosso da
un’incondizionata volontà, libera di orientare tutti i suoi atti verso le finalità che può
indicare al suo assenso soltanto una fede altrettanto libera. La libertà della fede è per
Ockham il fondamento della sua aspirazione a svincolare e purificare la Chiesa dai suoi
condizionamenti terreni. La stessa radicalità francescana è da intendersi come il
tentativo di realizzare i comandamenti nelle forme indicate dai testi evangelici, all’interno
di una condizione di assoluta libertà da parte dei fedeli. Ockham indica inoltre il ruolo del
potere pontificio, finalizzato alla guida dell’intero genere umano verso la beatitudine
promessa con la redenzione. Nel cuore di questa rigenerazione ideale della Chiesa
storica brillano gli effetti del principio di economia, che demolisce ogni struttura falsa e
falsificante sovrapposta dagli uomini con i loro artifici.!
Pagina 79 di 79
Downloaded by Paolo Giraudo (girdapaolo@gmail.com)
Potrebbero piacerti anche
- Il Pensiero Occidentale Dalle Origini Ad OggiDocumento28 pagineIl Pensiero Occidentale Dalle Origini Ad OggiFederica Di Chio100% (1)
- E Book Conoscenza Meditazione ContemplazioneDocumento307 pagineE Book Conoscenza Meditazione ContemplazionesterlinaNessuna valutazione finora
- Scientia CrucisDocumento22 pagineScientia CrucisAntonio De FilippisNessuna valutazione finora
- De Libero Arbitrio AgostinoDocumento26 pagineDe Libero Arbitrio AgostinoGiusy ZerilliNessuna valutazione finora
- Antropologia TeologicaDocumento87 pagineAntropologia TeologicaD Paolo Arena100% (1)
- Sant'agostinoDocumento4 pagineSant'agostinoElena della VellaNessuna valutazione finora
- Il Pensiero Di AgostinoDocumento4 pagineIl Pensiero Di AgostinoNeraEssenzaNessuna valutazione finora
- Il Pensiero Di AgostinoDocumento4 pagineIl Pensiero Di AgostinoNeraEssenzaNessuna valutazione finora
- P Teodoro Teologia MoraleDocumento624 pagineP Teodoro Teologia MoraleGiorgia LovatoNessuna valutazione finora
- Capisaldi Della Dottrina Dell'entità 'A'Documento8 pagineCapisaldi Della Dottrina Dell'entità 'A'Giulio Dimaria100% (1)
- La Ruota Dell'esistenzaDocumento270 pagineLa Ruota Dell'esistenzacapoverdeNessuna valutazione finora
- Il Rapporto Fra Fede e RagioneDocumento8 pagineIl Rapporto Fra Fede e RagioneStefanRaduNessuna valutazione finora
- Persona e Atto - DispensaDocumento33 paginePersona e Atto - DispensaStrokers sTkNessuna valutazione finora
- Appunti Filosofia Morale PDFDocumento110 pagineAppunti Filosofia Morale PDFdaniloNessuna valutazione finora
- Fides Et Ratio PDFDocumento156 pagineFides Et Ratio PDFfrancesca_sciancaleporeNessuna valutazione finora
- Frutti Don I Dello SpiritoDocumento16 pagineFrutti Don I Dello Spiritogreenbuddy123Nessuna valutazione finora
- Schemi Appunti Ontologia e Metafisica INTRODUZIONE HEGEL - SISTEMADocumento6 pagineSchemi Appunti Ontologia e Metafisica INTRODUZIONE HEGEL - SISTEMAgiusarma56Nessuna valutazione finora
- Immanuel Kant - Scritti Di Storia, Politica e DirittoDocumento17 pagineImmanuel Kant - Scritti Di Storia, Politica e DirittoEmanuele GiustiniNessuna valutazione finora
- Agostino Anselmo TommasoDocumento11 pagineAgostino Anselmo TommasoElisa CasadeiNessuna valutazione finora
- Filosofia AgostinoDocumento6 pagineFilosofia AgostinoDaniele VarlettaNessuna valutazione finora
- AgostinoDocumento4 pagineAgostinoCixo Gabriel DanteNessuna valutazione finora
- Boezio e Agostino - Sintesi FrammentariaDocumento8 pagineBoezio e Agostino - Sintesi FrammentariaFrancescoMaria VarrialeNessuna valutazione finora
- Sant'AgostinoDocumento2 pagineSant'AgostinoMartina VitielloNessuna valutazione finora
- AGOSTINODocumento8 pagineAGOSTINOgeorgiaNessuna valutazione finora
- Appunti Filosofia 4° Anno Liceo ScientificoDocumento4 pagineAppunti Filosofia 4° Anno Liceo ScientificoNoel Di FrescoNessuna valutazione finora
- Riassuntone Del D'OnofrioDocumento44 pagineRiassuntone Del D'OnofrioChristopher Ernesto MarangoneNessuna valutazione finora
- Sant'Agostino D'ippona - AppuntiDocumento6 pagineSant'Agostino D'ippona - Appuntiluca.inge6128Nessuna valutazione finora
- AgostinoDocumento2 pagineAgostinoedoardoNessuna valutazione finora
- CAP.13 AgostinoDocumento3 pagineCAP.13 AgostinocuconeNessuna valutazione finora
- I Principali Tratti Del Pensiero AgostinianoDocumento3 pagineI Principali Tratti Del Pensiero AgostinianoRaff DlsNessuna valutazione finora
- Aurelio AgostinoDocumento10 pagineAurelio AgostinoNicola RosielloNessuna valutazione finora
- San BonaventuraDocumento4 pagineSan BonaventuraGaetano83Nessuna valutazione finora
- AgostinoDocumento5 pagineAgostinoLUISANessuna valutazione finora
- Eta' ModernaDocumento3 pagineEta' ModernaEva SlimanNessuna valutazione finora
- BergsonDocumento3 pagineBergsonsvevaNessuna valutazione finora
- AgostinoDocumento6 pagineAgostinofabiomalesaNessuna valutazione finora
- Sant' Agostino - Tutti A Bordo-DislessiaDocumento12 pagineSant' Agostino - Tutti A Bordo-DislessiaFrancesca StoraceNessuna valutazione finora
- FILOSOFIADocumento22 pagineFILOSOFIAChiaraNessuna valutazione finora
- Appunti Teologia. CattolicapdfDocumento15 pagineAppunti Teologia. CattolicapdfValentina VolpiNessuna valutazione finora
- Interiorita in Santo AgostinoDocumento21 pagineInteriorita in Santo AgostinoAndre CastroNessuna valutazione finora
- S TomkantDocumento27 pagineS Tomkantxdde19Nessuna valutazione finora
- Marchino Risvegliare EnergiaDocumento5 pagineMarchino Risvegliare EnergiacaspoNessuna valutazione finora
- Anselmo D'aostaDocumento5 pagineAnselmo D'aostaDaria GeriaNessuna valutazione finora
- Agostino Di IpponaDocumento9 pagineAgostino Di IpponaGiovanni Paolino100% (1)
- Michelina Tenace. NELLA TEOLOGIA ORIENTALE, ASPETTI DELL'AZIONE DELLO SPIRITO SANTO NELLA PERSONADocumento27 pagineMichelina Tenace. NELLA TEOLOGIA ORIENTALE, ASPETTI DELL'AZIONE DELLO SPIRITO SANTO NELLA PERSONAFelipe SESNessuna valutazione finora
- Dove È Dubbio - RevDocumento13 pagineDove È Dubbio - RevatrabucchiNessuna valutazione finora
- Agostino, Bonaventura, Tommaso D'aquinoDocumento2 pagineAgostino, Bonaventura, Tommaso D'aquinoMorena ScaglioneNessuna valutazione finora
- Storia Della Filosofia Medievale AppuntiDocumento28 pagineStoria Della Filosofia Medievale AppuntiEdoardo SacchettoNessuna valutazione finora
- PASCALDocumento9 paginePASCALpaolo.ferretoNessuna valutazione finora
- Domande Chiuse Esame Filosofia 1Documento19 pagineDomande Chiuse Esame Filosofia 1Francesco FucciNessuna valutazione finora
- Appunti Filosofia Kant, Fichte, HegelDocumento7 pagineAppunti Filosofia Kant, Fichte, HegelAlessio UffreduzziNessuna valutazione finora
- Latino Esame: Sant'AgostinoDocumento1 paginaLatino Esame: Sant'AgostinoMartina VitielloNessuna valutazione finora
- Sant' Agostino e Controriforma 2Documento6 pagineSant' Agostino e Controriforma 2Martina RomagnoliNessuna valutazione finora
- HegelDocumento7 pagineHegelIlaria PolifroneNessuna valutazione finora
- Aspetti Antropologici della gratuità in Giuliano AgrestiDa EverandAspetti Antropologici della gratuità in Giuliano AgrestiNessuna valutazione finora
- Neoplatonismo e PlotinoDocumento4 pagineNeoplatonismo e PlotinoGiulia GhianiNessuna valutazione finora
- Spinoza PDFDocumento7 pagineSpinoza PDFGaia Di LorenzoNessuna valutazione finora
- Filosofia A Empirismo RazionalismoDocumento28 pagineFilosofia A Empirismo RazionalismoMaxNessuna valutazione finora
- HEAM GiordanoBRUNO RiassuntoDocumento8 pagineHEAM GiordanoBRUNO RiassuntoHoracio Eduardo Antonelli MattersonNessuna valutazione finora
- Riassunto Su SpinozaDocumento5 pagineRiassunto Su Spinozababe_mcNessuna valutazione finora
- Etica Del Finito e NeopaganesimoDocumento11 pagineEtica Del Finito e NeopaganesimoEsonet.orgNessuna valutazione finora
- L'etica Di SpinozaDocumento3 pagineL'etica Di Spinozascevola09Nessuna valutazione finora
- Shopenauer, Kierkegard, FeuerbachDocumento7 pagineShopenauer, Kierkegard, FeuerbachsaraNessuna valutazione finora
- "Dio è esistito come i dinosauri, poi si è estinto": Considerazioni sull'esistenza di Dio e sulla relazione che l'essere umano ha con il divinoDa Everand"Dio è esistito come i dinosauri, poi si è estinto": Considerazioni sull'esistenza di Dio e sulla relazione che l'essere umano ha con il divinoNessuna valutazione finora
- Hans Jonas Il Principio Di ResponsabilitàDocumento6 pagineHans Jonas Il Principio Di ResponsabilitàRebecca Di BerardinoNessuna valutazione finora
- Test Prime (1periodo) - ReligioneDocumento2 pagineTest Prime (1periodo) - ReligioneFrancesca SennaNessuna valutazione finora
- Che Cosa È La FilosofiaDocumento79 pagineChe Cosa È La FilosofiaElio FerraraNessuna valutazione finora
- Dennett - Estratto Da La Coscienza Che Cosa ÈDocumento18 pagineDennett - Estratto Da La Coscienza Che Cosa ÈElio FerraraNessuna valutazione finora
- Storia Delle Dottrine PoliticheDocumento65 pagineStoria Delle Dottrine PoliticheElio FerraraNessuna valutazione finora
- Einaudi Nuvole Bianche For Guitarpdf PDFDocumento2 pagineEinaudi Nuvole Bianche For Guitarpdf PDFElio FerraraNessuna valutazione finora
- Lodi Di Dio AltissimoDocumento1 paginaLodi Di Dio AltissimoAlessandro CicognaniNessuna valutazione finora
- Schopenhauer, KierkegaardDocumento10 pagineSchopenhauer, Kierkegaardferroirene2008Nessuna valutazione finora
- Verifica Di Filosofia - KantDocumento2 pagineVerifica Di Filosofia - KantNiccolò SchermiNessuna valutazione finora
- Illuminismo e RousseauDocumento7 pagineIlluminismo e RousseauUnGayNessuna valutazione finora
- Mariologia Di Sant'Efrem Siro. Studio Degli Inni Alla Beata Maria VergineDocumento25 pagineMariologia Di Sant'Efrem Siro. Studio Degli Inni Alla Beata Maria VerginePippoBaudo23Nessuna valutazione finora
- La Prima ConversioneDocumento19 pagineLa Prima ConversioneIosif SandoruNessuna valutazione finora
- Thomas Szasz - La Teologia Della Medicina (Ed. 3)Documento31 pagineThomas Szasz - La Teologia Della Medicina (Ed. 3)Tristano AjmoneNessuna valutazione finora
- Sete Di Parola - XXXI Settimana T.O. - ADocumento10 pagineSete Di Parola - XXXI Settimana T.O. - AJasmin SabljakovicNessuna valutazione finora
- Purità Come Valore MetafisicoDocumento6 paginePurità Come Valore MetafisicoSheenky_webNessuna valutazione finora
- La Fine Della Filosofia "È" Il Compito Del PensieroDocumento8 pagineLa Fine Della Filosofia "È" Il Compito Del PensieroSaso Bellantone100% (1)
- Immanuel KantDocumento8 pagineImmanuel KantElettra RizzottiNessuna valutazione finora
- Servizio Ecclesiale Del TeologoDocumento11 pagineServizio Ecclesiale Del TeologoframaceriNessuna valutazione finora
- La Chiesa Primo Soggetto Della Fede - JimenezDocumento14 pagineLa Chiesa Primo Soggetto Della Fede - JimenezDiego LopesNessuna valutazione finora
- Sant' Agostino e Controriforma 2Documento6 pagineSant' Agostino e Controriforma 2Martina RomagnoliNessuna valutazione finora
- TEOGENESIDocumento297 pagineTEOGENESIramano1942Nessuna valutazione finora
- Hegel e La GuerraDocumento8 pagineHegel e La Guerrainnominabile64Nessuna valutazione finora
- Riassunto Autolimitazione Razionale e DesiderioDocumento11 pagineRiassunto Autolimitazione Razionale e DesideriosaraNessuna valutazione finora