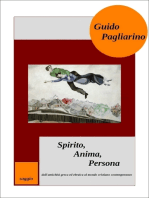Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Schemi Appunti Ontologia e Metafisica INTRODUZIONE HEGEL - SISTEMA
Caricato da
giusarma56Titolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Schemi Appunti Ontologia e Metafisica INTRODUZIONE HEGEL - SISTEMA
Caricato da
giusarma56Copyright:
Formati disponibili
Laurea Magistrale in Filosofia – AA. 2019-2020 – 1°- 2° Semestre – Ontologia e Metafisica – Prof.
Marco Dario SACCHI
INTRODUZIONE A HEGEL
Si tratta di un’opera inizialmente concepita come
Il sapere assoluto non è dato
introduzione al sistema, ma che finisce per La Fenomenologia, tracciando il cammino della
con un colpo di pistola, è una
“Fenomenologia costituire un’opera a se stante. Essa descrive il il
conquista che si ottiene con un
coscienza, si riferisce alla coscienza dell’umanità, non
solo a quella pratica, ma anche a quella teoretica
vero sapere, o il cammino dell’anima che percorre
dello spirito” la serie delle sue figure per purificarsi e diventare
lungo percorso.
spirito, mentre arriva alla conoscenza di ciò che
essa è in sé.
cioè quel momento in cui si crede che l’oggetto del sapere sia, indipendentemente dal
La prima parte è dedicata alla coscienza sapere stesso. Questo accade nella certezza sensibile, nella percezione e nell’intelletto.
La coscienza dell’altro è autocoscienza, cioè scoperta che l’in sé dell’oggetto è la coscienza stessa, che la coscienza è la stessa verità
L’autocoscienza si manifesta prima come vita, di cui la prima manifestazione è l’appetito, inteso come tendenza all’autoconservazione e
all’affermazione. A tal proposito, Hegel introduce la celebre dialettica servo-padrone. In essa, due autocoscienze si trovano l’una di fronte all’altra e
lottano per il riconoscimento. Una delle due, per paura della morte, si arrende e diviene lo schiavo, mentre l’altra diventa padrone. Lo schiavo
Coscienza e produce i beni di cui il padrone gode, ed è nel suo lavoro che egli riscatta la sua indipendenza: dando forma alle cose, ne diviene padrone, mentre il
autocoscienza padrone dipende da lui per poter fruire di quelle cose. Lo schiavo prende coscienza di sé, del suo valore: il fatto di essere pensante, di essere
autocoscienza libera.
Dalla figura dello schiavo si passa a quella dello stoicismo: per gli Stoici, infatti, tutti gli uomini sono uguali e la loro dignità risiede nel pensiero. Il
problema dello stoicismo è la mancanza della pienezza della vita. Lo stoicismo, in quanto pensiero che si apparta dal mondo, trapassa nello
scetticismo, che è pensiero che nega il mondo. Questo genera una scissione nell’autocoscienza, in cui viene percepito qualcosa di immutabile (la
coscienza) e qualcosa di continuamente contraddittorio: si tratta della figura della coscienza infelice, che è tale in quanto scissa. Tale atteggiamento
si trova nel cristianesimo, in cui di fronte a Dio la coscienza si annulla. L’autocoscienza deve riconciliarsi con la realtà e divenire ragione.
La ragione è la certezza che la coscienza ha di essere ogni realtà. In tale certezza consiste l’idealismo, che è l’affermazione che tutto è coscienza.
Nell’idealismo inteso da Hegel, tale certezza è il punto di arrivo, a differenza di quanto accade nell’idealismo fichtiano, in cui essa è il punto di
La ragione partenza.
è necessario seguire il percorso della coscienza che si fa ragione. La coscienza inizia cercando di identificare a sé la natura, ma non ci riesce. Dato che
la ragione non si attua come ragione che contempla, essa cerca di attuarsi da sé, nell’attività pratica. L’autocoscienza tenta di realizzarsi prima come
individuo, ma poi questo individuo diviene ragione universale, che unifica ogni autocoscienza.
Giuseppe ARMANI 4912780
Laurea Magistrale in Filosofia – AA. 2019-2020 – 1°- 2° Semestre – Ontologia e Metafisica – Prof. Marco Dario SACCHI
INTRODUZIONE A
La coscienza diventa spirito con l’eticità. Le figure dello spirito, che è sfera della coscienza nella comunità civile, sono
HEGEL
spiriti reali inseriti nella storia. Il mondo greco rappresenta il mondo della libertà bella, in cui non c’è ancora stato il
travaglio della consapevolezza razionale. Già in tale mondo sembrano nascere opposizioni, come quella fra legge umana
“Fenomenologia Lo spirito e legge divina (cfr. Antigone). Nel mondo greco, però, non c’è opposizione tra coscienza individuale e collettiva. Essa
dello spirito” emerge nel mondo romano, in cui il diritto si oppone alle persone dei cittadini. La sintesi è rappresentata invece dal
mondo moderno.
Coscienza e La ragione
autocoscienza
Nella ricostruzione suddetta, è fondamentale l’alienazione della persona astratta. Il mondo civile sorge dal
Dall’autocoscienza allo spirito, movimento per cui l’autocoscienza si aliena dalla sua personalità, esce dal suo stato di natura e si afferma come
Hegel fornisce una filosofia dello essere sociale. Di fronte alla civilà laica sta la fede e in atteggiamento critico rispetto ad entrambe sta la pura
spirito oggettivo. A partire dalla intellezione. Quest’ultima coincide con l’atteggiamento illuministico, che esalta la ragione e considera la religione un
religione, invece, comincia la ammasso di errori, nati su un fondamento di verità che è la religione naturale. Essa viene travisata dal clero, che
filosofia dello spirito assoluto. inganna il popolo, con l’aiuto del dispotismo politico. Per Hegel, invece, la religione è pensiero dell’assoluto. Egli parla
La religione è rappresentazione Religione poi di libertà assoluta, una volontà che non lascia sussistere nulla di fronte a sé: tale figura corrisponde alla
dell’assoluto, è pensiero, non e filosofia Rivoluzione Francese, che culmina nel terrore. La morale kantiana è il suo parallelo: nella Rivoluzione non c’è
ancora concetto. La religione opposizione tra individuo e stato e nella morale kantiana non c’è opposizione tra volontà e legge. Tuttavia, la legge si
non si trova allo stesso livello presenta come un dover essere: per superare tale difficoltà, ci si appella alla coscienza, cioè un atteggiamento in cui
della filosofia, perché ritiene si conosce direttamente ciÒ che è bene e ciò che è male. Esso assume la forma dell’anima bella, che, però, si ritrae
l’assoluto separato dalla dall’azione.
coscienza.
la religione artistica, in cui lo spirito si sa come naturalità tolta, perché le rappresentazioni
dell’assoluto sono figure umane. Si tratta delle divinità greche, rappresentate dapprima tramite
la scultura, e a cui poi viene conferita la parola, mediante gli oracoli. Il Dio si esprime poi
La prima forma di religione
chiaramente, con la poesia epica e con la tragedia.
La seconda
forma di religione
La terza forma di religione
è quella naturale, in cui lo
spirito sa se stesso
rappresentandosi in forma di La terza forma é la religione rivelata e si realizza nel cristianesimo, in cui l’assoluto é
figure attinte dalla natura. presente come autocoscienza, come uomo reale. Il contenuto del cristianesimo é filosofico, ma
la comunità lo pensa in forma rappresentativa, cioé riferito ad un uomo inserito nella storia. Allo
stesso modo, la dottrina della Trinità esprime un movimento dialettico nella divinità ed esprime
l’assoluto come spirito. È necessario superare la forma della rappresentazione.
Giuseppe ARMANI 4912780
Laurea Magistrale in Filosofia – AA. 2019-2020 – 1°- 2° Semestre – Ontologia e Metafisica – Prof. Marco Dario SACCHI
INTRODUZIONE A L’oggetto della Fenomenologia è la coscienza come
HEGEL sapere concreto, cioé immerso nell’esteriorità. La La logica si occupa dunque dei principi, delle
progressione di tale oggetto, tuttavia, riposa sulla strutture che stanno a fondamento della realtà
Che cosa è la concrete offerte dall’esperienza. Ecco che la
LOGICA natura delle pure essenzialità che costituiscono il
logica si identifica con la metafisica. La
logica contenuto della logica. La logica studia, per Hegel,
realtà, infatti,si identifica con il
l’impalcatura delle forme dello spirito, oggetto della
pensiero.
Fenomenologia.
Dato che il pensiero costituisce la totalità dell’oggetto, le pure Nell’introduzione alla logica dell’Enciclopedia, Hegel critica Kant
per non aver compreso che il concetto costituisce la
essenzialità sono l’impalcatura della realtà, che, però, non si è
L’ESSERE totalità dell’oggetto. I concetti kantiani non sono quindi in
ancora rivestita di tutta la ricchezza della realtà. Per questo,
grado di cogliere l’assoluto, che resta nella sfera dell’inconoscibile
Hegel definisce l’oggetto della logica in due modi contrastanti: come cosa in sé. Kant nega così la metafisica, ma in modo
illegittimo. Hegel apprezza di Kant quelle teorie in cui la dualità
1 DEFINIZIONE dell’OGGETTO 2 DEFINIZIONE DELL’OGGETTO
Della LOGICA viene superata, come quella del giudizio riflettente o del giudizio
della LOGICA
sintetico a priori.
Dio, per Hegel, si fa, diviene, in un processo al
cui termine sta la perfezione.
Hegel critica la concezione della Tuttavia, se si pensa che il finito ha in
L’esposizione di Dio come metafisica tradizionale riguardo il sé la negazione, si vede che il perire del
egli è nella sua eterna Il regno delle ombre, finito: essa lo pone come qualcosa finito è negazione di negazione, cioé
essenza prima della delle semplici che sta accanto all’infinito. Hegel l’affermarsi dell’infinito. Quest’ultimo è
creazione della natura e essenzialità. critica anche Fichte, che vede il finito il sorpassarsi del finito e si realizza in
di uno spirito finito; come continuo sforzo di negare il ogni momento.
limite e l’infinità come un dover
La logica coglie l’origine quando è ancora ombra: per questo, la Logica essere.
inizia con il contenuto piÙ povero, cioé l’essere in generale. Esso
si identifica con il nulla. La verità dell’essere e del nulla è il divenire.
L’andamento della realtà è infatti dialettico.
L’idealismo, per Hegel, consiste nel riconoscere il finito
come un vero essere: l’infinito si attua nel perenne
La realtà è contraddittoria, è sintesi di essere e nulla: le cose
avvicendarsi del finito, nella storia e la vera realtà è il
che ci sono hanno un aspetto positivo, per cui sono essere in
divenire, il negarsi e sorpassarsi di ogni finito.
quanto sono questa cosa, e uno negativo, per cui sono questa
cosa e non un'altra cosa
Giuseppe ARMANI 4912780
Laurea Magistrale in Filosofia – AA. 2019-2020 – 1°- 2° Semestre – Ontologia e Metafisica – Prof. Marco Dario SACCHI
INTRODUZIONE A HEGEL È l’idea fuori di sé. L’emergere dell’idea, però,
CHE COS’é LA La natura, scrive
è un processo dialettico. La natura è il
NATURA? Hegel, è l’idea nella
momento negativo, in cui l’idea si fa altro. La
FILOSOFIA DELLA 1^ PARTE forma del suo esser
filosofia della natura deve mostrare la
NATURA NATURA altro
presenza dell’idea nei vari gradi della natura.
L’ultima parte della filosofia della natura è Esso è teoretico perché è determinato
ULTIMA PARTE SPIRITO connessa allo spirito soggettivo. Lo spirito ha dall’oggetto: questa è la sua apparenza,
SOGGETTIVO un primato rispetto alla natura: la conoscenza perché l’oggetto é posto dall’intelligenza,
dello spirito è la più concreta delle conoscenze, che si svolge attraverso l’intuizione, la
la più alta e la più difficile. Lo spirito è l’idea rappresentazione, l’immaginazione, la
che ha preso coscienza di sé ed è realtà memoria e il pensiero. Il pensiero é la
intellegibile e intelligente. forma più alta dello spirito teoretico
Lo spirito pratico é il volere che si afferma prima come individualità, come impulso, sentimento. Il
FILOSOFIA DELLO sentimento trae il suo pregio da ciò che é giustificato razionalmente. Di fronte al sentimento come
SPIRITO impulso e arbitrio sta il dovere. Il male é l’inadeguatezza dell’essere rispetto al dover essere. In cosa
consista il dovere é determinato però nello spirito oggettivo.
SPIRITO OGGETTIVO:IL Lo spirito oggettivo è lo spirito che si realizza in un mondo suo, distinto
SPIRITO OGGETTIVO
DIRITTO da quello naturale: il mondo delle leggi, delle istituzioni, dei costumi. Esso
è la realizzazione della libertà, che per Hegel è l’unità del volere razionale
col volere singolo. C’è identità tra libertà e legge, dunque la libertà si
realizza nel diritto. Il diritto è il primo momento dello spirito oggettivo, al
La filosofia del diritto deve scoprire la razionalità del diritto vigente, di ciò che quale si oppone come antitesi la moralità, e che sarà inverato nell’eticità
è. A tal proposito, la celebre affermazione tutto ciò che è reale è razionale, e come sintesi.
tutto ciò che è razionale è reale. La filosofia del diritto deve insomma
giustificare razionalmente ciò che è
Il diritto astratto è l’insieme dei rapporti esteriori fra gli individui che formano la comunità.L’individuo è persona, cioè soggetto capace di proprietà.
Nella moralità, invece, l’individuo è soggetto, volontà consapevole, che accetta la legge solo riconoscendola come sua. Questo rispecchia la morale
kantiana. La vera vita morale si attua nell’eticità: la virtù consiste nella dedizione alla comunità in cui si vive, al bene del popolo. Lo Stato è la comunità più
perfetta e a questo sono presupposte la famiglia e la società civile. Si tratta dei tre momenti dell’eticità. Il culmine è rappresentato dallo Stato, che realizza
pienamente l’uomo nella sua umanità. Gli individui sono uomini solo se inseriti nello Stato. La forma perfetta, per Hegel, è la monarchia, in cui
ci deve essere una mediazione tra individui e potere tramite la rappresentazione delle varie classi.
Giuseppe ARMANI 4912780
Laurea Magistrale in Filosofia – AA. 2019-2020 – 1°- 2° Semestre – Ontologia e Metafisica – Prof. Marco Dario SACCHI
INTRODUZIONE A HEGEL
L’essenza è il vero essere, non solo l’oggetto
La verità di una conoscenza profonda, ma
LOGICA L’ESSERE Qual’è la verità L’ESSENZA dell’essere è l’approfondirsi stesso dell’essere. L’essere
dell’Essere? l’essenza torna all’essenza, negando le
determinazioni superficiali, accidentali,
sotto le quali ci si presenta
Hegel parla poi dei principi della metafisica tradizionale: immediatamente.
1. Il principio di identità è contraddetto da ogni giudizio autentico,
perché il predicato esprime sempre qualcosa di diverso dal soggetto. Riflessione
2. Il principio di non contraddizione dà l’occasione ad Hegel di definire Critica alla
la contraddizione come il momento risolutivo in cui gli opposti Metafisica tradizionale
Per indicare l’atto per cui l’essenza si nega
entrano in rapporto fra loro. come immediato e si pone come interiorità,
3. Le cose finite rimandano ad un fondamento, categoria che Hegel utilizza il termine riflessione
risponde al principio di Leibniz di ragion sufficiente.
fondamento Dall’essenza si passa al concetto: se Come puro intellegibile, il concetto è
l’essenza è il fondamento, il universale; esso deve però determinarsi e
fondamento dell’essenza è il farsi particolare e individuo. Il compito della
Per quanto riguarda il fondamento, esso è concetto. Il concetto è la verità della seconda sezione della logica del concetto è
l’essenza come ragion d’essere di ciò che appare, sostanza. Hegel parla del concetto ritrovare la razionalità nella natura. L’ultimo
ciò per cui il fenomeno esiste. come intellegibilità in generale. capitolo della Logica è poi dedicato all’idea
assoluta, che è l’unità del concetto e
esistenza dell’oggettività, è il reale in quanto coincide
con la sua intellegibilità
L’esistenza è il modo di manifestarsi dell’essenza,
IL CONCETTO
è il mondo visto come manifestazione di Dio
Tale idea è in divenire: deve estraniarsi
dalla natura per divenire
autoconsapevole nello spirito. Dio,
Per Hegel, inoltre, c’è intellegibilità
Secondo Hegel, la prova ontologica e cosmologica infatti, si fa, diviene. L’attuazione più
solo quando una cosa è spiegata da
dell’esistenza di Dio sono una sola: è impossibile pensare perfetta di Dio si ha nello spirito
un’altra: intellegibile è solo il reale
Dio senza pensarlo esistente ed è impossibile pensare il umano.
nella sua totalità.
mondo senza pensarlo come una manifestazione
dell’assoluto.
Giuseppe ARMANI 4912780
Laurea Magistrale in Filosofia – AA. 2019-2020 – 1°- 2° Semestre – Ontologia e Metafisica – Prof. Marco Dario SACCHI
INTRODUZIONE A HEGEL Hegel parla dei rapporti tra Stati e, a tal proposito,
ritiene che, non essendoci universalità del diritto, bisogna
FILOSOFIA DELLO SPIRITO OGGETTIVO:IL
accettare i rapporti tra gli stati per come sono, cioè
SPIRITO SPIRITO OGGETTIVO rapporti di forza. Essi si risolvono spesso con la guerra,
DIRITTO condizione necessaria e insuperabile.
I popoli mirano ai fini personali, ma, inconsapevolmente, realizzano un fine universale. Vi sono poi individui
superiori che intuiscono la direzione della storia e la fanno progredire: si tratta di figure come Alessandro La storia
Magno, Giulio Cesare e Napoleone. Hegel distingue le grandi epoche storiche e ne individua il senso:
- Il mondo orientale: esso rappresenta l’affermazione esclusiva della totalità, dello Stato, di fronte al
La storia viene considerata una sorta di tribunale del
singolo. C’è un’eticità immediata e naturale.
mondo, la giustizia nei rapporti tra gli stati. Hegel parla di
- Il mondo greco: esso rappresenta la giovinezza dello spirito, in cui l’armonia tra totalità e particolare si
una filosofia della storia, che ha il compito di cogliere la
compie spontaneamente. Il centro di tale cultura è l’arte, considerata come momento aurorale dello spirito.
razionalità di ciò che avviene nella storia. Essaè│
Lo stato greco, tipicamente democratico, rappresenta la sintesi fra soggettività (arte) e oggettività
teodicea, cioè giustificazione di Dio.
(religione).
Il soggetto della storia è lo spirito dei popoli,
- Il mondo romano: esso rappresenta l’antitesi della libertà greca. Esso è il regno della separazione
rappresentato dallo Stato. Gli individui sono strumenti
dell’universale dal particolare.
per lo svolgimento della vita dei popoli.
- Il mondo cristiano-germanico: il mondo moderno nasce con la Riforma Protestante, che È una
rivalutazione dell’interiorità e della libertà. In questo modo, gli stati si consolidano, perché il
protestantesimo insegna che l’eticità e la giustizia nello Stato è anche espressione del divino e comando di
Dio.
La prima espressione dello spirito assoluto è l’arte. L’estetica di Hegel riguarda
SPIRITO ASSOLUTO solo il bello artistico. L’arte ha come materiale il sensibile spiritualizzato, o lo
spirito reso sensibile. L’arte deve idealizzare la natura, cioé mettere in rilievo la
vera realtà di ogni cosa. L’arte è tanto più perfetta quanto più perfetta è l’unità fra
Oltre lo spirito oggettivo, Hegel colloca lo spirito assoluto, con contenuto e forma, fra idea e il suo modo di apparire. Se tra i due c’è
ARTE
le sue espressioni di arte, religione,filosofia. sproporzione, allora ha luogo il sublime: l’espressione sensibile tenta invano di
adeguarsi all’idea e dà luogo al simbolo. Nell’arte classica, invece, forma e
contenuto sono compenetrati. Tuttavia, l’uomo cerca una superiore unione con
FILOSOFIA Dio, cio│ una totale identificazione. Essa è espressa dal cristianesimo, con cui nasce
l’arte romantica, in cui è fondamentale l’interiorità del sentimento.
La filosofia è sapere dell’Assoluto e sapere assoluto, ossia sapere
nella forma più perfetta, cioè il concetto. Il concetto è RELIGIONE La seconda forma dello spirito assoluto è la religione, che è pensiero dell’Assoluto,
sapere che si identifica pienamente con il reale. la coscienza della verità assoluta. Essa, però, non è concetto, come invece è la
La legge dello svolgimento, secondo cui ciò che è termine di un filosofia. Il fatto religioso si determina nei momenti del sentimento, della
processo di svolgimento è a sua volta punto di partenza per uno rappresentazione e del pensiero. La religione apprende il soggetto come
svolgimento ulteriore, vale anche per la filosofia: la filosofia si fa, trascendente lo spirito umano, trascendenza che tenta di superare tramite il culto.
dunque si identifica con la sua storia, la quale è verità che si svolge La religione tenta di diventare sapere, tramite le prove dell’esistenza di Dio, ma si
nel tempo. Ogni filosofia che è storicamente esistita è un tratta di un sapere imperfetto.
momento necessario affinchè la verità sia.
Giuseppe ARMANI 4912780
Potrebbero piacerti anche
- Spirito, Anima, Persona dall'antichità greca ed ebraica al mondo cristiano contemporaneoDa EverandSpirito, Anima, Persona dall'antichità greca ed ebraica al mondo cristiano contemporaneoNessuna valutazione finora
- La Nascita Della FilosofiaDocumento33 pagineLa Nascita Della FilosofiaFrancesco Bonsignore100% (1)
- Relazione Sul RazionalismoDocumento3 pagineRelazione Sul RazionalismoDanilo SchiavoneNessuna valutazione finora
- L Origine Della FilosofiaDocumento9 pagineL Origine Della FilosofiaFrancesco BonsignoreNessuna valutazione finora
- Il Soggetto Credente e La Sua ImmaginaziDocumento31 pagineIl Soggetto Credente e La Sua ImmaginaziMarco MagnaghiNessuna valutazione finora
- Conoscere I VangeliDocumento67 pagineConoscere I VangeliAlessandro BarzaghiNessuna valutazione finora
- Senza TitoloDocumento23 pagineSenza TitoloSalvatore Di LeoNessuna valutazione finora
- 8 M3 Pontificia Commissione Biblica 1993Documento13 pagine8 M3 Pontificia Commissione Biblica 1993COSTANTINOV68100% (1)
- Lezioni CirellaDocumento9 pagineLezioni CirellaGiuseppe GrecoNessuna valutazione finora
- Relazione TRA Fede E Ragione: Uno Sguardo Storico-Prospettico Sul Rapporto Tra Filosofia e TeologiaDocumento118 pagineRelazione TRA Fede E Ragione: Uno Sguardo Storico-Prospettico Sul Rapporto Tra Filosofia e TeologiarosannaNessuna valutazione finora
- Filosofia Medievale e ScolasticaDocumento44 pagineFilosofia Medievale e ScolasticaMarcoNessuna valutazione finora
- Dal Pra - Sommario Di Storia Della Filosofia - 1 La Filosofia Antica e Medievale - 1990Documento385 pagineDal Pra - Sommario Di Storia Della Filosofia - 1 La Filosofia Antica e Medievale - 1990auloagerioNessuna valutazione finora
- Lez.9 Teologia Fondamentale I - 22-11-23Documento8 pagineLez.9 Teologia Fondamentale I - 22-11-23Irene GobbiNessuna valutazione finora
- Veritatis Splendor - Giovanni Paolo IIDocumento70 pagineVeritatis Splendor - Giovanni Paolo IIMaria Concetta PalumboNessuna valutazione finora
- 1.d FINITADocumento28 pagine1.d FINITAbianchilisa100% (1)
- 01a Introduzione-La Scienza Frammenta La Realta-evoluzionismo-Australopithecus-luomo-il Cervello UmanoDocumento54 pagine01a Introduzione-La Scienza Frammenta La Realta-evoluzionismo-Australopithecus-luomo-il Cervello UmanoFrancesco BonsignoreNessuna valutazione finora
- I Gruppi Religiosi in PalestinaDocumento11 pagineI Gruppi Religiosi in PalestinaMarica FranchinaNessuna valutazione finora
- Parola Di Dio e Linguaggio UmanoDocumento4 pagineParola Di Dio e Linguaggio Umanolezione27Nessuna valutazione finora
- ErmeneuticaDocumento18 pagineErmeneuticaGiacomino MessinaNessuna valutazione finora
- Storia Chiesa AnticaDocumento90 pagineStoria Chiesa AnticaemanuelNessuna valutazione finora
- I Primi Filosofi E La Ricerca Dell' ArchéDocumento16 pagineI Primi Filosofi E La Ricerca Dell' ArchéDarioNessuna valutazione finora
- SAGRADAS ESCRITURAS I - Apunte de CatedraDocumento83 pagineSAGRADAS ESCRITURAS I - Apunte de CatedraLautaro MuñozNessuna valutazione finora
- Storia Del Concetto Di Persona PDFDocumento31 pagineStoria Del Concetto Di Persona PDFAndre SegoviaNessuna valutazione finora
- 51Documento226 pagine51Franz KafkaNessuna valutazione finora
- Ispirazione e Verità Della Sacra ScritturaDocumento129 pagineIspirazione e Verità Della Sacra ScritturaJeshuaorNessuna valutazione finora
- 2 - La Ricerca Del PrincipioDocumento4 pagine2 - La Ricerca Del PrincipioCrocetti SimonaNessuna valutazione finora
- All 621034Documento105 pagineAll 621034Fabio ColonnaNessuna valutazione finora
- Persona Humana PDFDocumento22 paginePersona Humana PDFTiziano LicataNessuna valutazione finora
- Relazione P Giuseppe Ciutti Concetto Di PersonaDocumento8 pagineRelazione P Giuseppe Ciutti Concetto Di PersonaRoberto Casillo100% (1)
- Capitolo 1: Il Ragionamento UmanoDocumento34 pagineCapitolo 1: Il Ragionamento UmanoSonia VelascoNessuna valutazione finora
- Theo FondamentaleDocumento94 pagineTheo FondamentaleGuelord MudingunzuNessuna valutazione finora
- Riassunti Metafisica Sem2Documento3 pagineRiassunti Metafisica Sem2Andrea StradaNessuna valutazione finora
- Seminario, L'olio Nella Messa CrismaleDocumento18 pagineSeminario, L'olio Nella Messa CrismaleJobit Priester100% (1)
- Parola e Tempo 2011Documento464 pagineParola e Tempo 2011ivano rovidaNessuna valutazione finora
- Concilio Vaticano IiDocumento70 pagineConcilio Vaticano IiSérgio LealNessuna valutazione finora
- Metafisica - Sem2 - by Don RosarioDocumento28 pagineMetafisica - Sem2 - by Don RosarioAndrea StradaNessuna valutazione finora
- Eclisse Della RagioneDocumento18 pagineEclisse Della RagioneSara AlfanoNessuna valutazione finora
- Conosci Te StessoDocumento6 pagineConosci Te StessoGiuliaNessuna valutazione finora
- Profeti - RiassuntoDocumento8 pagineProfeti - RiassuntoTomislav RistovNessuna valutazione finora
- Alle Radici Della Persona K-CharamsaDocumento31 pagineAlle Radici Della Persona K-CharamsaFederico VirgilioNessuna valutazione finora
- Linguaggi Comunicazione BiblicaDocumento12 pagineLinguaggi Comunicazione BiblicaEmanuela NardinNessuna valutazione finora
- IspirazioneDocumento17 pagineIspirazioneJose David DuarteNessuna valutazione finora
- Sintesi Di Metafisica - by Don RosarioDocumento9 pagineSintesi Di Metafisica - by Don RosarioAndrea StradaNessuna valutazione finora
- Pascal - L'Uomo Di Fronte All'InfinitoDocumento2 paginePascal - L'Uomo Di Fronte All'InfinitoPietro Viviani100% (1)
- Aristotele La-MetafisicaDocumento21 pagineAristotele La-Metafisicaelisa.taralunga888100% (1)
- La Veridicità Della Fede. Breve Introduzione Alla Teologia FondamentaleDocumento18 pagineLa Veridicità Della Fede. Breve Introduzione Alla Teologia FondamentaleBernardo Sastre ZamoraNessuna valutazione finora
- OntologiaDocumento14 pagineOntologiadottlillyNessuna valutazione finora
- La Pedagocia Dell, Anno LiturgicoDocumento11 pagineLa Pedagocia Dell, Anno Liturgicoaldebaran66Nessuna valutazione finora
- Lezione 1 - Dio Uno e Trino CreatoreDocumento4 pagineLezione 1 - Dio Uno e Trino CreatoreLuca RinaldiNessuna valutazione finora
- Storia Della Chiesa II FinDocumento116 pagineStoria Della Chiesa II FinGuelord MudingunzuNessuna valutazione finora
- Alla Ricerca Di Se'Documento155 pagineAlla Ricerca Di Se'anton3llo100% (1)
- Un Solo Dio in Tre PersoneDocumento4 pagineUn Solo Dio in Tre PersoneJhon CalderaNessuna valutazione finora
- PONTIFICIA-COMMISSIONE-BIBLICA-Linterpretazione-della-Bibbia-nella-Chiesa 1993Documento53 paginePONTIFICIA-COMMISSIONE-BIBLICA-Linterpretazione-della-Bibbia-nella-Chiesa 1993Welton Ramos SabinoNessuna valutazione finora
- Interpretazione Della BibbiaDocumento5 pagineInterpretazione Della BibbiaserdidioneNessuna valutazione finora
- PDF Sulla BibbiaDocumento14 paginePDF Sulla BibbialongulucasNessuna valutazione finora
- Fernand Crombette - Rivelazione Della Rivelazione 01Documento244 pagineFernand Crombette - Rivelazione Della Rivelazione 01Novevacche DemoncowsNessuna valutazione finora
- Rivelazione e FedeDocumento13 pagineRivelazione e FedeAlessandroPiazzesiNessuna valutazione finora
- G. Salmeri - Dio e L'idea Dell'EssereDocumento15 pagineG. Salmeri - Dio e L'idea Dell'EsserebrunomorabitoNessuna valutazione finora
- Filo SofiaDocumento53 pagineFilo Sofiasaverio dianoNessuna valutazione finora
- Schemi Teologia LM50 2019-2020 (Giugno 2020) G.ArmaniDocumento9 pagineSchemi Teologia LM50 2019-2020 (Giugno 2020) G.ArmaniGiuseppe ArmaniNessuna valutazione finora
- Kant, Critica Del Giudizio - Schema Riassuntivo PDFDocumento3 pagineKant, Critica Del Giudizio - Schema Riassuntivo PDFChristian MartiniNessuna valutazione finora
- Schemi Esperienza Estetica 2019-2020 - Educazione Estetica (Gennari)Documento15 pagineSchemi Esperienza Estetica 2019-2020 - Educazione Estetica (Gennari)giusarma56Nessuna valutazione finora
- Schemi Esperienza Estetica 2019-2020 - SYNOPSIS (Carmagnola)Documento11 pagineSchemi Esperienza Estetica 2019-2020 - SYNOPSIS (Carmagnola)giusarma56Nessuna valutazione finora
- Filosofia Spirito Jenese - Natura e GeistDocumento8 pagineFilosofia Spirito Jenese - Natura e Geistbruno_mor33Nessuna valutazione finora
- F. Menegoni - Religione Disvelata e Sapere Assoluto Nella Fenomenologia Dello SpiritoDocumento13 pagineF. Menegoni - Religione Disvelata e Sapere Assoluto Nella Fenomenologia Dello SpiritoGeist89Nessuna valutazione finora
- Friedrich HegelDocumento19 pagineFriedrich HegelAlessiaNessuna valutazione finora
- Fenomenologia Dello Spirito HEGELDocumento6 pagineFenomenologia Dello Spirito HEGELAntonella DannaNessuna valutazione finora
- Croce Storicismo Assoluto PDFDocumento16 pagineCroce Storicismo Assoluto PDFHui YangNessuna valutazione finora
- Adolf Reinach - Che Cos'è La FenomenologiaDocumento24 pagineAdolf Reinach - Che Cos'è La FenomenologiaLibricusNessuna valutazione finora
- SchopenhauerDocumento4 pagineSchopenhauerMattia Macor100% (2)
- Dawson - Progresso e ReligioneDocumento116 pagineDawson - Progresso e ReligioneFelipe d'AmicoNessuna valutazione finora
- ShellingDocumento4 pagineShellingclaudiaNessuna valutazione finora
- HegelDocumento27 pagineHegelFrancesca PinchiarulNessuna valutazione finora
- Corso Di Esoterismo GeneraleDocumento249 pagineCorso Di Esoterismo GeneraleClaudio Pilotto100% (3)
- Nunzio Incardona - Il TempoDocumento288 pagineNunzio Incardona - Il TempoMauritiusNessuna valutazione finora
- I Paradossi Dell'Arte Nella Teoria Estetica Di Theodor W. AdornoDocumento16 pagineI Paradossi Dell'Arte Nella Teoria Estetica Di Theodor W. AdornoLandini Carlo AlessandroNessuna valutazione finora
- SchellingDocumento2 pagineSchellingrimofabio_569973046Nessuna valutazione finora
- 019 DiscepoloDocumento40 pagine019 DiscepoloLorenzo GraziottiNessuna valutazione finora
- R Ronchi Bergson PDFDocumento20 pagineR Ronchi Bergson PDFMariana Urquijo RegueraNessuna valutazione finora
- Storia Della Mistica Di Marco VanniniDocumento12 pagineStoria Della Mistica Di Marco Vanninirebellin100% (1)
- La Forma Campo - RaholaDocumento15 pagineLa Forma Campo - RaholaLia CampagnaNessuna valutazione finora
- Concetto Di Spazio Nel Carteggio LeibnizDocumento7 pagineConcetto Di Spazio Nel Carteggio LeibnizAndrea BelliniNessuna valutazione finora
- FichteDocumento4 pagineFichteRonnie JamesDio100% (1)
- La Dotta IgnoranzaDocumento10 pagineLa Dotta IgnoranzaVincenzo GrassoNessuna valutazione finora
- L'Illuminazione Ed Errori Simili (Karl Renz)Documento27 pagineL'Illuminazione Ed Errori Simili (Karl Renz)dozz87Nessuna valutazione finora
- Inno in Dieci Versi - Dasasloki (Shankara)Documento2 pagineInno in Dieci Versi - Dasasloki (Shankara)gianfrancobNessuna valutazione finora
- Giovanni Papini Il Crepuscolo Dei FilosofiDocumento318 pagineGiovanni Papini Il Crepuscolo Dei FilosofialdosciNessuna valutazione finora
- Schemi Appunti Ontologia e Metafisica INTRODUZIONE HEGEL - SISTEMADocumento6 pagineSchemi Appunti Ontologia e Metafisica INTRODUZIONE HEGEL - SISTEMAgiusarma56Nessuna valutazione finora
- Lettura Introduzione Della Fenomenologia Dello SpiritoDocumento83 pagineLettura Introduzione Della Fenomenologia Dello Spiritomais51Nessuna valutazione finora
- Spunti Importanti Della Prefazione Alla Fenomenologia Dello Spirito. Concetto, Speculazione, Negazione, Mediazione, Verità, Realtà, Attualità Nel Senso Dell'EntelecheiaDocumento7 pagineSpunti Importanti Della Prefazione Alla Fenomenologia Dello Spirito. Concetto, Speculazione, Negazione, Mediazione, Verità, Realtà, Attualità Nel Senso Dell'EntelecheiaJosé PalmaSantyagoNessuna valutazione finora
- 15Documento80 pagine15robertoslNessuna valutazione finora
- Holos 03 Perdono AssolutoDocumento14 pagineHolos 03 Perdono AssolutoAlexaj74Nessuna valutazione finora
- SchellingDocumento21 pagineSchellinggedeone10Nessuna valutazione finora