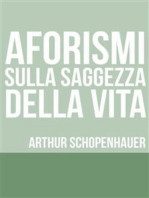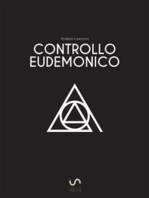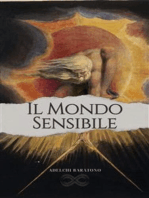Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Immanuel Kant
Caricato da
Elettra RizzottiCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Immanuel Kant
Caricato da
Elettra RizzottiCopyright:
Formati disponibili
IMMANUEL KANT
Nato a Konigsberg (Prussia orientale, ora territorio russo) nel 1724. Vive una vita appartata nella sua citt natale, lavora molto come precettore, nel 1755 diventa libero docente, e nel 1770 professore ordinario di filosofia. Era una persona metodica, cordiale, molto aggiornata grazie ai giornali. Viene educato al razionalismo, influenzato da Leibniz, ma sinteressa di pi allempirismo. uno degli ultimi filosofi ad essere anche scienziato, infatti approfondisce il tema dellorigine delluniverso (a partire da una nebulosa originaria). Non lasci mai la sua citt natale, dove mor nel 1804. Critica per Kant voleva dire analisi (della ragione umana, della conoscenza, etc.). 1 periodo (1746-1760): caratterizzato dallinteresse per le scienze naturali. 2 periodo (1760-1770): detto precritico, con prevalenza delle tematiche filosofiche. Unopera di cui tener conto Sulla forma e i principi del mondo sensibile e intelligibile (1770), in cui possibile ritrovare alcuni temi presenti nella Critica della ragion pura (distinzione tra conoscenza sensibile e intellettuale, e tra fenomeno e noumeno). 3 periodo (1770-1800): quello della fase critica. In questo periodo si ha la stesura delle 3 Critiche: la Critica della ragion pura (1781, seconda edizione nel 1787), la Critica della ragion pratica (1788) e la Critica del giudizio (1790).
Critica della ragion pura.
In questopera si propone di fondare la conoscenza a partire dalla ragione, che deve esaminare e riconoscere i limiti e le possibilit delle proprie facolt. Se le scienze della natura hanno compiuto innegabili progressi, come mai la metafisica pare non aver fatto passi avanti? Poich nessuna conoscenza degna di questo nome pu prescindere dallesperienza, la metafisica non considerabile una scienza. Kant parte da un esame dei giudizi (connessione di concetti che unisce un soggetto ad un predicato) mediante i quali si esprime la conoscenza, che secondo la gnoseologia e la logica sono: - Analitici a priori: indipendenti dallesperienza, il P non aggiunge nulla al contenuto del S; - Sintetici a posteriori: dipendono dallesperienza, il P aggiunge qualcosa al contenuto del S. La conoscenza umana deriva dalla sintesi di due elementi: - Materia (insieme delle impressioni sensibili derivanti dallesperienza); - Forma (insieme dei modi attraverso cui la mente percepisce la realt). La conoscenza scientifica ha tre caratteristiche: - Universalit (validit e contenuto uguale per tutti gli uomini); - Necessit (validit in ogni luogo e tempo); - Fecondit (ampliamento del patrimonio conoscitivo). Il vero sapere scientifico si fonda su giudizi sintetici a priori: essi si basano su elementi a priori presenti nella ragione umana (da cui derivano universalit e necessit), ma allo stesso tempo traggono il loro contenuto dalesperienza (aggiungendo fecondit). La ragione pura la facolt conoscitiva in senso generale, distinta tra: - Sensibilit. Ha il compito di riordinare i dati empirici mediante due forme a priori: spazio e tempo (non hanno esistenza in s, ma esistono in funzione dellesperienza. Spazio= forma del senso esterno; Tempo= forma del senso interno). La sensibilit e le sue
forme sono passive (ricevono il materiale della conoscenza), ma anche attive (organizzano le sensazioni materiali con un ordine spaziale e temporale). - Intelletto. Il materiale della sensibilit acquisito viene trasformato dallintelletto in oggetti di pensiero, e questo contenuto viene organizzato per mezzo delle categorie (o concetti puri). Kant realizza una tavola delle categorie che intervengono nelle operazioni di pensiero (organizzata in quattro gruppi: quantit, qualit, relazione, modalit). - Ragione. La facolt che aspira ad estendere la conoscenza al di l dellesperienza e a spiegare la realt tramite le tre idee di anima, mondo e Dio.
Lestetica trascendentale.
in altre parole la dottrina della sensibilit, la parte dellopera in cui si studiano le condizioni a priori che rendono possibile la conoscenza sensibile. Ogni sensazione contraddistinta da spazio e tempo, la fondazione del sapere di fatto affidata al criticismo (cio la scoperta delle condizioni di possibilit che permettono la conoscenza). Presupposto fondamentale di tutta la ricerca quindi la coscienza che il soggetto ha del mondo (conoscenza, o meglio immagine del mondo, definita da Kant fenomeno). Fenomeno definito come ci che deriva dallesperienza.
La logica trascendentale.
Si suddivide in: - Analitica trascendentale: sezione che analizza i modi di funzionamento del nostro intelletto, prendendo in considerazione solo la forma del pensiero. Si parla di deduzione trascendentale in quanto non possiamo ricevere nulla al di l delle nostre forme a priori, e dato che non abbiamo altri mezzi lutilizzo di queste forme gi giustificato. Abbiamo visto che le categorie sono molteplici, e a garantire che latto di pensare sia unitario Kant individua lIo penso. unit attiva, non la semplice sostanza pensante della tradizione metafisica, ed anche percezione accompagnata dalla coscienza del proprio percepire e della propria identit (=appercezione trascendentale). Senza lIo penso sarebbe impossibile la conoscenza delloggetto in generale.
- Dialettica trascendentale: sezione che analizza il problema della metafisica, in particolare studia la tendenza della ragione ad utilizzare i concetti dellintelletto in argomenti che sono al di l dellesperienza sensibile. Dimostra come le idee metafisiche di anima (insieme dei fenomeni interni), cosmo (insieme dei fenomeni esterni) e Dio (tutto ci che esiste) vadano oltre il limite della conoscenza razionale (dato che non hanno fondamento nellesperienza, danno luogo ad antinomie risolvibili solo in ambito morale). Tendere alla generalizzazione, per cui luomo pensa di sapere ci che in realt non sa, una caratteristica umana naturale, ma noi non abbiamo le esperienze necessarie a conoscere scientificamente questi tre concetti.
La rivoluzione copernicana del pensiero.
Kant effettua un capovolgimento conoscitivo secondo il quale loggetto si adatta alle strutture del soggetto, in modo che possibile conoscere delloggetto qualcosa a priori. Ci che possiamo vedere e sapere del mondo deriva e dipende dalle strutture trascendentali del soggetto. Il fatto che la soggettivit sia posta al centro del processo conoscitivo non significa che sia priva di limiti e possa conoscere la totalit e lessenza dellessere. La ragione deve quindi riconoscere dei limiti, e ne deriva che la nostra conoscenza soltanto di fenomeni: conosciamo le cose non come sono in se stesse, ma come ci appaiono in seguito allelaborazione compiuta dalla sensibilit e dallintelletto. La cosa in s, cio il noumeno, pu essere soltanto pensata: una cosa che non si pu conoscere, ma di cui si afferma lesistenza.
Critica della ragion pratica.
Il punto di partenza della morale kantiana consiste nel ritenere che in ogni uomo esista una legge morale incondizionata valida universalmente: se ogni individuo pu decidere con piena libert di scelta i suoi comportamenti, allora occorre presupporre lesistenza di una legge morale universale e necessaria. La volont (che potrebbe cadere vittima di condizionamenti) se vuole essere morale deve sottomettersi alla ragione (che invece comanda incondizionatamente).
Il comando che la ragione rivolge alla volont definito da Kant imperativo categorico (che , rispetto alla volont, un a priori che non ammette deroghe). A differenza dellimperativo ipotetico, che vale soltanto se si vuole raggiungere un certo scopo, quello categorico comanda incondizionatamente: in quanto principio pratico oggettettivo deve valere per tutti e va distinto dalle regole di comportamento. Secondo Kant c un solo modo per capire se la mia azione morale o meno: vorrei che il mio comportamento fosse modello per qualsiasi altro individuo? Dunque la morale kantiana forma, senza contenuto, scaturita dalla sola ragione. La legge morale e la ragione che la formula hanno valore solo ad alcune condizioni: - libert: ogni nostro comportamento morale, per essere tale, esige la pi completa libert dazione. Dove non c alternativa non c nemmeno comportamento morale; - vita dopo la morte: dato che luomo ha il dovere di promuovere il sommo bene (lideale che luomo chiamato a realizzare nella sua vita pratica, che consegue allazione morale secondo virt) non gli pu bastare questa vita, quindi solo limmortalit dellanima gli garantisce la possibilit di perfezionare allinfinito la sua moralit; - esistenza di Dio: anche la fede nellesistenza di Dio d un senso allagire delluomo, e inoltre Dio il garante dellunione proporzionata di felicit e virt. Occorre supporre lesistenza di un Dio buono che garantisca laccordo tra le intenzioni morali delluomo e la felicit: rappresenta la garanzia del conseguimento del sommo bene. La volont obbedendo allimperativo categorico diventa volont buona. Questa la sola che importi alla rettitudine dellagire morale, quindi identificata con lintenzione. Questo ci che conta al di l dei risultati, la legge che ci impone di essere onesti e che andrebbe seguita senza riserve. Questo agire dei buoni una sorta di distintivo che unisce tutti coloro che lo praticano in una societ ideale dei giusti: il regno dei fini.
Critica del giudizio.
Dopo la Critica della ragion pura e la Critica della ragion pratica, Kant si domanda: che rapporto c tra questi due domini dellesistenza umana, quello conoscitivo e quello morale, quello fenomenico e quello noumenico? La critica della facolt di giudizio diventa cos ponte tra mondo teoretico e mondo morale. Distingue il giudizio tra: - determinante: quando le categorie dellintelletto si applicano agli oggetti dellesperienza sensibile e ad essi si riferiscono; - riflettente: quando riconduce gli oggetti alle aspirazioni e ai desideri della soggettivit. Il giudizio riflettente si suddivide a sua volta tra: - estetico: relativo al sentimento di piacere prodotto dal bello; - teleologico: atto ad individuare un tels, cio un fine nelle manifestazioni della natura. Se la conoscenza data dai principi a priori dellintelletto e lapprezzamento del valore morale dato dalla ragion pratica, lesperienza del bello resa possibile dalla facolt chiamata gusto (facolt del piacere o del dispiacere).
Lanalitica del bello.
Il bello competenza del gusto. In sintesi: - privo di interesse pratico e dunque in se stesso inutile; - il piacere di cui causa deve essere avvertito da chiunque e dunque universale; - non apporta nessuna conoscenza delloggetto contemplato ( senza concetto); - esprime una finalit puramente formale; - non pu non comportare un piacere. La bellezza si distingue in libera (ogni prodotto o combinazione naturale, tale dunque in virt di una semplice forma) e aderente (qualcosa che unisce in s un concetto di scopo, cio di una struttura funzionale). Infine il bello il simbolo del bene morale. Secondo Kant il bello artistico unicamente opera del genio che non si limita, come fa la natura, a produrre un oggetto bello, ma
rappresenta bello un oggetto: in due parole crea bellezza. Il bello ci che in qualche modo si mantiene nei limiti della ragione. Sul piano estetico, ci che oltrepassa tali limiti, linfinitamente grande espresso dalla natura, provoca la percezione del sublime. Kant tuttavia precisa che si trova soltanto nella natura grezza, e in questa soltanto a condizione che non presenti alcuna attrattiva e non susciti la paura dun pericolo reale. Infatti la paura di fronte alla minaccia incombente (ad esempio di uno tsunami) annullerebbe la percezione del sublime. Distingue inoltre il sublime matematico, scaturito dalla percezione dellincommensurabile sia spaziale che temporale, dal sublime dinamico, prodotto dalla percezione della potenza della natura (sia luno che laltro hanno in comune la smisuratezza).
Dialettica del giudizio teleologico.
Il giudizio riflettente che Kant chiama giudizio teleologico, vede la natura come un sistema di fini retto da unintelligenza. Sottopone la natura a principi di osservazione ed investigazione che da un lato ricorrono alla casualit, dallaltro non possono pretendere di poterla spiegare. Se si ammettesse lesistenza di un fine reale, bisognerebbe ammettere che la natura abbia in s unintelligenza o sia guidata da una volont operante. Nulla per nellesperienza pu provare lesistenza di un principio intelligente: sul piano gnoseologico quindi una causa intelligente operante nella natura resta indimostrabile e inconoscibile. Daltronde se nella vita di ogni giorno concepiamo propositi e scopi, parte dei quali poi realizziamo concretamente, ebbene questi stessi scopi e propositi noi li vediamo progettati, per analogia, anche nella natura che diventa cos un sistema intelligente, un organismo orientato verso la realizzazione di un fine unitario. Non ci accontentiamo di vedere la natura stretta in una rete di casualit meccaniche e noi con essa, ma incliniamo piuttosto a vederla come un sistema di finalit. Nella natura dobbiamo supporre che ogni individuo risponda a un fine determinato, che la natura per realizza autonomamente. La causa dellorganizzazione del mondo della natura ipotizzata dal giudizio riflettente deve essere pensata appunto come interna alla natura stessa. Anzi, sostenere che i fini della natura dimostrano lesistenza di Dio, urta con la necessit di dimostrare per prima cosa lesistenza di un Dio, e ci cade al di fuori dei limiti della conoscenza umana.
In tema di finalismo, il soggetto pensante si trova cos di fronte a una ben netta antinomia: - lintera produzione di cose materiali e naturali possibile secondo leggi meccaniche; - la produzione di alcune cose materiali non possibile secondo leggi meccaniche e dunque dobbiamo ricorrere a unintenzione intelligente. In pratica: lo scienziato non pu che attenersi a uninterpretazione meccanicistica della natura, il filosofo legittimato a vedere la cosa anche da un altro punto di vista.
Elettra Rizzotti 4Bsp A.S. 2010/11
Potrebbero piacerti anche
- FilosofiaDocumento11 pagineFilosofiaAlessandro IsidoriNessuna valutazione finora
- KantDocumento3 pagineKantAlessandro Volpe50% (2)
- Appunti Filosofia 3Documento14 pagineAppunti Filosofia 3peter gazzettaNessuna valutazione finora
- KantDocumento6 pagineKantNoemi PelleritoNessuna valutazione finora
- Kant FilosofiaDocumento9 pagineKant FilosofiaEleonora GasparoniNessuna valutazione finora
- KantDocumento8 pagineKantGaia Di LorenzoNessuna valutazione finora
- Esame FilosofiaDocumento30 pagineEsame FilosofiaIris ArbustiniNessuna valutazione finora
- KantDocumento16 pagineKantRossanaNessuna valutazione finora
- KantDocumento3 pagineKantErosNessuna valutazione finora
- Kant 24Documento5 pagineKant 24Mattia De GiglioNessuna valutazione finora
- Critica Della Ragion Pura Di Kant 1Documento6 pagineCritica Della Ragion Pura Di Kant 1Laura MessinaNessuna valutazione finora
- KantDocumento3 pagineKantSimone d'AlessioNessuna valutazione finora
- Filosofia KantDocumento21 pagineFilosofia KantbuzzableNessuna valutazione finora
- Immanuel Kant - CriticheDocumento2 pagineImmanuel Kant - Critichefede_pennyNessuna valutazione finora
- La Critica Della Ragion PuraDocumento9 pagineLa Critica Della Ragion Purastefania comesNessuna valutazione finora
- Critica Della Ragion PuraDocumento7 pagineCritica Della Ragion PuraFilippo D. BardosciaNessuna valutazione finora
- Immanuel Kant - Analitica TrascendentaleDocumento2 pagineImmanuel Kant - Analitica TrascendentaleDiego Deplano88% (8)
- IMMANUEL KANT (Breve Introduzione)Documento11 pagineIMMANUEL KANT (Breve Introduzione)Aurora IppolitiNessuna valutazione finora
- KantDocumento4 pagineKantCarloCarminati50% (2)
- 8 Kant DispensaDocumento5 pagine8 Kant DispensaMicaela De MarcoNessuna valutazione finora
- KantDocumento8 pagineKantagatino.barberi48Nessuna valutazione finora
- Filosofia - Kant, Critica Della Ragion PraticaDocumento9 pagineFilosofia - Kant, Critica Della Ragion PraticaGiovanni TrimarcoNessuna valutazione finora
- Immanuel KantDocumento8 pagineImmanuel KantmatildeNessuna valutazione finora
- KantDocumento9 pagineKantSilvia FerrariNessuna valutazione finora
- Kant Critica Della Ragion PuraDocumento13 pagineKant Critica Della Ragion PuraelisazitielloNessuna valutazione finora
- KantDocumento5 pagineKantFrancesca D'orsiNessuna valutazione finora
- KANTDocumento6 pagineKANTChiara PaganiNessuna valutazione finora
- Kant AppuntiDocumento6 pagineKant Appuntiemanu trekNessuna valutazione finora
- Nella Figura Di Kant Troviamo La Massima Evoluzione Del Pensiero Occidentale Dai Grandi Pensatori Greci Agli IlluministiDocumento2 pagineNella Figura Di Kant Troviamo La Massima Evoluzione Del Pensiero Occidentale Dai Grandi Pensatori Greci Agli IlluministinefralthNessuna valutazione finora
- Kant - Metafisica e Critica Della Ragion PuraDocumento23 pagineKant - Metafisica e Critica Della Ragion PuraFederica SantodonatoNessuna valutazione finora
- Riassunto KantDocumento6 pagineRiassunto KantFederico ToffoliNessuna valutazione finora
- Storia Dell'etica ContemporaneaDocumento47 pagineStoria Dell'etica ContemporaneaASSIA ZABORINessuna valutazione finora
- La Critica Della Ragion PuraDocumento4 pagineLa Critica Della Ragion PuraStefano FotiNessuna valutazione finora
- KantDocumento6 pagineKantminchiadimare1996Nessuna valutazione finora
- Kant (Schema)Documento9 pagineKant (Schema)nicolasgueraNessuna valutazione finora
- Lessico Kantiano Italiano-TedescoDocumento7 pagineLessico Kantiano Italiano-TedescoSandro BorzoniNessuna valutazione finora
- KantDocumento4 pagineKantSilvano SpagnoloNessuna valutazione finora
- Kant 2-2Documento7 pagineKant 2-2Laura Di PumaNessuna valutazione finora
- KantDocumento3 pagineKantAlessandra GrecoNessuna valutazione finora
- Immanuel Kant - IntroduzioneDocumento2 pagineImmanuel Kant - IntroduzioneDiego Deplano100% (3)
- KANTDocumento11 pagineKANTalessandro.vattimo77Nessuna valutazione finora
- Critica Della Ragion PuraDocumento3 pagineCritica Della Ragion PuraMirea DestratisNessuna valutazione finora
- Kant Distingue Tra Ragion Pura Pratica Indipendente DallDocumento3 pagineKant Distingue Tra Ragion Pura Pratica Indipendente DallCristiana BelloNessuna valutazione finora
- FILOSDocumento8 pagineFILOSRomeo GalianiNessuna valutazione finora
- KantDocumento10 pagineKantFilippo AsvisioNessuna valutazione finora
- Domande Verifica KantDocumento8 pagineDomande Verifica KantnicolopedeferriNessuna valutazione finora
- KantDocumento3 pagineKantfrancesca.dc.0906Nessuna valutazione finora
- Hume e KantDocumento7 pagineHume e Kantferroirene2008Nessuna valutazione finora
- Critica Della Ragion PuraDocumento5 pagineCritica Della Ragion PuraCatalina Valeria MocanuNessuna valutazione finora
- Kant CiticismoDocumento2 pagineKant CiticismoMattia De GiglioNessuna valutazione finora
- KantDocumento10 pagineKantnachinjp1Nessuna valutazione finora
- KantDocumento5 pagineKantcaterinaNessuna valutazione finora
- Riassunto CartesioDocumento4 pagineRiassunto CartesiomatNessuna valutazione finora
- Immanuel Kant: Corso Di Riallineamento Di Filosofia A.A. 2015/2016 Prof - Ssa Laura StochinoDocumento20 pagineImmanuel Kant: Corso Di Riallineamento Di Filosofia A.A. 2015/2016 Prof - Ssa Laura StochinoGiada ZaccariNessuna valutazione finora
- Occultismo e filosofia - magnetismo, spiritismo e magia nella visione di un grande filosofoDa EverandOccultismo e filosofia - magnetismo, spiritismo e magia nella visione di un grande filosofoNessuna valutazione finora
- Dispensa Tecnica TaekwondoDocumento52 pagineDispensa Tecnica TaekwondoAvaluador Edixson Villalobos MSc50% (2)
- Genetica Appunti 2020.21Documento17 pagineGenetica Appunti 2020.21Giulia VizzaNessuna valutazione finora
- Stati Europei Tra XV e XVI Secolo e Rinascimento (Autore Mattia Lai)Documento3 pagineStati Europei Tra XV e XVI Secolo e Rinascimento (Autore Mattia Lai)Gianfranco Marini100% (1)
- Violetta-Germont The SacrificeDocumento3 pagineVioletta-Germont The SacrificeSofia MamacitaNessuna valutazione finora
- Lezione 2Documento9 pagineLezione 2Stamatia PortanovaNessuna valutazione finora