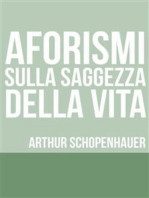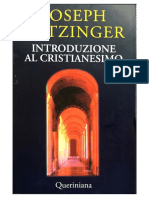Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Riassunto Pascal
Caricato da
Salvatore MazzoneCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Riassunto Pascal
Caricato da
Salvatore MazzoneCopyright:
Formati disponibili
ANGIONI FEDERICA - IV F PASCAL
PASCAL
1. La curvatura esistenziale del pensiero
Blaise Pascal nacque a Clermont nel 1623. I suoi primi interessi erano rivolti alla matematica e alla fisica:
1639: a sedici anni compose il Trattato delle sezioni coniche, un'opera contenente i teoremi-base della
teoria delle coniche ancora oggi considerata uno dei più brillanti lavori di geometria;
1641: a diciotto anni progettò e costruì circa cinquanta esemplari di una calcolatrice capace di
eseguire addizioni e sottrazioni;
1650: elaborò il cosiddetto “Triangolo” o “Teorema di Pascal”;
1654: compose un piccolo teorema sulle probabilità;
in seguito fece numerosi studi e scoperte sul vuoto e sulla pressione, e continuò a dedicarsi alle
invenzioni fino agli anni della sua maturità.
Nel 1654 la vocazione religiosa prese il posto della vita mondana e delle ricerche scientifiche: Pascal entrò a
far parte dei solitari di Port-Royal; questa era una comunità religiosa priva di regole determinate, i cui
membri si dedicavano alla meditazione, allo studio e all'insegnamento.
Con Antoine Arnauld si affermarono tra i solitari di Port-Royal le idee del vescovo Giansenio.
Quest'ultimo, con l'opera intitolata Augustinus, intendeva riformare la chiesa cattolica mediante un ritorno
alle tesi di Agostino, in particolare con la tesi della grazia. Secondo Giansenio, la dottrina agostiniana implica
che il peccato originale ha reso l'uomo incapace di fare il bene e lo ha inclinato necessariamente al male.
Solo Dio può concedere a pochissimi eletti la salvezza dalla dannazione.
Queste tesi si contrapponevano alla morale della chiesa cattolica, in particolare a quella dei gesuiti. Secondo
la morale gesuitica, infatti, la salvezza è sempre a portata dell'uomo che, se vive secondo i precetti della
chiesa e mostra buona volontà, otterrà una “grazia sufficiente” che lo salverà dalla dannazione. Contro tale
tesi, il giansenismo faceva dipendere la salvezza soltanto dall'azione efficace della grazia divina riservata a
pochi.
Il giansenismo suscitò reazioni tanto forti negli ambienti ecclesiastiche che il papa Innocenzo X condannò le
cinque proposizioni nelle quali la Facoltà teologica di Parigi aveva riassunto la dottrina di Giansenio. I
giansiniani accettarono tale condanna, ma negarono che le cinque proposizioni appartenessero a Giansenio e
che si trovassero nella sua opera.
Qualche anno dopo la disputa fu ripresa e in essa intervenne anche Pascal il quale pubblicò diciassette
lettere.
Nelle prime lettere egli polemizza con il teologo Molina e la sua dottrina.
“Ma infine, padre, questa grazia data a tutti gli uomini è sufficiente? – si. Egli disse. – E
tuttavia essa non ha effetto senza la grazia efficace? – Questo è vero, egli disse. – E tutti gli
uomini hanno la sufficiente, continuai io, e non tutti hanno l’efficace? – È vero, egli disse.
-Vale a dire, gli dissi io, che tutti hanno abbastanza grazia e che tutti non ne hanno
abbastanza; vale a dire che questa grazia basta, sebbene essa non basta affatto; vale a dire che
essa è sufficiente di nome e insufficiente di fatto”
A partire dalla quinta lettera, le critiche di Pascal si rivolgono ai gesuiti e alla loro condotta; nell'ultima
lettera ribadisce la dottrina agostiniana della grazia. Il filosofo cerca di trovare un compromesso tra due
punti di vista differenti: il punto di vista di Calvino e Lutero, secondo il quale noi non cooperiamo in alcun
modo alla nostra salvezza, e il punto di vista di Molina, il quale non riconosce che la nostra cooperazione è
dovuta alla forza stessa della grazia. Pascal, in accordo con Agostino, afferma che le nostre azioni sono tali a
causa del libero arbitrio che le produce; esse sono anche di Dio, a causa della sua grazia, la quale fa sì che
il nostro arbitrio le produca.
Mentre scriveva le Lettere, Pascal lavorava anche a una Apologia del cristianesimo. Questa sarebbe dovuta
essere la sua più grande opera, ma egli non poté terminarla a causa della morta giunta quando il filosofo
aveva solamente 39 anni.
2. Il problema del senso della vita
Pascal ritiene che la questione più importante dell'uomo sia l'interrogativo sul senso della vita.
LICEO SCIENTIFICO G. BROTZU 1 ANNO SCOLASTICO 2011-2012
ANGIONI FEDERICA - IV F PASCAL
“Non so chi mi abbia messo al mondo, né che cosa sia il mondo, né che cosa io stesso. Sono in
un’ignoranza spaventosa di tutto. Non so che cosa siano il mio corpo, i miei sensi, la mia
anima e questa stessa parte di me che pensa quel che dico, che medita sopra di tutto e sopra se
stessa, e non conosce sé meglio del resto. Vedo quegli spaventosi spazi dell’universo, che mi
rinchiudono; e mi trovo confinato in un angolo di questa immensa distesa, senza sapere perchè
sono collocato qui piuttosto che altrove, né perchè questo po’ di tempo che mi è dato da vivere
mi sia assegnato in questo momento piuttosto che in un altro di tutta l’eternità che mi ha
preceduto e di tutta quella che mi seguirà. Da ogni parte vedo soltanto infiniti, che mi
assorbono come un atomo e come un’ombra che dura un’istante, e scompare poi per sempre.
Tutto quel che so è che debbo presto morire; ma quel che ignoro di più è, appunto, questa
stessa morte, che non posso evitare”
Pascal ritiene il quesito “che cos’è l’uomo?” l'interrogativo più importante, e considera mostruoso il fatto che
certi individui possano rimanervi indifferenti. Per Pascal lo studio dell'uomo e quello correlativo di Dio e
dell'anima, sono gli unici studi a cui l'uomo si deve interessare; tutto il resto è “svago, libido sciendi, inutile
curiosità”. E' a questo punto che viene messa in evidenza la curvatura religiosa del filosofo: egli crede che
l'enigma dell'uomo e della vita possa trovare una soluzione solo con la fede.
Di conseguenza, la strategia filosofica attuata da Pascal mira a mostrare il fallimento non solo della
mentalità comune, ma anche della filosofia e della scienza davanti al problema del senso dell'esistenza, e
a mettere in evidenza la capacità del cristianesimo di darvi una risposta adeguata. Pascal, quindi, aveva
come obiettivo quello di comporre un'apologia del cristianesimo rivolta a un interlocutore miscredente e al
libero pensatore razionalista, che egli vuol portare a far prendere on considerazione la “ragionevolezza del
cristianesimo”.
3. I limiti della mentalità comune: il divertissement, o lo stordimento di sé
Per Pascal l'uomo ha natura indefinita e indeterminata; egli non ha certezze, ma ha bisogno di averle. Per
ottenere tali certezze non ci si deve affidare né alla ragione né alla scienza: solo Dio può risolvere i nostri
problemi.
Il filosofo ritiene che l'atteggiamento della mentalità comune davanti ai problemi esistenziali sia quello del
divertissement. Questo termine, che viene solitamente tradotto con “distrazione” o “divertimento”, assume il
significato filosofico di oblio e stordimento di sé davanti alle occupazioni, ai lavori e alle attività generali
che svolgiamo per non pensare. Il divertimento, quindi, è una fuga da sé e dalla ricerca dello scopo della
propria esistenza ottenuta tramite qualsiasi attività. Ma da cosa fugge l'uomo?
Innanzitutto dalla propria infelicità e dagli interrogativi sulla vita e la morte.
“Per sfuggire l'angoscia di questa situazione lacerata gli uomini hanno due possibilità. La
prima è non pensarci, distrarsi, lasciarsi afferrare e trascinare dalle circostanze. È però una
strada senza uscita: al fondo si trova soltanto, inevitabilmente, la noia, che è la conseguenza e
il segno della rinuncia a ciò che è profondamente umano.
Nonostante queste miserie, vuole essere felice, non vuole che essere felice, non può non voler
esserlo; ma che cosa può fare? Bisognerebbe, per raggiungere questo fine, che si rendesse
immortale; ma, non potendolo, si è risolto a impedirsi di pensarci. (169)
Gli uomini, non avendo potuto guarire la morte, la miseria, l'ignoranza, si sono risolti, per
procurarsi di essere felici, a non pensarci.”
Nulla è insopportabile all'uomo quanto l'essere in pieno riposo, senza da fare, senza divertimento; in questo
modo, infatti, l'uomo sente il suo niente, la sua insufficienza, la sua impotenza, che porteranno al mal umore,
alla perfidia, alla disperazione e, soprattutto, alla noia. A questo punto, quindi, l'uomo è preso dall'angoscia
e cerca di distrarsi tramite varie occupazioni. Disperdendosi in mille attività, l'uomo non cerca le cose, ma
“la ricerca delle cose”. Queste cose, comunque, non sono cercate in vista della felicità: sono cose che non si
vorrebbero se fossero offerte.; non viviamo mai nel presente, ma in attesa del futuro.
“Distrazione. A volte mi sono messo a considerare le diverse forme di distrazione degli uomini,
e i pericoli e le fatiche a cui si espongono, a corte come in guerra, e donde nascano tante
contese, passioni, imprese audaci e spesso dissennate: ho scoperto che l'infelicità degli uomini
LICEO SCIENTIFICO G. BROTZU 2 ANNO SCOLASTICO 2011-2012
ANGIONI FEDERICA - IV F PASCAL
deriva da una sola cosa, che è quella di non riuscire a starsene tranquilli in una stanza. Un
uomo che ha mezzi sufficienti per vivere, se sapesse stare a casa sua traendone piacere, non
uscirebbe per mettersi in mare o all'assedio di una postazione.
Ma quando ci ho maggiormente riflettuto e, dopo aver trovato la causa di tutti i nostri mali, ne
ho voluto scoprire la ragione, mi sono reso conto che ce n'è una molto concreta, che consiste
nell'infelicità intrinseca della nostra condizione debole e mortale, e così miserabile che niente
ce ne può consolare, quando ci soffermiamo a pensarci. [...]
Da ciò si desume perché il gioco e la ricerca della compagnia femminile, la guerra, le alte
cariche siano mete tanto ambite. Non che vi si trovi effettivamente della felicità, né che ci si
immagini che la vera beatitudine consista nel denaro che si può vincere al gioco, o in una lepre
che corre: non si accetterebbero come doni, se ci fossero offerti. Non è questo possesso, molle
e placido, e che ci lascia pensare alla infelicità della nostra condizione, che si ricerca, né i
pericoli della guerra, né gli affanni delle cariche, ma è il frastuono che ci toglie dai pensieri e
ci distrae. Ragion per cui si ama di più la caccia che la preda.”
Tuttavia il divertimento, essendo una continua fuga da noi stessi, non genera felicità, ed è qualcosa di
fallimentare perchè non porta e a un completo appagamento del desiderio. Il divertimento, provenendo
dall'esterno, porta l'uomo ad essere schiavo delle cose anziché consolarlo. Così, la sola cosa che può
consolarlo dalle sue miserie è la più grande delle sue miserie. Il divertimento, però, non porta a nulla, se non
ad arrivare alla morte senza avere mai vissuto. Per questo motivo l'uomo non deve chiudere gli occhi
davanti alla sua miseria, ma deve saper accettare la propria condizione e tutto ciò che essa implica senza
fuggire.
"L’uomo è manifestamente nato per pensare; qui sta tutta la sua dignità e tutto il suo pregio; e tutto il suo
dovere sta nel pensare rettamente"
4. I limiti del pensiero scientifico: “spirito di geometria” e “spirito di finezza”
Pur essendo uno scienziato e pur avendo interesse per il sapere esatto, Pascal ritiene che la scienza presenti
alcuni limiti che le impediscono di dare risposte ai quesiti circa il senso della vita.
La scienza si basa sulla ragione e ha come primo limite l'esperienza. Sebbene l'esperienza da un lato
rappresenti un punto di forza, in quanto la scienza si fonda e procede con essa, dall'altro lato rappresenta
un qualcosa con cui la ragione deve fare i conti. Per tale motivo il secondo limite della scienza è
rappresentato dall'indimostrabilità dei suoi principi primi. Alla base del ragionamento scientifico, infatti,
vi sono nozioni che sfuggono al ragionamento stesso, poiché nel campo del sapere è impossibile una
regressione all'infinito dei concetti, per cui ci si deve per forza arrestare a dei termini primi, che
rappresentano il limite oltre il quale non si può procedere e dal quale nascono le catene dei ragionamenti. La
scienza, quindi, si basa su principi che non possono essere dimostrati e che quindi non sono mai assoluti
(come, invece, credeva Cartesio), ma che comunque vengono assunti come postulati di per sé evidenti. A tal
proposito, quindi, Pascal rifiuta: il dogmatismo, che non riesce a fondare i principi primi; lo scetticismo, che,
pur tentandoci, non riesce a confutare i principi primi poiché sono evidenze intuitive più sicure di qualsiasi
ragionamento. Pascal, inoltre, respinge ogni intrusione metafisica o teologica e ogni principio di autorità.
Alla ragione scientifica incapace di dare risposte ai problemi esistenziali, Pascal oppone la comprensione
istintiva che lui chiama il “cuore”. Egli intende il cuore come l' “organo” capace di captare gli aspetti più
profondi e problematici dell'esistere:
“Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce”
Per esprimere l'antagonismo esistente tra ragione e cuore, Pascal introduce il concetto di “ esprit de
géométrie” e di “esprit de finesse”. Lo spirito di geometria è la ragione scientifica, che ha per oggetto la
realtà fisica e sensibile e gli enti astratti della matematica e procede dimostrativamente. Lo spirito di finezza
ha per oggetto l'uomo e si fonda sul cuore, sul sentimento e sull'intuito.
Lo spirito di finezza vede l'oggetto senza ragionamento; le cose di finezza si sentono più che vedersi e non
possono essere dimostrate poiché non si posseggono i loro principi come si posseggono, invece, quelli della
geometria. Pascal ritiene che lo spirito di geometria “ragiona” intellettivamente, lo spirito di finezza
“comprende” intuitivamente. Un certo grado di finezza, ossia di comprensione, è necessario anche anche per
LICEO SCIENTIFICO G. BROTZU 3 ANNO SCOLASTICO 2011-2012
ANGIONI FEDERICA - IV F PASCAL
fondare il ragionamento geometrico. Anzi, i principi primi vengono colti proprio attraversi lo spirito di
finezza, poiché si “sente”, ad esempio, che vi sono tre dimensioni dello spazio e si intuisce che i numeri sono
infiniti.
La scienza, davanti agli interrogativi umani, risulta impotente, e si ritrova praticamente nella stessa
situazione della mentalità comune e del divertissement. Per questo motivo, in relazione ai destini ultimi
dell'individuo, essa risulta vana.
Vanità delle scienze. Nei giorni di afflizione, la scienza delle cose esteriori non varrà a consolarmi dell'ignoranza della
morale; ma la conoscenza di questa mi consolerà sempre dell'ignoranza del mondo esteriore.
5. I limiti della filosofia
I filosofi e il problema di Dio
La filosofia è superiore alla mentalità comune e alla scienza in quanto si pone i massimi problemi metafisici
ed esistenziali; essa, comunque, non è in grado di risolverli.
Ad esempio, la pretesa dei metafisici di dimostrare, a partire dalla natura, l'esistenza di Dio è falsa, giacché
l'ordine e le “meraviglie” del creato non dimostrano di per sé l'esistenza di Dio; solo agli occhi di chi crede
la natura appare come un'opera divina, mentre per chi non crede essa può venire interpretata anche senza
Dio.
“-Come! Non dite anche voi che il cielo e gli uccelli provano Dio? - No. - E la vostra religione non lo dice? - No: perchè,
sebbene ciò in un certo senso sia vero per alcune anime, alle quali Dio dona questa luce, nondimeno è falso per i più.”
Per Pascal l'esistenza di un Creatore, razionalmente parlando, non è chiara né certa, bensì oscura e
problematica quanto la sua esistenza. La ragione umana, quindi, non può dimostrare né che dio esiste, né
che non esiste.
“Esaminiamo dunque questo punto, e diciamo: Dio è, Dio non è. Ma da quale parte propenderemo? La
ragione in ciò non può determinare nulla: c’è di mezzo un caos infinito”
Inoltre le prove metafisiche dell'esistenza di Dio hanno il limite di giungere a una divinità puramente
astratta, a un semplice “Dio dei filosofi e degli scienziati” che, essendo un puro ente di ragione, è del tutto
inutile all’uomo.
“Non posso perdonare Cartesio, il quale in tutta la sua filosofia avrebbe voluto poter fare a
meno di Dio, ma non ha potuto evitare di fargli dare un colpetto al mondo per metterlo in
moto; dopodiché non sa più che farne di Dio.”
“Il Dio dei Cristiani non è un Dio semplicemente autore delle verità geometriche e dell'ordine
degli elementi, come la pensavano i pagani e gli Epicurei. [...] il Dio dei Cristiani è un Dio di
amore e di consolazione, è un Dio che riempie l'anima e il cuore di cui Egli s'è impossessato, è
un Dio che fa internamente sentire a ognuno la propria miseria e la Sua misericordia infinita,
che si unisce con l'intimo della loro anima, che la inonda di umiltà, di gioia, di confidenza, di
amore, che li rende incapaci d'avere altro fine che Lui stesso. [...]”
I filosofi e la condizione umana
Così come è incapace di risolvere la questione di Dio, la filosofia è incapace di spiegare la condizione
dell'uomo del mondo.
Per Pascal la caratteristica principale dell'uomo è quella di essere in una posizione mediana nell'ordine delle
cose. La stessa dislocazione spaziale dell'uomo dimostra tale posizione: l'uomo è compreso tra
l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo (ambito ontologico), anzi tra il tutto e il nulla, l'uomo è un
nulla di fronte al tutto e un tutto di fronte al nulla, un misto di essere e non essere.
Chi non sarà preso da stupore al pensiero che il nostro corpo – che dinanzi non era percepibile nell'universo, che a sua
volta era impercettibile in senso al Tutto – sia ora un colosso, un mondo, anzi un tutto rispetto al nulla...?
LICEO SCIENTIFICO G. BROTZU 4 ANNO SCOLASTICO 2011-2012
ANGIONI FEDERICA - IV F PASCAL
Questa medietà tra massimo e minimo trova riscontro anche nell'ordine della conoscenza e nell'ordine
pratico. Nell'ambito conoscitivo si può dire che l'uomo conosca e non conosca; l'uomo, quindi, si trova in una
via di mezzo tra l'ignoranza assoluta e la scienza assoluta. L'uomo, pur possedendo un illimitato desiderio
di conoscere, è impossibilitato a cogliere il principio e il fine delle cose, e deve accontentarsi di
apprendere qualche cosa della zona mediana dell'universo. Tutte le nostre capacità, infatti, sono limitate da
due estremi al di là dei quali le cose ci sfuggono perchè sono troppo al di sopra o troppo al di sotto di esse.
Una medesima duplicità e medietà caratterizza l'uomo in relazione al bene e alla felicità. L'uomo tende alla
ricerca del bene e della felicità assolute ma non è mai in grado di raggiungere ne l’uno ne l’altra.
“Tutti gli uomini, nessuno eccettuato cercano di essere felici: per quanto impieghino mezzi
diversi, tutti tendono a questo fine. Quel che spinge alcuni ad andare alla guerra ed altri a non
andarci è sempre questo desiderio. La volontà non fa mai il minimo passo se non verso
quest'oggetto è il movente di tutte le azioni di tutti gli uomini anche di quelli che s'impiccano”
Questa situazione esistenziale mediana determina, nell'uomo, uno scarto incolmabile tra aspirazione e
realtà e fa sì che egli sia un desiderio frustrato condannato all’infelicità in quanto non si accontenta di quel
che è e non può divenire ciò che vuole. D'altra parte, se nell'uomo vi sono la spinta verso la verità assoluta e
l'istinto di una felicità piena, vuol dire che in lui vi è la vocazione naturale verso un ordine superiore di
essere e si valore. Inoltre, la stessa coscienza della propria miseria è già un segno di grandezza. L'essenza
dell'uomo, la specificità della sua condizione, sta proprio in questa ambigua compresenza di miseria e
grandezza, che fa di lui un “mostro incomprensibile”, un “paradosso di fronte a se stesso”.
Ma se la condizione umana è tutta in questa duplicità di grandezza e miseria, ogni tentativo di sottolineare
un aspetto a scapito dell'altro è destinato a fallire. Lo sbaglio della filosofia, infatti, è stato quello di aver
oscillato tra la celebrazione della grandezza dell'uomo (come è avvenuto nei dogmatici) e la
puntualizzazione della sua miseria (come è avvenuto negli scettici). Incapaci di spiegare la dualità
dell'uomo, i filosofi hanno cercato di annullarla, neutralizzando l'uno o l'altro dei due termini.
«se si esalta, l'abbasso; se s'abbassa, lo esalto; lo contraddico sempre fino a che comprende
che è un mostro incomprensibile».
I filosofi e i principi primi
Secondo Pascal il fallimento della ragione filosofica avviene anche in un altro settore di fondamentale
importanza: quello dei principi pratici morali e politici.
Pascal dice che gli uomini, sulla base della ragione, non sono stati capaci a mettersi d'accordo sulle regole del
vivere e del comportamento, e non sono riusciti ad elaborare un'etica immutabile e universale.
“non si vede nulla di giusto o di ingiusto che non muti qualità con il mutare del clima ; tre
gradi di latitudine sovvertono tutta la giurisprudenza, un meridiano decide della verità; nel
giro di pochi anni le leggi fondamentali cambiano; il diritto ha le sue epoche […]. Singolare
giustizia, che ha per confine un fiume! Verità al di qua dei Pirenei, errore al di là […]. Il furto,
l’incesto, l’uccisione dei figli o dei padri, tutto ha trovato posto tra le azioni virtuose. Si può
dar cosa più spassevole di questa: che uomo abbia il diritto di ammazzarmi solo perché abita
sull’altra riva del fiume e il suo sovrano è in lite con il mio, sebbene io non lo sia con lui?”
Così, su tutto ciò che si riferisce al bene regna da sempre la massima confusione. Per gli uomini comuni il
bene sta nelle ricchezze, nelle cose esterne e nel divertimento. I filosofi, invece, differiscono tra loro nel
determinare l'essenza del sommo bene: c'è chi ritiene che esso consista nella virtù, chi nel piacere, chi nella
ragione, nella morte, ecc. Altri, invece, affermano che il bene non si può trovare, altro ancora rinunciano a
cercarlo.
“Che cosa può esser chiamato un bene? La castità? No, perchè il mondo si spegnerebbe. Il matrimonio? No, perchè è
migliore la continenza. Il non uccidere? No, ché ne seguirebbero orribili disordini, e i malvagi ucciderebbero i buoni.
L'uccidere, allora? No, perchè la natura ne sarebbe distrutta”
I cosiddetti principi “universali” del comportamento, considerati certi dagli uomini comuni e naturali e
razionali dai filosofi, non sono altro che il frutto di convenzione, abitudine, storia, interesse, forza o
LICEO SCIENTIFICO G. BROTZU 5 ANNO SCOLASTICO 2011-2012
ANGIONI FEDERICA - IV F PASCAL
arbitrio.
Questa dialettica pascaliana trae ispirazione dal pensiero scettico e da Montaigne, ma in particolare dai
libertini del XVII secolo. Con questi ultimi, tuttavia, vi sono delle differenze: essi, infatti, consideravano il
relativismo un'arma filosofica che funge da solvente delle credenze sociali e religiose e da giustificazione
della libertà dei costumi; Pascal, invece, considerava il relativismo uno strumento per mostrare come la
ragione, con le sue sole forze, non risulta in grado di fondare solide norme comportamentali e come
l'uomo in generale, senza la luce della fede, sia destinato a vagare nell'incerto e ad approdare allo
scetticismo.
6. La meta-filosofia di Pascal e la “ragionevolezza” del cristianesimo
I limiti della filosofia nei confronti dei problemi di Dio e della condizione esistenziale dell'uomo, sono gli
stessi limiti della ragione e la stessa sua impotenza nei confronti dei massimi problemi.
Secondo Pascal l'unica vera filosofia è una sorta di meta-filosofia consapevole dei limiti della filosofia:
“beffarsi della filosofia è filosofare davvero”.
La meta-filosofia di Pascal, unendo ragione e fede, conduce al cristianesimo, il quale viene inteso come un
messaggio sovrarazionale che risolve problemi che la ragiona, da solo, non riesce a risolvere. La filosofia per
Pascal, quindi, pur essendo sterile, risulta fondamentale perchè conduce alla ricerca di risposte in altre
strade, e precisamente nella superiore forma di conoscenza che è la rivelazione religiosa. Pascal, infatti,
ritiene che l'uomo sia un problema la cui soluzione si trova soltanto in Dio (concezione molto lontana
dall'Umanesimo).
Ora, secondo Pascal, la religione cristiana è l'unica religione vera, in quanto fornisce risposte ai problemi
dell'uomo che si sono in accordo alla reale condizione umana: “Perché una religione sia vera, è necessario che
abbia conosciuto la grandezza e la miseria, e le cause dell'una e dell'altra. Chi, tranne la religione cristiana, l'ha
conosciuta?”. Solo il cristianesimo e la dottrina biblica del peccato originale spiegano la condizione
esistenziale dell'uomo: tale religione, infatti, parla della caduta dei nostri antenati dal Paradiso. Il fatto che
l'uomo accolga in sé due opposti o è una tragica assurdità, o è la prova del fatto che l'uomo non è come
dovrebbe essere e che risulta privo di qualcosa che un giorno deve aver posseduto. L'uomo va alla ricerca
della completa felicità perchè i nostri antenati, quando erano in Paradiso, hanno conosciuto tale felicità; se
l'uomo fosse stato da sempre corrotto, non avrebbe mai avuto il desiderio di essere completamente felice.
L'uomo, quindi, potrebbe essere paragonato a un re spodestato che mentre si trova in esilio ricorda con
nostalgia le ricchezze che possedeva e che ora non possiede più.
Mettendo in luce la simultanea dignità e bassezza dell'uomo, la religione cristiana spiega, nel frattempo, la
perenne inquietudine e frustrazione dell'uomo che, essendo nato per l'infinito, cerca invano la
soddisfazione del proprio desiderio di felicità nel finito, dimenticando che il vuoto abissale che porta
dentro di sé può essere colmato solo da Dio.
Il cristianesimo, quindi, pur non essendo “razionale”, ossia pur non essendo un corpo dimostrato di verità
cui si accede attraverso l'intelletto, è “ragionevole”, ossia conforme alla ragione. Anzi, pur essendo una fede
e non una filosofia, il cristianesimo è così aderente alla ragione da essere in grado di chiarire ciò che essa
non chiarisce.
7. La “scommessa” su Dio
Per mostrare ulteriormente la “ragionevolezza” della fede, Pascal, rivolgendosi in particolare ai “liberi
pensatori”, elabora il celebre concetto della “scommessa su Dio”, il quale afferma che l'uomo deve scegliere
tra il vivere come se Dio ci fosse e il vivere come se Dio non ci fosse; sottrarsi a una decisione è già una
scelta negativa.
In questa scommessa bisogna considerare da un lato la posta, dall'altro la perdita o l'eventuale vincita. Ora,
chi scommette sull'esistenza di Dio, se guadagna, guadagna tutto, se perde, non perde nulla . In poche
parole, l'uomo ha interesse a scommettere su Dio perchè in caso di perdita perderà solo dei beni ”finiti”,
intesi da Pascal come i beni mondani, e in caso di vincita guadagnerà quel bene infinito che è Dio e la
beatitudine eterna. La scommessa, quindi, è conveniente e ragionevole poiché la vincita è infinita e
infinitamente superiore alla posta. Se invece un uomo decidesse di scommettere sulla non-esistenza di Dio,
in caso di vincita, non vincerebbe nulla, in caso di perdita, perderebbe tutto. In un gioco in cui ci sono uguali
probabilità di vincita e di perdita, è conveniente rischiare il finito per guadagnare l'infinito.
Questa dottrina pascaliana non ha trovato accoglienza nella cultura e nella filosofia moderna. Invece, è stata
LICEO SCIENTIFICO G. BROTZU 6 ANNO SCOLASTICO 2011-2012
ANGIONI FEDERICA - IV F PASCAL
accolta favorevolmente la tesi secondo la quale l'uomo è obbligato a “scommettere” su Dio e, quindi, a
“decidersi” nei confronti di una divinità la cui esistenza o non-esistenza appare “problematica”.
Nonostante tutto, Pascal riconosce che non si può comandare la propria fede; egli dice che è necessario
lavorare e convincersi dell'esistenza di Dio non aumentando le prove della sua esistenza, ma diminuendo
tutti quegli elementi che ostacolano la fede. Bisogna, inoltre, entrare nel meccanismo della fede, far tutto
come se si credesse: far dire messe, mettersi in ginocchio, ecc; tutto ciò farà tacere i dubbi e indurrà
l'abitudine della fede. In altri termini, Pascal crede che l'uomo non possa impegnarsi nella fede solo con la
ragione: deve impegnarsi con tutto se stesso.
Trovato Dio, anche la morale, secondo Pascal, diventa qualcosa di saldo, poiché i suoi principi vengono
derivati dall' “amor di Dio” e fondati su di esso.
LICEO SCIENTIFICO G. BROTZU 7 ANNO SCOLASTICO 2011-2012
Potrebbero piacerti anche
- Riassunto: Rivoluzione Scientifica PDFDocumento3 pagineRiassunto: Rivoluzione Scientifica PDFDaniele Gioué ZerbinatiNessuna valutazione finora
- Appunti CartesioDocumento2 pagineAppunti Cartesiobla blaNessuna valutazione finora
- CARTESIO RiassuntoDocumento2 pagineCARTESIO RiassuntoEdoardo Rosati100% (1)
- ComteDocumento3 pagineComtenicolasgueraNessuna valutazione finora
- Riassunto La Nascita Della Filosofia CristianaDocumento4 pagineRiassunto La Nascita Della Filosofia Cristianageorgia100% (1)
- L Esistenzialismo Da KierkegaardDocumento2 pagineL Esistenzialismo Da KierkegaardGiovanni LuigiNessuna valutazione finora
- Le Filosofie EllenisticheDocumento8 pagineLe Filosofie Ellenistichebastianelli1976Nessuna valutazione finora
- Critica Della Ragion PuraDocumento2 pagineCritica Della Ragion PuraAlessandro D'AbbruscoNessuna valutazione finora
- SartreDocumento2 pagineSartreluiNessuna valutazione finora
- SurrealismoDocumento4 pagineSurrealismoFrancesco ContiNessuna valutazione finora
- PASCALDocumento5 paginePASCALedoardoNessuna valutazione finora
- Società e Cultura Nell'età EllenisticaDocumento4 pagineSocietà e Cultura Nell'età EllenisticailarfNessuna valutazione finora
- BerkeleyDocumento2 pagineBerkeleyvitazzo0% (1)
- HobbesDocumento3 pagineHobbesFrancescoColosimoNessuna valutazione finora
- David HumeDocumento4 pagineDavid HumeiphigenyaNessuna valutazione finora
- KantDocumento10 pagineKantFilippo AsvisioNessuna valutazione finora
- I Comuni RiassuntoDocumento6 pagineI Comuni RiassuntoSara GalluccioNessuna valutazione finora
- Riassunto SpinozaDocumento5 pagineRiassunto SpinozamatNessuna valutazione finora
- Rivoluzione IngleseDocumento3 pagineRivoluzione IngleseMoiraMarco PassaNessuna valutazione finora
- HumeDocumento4 pagineHumeIrene Nenina GattiNessuna valutazione finora
- Epicuro ItDocumento8 pagineEpicuro ItMicaelaDeLaOperaNessuna valutazione finora
- Critica Della Ragion PuraDocumento6 pagineCritica Della Ragion PuravaffansucaNessuna valutazione finora
- Società e Cultura Nell'età EllenisticaDocumento4 pagineSocietà e Cultura Nell'età EllenisticailarfNessuna valutazione finora
- Immanuel KantDocumento32 pagineImmanuel KantFabio Di FuscoNessuna valutazione finora
- GOYADocumento3 pagineGOYASara Menghetti100% (1)
- Gianbattista Marino - Opera e VitaDocumento3 pagineGianbattista Marino - Opera e VitaIvan George DoruNessuna valutazione finora
- Riassunto Tommaso FilosofiaDocumento3 pagineRiassunto Tommaso FilosofiaFrancescoNessuna valutazione finora
- BergsonDocumento3 pagineBergsonMario LeoneNessuna valutazione finora
- Tommaso CampanellaDocumento1 paginaTommaso CampanellaGiovanni PaolinoNessuna valutazione finora
- Giovanni PascoliDocumento13 pagineGiovanni PascoliGinevra SinicropiNessuna valutazione finora
- Luigi XIV e L'assolutismoDocumento4 pagineLuigi XIV e L'assolutismoJessica Vacca100% (1)
- La Rivoluzione ScientificaDocumento9 pagineLa Rivoluzione ScientificaAlessioContuNessuna valutazione finora
- Riassunto HegelDocumento5 pagineRiassunto HegelDe Sire DarioNessuna valutazione finora
- KantDocumento10 pagineKantnachinjp1Nessuna valutazione finora
- Giordano BrunoDocumento1 paginaGiordano Brunofedeg94Nessuna valutazione finora
- Simposio (Dialogo) - WikipediaDocumento8 pagineSimposio (Dialogo) - WikipediafabromNessuna valutazione finora
- FoscoloDocumento4 pagineFoscoloLeonardo PradoNessuna valutazione finora
- SartreDocumento5 pagineSartreClaudio NWave100% (1)
- Seneca Letteratura LatinaDocumento2 pagineSeneca Letteratura LatinaGiosinigaNessuna valutazione finora
- HegelDocumento9 pagineHegelMarco StefanelliNessuna valutazione finora
- ILLUMINISMODocumento4 pagineILLUMINISMOalecaldera6957100% (1)
- HOBBES e LOCKEDocumento6 pagineHOBBES e LOCKEMicheleNessuna valutazione finora
- Critica Del GiudizioDocumento2 pagineCritica Del GiudizioOlivia GuardiNessuna valutazione finora
- FichteDocumento2 pagineFichteAndreaCintiNessuna valutazione finora
- Il Pensiero Di CampanellaDocumento8 pagineIl Pensiero Di Campanellasebatorres7Nessuna valutazione finora
- Trattati Politici Vittorio AlfieriDocumento2 pagineTrattati Politici Vittorio AlfieriGiulia De LucaNessuna valutazione finora
- HegelDocumento24 pagineHegelOnofrio DefinaNessuna valutazione finora
- Leopardi SSLAZIO8Documento9 pagineLeopardi SSLAZIO8Valentino MasiNessuna valutazione finora
- TucidideDocumento10 pagineTucidideClaudia De FeliceNessuna valutazione finora
- L'età Di Calvino e Filippo II.Documento12 pagineL'età Di Calvino e Filippo II.LauraPiras100% (1)
- Sul Divenire. Dialogo Con Biagio de Giovanni, Emanuele SeverinoDocumento1 paginaSul Divenire. Dialogo Con Biagio de Giovanni, Emanuele SeverinoMucchi EditoreNessuna valutazione finora
- PersioDocumento3 paginePersioKlea KertushaNessuna valutazione finora
- Biografia Giulio CesareDocumento4 pagineBiografia Giulio CesareLuca MusciaNessuna valutazione finora
- Appunti Su FICHTEDocumento4 pagineAppunti Su FICHTEHayleyNessuna valutazione finora
- La Rivoluzione Copernicana Di KantDocumento2 pagineLa Rivoluzione Copernicana Di KantAnna MazzeiNessuna valutazione finora
- LeopardiDocumento32 pagineLeopardipinaNessuna valutazione finora
- EpicuroDocumento3 pagineEpicuroLucaNessuna valutazione finora
- Stalingrado. Il polittico di Vasilij Grossman.: Memorie plurali e memoria di StatoDa EverandStalingrado. Il polittico di Vasilij Grossman.: Memorie plurali e memoria di StatoNessuna valutazione finora
- DELEUZE Lezione Del Novembre 1986 Su LeibnizDocumento35 pagineDELEUZE Lezione Del Novembre 1986 Su Leibnizodradek86Nessuna valutazione finora
- Cartesio - Pascal - LeibnizDocumento7 pagineCartesio - Pascal - LeibnizLorenzo VicariNessuna valutazione finora
- Pensieri (Blaise Pascal, A Cura Di Paolo Serini)Documento522 paginePensieri (Blaise Pascal, A Cura Di Paolo Serini)marco di micoNessuna valutazione finora
- Blaise Pascal e La Scommessa/ Radu OrghidanDocumento4 pagineBlaise Pascal e La Scommessa/ Radu Orghidanifilosofie.roNessuna valutazione finora
- BlondelDocumento24 pagineBlondelmiguel bautistaNessuna valutazione finora
- Claudio Ciancio - La Svolta Epistemologica Di Cartesio e PascalDocumento16 pagineClaudio Ciancio - La Svolta Epistemologica Di Cartesio e PascalambientiNessuna valutazione finora
- Filosofia2013 Borghesi Il Razionalismo Tra Cartesio e Pascal1Documento11 pagineFilosofia2013 Borghesi Il Razionalismo Tra Cartesio e Pascal1Horacio Martín SistoNessuna valutazione finora
- Cartesio Pascal e Leibniz A ConfrontoDocumento45 pagineCartesio Pascal e Leibniz A ConfrontoMaria RossiNessuna valutazione finora
- Appunti Tesina Su Pascal - GiansenismoDocumento6 pagineAppunti Tesina Su Pascal - GiansenismoCristinuccia88Nessuna valutazione finora
- Presentazione Filosofia Di PascalDocumento10 paginePresentazione Filosofia Di PascalGianfranco Marini100% (2)
- Pascal PaolineDocumento503 paginePascal PaolineSaussureNessuna valutazione finora
- Pascal: Mappe ConcettualiDocumento5 paginePascal: Mappe ConcettualiGianfranco Marini100% (3)
- Dio NascostoDocumento15 pagineDio NascostoLeonardo PorrazziniNessuna valutazione finora
- B. Ghielmi - Elaboratum - Homo ReligiosusDocumento42 pagineB. Ghielmi - Elaboratum - Homo ReligiosusBernardo GhielmiNessuna valutazione finora
- A037Documento11 pagineA037Osric ElsinoreNessuna valutazione finora
- Le Preghiere Degli ScienziatiDocumento14 pagineLe Preghiere Degli ScienziatiMario GranuzzoNessuna valutazione finora
- PascalDocumento9 paginePascalsofiaNessuna valutazione finora
- ScilicetDocumento491 pagineScilicetCarlo AnaclerioNessuna valutazione finora
- Maurice BlondelDocumento90 pagineMaurice BlondelleopoldoNessuna valutazione finora
- P. Odifreddi - Hexagrammum MysticumDocumento1 paginaP. Odifreddi - Hexagrammum MysticumnellopostiNessuna valutazione finora
- Documentazione Interdisciplinare Di Scienza e Fede - Gli Scienziati PreganoDocumento5 pagineDocumentazione Interdisciplinare Di Scienza e Fede - Gli Scienziati Preganomariobianchi182Nessuna valutazione finora
- La Prudenza Eroica Nel Manuale Di GracianDocumento6 pagineLa Prudenza Eroica Nel Manuale Di GracianAnna Rescigno0% (1)
- PascalDocumento3 paginePascalFederica CerracchioNessuna valutazione finora
- Antologia Della FilosofiaDocumento46 pagineAntologia Della Filosofiacuba esquivel amadeoNessuna valutazione finora
- Filosofia - Pascal e HobbesDocumento7 pagineFilosofia - Pascal e HobbesDomenicoNessuna valutazione finora
- Tabela de ConversãoDocumento1 paginaTabela de ConversãoÁdria Mendonça Fontes100% (8)
- Ignacio Matte BlancoDocumento17 pagineIgnacio Matte Blanconazioneindiana100% (2)
- J.ratzinger - Cap. 3 Dio Della Fede e Dio Dei Filosofi (Da Introduzione Al Cristianesimo) OCRDocumento14 pagineJ.ratzinger - Cap. 3 Dio Della Fede e Dio Dei Filosofi (Da Introduzione Al Cristianesimo) OCRLuca Consonni100% (1)
- PascalDocumento12 paginePascalsimonamoraschiniNessuna valutazione finora