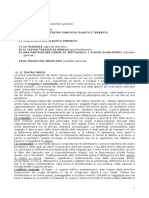Storia Del Teatro e Dello Spett Riassunti
Caricato da
Cecilia BellentaniStoria Del Teatro e Dello Spett Riassunti
Caricato da
Cecilia BellentanilOMoARcPSD|4655872
Storia del Teatro e dello Spett. riassunti
Storia del teatro e dello spettacolo (Università degli Studi di Perugia)
StuDocu no está patrocinado ni avalado por ningún colegio o universidad.
Descargado por Cecilia Bellentani ([Link]@[Link])
lOMoARcPSD|4655872
STORIA DEL TEATRO E DELLO SPETTACOLO
(Roberto Alonge, Franco Perrelli)
1. Il teatro classico greco-romano
Aristotele scrive, nella “Poetica”, che la tragedia ha origine “da coloro che guidavano il ditirambo” (canto in onore di
Dioniso). Il teatro nasce, quindi, in connessione con la religione. Eppure, nelle tragedie greche che ci sono pervenute, la
figura di Dioniso non è particolarmente presente; bisogna, quindi, ipotizzare un processo di progressivo allargamento
tematico, per giungere ai personaggi eroici che dominano il teatro del V secolo a.C. (stagione di piena maturità del
fenomeno).
Originariamente nell’evento teatrale ci sarebbe il Coro che canta in onore di Dioniso e da cui si stacca successivamente il
“corifeo” (capo del Coro), che comincia a dialogare con il Coro, diventando personaggio autonomo.
Nella sua fase più definita l’evento teatrale si realizza dentro uno spazio specifico (l’edificio teatrale greco), che utilizza per
lo più un pendio naturale su cui viene impiantato un sistema di gradinate a semicerchio intorno al Coro, che agisce a livello
terra, in uno spazio circolare denominato “orchestra”. Il Coro danza e canta, mentre l’attore recita. Sul fondo dell’orchestra
c’è la skené: un povero edificio che serve all’attore per vestirsi, anche se in qualche modo funge già da struttura
scenografica minima. Non c’è separazione fra lo spazio utilizzato dal Coro e lo spazio utilizzato dagli attori. Nel V secolo
a.C. gli attori non stanno su un palcoscenico, ma operano allo stesso livello-terra su cui opera il Coro.
Il Coro, rappresentato prima da 12 e poi da 15 persone, si pone come un vero e proprio personaggio. Inizialmente c’è un
solo attore; Eschilo avrebbe introdotto un secondo attore, mentre a Sofocle è attribuito l’inserimento di un terzo attore.
Attori che sono sempre maschi, secondo un pregiudizio antifemminile.
Una caratteristica del teatro greco è data dalla presenza della maschera (posta sul volto sia degli attori sia dei coreuti). La
maschera ha sicuramente un legame con l’origine religiosa della tragedia, compete infatti una funzione rituale evidente:
diventare altro da sé. Ha anche una funzione pratica: facilita l’identificazione dell’attore con il personaggio, tanto più
necessaria in un teatro che raggiungeva sicuramente i 15.000 spettatori. Inoltre, la maschera consentiva al numero ridotto
degli attori (al massimo 3) di sostenere più parti.
I primi autori erano anche attori, oltre che registi dello spettacolo. Da questo fatto deriva probabilmente la mancanza di
didascalie nei testi greci (anche perché originariamente le tragedie venivano rappresentate una sola volta).
Per quanto riguarda i costumi, le raffigurazioni vascolari del V secolo attestano una certa vicinanza ai costumi
contemporanei.
Nonostante fosse all’aperto, il teatro greco non ignorava del tutto effetti scenici prodotti da specifici artifici. Il
“theologèion” era una piattaforma posta al di sopra della skené, mentre la “mechané”, una sorta di gru che sollevava in aria
gli attori, come in una specie di volo. È invece da escludere l’esistenza nel V secolo dell’”ekkùklema”, una macchina che
doveva proiettare all’esterno l’esito di un’azione svoltasi all’interno.
Le Grandi Dionisie erano la principale occasione del teatro greco. Si identificano come feste in onore di Dioniso ed erano
organizzate direttamente dallo stato ateniese, che provvedeva a pagare sia gli attori sia gli autori, mentre le spese del Coro
erano assunte da ricchi privati cittadini. Inoltre il biglietto d’ingresso era rimborsato dallo stato ai cittadini che ne facevano
domanda. In sostanza: lo stato si assumeva il peso di un’iniziativa culturale, ovviamente in perdita, perché riconosceva la
funzione civile (oltre che religiosa) del teatro, come modo di cementare la comunità. Quest’ultima si reca a teatro nella sua
pienezza e lì vede riflessi i miti del proprio patrimonio culturale e mitologico. Gli spettacoli teatrali si inserivano in una
struttura agonale fra tre autori, ciascuno dei quali faceva rappresentare, in un giorno, una tetralogia, composta da 3 tragedie
e da 1 dramma satiresco (forma burlesca che prevedeva la presenza dei satiri e che rappresentava un contrapposto più
leggero rispetto alle 3 tragedie). Ci è giunta una sola trilogia tragica: l’”Orestea” di Eschilo, che presenta una
concatenazione organica nelle 3 tragedie. Non sempre le trilogie erano così organicamente concatenate; potevano ridursi a
un’offerta più generica di 3 distinte e diverse tragedie. Erano previsti premi al miglior autore, al miglior attore e al miglior
coro.
Nella sua “Poetica”, Aristotele non detta delle norme riguardanti le unità di tempo e di luogo, ma si limita a constatare che
nella maggior parte delle tragedie la vicenda si svolgeva in un luogo fisso ed entro un solo volgere del sole. I teorici
classicisti del Rinascimento trasformarono quella che in Aristotele era una semplice constatazione in criteri normativi rigidi,
validi sia per la tragedia sia per la commedia, poi sopravvissuti sino alla rivoluzione romantica. Anche la divisione della
tragedia in 5 atti non risale ad Aristotele, ma sembra imporsi in epoca ellenistica (323-31 a.C).
Dal punto di vista dei contenuti, tutt’e 3 i grandi tragici attingono al patrimonio culturale degli eroi e delle eroine. Soltanto
il mondo greco, privo della fede in una giustizia divina che assicuri nell’aldilà premi e castighi, poteva inventare la tragedia,
che ha al centro il tema del dolore e della sofferenza come conseguenza di una colpa, di un errore o di un destino
imperscrutabile chiamato “fato”. La libertà individuale evidenzia la grandezza dell’eroe, ma contrasta con il destino e
soccombe ad esso (Edipo).
Nel più giovane dei 3 tragici, Euripide, si avverte un clima già in parte cambiato. L’interesse si concentra sulla personalità
umana, sulle motivazioni psicologiche e sentimentali del suo agire. In quest’ultimo senso, una buona esemplificazione è
Descargado por Cecilia Bellentani ([Link]@[Link])
lOMoARcPSD|4655872
offerta da “Ifigenia in Aulide”, una delle ultime opere dell’autore, composta attorno al 408-406 a.C. In questa tragedia
viene meno la consueta atmosfera sublime. Il protagonista, Agamennone, è ambizioso ma velleitario, comicamente
oscillante fra desiderio e paura, fra ambizione pubblica e scrupoli rispetto ai sentimenti familiari, fa e disfa con l’incoerenza
accettabile nell’uomo normale, non nel comandante.
La “Poetica” di Aristotele fissa una riflessione capitale sulla struttura tragica nel capitolo XIII, facendo emergere la qualità
sociale dei personaggi tragici, che si collocano a “un alto livello di fama e di prosperità”, appartenendo al rango di “uomini
famosi” di famiglie aristocratiche. Aristotele dice chiaramente che la tragedia mette in scena uomini “superiori” alla realtà,
e la commedia uomini “inferiori”.
Nel capitolo VI della “Poetica”, Aristotele definisce la tragedia come l’imitazione di un’azione che produce, mediante pietà
e terrore, la catarsi (purificazione) di questi sentimenti. La catarsi di cui parla il filosofo è relativa unicamente alle 2 passioni
citate: pietà e terrore. Per un verso viene vista come motore della crisi, per un altro verso come elemento risolutore della
crisi stessa.
La tragedia induce pietà e terrore dinanzi alle sventure che colpiscono un protagonista in cui ci immedesimiamo, perché ci
assomiglia, ma quel protagonista è avvertito come appartenente a una razza superiore, che si può concedere delle
trasgressioni.
Se il terrore è direttamente ispirato dalle trame delle tragedie è perché la civile e democratica società ateniese è affascinata
da queste storie di eccessi. I personaggi aristocratici delle tragedie sono la proiezione di desideri trasgressivi che i membri
di una società ordinata, civile e democratica non possono consentirsi di praticare.
Una lunga tradizione critica ha ritenuto di vedere in Aristotele il fermo difensore del valore letterario del testo teatrale, ma
dobbiamo tener conto che la “Poetica” è stata scritta nello stesso giro di anni in cui lo statista Licurgo fa preparare
un’edizione canonica dei tragici per arginare le troppo libere interpretazioni degli attori. È necessario aver presente questa
supremazia della dimensione spettacolare rispetto a quella letteraria per capire il senso della “Poetica” di Aristotele. Il
filosofo è stato costretto a reagire per evitare le degenerazioni di un attivismo scenico dominante e troppo imperante.
Resta da dire della commedia che, non meno della tragedia, esprime lo spirito profondo della società ateniese, anche se il
suo pieno affermarsi è della seconda metà del V secolo a.C. Accanto alle Grandi Dionisie abbiamo le feste minori delle
Lenee, sempre in onore di Dioniso, collocabili verso la fine di gennaio, riservate alla commedia. Per la “Poetica”, la
commedia deriva da “coloro che guidano le processioni falliche”.
Già gli antichi filologi distinguevano la commedia “antica”, rappresentata da Aristofane (450-385 a.C.), da quella “di
mezzo” e da quella “nuova”, rappresentata da Menandro (342/341-293/292 a.C.). La commedia di Aristofane presenta
trame molto vaghe che costituiscono un semplice filo attorno a cui si annoda tutta una serie di spunti satirici che
colpiscono i temi dell’attualità. Di Menandro ci è rimasta una sola commedia completa, ma il commediografo è ripreso
largamente dai latini Plauto e Terenzio, i quali definiscono un modello che si esalta nella commedia italiana del
Rinascimento. In tale modello è dominante la dimensione domestica, urbana, con al centro la storia d’amore di un
protagonista giovane, contrastato dai genitori. Alla fine scatta spesso il meccanismo dell’agnizione, cioè del
riconoscimento.
In merito al teatro latino, dobbiamo subito constatare come esso ripeta sostanzialmente i modi e i contenuti del teatro
greco, ma con un margine di indubbia estraneità. Il teatro era legato per i Greci ai valori di una comunità; per i Romani il
teatro non ebbe mai questo rapporto di profonda adesione alla vita della società e fu essenzialmente un fenomeno di
importazione che interessava un’élite culturalmente più raffinata, sensibile al fascino della civiltà greca.
La tragedia fu trascurata dai Romani, una certa fortuna ebbe invece la commedia. I due autori più significativi sono Plauto
e Terenzio. In Plauto c’è una vivacità farsesca e una duttilità satirica notevole; in Terenzio c’è maggior raffinatezza
psicologica dei personaggi, che risultano meno schematici di quelli plautini.
Un posto a parte merita Seneca (5 a.C.-65 d.C.), filosofo e autore di una serie di tragedie letterarie (scritte, cioè, per essere
lette e non rappresentate). Ritornano gli stessi temi della tragedia greca, ma con un’angolazione nuova, esasperata, che
attinge al macabro, al mostruoso, e che risente delle fasi più drammatiche dell’Impero.
Il teatro greco ereditato dai romani fonda nel complesso un modello di drammaturgia che resta decisivo nella storia dello
spettacolo occidentale, perché ne fissa alcuni tratti caratteristici: il privilegio del racconto, la semplicità della trama, il
numero limitato dei personaggi, la separazione degli stili (tragico e comico), le unità di tempo e di luogo.
2. La scena medievale
Con la dissoluzione dell’Impero romano viene meno l’intero assetto culturale di quella società, e con esso in particolare
ogni continuità di pratica teatrale. Alla perdita dell’idea di teatro che si ha nel Medioevo contribuisce in maniera decisiva
l’attacco violento che la Chiesa porta al teatro negli ultimi secoli della romanità. Tertulliano sottolinea con forza il legame
fra lo spettacolo e le divinità pagane ma, più specificamente, il legame fra teatro e Venere, denunciando l’influenza di
questa sulle arti sceniche. Gli attori sono paragonati alle prostitute perché, come loro, fanno mercimonio del proprio
corpo.
Descargado por Cecilia Bellentani ([Link]@[Link])
lOMoARcPSD|4655872
I Padri della Chiesa mettono efficacemente a fuoco il rapporto di seduzione che lo spettacolo intrattiene con il pubblico.
C’è una sorta di vera e propria ossessione dello sguardo in questi scritti. Lo spettacolo è pericoloso perché è il luogo nel
quale gli attori si offrono allo sguardo impudico degli spettatori.
La grande potenzialità di fascinazione che ha lo spettacolo e la sua capacità di toccare i sensi dello spettatore (2 elementi
che costituiscono la radice stessa del teatro) si pongono in un’ottica diabolica.
Se con la caduta dell’Impero romano inizia il processo di abbandono degli edifici teatrali, è indubbio che resta una
spettacolarità di strada, costituita dalle modeste esibizioni dei mimi, dei giullari e degli histriones. Sono queste figure a
mantenere in piedi una qualche forma di spettacolarità, per il corso di secoli che consideriamo come epoche senza teatro.
Siamo, infatti, più nella dimensione dello spettacolo che in quella del vero e proprio teatro. Il giullare, ad esempio, è in
grado di raccontare una storia, ma non scompare dietro i personaggi come fa l’attore, diventando strumento della loro
rappresentazione; e quando arriva a drammatizzare storie che appartengono alla cultura del tempo, opera in riferimento a
una memoria orale e non tanto a un testo scritto; differenza capitale rispetto all’idea di teatro che si è in seguito affermata.
Il Medioevo non possiede l’idea di teatro, distrutta per un verso dalla disgregazione delle forme culturali che discende dalla
caduta dell’Impero romano e, per l’altro, dalla durissima campagna contro il teatro e contro lo spettacolo che portano
avanti dapprima i Padri della Chiesa e poi la Chiesa ufficiale per tutto il Medioevo e anche oltre.
La Chiesa si rende conto dell’importanza del pieno possesso e dell’uso di certe tecniche “giullaresche” perché ha capito che
esse posseggono una grande forza di attrazione rispetto al pubblico dei fedeli. Da parte della cultura cristiana medievale c’è
il riconoscimento di una nozione di “spettacolo”, considerato utile come mero strumento di educazione dei fedeli.
Il “Quem quaeritis?”, ad esempio, è una forma di drammatizzazione dell’uffizio pasquale che consiste in un breve dialogo
fra l’angelo che veglia sul sepolcro di Cristo risorto e le pie donne che sono venute alla tomba. Si traduce in uno scambio
di battute, all’interno del rito religioso, fra il monaco che rappresenta l’angelo e i religiosi che gli rispondono,
impersonando le donne. L’atto di drammatizzazione dell’uffizio liturgico si costituisce in un processo lento e complesso
che determina una progressiva estensione dell’episodio drammatizzato, uno slittamento dal latino ai diversi volgari e,
infine, una completa emancipazione dalla matrice rituale. La rappresentazione passa dall’interno della chiesa al sagrato, per
finire in piazza e dilagare nello spazio della città medievale. La gestione di questi drammi sacri passa dai religiosi alle
confraternite o sodalizi laici.
Il “Jeu d’Adam” è un testo-simbolo di questa teatralità medievale perché in esso traspare la consapevolezza di una
comunicazione che si rivolge a un pubblico per una precisa funzione catechetica.
Anche se il dramma non è più in connessione diretta con la liturgia e non si svolge più dentro la chiesa, è chiaro che il
committente dello spettacolo è sempre la struttura ecclesiastica, questo si nota dallo scarto culturale evidente tra
organizzatori e spettatori, ma anche tra organizzatori ed interpreti.
Il teatro religioso medievale ha (non foss’altro per la sua estensione europea e per la sua durata nel tempo, che si prolunga
fino a tutto il Quattrocento e oltre) una molteplicità di espressioni. Ma, al di là della varia fenomenologia, è importante
cogliere il definirsi di una esemplarità tragica, sconosciuta al mondo classico. Per la spiritualità cristiana non c’è rigida
separazione degli stili: la figura di Cristo ne rappresenta la contaminazione, perché è quella di un eroe bastonato, offeso,
umiliato. Il gusto della mescolanza stilistica spiega anche l’inserirsi, all’interno della vicenda religiosa, di intermezzi comici
da parte di pastori o contadini.
La scena medievale è multipla, presenta allineati degli spazi predeterminati in cui gli attori si spostano via via. I vari luoghi
sono predisposti con un minimo di arredo e di attrezzeria utile alla scena o sono anche soltanto designati
convenzionalmente.
Tutte queste forme di teatralità erano spesso di grande impegno organizzativo e coinvolgevano l’intera comunità
medievale. Da questo angolo concettuale ci sono elementi di contatto con il teatro greco: il teatro nasce in rapporto con la
religione e coinvolge l’intera collettività. Su un punto, invece, il teatro medievale marca delle peculiarità divergenti rispetto
al teatro greco: la non costruzione di luoghi teatrali specifici. La motivazione è evidente: la cultura cristiana combatte a
lungo il teatro, sino a perderne la nozione culturale. Quando si riappropria di questo strumento, contrastato per secoli, lo
può fare solo perché non lo riconosce come tale.
Le forme di spettacolo medievale a orientamento religioso danno frutti secondari e consistenti al processo di rinascita del
teatro moderno (scenotecnica prebarocca, scenografia rinascimentale) e hanno costituito un serbatoio di suggestioni e di
rimandi del teatro contemporaneo (struttura per assemblaggio dei testi, mescolanza degli stili, non unitarietà della scena).
Tuttavia non si può negare che il teatro moderno (quello del XVI secolo in Italia e del secolo successivo in Francia) nasca
proprio da una discontinuità con questa tipologia di spettacolo. Il teatro moderno, infatti, deve assai di più al teatro
profano che, soprattutto verso la fine del Medioevo, comincia a trovare una propria forma sedimentata dentro ai
meccanismi della festa.
Trattando del Medioevo in sede storiografica, non è corretto enfatizzare solo i momenti spettacolari riconducibili alla
Chiesa o alla religione, trascurando le manifestazioni giullaresche e mimiche profane, nonché vari generi farseschi.
Il Medioevo copre oltre mille anni e ha quindi conosciuto, al suo interno, differenti “Medi Evi”, con momenti di splendore
culturale e artistico declinati con differenti sensibilità in paesi d’Europa di diversa civilizzazione. È prevedibile che una fase
Descargado por Cecilia Bellentani ([Link]@[Link])
lOMoARcPSD|4655872
storica così estesa e variegata abbia presentato parecchi e indipendenti filoni spettacolari, che fanno escludere a priori la
mera e unica origine religiosa delle forme rappresentative.
3. Il primo Cinquecento: il Rinascimento
Proprio in Italia, nel corso del Quattrocento, si va riscoprendo la cultura classica, a opera dei cosiddetti “umanisti”. È
l’intero patrimonio culturale del mondo antico che viene rimesso in circolazione, e con esso, ovviamente, anche il teatro.
Le accademie (primi centri di rielaborazione di questo grande tesoro) sono il punto di partenza intellettuale di un processo
che ha come motore autentico la rete delle corti principesche diffuse nell’Italia centro-settentrionale. Le corti si circondano
di artisti che abbelliscono le città, e di intellettuali che lavorano all’interno della corte.
Siamo al “ritrovamento” del teatro moderno. È la corte a farsi centro di diffusione della nuova tipologia del teatro classico.
La soluzione del cortile si alterna a quella delle recite allestite nel chiuso di una grande sala del palazzo principesco, ma lo
schema è il medesimo: è la corte che prende occasione da una ricorrenza festiva periodica o da altre opportunità festive
non periodiche per esibire una manifestazione ludica all’interno della quale lo spettacolo teatrale si inserisce. Il pubblico
degli spettatori coincide con il pubblico degli invitati. Il teatro rinascimentale che si sviluppa nelle corti si riferisce a
un’élite. Siamo davanti a un fenomeno che possiamo chiamare: “privatizzazione del teatro”. Il passaggio dal Medioevo
all’Età Moderna è contrassegnato dal fatto che il potere politico si trasmette dalle vecchie aristocrazie feudali ai nuovi ceti
borghesi. Siamo a un cambiamento epocale e il teatro serve a contrassegnare il potere delle nuove classi dirigenti, funziona
cioè come “status symbol”. Il teatro allestito nel palazzo del principe presenta tragedie e commedie di stampo classico
mentre, al di fuori del palazzo, il popolo continua ad assistere alle tradizionali Sacre Rappresentazioni.
La scenografia medievale presentava tutti i luoghi dove si svolgeva l’azione. Al contrario, la scenografia rinascimentale
unifica il luogo dello spettacolo in un quadro solo, costituito da uno spicchio di città dipinto alle spalle degli attori, sul
fondo del lato più corto del rettangolo in cui consiste la sala del palazzo principesco destinata a ospitare l’evento teatrale. Il
fondale dipinto non corrisponde all’intera immagine riprodotta, ma è solo la porzione che chiude la prospettiva delle case,
appunto sul fondo. I primi 2 casamenti (a destra e a sinistra dello spettatore) sono invece dipinti su quinte disposte in
profondità, integrate da elementi in rilievo in legno e stucco. La scena prospettica non è insomma veramente
bidimensionale, ma in qualche modo risulta tridimensionale; non solo dipinta ma parzialmente anche in rilievo. Gli attori
sono costretti a recitare unicamente in proscenio perché, se indietreggiassero verso il fondo, risulterebbero
inverosimilmente alti quanto i casamenti dipinti sulle quinte laterali o quelli dipinti sul fondale.
“La commedia è l’effimero, la scenografia è il durevole, lo stabile, il perpetuo” (Mario Baratto), questa definizione deve
essere intesa non solo nel senso che i testi drammaturgici variano, mentre spesso la scenografia resta la medesima, ma
anche intendendo che non conta tanto la vicenda rappresentata dagli attori, quanto l’esaltazione del vivere urbano che ha
nel principe il suo reggitore politico.
Il teatro rinascimentale nasce dentro la festa, è il segmento di un contesto festivo più ampio. La festa ha un committente,
che è il principe, e il teatro è una parte di un tutto cui si applicano non già dei professionisti bensì dei dilettanti, che lo
fanno per diletto, per il proprio piacere e per piacere al proprio principe.
Il teatro è comunque sempre, nel quadro generale del Rinascimento, attività marginale, anche quando si tratta delle grandi
commedie. Inoltre “c’è lo spettacolo ma non ci sono ancora le professioni dello spettacolo”. I recitanti non sono attori
bensì generici cortigiani (si tratta sempre di interpreti maschi, che sostengono anche le parti femminili). Se il familiare è per
così dire “proprietà del principe”, allora anche il frutto del suo ingegno è attribuito al principe stesso.
Non solo la commedia è un semplice momento della festa principesca, ma i 5 atti della commedia sono diluiti in un
continuum di intermezzi e moresche che nascono, sì, con la funzione di far rilassare gli spettatori, ma che poi, in
conclusione, finiscono per porsi come l’oggetto principale dello sguardo dello spettatore, proprio per la forza icastica,
scenografica e scenotecnica, della visione spettacolare.
L’elemento dominante è l’eccezionalità della visione, è l’eccellenza della costruzione inaspettata, straordinaria, che
sorprende e stupisce. Il teatro del Rinascimento nasce sotto il segno di questa componente visionaria. Ciò che tende a
imporsi da questo punto in poi, nella concezione della cultura occidentale, è la visione frontale che separa nettamente
spettatori e attori (ciò che si indica come “scena all’italiana” o “teatro all’italiana”). C’è una superiorità gerarchica e morale
in chi guarda rispetto a chi è guardato.
È sintomatico che la cultura del Rinascimento non riesca a convincere i principi della necessità di costruire edifici teatrali.
Gli umanisti riscoprono il valore fondante del teatro, cemento della comunità, e chiedono pertanto la creazione di teatri
stabili, cittadini, in grado di accogliere e ricomporre la comunità; ma i principi (che pure accettano e promuovono i modelli
teatrali della classicità) rifiutano l’idea di un teatro come legame dell’intera comunità e imprimono un forte segno di classe
alla pratica del teatro, preferendo rappresentare all’interno dei cortili e delle sale del palazzo del potere.
4. La drammaturgia del primo Cinquecento
La scena cortigiana è riempita in prima istanza dalla ritrovata drammaturgia classica. Le commedie latine, allestite talvolta
in lingua originale, si alternano con le traduzioni in italiano, e a queste si affiancano prodotti autonomi, frutto di imitazione.
Descargado por Cecilia Bellentani ([Link]@[Link])
lOMoARcPSD|4655872
La commedia rinascimentale non si limita a tener presente il modello classico, sul fondo plautino-terenziano innesta la
grande novità della cultura romanza. La commedia italiana del Cinquecento si pone al punto d’incontro, da un lato, della
tradizione dei commediografi latini, e dall’altro lato, della tradizione boccacciana, percepita come uno straordinario
serbatoio di vicende drammaturgiche.
La cultura cortigiana non è però caratterizzata da una scelta stilistica compattamente solenne. Anzi, all’interno
dell’ambiente di corte domina il gusto della varietà e del contrasto. A fianco di rappresentazioni di commedie latine e di
commedie italiane, troviamo anche la diversa spettacolarità mimico-gestuale di buffoni, giocolieri, mimi, danzatori, che
agiscono in gruppo o come solisti, inventando talvolta dei personaggi o delle vere maschere teatrali. Nel senese c’è una
realtà diffusa nel primo trentennio del secolo, fatta di piccoli intellettuali di modesto livello culturale che amano scrivere e
recitare una ricca gamma di testi teatrali: commedie rusticane, cittadine, pastorali. La composizione scritta è soltanto il
punto di partenza di un’abilità tutta attorica, che faceva valere delle doti di imitazione, mimo, improvvisazione, canto e
musica. La novità più significativa, a livello di generi teatrali, è nella direzione della commedia rusticana o “commedia alla
villanesca”. Nasce nel Medioevo, e si prolunga sino al Cinquecento, una violenta polemica contro i contadini, che ha radici
economiche e affonda nel contrasto città-campagna, da cui deriva una ricca e variegata produzione letteraria cui si dà il
nome complessivo di “satira antivillanesca”. La diffusione di questo genere conferma il pieno apprezzamento che la corte
ha anche della spettacolarità bassa, accanto a quella alta.
Fuori dalla rete delle corti centro-settentrionali, il gusto del teatro si diffonde con un certo ritardo. A Venezia, dove c’è un
sistema oligarchico, il teatro è percepito come una potenzialità trasgressiva. Il motore trainante è rappresentato dalle
Compagnie della Calza, che si preoccupavano di organizzare eventi ludici e festivi. Spesso sono gli stessi giovani patrizi che
recitano, da dilettanti, secondo il modello delle corti. Recitare è per loro, al tempo stesso, elemento di distinzione ed
elemento di trasgressione. Accanto ai dilettanti patrizi troviamo giocolieri, buffoni e professionisti del teatro più impegnato
culturalmente. L’ambiente veneziano si apre, sia pure lentamente, all’intera gamma della spettacolarità primo-
cinquecentesca: alle pastorali ma anche alle commedie alla villanesca della tradizione senese. Si consuma teatro, su invito,
nelle case patrizie delle Compagnie della Calza, ma anche, a pagamento, in altre sale aperte a un pubblico più variegato.
In questo ambiente di varietà di stili spettacolari rappresentato dalla Venezia degli anni Venti si impone l’astro del
padovano Angelo Beolco, detto Ruzante (1496/1542). Beolco scrive (in dialetto pavano, cioè in padovano antico) e recita i
suoi testi che presenta spesso a Venezia. Sappiamo poco della vita di Beolco, e anche la cronologia delle sue opere è
controversa. Le più recenti ricerche biografiche hanno comunque messo in luce il profilo di un borghese abbastanza
agiato, dotato di una certa cultura, operante sul piano pratico come uomo di fiducia del ricco latifondista Cornaro.
Nella sua prima commedia, la “Pastoral” (1517/1518), non troviamo troppa differenza rispetto alle molte pastorali del
tempo, nelle quali il contadino è inserito come elemento di disturbo degli amori fra pastori e ninfe, con effetti puramente
comici. Il Beolco tende a creare una commedia contadina accanto alla commedia dei pastori, ma il processo non è portato
sino in fondo e il personaggio contadino non riesce ancora ad affermarsi come tale. Molti tratti in cui è rappresentato il
Ruzante della “Pastoral” ricordano la satira antivillanesca, a cominciare dalla scelta del nome per finire con il motivo della
fame: ingordigia che suscita il riso, anziché la comprensione e il compatimento.
Lo stesso discorso può ripetersi in parte per la seconda opera, la “Betìa” (1524 circa), che affonda le sue radici nella
tradizione pavana quattrocentesca dei “mariazi” (componimenti dialogati corrispondenti ai “contrasti”, combinati però con
l’occasione esterna di una cerimonia nuziale). Anche qui manca una profonda adesione al mondo contadino, e c’è un
interesse di tipo folclorico. Il contadino vale come mezzo di una polemica che lo travalica e che si colloca propriamente nel
mondo colto.
La “Betìa” sta comunque al termine della prima stagione del Beolco. Sia essa sia la “Pastoral” sono ancora scritte in versi,
mentre tutta la restante produzione sarà in prosa. C’è insomma una certa partenza del Beolco in termini sostanzialmente
letterari, anche se con tendenza a fare una letteratura antiletteraria e antiaccademica. Con i due dialoghi “Parlamento de
Ruzante che iera vegnù de campo” e “Bilora” e la commedia “Moschetta”, che sono degli anni 1529-1530, si ha invece
veramente un superamento di questo contegno inizialmente parodistico nei confronti della realtà contadina. L’esperienza
della carestia fece precipitare e condensare quegli spunti di simpatia filo contadina emergenti, al di sotto della caricatura,
nelle prime due opere. Il contadino non è più uno strumento per una polemica che lo travalica, ma diventa personaggio
autonomo, protagonista. Beolco mette allo scoperto le contraddizioni del quadro sociale, il rapporto di sfruttamento e di
alienazione chela città ha nei confronti della campagna.
Il “Parlamento” consiste quasi interamente nella parlata del villano Ruzante reduce dal campo militare. È la tragedia del
villano che va in guerra per arricchire, per sfuggire al suo destino di miseria e di fame, e ritorna più miserabile e stracciato
di prima, pieno di pidocchi e di paura per l’esperienza vissuta.
La stessa impostazione è nel dialogo “Bilora”, in cui il contadino eponimo arriva in città per riprendersi la moglie, Dina,
che gli è stata portata via da un vecchio mercante veneziano, messer Andronico. La tensione teatrale si accende nel
contrasto fra i due uomini. Il villano beolchiano è in continuo stato di eccitazione, necessaria per superare gli scacchi della
vita; il suo “parlamento” è costantemente saturo di immagini di violenza e di vendetta contro tutto e tutti.
Descargado por Cecilia Bellentani ([Link]@[Link])
lOMoARcPSD|4655872
La “Moschetta” segna invece già un certo qual superamento della fase di maggiore adesione al mondo contadino,
rappresentata appunto dai due dialoghi. Il Ruzante della “Moschetta” è già in qualche modo integrato nella realtà cittadina,
anche se rigettato ai margini della vita associata, a livello di sottoproletariato che vive di espedienti.
La “Moschetta”, con i suoi 5 atti e il suo taglio da commedia regolare, segna indubbiamente il passaggio all’ultima fase della
produzione beolchiana, quella dichiaratamente classicheggiante. Il villano perde la sua carica e la sua pienezza umana e
sociale, e tende a trasformarsi nella figura tradizionale del servo astuto. In questo presagire la Commedia dell’Arte, il teatro
del Beolco non potrebbe terminare meglio: il villano ha ormai perso per sempre la propria vitalità umana e sociale e si è
irrigidito nella maschera del personaggio dell’Arte.
Se Angelo Beolco è l’esempio più alto di commedia villanesca, la commedia villanesca non è però solo Beolco. A Siena sin
dai primi anni del Cinquecento si coagula e si solidifica una tradizione che utilizza, sia pure all’interno di un’offerta
drammaturgico-attoriale più ampia e diversificata, proprio la figura del personaggio contadino, svolto ovviamente in chiave
di satira antivillanesca. E a Siena, nel 1531, si ha la costituzione di una precisa associazione di attori-autori dilettanti che
incentra il proprio lavoro entro questo stesso orizzonte rusticano: la Congrega dei Rozzi.
Il villano, che nei Pre-Rozzi deve dividere il palcoscenico con pastori e cittadini, conquista qui centralità scenica,
autonomia di rappresentazione. Il che non significa affatto che ci sia, da parte dei Rozzi, uno sguardo di simpatia verso il
mondo contadino. Per Pre-Rozzi e Rozzi, il punto di partenza è sempre la tradizionale satira antivillanesca (a Siena c’è una
peculiarità di situazione che aggrava la consueta contrapposizione città-campagna), ma l’aver assunto il mondo contadino
come centro unico del proprio interesse drammaturgico porta a esiti divergenti rispetto ai Pre-Rozzi. Nei Rozzi il senso
dell’associazione artigiana guida a una polemica differenziazione rispetto all’alta borghesia proprietaria di terre nel contado.
Sicché il villano è suscettibile di farsi portavoce delle insofferenze dell’artigianato urbano verso la classe dirigente.
Anche a Firenze il teatro si diffonde relativamente tardi. La storia di Firenze non presenta la realtà forte di un’istituzione
principesca, l’istituzione repubblicana si alterna con la presenza dei Medici e non è possibile parlare di una “corte
medicea”, simile a quelle che troviamo a Ferrara, Mantova, Urbino, Roma. Dove manca un’organizzazione principesca
dello Stato, non si apre la scena cortigiana e più resistente è il legame con l’associazionismo cittadino di impianto consortile
e corporativo. La spettacolarità fiorentina del primo trentennio del secolo appare innestata nelle consuetudini
municipalesche, societarie e conviviali, di cui figura emblematica è l’”araldo”: attore-autore di un teatro ancora informe,
fatto di cantari, di frottole, di esposizioni di novelle, prima ancora che di veri e propri testi drammaturgici, dove il segno
prevalente non è quello della scrittura bensì quello dell’oralità.
Le “compagnie di piacere” sono sodalizi che riuniscono artigiani, artisti e ricchi popolani, ma anche esponenti
dell’oligarchia politico-culturale fiorentina e i più rinomati intrattenitori e attori del tempo. Queste compagnie svolsero a
Firenze una fondamentale opera di organizzazione e promozione teatrale, sostituendosi al vuoto di iniziative provocato
dall’assenza di una corte medicea.
Se a Venezia è la scena villanesca che si impone grazie alla fervida originalità linguistica e attorica di Angelo Beolco, a
Firenze, sotto la spinta travolgente di quell’autentico capolavoro che è la “Mandragola”, sembra piuttosto affiorare il
motivo di una “scena cittadina”.
Machiavelli, con il suo teatro, interviene sulla contemporaneità. Le due commedie (“Mandragola” e “Clizia”) sono due
maniere parzialmente diverse di mettere a fuoco lo stesso milieu sociale di una borghesia cittadina del tempo della
repubblica fiorentina divisa tra affari e sesso, fra pubbliche virtù e vizi privati. L’angolazione è ovviamente diversa. La
“Mandragola” è la storia del faticoso processo attraverso cui si perviene alla fondazione di una casata. La follia, la beffa
sono la superficie che occulta il conseguimento di un obiettivo serio, drammatico: la definizione di un ordine che
garantisca la discendenza. La “Clizia” inizia dove la “Mandragola” finisce, presupponendo l’ordinato vivere civile di un
clan familiare. Qui la follia e la beffa sono ciò che rischia di mettere in crisi quanto è già dato per consolidato.
La scena cittadina che Machiavelli si inventa, si impone con una sua autorevolezza nei maturi anni Venti, e riesce ad
attirare l’attenzione anche di quanti inizialmente si erano mossi in una diversa temperie stilistica. Ariosto, da grande
organizzatore teatrale di corte, si preoccupa di aiutare Beolco nelle sue performances ferraresi e non può fare a meno di
respirare la nuova aria che circola, facendo tesoro di ciò che vede e di ciò che legge, di Beolco e di Machiavelli. Nella sua
“Lena” c’è il duro spaccato di una scena di città contemporanea, con una fredda e implacabile tranche de vie, relativa alla
miseria sociale di due emarginati della Ferrara del tempo: un marito inconcludente, Pacifico, che vive di espedienti,
spingendo la consorte a una sorta di prostituzione dissimulata, e una moglie, Lena, che si offre come amante al vecchio
padrone di casa, Fazio, in cambio della gratuità dell’affitto.
Il frutto più maturo del realismo rinascimentale, applicato alla commedia cittadina, è però costituito dalla anonima
“Veniexiana”, che già nel titolo sottolinea la centralità della dimensione urbana, significando “la comedia di Veniexia”,
sebbene sia ovvio che si riferisce anche alle due protagoniste (Angela e Valeria), due nobildonne che si contendono l’amore
dell’avvenente Iulio, un forestiero milanese disinvolto e spregiudicato. La “Veniexiana” è tanto più eccezionale perché non
ha nulla a che fare con il panorama classico del teatro cinquecentesco: non ci sono servi astuti, travestimenti, agnizioni,
figure tipiche... ma soprattutto non c’è la struttura teatrale coerente e chiusa della commedia di fattura classica, infatti dopo
il primo atto, la commedia si spezza in due sezioni quasi totalmente prive di collegamenti interni, legate solo dalla
Descargado por Cecilia Bellentani ([Link]@[Link])
lOMoARcPSD|4655872
continuità fisica di Iulio, che trascorre momentaneamente dalle braccia di Angela a quelle di Valeria. È qui la grandiosa
novità della “Veniexiana” che ne fa quasi un sorprendente documento di naturalismo, con tre secoli di anticipo: la
commedia come rappresentazione aperta dell’esistenza, senza una conclusione, così come la vita di tutti i giorni.
Ma ancora per un altro motivo la “Veniexiana” occupa un posto così eccezionale sullo sfondo della drammaturgia
cinquecentesca: insieme al finale, essa rifiuta le canoniche unità di tempo e di luogo. E di questa libertà spaziale e
temporale l’anonimo autore si serve per dare ai personaggi uno spessore psicologico che manca alle stilizzate figure
tradizionali della commedia cinquecentesca. Allo stesso modo, profondamente diversa, è la sensazione dello spazio. Lo
spazio aperto è dissipazione, vuoto, è lo spazio dei servi, degli esseri inferiori, di coloro che si vendono. Lo spazio chiuso è
invece privilegio. Dentro lo spazio chiuso delle dimore signorili si svolge il rito della celebrazione amorosa.
L’erotismo, lungi dal porsi quale segno distintivo della potenza oligarchica veneziana in quanto classe egemone, sembra
essere piuttosto l’emblema del fallimento di questa classe dirigente, uscita fiaccata e prostrata dalle vicende belliche italiane
del primo Cinquecento. In siffatta capacità di lasciar intravedere dietro lo scacco sentimentale delle due gentildonne
veneziane lo scacco dell’intera società veneziana di quegli anni, la “Veniexiana” rappresenterebbe non soltanto la più bella
commedia del Cinquecento, ma anche, accanto al teatro del Beolco, uno dei più significativi esempi di realismo del secolo.
5. Il secondo Cinquecento e la Commedia dell’Arte
La stagione teatrale rinascimentale ha una fioritura ricca ma di breve durata, la grande quantità di testi allestiti e pubblicati
nel corso del secolo è per la maggior parte fenomeno di epigonismo, cui si accompagna un progressivo irrigidimento
teorico e normalizzante (codificazione aristotelica).
La tragedia è (nella pratica teatrale delle corti) una realtà assai minoritaria, scarsamente frequentata. I letterati scrivono
moltissime tragedie, ma pochissime sono rappresentate. La classe dirigente rinascimentale è laica, edonistica, ama divertirsi,
non ama interrogarsi sul significato profondo della vita. Il sentimento del tragico era presente, ma non fu vissuto come
dramma di un’intera società, di cui un poeta potesse farsi interprete.
Leone de’ Sommi è l’autore di un trattato intitolato: “Quattro dialoghi in materia di rappresentazioni sceniche”.
L’originalità del suo trattato consiste nell’attenzione alla dimensione dello spettacolo. Siamo su una linea che rinforza la
dimensione del professionismo teatrale (realtà nuova, imposta nella seconda metà del Cinquecento dai comici dell’Arte)
all’opposto della logica dei dilettanti di corte tipica del primo Cinquecento.
Alla data del 25 febbraio 1545 appartiene un documento notarile che contrassegna la nascita della Commedia dell’Arte. In
questo documento (che attesta le volontà di un gruppo di 8 uomini a costituirsi come compagnia itinerante) c’è uno spirito
pratico, molto borghese, che ha inventato una nuova professione. Lo stesso termine “Commedia dell’Arte” rinvia alle Arti
e Corporazioni del Medioevo, dunque “arte” come “lavoro”. Il teatro piace e può diventare una professione: facendolo
pagare e a condizione di girare “di loco in loco”, perché occorre andare a cercarsi il pubblico.
Caratteristiche dei comici dell’Arte: necessità di far pagare un biglietto, essere itineranti, interpretare ruoli fissi. Ogni attore
ha un suo bagaglio di monologhi che manda a memoria, chiamati “generici” perché si adattano con poche varianti a
diverse commedie. Poi ci sono i “canovacci”, che sostituiscono il testo, sulla base dei quali gli attori improvvisano le
battute. Nell’interazione di ruoli fissi, generici e canovacci nasce il miracolo dell’improvvisazione.
Di grande efficacia è comunque la novità delle maschere (4 fisse: il mercante veneziano, il dottore bolognese, il servo
sciocco e il servo astuto). Le maschere sono tratte dal folklore, dalle pratiche carnevalesche, ma in qualche modo sono
implicite negli intrecci della commedia del primo Cinquecento, che ruota sempre attorno a una serie di tipi. Anche il
pluralismo linguistico (con dialetti che contrastano violentemente con l’italiano) obbedisce allo stesso fine di rendere lo
spettacolo più vario e attraente. Caratteristica decisiva della Commedia dell’Arte è però la forte sottolineatura della
gestualità della recitazione, della piena valorizzazione del corpo, compresi salti, capriole e funambolismi vari. La trovata
vincente della Commedia dell’Arte si ha solo attorno al 1570: l’invenzione della donna-attrice. Ciò che determina il trionfo
della Commedia dell’Arte è la novità rivoluzionaria della donna sul palcoscenico.
Le trame dei canovacci non differiscono molto dagli intrecci delle commedie che vengono messe in scena nelle corti e nei
palazzi oligarchici dell’Italia del primo Cinquecento. La differenza la fa la “professione del teatro”. I comici suscitano le
invettive degli uomini di Chiesa perché costituiscono una microsocietà dentro la società, con regole proprie e modalità di
esistenza che risultano trasgressive rispetto alla moralità dominante. La Chiesa li marginalizza, li ghettizza, vieta che si
accostino ai sacramenti e rifiuta di seppellirli in terra benedetta. Ci si avvicina al teatro per quello che esso rappresenta “al
di fuori del teatro”, cioè la possibilità di una vita meno chiusa e repressiva.
La Commedia dell’Arte ha una durata lunga, un paio di secoli, da metà Cinquecento a metà Settecento, e il passare dei
decenni accompagna il progressivo decadere del fenomeno.
Il picco del fenomeno è nei decenni a cavallo tra fine Cinquecento e primo Seicento, quando operano comici illustri, che
sanno usare anche la penna: i coniugi Isabella e Francesco Andreini, e Flaminio Scala.
6. La scena elisabettiana tra Cinquecento e Seicento
Tra fine Quattrocento e inizio Cinquecento si realizza in Italia uno strappo drastico rispetto alla tradizione teatrale
medievale: mentre nelle piazze italiane il popolo spettatore continua ad assistere a spettacoli religiosi, all’interno dei palazzi
Descargado por Cecilia Bellentani ([Link]@[Link])
lOMoARcPSD|4655872
del principe un pubblico elitario e raffinato si dedica alla fruizione di spettacoli laici, costruiti su principi della teatralità
classica. Questa rottura non si determina però in tutta Europa. Solo la Francia subisce l’influsso del classicismo propagato
dal Rinascimento italiano. Per gli altri grandi paesi europei (Inghilterra, Spagna, Germania) prosegue la tradizione del teatro
medievale. Ci si apre ai nuovi contenuti laici della spettacolarità cinque-secentesca, sebbene l’impianto generale non muti.
Shakespeare tratta di conflitti di potere, di eventi della recente storia inglese, di vicende d’amore, ma continua a utilizzare la
libertà spazio-temporale del teatro sacro medievale. La stessa mescolanza degli stili che caratterizza lo spettacolo religioso
medievale, si ritrova puntualmente in Shakespeare.
Tutto questo non significa che non ci fossero nell’Inghilterra dell’epoca delle élites intellettuali al corrente delle
elaborazioni classicistiche italiane. Ma la loro capacità egemonica appare relativa. E comunque il teatro registra una
dimensione maggiormente di massa.
La sete di divertimento fa parte della vita di una metropoli viva e dinamica, ansiosa e tutta protesa nei traffici e
nell’arricchimento, com’è la Londra di fine Cinquecento. Non è provocatorio dire che il ruolo del teatro è, all’epoca, simile
a quello della televisione oggi. E chi scriveva per il teatro aveva giustappunto l’atteggiamento di chi scrive oggi per la
televisione: produzione commerciale, che viene commissionata, e quindi elaborata in tempi accelerati, e di cui l’autore per
primo si disinteressa, una volta che ne ha tratto il guadagno pattuito.
Vanno sottolineati tuttavia alcuni aspetti contraddittori del quadro inglese. Da un lato, Londra sembra in anticipo su tutta
l’Europa nel definire i primi tratti di quella che si chiamerà propriamente “industria dello spettacolo”. Ma, dall’altro lato, è
eccezionalmente forte, proprio e solo in Inghilterra, l’opposizione di principio all’idea stessa del teatro. La tradizionale
avversione al teatro della Chiesa cattolica è ulteriormente rinforzata con la Riforma protestante e da parte di quella fetta di
protestanti inglesi particolarmente rigoristi, che vanno sotto il nome di Puritani, si registra un autentico ostracismo. Al
tempo di Elisabetta I (1558/1603), i primi edifici teatrali sorgono sulla riva meridionale del Tamigi, dove si trovano i
bordelli e le arene per i combattimenti degli animali. E proprio simile all’arena da combattimento è l’edificio teatrale, a
forma vagamente circolare, a cielo aperto, funzionalmente diverso dalle consuetudini del Rinascimento italiano. Il
palcoscenico inglese si protende dentro la platea, sì che gli spettatoti in qualche modo circondano gli attori. Sul
palcoscenico, una botola, a simboleggiare l’inferno, da cui può uscire un diavolo o un fantasma, ma anche un paio di
colonne, sul fondo, che sostengono una tettoia e creano dunque un vano, che può essere chiusa da una tenda, per scene
d’interno. In alto una balconata.
Un teatro scenograficamente spoglio, senza ovviamente attenzione alle luci, visto che le recite sono diurne. Si è parlato di
“scenografia verbale” per intendere che sono le parole dei personaggi a evocare il tipo di ambientazione. Le compagnie
teatrali sono snelle, non più di una mezza dozzina di attori, che però riescono a recitare diverse parti. I ruoli femminili
sono recitati da giovinetti vestiti da donne, come nel teatro di corte italiano della prima metà del Cinquecento. Mancano le
attrici a causa della forte pressione moralizzatrice dei Puritani. L’introduzione della donna-attrice è merito dei comici
dell’Arte, attivi a partire dal secondo Cinquecento. Le loro tournées in Francia e in Spagna valgono proprio a incoraggiare
in quei paesi la pratica del professionismo teatrale femminile. Ma in Inghilterra i comici dell’Arte sono meno presenti, per
ragioni geografiche, oltre che per le generali ragioni di dura opposizione religiosa. Le attrici inglesi arriveranno solo con
riapertura dei teatri, con il ritorno del nuovo re, Carlo II. A partire dal Rinascimento italiano, il teatro appare sempre legato
al gusto della corte, al piacere dell’aristocrazia. Gli attori perseguitati dalla legge inglese sono costretti a mettersi sotto la
protezione di qualche nobile.
Il teatro è lo specchio fedele delle contraddizioni di un paese in profonda trasformazione, in un passaggio epocale della
propria storia. L’Inghilterra è sulla via di imporsi ormai sulla scena mondiale quale grande potenza marinara e mercantile. A
ciò corrisponde una società dinamica, caotica, fatta di avventurieri, ribelli, uomini spesso liberi e spregiudicati, sia sul piano
esistenziale che culturale e religioso. Il teatro è naturalmente un laboratorio particolarmente vivo. Si tratta di una
drammaturgia complessivamente aperta alla contemporaneità, in parte lontana dalle tematiche astratte e stilizzate, tutte e
solo letterarie, tipiche del teatro italiano del Rinascimento, fondato sui modelli della classicità.
È in questo quadro generale che giganteggia William Shakespeare, della cui vita poco sappiamo. Artisticamente non
miracoloso fiore solitario, come si è spesso creduto, ma punto più alto di un ricco panorama di scrittori e di geniali
mestieranti della penna, tra cui Christopher Marlowe e Thomas Kyd. Il modo di operare di Shakespeare è quello di tutti gli
altri: lavoro di scrittura sostanzialmente artigianale, fatto spesso di adattamenti di testi già scritti da altri. Anche
Shakespeare attinge a fonti moderne che gli servono per gran parte delle sue “histories”, drammi storici su sovrani inglesi.
Shakespeare è un attore manager di compagnia, ma non propriamente un grande interprete. Il suo impegno principale era
quello di fornitore di copioni che erano scritti in parte in versi e in parte in prosa. Il suo “blank verse” è un verso sciolto,
non rimato, il cui ritmo si avvicina al ritmo del parlato inglese.
L’epopea elisabettiana si chiude con John Ford che, pur restando completamente al di fuori (per ragioni cronologiche)
dell’arco temporale del regno di Elisabetta, riassume bene i caratteri della condizione estrema, trasgressiva della fantasia
dell’epoca.
Descargado por Cecilia Bellentani ([Link]@[Link])
lOMoARcPSD|4655872
7. La scena spagnola tra Cinquecento e Seicento
I teatri che fiorirono nella Spagna rinascimentale sorsero all’incirca nello stesso periodo dei teatri elisabettiani, nel decennio
tra il 1570 e il 1580, ed ebbero una forma non dissimile. Entrambi i teatri nascono da una matrice comune, che è quella
della scena medievale. Dal punto di vista storico, fra Cinquecento e Seicento si consuma un curioso processo inverso delle
due potenze, Spagna e Inghilterra. La Spagna, dopo aver toccato il proprio apogeo con Carlo V, decade rapidamente. Al
contrario, nello stesso giro di anni, l’Inghilterra esprime compiutamente la propria vocazione a espandersi sui mari e, con
Enrico VIII, si apre sempre più al commercio, accogliendo i perseguitati religiosi. Acquista così saperi e forza-lavoro
specializzata che generano ricchezza e sviluppo.
La religione ha costituito la spinta capitale e l’unificazione della Spagna sotto la corona e si configura dunque quale sorta di
collante, elemento di identità della popolazione, che, in una fatale espressione di fondamentalismo religioso, sente il
bisogno di marcare la differenza con il diverso.
Tutto questo non può non riversarsi, in qualche modo, anche nella storia del teatro. Non è un caso che quasi tutti i
personaggi più significativi della scena spagnola (Tirso de Molina, Calderòn de la Barca, Lope de Vega, Fernando de Rojas)
siano fortemente coinvolti nel discorso religioso, qualche volta anche in termini biografici. Se anche in Spagna, come in
Inghilterra, si assiste a un processo di progressiva laicizzazione dei contenuti drammaturgici, è ben vero che accanto al
teatro profano continua a vivere una tematica di carattere sacro, con commedie che attingono a personaggi e figure della
Bibbia e della vita dei santi.
Un siffatto impegno di orientamento religioso non toglie, naturalmente, che gli strati più rigidi del potere religioso e
politico guardino con diffidenza al mondo teatrale, ma senza poter incidere più di tanto, perché l’interesse per il teatro è
enorme e la richiesta di spettacoli è vorace. Numeri che si spiegano con la caratteristica che la Spagna non ha solo la scena
della propria capitale, ma presenta un ventaglio di centri urbani numerosi e vivaci.
Al centro della scena spagnola c’è il “corral”, un recinto, sorta di cortile costituito dalle pareti delle case contigue, con il
palcoscenico impiantato a una estremità dello spazio. Sul terreno, in piedi, il pubblico popolare, sempre come nei teatri
inglesi. Intorno, lungo i muri, gradinate con posti a sedere per spettatori più agiati. In fondo la “cazuela”, loggione per
pubblico femminile, separato da quello maschile. Ai balconi e alle finestre delle case circostanti dame e spettatori di rango
più elevato. A partire dal 1574, la presenza dei comici dell’Arte, in provenienza dall’Italia, contribuisce ad accelerare il
processo di trasformazione della scena teatrale in senso professionistico. La loro influenza consente di far accettare la
presenza delle donne come attrici, ma per il resto gli spettacoli dei comici italiani non incidono sulla drammaturgia
spagnola, che continua a restare legata alla tradizione medievale.
La “comedia nueva” (inventata da Carpio Lope de Vega) ripropone i moduli più significativi della tradizione medievale:
piena libertà spazio-temporale, superamento della distinzione dei generi, presenza quasi sistematica della figura del
“gracioso” (sorta di buffone, spesso giocato come alter ego del protagonista). Accanto agli elementi di continuità ci sono
naturalmente delle innovazioni: una decisa attenzione alla problematica contemporanea si esprime nella moltiplicazione
all’infinito di commedie di genere avventuroso (le cosiddette commedie di “capa y espada”, che spesso mettono a fuoco la
tematica della vendetta e dell’onore, cui è particolarmente sensibile la mentalità guerriera della società spagnola). I 5 atti
della tradizione classicista lasciano il posto a una scansione di 3 atti.
È il riconoscimento della centralità sociologica del pubblico, che è il vero committente-pagatore del drammaturgo, il quale
deve dunque mettersi in sintonia con le predilezioni dei suoi spettatori, sacrificando i diritti di Aristotele e della tradizione
classica.
Per il teatro spagnolo, il Seicento è un secolo d’oro che contrasta con il declino politico-sociale della Spagna. In questo
teatro si respira il clima della Controriforma, una sorta di immobilità ideologica, un ancoramento fortissimo ai valori
dell’autorità politica e del conservatorismo sociale. C’è un ribaltamento della visione anti-contadina, consueta in tutta
Europa, dal Medioevo in poi. A dispetto di tale tradizione, i contadini risultano sempre portatori di moralità e dignità,
contro le ignominie nobiliari.
L’ideologia conservatrice e religiosa del Siglo de Oro non deve essere un pregiudizio a riconoscerne il valore artistico. È
proprio la peculiare sensibilità religiosa della civiltà spagnola del Seicento che consente ad alcuni capolavori di raggiungere
vette di acuta riflessione sulla condizione umana.
8. La scena francese del Seicento
Rispetto all’Inghilterra e alla Spagna, la Francia vanta una maggiore vicinanza geografica con l’Italia, e forse questo spiega
l’influsso che la cultura classicista del Rinascimento italiano esercitò sulla cultura francese. Mentre la scena elisabettiana e la
scena spagnola conservano forti legami con la tradizione teatrale medievale, la Francia, tutt’altro che priva di contatti con
questo retroterra, tende comunque ad adattarsi alle indicazioni che provengono da Oltralpe. Dall’Italia provengono flussi
Descargado por Cecilia Bellentani ([Link]@[Link])
lOMoARcPSD|4655872
ininterrotti di comici dell’Arte, che a Parigi si fissano, in pianta stabile, a partire dal 1653. La Francia diventa a tutti gli
effetti la seconda patria della Commedia dell’Arte.
Corneille, Moliére e Racine, bastano questi tre nomi di assoluta grandezza (in ordine cronologico) a dare il senso della
pienezza artistica del Seicento francese, definito appunto: Il Grande Secolo. Il teatro è uno strumento nuovo, nella storia
culturale francese, e nel corso del secolo si definisce appunto come luogo privilegiato dei conflitti sociali, del presentarsi e
del contrapporsi delle varie classi sociali. È l’aristocrazia a tentare di usare il teatro tragico come arma ideologica, per
celebrare i valori che definiscono la propria superiorità di classe.
I principi di Aristotele si impongono in Francia nel corso di una certa durata temporale, e comunque diventano cogenti
solo dopo il 1640. La caratteristica di Corneille è una doppia tattica: da un lato puntare sul consenso del pubblico
mondano, ma poi cercare la legittimazione dei dotti rispetto ai successi conseguiti a livello popolare. L’amore che combatte
contro l’onore. Questo tema è rintracciabile in tutto il teatro di Corneille.
Su un piano sensibilmente diverso si colloca il teatro tragico di Jean Racine, in cui i grandi ideali perdono immediatamenti
di forza di convincimento. Tutti i personaggi di Racine appaiono divorati dalla passione e dal desiderio amoroso,
attanagliati dai propri sentimenti, che li rendono quasi nevrotici, e comunque sempre violenti, pronti a porre dei ricatti, a
pretendere di essere amati per forza.
La modernità di Racine è proprio nella capacità pre-freudiana di scavare nella psicologia dei personaggi, di proiettare fasci
di luce tenebrosi e inquietanti sull’inconscio dei suoi eroi e delle sue eroine.
Racine ha una grande cultura classicista: il dramma dei figli degli eroi è di doversi confrontare con modelli insuperabili. Da
qui una sorta di fragilità psicologica, d’inadeguatezza, di insufficienza un po’ poetica e un po’ comica.
Jean-Baptiste Poquelin, detto Moliére, è più vecchio di quasi vent’anni di Racine. È una figura nuova, di attore-scrittore,
legato alla convenzione della commedia, con ascendenze nella commedia italiana del primo Cinquecento, filtrate a loro
volta attraverso i moduli della Commedia dell’Arte, diffusasi nel corso del Seicento sull’intero territorio europeo, ma
radicata profondamente a Parigi. Come scrittore, resta memorabile per aver inventato una serie di capolavori assoluti.
Pièces che preparano alla lontana quello che sarà il cosiddetto dramma borghese, che nascerà propriamente nel corso del
Settecento e s’imporrà in tutta Europa alla fine dell’Ottocento. Moliére scrive spesso in versi, e non sempre in prosa, ma i
suoi personaggi cominciano a respirare vivamente lo status sociologico della condizione borghese, anche se manca una
definizione puntuale dell’habitat borghese.
9. Settecento: la nascita del dramma borghese
Bisogna arrivare a metà del Settecento perché si definisca un nuovo capitale genere, quello del “dramma”, che è poi, in
buona sostanza ciò che viene chiamato “dramma borghese”.
C’è la richiesta di una drammaturgia capace di rendersi libera dai condizionamenti delle convenzioni letterarie e sceniche.
Ma soprattutto c’è la volontà di dare ospitalità e cittadinanza agli autentici protagonisti della nuova realtà sociale che
comincia a essere egemonizzata dal ceto borghese in ascesa. Siamo di fronte a una domanda molto forte di realismo.
Denis Diderot fissa due punti basilari del nuovo discorso della cultura borghese: il valore pedagogico del teatro, ma anche
la qualità dei contenuti drammatici, che non devono più essere attinti al grande repertorio della convenzione classicista, ma
vanno estratti dalla dimensione calda della vita vissuta.
Il “dramma” è il genere nuovo inventato dalla borghesia europea di metà Settecento, che però impone la propria
drammaturgia facendo valere prima di tutto il proprio spazio, la propria casa. Il palcoscenico coincide con il salotto della
casa borghese.
Non c’è mai in Goldoni questo sapore di vita borghese vissuta. Gli spazi delle sue commedie sono fondamentalmente
vuoti. In Goldoni l’ambiente conserva ancora qualcosa di aperto, o comunque d’indeterminato, di generico.
Goldoni sa cogliere la qualità di insicurezza dell’interno borghese, sotto la pressione delle forze esterne, date per nemiche,
per ostili. Lo spazio interno ancora informe di Goldoni si arricchisce qualche volta di una connotazione fondamentale,
quella delle porte, luoghi di passaggio, che dovrebbero difendere l’intimità dall’interno e che invece si rivelano oggetto di
violenza esterna.
La fondazione del dramma borghese non si risolve però solo nell’individuazione di uno specifico spazio scenico, definito
con i tratti dell’interno, del salotto borghese. È bene sottolineare anche i contenuti nuovi che ritroviamo. Ne “Il figlio
naturale”, Diderot fissa un viluppo fermo e sicuro di storia d’amore e di storia di soldi, saldando l’una e l’altra a una istanza
di moralità dall’accento borghese. Il dramma è la trascrizione scenica di una storia vera. Non più finzione ma verità. Siamo
a una svolta capitale della storia del teatro. La borghesia si sente così egemone da osare di raccontare sé stessa.
Nel 1761, Goldoni compone “Trilogia della villeggiatura”, che mescola dissipazione finanziaria e dissipazione amorosa.
Tra Diderot e Goldoni si definisce un filo destinato a portare alla piena individuazione del dramma vorghese, che avrà la
sua piena realizzazione a fine Ottocento, con la drammaturgia di Ibsen. Siamo di fronte a una macchina che comincia a
mettersi in moto a metà Settecento e che esprime pienamente la propria potenza alla fine dell’Ottocento. Si tratta di un
processo lungo e contorto, che richiede di vincere molte resistenze e di passare attraverso lunghi purgatori. Il teatro
Descargado por Cecilia Bellentani ([Link]@[Link])
lOMoARcPSD|4655872
moderno nasce storicamente come divertimento di corte e la classe borghese si appropria dello strumento teatrale solo
attraverso lacerazioni e psicodrammi di grande entità.
Il teatro resta l’affare di un settore minoritario della borghesia stessa. Il teatro è una forma di commercio che fatica a
sopravvivere con le semplici leggi del commercio; necessita di sovvenzioni reali, oppure di biglietti dal costo proibitivo. Il
problema è però quello di assimilare il teatro dal punto di vista borghese, sottraendolo alla sua dimensione di giocattolo di
corte, per piegarlo a un uso di classe, per inserirlo pienamente nella strategia della classe borghese.
È un momento fondamentale anche per il consolidarsi della critica teatrale come professione nuova, nata sostanzialmente
con il diffondersi della pratica della carta stampata periodica.
Il processo d’impossessamento del teatro da parte della borghesia è un percorso lento e accidentato, e la riprova la offre la
situazione italiana, ovviamente in ritardo rispetto al panorama europeo più avanzato. Baretti è un intellettuale che non
capisce che il teatro può esistere anche senza drammaturgia. Agita la sua frusta per colpire Goldoni, che pure rappresenta
la punta più moderna della scena italiana, che ha rotto con la tradizione dello scrittore chiuso nel proprio studio. Goldoni è
un poeta di compagnia, vive accanto agli attori, è uno dei primi a guadagnarsi l’esistenza con la propria professionalità di
scrittore teatrale, proprio questo gli rinfaccia Baretti. Mente in Europa gli spiriti più vivi si muovono nella direzione di
legare classe borghese e teatro, Baretti si chiude in un aristocratico disprezzo.
Con l’aprirsi dei teatri d’opera a un pubblico più vasto, incomincia a imporsi la necessità di non considerare più il
centralistico punto di percezione monofocale del principe, ma in qualche modo di rendere principe chiunque paghi per
uno spettacolo elargito per denaro dalla nuova industria dello spettacolo. Con queste trasformazioni, Bibbiena teorizza la
“prospettiva per angolo”. Il risultato è una più stringente combinazione di illusione e verosimiglianza, che si apre
inevitabilmente a una maggiore razionalizzazione dello spazio scenico e a un riequilibrio fra lo spreco delle macchine
barocche e l’arte di un’affascinante architettura e pittura.
Dopo due secoli di vita, la Commedia dell’Arte, a metà Settecento, è ormai in sofferenza. Gli attori non sono nemmeno in
grado di elaborare in prima persona i loro testi, e devono ricorrere per questa finalità al poeta di compagnia. Goldoni si
avvicina al teatro appunto come poeta di compagnia. La sua riforma della commedia procede per gradi. Nella fase iniziale
abbiamo dei prodotti misti, con parti di taluni personaggi compiutamente scritte, e altre parti redatte solo sotto forma di
canovacci. Soltanto successivamente si avranno testi che presentano le battute di tutti i personaggi. Non bisogna però
credere che, per questo fatto, Goldoni abbia vinto al sua battaglia in modo definitivo. Perché la riforma goldoniana trionfi
veramente bisogna quindi attendere in Italia l’arrivo della figura del regista, nei primi anni del secondo dopoguerra.
Le teorie d’arte attorica proposte nel corso dei secoli sono molteplici. Semplificando molto, ne possiamo individuare due
particolarmente diffuse: l’una, prediletta in area romantica, accredita l’attore “caldo”, intimamente partecipe dei sentimenti
e dei pensieri del proprio personaggio; l’altra pensa all’attore come ad un artista dotato di una tecnica sofisticata che recita
in una condizione di distacco. Alla seconda scuola appartiene Diderot.
10. L’intermezzo classici-romantici
La strada del dramma borghese è lunga e accidentata, prima di arrivare al suo completo trionfo, a fine Ottocento. Il
processo storico ha le sue complessità, i suoi percorsi sinuosi, le sue contraddizioni. A metà del Settecento, commedia e
tragedia cominciano ad essere arnesi non più funzionali, e sono sul punto di essere soppiantati dalla nuova forma teatrale
del dramma borghese. Nella commedia si aggiungono timbri nuovi, anche intensamente drammatici, che si aprono a una
forte satira sociale contro il dispotismo della nobiltà e della magistratura del tempo.
In quanto alla tragedia, essa appare irrimediabilmente condannata, legata com’è a un’ideologia aristocratica messa in crisi,
prima, dalla rivoluzione degli intellettuali dell’Illuminismo e, poi, dalla Rivoluzione Francese del 1789. Ma per tutto il
Settecento, e fino all’inizio dell’Ottocento, molti letterati europei continuano imperterriti a coltivare quella sorta di fiore di
serra che è la tragedia, soprattutto la tragedia classicistica, fondata cioè su tutte le buone regole aristoteliche dell’unità di
tempo e di luogo. Esempio tipico il francese Voltaire, che resta fedele alla forma canonica della tragedia.
In Italia l’autore più significativo, in questo senso, è il conte astigiano Vittorio Alfieri.
Dal Romanticismo in poi ciò che conta è l’Io, irriducibile nel suo opporsi a ogni legame, a ogni dipendenza. Il valore, il
merito, la qualità stanno solo nell’assoluta, totale, radicale novità. Ben diversamente nella cultura classica. Per la quale il
valore, il merito, la qualità stanno invece nella capacità di collocarsi entro una linea di continuità, nella disponibilità a porsi
come anello di una catena lunga. L’originalità va bene, ma come variazione sul tema.
Alfieri si sente un grande tragico perché si inserisce nella catena dei grandi tragici che l’hanno preceduto. Ma la continuità
non impedisce la sfida. Il piacere narcisistico dello scrittore è di misurarsi e di confrontarsi con dei modelli considerati
eccellenti. La scommessa da vincere consiste nel dimostrare che si può scegliere anche un argomento moralmente
pericoloso, riuscendo egualmente a creare un testo moralmente accettabile. Questo gioco di rimandi e citazioni indirette
può essere apprezzato solo da uno spettatore raffinato, che sappia cogliere il senso dell’allusione. Ma questo è il significato
profondo della tradizione, che è, da un lato, soddisfatta collocazione all’interno di un asse ereditario sentito come
privilegio, e, dall’altro lato, compiaciuto gusto a mostrare la propria originalità in un confronto continuo e serrato con
quello.
Descargado por Cecilia Bellentani ([Link]@[Link])
lOMoARcPSD|4655872
Al di sotto della forma tragica dell’opera di Alfieri preme una forma comica. All’altezza cronologica di metà Settecento le
strutture di commedia e tragedia entrano in crisi.
Il nascente dramma borghese preme e vive dietro le pieghe della paludata tragedia alfieriana. Ma la tragedia di impianto
classicistico non è solo insidiata da una vita sociale che è sempre più borghese e mercantile. Tra fine Settecento e primo
Ottocento il classicismo è insidiato anche dal diverso modello della tragedia romantica. Se la Francia è sostanzialmente la
patria del dramma borghese, tedesco è il grande movimento culturale del Romanticismo che ha nello “Sturm und Drang”
la sua prima espressione di massima visibilità. I tedeschi Friedrich Schiller e Wolfgang Goethe contrappongono con forza
al dramma diderotiano il modello del genio assoluto di Shakespeare, libero dagli impacci delle regole aristoteliche, pronto a
mescolare tragico e comico, e soprattutto prontissimo a dare sfogo all’erompere della passione. In opposizione al lungo
sforzo di individuare un genere intermedio (appunto il dramma borghese) i romantici tedeschi ribadiscono la centralità
della tragedia pura, come espressione dell’Io in rivolta contro la realtà esistente; alla piattezza della prosa oppongono la
poesia, il verso; al controllo delle passioni l’esplosione delle passioni; alla strutturazione dei personaggi in un quadro per
così dire “corale” il violento individualismo del protagonista assoluto; allo spazio interno del salotto borghese gli spazi
aperti.
Su questa linea anche Alessandro Manzoni, che insiste soprattutto sul problema delle unità aristoteliche. Egli individua
nitidamente la duplice conseguenza negativa di quelle unità: una di ordine estetico (facilmente comprensibile, nel senso che
impediscono molte bellezze e producono molti inconvenienti di verosimiglianza) e una di ordine morale. Il nucleo
autentico della poetica manzoniana consiste in un bisogno di verità. Il vero è la sorgente della poesia. Il nazionalismo (che
caratterizza il movimento romantico) è bisogno di riscoperta di sé, della propria identità, linguistica e politica.
Il Romanticismo esporta tensioni morali e teorie estetiche più che tipologie drammaturgiche. Il teatro romantico
propriamente detto ha in Francia vita brevissima, non più di una quindicina d’anni. Il romanticismo italiano ha di per sé
una struttura assai gracile. Vince il dramma di ascendenza diderotiana, perché la borghesia, nel momento del suo
consolidamento, ha più bisogno del teatro come strumento sociale, come luogo in cui rappresentare fedelmente e
riconoscibilmente i propri valori. D’altra parte, occorre non dimenticare che anche la drammaturgia romantica è borghese,
se non nelle ambientazioni certo nei valori che la fondano e nella rivendicazione della propria modernità. L’impegno
romantico è teso a distruggere l’ingessatura classicistica, soprattutto aristotelica, che da sempre blocca la forma tragica, ma,
così facendo, contribuisce alla definizione di una strategia che guarda nella direzione del realismo e della contemporaneità.
Su questa linea drammaturgica (che intreccia sentimenti e passioni con le barriere sociali) più risolutamente, procede la
generazione di Alexandre Dumas figlio.
Già in epoca pienamente romantica il genere largamente dominante a Parigi, rispetto a tutti gli altri generi teatrali, è il
vaudeville, un prodotto industriale fatto in serie, a più mani, con una forma drammaturgica esile, in cui parti dialogate si
alternano a canzonette. Scribe, Labiche, Sardou, Feydeau... sono tutti autori che trionfano con quella che si chiama
ovunque la piéce bien faite, elaborata con grande perizia artigianale, che intreccia (sul filo di un ritmo sempre teso, talvolta
indiavolato, in una girandola di grande comicità) intrighi complicati e puriginose storie di adulteri.
11. Fine Ottocento tra Marx e Freud: la grande drammaturgia europea e la piccola drammaturgia italiana
Abbiamo detto che la borghesia ha faticato ad assimilare il teatro, nato come giocattolo di corte, e poi gradualmente
assimilato quale elemento canonico del proprio intrattenimento social-mondano. Ma si determina a questo punto un’altra
divaricazione importante all’interno della borghesia: quella che contrappone il divertimento all’istruzione, lo svago alla
riflessione intellettuale. C’è uno scarto ampio fra l’uso del teatro con funzioni culturali e il suo uso con mere funzioni
edonistiche.
Gli ultimi decenni dell’Ottocento vedono insomma una battaglia importante ingaggiata da un’ala minoritaria della
borghesia, determinata a investire il teatro della funzione di cogliere e comunicare i segni profondi dei mutamenti epocali
che il trionfo del capitalismo ha comportato a livello europeo. Il teatro come occasione di riflessione e di autocritica, sulla
direttrice che da Ibsen arriva a Pirandello.
L’infittirsi della popolazione urbana nelle metropoli dell’Occidente crea le condizioni di un mercato per la vendita dei
prodotti dell’industria dello spettacolo assolutamente inedito rispetto ai parametri storici del passato. Gli edifici teatrali si
moltiplicano nel tessuto cittadino. Il flusso improvviso e inusitato di nuovi strati di spettatori apre per i teatri parigini
un’era di prosperità. Si tratta di un pubblico eterogeneo, cosmopolita, sicuramente meno acculturato, costituito spesso dai
“nuovi ricchi”, con una sete più avida di denaro, divertimento e sesso. Non a caso la drammaturgia francese di questo
periodo è dominata dalla doppia problematica del denaro e del sesso, della ricerca del guadagno e dell’ossessione
dell’adulterio. Proprio il senso di quest’alterazione stretta fra vitalità edonistica borghese e inventività teatrale è evidente
nell’affermarsi di quella forma particolare di teatro che è il “café-chantant” o “café-concert”, cioè un locale in cui i
consumatori possono ascoltare musica ed esibizioni di canto. La macchina spettacolare si fa via via più complessa e
articolata. All’inizio c’era solo una pedana per il cantante e un’orchestrina ridottissima; poi si passa a piccoli palcoscenici
all’italiana, in fondo alla sala, con fossa d’orchestra e qualche ordine di palchi. A musicisti e cantanti si affiancano comici,
Descargado por Cecilia Bellentani ([Link]@[Link])
lOMoARcPSD|4655872
danzatori, acrobati, giocolieri, ventriloqui, fachiri, illusionisti e performers. Uno spettacolo composto di una varietà di
numeri, destinato a diventare con il tempo, il vero e proprio varietà.
Il café-concert è il luogo dove il dato artistico è degradato a semplice integrazione della consumazione; la merce teatrale è
ridimensionata alla capacità di concentrazione e di partecipazione di una platea di spettatori più vasta, di strati sociali umili,
financo con possibili valenze domestico-familiari.
È tutto il teatro ottocentesco (non solo quello minore ma anche quello maggiore) a essere governato dalla logica del
visuale, del piacere dell’occhio. Domina ovunque la sala all’italiana. Anche il vero e proprio teatro di prosa è egemonizzato
dalla forza catturante del dato visivo.
La produzione drammaturgica di un Ibsen, di uno Strindberg, di un Cechov rappresenta un piccolo settore della realtà
spettacolare effettiva del tempo. Il norvegese Henrik Ibsen è il principale rappresentante di un teatro che si pone come
momento di alta e sofferta riflessione sulla condizione borghese. È lui l’inventore di quello che possiamo chiamare “il
teatro del salotto borghese”. È con lui che giunge a termine il lungo processo, iniziato con Diderot, di messa a fuoco del
dramma borghese.
Quando si dice che Ibsen è il maggior poeta del salotto borghese, vogliamo anche dire che questo spazio si dilata, si
articola in una molteplicità di tappeti, tende, portiere che attutiscono i rumori, che attenuano l’eccesso di luce e di
trasparenza, per definire meglio il profilo di couche calda, intima, discreta, riservata, offerta alla privacy dell’agiato
borghese. Ma tutto questo finisce anche, paradossalmente, per sollecitare travalica menti, oltrepassamenti di spazi,
origliamenti. Ciò che va tenuto celato può sempre essere spiato. Nel corso dell’Ottocento la famiglia borghese si rafforza
in potere e dignità. Nel teatro di Ibsen si origlia moltissimo. Ma è tutto il teatro borghese dell’Ottocento che è traboccante
di spazi insidiati, di occhi che s’insinuano velatamente, di porte che hanno orecchie.
Insomma se la “piéce bien faite”, di fattura francese, può consentire alla classe borghese di rispecchiarsi a teatro, è con
Ibsen che si realizza un primo decisivo rovesciamento. Il teatro diventa lo specchio critico della società, il luogo deputato a
dibattere seriamente le grandi questioni della famiglia e, accanto a queste, del lavoro, della carriera. I contemporanei più
acuti hanno lucida consapevolezza di questa correzione di tiro.
Ibsen sottrae al teatro la dose tradizionale di sentimentalità e di amore, e introduce la sorprendente novità formale della
discussione, della svolta determinata nel corso del dramma dall’attimo in cui uno dei personaggi impone la riflessione,
l’analisi dei problemi. Nasce la cosiddetta tecnica analitica dei drammi ibseniani (e di tutto il teatro moderno). Di lì a poco
Freud (l’inventore della psicanalisi) farà stendere i suoi pazienti della borghesia viennese sul lettino della psicanalisi.
Lo scatto in più di Ibsen, rispetto a quella che abbiamo chiamato la linea Diderot-Goldoni, è proprio qui: non solo gli
intrecci familiari, le relazioni sentimentali, non sono i soldi, il lavoro, la carriera, ma anche la potenza delle pulsioni vitali,
degli stimoli profondi che si spalancano e si scatenano. Sono i mostri dell’inconscio che Ibsen evoca sulla scena; i
personaggi hanno scheletri dentro gli armadi e il dramma ibseniano si incarica di aprirli, di metterli allo scoperto.
La drammaturgia ibseniana nasce, sì, nell’Ottocento, come peraltro la psicoanalisi di Freud, ma, esattamente come quella, si
prolunga ben oltre l’Ottocento, getta la propria sonda a uno strato profondo, inesplorato dell’animo umano, dove sono in
gioco le classi sociali e le civiltà storiche, certo, ma anche le grandi ossessioni dell’uomo di sempre, l’urto frontale fra
elemento maschile e elemento femminile, la paura terribile che l’uomo mostra di avere della donna.
Da questo punto di vista è doveroso fare il nome dello svedese August Strindberg, i cui primi capolavori risultano
fortemente incentrati sul tema dello scontro dei sessi.
La grande drammaturgia ottocentesca è davvero intrepida capacità di scrutare l’abisso, di sondare i mostri dell’inconscio.
Se Ibsen non arretra di fronte alle più segrete pulsioni, Strindberg non esita a dichiarare che il linguaggio dell’eros è anche il
linguaggio della violenza, e non solo della tenerezza.
Un po’ diverso il quadro che emerge dal terzo grande rappresentante della drammaturgia europea, il russo Anton Cechov,
che sembra operare una radicale trasformazione della tipologia del dramma di fine Ottocento. Il salotto borghese della
tradizione, con quell’aria sempre vagamente asettica appare sottoposto a tensioni inaspettate. La materialità dei bisogni
fisiologici invade a poco a poco lo spazio sublimato della casa in cui la borghesia era solita autorappresentarsi e
autocelebrarsi nelle sue attitudini più nobili e più spirituali. Il salotto tende a porsi come una sorta di paradossale luogo
pubblico in cui la gente circola liberamente.
Il salotto da interno si fa esterno, perché Cechov sembra attratto dalla dimensione del fuori, dell’aperto, al di là della
barriera claustrofobica della demeure di tanto teatro ottocentesco. Siamo insomma di fronte a uno spazio in qualche modo
dilatato, in cui viene a situarsi un numero parimenti dilatato di personaggi. Cechov ha sempre bisogno di una dozzina di
figure.
Non è questione di aridi dati numerici. In Ibsen c’è sempre un eroe, un protagonista, circondato da un coro di altri
personaggi, più o meno numerosi; in Cechov c’è un gruppo di personaggi privo di centro. È sempre problematico
individuare l’attore principale di un testo di Cechov. Anche la struttura del dialogo viene pertanto a mutare. Non più la
prevalenza di duetti, di scambi di battute limitati a pochi interlocutori, ma un’insistenza decisa su concertati corali.
Descargado por Cecilia Bellentani ([Link]@[Link])
lOMoARcPSD|4655872
Tutto questo non azzera l’eredità più significativa della linea Ibsen-Strindberg, cioè l’indagine sui mostri inconsci. Cechov
(non meno di Ibsen e Strindberg) sembra appartenere alla civiltà del Naturalismo, ma appartiene invece, semmai, a quella
del Simbolismo.
Rispetto alla grande drammaturgia europea di Ibsen, Strindberg, Cechov, non c’è dubbio che quella italiana sia una piccola
drammaturgia, di respiro corto, con scrittori che spesso sono autori di un solo testo, senza capacità di fondare una linea di
sviluppo, di dare continuità allo slancio creativo. Eppure, nei suoi limiti, è una produzione che si muove in sintonia con i
modelli europei, e che risulta autonoma rispetto a quelli.
In Giacosa c’è quello che ritroviamo in Ibsen: le questioni della famiglia, del rapporto uomo-donna che si mescola con le
volontà di ascesa sociale, con la determinazione dei maschi a realizzarsi nel loro lavoro.
12. Il teatro del Grande Attore tra Ottocento e primo Novecento
Dal punto di vista teatrale l’Ottocento è un periodo di svolta e di modificazioni molto complesso, in cui si intrecciano fili
diversi: la drammaturgia, ma anche gli attori, e infine la nuova figura del regista. I tre fili sono un intreccio di realtà che
occupano spesso gli stessi anni, che si svolgono cioè in contemporanea.
Cominciamo con l’esaminare l’architettura delle compagnie italiane, che risultano basate su un organico di ruoli. Il ruolo
non va confuso con la parte; semmai il ruolo comprende la parte.
Il primo attore e la prima attrice sono coloro che hanno diritto di scelta prioritaria sulle varie parti, quali che siano, a
condizione che non si discostino troppo dalle proprie possibilità artistiche. In pratica, a loro spettano le parti di
protagonista. Il primo attore deve essere fisicamente un bell’uomo, imponente, con una voce potente. E similmente alla
prima attrice è richiesta figura maestosa, casomai anche un po’ giunonica, voce non deficiente.
Il brillante è sempre un ruolo maggiore, che introduce una nota più leggera nei testi seri, e che diventa determinante nei
testi comici, assumendo la funzione di motore dinamico della vicenda, spesso finendo per assorbire il ruolo del primo
attore. Nel teatro del primo Novecento il brillante si trasforma a poco a poco, raffinandosi sempre più e risolvendosi nella
figura del raisonneur, ironico e sottile, spesso portavoce dell’autore.
Il caratterista è legato ai personaggi di carattere della drammaturgia molièriana e goldoniana, sebbene la terminologia sia
ottocentesca. Essenziale un certo tipo di fisico che sottolinea gli elementi caricaturali dei personaggi che incarna. Ci sono
varianti più serie del caratterista: uomo/donna di mezza età, tiranno...
All’attor giovane e all’attrice giovane spettano parti importanti ma di personaggi definiti giovanili per età.
La seconda donna interpreta il personaggio rivale di quello scelto dalla prima attrice. Deve avere doti fisiche analoghe a
quelle della prima donna.
Il promiscuo indica un ruolo capace di consentire il passaggio da personaggi patetici a personaggi comici. Si tratta di un
ruolo minore ma di grande importanza, soprattutto nelle compagnie dialettali.
Sul gradino più basso della scala stanno i generici, utilizzati in parti drammaturgicamente abbozzate, cioè generiche, tali che
l’attore possa fungere indifferentemente in parti di diversa natura.
Non è così pacifico per tutti gli studiosi che la strutturazione per ruoli discenda dalla pratica della Commedia dell’Arte. È
chiaro comunque che, dal punto di vista dell’attore, il massimo di specializzazione coincide con una resa professionistica
ottimale. Attraverso il ruolo l’attore ripete per tutta la sua vita artistica uno stesso tipo di prestazione, e questo gli
garantisce una possibilità più ampia di perfezionismo. Significativo il fatto che l’attore fosse orientato verso questo o quel
ruolo prima di tutto proprio dalla maggiore o minore corrispondenza con le caratteristiche fisiche implicite in esso.
L’articolazione per ruoli svolge una funzione di mediazione fra il tramonto del vecchio modo di produzione, risalente alla
Commedia dell’Arte, e la nuova situazione storico-culturale che si impone a cavallo fra Settecento e Ottocento.
Dal punto di vista economico la compagnia ottocentesca è generalmente di proprietà del capocomico, il quale assume
funzioni di impresario. I contratti durano almeno un anno, ma spesso sono stipulati per un triennio, con possibilità di
rinnovo. La compagnia ottocentesca è molto instabile per il suo nomadismo, ma molto stabile per la coerenza e
l’affiatamento degli interpreti.
Il capocomico svolge anche funzioni di coordinamento del lavoro di tutti gli attori. Non è possibile parlare di regia, ma è
indubbio che esiste una sorta di supervisione. Il capocomico è colui che non solo sceglie il repertorio, tratta con gli autori
ma distribuisce le parti e dirige le prove.
Inutile insistere sull’assoluta disinvoltura con cui il capocomico interveniva sul testo: tagliando, spostando, aggiungendo.
Ancora al capocomico spetta la cura della scenografia, estremamente sommaria, fatta di carta dipinta. Lo spettacolo italiano
ottocentesco è una semplice sommatoria di diversi ingredienti che non un tutto organico e armonico.
Per i costumi la cosa era più semplice ancora, dal momento che gli attori, per contratto, provvedono a proprie spese agli
abiti relativi al proprio ruolo. Si fa eccezione per i costumi di carattere o stranieri, che sono forniti dalla compagnia. Nella
misura in cui i costumi sono a carico degli attori, essi finiscono quasi sempre per risultare approssimativi, stilisticamente
disomogenei.
Estremamente sommaria anche l’illuminazione che si riduceva in pratica alle luci in basso della ribalta e alla fila di
lampadine in alto dette la bilancia. Un’illuminazione fissa, che si limita a far vedere, ma che non ha una funzione
Descargado por Cecilia Bellentani ([Link]@[Link])
lOMoARcPSD|4655872
rappresentativa e tanto meno una valenza simbolica, legata al personaggio, ai suoi stati d’animo. Assai lentamente si arriva
all’idea di poter usare la luce come un fattore di poesia scenica. In attesa di tutto ciò l’attore è spinto a recitare in proscenio,
perché è l’unica parte illuminata. Questo ritardo nell’illuminotecnica esalta il valore mimico del volto dell’attore, in cui ciò
che conta è la presenza viva, demiurgica dell’attore, e tutti gli altri aspetti del linguaggio scenico sono ricondotti a sviluppo
zero.
Resta da dire dell’anno teatrale che per la prosa dura dalla prima domenica di Quaresima fino all’ultimo giorno del
successivo carnevale. Soltanto negli ultimi decenni dell’Ottocento si avvia un processo di sindacalizzazione dell’attore, che
riuscirà a modificarne la condizione assai pesante.
La novecentesca razionalizzazione del lavoro eliminerà implacabilmente certi aspetti indegni della dignità professionale del
lavoratore della scena, come le serate d’onore o di beneficio.
Quello delle compagnie teatrali è un mondo stratificato. Ci sono le compagnie primarie, che percorrono le capitale e le più
prestigiose città delle province; le secondarie, che limitano i propri giri alle città meno importanti della provincia e ai grossi
paesi; e le cosiddette compagnie di terz’ordine che sono le compagnie dei guitti, operanti in paesini e paesetti anche i più
sperduti. Fra i vari livelli verticali della compagnia non esistono barriere (la Duse era una guitta all’inizio).
Il quadro complessivo che abbiamo delineato ci fa capire che la performance del grande attore è fondata sulle risorse
individuali dell’interprete.
Il grande attore può alternare Shakespeare con mediocri pennivendoli contemporanei. Anzi, il suo repertorio è costituito in
prevalenza da lavori dozzinali. Ciò che conta non è il copione ma la poesia d’attore, perché è l’arte del grande attore che
riscatta il testo e rende un capolavoro anche quello che era un copione insufficiente. Il pubblico ama andare a teatro per
vedere il lavoro dell’attore, non già per vedere capolavori culturali.
Il teatro del Grande Attore non è solo una specificità della scena italiana, ma è la sigla in cui si ritrova una parte cospicua
del panorama teatrale europeo di fine Ottocento e primo Novecento.
In Inghilterra e in Francia, non meno che in Italia, il grande attore si pone indubbiamente come un vettore portante della
nascita e dell’esplosione dell’industria dello spettacolo.
13. Il teatro del regista tra Ottocento e primo Novecento
“Teatro del grande attore” e “teatro del regista” convivono e occupano cronologicamente più o meno gli stessi anni, cioè i
decenni tra fine Ottocento e primo Novecento. La regia nasce come reazione ai guasti più evidenti del modo di fare teatro
fondato sull’attore.
Si dice che un notevole impulso alla formalizzazione della regia moderna venga dalla compagnia dei Meininger, attiva dal
1866 al 1874 nel teatro ducale di Sassonia-Meiningen. Per questa compagnia è fondamentale il rispetto del testo, la pratica
di prove lunghe e rigorose, la verità quasi archeologica dei costumi e delle scene, l’adozione di nuove tecniche
d’illuminazione elettrica, la massima cura nelle scene di massa. Il valore storico dei Meininger è nell’imposizione della
disciplina, nella fondazione del controllo sull’attore.
Dal 24 giugno al 1 luglio 1888 André Antoine è a Bruxelles per seguire alcune rappresentazioni dei Meininger. Antoine ha
fondato nel 1887 il suo Theatre Libre e la lezione dei Meininger lo rafforza nel suo progetto. Il suo punto di riferimento è
Zola, che dopo aver rinnovato in senso naturalistico il romanzo, si era improvvisato per quattro anni, quale critico teatrale,
al fine di sollecitare anche la scena a una riconversione naturalistica. Antoine parte da queste considerazioni zoliane. Il
primo obiettivo è la riforma del décor. Ciò che deve emergere è innanzitutto il quadro d’insieme, la totalità. Lo spazio, la
scenografia, non sono più un dato secondario. Antoine recupera il discorso zoliano sul décor che spiega e determina i
personaggi. Gli attori devono essere collocati in uno spazio credibile, reale, non ridicolo. Con Antoine siamo a un tipo di
piantagione che azzera la tela dipinta e gli effetti illusionistici. La scena è costruita, l’attore vi recita dentro. Il messaggio
non passa più unicamente attraverso lo charme della voce del grande attore o attraverso la sua immagine, ma passa
all’interno di un effetto complesso di composizione.
Quello che può sembrare il limite del Theatre Libre (la condizione amatoriale dei suoi componenti) si rovescia in
coefficiente di forza. Il dilettantismo ha preservato i compagni di Antoine dal rischio dei cliché sclerotizzati della tradizione
recitativa sancita nelle accademie.
Dieci anni esatti separano Antoine da Stanislavskij, che possiamo considerare una specie di padre del teatro moderno. Nel
giugno del 1897 Stanislavskij fonda il Teatro d’Arte di Mosca in cui confluirono, da un lato, il gruppo di dilettanti che
Stanislavskij aveva organizzato e, dall’altro, i migliori allievi di una scuola teatrale. In questa nuova formazione, viene
dichiarata guerra a tutti i vizi consueti dell’attore. Si rifiutano le gerarchie delle parti. Ancora una volta ciò che può
sembrare una limitazione si ribalta in elemento di forza: gli attori dilettanti offrono il grande vantaggio di non essere
condizionati dai tic insopportabili del mestiere. La battaglia che il Teatro d’Arte di Mosca intraprende immediatamente è
infatti contro tutti i guasti di certa tradizione attorica ottocentesca; il pathos e la declamazione affettata di marca tardo-
romantica; la teatralità come sinonimo di falsità scenica, di convenzione approssimativa, di costumi sommari, totalmente
inaffidabili per quanto riguarda la credibilità storica di drammi d’epoca. La possibilità di non mostrare sempre il viso al
Descargado por Cecilia Bellentani ([Link]@[Link])
lOMoARcPSD|4655872
pubblico, di recitare anche di spalle. La collocazione di alcune scene in un quadro di oscurità, abbandonando la
consuetudine della recitazione in piena luce. E il solito studio minuzioso e fanatico per le ambientazioni degli spettacoli.
Stanislavskij arriverà presto a comprendere che la funzione profonda del regista non è quella di sovrapporsi all’attore ma di
assecondarlo, di aiutarlo a esprimersi, perché l’essenziale è nelle mani degli attori. Il passaggio ulteriore avverrà soltanto
grazie all’incontro con Cechov, cioè con una drammaturgia assolutamente originale e diversa, che permetteva a
Stanislavskij di ricercare una verità più intima, priva di appoggi in svolgimenti e in accadimenti vistosi. Per una
drammaturgia come quella cecoviana (in cui non succede mai nulla di decisivo) occorre riuscire a creare un’atmosfera,
porgere le battute in modo diverso dallo stile un po’ enfatico e un po’ melodrammatico che caratterizza gli attori del
tempo. Nasce una recitazione fatta di tonalità sfumate, di pause, di silenzi.
Il rinnegamento della figura del regista-despota si accompagna in Stanislavskij al nuovo metodo di preventiva
considerazione dell’attore, sicché la messinscena nasce in accordo con l’attore, in collaborazione con lui, anziché calarsi su
di lui in maniera costrittiva.
Accanto al Teatro d’Arte, Stanislavskij apre via via una serie di studi, collegati con la scena-madre ma autonomi, in cui
sperimenta la sue riflessioni sull’arte attorica.
È qui che si definisce ciò che si chiama il “Sistema”: un codice recitativo che comincia a essere conosciuto nei primi anni
Venti, espresso nei libri “Il lavoro dell’attore su sé stesso” e “Il lavoro dell’attore sul personaggio”. Il Maestro è
ossessionato da un problema: come evitare che l’attore, replicando la propria parte infinite volte, non scada in iterazione
meccanica di stampi esteriori, di clichés? Stanislavskij (sostenitore dell’idea che lo spettatore debba essere coinvolto
emotivamente) ritiene che una partecipazione affettiva da parte del fruitore possa scattare con intensità solo se l’attore è
intimamente commosso. Il Sistema è l’insieme delle proposte, dei suggerimenti, delle tecniche di allenamento elaborate
faticosamente per mettere l’attore nella condizione di grazia: attraverso uno scavo interiore, attingendo al patrimonio del
proprio vissuto, delle proprie emozioni.
Il Sistema non ha nessuna pretesa di sistematicità (Actor’s Studio).
L’ultima rimessa in discussione si ha negli anni Trenta, allorché Stanislavskij rovescia completamente il Sistema e comincia
a parlare di “metodo delle azioni fisiche”. È sempre operante l’intreccio spirito/corpo, che è il nucleo di fondo del
pensiero del nostro, ma il regista si è reso conto che il percorso dal sentimento alla dimensione mimico-gestuale è arduo, e
in ogni caso è sempre problematico fissare i sentimenti, che sono di per sé instabili e capricciosi. Per l’inverso sembra più
agevole fissare le azioni fisiche.
È curioso come alle origini della regia moderna ci siano sempre dei gruppi di origine più o meno dilettantistica. Il regista si
impone avendo di fronte degli attori non prestigiosi. Perché il grande attore oppone una resistenza fortissima all’avvento
della regia.
Pervenuto al culmine del proprio trionfo, in pieno Novecento, il regista taglia e modifica il testo, come e più di quanto
abbia mai fatto l’attore nel corso dei secoli. E a mano a mano che il regista impone il suo dominio sulla scena, l’attore si
sente progressivamente ridotto a una semplice rotella di un ingranaggio, represso nella sua capacità di rinnovamento
fantastico e creativo.
I registi hanno necessità di nuove forme drammatiche: non più copioni che prevedono squarci lirici attraverso i quali
irrompe la recitazione del grande attore solista, e nemmeno la piéce bien faite della tradizione francese, fatta di intrighi e di
colpi di scena, bensì una struttura rispettosa dell’insieme, dell’interazione di tutti i personaggi, attentissima allo sviluppo e
all’approfondimento psicologico dei medesimi, coraggiosamente pronta a rinunciare alla grossolanità dei fatti e degli eventi.
Non è certo una casuale coincidenza che la regia e la grande drammaturgia europea nascano negli stessi anni, nell’ultimo
trentennio dell’Ottocento. Gli scrittori per teatro di fine Ottocento hanno bisogno di una particolare messinscena;
presuppongono il regista e in qualche modo lo mimano. Si pensi al fenomeno dell’ampliarsi delle didascalie: sempre più
particolareggiate e tali da prefigurare un’ipotesi di allestimento.
Per alcuni specialisti la regia è un fenomeno novecentesco, che annovera una serie di padri fondatori, i quali sono registi
ma anche teorici e scenografi. Altri studiosi preferiscono cogliere nello sviluppo della regia al passaggio di secolo fra
Ottocento e Novecento, non già l’elemento della rottura bensì quello della continuità, e si preoccupano di retrodatare il
manifestarsi della regia come sintomo di una organica organizzazione del palcoscenico e fenomeno professionale.
Che cosa distingue il teatro dell’attore dal teatro del regista? La forza dello spettacolo del grande attore non è fondata sul
testo, bensì sul proprio corpo, sulla propria voce. La forza dello spettacolo del regista ottocentesco è fondata sul rispetto
vigoroso del testo. C’è una spinta naturale che sembra guidare l’autore verso la funzione registica.
Sarà anche vero che nel Novecento la regia si mostra nel suo volto di principio estetico; e sarà anche vero che la pulsione
registica degli autori drammatici sia un fatto di carattere culturale, ma è certo e sicuro che la regia si definisca prima di tutto
come un mestiere, come un nuovo mestiere dell’industria dello spettacolo che si va affermando nel corso del primo
Ottocento.
Il regista è il nome nuovo di una nuova professione, quella di un professionista che sa trovare gli attori giusti, sa a chi
commissionare scenografie e costumi, e infine sa come coordinare il lavoro degli attori sulla scena. La lunga storia della
regia (dal primo Ottocento al Novecento) è la storia della lenta trasformazione di questa pratica operativa: non più un
Descargado por Cecilia Bellentani ([Link]@[Link])
lOMoARcPSD|4655872
mestiere, ma un’arte. Mentre il professionista del primo Ottocento ha come obiettivo di fare un duplicato, l’artista del
Novecento ha come obiettivo di realizzare un prodotto originale, unico.
14. Primo Novecento: le Avanguardie Storiche e la centralità di Pirandello
L’inizio del Novecento è contrassegnato da una grande irrequietudine spirituale. Molti intellettuali rimettono in discussione
le certezze della cultura dominante e si impegnano in uno sperimentalismo accanito e instancabile, dando vita a una serie di
correnti che i manuali unificano sotto l’etichetta di Avanguardie Storiche.
In termini cronologici il primo evento è rappresentato dal “Manifesto del Futurismo”, pubblicato il 20 febbraio 1909 sul
parigino “Figaro” da Filippo Tommaso Marinetti. Marinetti è il fondatore di un movimento che ha una certa risonanza
internazionale e che si batte per adeguare la realtà artistica alla “modernità” del sistema economico-sociale, con parole
d’ordine talvolta chiassose talaltra nazionalistiche e guerrafondaie, sicché non stupisce la confluenza del Futurismo italiano
nel fascismo. Del 1911 è il “Manifesto dei drammaturghi futuristi”, sempre composto da Marinetti, che rivela però tutti i
limiti di consapevolezza della problematica teatrale. Marinetti non sembra sfiorato dal dubbio che la scena europea ha
ormai assimilato la figura del regista, e continua a parlare di “drammaturghi”. Più interessante un altro manifesto, “Il teatro
di varietà”, firmato ancora dal solo Marinetti nel 1913, dedicato a una forma di teatro minore, solitamente ignorata dagli
intellettuali, che si deve aprire a una pluralità di espressioni spettacolari, ma soprattutto a una interazione con il pubblico,
che non rimane statico come stupido “voyeur”, ma partecipa all’azione. La rottura della barriera palcoscenico/platea è il
filo rosso che attraversa il variegato panorama delle Avanguardie Storiche. Il Futurismo italiano non lascia segno in campo
teatrale, ma certo contribuisce a definire lo “spettacolo moderno”, con l’invenzione delle “serate futuriste”.
Qualche contatto con i futuristi ebbe certamente Ettore Petrolini, geniale artista solista di varietà, inventore di macchiette e
caratteri, di lazzi e filastrocche, che irridono il sentimentalismo, le mode del tempo, l’idiozia dell’umanità.
Di matrice principalmente tedesca, databile fra il 1910 e il 1924, è l’Espressionismo, legato originariamente alle arti
figurative, come reazione all’Impressionismo. L’Espressionismo esalta la visione soggettiva dell’artista. Sul terreno teatrale
l’Espressionismo esprime la denuncia sofferta della disumanità del mondo, e soprattutto dell’esperienza traumatica della
Prima Guerra Mondiale.
Sulla stessa linea delle serate futuriste saranno le “serate dadaiste”. Ma Dada non si batte per un’arte nuova (come il
Futurismo), e nemmeno porta avanti una battaglia, attraverso l’arte, per un mondo nuovo (come l’Espressionismo).
Fondato a Zurigo nel 1916 dal poeta Tristan Tzara, Dada si estende rapidamente a livello internazionale, con propaggini a
New York, Berlino, Colonia, Parigi. Il manifesto di fondazione di Tzara dichiara a tutte lettere che “l’arte non è una cosa
seria”. Viene meno con Dada, forse per la prima volta nella storia della cultura occidentale, la fiducia sulla funzione
positiva che l’arte e la cultura possono esercitare nella vita quotidiana.
Ben presto, proprio all’interno di Dada rinasce la richiesta di un discorso positivo. Tra il ’22 e il ’23 si esaurisce il
movimento Dada; nel ’24 Breton firma il primo manifesto surrealista. E con Breton molti seguaci di Dada passano al
Surrealismo, che (sotto l’influsso della psicanalisi di Freud) ripropone uno sguardo costruttivo, teso a scandagliare le
profondità dell’Io.
Un accento positivo presentano anche le Avanguardie in terra sovietica. Il Futurismo russo si colora di falce e martello. La
complessiva scelta strategica delle Avanguardie Storiche punta a valorizzare al massimo l’intervento del pubblico, a
spingere per una irruzione della realtà, della vita nel campo dell’arte e della finzione. Il teatro è ovunque, ogni luogo può
diventare spazio scenico. Si lavora freneticamente per infrangere la contrapposizione attore/spettatore.
La volontà di usare il teatro come arma di critica si configura quale rottura della convenzione teatrale, come tentativo,
ancora una volta, di attirare il pubblico, di coinvolgerlo direttamente.
Di fede inizialmente surrealista è Antonin Artaud, attore regista drammaturgo, dall’esistenza avventurosa e oscura, che lo
condusse alla pazzia, autore di un libro, “Il teatro e il suo doppio” (1938), che contiene intuizioni illuminanti, sebbene non
sistematiche, sulla natura di un “teatro della crudeltà”: suggestione che avrà ricadute importantissime sui principali
esponenti della scena novecentesca e anche oltre.
La figura di Jacques Copeau è attenta a riportare il teatro a una sorta di “classicismo moderno”, proponendo una severa
pedagogia basata su “formazione dell’attore all’esercizio dello spirito, formazione del poeta all’esercizio della scena,
concordia dell’opera letteraria con lo stile dell’architettura teatrale, unità di fondo della rappresentazione”. Da Copeau si
dirama una straordinaria scuola cui appartengono registi come Jouvet, Dullin e, in Italia, Orazio Costa.
A livello europeo, una funzione egemonica l’assume senz’altro Luigi Pirandello, che si posiziona come il massimo
drammaturgo del Novecento. Nel 1921 sfodera un testo-bomba: “Sei personaggi in cerca d’autore”. In un colpo solo,
Pirandello ha distrutto la bicentenaria tradizione europea del “teatro del salotto borghese”. Il pubblico entra in teatro e
trova il teatro. Non c’è sipario, e non c’è illusione teatrale; c’è il palcoscenico nudo, e degli attori che fanno gli attori, che
stanno mettendo in prova uno spettacolo, e poi arrivano 6 tipi strani che dicono di essere dei personaggi, dichiarando di
Descargado por Cecilia Bellentani ([Link]@[Link])
lOMoARcPSD|4655872
voler recitare un dramma, ma pretendendo che il Capocomico sia il loro autore. Il dramma, infatti, lo hanno in loro stessi;
ma, scritto, propriamente non c’è; e dovrà essere dunque il Capocomico a scriverlo, a mano a mano che essi lo vivranno
sul palcoscenico.
La stessa cosa avviene in “Ciascuno a suo modo” (1924), secondo pezzo della cosiddetta “trilogia del teatro nel teatro”.
Anche qui abbiamo una prolungata bagarre fra spettatori, o fra spettatori e attori (e personale del teatro), ma tutto (come
già nei “Sei personaggi...” del ’21) si svolge puntualmente sul palcoscenico. La commedia inventata da Pirandello è
immaginata come ispirata a un fatto di cronaca, e i protagonisti del fatto di cronaca si riconoscono nell’intreccio teatrale e
saltano su a protestare la loro indignazione. Ma alla fine i personaggi della realtà si comportano come i personaggi della
finzione. In Pirandello, la vita irrompe nel teatro solo per riconoscere la superiorità del teatro, il suo decisivo valore
maieutico.
La centralità di Pirandello nel panorama del tempo è costituita da questa sua capacità di raccogliere, depurare, rielaborare.
Pirandello percepisce le rotture delle Avanguardie Storiche, ma, stando all’interno del teatro di tradizione, dell’industria
dello spettacolo, non può che svolgere un lavoro di adattamento, e quindi di mediazione, rispetto alle spinte più estreme di
cui pure ha conoscenza.
Le cose cominciano a cambiare (ma in maniera limitata) soltanto con il 1925, data spartiacque per Pirandello.
Ripubblicando i suoi testi, si apre a una più esplicita audacia avanguardistica, propone anche lui un effettivo superamento
della frattura palcoscenico/platea.
La stessa cosa avverrà nell’ultimo segmento della trilogia: “Questa sera si recita a soggetto” (1930).
Pirandello non si esaurisce nella riflessione metateatrale della trilogia del teatro nel teatro. Riprende il filo della “piccola
drammaturgia” di Giacosa e scrive (a partire dal 1916) una serie di drammi da salotto borghese, che scavano in profondità
nelle miserie umane e psicologiche dei suoi eroi.
Al di fuori di Pirandello, in Italia, non c’è nulla di cui valga la pena conservare memoria. Per qualche tempo Gabriele
D’Annunzio si illude di riuscire a realizzare un “teatro di poesia” che gli fallisce miseramente, nonostante si appoggi alla
più grande attrice di tutti i tempi, Eleonora Duse, sua compagna di vita per un certo numero di anni.
15. Anni Venti-Cinquanta: dal teatro politico al teatro dell’Assurdo
Il cinema è diventato mezzo di comunicazione di massa, marginalizzando irrimediabilmente il teatro. Dall’avvento del
cinema alla fine degli anni Venti, il teatro si rassegna a diventare un’arte che interessa uno strato sociale limitato, di persone
colte.
Nell’imperversare delle lotte di classe, nel quindicesimo che segue la Rivoluzione Russa del 1917, il teatro si riscopre
importante, strategico per la possibilità che ha di essere usato come un’arma politica. Rispetto al cinema, che è un “mezzo
freddo” per la presenza solo virtuale dell’attore, il teatro è un “mezzo caldo”. Nasce cos’ il teatro “agit-prop” (forma
abbreviata per “agitazione e propaganda”), che interviene al di fuori degli spazi tradizionali, dove non è vigente il criterio
del professionismo: operai, impiegati, militanti politici utilizzano la chiave teatrale per determinare la presa di coscienza
delle masse sui problemi del giorno. Siamo dinanzi a una intensa politicizzazione dell’intera vita sociale e culturale, che non
risparmia nemmeno il mondo dell’infanzia.
Molti intellettuali russi vivono il sogno di essere contemporaneamente artisti e militanti rivoluzionari. Il suicidio di
Vladimir Majakovskij (massimo esponente del Futurismo russo) sigilla la difficoltà di questo doppio impegno,
l’impossibilità di restare fedele allo sguardo critico sulla realtà contemporanea, nel momento in cui lo stalinismo ormai
dominante imponeva agli artisti di contribuire a propagandare una visione acritica e ottimistica della società sovietica.
Vsevolod Emilevi Mejerchol’d, il più geniale degli allievi di Stanislavskij, inventore della “Biomeccanica” (sorta di training
per forgiare attori in grado di controllare il proprio corpo), dopo il 1917 diventa un acceso fautore della Rivoluzione. Era
diventato il fautore dell’”Ottobre teatrale”, equivalente artistico della Rivoluzione d’Ottobre. Morirà fucilato durante le
purghe staliniane (repressione per stroncare le opposizioni al regime, colpendo alla cieca anche innocenti). Il Teatro d’Arte
era una istituzione privata, sostenuta dal mecenatismo degli industriali moscoviti. Lenin decide di finanziare con i soldi
dello Stato dei Soviet il Teatro d’Arte. Il vecchio teatro va conservato (a condizione che resti “almeno neutrale”) perché il
nuovo pubblico deve essere acculturato.
Mejerchol’d è avverso a Stanislavskij. L’attore sovietico non è neutrale, non può essere apolitico; è comunque portatore di
una determinata concezione del mondo, ed è questo sguardo politico che deve essere rivolto al personaggio. L’interprete
deve riuscire a “smascherare il personaggio”, per impedire che lo spettatore si identifichi con il personaggio negativo.
È da qui che parte il tedesco Bertolt Brecht (1898/1956). La linea Mejerchol’d-Brecht rimanda a quello che è stato
storicamente il tentativo di allargare l’onda rivoluzionaria dell’Ottobre. Dalla Russia dei Soviet alla Germania della Lega di
Spartaco di Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg, avanguardia del più forte movimento operaio presente in Europa.
Ritroviamo le stesse problematiche cui abbiamo accennato a proposito della Russia sovietica: anche qui compaiono le varie
forme del teatro agit-prop, e anche qui si definiscono le modalità di un teatro proletario per bambini. Ed è qui che nasce il
“teatro politico”, chiamato anche “teatro epico”. L’aggettivo tedesco “episch” rinvia alla distinzione fissata da Aristotele
nella “Poetica” fra “epico” e “drammatico”. Nel poema epico c’è un narratore che racconta mediando fra i personaggi e il
Descargado por Cecilia Bellentani ([Link]@[Link])
lOMoARcPSD|4655872
lettore, nella rappresentazione teatrale, invece, i personaggi si presentano da soli. Il teatro epico presuppone quindi una
sorta di “io epico” che organizza lo spettacolo.
Il regista tedesco Erwin Piscator (1893/1966) è colui a cui si deve il primo tentativo di teatro politico con “Ad onta di
tutto!” (1925).
Ma se Piscator anticipa di qualche anno Brecht su questo terreno di un rinnovamento radicale della vecchia struttura
teatrale, è indubbio che Brecht insiste maggiormente, e con più coerente radicalità, sul fatto che il teatro epico debba
combattere l’aspetto psicologico-emozionale della comunicazione teatrale. Brecht si oppone con forza
all’immedesimazione dell’attore nel personaggio. Secondo Brecht, se l’attore s’immedesima nel personaggio, anche lo
spettatore si immedesima. Occorre invece che l’attore conservi un margine di distacco rispetto al proprio personaggio; solo
così potrà “straniare” lo spettatore, renderlo cioè estraneo rispetto alla rappresentazione. È necessario che lo spettatore
resti distanziato, cogliendo così nell’accadimento teatrale l’occasione di una crescita intellettuale e sociale, di una sua
consapevolezza maggiormente critica. Solo attraverso la razionalità lo spettatore può comprendere la condizione umana
come trasformabile e da trasformare, ma da trasformare solo e soltanto attraverso la lotta politica.
La sostanziale contemporaneità delle date (fra Mejerchol’d da un lato e la direttrice Piscator-Brecht dall’altro lato) dimostra
che non c’è stata un’influenza di Mejerchol’d sulla scena tedesca: è piuttosto il determinarsi di condizioni politiche
analoghe (lo scontro aspro contro un sistema di potere borghese) che spinge a soluzioni culturali analoghe. Brecht è
consapevole che il teatro epico può sorgere solo nel quadro di una precisa battaglia politica.
Brecht approfondisce e articola la riflessione sulla nuova tecnica dello straniamento lungo l’intero periodo della propria
vita: dagli anni dell’esilio, durante il Nazismo, al dopoguerra, quando torna a Berlino Est, a capo di un suo teatro, il
Berliner Ensemble, in cui svolge una importante azione di regista. Brecht sistematizza la ricca strumentazione che vale a
straniare la rappresentazione per riflettere criticamente su di essa: titoli e cartelli proiettati, con funzione di anticipazione
delle scene; canzoni che spezzano il recitativo e commentano i personaggi e le loro vicende; fotografie, proiezioni di vario
genere; visibilità delle fonti luminose e musicali ecc. Tutto ciò che serve a ricordare allo spettatore che si trova a teatro, a
impedirgli l’illusione scenica, la magia dell’immedesimazione, e dunque a costringerlo a guardare con l’occhio critico.
Ma perché tanta insistenza sullo straniamento come fondamento di uno sguardo freddo e razionale? E cosa c’entra tutto
questo con la rivoluzione profetata da Marx? Marx fa un’analisi scientifica del capitalismo; fonda la sua critica su una base
razionale. Dunque bisogna fare appello non tanto ai buoni sentimenti dei rivoluzionari, ma alla loro capacità razionale.
Ci sono momenti diversi nella drammaturgia brechtiana. La produzione giovanile è ancora genericamente espressionista
(“Tamburi nella notte”, 1919). Grande importanza hanno i cosiddetti “drammi didattici” (“La linea di condotta”, 1930;
“L’eccezione e la regola, 1930), composti e pensati esplicitamente per il pubblico operaio berlinese. Infine la stagione
dell’esilio che annovera forse i suoi capolavori (“Madre Courage e i suoi figli”, 1939; “Vita di Galileo”, 1938-1939;
“L’anima buona del Sezuan”, 1938-1940).
Il teatro brechtiano ha una grande diffusione nella stagione della Guerra Fredda fra mondo occidentale e mondo
comunista, con un picco massimo negli anni intorno al ’68. Poi, con il crollo del Muro di Berlino (1989) e la fine dei regimi
comunisti nell’Europa dell’Est, viene meno l’accanita opposizione alla civiltà occidentale, fondata sull’economia di
mercato. In questo clima mutato la drammaturgia di Brecht sembra risultare meno stimolante e tende a cadere nel
dimenticatoio.
Permane però la lezione dello straniamento, da integrare sapientemente con la tecnica di immedesimazione del maestro
Stanislavskij: per poter stare contemporaneamente “dentro” e “fuori” il personaggio.
A partire dai primi anni Cinquanta, si evidenzia, in antitesi al diffuso brechtismo, un movimento d’avanguardia, il Teatro
dell’Assurdo, che si richiama in qualche modo alle Avanguardie Storiche del primo Novecento. Eugène Ionesco
(1912/1994) e Samuel Beckett (1906/1989) sono i nomi più famosi di questo Teatro dell’Assurdo, che esprime il disagio di
una civiltà occidentale che ha vissuto il trauma di eventi storicamente prima inimmaginabili. Si tratta di artisti che, evitando
l’impegno politico della linea Piscator-Brecht, si soffermano piuttosto sui grandi temi esistenziali: la falsità dei rapporti
sociali, la solitudine, l’incomunicabilità, la mancanza di valori, l’insensatezza del vivere, il mistero della morte, la ferita
irrimediabile che la morte rappresenta per tutti, e che tutti tendono a rimuovere. La novità dei contenuti si accompagna
sempre a una ironica rimessa in discussione del linguaggio e alla destrutturazione della forma teatrale.
Nel 1953 si ha la rivelazione di Beckett, con la messinscena di “Aspettando Godot” (1948-1949), ambientato in una strada
di campagna, dove due vagabondi in bombetta, Estragone e Vladimiro, aspettano un misterioso Godot. Ma Godot non
arriva e nei due atti del testo non succede praticamente niente. Ciò che emerge in primo piano non è tanto l’oggetto
dell’attesa, quanto la condizione dell’attendere, l’inutilità e l’assurdo dell’esistenza umana, percepita come attesa senza
scopo, lungo preludio alla morte (“Partoriscono a cavallo di una tomba, il giorno splende in un istante, poi è di nuovo la notte”).
Il significato di “Aspettando Godot” non riposa solo sull’attesa di Estragone e Vladimiro, ma sull’incrocio dei 4
personaggi: 2 che aspettano la fine della vita, 2 che subiscono le metamorfosi della vita. La lezione profonda del testo è
nella somma delle 2 coppie, è in una vita che è attesa della fine, ma attesa intessuta di menomazioni progressive.
Con il Teatro dell’Assurdo l’atto unico o comunque la misura breve del testo si ripropone come scelta determinata,
consapevole, alternativa al teatro tradizionale.
Descargado por Cecilia Bellentani ([Link]@[Link])
lOMoARcPSD|4655872
Non c’è dubbio che il teatro di Beckett costituisca una metafora lucida e implacabile dell’esistenza umana. Attesa,
mutilazione, silenzio: questi i 3 vertici del triangolo perverso del teatro beckettiano.
Può sembrare strano che nel giro di un trentennio si intersechino e si sovrappongano due visioni così diverse del teatro e
del mondo: da un lato un poderoso sforzo di utilizzare il teatro come arma per abbattere la società capitalistica, e dall’altro
lato la dolorosa riflessione sull’assurdo della condizione umana.
16. Secondo Novecento italiano: l’avvento (tardivo) della regia e tardi epigoni del Grande Attore
C’è un ritardo storico della scena italiana rispetto all’Europa. Si è detto che la regia comincia a diffondersi alla fine
dell’Ottocento. In Italia si può cominciare a parlare di regia solo a partire dal 1932, quando Silvio D’Amico introduce un
neologismo: “regista”. Il motivo del ritardo è complesso. L’Italia è il paese del Grande Attore, è il paese che ha visto
nascere la Commedia dell’Arte, che ha alle sue spalle una tradizione plurisecolare di protagonismo attorico. È ovvio che in
Italia la resistenza degli attori all’avvento del regista sia più tenace, e sostanzialmente vincente. Oltretutto la caratteristica
dell’attore italiano è di tramandarsi di padre in figlio, secondo linee di prosecuzione familiare. Non c’è una scuola di teatro.
Non c’è nessuna attitudine a “stare sotto padrone”, ad accettare la disciplina. Inoltre, la regia è l’altra faccia della grande
drammaturgia di fine Ottocento. In Italia, in quegli stessi anni, la drammaturgia è gracile, con autori scarsamente
autorevoli, che non riescono a influenzare gli attori con cui lavorano.
Il vero innovatore della scena italiana è Silvio D’Amico, giornalista teatrale, ma anche funzionario del Ministero della
Pubblica Istruzione. Cattolico ma politicamente nazionalista, non ostile al regime fascista, dal fascismo ottiene l’aiuto
decisivo per fondare nel 1935 l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica. D’Amico ha capito che l’Italia poteva mettersi
al passo con l’Europa solo rinunciando al teatro del Grande Attore e promuovendo il teatro di regia, ma ha anche capito
che il regista, per nascere e affermarsi, ha bisogno di ritrovarsi fra le mani un attore disciplinato, educato, che soltanto la
scuola può forgiare.
D’Amico è un fautore moderato della regia, che concepisce come attività al servizio dell’autore. Diffida dunque di quelle
che gli appaiono delle licenze registiche troppo disinvolte. Tra i primi fondatori della regia italiana troviamo Luchino
Visconti (1906/1976), grande regista teatrale e fondatore della nuova scena italiana. Visconti si qualifica subito per una
nuova disciplina del lavoro attorico. È il primo a eliminare il suggeritore, a imporre lunghe prove a tavolino e una durata
complessiva delle prove che per l’epoca risulta scandalosa.
La caratteristica dell’opera d’arte è contenere in sé una pluralità di significati, e il lavoro della critica consiste nel mettere a
fuoco dimensioni prima occultate. Il “realismo” di Goldoni è la grande conquista degli studi goldoniani a partire dagli anni
Sessanta, che hanno il loro ispiratore proprio in Visconti, geniale realizzatore della “Locandiera”. La vicenda privata di
Mirandolina e dei 3 lestofanti aristocratici si inserisce in un rapporto dialettico con il sociale, la comunità, la storia.
C’è un filo rosso che guida la fondazione del teatro di regia in Italia nel secondo dopoguerra, ed è la parola d’ordine del
realismo, dell’attenzione allo spessore sociologico dei testi che vengono messi in scena. Giorgio Strehler (1921/1997),
fondatore nel 1947 del Piccolo Teatro di Milano, con “Arlecchino servitor di due padroni” esalta il gusto della corporeità,
del funambolismo attorico della tradizione della Commedia dell’Arte perché ha bisogno di valorizzare le radici del teatro
italiano; ma con “Trilogia della villeggiatura” (1954) si allinea rapidamente alla linea di lettura storicistica, producendo una
sapiente ricostruzione di un ceto borghese al tramonto, percepito come alle soglie di un grande trauma storico.
Strehler è artista complesso, individualità inquieta. La scelta del realismo e dell’engagement politico nelle file del Partito
Socialista si accompagnano a una vena lirico-sentimentale, a capacità di grande illustratore di atmosfere e paesaggi.
Mario Missiroli (1934), regista non lineare, ma autore di spettacoli memorabili, negli anni in cui ha diretto il Teatro Stabile
di Torino, firma anche lui una “Trilogia”, nel 1981. Innova radicalmente a livello di scenografia per fissare un primo segno
personale. Nessuna ambientazione realistica. Nella scena compare una cancellata sullo sfondo. Al di là della cancellata sono
Giacinta e Guglielmo. Missiroli sopprime il monologo di Giacinta e impone un altro segno stilistico molto netto:
Guglielmo afferra Giacinta per un braccio, la fa roteare e la spinge contro l’inferriata, con la faccia verso gli spettatori.
Giacinta parla in quella posizione innaturale, con l’uomo addosso a lei.
È una fotografia cruda, che suggerisce l’idea di un rapporto carnale, brutale, bestiale. Quando per due volte dice “Vi amo”,
l’attrice di Missiroli grida le battute, come fossero gli istanti culminanti di un orgasmo.
Ancora diverso il modo di lavorare di Massimo Castri (1943), che firma a sua volta nel 1995-1996 una “Trilogia”, in 3
distinte serate. Anche Castri lavora sulla scenografia, ma con minor senso di astrazione rispetto a Missiroli. Le coordinate
dell’habitat ci sono tutte, anche se dilatate e sottolineate in termini un po’ espressionistici. Castri sistema in mezzo al cortile
delle grandi lenzuola bianche ad asciugare e dietro quelle lenzuola vanno ad amoreggiare due personaggi minori non
previsti in scena da Goldoni. A Castri servono per dare subito l’idea che la grande sequenza fra Giacinta e Guglielmo è
origliata.
Castri applica a Goldoni le chiavi interpretative che utilizza per mettere in scena Ibsen e Pirandello, dove la dimensione
dell’origliamento è fondamentale.
Castri è regista assai rappresentativo della generazione del ’68, che ha scoperto Marx ma anche Freud. La dimensione
sociologica è un primum per il lavoro artistico di Castri, che opera poi degli scandagli sulla psicologia dei personaggi, sullo
Descargado por Cecilia Bellentani ([Link]@[Link])
lOMoARcPSD|4655872
strato profondo, nascosto nel testo. Luca Ronconi (1933) sembra meno coinvolto dai condizionamenti della Storia; si
aggira circondato dall’aura del genio teatrale cui tutto è concesso e percorre i camminamenti solitari di uno
sperimentalismo ininterrotto e inesausto, relativo alla dimensione spaziale-comunicativa. Rispetta anche lui la lettera del
testo, ma lo scandaglio del testo è per Ronconi prima di tutto stimolo per una mise en espace, per una sua collocazione in
uno spazio, possibilmente inedito, imprevisto e indimenticabile. Ma, al di là di questa pulsione primigenia e irreprimibile, lo
scavo nel testo è sempre suggestivo, stimolante.
Se il regista è colui che interpreta il testo, che ne mette in luce aspetti nuovi, non c’è dubbio che Ronconi (insieme a Castri)
è fra gli esiti più alti della regia, non solo italiana ma mondiale. Il teatro di regia rappresenta la grande novità della scena
italiana del secondo Novecento, che si accompagna alla fondazione dei “teatri pubblici” (detti anche “teatri stabili”).
La novità della regia non esaurisce il panorama della scena italiana. Permangono alcune espressioni della tradizione illustre
del grande attore di ottocentesca memoria. A cominciare da Vittorio Gassman.
Alla tradizione appartiene egualmente il napoletano Eduardo De Filippo. Anche Eduardo gioca sui due tavoli
dell’interpretazione e della scrittura, ma inizialmente è più attore che autore, ed è comunque attore che lavora in
palcoscenico, che improvvisa, che si costruisce i testi come canovacci da consumarsi in famiglia. Eduardo ci spalanca sotto
gli occhi la visione materiale dei suoi popolani e dei suoi piccolo-borghesi partenopei, collocati nel riquadro di sgraziate e
impoetiche camere da letto o, peggio, nella miseria dolorosa di un basso, la caratteristica abitazione napoletana.
Attore/autore è anche Dario Fo (1926/2016), che scrive negli anni Sessanta commedie di mordente satira politico-sociale
che l’italica borghesia accoglie e digerisce senza problemi. Il ’68 determina tante conversioni, e dunque anche quella di Fo,
che diventa il cantore ispirato di una lunga e intransigente battaglia politica, a sinistra del Partito Comunista e del sindacato.
Se Eduardo lavora con la maschera facciale, Dario Fo lavora teatralmente con tutto il corpo, ed è un mimo straordinario.
L’ultimo nome da fare è quello di Carmelo Bene (1937/2002), il massimo rappresentante della Neoavanguardia italiana
degli anni Sessanta e Settanta (indicata anche con i termini sinonimi di “teatro di ricerca” o “teatro di sperimentazione”). Il
nuovo teatro di quegli anni punta tutto sul linguaggio non verbale, polemizza con la centralità della parola e del tessuto
drammaturgico, e valorizza la dimensione del corpo e del gesto. Al contrario, Carmelo Bene porta avanti una
sperimentazione sulla voce, sulla phoné.
17. Sciamani e poeti della scena
Abbiamo parlato spesso di industria dello spettacolo, cioè di un processo di mercificazione che pone al centro di tutto il
teatro-prodotto, indirizzato a un pubblico-consumatore che guarda al teatro da un punto di vista essenzialmente
disimpegnato. In opposizione a tutto ciò non può non determinarsi una reazione che tenta di recuperare un rapporto reale,
di partecipazione e quasi di fusione, fra attori e pubblico, riproponendo in qualche modo la funzione rituale dello
spettacolo. Ciò che conta è l’incontro fra attori e spettatori.
La prima e più dura espressione di questo rinnovato contegno culturale avviene negli Stati Uniti. Nel 1959 abbiamo la
presentazione a New York del primo “happening”. Il termine significa “avvenimento” e indica un tipo di spettacolo che
rifiuta tanto l’idea di palcoscenico quanto l’idea che tutti gli spettatori vedano la stessa cosa. È importante in questa nuova
forma la rinuncia quasi totale all’elemento dialogico, a favore del visuale, del sonoro, o al massimo del materiale pre-
verbale, nonché il tentativo di coinvolgere il pubblico, sia pure parzialmente.
Occorre cogliere lo stretto legame che intercorre fra la dimensione dell’incontro e la dimensione dello spazio. Lo spazio
teatrale tende ad essere uno spazio di relazione, per l’attore ma anche per lo spettatore. Lo spazio diventa una componente
dello spettacolo, una sua articolazione. Nasce di qui una ricca e instancabile ricerca di spazi teatrali.
Nello stesso 1959 che vede il primo affermarsi dello happening, abbiamo, sempre a New York, il primo importante
successo del Living Theatre, fondato nel 1947 a New York da Judith Malina (1926), attrice, regista, allieva di Piscator, e da
Julian Beck (1925/1985), attore e scenografo.
L’ideologia anarco-pacifista del Living si esalta e si incrocia con l’onda lunga del ’68. Due mesi dopo il Maggio francese, nel
luglio, si tiene il Festival d’Avignone, dove debutta “Paradise now”, il grande evento scandalo del Living. Il dato più
clamoroso è la rottura concreta della barriera che oppone palcoscenico e platea, è la trasformazione dello spettacolo in un
happening in cui gli spettatori recitano, intervengono, agiscono.
Il risultato teatrale è meno importante del fatto che un gruppo di persone con uguali valori e convincimenti si sia riunito in
una grande famiglia per fare teatro. Ciò che conta è soprattutto l’esperienza esistenziale.
Peter Brook (1925) è un altro dei grandi sciamani della scena contemporanea. Della stessa generazione di Beck e Malina,
presenta però un percorso professionale assai diverso. Regista inglese, lavora inizialmente e con successo sia nel teatro
commerciale, sia nelle severe istituzioni culturali della Gran Bretagna. Una vera svolta per Brook si determina nel 1970,
quando si trasferisce a Parigi, e dà vita al Centro Internazionale di Ricerca Teatrale. Inizia il suo percorso di
Descargado por Cecilia Bellentani ([Link]@[Link])
lOMoARcPSD|4655872
allontanamento dalle istituzioni teatrali. Si lega di amicizia con Grotowski. Anche per lui diventano fondamentali il lavoro
sulle radici del fenomeno teatrale, lo scavo sull’arte dell’attore. Decisiva è la scelta di operare con una troupe di attori di
varia nazionalità, di differenti razze, che parlano lingue diverse, e che rompono pertanto la compiaciuta convenzione della
dizione perfetta su cui si regge l’industria dello spettacolo. Per Brook resta capitale il rapporto con il pubblico.
Il più ascetico e il più solido interprete di questo rinnovamento scenico resta però il regista polacco Jerzy Grotowski
(1933/1999), fondatore nel 1959 del celebre Teatro Laboratorio. Grotowski parte da una riflessione sulla progressiva
perdita di identità del teatro rispetto al dispiegarsi del potere del cinema e della televisione. Il teatro deve ammettere i suoi
limiti, evitando scenografie, effetti luminosi e sonori, costumi, trucco ecc.
Solo così (accettandosi come “teatro povero”) ritroverà la propria specificità rispetto al cinema e alla televisione.
Rinunciando a tutto, il teatro si scopre ricco di qualcosa che manca propriamente a cinema e televisione: la presenza viva,
in carne e ossa, dell’attore. Il teatro può esistere non solo senza apparato tecnologico, ma anche senza testo. La regia nasce
storicamente in parte al servizio del testo, ma per questa realtà teatrale ciò che conta non è il testo ma l’incontro.
Alle messinscene del Teatro Laboratorio gli spettatori, di regola, non sono mai più di una cinquantina. La prospettiva
antropologica dell’incontro mira alla concezione del teatro come esperienza di vita, che è lavoro su di sé, veicolo e
alimento di arricchimento spirituale, in grado di trasformare chi fa e chi osserva il teatro.
L’influenza di Grotowski nella scena contemporanea è tanto più sconvolgente perché tutto si gioca sull’arco breve di un
decennio scarso.
Il grande allievo di Grotowski è notoriamente l’italiano Eugenio Barba (1936) che, nel 1964, fonda a Oslo l’Odin Teatret,
riunendo attori rifiutati dalle tradizionali accademie d’arte drammatica. Dal 1966 sposta la sede del suo teatro nella cittadina
danese di Hostelbro, dove può contare su una sovvenzione stabile. L’Odin è l’unico vero teatro di outsiders, di autodidatti,
che riesca a imporsi, partendo da una condizione di marginalità e di inferiorità.
Il primo grande successo del gruppo, “Min Fars Hus” (“La casa del padre”), debutta nel 1972. Gli attori (questo il metodo
di Barba, sviluppato da Grotowski) creano delle improvvisazioni, durante il lunghissimo periodo di prove, a partire da
spunti che essi stessi ritrovano studiando.
All’indomani di “Min Fars Hus”, Barba attivò la pratica dei “baratti”, cioè degli interventi dell’Odin in territori marginali
che si posero come incontri di culture. In situazioni particolari, interventi di questo tipo si caricano di un rilevante
significato politico.
Il senso ultimo della creatività barbiana è tutto da cogliere all’interno di una carica vitale prorompente, passionale, a tratti
selvaggia, che ha essenzialmente una vocazione lirica, non drammaturgica. È un teatro prepotentemente musicale e
intensamente cromatico.
Su una linea diversa si situa infine il teatro del polacco Tadeusz Kantor (1915/1990), artista prima ancora che teatrante:
pittore, scenografo di professione per un certo periodo, legato alle Avanguardie Storiche, e dunque organizzatore inventivo
di happenings, di eventi sperimentali. Il successo europeo arriva nella misura in cui quel fervore di ricerca e di
rinnovamento formale si prosciuga sapientemente entro la cornice di un impianto comunicativo in qualche modo classico.
Siamo di nuovo nella dimensione dello spettacolo. Il dato che ha più sorpreso e impressionato è la sconcertante e ossessiva
presenza del regista sulla scena.
La presenza del regista sulla scena ha un valore simbolico fortissimo, evidenzia la presenza risolutrice del regista nel teatro
del Novecento, la sua presa di possesso del palcoscenico, il suo sottrarlo definitivamente agli attori.
Non possiamo concludere questo capitolo dedicato ai registi della sperimentazione senza ricordare l’americano Robert
Wilson (1941), che lavora essenzialmente sulle dimensioni del tempo e dello spazio ovvero di quelle forme definite spesso
di teatro immagine che, per una caratteristica prevalenza della visualità, tendono a smarcarsi dalle espressioni sperimentali
più vicine a una matrice antropologica. In molte sue realizzazioni il tempo viene rallentato. Grazie all’accompagnamento di
una musica armonica a lenta modulazione si ha un effetto ipnotico, che determina una sorta di dissociazione fra ciò che si
vede sulla scena e ciò che si pensa.
18. Teatro del Novecento e teatro eurasiano
I principali artefici della prima riforma del teatro (nel trentennio d’esordio del Novecento) come della seconda (negli anni
Sessanta-Ottanta) hanno guardato a Oriente con ammirazione e fascino.
I teatri d’Asia hanno nutrito le principali esperienze dell’avanguardia novecentesca, per esempio, fondendosi con il mito
della tragedia greca al fine di realizzare un’arte contraria alla restituzione della realtà.
I teatri d’Asia sono caratterizzati da una stretta fusione di danza, teatro e musica. Essi inoltre conservano un evidente
sostrato religioso e una marcata codificazione e presentano una dinamica storica di lente metamorfosi e contaminazioni.
Sommariamente e parzialmente, i principali (e sull’Occidente più influenti) teatri asiatici sono localizzabili nelle seguenti
aree geografiche.
India
Descargado por Cecilia Bellentani ([Link]@[Link])
lOMoARcPSD|4655872
Nel contesto di questo grande paese, si contano svariate forme di danza religiosa, spesso solistica, riportabile a
sacerdotesse del culto di Shiva.
Fra le danze più note sono da annoverare la “Bharata Natyam” e la “Orissi”. La prima è tipica dell’India meridionale e si
sviluppa secondo una tecnica per la quale i piedi tengono il ritmo, le mani raccontano la storia, il volto esprime le
impressioni e le reazioni alla storia raccontata dalle mani, mentre il testo viene intonato da un cantante, che, con gli
strumentisti, si colloca di fianco alla scena. La danza “Orissi” è caratteristica della zona di Orissa. Nell’”Orissi” ci si trova
di fronte a un’esuberanza di gesti e passi di virtuosistica quanto sensuale eleganza, la cui tecnica è basata sulla divisione del
corpo in due metà uguali, secondo una linea che lo attraversa verticalmente e sulla suddivisione ineguale del peso ora su
una parte ora sull’altra.
Il termine “Kathakali” significa “rappresentazione di storie” ed è una forma del teatro classico indiano, caratteristica della
zona di Kerala. Si tratta di un’espressione spettacolare fondata sul canto, la recitazione, il mimo e la danza, portata avanti
da esecutori maschi, con l’accompagnamento di due cantanti e strumenti, su un repertorio eroico e mitico che attinge ai
grandi poemi del “Mahabharata” e del “Ramayana”. La rappresentazione avviene all’aperto con un apparato scenico
minimo e si protrae talora sino a notte avanzata.
Bali
L’Isola di Bali presenta una straordinaria varietà di espressioni sceniche, che spaziano dagli spettacoli di marionette
proiettate contro uno schermo bianco traslucido, di argomento mitologico e storico e della durata di un’intera notte, alle
danze, le quali presentano influssi indù e un radicato sottofondo religioso e sciamanico. Queste danze sono state suddivise
da un comitato locale nel 1971 in tre categorie: a) sacre, da danzarsi nel cortile del tempio; b) cerimoniali, da danzarsi nel
cortile intermedio del tempio; c)d’intrattenimento, da danzarsi anche fuori dal tempio.
Cina
Quella che in Occidente definiamo come “Opera cinese” s’individua segnatamente attorno al XII secolo, e, basandosi sulla
recitazione e il canto, va assai al di là del nostro concetto di melodramma sia per l’importanza della parte mimico-
acrobatica sia per la specificazione dei personaggi in ruoli, costumi e trucchi prefissati.
L’importante Opera di Pechino è comunque l’erede di differenti tradizioni regionali dalla fine del XVIII secolo e prevede
una recitazione largamente mimica con canto e improvvisazione, accompagnata da una piccola orchestra. La recitazione,
che si concentra su un assemblaggio di scene tradizionali, è caratteristica per l’amplificazione e la contrazione stilizzate dei
gesti, oltre che per il virtuosismo acrobatico.
Il celebre attore e innovatore dell’Opera di Pechino, Mei Lan Fang (1894/1961), fu in tournée in Russia nel 1935 e
influenzò larga parte del teatro di quella nazione e di quel continente.
Giappone
In Giappone troviamo il “Noh”, nobile forma drammatica di ascendenza sciamanica che si struttura nel XIV secolo. I suoi
attori (maschi) sono mascherati, accompagnati da un coro di una decina di elementi, e parlano, danzano e cantano con
caratteristica monotonia, accompagnati da musica di flauto e percussioni. A differenza del teatro occidentale, dove
“qualcosa accade”, nel teatro giapponese resta centrale l’arrivo di qualcuno.
Il “Kabuki” è invece una forma di spettacolo che concerne eventi sia drammatici sia storici e amorosi. Si manifesta nel
XVII secolo, conquistò un largo pubblico cittadino, borghese e più popolare di quello del Noh. La rappresentazione, che
può essere articolata in 5 atti, contempla interventi di danza e mimo e si tiene su una scena.
L’attore occidentale non ha un rigido sistema di riferimento a cui rifarsi, mentre gli attori del kathakali, del Noh giapponese
e dell’Opera di Pechino debbono attenersi a dei codici espressivi ben precisi e tramandati, trasformandosi in tutori di una
tradizione e di una specializzazione.
Dai teatri asiatici ricaviamo uno stimolo essenziale: la fine della distinzione dell’attore dal danzatore.
Se il teatro asiatico ci può apparire distante, la contrapposizione netta con quello occidentale ha poco senso. Gli studi
hanno dimostrato l’opportunità di una prospettiva di analisi eurasiana, nella quale inquadrare la relazione costante e ricca
fra il teatro dell’Occidente e quello dell’Oriente sin dalla tragedia greca.
19. Il secolo lungo della danza
Si è visto come nel settore più innovativo del teatro del secondo Novecento, tutti esprimano in qualche modo una stessa
direzione di percorso verso l’immagine. Il Novecento è, sì, il secolo della regia, ma è anche il secolo dell’attore, delle scuole
teatrali, degli esercizi per gli attori. Fino all’Ottocento l’attore fa degli esercizi in funzione di uno spettacolo. Nel
Novecento il training diventa una dimensione costitutiva e permanente del lavoro attorico.
In questa valorizzazione novecentesca del corpo il teatro è stato stimolato dalla danza. A partire dall’americana Isadora
Duncan (1877/1927), fortunata fondatrice in Europa della “danza libera”, libera dalle convenzioni del balletto accademico.
Americana è anche Martha Graham (1894/1991), profetessa della “modern dance”, che codifica una tecnica e uno stile che
rivoluzionano i sistemi tradizionali di danza e balletto. La Graham rifiuta gli estetismi astratti del balletto accademico e
propone un movimento carico di senso e drammaticità.
Descargado por Cecilia Bellentani ([Link]@[Link])
lOMoARcPSD|4655872
In America, nel corso del Novecento, nascono e si sviluppano una serie di fenomeni che oggi riferiamo alla danza
moderna. Quest’ultima è un’espressione generica, usata spesso per indicare tutte le tecniche diverse dal classico, ma che in
particolare designa un insieme di generi sentiti fra loro affini e separati da confini labili, come ad esempio la danza jazz,
l’hip-hop, la break dance ecc.
La definizione di “danza moderna” viene riferita anche a tutto il movimento della danza d’espressione tedesca, che precede
la Seconda Guerra Mondiale.
Quando, invece, si parla di “balletto moderno” ci si riferisce a un utilizzo libero della tecnica accademica, più o meno
manipolata dal punto di vista estetico ed esecutivo, più o meno contaminata con altri linguaggi e tecniche strutturati, in
contesti spettacolari e teatrali attuali.
Il segno più forte e convincente del secondo dopoguerra è senza dubbio il teatrodanza. Il termine è la traduzione del
tedesco “Tanztheater”, forma storica di spettacolo fatta conoscere in Italia dalla coreografa e danzatrice Pina Bausch
(1940/2009). Il Tanztheater è un fenomeno storico preciso, circoscrivibile a un’area geografica e culturale determinata.
Bisogna risalire alla Germania dei primi decenni del Novecento. Il teatrodanza tedesco degli anni Settanta muove proprio
da questo retroterra, vivendo in osmosi col clima culturale di generale ridefinizione dei linguaggi artistici.
Ciò che fa dunque del Tanztheater qualcosa di dirompente sulla scena degli anni Ottanta è la riscoperta del linguaggio del
corpo, ma anche la ripresa dell’antico mito dell’arte totale, la riaffermazione del teatro come luogo dello
spettacolo/accadimento, all’interno del quale non esistono più confini di genere.
Mentre in Europa il teatro danza rivela nuove prospettive della scena, negli Stati Uniti l’innovazione è rappresentata dalla
corrente fortemente rivoluzionaria della post-modern dance, fenomeno dirompente di ripensamento globale del medium
danza, della figura del coreografo e del danzatore, nonché momento di rifondazione di un’estetica della contemporaneità.
Le performances dei danzatori post-modern spingono all’esplorazione di luoghi alternativi al teatro: in questi anni, la danza
esce all’aperto, occupa le strade delle città, usa alberi e grattacieli come base d’appoggio e invade le gallerie d’arte. La danza
diviene il luogo privilegiato della liberazione del corpo dall’alienazione che esso subisce in una società regolata dalla
competizione economica. Fra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta l’attenzione di questi coreografi e
danzatori si concentra sui temi politici.
Nel corso degli anni Novanta è stata introdotta la nozione di “danza d’autore”, per rendere ragione di una nuova tendenza
coreografica contemporanea presente in molti paesi europei. Questa espressione descrive infatti un nuovo territorio della
danza in cui autori molto diversi fra loro nella cifra stilistica rigettano parimenti il codice classico e quello moderno,
proponendo una originale costruzione di segni che è il portato di una nuova estetica della danza, spesso sintesi e
rielaborazione di molte delle tendenze che l’hanno preceduta.
All’interno delle nuove danze europee degli anni Ottanta e Novanta un posto particolare ha assunto il teatro danza
“povero”, in cui l’attore/danzatore non si fa mediatore di un contenuto estraneo, ma recupera all’interno di se stesso
dimensioni che gli sono proprie e si impongono nel contempo come universali. Si giunge a queste realizzazioni
coreografiche attraverso il metodo dell’improvvisazione e un duro e costante lavoro da parte di ciascun danzatore. Il
risultato è una forma di espressione pre-verbale, un nuovo teatro in cui anche la parola è vissuta per il suo valore gestuale,
non puramente sonoro.
Oggi la danza si trova nella necessità di confrontarsi con l’entusiasmo, da parte di un certo mondo giovanile, delle sue
forme più facili ed edonistiche.
La storia dello spettacolo del Novecento, su un percorso che ora muove dal teatro verso la danza, ora dalla danza al teatro,
mostra il tentativo di ricucire l’antica ferita che in nome di un’attribuzione assoluta di valore al logos aveva separato un’arte
del corpo, la danza, da un teatro inteso unicamente come arte della messa in scena di un testo drammatico.
Descargado por Cecilia Bellentani ([Link]@[Link])
Potrebbero piacerti anche
- Riassunto Storia Del Teatro e Dello SpettacoloNessuna valutazione finoraRiassunto Storia Del Teatro e Dello Spettacolo4 pagine
- 01 Teatro Greco Romano PL Terenzio Seneca Teatro MedievaleNessuna valutazione finora01 Teatro Greco Romano PL Terenzio Seneca Teatro Medievale12 pagine
- Linguistica Generale, Fonologia e Morfologia100% (3)Linguistica Generale, Fonologia e Morfologia11 pagine
- Letteratura Latina 20 - 21 Modulo ANessuna valutazione finoraLetteratura Latina 20 - 21 Modulo A148 pagine
- 1-Canfora - SLGA. La Biblioteca e Il Museo100% (2)1-Canfora - SLGA. La Biblioteca e Il Museo14 pagine
- Letteratura Latina - Petronio, Lucano, Persio, GiovenaleNessuna valutazione finoraLetteratura Latina - Petronio, Lucano, Persio, Giovenale7 pagine
- Teorie Della Ricezione Il Caso Di CalvinNessuna valutazione finoraTeorie Della Ricezione Il Caso Di Calvin43 pagine
- Il Dramma Come Il Genere e La Forma Letteraria100% (1)Il Dramma Come Il Genere e La Forma Letteraria9 pagine
- Appunti Di Lingua e Letteratura GrecaNessuna valutazione finoraAppunti Di Lingua e Letteratura Greca7 pagine
- Riassunto Del Libro ''Cose Che Parlano Di Noi''Nessuna valutazione finoraRiassunto Del Libro ''Cose Che Parlano Di Noi''14 pagine
- 07 La Riforma Di Gluck e CalzabigiNessuna valutazione finora07 La Riforma Di Gluck e Calzabigi10 pagine
- Estratto Di Conte Letteratura LatinaNessuna valutazione finoraEstratto Di Conte Letteratura Latina11 pagine
- Breve Manuale Di Geografia Umana, Minca C., Colombino A.Nessuna valutazione finoraBreve Manuale Di Geografia Umana, Minca C., Colombino A.47 pagine
- Guida All'Uso Delle Parole - Semiotica - Tullio de MauroNessuna valutazione finoraGuida All'Uso Delle Parole - Semiotica - Tullio de Mauro9 pagine
- Louis Hjelmslev: I Tratti Fondamentali Dei Linguaggi0% (1)Louis Hjelmslev: I Tratti Fondamentali Dei Linguaggi5 pagine
- Riassunto de L'Immaginazione Sociologica (C.W. Mills)Nessuna valutazione finoraRiassunto de L'Immaginazione Sociologica (C.W. Mills)12 pagine
- Presentazione Gli Egizi Con RiassuntiNessuna valutazione finoraPresentazione Gli Egizi Con Riassunti51 pagine
- Letteratura Latina in Sintesi L'era ArcaicaNessuna valutazione finoraLetteratura Latina in Sintesi L'era Arcaica8 pagine
- Nuovo Manuale Di Storia Del Teatro Alonge100% (1)Nuovo Manuale Di Storia Del Teatro Alonge74 pagine
- Screenshot 2024-12-21 (12.04.46)Nessuna valutazione finoraScreenshot 2024-12-21 (12.04.46)247 pagine
- Trascrivere La Vita Intera - Bozza 2Nessuna valutazione finoraTrascrivere La Vita Intera - Bozza 2512 pagine
- Il Flauto Magico (Transcribed On 16 Feb 2025 22-01-47)Nessuna valutazione finoraIl Flauto Magico (Transcribed On 16 Feb 2025 22-01-47)22 pagine
- STORIA DEL CINEMA Commedia All'italianaNessuna valutazione finoraSTORIA DEL CINEMA Commedia All'italiana13 pagine
- Gioachino Chiarini. Plauto, La Farsa, La FestaNessuna valutazione finoraGioachino Chiarini. Plauto, La Farsa, La Festa4 pagine
- TV Sorrisi e Canzoni N4 - 16 Gennaio 2024s - 240119 - 030335100% (1)TV Sorrisi e Canzoni N4 - 16 Gennaio 2024s - 240119 - 030335125 pagine
- Bizet Carmen Acte1-4 Choeur Des CigarieresNessuna valutazione finoraBizet Carmen Acte1-4 Choeur Des Cigarieres11 pagine
- 20240304140844-5722-Ulti Yayinlari 10 Sinif Deneme Sinavi 3 Cevap AnahtariNessuna valutazione finora20240304140844-5722-Ulti Yayinlari 10 Sinif Deneme Sinavi 3 Cevap Anahtari1 pagina
- La Guitarra de Lolo - Banda MisteriosaNessuna valutazione finoraLa Guitarra de Lolo - Banda Misteriosa15 pagine
- DONT CRY FOR ME ARGENTINA FULL SCORE TimpaniNessuna valutazione finoraDONT CRY FOR ME ARGENTINA FULL SCORE Timpani2 pagine
- 10) Dahlhaus Drammaturgia MusicaleNessuna valutazione finora10) Dahlhaus Drammaturgia Musicale5 pagine
- Glossario Di Termini Tecnici e Gergali Del TeatroNessuna valutazione finoraGlossario Di Termini Tecnici e Gergali Del Teatro10 pagine