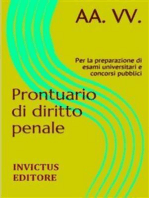Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
1.1-Teoria Del Reato
Caricato da
tortoramariateresa3Titolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
1.1-Teoria Del Reato
Caricato da
tortoramariateresa3Copyright:
Formati disponibili
PARTE TERZA
IL REATO
SEZIONE PRIMA
INTRODUZIONE ALLA DOTTRINA DEL REATO
TEORIA BIPARTITA
La c.d. teoria generale del reato è quella parte della scienza del diritto penale che mira ad individuare e ad
ordinare in forma sistematica gli elementi che configurano, in via generale, la fisionomia del fatto penalmente
rilevante.
Oggetto della teoria del reato è, in altre parole, il concetto giuridico del reato, inteso come fattispecie
astratta e generale di esso: vale a dire quale insieme dei requisiti necessari e sufficienti per il prodursi della
conseguenza giuridica della pena.
L’analisi del reato è stata storicamente condotta secondo metodologie differenti, a cui corrisponde una
differente prospettazione del concetto dommatico del reato.
Un primo schema di analisi della struttura del reato muove dalla differente essenza naturalistica degli
elementi in cui è possibile scomporre un comportamento umano, e cioè l’elemento della fisicità (l’accadere
visibile nel mondo esterno) e l’elemento psicologico che sostiene la condotta dell’uomo, vale a dire il suo
atteggiamento interiore.
In tale prospettiva il reato si compone: 1) di un elemento oggettivo, comprendente condotta, evento (inteso
in senso naturalistico come modificazione del mondo esterno) e nesso di causalità fra condotta ed evento; 2)
elemento soggettivo, comprendente colpevolezza, colpa e dolo.
Questo schema di scomposizione del reato si può dire senz’altro caratteristico della tradizione penalistica
italiana, in particolare della Scuola classica. Francesco Carrara distingueva, appunto, nel reato un elento
oggettivo o forza fisica, quale manifestazione nel mondo esterno di una condotta lesiva di beni giuridici, e un
elemento soggettivo o forza morale, dato dal dolo o dalla colpa.
Quest’embrione di analisi di struttura del reato assolve una funzione critica del sistema penale, poiché
impone che siano considerati illeciti solo le azioni esterne dell’uomo lesive di beni giuridici commesse con dolo
o colpa.
È possibili muovere tre obiezioni alla teoria bipartita: 1) innanzitutto, adotta un metodo naturalistico, per
cui si limita a scomporre e classificare la realtà esistente a prescindere da qualsiasi tipo di valutazione sul
fondamento e sulla legittimazione del potere punitivo statuale; 2) in secondo luogo, si fonda su un’ideologia
retributiva della pena per cui il reato è un fatto che lo Stato comanda o vieta di realizzare, purchè presenti gli
elementi oggettivi o soggettivi a prescindere dalla lesione di un bene giuridico dei consociati. Ne consegue che
l’antigiuridicità non è un elemento del reato, ma è l’in sé del reato (cioè coincide con la sussistenza
dell’elementi oggettivi e soggettivi); 3) infine, non fornisce un’adeguata definizione del reato omissivo, giacchè
in questo caso non vi è alcuna modificazione nel mondo esterno, ragion per cui i sostenitori della teoria
bipartita hanno affermato che omettere significa trattenere le proprie energie o fare qualcos’altro.
TEORIA TRIPARTITA CLASSICA
La dommatica tradizionale (Beling), di ispirazione positivistico-naturalistica, nel suo sforzo di utilizzare
nella costruzione sistematica del diritto penale gli schemi delle scienze naturali, delimita il fatto tipico
all’insieme degli elementi esteriori dei singoli reati, con l’esclusione di ogni coefficiente psichico. Ciò conduce
ad un concetto naturalistico di azione rigorosamente causale, concepita come movimento corporeo che
provoca un cambiamento del mondo esterno verificabile sul piano fisico. Il fulcro del tatbestand costruito
naturalisticamente è dato dal nesso di causalità fra condotta ed evento, che viene accertato applicando la
regola della condicio sine qua non (o teoria dell’equivalenza delle condizioni) in virtù della quale una condotta
è “causa” dell’evento se eliminando mentalmente la condotta viene meno anche l’evento. Tale teoria non
concede spazi per una valutazione in termini normativi di fattori causali diversi, ritenendola non scientifica. In
tale prospettiva, tutte le cause sono equivalenti se costituiscono condizione necessaria e sufficiente per la
produzione dell'evento. Ciò comporta un eccessivo ampliamento della fattispecie: un’azione omicida viene
compiuta non solo da chi ha esploso il colpo letale ma anche da che ha fabbricato o venduto l’arma.
Nei casi in cui, per la presenza di un decorso causale atipico, l’applicazione della sanzione appariva
inadeguata, si fa ricorso alla mancanza del dolo, spostando il problema dall’ambito dell’imputazione oggettiva
a quella soggettiva. Ad esempio, pensiamo al caso di chi, all’approssimarsi di un temporale, induca taluno a
fare una passeggiata, nella speranza che venga colpito da un fulmine. Se l’evento si verifica, in base alla teoria
dell’equivalenza, la causalità non può essere negata, per cui si considera realizzata la fattispecie oggettiva e la
sanzione può non essere inflitta solo sulla base dell’esclusione del dolo.
Tuttavia, va osservato che da un punto di vista soggettivo, l’agente voleva ciò che poi si è realizzato ma,
nonostante ciò si ritiene che non debba essere punito, per cui l’esclusione dell’imputazione non deve essere
ricercata nella mancanza del dolo ma nell’oggettiva casualità dell’accadimento dal momento che una morte
casuale non può considerarsi omicidio in senso giuridico-penale.
La configurazione dell’illecito penale in termini naturalistici comporta, altresì, l’isolamento della categoria
(oggettivo-normativa) dell’antigiuridicità, nonché, la separazione e l’isolamento del concetto (subiettivo-
descrittivo) della colpevolezza.
L’accertamento dell’antigiuridicità, presuppone, da un lato, l’esistenza di un fatto che presenti tutti i
requisiti, oggettivi e psicologici, descritti nella fattispecie legale di un reato e dall’altro, l’inesistenza di
situazioni o circostanze a cui l’ordinamento giuridico attribuisca una efficacia giustificante. In presenza di
situazioni o circostanze del genere, il fatto tipico, pur restando tale, tuttavia non è antigiuridico, per effetto di
una norma permissiva che lo autorizza o lo impone; con la conseguente elisione dell’applicabilità, in concerto,
della norma di divieto.
Da Beling in poi, la moderna dottrina del reato esprimerà appunto l’idea dell’antigiuridicità, mediante il
riferimento alla mancanza di cause di giustificazione. Un fatto tipico può, infatti, risultare non antigiuridico, se
esiste una norma dell’ordinamento che l’autorizzi o addirittura lo imponga.
La “scoperta” dell’antigiuridicità e la sua configurazione come autonomo elemento costitutivo del reato
contengono una duplice significativa implicazione.
Da un lato, in linea con le esigenze di certezza del diritto, la distinzione tra “fatto” e “antigiuridicità”
sottolinea la necessità di separare l’oggetto della valutazione (il fatto conforme al tipo) dalla valutazione
dell’oggetto (nei termini della sua contrarietà al diritto). Ciò comporta, com’è evidente, una netta separazione
fra gli elementi descrittivi della fattispecie e i momenti valutativi di essa.
Dall’altro lato, il concetto dell’antigiuridicità implica la presa d’atto che l’esistenza di una lesione di beni
che contrasti con il diritto obiettivo non ha nulla a che vedere con l’esistenza dei presupposti per una
incolpazione, vale a dire per un giudizio di riprovevolezza nei confronti dell’autore.
Proprio in relazione alla categoria dell’antigiuridicità è possibile cogliere le differenze tra la teoria tripartita
e la teoria degli elementi negativi del fatto. Ed invero, la prima considera l’antigiuridicità come un autonomo
elemento costitutivo del reato, per cui dopo l’accertamento del fatto si deve procedere ad un ulteriore
accertamento, che concerne la sua antigiuridicità e a decidere di questa non sarà la singola norma
incriminatrice speciale, bensì il rapporto del fatto con l’intero ordinamento giuridico. La teoria degli elementi
negativi del fatto, invece, considera l’antigiuridicità come “l’in sé del reato”, ovvero come un elemento negativo
della tipicità, per cui la presenza di cause di giustificazione fa venir meno lo stesso fatto tipico.
L’ulteriore figura di qualificazione concerne la verifica dei presupposti di ordine soggettivo che permettono
di applicare una pena all’autore del fatto. Questo terzo ed ultimo elemento costitutivo del fatto punibile viene
tradizionalmente contrassegnato col nome di colpevolezza.
Il contenuto di quest’ultima categoria non appare, tuttavia, definito in modo uniforme nell’ambito della
stessa concezione tripartita.
Nell’originario schema “tripartito” del reato, il terzo elemento costitutivo dell’illecito penale, nasce dalla
separazione di principio tra lato “esterno” ed “interno” del reato, tra l’oggettivo e il soggettivo (“imputatio
facti” e “imputatio juris”).
Nel modello di Beling, la “tipicità” della condotta è data interamente dalla sua rispondenza al modello
legale di un reato, nei suoi connotati esteriormente riconoscibili; ed appare contrassegnata dalla sua efficienza
causale per la lesione del bene tutelato. Questo è sufficiente per decidere dell’esistenza del fatto tipico e
fornire, quindi, il primo indispensabile “appiglio” per il giudizio di antigiuridicità.
Il contenuto psichico dell’azione viene, invece, distaccato dalla sua base oggettiva ed inserito nel concetto
del reato a rappresentare la categoria della “colpevolezza”, che esprime appunto “il rapporto psicologico
dell’autore con il fatto quale azione tipica antigiuridica” e resta, quindi, estranea alla dimensione della tipicità.
Per la tipicità si richiede, bensì, l’esistenza di un’azione umana sorretta dalla volontà; ma ciò unicamente
per stabilire una differenza fra ciò che è azione e ciò che non lo è. Per determinare ciò che è azione, basta,
infatti, la certezza che l’autore volontariamente abbia agito o sia rimasto inattivo; che cosa egli abbia voluto è,
invece, indifferente; il contenuto della volontà, infatti, ha importanza solo per il problema della colpevolezza.
In questo schema di analisi del reato i predicati di valore del fatto penalmente rilevante concernono in
modo separato l’aspetto oggettivo e quello soggettivo della condotta: solo il primo – cioè l’azione umana
esteriormente riconoscibile – costituisce oggetto del giudizio di antigiuridicità; mentre le sue componenti
soggettive orientano il giudizio di colpevolezza, di cui l’imputabilità rappresenta un “presupposto”, il dolo e la
colpa le “forme” costitutive. Trattasi, dunque, di una concezione psicologica della colpevolezza.
TEORIA FINALISTICA DELL’AZIONE (WELZEL)
Alla concezione tradizionale (che esauriva la tipicità della condotta nella sua efficienza per la lesione del
bene) si contrappone la teoria finalistica di Welzel che identifica l’azione come un atto finalistico rivolto ad
uno scopo. L’uomo, infatti, sulla base della conoscenza delle leggi della causalità, è in grado di antivedere,
entro certi limiti, le conseguenze del proprio agire causale e perciò di dirigerlo in funzione del conseguimento
di uno scopo.
Questo modo di intendere l’azione scongiura il regressus ad infinitum della dottrina causale cell’azione,
nella misura in cui, a differenza di quella, considera il dolo come momento soggettivo della fattispecie.
Così, ad esempio, se qualcuno resta ferito da una revolverata, sulla base della causalità, potremmo dire
soltanto che un uomo ha riportato una lesione, a causa di un colpo di arma da fuoco. Ma per stabilire se si è
trattato di un ferimento o di un tentato omicidio, dovremo fare riferimento al contenuto della volontà
dell’agente.
Il nuovo concetto di azione costituì la premessa di una revisione della sistematica del reato, a partire dalla
nozione del fatto tipico, che si compone:
- di una fattispecie oggettiva, che comprende il disvalore d’evento, inteso come offesa al b.g. in termini
di lesione o messa in pericolo, e il disvalore d’azione oggettivo, che consiste nel dato per cui la condotta appaia
ex ante, cioè al momento in cui si agisce, e dal pdv di un osservatore medio posto nella stessa situazione
dell’agente, oggettivamente rivolta all’aggressione al b.g.;
- di una fattispecie soggettiva, che comprende il disvalore d’azione soggettivo, inteso come volontà
dell’agente rivolta all’aggressione al b.g.. Così, ad esempio, nel caso del conducente di un’automobile,
rispettoso delle regole di diligenza, che investe un bambino sbucato all’improvviso, è presente il disvalore
d’evento, costituito dalla morte o lesione del bambino, ma manca sia il disvalore oggettivo di azione, perché
chiunque, nella medesima situazione, si sarebbe comportato allo stesso modo, che il disvalore soggettivo di
azione, perché manca dolo/colpa.
L’anticipazione del dolo/colpa nell’ambito della categoria della tipicità consentì di chiarire da un lato i
rapporti fra imputabilità e dolo e dall’altro fra dolo e coscienza dell’antigiuridicità.
Per quanto concerne i rapporti fra imputabilità e dolo si è osservato che sia la concezione normativa
che la concezione psicologica della colpevolezza considerano l’imputabilità come presupposto del dolo/colpa.
Secondo la teoria finalistica dell’azione, invece, ogni azione, in quanto finalistica, contiene necessariamente
dolo/colpa, compresa l’azione di un soggetto non imputabile. Un bambino ad esempio si può rendere conto di
provocare un male, ma non che quella condotta che quella condotta costituisce reato. Ciò dimostra come
nell’ambito della tipicità vada valutato il dolo/colpa e nell’ambito della colpevolezza l’imputabilità.
Per quanto concerne, invece, i rapporti fra dolo e coscienza dell’antigiuridicità, va osservato che il
dolo si riferisce al fatto mentre la coscienza dell’illecito si riferisce all’antigiuridicità, cioè alla contrarietà della
condotta con l’intero ordinamento giuridico.
Si venne definitivamente chiarendo, così, anche la problematica dell’errore: alla dicotomia tradizionale fra
errore di fatto e errore di diritto si sostituì progressivamente la contrapposizione fra errore sul fatto, che
esclude l’esistenza del dolo, ed errore sul divieto, che esclude la rimproverabilità e quindi la colpevolezza
dell’autore, solo quando è inevitabile.
Al concetto finalistico dell’azione si oppose fin dall’inizio il carattere problematico dell’assimilazione delle
condotte dolose di azione, di quelle omissive e di quelle colpose sotto uno stesso concetto di genere,
la “finalità”.
Quanto all’omissione si è osservato che non può essere oggetto di dominio finalistico il non agire, perché
chi omette non dirige alcun processo causale verso uno scopo, ma si limita a non intervenire in un processo
causale che si svolge indipendentemente da lui. Analogamente, rispetto alle condotte colpose si è osservato
che se l’azione è finalistica nella misura in cui si dominano i decorsi causali in vista di uno scopo, la condotta
colposa, soprattutto nel caso di colpa incosciente, non può essere considerata un’azione finalistica, e quindi
tipica, proprio perché l’agente non vuole realizzare il fatto o addirittura non lo prevede. Per ovviare a tale
inconveniente, i sostenitori della teoria finalistica fanno ricorso al concetto di finalità potenziale, per cui: 1)
l’omissione è una condotta potenzialmente finalistica, ovvero elemento essenziale della tipicità del reato
omissivo è la violazione di un obbligo o dovere di agire, avendo la possibilità di agire e quindi di dominare
l’accadimento causale (disvalore d’evento: offesa al bene giuridico in termini di lesione o messa in pericolo;
disvalore d’azione: la condotta violando un obbligo o dovere di agire crea o aumenta il rischio di lesione del
bene giuridico); 2) la condotta colposa è finalistica in quanto l’autore poteva e doveva prevedere le
conseguenze del proprio agire, ovvero elemento essenziale della tipicità dei reati colposi è la violazione di un
dovere di diligenza, cd disvalore oggettivo di azione. Ma anche nei delitti dolosi la teoria finalistica dell’azione
si trova in difficoltà perché nella dottrina della fattispecie oggettiva rimane ancorata a referenti causali. Ad
esempio, pensiamo al caso di chi, all’approssimarsi di un temporale, induca taluno a fare una passeggiata,
nella speranza che venga colpito da un fulmine. Se l’evento si verifica, Welzel, al pari della teoria
dell’equivalenza, considera realizzata la fattispecie oggettiva e la sanzione può non essere inflitta solo sulla
base dell’esclusione del dolo.
Tuttavia, va osservato che da un punto di vista soggettivo, l’agente voleva ciò che poi si è realizzato ma,
nonostante ciò si ritiene che non debba essere punito, per cui l’esclusione dell’imputazione non deve essere
ricercata nella mancanza del dolo ma nell’oggettiva casualità dell’accadimento dal momento che una morte
casuale non può considerarsi omicidio in senso giuridico-penale.
LA DOTTRINA DEGLI “ELEMENTI NEGATIVI DEL FATTO”
Alla concezione “tripartita” del reato si è ripetutamente contrappostala teoria degli elementi negativi del
fatto, il cui punto di partenza è rappresentato dall’asserzione che la previsione legale del reato non contiene
una mera descrizione dei requisiti dell’azione vietata, ma altresì un giudizio di valore, circa il carattere
antigiuridico del fatto. In tale prospettiva, l’antigiuridicità si configura come “l’in sé del reato”, ovvero come un
elemento negativo della tipicità, per cui la presenza di cause di giustificazione fa venir meno lo stesso fatto
tipico. Ciò dà luogo a due importanti conseguenze: 1) le cause di giustificazione in quanto elementi del fatto
sono norme penali soggette al principio di legalità (non provengono cioè dall’intero ordinamento); 2) l’errore
sulle cause di giustificazione viene disciplinato come errore sul fatto, per cui esclude il dolo.
Va osservato che la dottrina degli elementi negativi del fatto, anche se propone una differente articolazione
degli elementi costitutivi del reato, in particolare una diversa accezione della tipicità in quanto comprensiva
del carattere antigiuridico del fatto, condivide tuttavia con la concezione tripartita il metodo (normativo-
valutativo) dell’analisi e della costruzione del concetto di reato.
Concezione “tripartita” del reato e dottrina degli elementi negativi del fatto, in altre parole, si distinguono
fra loro solo per una diversa collocazione del momento valutativo dell’antigiuridicità.
È, dunque improprio assimilare la teoria degli elementi negativi del fatto alla mera scomposizione del reato
in elemento oggettivo e soggettivo che, invece, prescinde del tutto dalla categoria dell’antigiuridicità; di cui,
anzi, contesta la funzione costitutiva, nell’ambito del concetto del reato.
Fiore muove alla teoria degli elementi negativi del fatto una serie di critiche. Innanzitutto, osserva che la
norma che toglie illiceità al fatto penalmente rilevante, non modifica, né limita, la materia del divieto (cioè la
condotta tipica), ma soltanto ne esclude l’applicabilità ai casi concreti, in cui ricorra anche l’ipotesi prevista
dalla norma permissiva. La distinzione tra fatto tipico e antigiuridicità si rifà qui all’antica distinzione fra
divieto e materia del divieto. Se la materia del divieto è l’uccisione di un uomo, attraverso il momento legittima
difesa essa non viene eliminata, ed invero resta il fatto che un uomo è stato ucciso sia pure per legittima difesa;
viene soltanto eliminata l’efficacia del divieto di uccidere, che in quella particolare situazione non si applica.
In secondo luogo, Fiore sottolinea che le norme a contenuto “permissivo” esprimono principi
dell’ordinamento giuridico generale, e non soltanto del diritto penale e possono escluderne l’applicazione.
Infine, secondo Fiore, l’errore fondamentale della teoria finalistica dell’azione consiste nel contestare una
reale diversità tra ciò che è permesso (omicidio commesso in stato di legittima difesa) e ciò che è irrilevante
dal pdv giuridico-penale (omicidio di un insetto). Vi sono, infatti, comportamenti rilevanti per il diritto penale,
in quanto tipici, che sono permessi dall’ordinamento perché giustificati, e comportamenti non tipici, che sono
sempre irrilevanti per il diritto penale.
Ma la distinzione tra fatto tipico e antigiuridicità non obbedisce solo ad esigenze di carattere processuale;
in realtà, come si è visto, essa corrisponde a una precisa graduazione di valori, giuridicamente rilevante.
L’errore fondamentale della dottrina degli elementi negativi del fatto sta proprio nel contestare, più o meno
consapevolmente, una reale differenza di valore giuridico fra ciò che è “permesso” e ciò che è “irrilevante” dal
punto di vista giuridico-penale.
In altre parole, vi sono comportamenti rilevanti dal punto di vista giuridico-penale, in quanto tipici, che
sono proibiti, perché antigiuridici; e vi sono comportamenti, anch’essi rilevanti per il diritto penale, in quanto
tipici, che non sono proibiti dall’ordinamento, in quanto da esso permessi, perché giustificati. Questi ultimi
vanno nettamente distinti dalla serie innumerevole dei comportamenti “non tipici”, che sono sempre
irrilevanti per il diritto penale.
DALLA CONCEZIONE “PSICOLOGICA” ALLA CONCEZIONE “NORMATIVA” DELLA
COLPEVOLEZZA
Nel linguaggio della dottrina penalistica il termine “colpevolezza” ha tradizionalmente designato
quell’aspetto dell’illecito, in cui si esprime il momento della disubbidienza ai comandi dell’ordinamento
giuridico, e a cui si collega il giudizio di riprovazione nei confronti dell’autore.
Nell’originario schema “tripartito” del reato, il terzo elemento costitutivo dell’illecito penale, nasce
dalla separazione di principio tra lato “esterno” ed “interno” del reato, tra l’oggettivo e il soggettivo (“imputatio
facti” e “imputatio juris”).
Nel modello di Beling, la “tipicità” della condotta è data interamente dalla sua rispondenza al modello
legale di un reato, nei suoi connotati esteriormente riconoscibili; ed appare contrassegnata dalla sua efficienza
causale per la lesione del bene tutelato. Questo è sufficiente per decidere dell’esistenza del fatto tipico e
fornire, quindi, il primo indispensabile “appiglio” per il giudizio di antigiuridicità.
Il contenuto psichico dell’azione viene, invece, distaccato dalla sua base oggettiva ed inserito nel concetto
del reato a rappresentare la categoria della “colpevolezza”, che esprime appunto “il rapporto psicologico
dell’autore con il fatto quale azione tipica antigiuridica” e resta, quindi, estranea alla dimensione della tipicità.
Per la tipicità si richiede, bensì, l’esistenza di un’azione umana sorretta dalla volontà; ma ciò unicamente
per stabilire una differenza fra ciò che è azione e ciò che non lo è. Per determinare ciò che è azione, basta,
infatti, la certezza che l’autore volontariamente abbia agito o sia rimasto inattivo; che cosa egli abbia voluto è,
invece, indifferente; il contenuto della volontà, infatti, ha importanza solo per il problema della colpevolezza.
In questo schema di analisi del reato predicati di valore del fatto penalmente rilevante concernono in modo
separato l’aspetto oggettivo e quello soggettivo della condotta: solo il primo – cioè l’azione umana
esteriormente riconoscibile – costituisce oggetto del giudizio di antigiuridicità; mentre le sue componenti
soggettive orientano il giudizio di colpevolezza, di cui l’imputabilità rappresenta un “presupposto”, il dolo e la
colpa le “forme” costitutive. Trattasi, dunque, di una concezione psicologica della colpevolezza.
I momenti di debolezza di questa costruzione furono subito evidenziati.
Da un lato, non appariva sostenibile la collocazione del dolo e della colpa sotto uno stesso concetto di
genere, per la mancanza di un comune denominatore. Il dolo, infatti, può essere descritto interamente come
struttura psichica; la colpa, viceversa, si può cogliere solo rifacendosi ad un elemento normativo, costituito
dalla violazione della regola obiettiva di diligenza che qualifica la causazione non volontaria dell’evento.
Nella colpa cd incosciente, d’altronde, sembra addirittura mancare un coefficiente psichico e non si
saprebbe, quindi, a che cosa ancorare il giudizio di colpevolezza.
La concrezione psicologica della colpevolezza, del resto, era manchevole proprio nel determinare il
fondamento del giudizio di colpevolezza e, correlativamente, le ragioni della sua esclusione, nelle ipotesi in
cui, pur essendovi dolo o colpa, tradizionalmente si escludeva la colpevolezza dell’agente. Il concetto
psicologico di colpevolezza, inoltre, non riusciva a dare una soddisfacente collocazione a quei fattori della
colpevolezza – sicuramente rilevanti per la commisurazione della pena – che non potevano essere sistemati né
nel dolo, né nell’imputabilità. Si pensi alle motivazioni dell’azione, al contesto personale, familiare e sociale di
essa, al grado di istruzione dell’autore: tutti elementi a cui l’ordinamento giuridico (art. 133 co. 2 c.p.) e la
prassi giudiziaria attribuiscono una rilevanza giuridica e che, tuttavia, sicuramente non “appartengono” alla
struttura psichica dell’azione, pur giocando un ruolo nel costituirsi del giudizio di riprovazione della norma e
nella sua graduazione.
Per definire questo aspetto del giudizio normativo sulla condotta si adoperò il termine di
“riprovevolezza” (Frank), intesa quale decisione libera di agire in modo non conforme al diritto.
Si afferma così un concetto “unitario” di colpevolezza, rispetto al quale dolo e colpa possono stare insieme,
perché in tutti e due i casi l’autore “ha agito, consapevolmente o meno, in modo difforme da come
l’ordinamento voleva che agisse”. Il fatto doloso è un fatto volontario che non si doveva volere, il fatto colposo
un fatto che non si doveva produrre. Ma, naturalmente, il giudizio di riprovazione normativo può sussistere
solo fin dove è possibile avanzare la pretesa ad un comportamento osservante della norma, poiché esistono
circostanze oggettive o di natura soggettiva in rapporto alle quali l’ordinamento autolimita la sua pretesa.
Perché il concetto “normativo” di colpevolezza si configurasse effettivamente come “relazione tra dovere e
volontà” era però necessario un passo ulteriore: e cioè l’estromissione dell’elemento psicologico dalla categoria
della colpevolezza.
La spinta decisiva al compimento di questo processo venne dalla dottrina finalistica dell’azione. Con
l’anticipazione del dolo e della colpa nell’ambito della categoria del fatto tipico, la colpevolezza risultava
“depurata” dal suo contenuto psicologico e si profilava, conseguentemente, quale puro concetto normativo. In
analogia alla operazione condotta da Beling a proposito dell’antigiuridicità, anche per la colpevolezza si
realizzava, così, la separazione fra l’oggetto della valutazione e la valutazione dell’oggetto.
Nello sviluppo del concetto normativo di colpevolezza vennero via via puntualmente individuati gli
elementi che permettono di configurare questa dimensione dell’illecito penale: in primo luogo l’imputabilità,
che ne costituisce il presupposto essenziale, poiché corrisponde alla capacità di autodeterminarsi del soggetto,
fondata sui requisiti della maturità e “normalità” dell’atto intellettivo; le circostanze per cui si agisce; la
coscienza (o almeno la possibilità di essere cosciente) del disvalore della norma, nella situazione concreta;
infine la personalità del soggetto.
Diventa così possibile anche una graduazione della colpevolezza – estremamente problematica nel quadro
della concezione psicologica – e si chiarificano i parametri alla cui stregua commisurare la pena all’entità della
colpevolezza.
Potrebbero piacerti anche
- Fiore, Diritto Penale Parte GeneraleDocumento107 pagineFiore, Diritto Penale Parte Generalerosa100% (1)
- Riassunto Diritto Penale Generale FioreDocumento164 pagineRiassunto Diritto Penale Generale FioreFrank Pellegrino100% (2)
- Manuale Diritto PenaleDocumento81 pagineManuale Diritto PenaleGiulia Casati BuscaNessuna valutazione finora
- Diritto Penale Marinucci Dolcini Riassunti Parte GeneraleDocumento103 pagineDiritto Penale Marinucci Dolcini Riassunti Parte GeneraleLuca Martini100% (1)
- Riassunti Diritto Processuale CivileDocumento126 pagineRiassunti Diritto Processuale CivileDjamilaNessuna valutazione finora
- Diritto Processuale PenaleDocumento163 pagineDiritto Processuale PenaleNuccia MaltaNessuna valutazione finora
- Procedura Civile Verde 1 e Schemi VariDocumento49 pagineProcedura Civile Verde 1 e Schemi VariRaffaeleD.ArgentoNessuna valutazione finora
- Diritto Penale Marinucci Dolcini Riassunti Parte GeneraleDocumento43 pagineDiritto Penale Marinucci Dolcini Riassunti Parte GeneraleErion Eri Ciko100% (2)
- Medicina Legale, Tossicologia e Medicina Del LavoroDocumento686 pagineMedicina Legale, Tossicologia e Medicina Del LavoroErmal64100% (1)
- 5 - Antigiuridicità @Documento15 pagine5 - Antigiuridicità @tortoramariateresa3Nessuna valutazione finora
- Cap 2 SECONDA PARTE MOCCIADocumento3 pagineCap 2 SECONDA PARTE MOCCIAludovica ruinaNessuna valutazione finora
- 4 - Le Cause Generali Di Esclusione Del Fatto TipicoDocumento7 pagine4 - Le Cause Generali Di Esclusione Del Fatto Tipicotortoramariateresa3Nessuna valutazione finora
- Libro Di Dirotto PenaleDocumento10 pagineLibro Di Dirotto PenaleOliviaNessuna valutazione finora
- 8 - Delitto TentatoDocumento7 pagine8 - Delitto Tentatotortoramariateresa3Nessuna valutazione finora
- 3 - Tipicità @Documento26 pagine3 - Tipicità @tortoramariateresa3Nessuna valutazione finora
- Slide Sulla Colpevolezza 1Documento4 pagineSlide Sulla Colpevolezza 1Federica StevanatoNessuna valutazione finora
- Penal Eee Eeeeeeeeeeeeeee EeeeeeeeeeeeeeeDocumento209 paginePenal Eee Eeeeeeeeeeeeeee Eeeeeeeeeeeeeeey6btcftbvgNessuna valutazione finora
- Domande Diritto Penale Prof Valentina MasaroneDocumento28 pagineDomande Diritto Penale Prof Valentina MasaroneFrancesca FalcoNessuna valutazione finora
- CAP 1. Moccia - Il DIRITTO PENALE Tra Essere e ValoreDocumento4 pagineCAP 1. Moccia - Il DIRITTO PENALE Tra Essere e Valoreludovica ruinaNessuna valutazione finora
- Quaderno Appunti Diritto PenaleDocumento41 pagineQuaderno Appunti Diritto PenalePaola RussoNessuna valutazione finora
- Manuale Di Diritto Penale II Ed 2021Documento12 pagineManuale Di Diritto Penale II Ed 2021MartaFabioNessuna valutazione finora
- La Colpa PDFDocumento10 pagineLa Colpa PDFGaia VergariNessuna valutazione finora
- Diritto Penale Nozioni Generali PDFDocumento15 pagineDiritto Penale Nozioni Generali PDFCarlos Antonio Agurto GonzalesNessuna valutazione finora
- Elementi Di Diritto PenaleDocumento14 pagineElementi Di Diritto Penalegiorgino96Nessuna valutazione finora
- Tesi La PreterintezioneDocumento140 pagineTesi La PreterintezioneMarco Nagar100% (1)
- Appunti Dettagliati Lavarini CompletiDocumento399 pagineAppunti Dettagliati Lavarini CompletiAmedeo CaviggiaNessuna valutazione finora
- Glossario Di Diritto PenaleDocumento24 pagineGlossario Di Diritto PenaleAtraNessuna valutazione finora
- Appunti Concorso Di Persone e Reati AssociativiDocumento12 pagineAppunti Concorso Di Persone e Reati AssociativiLorenzo PrencipeNessuna valutazione finora
- Teoria Del Delito GDocumento5 pagineTeoria Del Delito GBenito Irrael MartinezNessuna valutazione finora
- Da Balduzzi A GelliDocumento34 pagineDa Balduzzi A GelliSalvatore ProcopioNessuna valutazione finora
- Diritto PenaleDocumento10 pagineDiritto PenaleFederica TurraNessuna valutazione finora
- Glossario Di Diritto PenaleDocumento14 pagineGlossario Di Diritto Penalemorella70Nessuna valutazione finora
- Il Reale e La Legge PDFDocumento20 pagineIl Reale e La Legge PDFCarlos Antonio Agurto GonzalesNessuna valutazione finora
- EstrattoDocumento12 pagineEstrattowarren sabatiniNessuna valutazione finora
- Veprat PenaleDocumento190 pagineVeprat Penaleprinte 21shiNessuna valutazione finora
- Il Nesso Di Causalita Nella ResponsabiliDocumento9 pagineIl Nesso Di Causalita Nella ResponsabilitrevotjeanNessuna valutazione finora
- 761 Impossibilita Normativa MazzoleniDocumento11 pagine761 Impossibilita Normativa Mazzoleniwarren sabatiniNessuna valutazione finora
- MaliziaDocumento91 pagineMaliziaakashockNessuna valutazione finora
- Fiandaca Dispensa BuonaDocumento260 pagineFiandaca Dispensa BuonaFrancesca FalcoNessuna valutazione finora
- La PraeterintentionDocumento38 pagineLa Praeterintentionalyn3utzaNessuna valutazione finora
- Associazione Per Delinquere LuissDocumento225 pagineAssociazione Per Delinquere LuissOliviaNessuna valutazione finora
- Sbobina PenaleDocumento2 pagineSbobina Penalestefaniaspinelli1998Nessuna valutazione finora
- Taruffo La Prova Del Nesso CausaleDocumento9 pagineTaruffo La Prova Del Nesso CausaleEduardoHenrikAubertNessuna valutazione finora
- Appunti:Diritto Penale 1Documento23 pagineAppunti:Diritto Penale 1Alessia MaffaNessuna valutazione finora
- 9 - Concorso Di PersoneDocumento15 pagine9 - Concorso Di Personetortoramariateresa3Nessuna valutazione finora
- TONINI Diritto Processuale PenaleDocumento16 pagineTONINI Diritto Processuale PenaleCarmelo MessinaNessuna valutazione finora
- Dirtto penale RoxinDocumento10 pagineDirtto penale RoxinFrancesca FalcoNessuna valutazione finora
- Diritto Privato PDFDocumento226 pagineDiritto Privato PDFGiorgia ZaottiniNessuna valutazione finora
- La Disciplina Dell'Errore Nel Diritto PenaleDocumento7 pagineLa Disciplina Dell'Errore Nel Diritto PenaleAlessio CappelloNessuna valutazione finora
- Le Indagini Della Polizia Giudiziaria Analisi Scientifica Degli Istituti e Applicazione Pratica Di Nuove Tecniche InvestigativeDocumento56 pagineLe Indagini Della Polizia Giudiziaria Analisi Scientifica Degli Istituti e Applicazione Pratica Di Nuove Tecniche InvestigativeMarghe BorrelliNessuna valutazione finora
- Docsity Procedura Penale Tonini Sintesi 2021 22Documento187 pagineDocsity Procedura Penale Tonini Sintesi 2021 22giovanni russoNessuna valutazione finora
- DIRITTO PENALE - RiassuntiDocumento142 pagineDIRITTO PENALE - RiassuntiElena RomanNessuna valutazione finora
- ReatoDocumento12 pagineReatostef1234567890Nessuna valutazione finora
- Riassunto Pagliaro GeneraleDocumento232 pagineRiassunto Pagliaro GeneraleSilvia DchNessuna valutazione finora
- Elementi Individuatori Delle AzioniDocumento4 pagineElementi Individuatori Delle AzioniCarlo CostaNessuna valutazione finora
- La DetenzioneDocumento8 pagineLa DetenzionebrunoNessuna valutazione finora
- Condi Zion Amen Tops I Chico FinaleDocumento223 pagineCondi Zion Amen Tops I Chico FinalejaverianaNessuna valutazione finora
- Criminalistica RiassuntiDocumento244 pagineCriminalistica RiassuntiValeria D'AscoliNessuna valutazione finora
- La valutazione del danno esistenziale socio-relazionale e le competenze del sociologo nel processo civile e penaleDa EverandLa valutazione del danno esistenziale socio-relazionale e le competenze del sociologo nel processo civile e penaleNessuna valutazione finora
- 9 - Concorso Di PersoneDocumento15 pagine9 - Concorso Di Personetortoramariateresa3Nessuna valutazione finora
- 11 - SanzioniDocumento25 pagine11 - Sanzionitortoramariateresa3Nessuna valutazione finora
- 1 - Presupposti Culturali Del Diritto Penale VigenteDocumento12 pagine1 - Presupposti Culturali Del Diritto Penale Vigentetortoramariateresa3Nessuna valutazione finora
- 2 - Principio Di Legalità @Documento18 pagine2 - Principio Di Legalità @tortoramariateresa3Nessuna valutazione finora