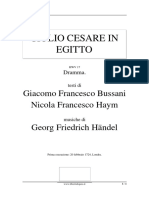Giacomo Leopardi
L’ultimo canto di Saffo
L’ultimo canto di Saffo fu pubblicato per la prima volta nell’opuscolo contenente
le dieci Canzoni stampato a Bologna nel 1824 (Canzoni del Conte Giacomo
Leopardi, Bologna, Nobile, 1824). Dei testi qui raccolti erano già apparsi a stampa
solo i primi tre: All’Italia e Sopra il monumento di Dante (Roma, Bourlié, 1818) e Ad
Angelo Mai (Bologna, Marsigli, 1820). Nelle Canzoni del 1824, dopo queste tre,
«ritoccate dall’autore», comparivano le nuove, in quest’ordine: Per le nozze della
sorella Paolina, A un vincitore di pallone, Bruto minore, Alla primavera, o delle
favole antiche, l’Ultimo canto di Saffo, l’Inno ai Patriarchi, Alla sua donna.
L’ultimo canto di Saffo si riconnette al Bruto minore attraverso il tema del
suicidio, che nell’antico eroe di libertà, sconfitto a Filippi, si configura come atto
estremo di protesta contro gli dei, accusati di fare oggetto di «ludibrio e scherno»
coloro che hanno praticato la virtù; ma si riconnette anche alle due canzoni tra cui è
collocato, Alla primavera e l’Inno ai Patriarchi, nelle quali era evidenziata la perdita
irrimediabile della capacità degli uomini moderni di animare coll’immaginazione le
cose della natura e dialogare con esse.
In un pensiero dello Zibaldone del 5 marzo 1821, il poeta aveva scritto:
L’uomo d’immaginazione di sentimento e di entusiasmo, privo della bellezza del corpo, è verso
la natura appresso a poco quello ch’è verso l’amata un amante ardentissimo e sincerissimo, non
corrisposto nell’amore. Egli si slancia fervidamente verso la natura, ne sente profondamente tutta la
forza, tutto l’incanto, tutte le attrattive, tutta la bellezza, l’ama con ogni trasporto, ma quasi che egli
non fosse punto corrisposto, sente ch’egli non è partecipe di questo bello che ama ed ammira, si
vede fuor della sfera della bellezza, come l’amante escluso dal cuore, dalle tenerezze, dalle
compagnie dell’amata. Nella considerazione e nel sentimento della natura e del bello, il ritorno
sopra se stesso gli è sempre penoso. Egli sente subito e continuamente che quel bello, quella cosa
ch’egli ammira ed ama e sente, non gli appartiene. Egli prova quello stesso dolore che si prova nel
considerare o nel vedere l’amata nelle braccia di un altro, o innamorata di un altro, e del tutto
noncurante di voi. Egli sente quasi che il bello e la natura non è fatta per lui, ma per altri [...]. Egli
insomma si vede e conosce escluso senza speranza, e non partecipe dei favori di quella divinità che
[...] gli è anzi così presente così vicina, ch’egli la sente come dentro se stesso, e vi s’immedesima,
dico la bellezza astratta, e la natura.
Come nel caso del Bruto, la protesta di Leopardi contro la negazione della felicità,
si traduce nell’identificazione della sua sofferenza soggettiva con quella di un illustre
personaggio antico. Nel Bruto Leopardi affronta il tema della sventura della virtù
(non riconosciuta e non ricompensata); nell’Ultimo canto di Saffo il tema è la
sventura della bruttezza, un tema difficilmente esprimibile nella forma della
confessione diretta, ma poetabile, invece, attraverso il filtro della testimonianza
antica, che, come egli scriveva altrove, «dà luogo a quel vago ed incerto che favorisce
sommamente la poesia». La suggestione dell’antico viene a Leopardi dalla Saffo
�ovidiana, raffigurata nella XV delle Heroides nella veste di donna innamorata
perdutamente di Faone, e da lui respinta per la sua bruttezza fisica.
Se nel Bruto minore il suicidio era trattato come una risposta, di impronta
alfieriana, all’ingiustizia della storia, nell’Ultimo canto di Saffo il suicidio è visto
come l’unica risposta praticabile a un’ingiustizia esistenziale. L’agonismo eroico di
Bruto si carica perciò in Saffo di una forte pateticità. Come ancora scrisse Leopardi,
la canzone «intende di rappresentare la infelicità di un animo delicato, tenero,
sensitivo, nobile e caldo, posto in un corpo brutto e giovane». L’ingiustizia
esistenziale risalta ancor più perché a subirla è una donna giovane, dotata di alto
ingegno e delicata sensibilità (incline al sentimento e all’entusiasmo, come Leopardi
aveva detto di sé).
Metrica. Nelle canzoni Leopardi si allontana sempre più marcatamente dal
modello petrarchesco, che già nei due secoli precedenti era stato rivisto e modificato
da vari poeti. L’abbandono definitivo dello schema tradizionale avverrà però più
tardi, con A Silvia (1828), dove il metro adottato, e prediletto nei grandi idilli della
maturità, è quello della “canzone libera leopardiana”: una successione di strofe di
varia estensione, costituite da endecasillabi e settenari liberamente disposti e rimati,
con abbondanza di versi irrelati. Questa forma consente al poeta di svincolarsi da
qualsiasi etichetta di genere per assecondare quell’idea assoluta di lirica come
«espressione libera e schietta di qualunque affetto vivo e ben sentito dell’uomo» di
cui parla nello Zibaldone (la citazione è del 15 dicembre 1826).
Nell’Ultimo canto di Saffo le quattro strofe, tutte di 18 versi, sono formate da 16
endecasillabi sciolti seguiti da un distico (settenario + endecasillabo) a rima baciata.
Si tratta, in sostanza, di un carme in endecasillabi sciolti, interrotti a intervalli regolari
da una clausola rimata (es. nella prima stanza: «fiume alla dubbia sponda / il suono e
la vittrice ira dell’onda). Della forma tradizionale della canzone si conserva, oltre che
l’impiego di soli versi endecasillabi e settenari, la ripetizione in tutte le strofe dello
stesso schema metrico.
Lettura del testo
Le quattro strofe scandiscono il monologo di Saffo in procinto di darsi la morte. Il
monologo ha le caratteristiche di un tragico dialogo con se stessa, che si sviluppa, con
voluta rispondenza antitetica, tra la «Placida notte» del primo verso e l’«atra notte»
dell’ultimo. In Leopardi la sventura della bruttezza diventa esclusione dalla bellezza
delle cose, dalle «dilettose e care sembianze» della natura raffigurate nei primi versi:
la notte quieta, vicina a lasciare il passo al sole nascente, e attraversata da un ultimo
raggio di luna al tramonto («vereconda» significa modesta, pudica, non sfolgorante
come la luce del sole). Presenze, quelle della notte, della luna e del sole che si
annuncia alle quali Saffo rivolge la sua apostrofe, dicendo che lo spettacolo dolce
della natura non può più allietare («già non arride») un cuore disperato («disperati
affetti»), come è il suo.
� Il «noi» del v. 8 apre il secondo tempo della strofa. Saffo passa, nel parlare,
dall’io («ignote mi fur») al noi, solenne e comprensivo di tutti coloro che patiscono la
stessa condizione di infelicità, e che traggono invece piacere dai paesaggi tempestosi,
quelli nei quali la natura mostra l’altra sua faccia, quella inquietante e distruttiva (vv.
9-13). Un secondo noi ribadisce, scandendo la terza e ultima parte della strofa, l’idea
della consonanza tra lo stato d’animo di Saffo e la natura orrida e terribile, trionfante
nella sua ira («il suono e la vittrice ira dell’onda»), nella quale la poetessa dice di
immergersi con voluttà («noi...natar giova...»).
Nella seconda strofa Saffo denuncia, usando la prima persona, la propria
esclusione: gli dei e la sorte avversa non le hanno concesso alcuna parte dell’infinita
bellezza del cielo e della terra. Alla natura rinfaccia di sentirsi come un’ospite
spregevole e fastidiosa, assegnata («addetta») ai suoi superbi regni (il creato, su cui la
natura regna superba e indifferente), e come un’amante disprezzata che rivolge
invano alle sue belle sembianze il desiderio («core») e lo sguardo supplichevoli:
«A’ tuoi superbi regni / vile, o natura, e grave ospite addetta, / e dispregiata
amante, alle vezzose / tue forme il core e le pupille invano / supplichevole intendo»
(vv. 23-27).
L’io riemerge con forza dal v. 27 («A me non ride.... me non il canto.. al mio
lubrico piè) per sottolineare tutti gli aspetti della propria esclusione dalla natura bella,
con una tensione ascendente che culmina nell’immagine conclusiva del «candido
rivo» che si sottrae al contatto del suo piede.
Nella terza strofa Saffo rivolge a se stessa (e al destino) un’interrogazione
drammatica, chiedendosi quale errore inconsapevole o colpa originaria abbia
commesso che possa giustificare la sua condanna all’infelicità. Ma si risponde da sola
(v. 44 e seguenti) che «i destinati eventi move arcano consiglio»: una misteriosa
volontà («arcano consiglio») guida («move») gli eventi che ci sono prefissati («i
destinati eventi»); tutto ci è inconoscibile fuorché il dolore che viviamo. Figli
abbandonati («negletta prole»), siamo predestinati alla sofferenza («nascemmo al
pianto»), e la causa di ciò («la ragione») sta in grembo agli dei (resta a noi oscura).
«Oh cure, oh speme / de’ più verd’anni!» (vv. 49-50): questa esclamazione
sconsolata (Oh affanni, oh speranza di quando si è giovani!) nasce dal sentimento di
disillusione provato da chi, essendo privo della bellezza, non può far risplendere le
virtù che pure possiede: Giove («il Padre») concesse alla bellezza («alle amene
sembianze») un potere eterno tra le genti; e non riesce a mostrare il suo splendore la
virtù, comunque praticata, o in imprese virili o attraverso la poesia («per dotta lira o
canto»), che si cela in un corpo privo di bellezza («virtù non luce in disadorno
ammanto»).
L’ultima strofa esordisce con «Morremo»: il verbo col quale Saffo esprime la sua
determinazione a darsi la morte riprende il moriemur pronunciato al momento del
suicidio da Didone nell’Eneide. Nello Zibaldone del 3 dicembre 1821 Leopardi
commentava quei versi virgiliani sottolineando come il poeta latino avesse voluto
�rendere «quel piacere che l’animo prova nel considerare e rappresentarsi non solo
vivamente, ma minutamente, intimamente, e pienamente la sua disgrazia, i suoi mali
[...] e nel sentire vivacemente che la sua sventura è propriamente immensa e perfetta
e [...] ben serrato ogni adito o alla speranza o alla consolazione qualunque».
«Il velo indegno» è il corpo deforme, non degno dell’animo nobile di Saffo.
I vv. 57-58 («e il crudo fallo emenderà del cieco / dispensator de’ casi»)
significano: rimedierà al crudele errore del destino.
«E tu»: si rivolge a Faone, l’uomo da lei amato invano, augurandogli la felicità,
ma aggiungendo all’augurio un presentimento pessimistico («se felice in terra / visse
nato mortal»). «Me» (v. 62) è fortemente avversativo: quanto a me, ed esprime la
certezza dell’infelicità del suo personale destino.
Il «doglio» del v. 63 è, come Leopardi scrive nelle Annotazioni, «quel vaso pieno
di felicità che Omero pone in casa di Giove», ed è «avaro» perché Giove soleva
dispensare la felicità solo raramente e mescolandola sempre con una parte di
infelicità. «Poi che perir gl’inganni e il sogno / della mia fanciullezza»: la
consapevolezza dell’infelicità è insorta dopo che sono crollate le illusioni della
fanciullezza. I vv. 65-68 traducono i vv. 66-69 del terzo libro delle Georgiche.
I vv. 68-70 («Ecco di tante / sperate palme e dilettosi errori, / il Tartaro
m’avanza») sono così commentati da Leopardi stesso:
Il Tartaro è forse una palma, o un error dilettoso? Tutto l’opposto, ma ciò appunto dà maggior
forza a questo luogo, venendoci ad entrare come un’ironia. Di tanti beni non m’avanza che il
Tartaro, cioè un male. Oltracciò si può spiegare anche esattamente, e con un senso molto naturale.
Cioè, queste tante speranze e questi errori così piacevoli si vanno a risolvere nella morte.
«M’avanza» significa infatti mi rimane, ed è detto ironicamente in contrasto col
verso precedente.
La «tenaria Diva» è Proserpina, la regina degl’Inferi, luogo cui appartengono
l’«atra notte» (le tenebre infernali) e la «silente riva» (le rive silenziose dei fiumi
dell’Averno). I tre termini sono i soggetti del verbo «han» (v. 71). «Il prode ingegno»
è complemento oggetto di «han», che significa possiedono. Saffo sta per gettarsi dalla
rupe Leucade, e immagina la scena in cui il suo valoroso ingegno sprofonda nel buio
della morte.
La clausola finale, costituita dal distico a rima baciata «han la tenaria Diva, / e
l’atra notte, e la silente riva», suggella la canzone con un ritmo di marcia funebre.