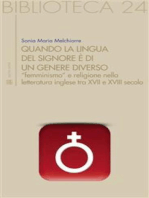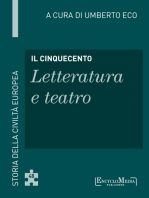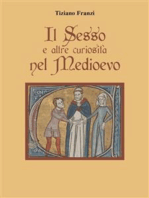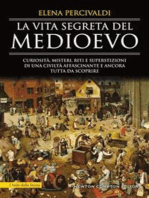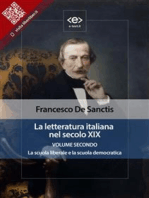Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Linvenzione Del Romanzo Il Caso Aphra Behn
Caricato da
Simone Del MauroCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Linvenzione Del Romanzo Il Caso Aphra Behn
Caricato da
Simone Del MauroCopyright:
Formati disponibili
lOMoARcPSD|1586236
L'invenzione del romanzo il caso Aphra Behn
Lingua e letteratura inglese (Università degli Studi di Napoli Federico II)
StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Scaricato da Simone Del Mauro (simonedelmauro@libero.it)
lOMoARcPSD|1586236
L'invenzione del romanzo.
Il caso Aphra Behn
Per Eliot il romanzo è finito con Flaubert e Joyce, perché è entrato in crisi il tempo che lo aveva prodotto.
Per lui il romanzo è espressione del profondo di un'epoca e del suo rapporto con gli ingranaggi mutevoli
della Storia. Per lui come per Virginia Woolf, il romanzo doveva cedere il passo a forme nuove, diventando
officina di sperimentazione e desacralizzazione del genere della prosa. Il secolo appena trascorso riassume
bene le tante metamorfosi di un genere longevo che si reinventa continuamente, adattandosi alle
metamorfosi dell’esperienza umana.
Il seicento è l’epoca che vede la disgregazione dei rapporti sociali, la fine dei legami che avevano prodotto il
romance, la favola eroica che affidava al mito la concezione aristocratica dei sentimenti e delle emozioni; il
genere romanzesco che sale impetuosamente alla ribalta risponde alle esigenze di gruppi sociali, eredi di
quegli uomini nuovi messi in scena da Shakespeare; l'epoca in cui i viaggi diventano avventurosa
trasportazione delle scienze, o peregrinazione eroica; il secolo delle sensate esperienze galileiane, in cui
scienza e natura si dividono, altra cosa essendo la fede, soggetta all’autorità.
Sarà proprio il dibattito teorico a mettere in pista i generi comunicativi della lettera, della comunicazione
scientifica, del resoconto di viaggio, e poi del romanzo.
Un tempo moderno che produce uomini nuovi, espressione di una rivoluzione che si affianca a quella
copernicana e getta sul palcoscenico della storia l'individuo come soggetto separato e autonomo che si
sostituisce a quello diretto dalla tradizione. È un mutamento radicale da cui nasce una nuova visione che
con il termine individualismo tenterà di riassumere l'irrisolto rapporto del singolo con un organismo sociale.
Ha inizio nel XVII secolo la cultura del sé, già anticipata dalla civiltà rinascimentale. Montaigne: “tutti
guardano davanti a sé, Io guardo dentro di me, ho a che fare soltanto con me stesso”. Cartesio: “ognuno di
noi è una persona separata dagli altri”.
La speculazione filosofica, insieme con la nuova visione escatologica nata dalla riforma, contribuisce così
alla nascita dell'uomo moderno che si definisce in primis nel “segreto di sé” poi nella dimensione sociale. Al
processo di emancipazione dell'io, aggiungerà un tassello anche il fervore politico nella prima metà del
Seicento che si muove anch’esso in sintonia con l’idea dell’autosufficienza del soggetto. Con il movimento
dei Livellatori, per la prima volta nella storia inglese, acquista diritto di cittadinanza una sorta di
individualismo sociale che stabilisce il diritto naturale dell'uomo ad essere padrone assoluto di se stesso. Il
sovrano non è più il garante deve essere individuale, inizia così il processo di laicizzazione della vita.
La nascita e l'esistenza del romanzo Borghese dipendono proprio dal sorgere di una società caratterizzata
dal Vasto complesso di fattori indipendenti e legati tra loro al tempo stesso che passa sotto il nome di
individualismo. Il Seicento è il primo secolo ad esibire la consapevolezza del continuo mutare del mondo e
degli individui che Shakespeare aveva saputo mettere in scena, creando una psicologia della mutabilità per i
suoi protagonisti quando i contemporanei erano ancora lontani dal coglierla.
Come conseguenza della trasformazione radicale dell’immagine del mondo teistica ereditata dal medioevo,
l’uomo entra così, con la complessità delle sue problematiche esistenziali, nelle declinazioni culturali del
dibattito teorico da cui emergerà come un personaggio moderno, alle prese con l’idea nuova della
soggettività della morale. La morale non è assoluta ma relativa perché è relativa ad una persona e alle sue
emozioni. La morale cambia in relazione al soggetto che la vive.
Il perseguimento della verità diventa così di natura esclusivamente individuale, indipendente dalla
tradizione e anzi più facilmente raggiungibile prescindendo da essa. La modernità che nasce dalla
epistemologia del secolo riconosce il tempo come la forza che plasma l’individuo, la sua esperienza unica e
quindi sempre nuova. Nella prosa del tempo fa così il suo ingresso la problematica della soggettività, legata
all'incessante mutare di tutte le cose, e parte dal nome, segno primario dell'identità di ciascuno. Proprio
all'epistemologia individualistica del pensiero dell'epoca e all'individualismo della struttura sociale
moderna, si lega in un vincolo inscindibile il romanzo moderno.
Scaricato da Simone Del Mauro (simonedelmauro@libero.it)
lOMoARcPSD|1586236
Il seicento delle donne
Religione e politica durante la guerra civile: come nasce il pensiero di genere
Secolo della peste e dell’incendio di londra, della guerra civile e di accademie scientifiche come la Royal
society, di sette religiose, del microscopio e del cannocchiale, nelle prime gazzette: la stagione del 600 è la
prima ad esibire la consapevolezza del continuo mutare del mondo e delle cose. il Barocco È espressione di
una cultura e di una società che si confrontano con un mutamento radicale. Nell’Inghilterra dell’epoca
anche la figura femminile, ancorata da una storia millenaria alla famiglia, allo spazio domestico, si stacca dal
quadro che l’ha finora rappresentata. Il pensiero di genere si è più volte soffermato sui momenti di svolta di
un paese, in questo caso i momenti di svolta sono: l'emergenza delle sette indipendentiste nate dalla
riforma e la guerra civile.
Il periodo Proietta le donne fuori dalla propria sfera, sul palcoscenico insanguinato della storia del loro
paese, obbligate a sostituire mariti e padri. lo scontro scompagina interi nuclei familiari, dando un
protagonismo inedito alla componente femminile: la linea Invisibile e invalicabile che chiudeva le donne nel
cerchio del privato e di colpo azzerata. Le donne si trovano a dover gestire case e beni. La lunga marcia
verso l'ingresso della vita politica ha inizio proprio in questo periodo quando molte donne si troveranno a
inventare se stesse al di fuori dei tracciati tradizionali.
Il rapporto tra genere e cittadinanza si coniuga durante la guerra, che oppone al sovrano i puritani di
Cromwell, quando una folla di donne invade uno dei luoghi simbolici cui non hanno diritto di accesso. È il 4
febbraio del 1642 quando davanti al Palazzo dei Comuni si svolge una scena insolita: un centinaio di donne
insiste per presentare una petizione ad una parte del potere politico. Per la prima volta nella storia inglese
un gruppo numeroso di donne si presenta come una personalità politica, collettiva. il loro documento
colpisce un'opinione pubblica ostile e del tutto impreparata. Le donne torneranno più volte davanti ai
palazzi del potere, organizzando vere e proprie manifestazioni di protesta e creando sconcerto e
scompiglio. Le petizioni Ste chiedono la pace, mettendo in discussione una concezione del potere politico
che le esclude, anticipando i momenti caldi della lotta per il voto due secoli più tardi. Per tutte loro che
appartengono in gran parte al mondo delle sette religiose come i quaccheri, i battisti, la Bibbia diventa
strumento di emancipazione e occasione di crescita individuale e collettiva.
Dove l'individuo è pensato nel suo rapporto con il divino senza la mediazione del sacerdote, viene
riconosciuta una sostanziale parità spirituale ai componenti della congregazione, tale da autorizzare le
donne a prendere la parola in chiesa. Saranno in particolare i quaccheri a interpretare la Scrittura nella
visione di una completa eguaglianza.
Nelle petizioni emerge la Chiara consapevolezza i diritti politici negati, la certezza di rappresentare la parte
più oppressa della società. La somma di divieti che caratterizzava un’esistenza al femminile spiega la grande
partecipazione delle donne alla vita delle sette, dove erano spesso in maggioranza e dove veniva accordato
quanto invece all’esterno era reputato inammissibile e contrario alla legge divina. La componente
femminile nella stessa Bibbia trova esempi di donne protagoniste, come Ester e Giuditta.
Scaricato da Simone Del Mauro (simonedelmauro@libero.it)
Potrebbero piacerti anche
- Quando la lingua del Signore è di un genere diverso: “femminismo” e religione nella letteratura inglese tra XVII e XVIII secoloDa EverandQuando la lingua del Signore è di un genere diverso: “femminismo” e religione nella letteratura inglese tra XVII e XVIII secoloNessuna valutazione finora
- Il Seicento e Il SettecentoDocumento6 pagineIl Seicento e Il SettecentoSara CardoniNessuna valutazione finora
- Il Cinquecento - Letteratura e teatro (48): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 49Da EverandIl Cinquecento - Letteratura e teatro (48): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 49Nessuna valutazione finora
- Volume 2 Sanders Letteratura Inglese IIDocumento60 pagineVolume 2 Sanders Letteratura Inglese IIchia.ro3199Nessuna valutazione finora
- L Ottocento: Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 67Da EverandL Ottocento: Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 67Nessuna valutazione finora
- 3 IlluminismoDocumento3 pagine3 IlluminismoFABIOLA BASELICENessuna valutazione finora
- Teoria Del RomanzoDocumento33 pagineTeoria Del RomanzoAnonymous DcaGyvzoSI100% (2)
- Trucheck - It - Positivismo, Realismo, Naturalismo, VerismoDocumento5 pagineTrucheck - It - Positivismo, Realismo, Naturalismo, VerismoValentino Masi100% (1)
- Futurismo LetteraturaDocumento12 pagineFuturismo LetteraturaelisaNessuna valutazione finora
- Il Cinquecento - Filosofia (46): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 47Da EverandIl Cinquecento - Filosofia (46): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 47Nessuna valutazione finora
- Manuale Di Letteratura Italiana 800 in POIDocumento250 pagineManuale Di Letteratura Italiana 800 in POINicolò Giorgio Mugnani100% (1)
- Il Periodo Della Controriforma (Agg. p.522)Documento3 pagineIl Periodo Della Controriforma (Agg. p.522)HsjdhdNessuna valutazione finora
- Di regine,di sante e di streghe. Storie di donne del medioevoDa EverandDi regine,di sante e di streghe. Storie di donne del medioevoNessuna valutazione finora
- Educazione Al Testo LetterarioDocumento27 pagineEducazione Al Testo LetterarioAurora FeltrinNessuna valutazione finora
- Torquato TassoDocumento6 pagineTorquato Tassolucia brascaNessuna valutazione finora
- La letteratura italiana nel secolo XIX. Volume secondo. La scuola liberale e la scuola democratica.Da EverandLa letteratura italiana nel secolo XIX. Volume secondo. La scuola liberale e la scuola democratica.Nessuna valutazione finora
- DecadentismoDocumento34 pagineDecadentismoGiuseppe Lo PrioreNessuna valutazione finora
- Il Cinquecento - Storia (44): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 45Da EverandIl Cinquecento - Storia (44): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 45Nessuna valutazione finora
- Umanesimo Nella Letteratura ItalianaDocumento8 pagineUmanesimo Nella Letteratura Italianachiarapiccola2007Nessuna valutazione finora
- Il Medioevo (secoli V-X) - Storia (20): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 20Da EverandIl Medioevo (secoli V-X) - Storia (20): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 20Nessuna valutazione finora
- Letteratura Inglese IiDocumento27 pagineLetteratura Inglese IiStefano Tutor AccountNessuna valutazione finora
- ESABAC - La Figura Del Intellettuale Tra Settecento e NovecentoDocumento4 pagineESABAC - La Figura Del Intellettuale Tra Settecento e NovecentoMariah ApostolNessuna valutazione finora
- Machiavelli e GuicciardiniDocumento11 pagineMachiavelli e GuicciardiniLmpus Anna100% (1)
- Guido Dall'olioDocumento36 pagineGuido Dall'olioAlessia ContiNessuna valutazione finora
- Duby Georges - Metodologia Storica, LaDocumento6 pagineDuby Georges - Metodologia Storica, LafjagorNessuna valutazione finora
- Attualità Del Pensiero Di FoscoloDocumento1 paginaAttualità Del Pensiero Di FoscologinoNessuna valutazione finora
- Neoclassicismo in FoscoloDocumento2 pagineNeoclassicismo in FoscoloMartaNessuna valutazione finora
- Storia Della Critica LetterariaDocumento26 pagineStoria Della Critica LetterariaCarola FiorindoNessuna valutazione finora
- Foscolo - Vita e OpereDocumento3 pagineFoscolo - Vita e Operevittorio98Nessuna valutazione finora
- Quattrocento e Cinquecento ItaliaDocumento4 pagineQuattrocento e Cinquecento ItaliaSteven ZeneliNessuna valutazione finora
- Tesina Sulla DonnaDocumento8 pagineTesina Sulla Donnaanon-37537167% (3)
- Nani Sulle Spalle Dei GigantiDocumento4 pagineNani Sulle Spalle Dei GigantiTheodorLudwigWiesengrundAdornoNessuna valutazione finora
- Riassunti Didattica Della StoriaDocumento20 pagineRiassunti Didattica Della StoriaMarika CasanovaNessuna valutazione finora
- Illuminismo (Tranne Goldoni)Documento10 pagineIlluminismo (Tranne Goldoni)HsjdhdNessuna valutazione finora
- DecadentismoDocumento4 pagineDecadentismoMattia ArculeoNessuna valutazione finora
- L'umanesimoDocumento3 pagineL'umanesimoLuana CelettaNessuna valutazione finora
- NIETZSCHEDocumento6 pagineNIETZSCHESandra BurchiNessuna valutazione finora
- 5 L'età Giulio ClaudiaDocumento13 pagine5 L'età Giulio ClaudiaGiuseppeNessuna valutazione finora
- Franco Venturi - Utopia e Riforma Nell'illuminismo (Riassunto)Documento14 pagineFranco Venturi - Utopia e Riforma Nell'illuminismo (Riassunto)fedeg94Nessuna valutazione finora
- Riassunto Manuale Storia MedievaleDocumento85 pagineRiassunto Manuale Storia Medievaleeletave24Nessuna valutazione finora
- Il Romanzo StoricoDocumento19 pagineIl Romanzo StoricoBelén Tortosa PujanteNessuna valutazione finora
- Umanesimo e Rinascimento.Documento6 pagineUmanesimo e Rinascimento.LauraPiras100% (1)
- 10 FattoDocumento7 pagine10 FattoMaurizio PomaricoNessuna valutazione finora
- Etàdella ControriformaDocumento3 pagineEtàdella ControriformaLuc MarNessuna valutazione finora
- Ap ScapigliaturaDocumento3 pagineAp ScapigliaturaJessica BoiciucNessuna valutazione finora
- Plutarco FemminileDocumento3 paginePlutarco FemminileVeronica TurnoneNessuna valutazione finora
- 01 Eta Giulio ClaudiaDocumento3 pagine01 Eta Giulio Claudiagianmario_cioffiNessuna valutazione finora
- Belle Epoque-ItaDocumento25 pagineBelle Epoque-Itagiulia filippiniNessuna valutazione finora
- La LetteraturaDocumento51 pagineLa LetteraturaAnrmskm JrjfkdkNessuna valutazione finora
- Storia ModernaDocumento10 pagineStoria ModernagiovanniNessuna valutazione finora
- 3 Vivi e Tre MortiDocumento13 pagine3 Vivi e Tre MortiAndrea LombardiNessuna valutazione finora
- Umanesimo in Italiano PDFDocumento4 pagineUmanesimo in Italiano PDFmarika_12Nessuna valutazione finora
- (09-2010) La Dinastia Giulio-ClaudiaDocumento2 pagine(09-2010) La Dinastia Giulio-ClaudiaDiego Deplano100% (1)
- MASI, Edoarda - Il Singolare e Il Plurale PDFDocumento20 pagineMASI, Edoarda - Il Singolare e Il Plurale PDFEnzo SalomoneNessuna valutazione finora
- Interrogazione Stori.Documento3 pagineInterrogazione Stori.Alice LanfranchiNessuna valutazione finora
- I Promessi Sposi Confronto Nella Società Di OggiDocumento1 paginaI Promessi Sposi Confronto Nella Società Di OggiLuisa CavaliereNessuna valutazione finora
- Cultura Un Lutto Per La Morte Del Professor Francesco Galli - Il Resto Del Carlino Del 14 Aprile 2020Documento1 paginaCultura Un Lutto Per La Morte Del Professor Francesco Galli - Il Resto Del Carlino Del 14 Aprile 2020tizianomanciniNessuna valutazione finora
- Dal Pozzolo - Pietro Della Vecchia Giovanni Nani - 2012Documento19 pagineDal Pozzolo - Pietro Della Vecchia Giovanni Nani - 2012trfgcrNessuna valutazione finora
- Allegato 2Documento10 pagineAllegato 2Gabriele RizzottoNessuna valutazione finora
- 4) PetronioDocumento3 pagine4) PetronioValeria La RoccaNessuna valutazione finora
- Scaricare Libri Fidanzati Dell'inverno. L'Attraversaspecchi - 1 Gratis Di Christelle DabosDocumento10 pagineScaricare Libri Fidanzati Dell'inverno. L'Attraversaspecchi - 1 Gratis Di Christelle DabosLaura Floris0% (2)
- Elementi Di Fisica 1Documento28 pagineElementi Di Fisica 1Boh HobNessuna valutazione finora
- Letteratura Lat 1Documento34 pagineLetteratura Lat 1Leonardo G. StentaNessuna valutazione finora
- Edoardo Sanguineti - Guido GozzanoDocumento10 pagineEdoardo Sanguineti - Guido GozzanoSamuele CapannaNessuna valutazione finora
- Bibliografia Carta Agro Romano - OPACDocumento1 paginaBibliografia Carta Agro Romano - OPACsegu82Nessuna valutazione finora
- Lucrezio, Letteratura LatinaDocumento5 pagineLucrezio, Letteratura Latinanicole fornariNessuna valutazione finora
- L'ISOLA CHE NON C'È Accordi 100% Corretti - Edoardo BennatoDocumento3 pagineL'ISOLA CHE NON C'È Accordi 100% Corretti - Edoardo Bennatostefano.sabloneNessuna valutazione finora
- Apollo e Dafne Nel Racconto Di OvidioDocumento1 paginaApollo e Dafne Nel Racconto Di OvidioAchraf BrhtNessuna valutazione finora
- Letteratura Italiana e InternetDocumento15 pagineLetteratura Italiana e InternetAngelo PagliardiniNessuna valutazione finora
- Appunti Di Letteratura ItalianaDocumento91 pagineAppunti Di Letteratura ItalianaAnna ViglioneNessuna valutazione finora
- Valéry, Paul - La Caccia Magica (LDB) PDFDocumento228 pagineValéry, Paul - La Caccia Magica (LDB) PDFViviana Atencio Arrojas100% (1)
- I Primi Documenti Del Volgare ItalianoDocumento3 pagineI Primi Documenti Del Volgare ItalianoIlaria MaiezzaNessuna valutazione finora
- De Cristofaro - La Palla Al Balzo.Documento26 pagineDe Cristofaro - La Palla Al Balzo.Fatima MeoNessuna valutazione finora
- Canto Divina Commedia 1 ParadisoDocumento1 paginaCanto Divina Commedia 1 Paradisoztef12345Nessuna valutazione finora
- 1AT Libri Di TestoDocumento2 pagine1AT Libri Di TestoiwdespoinaNessuna valutazione finora