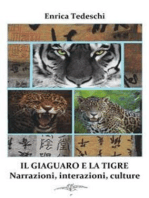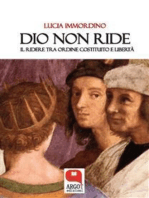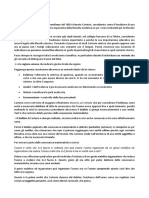Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Operette Morali
Operette Morali
Caricato da
Martina MucchiCopyright:
Formati disponibili
Potrebbero piacerti anche
- L'Evoluzione Del Pensiero Di LeopardiDocumento3 pagineL'Evoluzione Del Pensiero Di LeopardiChiara SantoroNessuna valutazione finora
- Commento Operetta Morale Leopardi (Dialogo Della Natura e Di Un IslandeseDocumento1 paginaCommento Operetta Morale Leopardi (Dialogo Della Natura e Di Un IslandeseFrancesco RonzioNessuna valutazione finora
- Il Bollettino Del Rosario Perpetuo n.1 - Gennaio-Aprile 2012Documento36 pagineIl Bollettino Del Rosario Perpetuo n.1 - Gennaio-Aprile 2012SantaMariaDelSassoNessuna valutazione finora
- TEMIDocumento2 pagineTEMIlatoxag718Nessuna valutazione finora
- LeopardiDocumento2 pagineLeopardiGiovanni MazzarielloNessuna valutazione finora
- Analisi Dei Testi Letteratura Per MaturitàDocumento16 pagineAnalisi Dei Testi Letteratura Per Maturitàcauseyouresky100% (1)
- Giacomo LeopardiDocumento8 pagineGiacomo LeopardiSelene De SantisNessuna valutazione finora
- LeopardiDocumento7 pagineLeopardiTabatha MazzaboNessuna valutazione finora
- Tesina ItalianoDocumento3 pagineTesina ItalianoArabela MateescuNessuna valutazione finora
- Tesina Illusione.Documento33 pagineTesina Illusione.Luciano Silvana ParrucchieriNessuna valutazione finora
- LeopardiDocumento5 pagineLeopardiFedeNessuna valutazione finora
- Leopardi ApprofondimentiDocumento26 pagineLeopardi ApprofondimentiEmanuela RosinaNessuna valutazione finora
- Giacomo LeopardiDocumento8 pagineGiacomo LeopardiGiuseppe AlloccaNessuna valutazione finora
- Le Operette MoraliDocumento1 paginaLe Operette MoraliLel100% (1)
- Dialogo Della Natura e Di Un Islandese EserciziDocumento1 paginaDialogo Della Natura e Di Un Islandese EserciziLelNessuna valutazione finora
- ITALIANODocumento24 pagineITALIANOgio cagliariNessuna valutazione finora
- Leopardi PDFDocumento5 pagineLeopardi PDFFrancescaNessuna valutazione finora
- Leopardi TestiDocumento14 pagineLeopardi TestiLorena BiniNessuna valutazione finora
- Analisi Alcune Poesie e Poemetti Di LeopardiDocumento6 pagineAnalisi Alcune Poesie e Poemetti Di Leopardiflory73Nessuna valutazione finora
- Leopardi VitaDocumento10 pagineLeopardi VitaAlessia SanFilippoNessuna valutazione finora
- Dialogo Della Natura e Di Un IslandeseDocumento1 paginaDialogo Della Natura e Di Un IslandeseSara GioacchiniNessuna valutazione finora
- Copia Di Cose Di Ita Che MancanoDocumento25 pagineCopia Di Cose Di Ita Che MancanoireneNessuna valutazione finora
- LeopardiDocumento4 pagineLeopardiMarta BrunelloNessuna valutazione finora
- TesinaDocumento36 pagineTesinaatzenimarco89Nessuna valutazione finora
- Operette MoraliDocumento3 pagineOperette MoraliGiuliaNessuna valutazione finora
- Fasi Del Pensiero LeopardianoDocumento3 pagineFasi Del Pensiero Leopardianoserena.liarNessuna valutazione finora
- Natura Di LeopardiDocumento1 paginaNatura Di LeopardiLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- Analisi La Ginestra - LeopardiDocumento4 pagineAnalisi La Ginestra - LeopardiGabriele FioreseNessuna valutazione finora
- Giacomo Leopardi 2Documento5 pagineGiacomo Leopardi 2ElianaNessuna valutazione finora
- Dialogo Della Natura e Di Un IslandeseDocumento2 pagineDialogo Della Natura e Di Un IslandeseMario MonticcioloNessuna valutazione finora
- Operette MoraliDocumento3 pagineOperette MoraliSara TommasinoNessuna valutazione finora
- LeopardiDocumento3 pagineLeopardiSandraNessuna valutazione finora
- LEOPARDIDocumento25 pagineLEOPARDIManar BechkouraNessuna valutazione finora
- Riassunto Giacomo LeopardiDocumento3 pagineRiassunto Giacomo Leopardieleonoragiaquinto0404Nessuna valutazione finora
- Appunti Su Leopardi, Produzione LetterariaDocumento5 pagineAppunti Su Leopardi, Produzione Letterariaflory73Nessuna valutazione finora
- Giacomo Leopardi Filosofo o poeta: Saggio e antologia a cura di Paolo MontanariDa EverandGiacomo Leopardi Filosofo o poeta: Saggio e antologia a cura di Paolo MontanariNessuna valutazione finora
- Giacomo - Leopardi Schemaa PDFDocumento2 pagineGiacomo - Leopardi Schemaa PDFMarco DifonzoNessuna valutazione finora
- Poeti Italiani 1900-1Documento42 paginePoeti Italiani 1900-1GiacomoNessuna valutazione finora
- Letteratura ItalianaDocumento6 pagineLetteratura Italianaalessandro.vattimo77Nessuna valutazione finora
- Leopardi, D'annunzio e Pascoli - Concetto Di NaturaDocumento2 pagineLeopardi, D'annunzio e Pascoli - Concetto Di NaturaViviana MarinoNessuna valutazione finora
- Eugenio MontaleDocumento5 pagineEugenio MontaleMarco BrunelliNessuna valutazione finora
- Leopardi (Obiettivi Minimi)Documento1 paginaLeopardi (Obiettivi Minimi)Emilia PalmieriNessuna valutazione finora
- Appunti Leopardi Concetto Di DeterminismoDocumento2 pagineAppunti Leopardi Concetto Di DeterminismoDesireeNessuna valutazione finora
- Italiano TuttoDocumento29 pagineItaliano TuttoGianna CianaNessuna valutazione finora
- Giacomo LeopardiDocumento6 pagineGiacomo LeopardiFrancescoNessuna valutazione finora
- Letteratura ItalianaDocumento89 pagineLetteratura ItalianaDennyNessuna valutazione finora
- Il Pensiero, La Poetica Del Vero e Dell'Indefinito Di LeopardiDocumento4 pagineIl Pensiero, La Poetica Del Vero e Dell'Indefinito Di LeopardiSara GioacchiniNessuna valutazione finora
- Pensiero Di LeopardiDocumento2 paginePensiero Di LeopardiPassa maneriaNessuna valutazione finora
- Giacomo Leopardi PDFDocumento3 pagineGiacomo Leopardi PDFSabrina C.Nessuna valutazione finora
- Giacomo LeopardiDocumento10 pagineGiacomo LeopardiFedeNessuna valutazione finora
- LeopardiDocumento9 pagineLeopardigiuseppe.cacciatoreNessuna valutazione finora
- Appunti Giacomo LeopardiDocumento4 pagineAppunti Giacomo LeopardiPiergyNessuna valutazione finora
- Letteratura ItalianaDocumento24 pagineLetteratura ItalianaLoris SchifanoNessuna valutazione finora
- LEOPARDIDocumento12 pagineLEOPARDIsirtoriauroraNessuna valutazione finora
- Il Più Miserabile Degli Animali. La Linea Anti-Antropocentrica Leopardi - SvevoDocumento16 pagineIl Più Miserabile Degli Animali. La Linea Anti-Antropocentrica Leopardi - SvevoHanaNessuna valutazione finora
- NaturaDocumento2 pagineNaturaMarta BrunelloNessuna valutazione finora
- Giacomo LeopardiDocumento5 pagineGiacomo LeopardiElianaNessuna valutazione finora
- Giacomo LeopardiDocumento4 pagineGiacomo LeopardiClaudiu FilipescuNessuna valutazione finora
- LeopardiDocumento3 pagineLeopardimichela atturaNessuna valutazione finora
- Il giaguaro e la tigre. Interazioni, narrazioni, cultureDa EverandIl giaguaro e la tigre. Interazioni, narrazioni, cultureNessuna valutazione finora
- Dio non ride. Il ridere tra ordine costituito e libertàDa EverandDio non ride. Il ridere tra ordine costituito e libertàNessuna valutazione finora
- GoldoniDocumento1 paginaGoldoniMartina MucchiNessuna valutazione finora
- Contesto Storico Del '700 e BaroccoDocumento2 pagineContesto Storico Del '700 e BaroccoMartina MucchiNessuna valutazione finora
- LeopardiDocumento1 paginaLeopardiMartina MucchiNessuna valutazione finora
- Car TesioDocumento10 pagineCar TesioMartina MucchiNessuna valutazione finora
- Siano Paolo Maria - San Massimiliano Kolbe e La Libera MuratoriaDocumento50 pagineSiano Paolo Maria - San Massimiliano Kolbe e La Libera MuratoriajczamboniNessuna valutazione finora
- Atto Di Fratellanza Della Giovane EuropaDocumento4 pagineAtto Di Fratellanza Della Giovane EuropamrtoneNessuna valutazione finora
- Ddi Matsuo BashōDocumento2 pagineDdi Matsuo BashōEnsoNessuna valutazione finora
- Economia Aziendale-Contabilita'Documento22 pagineEconomia Aziendale-Contabilita'AlebocNessuna valutazione finora
- GiantecoDocumento47 pagineGiantecoJako MishyNessuna valutazione finora
Operette Morali
Operette Morali
Caricato da
Martina MucchiTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Operette Morali
Operette Morali
Caricato da
Martina MucchiCopyright:
Formati disponibili
OPERETTE MORALI
In quest’opera composta nel 1824, Leopardi fa confluire la maggior parte delle sue riflessioni filosofiche e
delle conclusioni tratte da esse. Perciò se da un lato sono un riepilogo, dall’altro rappresentano il distacco e
disimpegno civile dell’autore, questo è visibile soprattutto grazie all’ironia.
Il fine del libro:
È duplice: la messa in evidenza di caratteri reali, senza illusioni; dall’altro, quello di trovare una morale
(mores) a ogni suo testo.
C’è un grosso ricorso al registro comico, utilizzato per esprimere contenuti principalmente tragici.
I temi principali:
-La teoria del piacere alla quale si legano il tema della natura e della civiltà.
-La concezione materialistica.
-Un tema insistente è quello della virtù che viene considerata un concetto senza alcuna sostanza e perciò
viene discreditata.
-Critica di fondo ad alcune costanti della civiltà umana: l’illusione antropocentrica (derisa a causa della
marginalità rappresentata dall’uomo nell’universo), il mito del progresso (screditato dal confronto con gli
antichi), la prospettiva religiosa (respinta in quanto illusione riparatoria all’infelicità umana).
Struttura:
24 prose ordinate in una struttura unitaria ma ricca di variazioni.
Modello:
Il modello di riferimento utilizzato da Leopardi sono i dialoghi greci di Luciano.
DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE
Attraverso questo dialogo Leopardi comunica le proprie idee sulla natura (vista come matrigna, cioè
intrinsecamente malvagia).
L’Islandese (che rappresenta Leopardi) incontra la personificazione della natura e le domanda i quesiti che si
è posto Leopardi per giungere alle conclusioni che ci vengono presentate attraverso le risposte che la Natura
dà.
Prima di tutto l’Islandese spiega cosa, facente parte della sua esperienza di vita, lo ha portato a porsi
determinate domande e a sviluppare riflessioni, in particolare, sul genere umano:
1. Nel tentativo di vivere una vita serena egli racconta di aver provato ad accontentarsi di poco e a
non offendere nessuno tuttavia, gli altri uomini hanno continuato a dargli fastidio.
2. Questo lo porta a isolarsi nella natura incontaminata ma questo lo fa stare peggio poiché un clima
adatto all’uomo non esiste.
3. Si rende conto che l’uomo vive in una condizione di infelicità che pare essergli propria e che i
momenti in cui sta male si alternano a momenti in cui sta peggio. Se la Natura fosse corretta
darebbe anche felicità.
4. Capisce che le cose che ci fanno sopravvivere ci danneggiano e che gli anni di giovinezza sono
pochi rispetto a quelli di decadenza.
La Natura gli risponde che l’infelicità umana non è intenzionale, è il meccanismo alla base della natura a
essere semplicemente così. Nel momento in cui l’Islandese chiede perché l’uomo esiste se tanto è destinato a
soffrire la Natura risponde che è tutto frutto di un rapporto causa-effetto (meccanicismo): l’universo fisico
necessita la sofferenza di tutti gli elementi poiché senza distruzione non può esistere produzione.
CANTO NOTTURNO DI UN PASTORE ERRANTE DELL’ASIA
È l’ultimo dei canti pisano-recanatesi. Un pastore nomade dell’Asia riflette sul senso della vita, la
particolarità di questo componimento è proprio che non contiene elementi autobiografici per l’autore o per
il lettore. L’ispirazione viene da un articolo letto da Leopardi che parlava di una popolazione nomade di
origine mongola, i kirghisi, che solevano trascorrere la notte a dedicare alla luna parole tristi su melodie.
Questo componimento fa parte dei Canti ed è una canzone libera di varia lunghezza.
Potrebbero piacerti anche
- L'Evoluzione Del Pensiero Di LeopardiDocumento3 pagineL'Evoluzione Del Pensiero Di LeopardiChiara SantoroNessuna valutazione finora
- Commento Operetta Morale Leopardi (Dialogo Della Natura e Di Un IslandeseDocumento1 paginaCommento Operetta Morale Leopardi (Dialogo Della Natura e Di Un IslandeseFrancesco RonzioNessuna valutazione finora
- Il Bollettino Del Rosario Perpetuo n.1 - Gennaio-Aprile 2012Documento36 pagineIl Bollettino Del Rosario Perpetuo n.1 - Gennaio-Aprile 2012SantaMariaDelSassoNessuna valutazione finora
- TEMIDocumento2 pagineTEMIlatoxag718Nessuna valutazione finora
- LeopardiDocumento2 pagineLeopardiGiovanni MazzarielloNessuna valutazione finora
- Analisi Dei Testi Letteratura Per MaturitàDocumento16 pagineAnalisi Dei Testi Letteratura Per Maturitàcauseyouresky100% (1)
- Giacomo LeopardiDocumento8 pagineGiacomo LeopardiSelene De SantisNessuna valutazione finora
- LeopardiDocumento7 pagineLeopardiTabatha MazzaboNessuna valutazione finora
- Tesina ItalianoDocumento3 pagineTesina ItalianoArabela MateescuNessuna valutazione finora
- Tesina Illusione.Documento33 pagineTesina Illusione.Luciano Silvana ParrucchieriNessuna valutazione finora
- LeopardiDocumento5 pagineLeopardiFedeNessuna valutazione finora
- Leopardi ApprofondimentiDocumento26 pagineLeopardi ApprofondimentiEmanuela RosinaNessuna valutazione finora
- Giacomo LeopardiDocumento8 pagineGiacomo LeopardiGiuseppe AlloccaNessuna valutazione finora
- Le Operette MoraliDocumento1 paginaLe Operette MoraliLel100% (1)
- Dialogo Della Natura e Di Un Islandese EserciziDocumento1 paginaDialogo Della Natura e Di Un Islandese EserciziLelNessuna valutazione finora
- ITALIANODocumento24 pagineITALIANOgio cagliariNessuna valutazione finora
- Leopardi PDFDocumento5 pagineLeopardi PDFFrancescaNessuna valutazione finora
- Leopardi TestiDocumento14 pagineLeopardi TestiLorena BiniNessuna valutazione finora
- Analisi Alcune Poesie e Poemetti Di LeopardiDocumento6 pagineAnalisi Alcune Poesie e Poemetti Di Leopardiflory73Nessuna valutazione finora
- Leopardi VitaDocumento10 pagineLeopardi VitaAlessia SanFilippoNessuna valutazione finora
- Dialogo Della Natura e Di Un IslandeseDocumento1 paginaDialogo Della Natura e Di Un IslandeseSara GioacchiniNessuna valutazione finora
- Copia Di Cose Di Ita Che MancanoDocumento25 pagineCopia Di Cose Di Ita Che MancanoireneNessuna valutazione finora
- LeopardiDocumento4 pagineLeopardiMarta BrunelloNessuna valutazione finora
- TesinaDocumento36 pagineTesinaatzenimarco89Nessuna valutazione finora
- Operette MoraliDocumento3 pagineOperette MoraliGiuliaNessuna valutazione finora
- Fasi Del Pensiero LeopardianoDocumento3 pagineFasi Del Pensiero Leopardianoserena.liarNessuna valutazione finora
- Natura Di LeopardiDocumento1 paginaNatura Di LeopardiLorenzo AlfanoNessuna valutazione finora
- Analisi La Ginestra - LeopardiDocumento4 pagineAnalisi La Ginestra - LeopardiGabriele FioreseNessuna valutazione finora
- Giacomo Leopardi 2Documento5 pagineGiacomo Leopardi 2ElianaNessuna valutazione finora
- Dialogo Della Natura e Di Un IslandeseDocumento2 pagineDialogo Della Natura e Di Un IslandeseMario MonticcioloNessuna valutazione finora
- Operette MoraliDocumento3 pagineOperette MoraliSara TommasinoNessuna valutazione finora
- LeopardiDocumento3 pagineLeopardiSandraNessuna valutazione finora
- LEOPARDIDocumento25 pagineLEOPARDIManar BechkouraNessuna valutazione finora
- Riassunto Giacomo LeopardiDocumento3 pagineRiassunto Giacomo Leopardieleonoragiaquinto0404Nessuna valutazione finora
- Appunti Su Leopardi, Produzione LetterariaDocumento5 pagineAppunti Su Leopardi, Produzione Letterariaflory73Nessuna valutazione finora
- Giacomo Leopardi Filosofo o poeta: Saggio e antologia a cura di Paolo MontanariDa EverandGiacomo Leopardi Filosofo o poeta: Saggio e antologia a cura di Paolo MontanariNessuna valutazione finora
- Giacomo - Leopardi Schemaa PDFDocumento2 pagineGiacomo - Leopardi Schemaa PDFMarco DifonzoNessuna valutazione finora
- Poeti Italiani 1900-1Documento42 paginePoeti Italiani 1900-1GiacomoNessuna valutazione finora
- Letteratura ItalianaDocumento6 pagineLetteratura Italianaalessandro.vattimo77Nessuna valutazione finora
- Leopardi, D'annunzio e Pascoli - Concetto Di NaturaDocumento2 pagineLeopardi, D'annunzio e Pascoli - Concetto Di NaturaViviana MarinoNessuna valutazione finora
- Eugenio MontaleDocumento5 pagineEugenio MontaleMarco BrunelliNessuna valutazione finora
- Leopardi (Obiettivi Minimi)Documento1 paginaLeopardi (Obiettivi Minimi)Emilia PalmieriNessuna valutazione finora
- Appunti Leopardi Concetto Di DeterminismoDocumento2 pagineAppunti Leopardi Concetto Di DeterminismoDesireeNessuna valutazione finora
- Italiano TuttoDocumento29 pagineItaliano TuttoGianna CianaNessuna valutazione finora
- Giacomo LeopardiDocumento6 pagineGiacomo LeopardiFrancescoNessuna valutazione finora
- Letteratura ItalianaDocumento89 pagineLetteratura ItalianaDennyNessuna valutazione finora
- Il Pensiero, La Poetica Del Vero e Dell'Indefinito Di LeopardiDocumento4 pagineIl Pensiero, La Poetica Del Vero e Dell'Indefinito Di LeopardiSara GioacchiniNessuna valutazione finora
- Pensiero Di LeopardiDocumento2 paginePensiero Di LeopardiPassa maneriaNessuna valutazione finora
- Giacomo Leopardi PDFDocumento3 pagineGiacomo Leopardi PDFSabrina C.Nessuna valutazione finora
- Giacomo LeopardiDocumento10 pagineGiacomo LeopardiFedeNessuna valutazione finora
- LeopardiDocumento9 pagineLeopardigiuseppe.cacciatoreNessuna valutazione finora
- Appunti Giacomo LeopardiDocumento4 pagineAppunti Giacomo LeopardiPiergyNessuna valutazione finora
- Letteratura ItalianaDocumento24 pagineLetteratura ItalianaLoris SchifanoNessuna valutazione finora
- LEOPARDIDocumento12 pagineLEOPARDIsirtoriauroraNessuna valutazione finora
- Il Più Miserabile Degli Animali. La Linea Anti-Antropocentrica Leopardi - SvevoDocumento16 pagineIl Più Miserabile Degli Animali. La Linea Anti-Antropocentrica Leopardi - SvevoHanaNessuna valutazione finora
- NaturaDocumento2 pagineNaturaMarta BrunelloNessuna valutazione finora
- Giacomo LeopardiDocumento5 pagineGiacomo LeopardiElianaNessuna valutazione finora
- Giacomo LeopardiDocumento4 pagineGiacomo LeopardiClaudiu FilipescuNessuna valutazione finora
- LeopardiDocumento3 pagineLeopardimichela atturaNessuna valutazione finora
- Il giaguaro e la tigre. Interazioni, narrazioni, cultureDa EverandIl giaguaro e la tigre. Interazioni, narrazioni, cultureNessuna valutazione finora
- Dio non ride. Il ridere tra ordine costituito e libertàDa EverandDio non ride. Il ridere tra ordine costituito e libertàNessuna valutazione finora
- GoldoniDocumento1 paginaGoldoniMartina MucchiNessuna valutazione finora
- Contesto Storico Del '700 e BaroccoDocumento2 pagineContesto Storico Del '700 e BaroccoMartina MucchiNessuna valutazione finora
- LeopardiDocumento1 paginaLeopardiMartina MucchiNessuna valutazione finora
- Car TesioDocumento10 pagineCar TesioMartina MucchiNessuna valutazione finora
- Siano Paolo Maria - San Massimiliano Kolbe e La Libera MuratoriaDocumento50 pagineSiano Paolo Maria - San Massimiliano Kolbe e La Libera MuratoriajczamboniNessuna valutazione finora
- Atto Di Fratellanza Della Giovane EuropaDocumento4 pagineAtto Di Fratellanza Della Giovane EuropamrtoneNessuna valutazione finora
- Ddi Matsuo BashōDocumento2 pagineDdi Matsuo BashōEnsoNessuna valutazione finora
- Economia Aziendale-Contabilita'Documento22 pagineEconomia Aziendale-Contabilita'AlebocNessuna valutazione finora
- GiantecoDocumento47 pagineGiantecoJako MishyNessuna valutazione finora