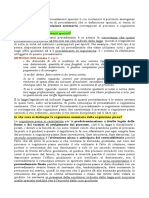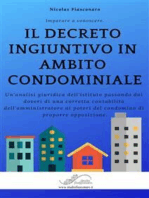Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Appunti Di Procedura Civile Parte 2
Caricato da
Debora Di PernaCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Appunti Di Procedura Civile Parte 2
Caricato da
Debora Di PernaCopyright:
Formati disponibili
lOMoARcPSD|6975046
Appunti di Procedura civile II
Diritto Processuale Civile 2^ Parte (Università degli Studi di Pavia)
Studocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
INTRODUZIONE.
Il libro terzo del codice è interamente dedicato ai procedimenti esecutivi, mentre il libro quarto del codice
contiene una varietà notevole di procedimenti speciali, nonché la disciplina dell’arbitrato. Ci occuperemo
anche degli artt. 409 ss. che disciplinano il rito del lavoro e sono contenuti nel libro secondo.
Uno dei grandi padri della procedura civile contemporanea, Andrioli definì il quarto libro come una specie di
Upim, cioè un grande magazzino in cui si trovano tutti i procedimenti speciali.
A questi procedimenti contenuti nel libro quarto, a partire da quest’anno, si aggiungeranno i c.d. collettive
redress, ossia azioni collettive a carattere risarcitorio.
Noi non ci occuperemo dei procedimenti speciali che sono disciplinati al di fuori del c.p.c., forme di tutela
differenziate rispetto a quelle ordinarie. Nel nostro sistema di tutela giudiziaria, al di là di ciò che era
disciplinato dal codice, esistevano non meno di cinquanta procedimenti di questo tipo. Nel 2011 il legislatore
emana, per questo motivo, il d.lgs. sulla semplificazione cercando di ricondurre tutti questi procedimenti a
tre macrocategorie: processo ordinario di cognizione, rito del lavoro e processo sommario di cognizione.
Peccato che per rendere operativi questi cambiamenti siano state dettate per ogni procedimento norme
particolari. È, quindi, opinione comune che la semplificazione abbia fallito.
IL PROCESSO DI ESECUZIONE.
L’esecuzione forzata occupa l’intero terzo libro. Restano fuori le c.d. esecuzioni forzate speciali (esecuzione
di tasse e tributi, esecuzione per insolvenza,…).
L’esecuzione forzata rappresenta il lato pratico della tutela giurisdizionale. Una volta accertato un diritto
avente a contenuto una prestazione che un soggetto è tenuto a garantire, una volta verificato che questo non è
stato fatto, entra in campo il processo di esecuzione.
I meccanismi dell’esecuzione forzata si comprendono vedendoli in correlazione con la sentenza di condanna.
Ricordiamo che il processo di cognizione può concludersi con tre tipi di sentenze, la sentenza di
accertamento mero, che accerta l’esistenza di un diritto, la sentenza costitutiva, che crea, modifica o estingue
un rapporto giuridico preesistente, e la sentenza di condanna, cioè la sentenza che, accertata in capo ad un
soggetto l’esistenza di un diritto a una prestazione, accerta anche che la prestazione è mancata e quindi il
soggetto tenuto a compierla è rimasto inadempiente. Il soggetto, in quest’ultimo caso viene condannato ad
adempiere. Se non lo fa, il titolare può ottenere il soddisfacimento del diritto in via coattiva, attivando i
meccanismi del processo di esecuzione.
Convenzionalmente nei processi esecutivi si parla di creditore e debitore. Intuitivamente, verrebbe da
considerarli come l’analogo dell’attore e del convenuto. È vero che il creditore si trova in una posizione
assimilabile a quella dell’attore perché è lui che è tenuto a dare impulso all’esecuzione. Tuttavia, la
posizione del debitore non è identica a quella del convenuto. Nel processo di cognizione, il convenuto ha la
possibilità di reagire attraverso la costituzione in giudizio e la proposizione di eccezioni. Nel processo
esecutivo, il debitore ha una posizione di soggezione: non ha un potere di reazione diretta. Questa situazione
di soggezione viene meno solo quando il creditore intraprende le c.d. opposizioni all’esecuzione che
implicano l’instaurazione di un giudizio di cognizione all’interno del processo esecutivo. Si tratta però di una
forma di reazione del convenuto puramente eventuale, nel senso che il debitore non è obbligato a proporre le
opposizioni, che rientrano, quindi, in una sua mera facoltà.
A questo punto possiamo chiederci se il principio del contraddittorio è presente nel processo esecutivo. Il
tema è stato ampiamente discusso dalla dottrina, la quale è arrivata alla conclusione che il principio ha una
forma più attenuata, che torna ad essere piena solo nel caso in cui il debitore proponga una opposizione. Del
resto è lo stesso codice che, in relazione al processo esecutivo, prevede l’audizione delle parti.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
Dal punto di vista strutturale, l’esecuzione forzata è un procedimento che si sviluppa in vari stadi. In realtà
non è corretto parlare di un solo procedimento, perché il codice prevede diversi tipi di esecuzione forzata.
Ciò che fa la differenza è il tipo di prestazione a cui il creditore ha diritto e che il debitore ha lasciato
insoddisfatta.
Dobbiamo ricordare la teoria delle obbligazioni. Le obbligazioni possono avere ad oggetto crediti pecuniari
– quindi somme di denaro –, la consegna di un bene mobile determinato, il rilascio di un bene immobile,
oppure una prestazione di fare o di non fare. Per ciascuna di queste obbligazioni rimaste insoddisfatte il
legislatore predispone un tipo di procedimento esecutivo, distinguendo tra espropriazione, che comprende le
varie procedure per l’esecuzione forzata degli obblighi o delle obbligazioni aventi contenuto pecuniario, e
l’esecuzione forzata in forma specifica, per gli altri tipi di obbligazioni.
Si parla, con riguardo all’espropriazione, di esecuzione forzata in forma generica – come sappiamo, infatti,
il denaro è il bene maggiormente fungibile, non rileva la qualità ma la quantità – mentre di esecuzione in
forma specifica per le obbligazioni di consegna o rilascio, o per quelle aventi ad oggetto un facere o un non
facere, proprio perché in questi casi il creditore ha diritto proprio a quella specifica prestazione.
A sua volta l’espropriazione si distingue a seconda che assoggettati alla procedura esecutiva siano beni
mobili, beni immobili o crediti.
Il patrimonio del debitore è comprensivo di beni mobili, beni immobili e di crediti. Per ciascuna tipologia di
beni il legislatore ha dettato norme specifiche che hanno come finalità ultima quella di procurare la
disponibilità di denaro nelle mani del debitore, al fine di poter adempiere l’obbligazione. Queste norme sono
state molto rimaneggiate nel corso degli anni e continuano ad esserlo.
Competenza. Si parla in generale di ufficio esecutivo. Esso è un’entità immateriale che però è ubicata
all’interno del tribunale. Ciò vuol dire che, in materia di esecuzione forzata l’organo giudiziario competente
in via esclusiva è, per ora, il tribunale (per ora perché se le cose non cambieranno, a partire dal 2021 anche il
giudice di pace avrà competenze in materia di esecuzione forzata per ciò che riguarda l’espropriazione di
beni mobili). Il tribunale è costituito da uno o più giudici dell’esecuzione, dal cancelliere e dall’ufficiale
giudiziario, il quale, nell’ambito delle procedure esecutive svolge delle funzioni molto più importanti di
quelle che normalmente gli competono come ausiliario del giudice.
Nei tribunali più grandi c’è spesso la sezione esecuzione. Non si tratta, tuttavia, di una sezione specializzata
del tribunale (sezione per le cause commerciali, la sezione per le controversie agrarie, la sezione per i
minorenni e poche altre). È solo una ripartizione interna (come anche per la sezione lavoro) dei carichi di
lavoro.
Sempre parlando di competenza in materia di esecuzione forzata, dobbiamo fare riferimento agli artt. 26,
26bis e 27. L’art. 26 stabilisce che, per l’esecuzione forzata su beni mobili è competente il giudice del luogo
in cui le cose si trovano, mentre per l’esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare è competente il
giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto. Dell’art. 26bis è particolarmente importante
l’ultimo comma, secondo il quale per l’espropriazione forzata di crediti, detta anche espropriazione forzata
presso terzi, è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio o la dimora.
L’art. 27 è relativo alle opposizioni all’esecuzione, ossia le eventuali parentesi di cognizione nella tutela
esecutiva. La norma fissa la competenza del giudice del luogo dell’esecuzione. Per le opposizioni ai singoli
atti esecutivi è competente il giudice davanti al quale si svolge l’esecuzione.
In materia di spese, la regola generale è quella dell’anticipazione delle spese da parte del soggetto che
compie i singoli atti o li richiede o anche quando è lo stesso legislatore (o il giudice) a porre a carico di un
determinato soggetto l’anticipazione. Questa norma è contenuta nel TU del 2002 sulle spese di giustizia, a
seguito dell’abrogazione della regola di contenuto analogo contenuta nell’abrogato art. 90 c.p.c.
Naturalmente, il carico delle spese sarà stabilito al termine del processo esecutivo.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
A differenza che nel processo di cognizione, nel processo esecutivo il ruolo degli avvocati sembra
attenuato. Siamo nel campo delle facoltà riservate al soggetto, nulla gli vieta di farsi rappresentare da un
avvocato di fiducia, avvocato che riassume un ruolo principale quando vi sia un’opposizione, in quanto si
tratta di giudizio di cognizione.
Il titolo esecutivo.
La norma che apre il terzo libro è l’art. 474, rubricato “Titolo esecutivo”. Questa norma apparentemente
semplice richiede una qualche spiegazione. Si dice che il titolo esecutivo è condizione necessaria e
sufficiente per intraprendere l’esecuzione forzata. Dal punto di vista pratico, il titolo esecutivo è un
documento che incorpora un diritto. Il diritto deve essere certo, liquido ed esigibile. Parte della dottrina parla
del titolo esecutivo come di una fotografia che cristallizza una certa immagine, una certa situazione di credito
e debito in uno specifico momento storico. Naturalmente può accadere che con il passare del tempo la realtà
non corrisponda più alla fotografia. Tuttavia, per l’esecuzione forzata basta la fotografia. Spetterà al debitore,
mediante l’opposizione, dimostrare che la realtà non è più corrispondente a quella del titolo esecutivo.
Altra descrizione abbastanza frequente del titolo esecutivo è quella che fa riferimento all’astrattezza
dell’azione esecutiva, proprio perché l’azione esecutiva prescinde dall’esistenza di ogni altro requisito che
non sia il possesso del titolo esecutivo.
Certezza. Non significa sentenza passata in giudicato, ma esatta identificazione del diritto di cui si chiede la
tutela coattiva. Consiste quindi in una serie di elementi che consentono di identificare chiaramente il tipo di
diritto per il quale si procede ad esecuzione. Quindi, ad es., se si tratta di diritto di credito pecuniario, la
certezza è individuata sufficientemente dall’importo del credito, se si tratta di diritto alla restituzione di un
bene occorre una specifica indicazione del bene, e così via.
Liquidità. Si riferisce alle obbligazioni a contenuto pecuniario di cui deve essere individuato l’importo. Per
l’individuazione è indispensabile che l’entità del credito per cui si procede possa essere ricavata mediante
una semplice operazione matematica.
Esigibilità. È legata all’assenza di termini o condizioni. Il diritto di credito è esigibile nel momento in cui si
avvera la condizione (sospensiva) o scade il termine.
Posti questi requisiti è necessaria una importante constatazione empirica. Non ci sono regole rispetto
all’identificazione dei titoli esecutivi, nel senso che non ci sono elementi che facciano desumere di essere in
presenza di un titolo esecutivo. Il titolo esecutivo è tale in seguito a una specifica scelta del legislatore. L’art.
474 individua due tipi di titoli esecutivi: i titoli esecutivi giudiziali e i titoli esecutivi stragiudiziali. I primi si
formano in giudizio, mentre i secondi al di fuori del processo.
Sono titoli esecutivi giudiziali: le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce
espressamente efficacia esecutiva (art.474, n. 1). Questa norma va decrittata.
Sentenze suscettibili di esecuzione forzata sono solo le sentenze di condanna. Non ci si deve far trarre in
inganno dal fatto che a volte le sentenze costitutive sembrano necessitare una sorta di attività esecutiva.
Possiamo prendere come esempio la sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio
deve essere annotata sugli atti dello stato civile: non si tratta di esecuzione forzata, ma di una attività
amministrativa che produce effetti erga omnes. Sono immediatamente, anche se provvisoriamente, esecutive
anche le sentenze pronunciate in primo grado. Si parla di esecutività provvisoria perché in sede di
proposizione dell’appello la parte soccombente potrà chiedere la c.d. inibitoria, quindi la sospensione
dell’efficacia esecutiva della sentenza. Una situazione di questo genere è particolarmente importante nel caso
in cui il debitore, che ha iniziato a subire l’esecuzione, intenda intraprendere iniziative perché in questo caso
si tratta di stabilire cosa passa davanti prima, se l’impugnazione o l’opposizione proposta dal debitore.
È necessaria un’attribuzione espressa da parte del legislatore. I provvedimenti, diversi dalla sentenza, aventi
efficacia di titolo esecutivo sono molti: ordinanza con cui si conclude il procedimento sommario di
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
condanna, il decreto ingiuntivo non opposto, alcune ordinanze in corso di causa, l’ordinanza presidenziale
nell’ambito del procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, e così via.
Per quanto riguarda gli altri atti, convenzionalmente si ritiene che il riferimento sia al verbale di
conciliazione, quindi sia il verbale omologato dal giudice, sia i verbali stragiudiziali che, ricorrendo
particolari condizioni, non la richiedono. Ad esempio, il verbale di conciliazione raggiunto a seguito
dell’esperimento con risultato favorevole di un tentativo di mediazione è immediatamente esecutivo se è
sottoscritto dalle parti coinvolte e dagli avvocati delle parti. In questo caso non è richiesta l’omologazione
del giudice e l’atto acquista immediatamente efficacia di titolo esecutivo. Idem dicasi per l’accordo raggiunto
in sede di negoziazione assistita e sottoscritto dalle parti e dagli avvocati. Sia la mediazione, sia la
negoziazione assistita sono due forme di risoluzione stragiudiziali che possono essere obbligatorie o
facoltative.
I nn. 2) e 3) dell’art. 474 fanno riferimento ai titoli esecutivi stragiudiziali. Essi sono: le scritture private
autenticate (o riconosciute o verificate), relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie in esse contenute –
non possono essere utilizzate, ad es. per ottenere il rilascio di un immobile –, le cambiali e gli altri titoli di
credito (assegni bancari, assegni circolari, ecc.) ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia.
Infine, gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli (atto pubblico).
L’ultimo comma della norma specifica che l’esecuzione forzata per consegna di un bene mobile o per
rilascio di un bene immobile può avere luogo solo in virtù di titoli esecutivi giudiziali o stragiudiziali, ma
rappresentati da un atto pubblico. Questo è molto importante per capire quale tipo di esecuzione forzata può
essere supportata da un determinato titolo esecutivo, perché anche questo è un problema di cui ci dovremo
occupare quando tratteremo delle opposizioni del debitore.
La spedizione in forma esecutiva. Vi sono alcuni tipi di titolo esecutivo che per poter essere utilizzati come
titolo esecutivo devono essere spediti in forma esecutiva. Questa espressione significa semplicemente che
necessitano l’apposizione di una particolare formula (molto rétro) su una copia autentica del titolo esecutivo:
“Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione
il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, a tutti gli ufficiali della forza pubblica di
concorrervi quando ne siano legalmente richiesti”. Non tutti i titoli esecutivi richiedono la spedizione in
forma esecutiva. Questa regola, prevista dall’art. 475, riguarda solo i titoli esecutivi giudiziali e quelli
costituiti da atti pubblici. Questo perché l’originale dell’atto resta presso il soggetto che l’ha formato (presso
la cancelleria o presso i repertori del notaio).
La copia autentica può e deve essere una sola (art. 476), quindi la spedizione in forma esecutiva può
riguardare un’unica copia autentica del titolo esecutivo. La ratio si rinviene nella necessità di evitare che il
creditore si procuri tante copie e inizi tanti procedimenti esecutivi contro lo stesso debitore. Naturalmente in
presenza di circostanze di particolari gravità può essere rilasciata una seconda (o una terza) copia in forma
esecutiva, previa richiesta al capo dell’ufficio che ha pronunciato il provvedimento giudiziario o al
presidente del tribunale nella cui circoscrizione l’atto è stato formato. È importante ricordare che il
cancelliere o il notaio, nel caso in cui contravvengano al divieto di rilascio di più di una copia, possono
essere condannati a una pena pecuniaria compresa tra €1.000 e €5.000, con decreto del capo dell’ufficio o
del presidente del tribunale.
Il secondo comma dell’art. 475 riguarda le modificazioni dal lato soggettivo sia dal lato del creditore, sia dal
lato del debitore. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale
fu pronunciato il provvedimento, o ai suoi successori. Qui si fa genericamente riferimento a tutti i successori
per atto inter vivos o mortis causa del creditore, senza distinguere a seconda del tipo di successione. Se,
invece, consideriamo l’art. 477, che riguarda gli eredi, vediamo che “Il titolo esecutivo contro il defunto ha
efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione
del titolo”. Sembrerebbe che il titolo esecutivo, dal lato passivo, sia trasmissibile solo agli eredi, quindi ai
successori mortis causa a titolo universale. Si nota un’apparente contraddizione tra il regime del soggetto
attivo e quello del soggetto passivo. In realtà, si dice che anche per il debitore si dice che trova applicazione
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
l’art. 111 del codice, che riguarda la successione a titolo particolare nel diritto controverso nel processo di
cognizione. Attraverso questa interpretazione si viene a riequilibrare la posizione dei due soggetti. Quando la
successione avviene nel corso del processo esecutivo, alla successione universale si applica l’art. 110, mentre
per la successione a titolo particolare il problema è più controverso ed è stato risolto dalla dottrina.
Gli atti preliminari o prodromici.
Sono la notificazione del titolo esecutivo e il precetto. Essi sono collocati prima dell’inizio vero e proprio
dell’esecuzione forzata. Lo deduciamo dall’art. 482 (termine ad adempiere), il quale afferma che “non si può
iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto”, nonché dall’art. 491,
sull’inizio dell’espropriazione, che afferma che essa inizia con il pignoramento.
Queste notificazioni possono avvenire separatamente o congiuntamente e devono essere fatte personalmente
al debitore. È importante sottolineare questa cosa perché, se si tratta di sentenza di condanna, la notificazione
fatta al difensore per la decorrenza dei termini di impugnazione, non vale anche per l’esecuzione forzata.
Ricordiamo che il termine breve dell’impugnazione è quello che decorre dalla notificazione (30 giorni per
l’appello e per la revocazione ordinaria, 60 giorni per il ricorso per cassazione), mentre il termine lungo
decorre indipendentemente dalla notificazione della sentenza e consiste in sei mesi dalla pubblicazione della
sentenza stessa. Decorso il termine lungo, la proposizione dell’impugnazione non è più possibile.
L’atto di precetto.
L’art. 480 dà una nozione di atto di precetto, il quale consiste in una intimazione ad adempiere l’obbligo
risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione attraverso
la quale questo termine può essere ridotto, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad
esecuzione forzata. È una sorta di ultimatum che il creditore rivolge al debitore. Se il debitore non adempie
comunque, il creditore è legittimato ad intraprendere l’azione esecutiva.
Il comma 2 elenca una serie di requisiti che il precetto deve contenere a pena di nullità: indicazione delle
parti, data della notificazione del titolo esecutivo o la trascrizione del titolo stesso, la dichiarazione di
residenza o l’elezione del domicilio del creditore, in mancanza della quale gli atti dell’ufficio o le
opposizioni del creditore si proporranno dinanzi al giudice del luogo in cui il titolo è stato notificato e le
notificazioni alla parte istante si faranno presso la cancelleria di questo stesso giudice. Vi è poi un altro
requisito, aggiunto di recente, di cui non è certa la natura, nel senso che si discute se la mancanza di esso
integri nullità o una mera irregolarità: si tratta dell’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un
organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla
situazione di sovra indebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o
proponendo un piano di composizione del consumatore. Sovra indebitamento è la situazione del soggetto che
si trovi ad avere una quantità di debiti tali da non poter far fronte a questa situazione. I soggetti che possono
utilizzare questo tipo di procedura dispensata dagli organismi di composizione delle crisi da sovra
indebitamento sono tutti i soggetti che non possono avvalersi di procedure fallimentari (consumatore,
imprenditore agricolo, piccolo imprenditore, ecc.). Come specifica l’art. 480 l’intervento dell’organismo può
aiutare il debitore ad elaborare un piano di rientro, che consiste in una rateizzazione. Il ricorso a questi
organismi funziona solo quando oggetto dell’obbligazione sia una somma di denaro.
Un problema abbastanza discusso è quello relativo alla sottoscrizione del precetto. L’ultimo comma dell’art.
480 prevede che il precetto debba essere sottoscritto a norma dell’art. 125. Quest’ultima norma disciplina il
contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte, affermando che, salvo diversa disposizione di legge, la
citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto devono indicare l’ufficio giudiziario, le parti,
l’oggetto, le ragioni della domanda e, tanto nell’originale, quanto nelle copie da notificare, debbono essere
sottoscritti dalla parte – se essa sta in giudizio personalmente –, oppure dal difensore. A basarsi strettamente
su questa norma, sembrerebbe che anche il precetto debba essere sottoscritto dal difensore della parte. È
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
comunque opinione corrente che non sia obbligatoria la sottoscrizione del difensore, con la conseguenza che
la l’assistenza tecnica è meramente facoltativa.
Nel facsimile di precetto si può notare una parte relativa al conferimento di una procura all’avvocato, quindi
si tratta di un atto elaborato da un difensore.
Il precetto è un atto a tempo: diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non
è iniziata l’esecuzione (c.d. perenzione del precetto).
L’ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE.
Riguarda le obbligazioni pecuniarie. Il nostro ordinamento conosce vari tipi di espropriazione, i quali hanno
discipline articolate diversamente a seconda che i beni che il creditore deve aggredire siano mobili, immobili
o crediti.
Dell’espropriazione forzata il legislatore si occupa inizialmente con una serie di norme generali, non
differenziate, a cui fanno poi seguito le disposizioni particolari.
Per quanto riguarda le norme generali, la prima norma che troviamo è l’art. 483, che prevede il cumulo dei
mezzi di espropriazione: il creditore può avvalersi cumulativamente dei mezzi di espropriazione previsti
dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice può limitare l’espropriazione al mezzo che ritiene più
opportuno, oppure chiedere al creditore di scegliere tra i mezzi inizialmente esperiti.
L’art. 484 afferma che l’espropriazione è diretta dal giudice dell’esecuzione, nominato dal presidente del
tribunale su presentazione, a cura del cancelliere, del fascicolo d’ufficio. La norma sembra riguardare solo
l’espropriazione. In realtà riguarda tutte le forme di esecuzione (anche quella in forma specifica), perché in
tutti i casi abbiamo un giudice dell’esecuzione. Si applicano le disposizioni degli artt. 174 e 175. Si tratta
delle norme che disciplinano la figura del giudice istruttore (che esiste solo nei casi in cui opera la riserva di
collegialità), mentre oggi la maggior parte delle cause è decisa dal giudice monocratico. L’art. 174 riguarda
la tendenziale immutabilità del giudice istruttore, mentre l’art. 175 parla della direzione del procedimento ad
opera del giudice istruttore, che esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del
procedimento. In realtà questa norma non ha applicazione diretta nell’ambito del processo esecutivo. La
fissazione di udienze successive non ha molto senso, perché le udienze, nel caso dell’espropriazione, sono
previste espressamente dal legislatore (idem dicasi per i termini).
L’art. 485 riguarda l’audizione degli interessati. Nel processo esecutivo il principio del contraddittorio non
ha la stessa espansione che ha nel processo di cognizione. In effetti, la norma prevede che, quando la legge lo
richiede o il giudice lo ritiene necessario, può essere disposto che le parti o eventuali terzi siano sentiti. La
norma è probabilmente in contrasto con quanto previsto dall’art. 111 Cost. sul giusto processo e sul principio
del contraddittorio. Silvestri non è d’accordo perché ritiene che la procedura esecutiva abbia una struttura
diversa rispetto al processo di cognizione e, in virtù di questa struttura particolare, lo spazio lasciato al
contraddittorio non possa essere il medesimo spazio che il contraddittorio deve trovare nel processo di
cognizione.
Per quanto riguarda le altre norme generali è interessante notare che gli artt. 486 e 487 si occupano delle
domande e delle istanze che possono essere poste al giudice tendenzialmente in forma orale all’udienza o
con la forma del ricorso, nonché della forma dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione, che hanno in
genere la forma dell’ordinanza (in base ai principi generali sempre modificabile o revocabile, almeno fino a
quando il provvedimento non ha avuto esecuzione). Alcune delle ordinanze del giudice dell’esecuzione
possono avere contenuto decisorio, ma la loro efficacia è meramente endoprocessuale.
Il richiamo all’art. 176 riguarda la conoscenza ad opera delle parti del provvedimento che si dà per
conosciuto soprattutto se è pronunciato in udienza. L’altro richiamo è all’art. 186, ed è relativo alla
pronuncia dei provvedimenti ad opera del giudice dell’esecuzione: essi possono essere pronunciati in udienza
o, previa riserva, entro un termine molto breve di cinque giorni.
Le norme successive parlano del fascicolo dell’esecuzione.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
Il luogo della notificazione delle comunicazioni è quello della residenza dichiarata o del domicilio eletto o, in
mancanza, presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione.
L’art. 490 è una delle norme inserite attraverso le molte modificazioni apportate alla disciplina
dell’espropriazione e riguarda le forme di pubblicità che sono richieste per taluni tipi di espropriazione. Si
prevede l’affissione di un avviso nel Portale delle vendite pubbliche.
Finalità primaria dell’espropriazione è quella di aggredire il patrimonio del debitore, tendenzialmente
convertirlo in denaro liquido, e con quel denaro soddisfare le esigenze del creditore. Per questo motivo le
fasi dell’espropriazione sono: il pignoramento, quindi l’aggressione e l’apposizione di un particolare
vincolo giuridico sui beni del creditore, la vendita forzata dei beni o l’assegnazione e infine la
distribuzione del ricavato tra il creditore procedente e gli altri creditori eventualmente intervenuti in quella
procedura.
Dobbiamo ricordare il fondamento della espropriazione. Esso si ritrova nel diritto sostanziale, in
particolare nell’art. 2740 relativo alla responsabilità patrimoniale del debitore. Secondo questa norma il
debitore risponde di tutte le sue obbligazioni con i propri beni, presenti e futuri. Andando nel dettaglio, nel
codice civile incontriamo norme che si riferiscono direttamente all’espropriazione, in particolare, gli artt.
2910 e 2911. Secondo la prima norma, il creditore per conseguire quanto gli è dovuto può far espropriare i
beni del debitore secondo le regole stabilite nel codice di procedura civile. Possono essere espropriati anche i
beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia di un credito o quando sono oggetto di un atto che è stato
revocato perché compiuto in pregiudizio di un creditore. Qui facciamo riferimento all’azione revocatoria, che
riguarda appunto atti compiuti fraudolentemente in pregiudizio delle ragioni del creditore. L’art. 2911 (“beni
gravati da pegno o ipoteca”) aggiunge che il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare
altri beni se non sottopone ad esecuzione anche i beni gravati da pegno. Non può parimenti, quando ha
ipoteca, pignorare altri immobili se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati da ipoteca.
Il pignoramento. Per quanto riguarda l’atto che dà inizio all’espropriazione, l’art. 491 afferma che, salvo
l’ipotesi di cui all’art. 502, l’espropriazione forzata si inizia con il pignoramento.
La disciplina del pignoramento è contenuta nell’art. 492. La norma è stata rimaneggiata più volte e, a parte i
primi due commi, è molto confusa e complessa. Il pignoramento è atto dell’ufficiale giudiziario (comma 1):
consiste in un’ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del
credito indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i loro frutti. Questo schema generale può
subire variazioni in relazione al tipo di pignoramento (mobiliare, immobiliare o di crediti). In sostanza
comunque il nucleo fondamentale del pignoramento è questa che vieta di compiere atti diretti a limitare la
garanzia patrimoniale del debitore. Il secondo comma afferma che il pignoramento deve contenere poi
l’invito rivolto al debitore ad effettuare, presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione, la dichiarazione di
residenza o l’elezione di domicilio, allo scopo di evitare che le notificazioni e le comunicazioni gli siano
fatte presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione.
Prima di proseguire con l’analisi dell’art. 492 è necessario comprendere quali sono i modi per evitare il
pignoramento. Qui vengono in considerazione, anzitutto, le ipotesi previste dall’art. 494. Il debitore può
evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo
delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore. Quindi, sostanzialmente, un modo per evitare
l’espropriazione è saldare il debito. L’ultimo comma di questo articolo prevede un’ipotesi ulteriore – questa
volta per evitare il pignoramento di cose –: il debitore deve depositare nelle mani dell’ufficiale giudiziario, in
luogo delle cose che stanno per essere pignorate, una somma uguale all’importo del credito per cui si
procede e delle spese, aumentato di due decimi.
A pignoramento avvenuto, invece, è necessario ritornare all’art. 492, il cui terzo comma riguarda un
particolare avvertimento che deve essere contenuto nel pignoramento. Questo avvertimento riguarda la
possibilità che, dopo il pignoramento, il debitore possa chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati
una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensiva
del capitale, degli interessi e delle spese. Questo avvertimento va messo temporalmente in una posizione
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
diversa rispetto alle ipotesi previste dall’art. 494, perché non è una possibilità di sottrarsi al pignoramento,
ma di ottenere una conversione di esso. Conversione che più specificamente è disciplinata dall’art. 495. È
importante ricordare che questo tipo di possibilità deve essere oggetto di uno specifico avvertimento
contenuto nel pignoramento.
L’art. 492, al quarto comma, stabilisce che quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni
assoggettati a pignoramento i beni appaiono insufficienti o di lunga e complessa liquidazione, l’ufficiale
giudiziario invita il debitore a indicare ulteriori beni utilmente pignorabili. Un’altra ipotesi è prevista dal
comma successivo. Si tratta dell’ipotesi di insufficienza di beni pignorati a seguito dell’intervento di ulteriori
creditori. In questo caso il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi
dei commi precedenti, quindi che l’ufficiale giudiziario si attivi richiedendo al debitore l’indicazione di altri
beni pignorabili. Il sesto comma presenta l’ipotesi del debitore-imprenditore commerciale: l’ufficiale
giudiziario chiede al debitore che gli indichi il luogo in cui sono tenute le scritture contabili, provvede a
nominare un commercialista o avvocato per l’esame delle scritture contabili per la ricerca di ulteriori beni
pignorabili.
La ricerca dei beni pignorabili può avvenire con modalità telematiche. Il presidente del tribunale può
autorizzare, ai sensi dell’art. 492bis, l’ufficiale giudiziario ad effettuare una ricerca di ulteriori beni
pignorabili facendo appello alle banche dati, in particolare quella dell’Agenzia delle Entrate.
L’art. 493 presenta la possibilità che su un unico bene vi siano più pignoramenti operati da creditori diversi,
oppure che più creditori si mettono insieme per compiere un solo pignoramento. Se il bene è oggetto di
pignoramenti successivi, i singoli pignoramenti mantengono la loro identità anche se riuniti in un unico
procedimento. Ciò significa che l’eventuale caducazione di un pignoramento non fa perdere efficacia anche
agli altri.
Il pignoramento ha un’efficacia temporale limitata: decorsi 45 giorni, se non sono compiuti atti successivi
del procedimento, in particolare se il creditore procedente non ha chiesto la vendita dei beni pignorati o
l’assegnazione di essi, il pignoramento perde efficacia e dovrà essere eventualmente ripetuto.
Tornando alla conversione del pignoramento, essa è la sostituzione alle cose o ai crediti pignorati di una
somma di denaro. Questa somma di denaro viene determinata nel suo importo dal giudice dell’esecuzione e,
se si tratta di una somma ingente, è anche possibile la rateizzazione. Tuttavia, il mancato versamento anche
di una sola rata o il ritardo di più di trenta giorni nel versamento di essa fa sì che le somme, anche già
versate, formino parte dei beni pignorati. Di fatto è come se venisse meno la conversione del
pignoramento.
L’art. 496 presenta poi l’ipotesi della riduzione del pignoramento, che si ha quando il valore dei beni
pignorati supera l’importo delle spese e dei crediti. In questo caso il giudice può disporre, sentito il creditore
pignorante e quelli intervenuti la riduzione.
Gli effetti sostanziali del pignoramento. Il pignoramento consiste nell’ingiunzione al debitore di astenersi
da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati a pignoramento. Il
pignoramento crea sui beni pignorati un vincolo giuridico molto particolare. Esso non priva il debitore della
titolarità del bene e nemmeno del potere di disporne; tuttavia, rende i suoi atti del tutto privi di effetto nei
confronti del creditore (artt. 2913 e 2914 c.c.). Si tratta quindi di atti che tra il debitore e il terzo acquirente
sono perfettamente validi, ma non lo sono nei confronti del creditore (inefficacia relativa). Questa
specificazione è importante perché, nel caso di pignoramento inefficace o nel caso di estinzione del
procedimento esecutivo, l’atto di disposizione riacquista l’efficacia erga omnes. Questo discorso si biforca
sia a seconda del tempo in cui è stato effettuato l’atto di disposizione, sia dell’oggetto dell’atto di
disposizione. Per quanto riguarda i beni immobili si deve infatti far riferimento alla trascrizione: ciò che fa la
differenza è infatti la data della trascrizione: se il pignoramento è stato trascritto prima della data di
trascrizione dell’atto di disposizione si verifica il fenomeno di inefficacia relativa. Per quanto riguarda i beni
mobili vale la regola del possesso vale titolo (art. 1153). Rispetto a questo vincolo si dice che esso è un
vincolo “a porta aperta”, in quanto di questa inefficacia relativa beneficiano sia il creditore procedente, sia
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
i creditori intervenuti, a differenza che nel sequestro conservativo in cui del medesimo vincolo beneficia solo
il creditore sequestrante.
Di recente è stata aggiunta una ulteriore norma che riguarda gli effetti del pignoramento. Si tratta dell’art.
2929bis, la quale afferma che, se il debitore, dopo il sorgere del debito, compie sui suoi beni immobili o
mobili registrati un atto di disposizione a titolo gratuito, l’atto è ope legis inefficace se la trascrizione di
questo stesso atto è avvenuta successivamente alla trascrizione del pignoramento. C’è quindi una
presunzione di volontà del debitore di sottrarre al creditore questo bene. La regola dell’inefficacia dell’atto e
la conseguente possibilità del creditore di assoggettare il bene a pignoramento riguarda anche l’ipotesi in cui
il bene sia stato trasferito ad un terzo dal soggetto che è risultato beneficiario dell’atto di disposizione a titolo
gratuito. La parte interessante della norma si rinviene nel fatto che il terzo può contestare le iniziative del
creditore proponendo opposizione all’esecuzione.
La trascrizione è lo strumento attraverso il quale si rendono pubbliche le vicende di beni immobili o mobili
registrati. Questo spiega perché quando il pignoramento cade su questi beni bisogna fare riferimento a questo
istituto (art. 2652 e ss.).
La par condicio creditorum applicata al processo esecutivo. L’art. 2741 afferma che tutti i creditori hanno
diritto di soddisfarsi sui beni del debitore, salvo le c.d. cause legittime di prelazione. Si dice che la par
condicio creditorum è un’applicazione pratica del principio della responsabilità patrimoniale, secondo il
quale il debitore risponde delle obbligazioni contratte con tutti i suoi beni, presenti e futuri (art. 2740). In
dottrina si è molto discusso sul significato dell’art. 2741. La cosa importante è che la posizione dei creditori
è qualificata a seconda che il credito sia assistito o meno da una causa legittima di prelazione (pegno, ipoteca
e privilegi), oppure no. In caso positivo, la posizione del creditore è rafforzata rispetto a quella dei c.d.
creditori chirografari.
Questo principio interagisce con la struttura dell’esecuzione forzata quando un debitore ha più creditori. In
questo caso possiamo avere varie ipotesi: ogni creditore può intraprendere iniziative individuali pignorando
il medesimo bene o beni diversi del debitore, nel primo caso i vari pignoramenti rimangono autonomi.
L’ipotesi più frequente è però quella in cui, iniziata l’espropriazione dal creditore procedente, gli altri
creditori intervengono nello stesso procedimento.
Il legislatore non contempla una informativa generale a tutti i creditori. Tuttavia ci sono delle eccezioni.
L’art. 498 contempla l’avviso ai creditori iscritti: i titolari di un diritto di prelazione risultante da pubblici
registri hanno diritto di essere informati dell’inizio dell’espropriazione, in modo da favorire la loro
partecipazione nella forma dell’intervento. La ratio di questo avviso è molto semplice: l’effetto purgativo
della vendita forzata. Quando c’è una vendita forzata, il bene viene venduto libero da qualunque vincolo.
Attraverso l’avviso il creditore viene posto in condizione di partecipare alla procedura espropriativa,
soddisfacendo le proprie ragioni. A ciascuno dei creditori iscritti deve essere notificato, a cura del creditore
pignorante, entro cinque giorni, un avviso che contiene l’indicazione del creditore pignorante, del credito per
cui si procede, del titolo e delle cose pignorate. La sanzione nel caso in cui non venga rispettato l’avviso è
data dall’impossibilità a procedere sull’istanza di assegnazione o vendita.
L’art. 499 tratta dell’intervento dei creditori nell’istanza posta dal creditore procedente. La legittimazione
all’intervento riguarda solo i creditori di uno stesso debitore e non tutti, solo particolari tipi di creditori. La
versione vigente, del 2005, è considerata da parte della dottrina lesiva della par condicio creditorum. I
creditori legittimati sono: i creditori che hanno il possesso di un titolo esecutivo (c.d. creditori titolati); i
creditori privi di titolo esecutivo, ma che avevano già eseguito precedentemente un sequestro conservativo; i
creditori privi di titolo esecutivo, ma con un diritto di pegno o di prelazione iscritto in pubblici registri;
infine, i creditori privi di titolo esecutivo, il cui credito è un credito di somme di denaro risultanti dalla tenuta
di scritture contabili obbligatorie ex art. 2214.
Per quanto riguarda la forma e il tempo dell’intervento si fa riferimento al secondo comma dell’art. 499:
l’intervento si realizza mediante ricorso. Il tempo varia a seconda del tipo di espropriazione. Nella prima
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
parte del secondo comma, tuttavia, si specifica che l’intervento deve comunque avvenire prima dell’udienza
in cui è disposta la vendita o l’assegnazione. La tardività o la tempestività rileva solo per i creditori
chirografari, perché i creditori che abbiano una causa legittima di prelazione passano comunque davanti ai
chirografari nella fase satisfattiva.
Se sono intervenuti tempestivamente più creditori chirografari, il creditore procedente ha facoltà di indicare
loro ulteriori beni pignorabili (art. 499.4). La ratio di questa regola è data dal fatto che più sono i creditori,
più è necessario che la somma ricavata dalla vendita forzata sia elevata.
Per quanto riguarda gli effetti dell’intervento, vi è una grande differenza tra i creditori muniti di titolo
esecutivo e quelli che non lo hanno. L’art. 500, infatti, stabilisce che soltanto i primi hanno potere di
provocare atti del procedimento, quindi ad esempio, proporre istanza di vendita o assegnazione, in caso di
inerzia del creditore procedente. Indipendentemente dal possesso del titolo esecutivo, l’intervento dà diritto a
partecipare alla distribuzione della somma ricavata.
I creditori privi di titolo esecutivo. Possono intervenire nella espropriazione, ma hanno l’onere di notificare
al debitore entro dieci giorni dal deposito del ricorso con il quale hanno esperito intervento una copia del
ricorso stesso. La posizione del creditore viene verificata in apposita udienza. questo perché, a differenza dei
possessori di titolo esecutivo, per questi non vi è certezza della esistenza del credito. L’art. 499.5 prevede che
il giudice fissi un’udienza di comparizione dinanzi a se del debitore e dei creditori sprovvisti di titolo
esecutivo. Se il debitore non compare, i crediti si hanno per riconosciuti de plano, anche se il riconoscimento
vale solo ai fini della procedura esecutiva in corso. Se il debitore compare all’udienza riconoscendo i crediti,
l’effetto è il medesimo. Se il debitore compare e disconosce in tutto o in parte il credito, il creditore ha diritto
solamente all’accantonamento della somma che gli spetterebbe a due condizioni: deve farne istanza; nei
trenta giorni successivi dimostri di aver intrapreso le iniziative necessarie per procurarsi il titolo esecutivo.
L’art. 510.3 tratta dell’accantonamento. L’accantonamento ha un termine massimo di tre anni. Decorso il
termine fissato dal giudice (o il termine fissato dalla legge), su istanza di una delle parti o anche d’ufficio, il
giudice dispone davanti a sé la comparizione del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti,
ad eccezione di quelli che siano stati integralmente soddisfatti. A questo punto occorrerà vedere se il
creditore intervenuto in assenza ti titolo esecutivo se lo è procurato. Se così non è, la somma accantonata
riconfluisce nella somma totale e se ne giovano gli altri creditori che sono riusciti a procurarsi il titolo
esecutivo. Se vi è un residuo, questo deve essere restituito al debitore.
Alcuni autori ritengono che la disciplina sia fortemente lesiva della par condicio perché opera una profonda
distinzione tra creditori provvisti di titolo e non.
La liquidazione dei beni assoggettati a pignoramento. Di norma avviene con vendita forzata o
assegnazione. L’assegnazione deve essere richiesta dal creditore procedente o da altro creditore provvisto di
titolo esecutivo, ma non può essere proposta se non sono decorsi almeno dieci giorni dal pignoramento (e
comunque entro quarantacinque giorni dall’efficacia di esso). Le forme della vendita forzata sono
sostanzialmente due: la vendita con incanto (o asta) e la vendita senza incanto. La prima si conclude in un
unico momento con offerte al rialzo rispetto a un prezzo base fissato dal giudice, con aggiudicazione del
bene al miglior offerente. La seconda consiste in una serie di offerte in busta chiusa, sempre facendo
riferimento a un prezzo base. In un’udienza fissata dal giudice si aprono le buste. Se il giudice ritiene di poter
realizzare un prezzo più alto, dispone un’asta tra le offerte migliori. La modalità preferita dal legislatore è
quella della vendita senza incanto, la quale si è rivelata la modalità più efficiente. Lo stesso art. 503 afferma
che l’incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene che la vendita con incanto può aver luogo
solo nell’ipotesi in cui il giudice ritenga di poter realizzare un prezzo superiore della metà rispetto al valore
del bene.
L’art. 504 afferma che, se la vendita è fissata in più lotti, deve interrompersi quando venga raggiunto
l’importo delle spese e dei crediti. È un’ipotesi che non si realizza mai nella pratica.
L’art. 164bis disp. att. segnala la sconfitta definitiva dell’ordinamento, prevedendo che, quando risulta che
non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del
presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.
L’alternativa alla vendita forzata è l’assegnazione. Questa può essere di due tipi: l’assegnazione satisfattiva,
disciplinata dall’art. 505, che si ha quando al creditore viene assegnata la proprietà di uno o più beni
pignorati (ma è tenuto al pagamento di un conguaglio se il valore del bene assegnato è superiore al suo
credito); l’assegnazione-vendita, disciplinata dall’art. 506, che viene richiesta da un creditore concorrente
con altri aventi diritto di prelazione anteriore al proprio: in questo caso, il valore dell’assegnazione può
essere superiore a quello effettivo delle cose assegnate. L’eventuale eccedenza deve essere depositata nelle
forme dei depositati giudiziari per essere distribuita tra il creditore assegnatario e gli altri creditori
eventualmente concorrenti.
Gli effetti sostanziali della vendita forzata. La vendita forzata è una vendita abbastanza diversa dal punto
di vista strutturale, da una vendita di diritto comune. Innanzitutto, il bene non è venduto dal proprietario, ma
dallo Stato. Va detto però che si tratta di una vendita che termina in capo al terzo acquirente, quindi è un
acquisto a titolo derivativo. L’art. 2919, effetto traslativo della vendita forzata, implica che è necessario che
il soggetto che è stato espropriato sia il proprietario legittimo del bene (salve le regole sul possesso di buona
fede nel caso di beni mobili). All’acquirente del bene in vendita forzata non sono opponibili gli stessi atti
che, a seguito del pignoramento, non erano opponibili al creditore procedente e ai creditori intervenuti. Qui si
fa riferimento agli atti di alienazione e disposizione compiuti dal debitore sui beni assoggettati a
pignoramento, che sono soggetti a inefficacia relativa (art. 2913). Tuttavia, può accadere che
successivamente l’acquirente della cosa espropriata subisca l’evizione. Si ha evizione quando un terzo
rivendica con successo la proprietà o un altro diritto reale su un determinato bene. In questo caso, secondo
l’art. 2921, l’acquirente della cosa espropriata può ripetere il prezzo, se il prezzo della cosa venduta non è
ancora stato distribuito, dedotte le spese, mentre se la distribuzione è già avvenuta può ripetere da ciascun
creditore la parte riscossa e dal debitore l’eventuale residuo. In ogni caso può sempre agire contro i creditori
per il risarcimento danni. L’ultimo comma dell’articolo esclude che l’acquirente possa ripetere il prezzo nei
confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile.
All’assegnazione si applicano le medesime disposizioni, in quanto compatibili. Siamo dispensati dallo studio
delle norme del codice civile che riguardano l’assegnazione forzata e i suoi effetti sostanziali.
La nullità del processo esecutivo. L’art. 2929 afferma che la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto
la vendita o l’assegnazione non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, salvo il caso di
collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto
hanno ricevuto per effetto dell’esecuzione. Questa norma ha dato vita a una serie di problemi interpretativi
molto complessi. Il riferimento agli atti esecutivi anteriori alla vendita ci fa capire che si tratta di nullità
puramente formali. La nullità di questi atti non incide sulla stabilità della vendita forzata. Le nullità degli atti
esecutivi possono essere fatte valere con le opposizioni agli atti esecutivi (parentesi del processo di
cognizione). Ci si è posti il problema se la regola della stabilità degli effetti della vendita forzata valga anche
per nullità diverse da quelle formali. L’opinione prevalente è che neppure questi tipi di vizi incidano sulla
vendita e sulla sua stabilità, perché la tendenza è quella di tutelare il più possibile il terzo acquirente e quindi
gli effetti della vendita che egli ha compiuto. Questo anche per stimolare la partecipazione alle procedure
esecutive e in particolare a quelle di vendita forzata, che rischierebbero di andare deserte se il terzo
acquirente non fosse in qualche modo tutelato rispetto alla stabilità della vendita stessa.
La distribuzione della somma ricavata. L’art. 509 tratta della composizione della somma ricavata,
affermando che la somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle
cose vendute o assegnate (vendita forzata), di rendita o provento delle cose pignorate (eventuali frutti), di
multa e risarcimento di danno da parte dell’aggiudicatario (versamento del prezzo ad opera del terzo che
acquista o si aggiudica il bene).
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
La distribuzione è particolarmente semplice se vi è un solo creditore, mentre si complica se i creditori sono
diversi. Le ipotesi sono due: se la somma è sufficientemente elevata per consentire il soddisfacimento di tutti
nulla quaestio; se essa non è sufficiente occorre che il giudice proceda alla redazione di un piano di riparto
in cui i creditori verranno collocati a seconda del possesso di cause legittime di prelazione e, se chirografari,
a seconda che abbiano compiuto un intervento tempestivo o tardivo. Può anche accadere che il piano di
riparto venga concordato dagli stessi creditori.
Proprio nell’ambito della redazione del piano di riparto è probabile che sorgano controversie tra i creditori,
oppure tra i creditori e il debitore sulla sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza o
meno di un diritto di prelazione. Questo tipo di controversie deve essere risolto dallo stesso giudice di
esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti (art. 512). Il giudice provvede con ordinanza
impugnabile nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi e può, con la stessa ordinanza sospendere, in
tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata. L’opposizione si conclude in un unico grado con
sentenza che non è appellabile, ma è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione. Questo tipo di
giudizio affidato al giudice dell’esecuzione implica un elemento di cognizione, in quanto il giudice deve
raccogliere le informazioni necessarie per capire se la contestazione di un creditore rispetto alla sua
posizione nel piano di riparto è fondata o infondata. Questa cognizione ha efficacia solamente
endoprocessuale. Al di fuori di questa specifica procedura esecutiva è possibile da parte del creditore che
aveva avanzato contestazione, instaurare un giudizio per contestare il fatto che un altro creditore intervenuto
abbia intervenuto abbia effettivamente un diritto di prelazione.
I vari tipi di espropriazione.
La costruzione dell’espropriazione voluta dal legislatore è complessa, in quanto comprensiva di una serie di
disposizioni di carattere generale, unitamente a una serie di disposizioni speciali, che distinguono vari tipi di
espropriazione in funzione della natura dei beni espropriati.
La disciplina specifica delle varie forme di espropriazione è particolarmente complessa, perché rimaneggiata
in particolare negli ultimi anni dal legislatore.
A complicare le cose in maniera molto più accentuata contribuisce il fatto che i recenti interventi legislativi
hanno creato spesso norme complesse e farraginose.
Restano ferme le disposizioni generali.
L’espropriazione mobiliare presso il debitore.
Questo tipo di espropriazione ha per oggetto beni mobili appartenenti al debitore. Va sottolineato che,
proprio nel pignoramento mobiliare presso il debitore emerge in tutta la sua importanza il ruolo dell’ufficiale
giudiziario, perché in questo tipo di espropriazione è questi che provvede alla scelta dei beni sui quali creare
il vincolo del pignoramento. Naturalmente perché l’ufficiale giudiziario si metta in moto è necessaria
un’istanza del creditore. Dopodiché, però, è l’ufficiale giudiziario che, ai sensi dell’art. 513 provvede alla
ricerca delle cose da pignorare. Il primo comma chiarisce che l’ufficiale giudiziario, munito del titolo
esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui
appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore osservando le opportune cautele per rispettarne
il decoro. La dottrina sottolinea che i luoghi possono anche non appartenere al debitore, ma essere nella sua
disponibilità: esempio tipico è dato dall’autovettura che si trova in un garage di proprietà di un terzo, rispetto
al quale il debitore, in virtù di un contratto di locazione ha la disponibilità.
Nel caso concreto può rendersi necessario l’ausilio della forza pubblica.
Rispetto a questo tipo di espropriazione sussiste tutta una serie di limiti particolari. Il codice, infatti, all’art.
514 comprende una lunga lista di beni impignorabili. Questa lista riflette uno stato di fatto e una immagine
della società italiana che è quella degli anni quaranta (es. anello nuziale, vestiti, biancheria, cassettoni,
frigorifero, armi e oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservale per il pubblico servizio...). Interessanti
gli ultimi due numeri della norma (6bis e 6ter), che sono aggiunte estremamente recenti e riguardano gli
animali di affezione (cane, gatto, ecc.) e gli animali impiegati ai fini terapeutici.
Il codice prevede agli artt. 515 e 516 anche una lista di beni relativamente impignorabili, cioè dei beni che
in determinate circostanze di tempo e di fatto non possono essere pignorati. Il secondo comma dell’art. 516 è
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
la perfetta dimostrazione che la norma non è stata mai modificata perché parla della pignorabilità dei bachi
da seta solo quando sono sui rami per formare il bozzolo.
Più importante è l’art. 517, rubricato scelta delle cose da pignorare, che dà delle indicazioni all’ufficiale
giudiziario rispetto ai beni che è opportuno vengano fatti oggetto di pignoramento prima di qualunque altro:
gioielli, preziosi, titoli di credito, altri beni che appaiono di sicura realizzazione e, in generale, tutto ciò che
secondo l’ufficiale giudiziario appare di facile è pronta liquidazione.
È importante anche tenere conto dei limiti di tempo del pignoramento previsti dall’art. 519. Il pignoramento,
infatti, non può essere eseguito nei giorni festivi, né fuori dalle ore indicate dall’art. 147 (riguardante il
tempo delle notificazioni), salvo che ne sia data autorizzazione dal presidente del tribunale o da un giudice
da lui delegato. Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può, tuttavia, essere proseguito fino al suo
compimento.
La forma del pignoramento. Il pignoramento si compie oralmente e deve contenere l’ingiunzione di non
sottrarre i beni alla garanzia del credito più tutti gli altri avvertimenti e informative presenti nella disciplina
del pignoramento in generale (possibilità di conversione del pignoramento, possibilità di estendere il
pignoramento ad altri beni, ecc.). Della forma orale del pignoramento è necessario conservare traccia, quindi
l’ufficiale giudiziario redige processo verbale, ai sensi dell’art. 518, quindi dà atto dell’ingiunzione di cui
all’art. 492 e descrive le cose pignorate, avvalendosi di riproduzioni fotografiche.
L’art. 165 disp. att. afferma che il creditore può chiedere di partecipare personalmente o mediante
rappresentanza del difensore di fiducia al pignoramento.
In relazione al pignoramento sono importanti due fasi: la stima del valore del bene pignorato, stima alla
quale procede direttamente l’ufficiale giudiziario o uno stimatore nominato per l’occasione; le disposizioni
relative alla custodia di beni pignorati. Fermo restando che per gioielli e titoli di credito la custodia spetta al
cancelliere, per gli altri beni l’art. 520.2 provvede l’ufficiale giudiziario, su richiesta del creditore,
trasportandole presso un luogo di custodia o affidandole a un custode diverso dal debitore, sempre che,
trattandosi di beni deperibili, non sia necessario adottare altre disposizioni.
L’art. 521 stabilisce chi non può essere designato custode del bene pignorato. Sono esclusi il creditore o il
debitore o i coniugi, a meno che non ci sia l’autorizzazione dell’altro soggetto.
Gli obblighi del custode sono particolari: egli non può usare le cose pignorate senza l’autorizzazione del
giudice dell’esecuzione. La responsabilità del custode ha anche un aspetto penalistico, che è dato dall’aver
sottratto o distrutto le cose pignorate.
Importante è la nota di iscrizione a ruolo per la formazione del fascicolo d’ufficio. Il sesto comma dell’art.
518, stabilisce un termine di quindici giorni per il deposito della nota da parte del creditore presso la
cancelleria del tribunale. Al momento del deposito, il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio. Questa norma
si ricollega con l’art. 164ter disp. att., secondo il quale, quando il pignoramento è divenuto inefficace per il
mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla
scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato (onere di
informazione). In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo
non è depositata nei termini di legge. In sintesi, la cessazione di efficacia del pignoramento si verifica per
l’inutile decorso dei quarantacinque giorni (art. 497) senza l’istanza di vendita o assegnazione, oppure per il
mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo, in quest’ultimo caso con l’aggiunta di un onere di
informazione a carico del creditore.
L’intervento dei creditori. Secondo l’art.525 esso deve aver luogo non oltre la prima udienza fissata per
l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione, a meno che non si tratti della c.d. piccola espropriazione
(in cui il valore dei beni non supera i 20.000 euro), in cui l’intervento deve essere contestuale alla
presentazione del ricorso per la richiesta della vendita o dell’assegnazione.
Il problema della tempestività o tardività dell’intervento si pone solo per i creditori chirografari. Infatti, l’art.
528 afferma che i creditori che hanno un diritto di prelazione, anche se intervengono tardivamente,
concorrono comunque alla distribuzione della somma ricavata in ragione della loro prelazione.
Nel caso in cui vi sia un intervento, l’art. 527 fa riferimento alla possibilità per il creditore procedente di
indicare ai creditori intervenuti l’esistenza di altri beni del debitore pignorabili. Questo articolo è stato
abrogato nel 2005, ma la norma è integralmente riprodotta nelle disposizioni generali, al quarto comma
dell’art.499.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
Fase della vendita/assegnazione. La vendita è tendenzialmente senza incanto. Qui viene in considerazione
una forma di vendita particolare: la vendita a mezzo di commissionario. Secondo l’art. 1731 c.c. la
commissione è il contratto che ha ad oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in
nome del commissionario. Il commissionario è, tendenzialmente, un istituto vendite giudiziarie, che opera
come soggetto che compie materialmente la vendita in nome proprio ma per conto del committente, che in
questo caso è lo Stato nella persona dell’ufficiale giudiziario o del giudice dell’esecuzione.
Solo nel caso in cui la vendita senza incanto non dia esito positivo si procede alla vendita con incanto.
L’art. 534bis parla della delega alle operazioni di vendita, ma è più importante nell’ambito delle
espropriazioni immobiliari.
Altra norma interessante è l’art. 534ter, riguardante le possibili difficoltà che sorgono nel corso delle
operazioni di vendita. In questo caso è possibile rivolgersi direttamente al giudice dell’esecuzione che
provvede con decreto.
La distribuzione del ricavato. Per quanto riguarda la distribuzione, il dato interessante è la possibilità di
una distribuzione “amichevole” della somma ricavata. L’art. 541, infatti, prevede che, se i creditori
concorrenti chiedono la distribuzione secondo un piano di riparto concordato, il giudice dell’esecuzione
provvede, sentito il debitore.
Nel caso in cui l’accordo tra creditori o tra creditori e debitore non venga raggiunto, ogni creditore può
chiedere che si proceda alla distribuzione giudiziale.
L’espropriazione mobiliare presso terzi.
Si tratta di un procedimento molto complesso. Questa forma di espropriazione riguarda beni mobili del
debitore nella disponibilità di un terzo o, più di frequente, crediti che il debitore vanta nei confronti di un
terzo. Abbiamo quindi tre soggetti coinvolti: il creditore, il debitore principale e il terzo, che è a sua volta
debitore del debitore principale.
Per quanto l’esecuzione riguardi direttamente il debitore, il terzo è ovviamente coinvolto, in quanto il
creditore vuole soddisfare le sue ragioni sui beni o sul credito che il debitore ha nei confronti del terzo.
Tizio è creditore di Caio. Caio non ha beni utilmente assoggettabili a pignoramento, però è dipendente di
Apple. Lo stipendio mensile viene depositato sul conto di Caio. Tizio allora ricorre al pignoramento presso
terzi, ossia al procedimento che gli consente di soddisfare le proprie ragioni sulla somma che Apple, in
quanto datore di lavoro di Caio, deve a quest’ultimo.
I crediti possono anche non essere ancora esigibili, in quanto sottoposti a condizione o termine, o anche
futuri, purché derivanti da un rapporto preesistente.
Il pignoramento. Anche in relazione al pignoramento presso terzi, in particolare al pignoramento di crediti,
dobbiamo fare una distinzione tra crediti assolutamente impignorabili e crediti relativamente impignorabili.
I crediti assolutamente impignorabili sono quelli che in nessuna circostanza possono essere assoggettati a
pignoramento (art. 545, commi 1 e 2). Si tratta di: crediti alimentari, crediti aventi ad oggetto sussidi, di
grazia, di sostentamento, indennità di maternità, malattie, ecc.
Tra i crediti relativamente impignorabili vi sono ipotesi molto importanti che riguardano, ad esempio, le
somme dovute da privati a titolo di salario o di stipendio o di altra indennità. Si tratta di crediti pignorabili
solamente entro specifici limiti prefissati dal legislatore (art. 545).
Il pignoramento in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dall’articolo è parzialmente inefficace.
L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.
La struttura del pignoramento è particolarmente complicata. Il pignoramento ha, in questo caso, forma
scritta e consiste in un atto notificato al debitore e al terzo. Questo atto, ai sensi dell’art. 543 deve contenere
l’indicazione del credito, del titolo esecutivo e del precetto; le ingiunzioni e avvertimenti tipici del
pignoramento; l’indicazione almeno generica delle cose o somme dovute dal terzo al debitore e l’intimazione
al terzo di non disporne in assenza di ordine del giudice; la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio
nel comune in cui ha sede il tribunale; la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente
(quello del luogo di residenza del debitore stesso) in una apposita udienza.
L’art. 546, rubricato obblighi del terzo, stabilisce che, dal momento in cui gli è notificato l’atto di precetto,
il terzo è costituito custode dei beni o delle somme assoggettate a pignoramento. Al di là della definizione, il
dato significativo è che, quand’anche restituisse i beni al debitore principale o pagasse il suo debito al
debitore principale, non interverrebbe alcun effetto liberatorio. L’art. 2917 c.c. (estinzione del credito
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
pignorato), infatti, afferma che se oggetto del pignoramento è un credito, l’estinzione di esso per cause
verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei
creditori intervenuti nell’esecuzione.
Tornando alla struttura del pignoramento e alla parte del pignoramento che riguarda il terzo, la parte più
importante è l’invito a rendere una particolare dichiarazione che chiarisca qual è la sua posizione
debitoria, con l’avvertimento che, in caso di mancata comunicazione, questa stessa comunicazione dovrà
essere resa in apposita udienza. Se anche in udienza il terzo non compare o non rende dichiarazione, il
credito pignorato o il possesso delle cose si avranno per non contestati ai fini del procedimento de quo.
L’art. 547 stabilisce il contenuto della dichiarazione del terzo. Si tratta di una dichiarazione che deve
essere inviata al creditore procedente a mezzo raccomandata o PEC. Il terzo la può inviare personalmente o
tramite procuratore speciale e deve specificare di quali cose o somme è debitore nei confronti del debitore
principale o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Il terzo deve in
sostanza chiarire la sua posizione debitoria nei confronti del debitore principale. Le cose si complicano se il
terzo non invia al creditore la dichiarazione.
Abbiamo detto che il pignoramento deve contenere l’invito al debitore a comparire davanti al giudice
competente in una apposita udienza. Se in questa udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la
dichiarazione il giudice fissa un’udienza successiva. Se anche a questa seconda udienza il terzo non compare
o, pur comparendo, non rende dichiarazione, il credito pignorato si considera non contestato. Quindi molto
dipende dalla condotta del terzo.
Si procede all’esecuzione sia quando il terzo compaia in udienza e renda dichiarazione, sia nel caso in cui il
terzo non sia comparso o non abbia reso dichiarazione e il suo credito sia considerato non contestato
nell’ipotesi in cui le allegazioni del creditore consentano l’identificazione del credito o dei beni di
appartenenza del debitore in possesso del terzo. Il creditore deve infatti indicare, almeno genericamente, i
beni in possesso del terzo. Se l’indicazione è sufficientemente dettagliata e facilmente individuabile, anche
se il terzo non rende la dichiarazione o non compare, si può procedere ad esecuzione forzata.
La situazione è totalmente diversa nell’ipotesi di cui all’art. 549, quando a seguito di dichiarazione del terzo
sorgono contestazioni o se, nel caso di mancata dichiarazione del terzo non è possibile verificare l’esatta
identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo. Su istanza di parte il giudice
dell’esecuzione provvede all’accertamento della posizione del terzo nel contraddittorio tra le parti (creditore,
debitore principale e terzo). È una vera e propria parentesi di cognizione del giudice dell’esecuzione che
provvederà in materia con ordinanza impugnabile esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi.
L’opposizione non è soggetta ad appello, ma è esperibile ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art.
111 Cost.
L’accertamento della posizione del terzo non è dotato di autorità di cosa giudicata, quindi non può valere
erga omnes. Avendo efficacia esclusivamente endoprocessuale, al di fuori di quella procedura esecutiva la
posizione del terzo potrà essere contestata senza timore di incorrere in una eccezione di giudicato.
Il procedimento segue poi i consueti passaggi, assegnazione o vendita, alle quali si applicano le norme della
espropriazione mobiliare presso il debitore in quanto compatibili, nonché distribuzione della somma ricavata.
L’espropriazione immobiliare.
Il pignoramento. L’espropriazione immobiliare ha ad oggetto beni immobili. È un istituto particolarmente
complesso, soprattutto in alcune fasi. Trattandosi di beni immobili assoggettati a pignoramento è onere del
creditore verificare che nel patrimonio del debitore siano compresi beni immobili. In considerazione della
natura del bene il pignoramento nasce direttamente come atto scritto. Infatti, l’art. 555 afferma che il
pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto
nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l’individuazione
dell’immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa
l’ingiunzione prevista dall’art. 492. Gli elementi dell’atto di pignoramento immobiliare sono quindi due: la
notificazione al debitore e la trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari. La tesi migliore,
secondo Silvestri, è quella della efficacia costitutiva della trascrizione rispetto all’atto del pignoramento,
anche in considerazione dell’inefficacia relativa degli atti di disposizione compiuti dopo il pignoramento (in
taluni casi anche prima), in cui ciò che fa la differenza è la data della trascrizione.
Immediatamente dopo la notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell’atto con le note
di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari che trascrive l’atto e gli restituisce una
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
delle note. La nota di trascrizione è un elemento indispensabile per ottenere la trasposizione dell’atto nei
registri immobiliari.
Il codice ci parla della possibilità che, insieme ai beni immobili, siano espropriati – seppure con atti diversi –
i beni mobili che arredano l’immobile.
Per quanto riguarda l’art. 557 è particolarmente importante il primo comma. Secondo la norma, eseguita
l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la
nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il secondo comma poi dispone che
il creditore deve depositare in cancelleria tutta la documentazione per la formazione del fascicolo d’ufficio.
L’ultimo comma prevede la perdita di efficacia del pignoramento quando la nota di iscrizione al ruolo, le
copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di
quindici giorni dalla consegna al creditore. Ricordiamo il riferimento all’art. 164ter disp. att. che prevede
l’onere di informazione al debitore della perdita di efficacia del pignoramento.
Anche in relazione ai beni immobili si pone il problema della custodia del bene pignorato. In linea di
principio è lo stesso debitore che è costituito custode, salvo casi particolari in cui si ritenga opportuno
costituire un soggetto diverso. L’art. 560 ci fa comprendere che le modalità della custodia devono essere tali
da favorire la futura vendita forzata del bene. Infatti, al di là della previsione secondo cui il custode ha il
dovere di vigilare affinché il bene pignorato venga mantenuto in buono stato è soprattutto importante il
quarto comma, a norma del quale il debitore deve consentire, in accordo col custode – supponendo che sia
persona diversa – che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti.
L’intervento dei creditori. Anche per il pignoramento immobiliare possiamo avere l’intervento. Questo è
disciplinato dagli artt. 563 ss. Oggi, l’art. 563 (condizioni e tempi dell’intervento) non esiste più, in quanto si
fa riferimento alla normativa generale in tema di espropriazione forzata di cui agli artt. 499 e 500.
L’intervento non può avvenire oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita. Il tempo
dell’intervento per comprendere se l’intervento è tardivo o tempestivo è rilevante solo per i creditori
chirografari, in quanto quelli privilegiati sono anteposti comunque ai primi in sede di distribuzione.
La vendita forzata. È disciplinata in maniera molto dettagliata dal codice. Dal punto di vista generale
possiamo considerare l’art. 567, che ci dice che il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti
muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato. Chi richiede la vendita deve,
oltre a fare la relativa istanza, procurare e allegare all’istanza di vendita tutta la documentazione necessaria a
identificare l’immobile e ricostruire i vari passaggi di mano, le varie vicende dell’immobile. Tutto ciò è
molto importante, in quanto se la documentazione non è depositata nel termine o dopo un primo tentativo
non è integrata come richiesta dal giudice, il giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia
del pignoramento. Vediamo quindi un’altra ipotesi di perdita di efficacia del pignoramento, relativa solo al
pignoramento immobiliare, relativa a un dato formale, che è il mancato deposito della documentazione
richiesta per identificare l’immobile. L’inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice
dispone, con l’ordinanza, la cancellazione della trascrizione del pignoramento e dichiara l’estinzione del
processo esecutivo se non ci sono altri beni pignorati. Vediamo quindi una sorta di crescendo di sanzioni
messe in atto dall’inosservanza della disposizione.
Qualunque sia la forma della vendita si richiede che venga determinato da un esperto il valore dell’immobile,
tenendo ovviamente conto del valore di mercato (c.d. stima).
La vendita può, anche in questo caso, essere senza incanto o con incanto e il legislatore privilegia la prima.
L’art. 571, in relazione alle offerte d’acquisto, stabilisce che tutti – tranne il debitore – possono formulare
offerte relative all’acquisto dell’immobile pignorato, personalmente o a mezzo del proprio difensore. Sono
anche possibili le offerte per persona da nominare.
La vendita con incanto ha luogo solo quando il giudice ritiene che la vendita avverrà ad un prezzo migliore,
ossia ad un prezzo superiore rispetto alla metà del valore di stima. È quindi un’ipotesi eventuale e non molto
frequente. L’art. 584 – rubricato “Offerte dopo l’incanto” – stabilisce che, avvenuto l’incanto, possono essere
fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo
offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell’incanto. L’aggiudicazione dell’asta è quindi solo
provvisoria. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni, l’aggiudicazione si stabilizza.
Molto importante è l’art. 585 relativo al versamento del prezzo: esso deve essere versato nel termine e nel
modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita e deve consegnato al cancelliere il documento
comprovante l’avvenuto versamento. Il versamento è un elemento indispensabile per il perfezionamento
dell’acquisto. Lo si ricava dall’art. 587, secondo il quale, se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
giudice dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e
dispone un nuovo incanto.
L’art. 586 tratta del trasferimento del bene espropriato. Il trasferimento del bene espropriato al soggetto
che l’ha acquistato è disposto con decreto di trasferimento, che il giudice pronuncia ripetendo la descrizione
contenuta nell’ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti
e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall’aggiudicatario.
Ricordiamo che, in linea di principio, i creditori dello stesso debitore non sono avvisati dell’iniziativa del
creditore procedente, salvo i creditori iscritti, ad es. quelli con privilegi risultanti da pubblici registri. La ratio
dell’avviso è data dal fatto che, se la procedura esecutiva andasse avanti senza un avviso e si arrivasse ad una
vendita forzata perderebbero la garanzia sul bene. Perderebbero la garanzia sul bene pignorato in quanto
proprio questa norma ci dice che con la vendita forzata viene disposta la cancellazione di trascrizioni e
inscrizioni sul bene pignorato (c.d. effetto purgativo della vendita forzata). La disposizione ha la finalità
specifica di favorire la vendita forzata dei beni.
Le vendite forzate, nella prassi, molto spesso vanno deserte. Ormai però, indipendentemente dalla preferenza
del legislatore per la vendita senza incanto, la forma più comune di vendita forzata è quella che viene affidata
a specifici professionisti. Viene qui in rilievo la delega delle operazioni di vendita, che è entrata a far parte
del nostro ordinamento alla fine degli anni Novanta ed è stata negli anni potenziata, in particolare nel 2005.
La delega delle operazioni di vendita è disciplinata dall’art. 591bis e ss.
L’art. 591bis afferma che il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di
vendita, delega a un notaio, a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’art.
179ter disp. att., il compimento delle operazioni di vendita, fissando anche il termine entro il quale tali
operazioni devono essere concluse. I delegati alla vendita hanno poteri amplissimi e discrezionali: questo è
dimostrato dal lunghissimo elenco di poteri elencati dall’art. 591bis. Questi poteri sono talmente ampi da
comprendere, da un lato, la predisposizione del decreto di trasferimento, che interviene dopo la vendita,
anche se poi il sigillo di garanzia dovrà essere apposto dal giudice, e dall’altro la redazione del progetto di
distribuzione della somma ricavata, nonché la sua trasmissione al giudice dell’esecuzione.
Peraltro, l’art. 591ter prevede che, in caso di difficoltà, il professionista possa rivolgersi al giudice
dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Contro questo decreto è esperibile la procedura di reclamo,
come pure lo è contro gli atti del professionista delegato. Anche sul reclamo provvede il giudice
dell’esecuzione e, a sua volta, contro l’ordinanza pronunciata dal giudice dell’esecuzione sarà possibile un
ulteriore reclamo nella forma del reclamo cautelare.
Per quanto riguarda la distribuzione del ricavato, possiamo fare riferimento all’art. 596. La norma prevede
la predisposizione del progetto di distribuzione, redatto o dal giudice dell’esecuzione o, più di frequente,
dal delegato alla vendita. Il progetto deve essere depositato in cancelleria nella prospettiva di una apposita
udienza alla quale parteciperanno il debitore e i creditori e in cui si deciderà il da farsi, nel senso che viene
data loro la possibilità di consultare il progetto e di rendere noto il loro parere sulla accettabilità dello stesso.
È interessante notare che chi non compare all’udienza, approva il progetto per fatti concludenti.
L’espropriazione dei beni indivisi.
Il riferimento è a un bene rispetto al quale esistono più comproprietari, uno dei quali è il debitore, mentre gli
altri non hanno un rapporto di debito nei confronti del debitore procedente. In questo caso il pignoramento è
comunque possibile, ma ovviamente devono essere avvisati gli altri comproprietari. Lo si ricava dall’art.
599, secondo il quale possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono
obbligati verso il creditore. In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante,
anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte
delle cose comuni senza ordine del giudice. Tutti i comproprietari vengono, quindi invitati a comparire in
apposita udienza, rispetto alla quale dobbiamo fare riferimento all’art. 180 disp. att. Con l’avviso che viene
notificato ai comproprietari che non sono debitori del creditore procedente, il giudice dell’esecuzione fissa
anche apposita udienza, in relazione alla quale si deve procedere alla separazione della parte di cui e
proprietario il debitore, rispetto alla parte dei comproprietari che rimangono fuori dal rapporto obbligatorio.
Nulla quaestio se la separazione è possibile in natura. Se la separazione in natura non è possibile, occorre
ricorrere a un normale giudizio di divisione a norma del codice civile. Giudizio di divisione che è affidato al
giudice dell’esecuzione, quindi è una delle tante parentesi di cognizione all’interno del processo esecutivo. In
una situazione di questo genere, l’esecuzione rimane sospesa, ai sensi dell’art. 601, finché sulla stessa non
sia intervenuto un accordo tra le parti o sia stata pronunciata una sentenza di divisione giudiziale passata in
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
giudicato. Una volta intervenuta la sentenza sarà necessario riassumere il processo esecutivo, ipotesi che non
c’è nel caso in cui sulla separazione le parti abbiano raggiunto un accordo.
L’espropriazione contro il terzo proprietario.
Il riferimento è a due ipotesi: a) il bene è gravato da pegno o ipoteca per un debito altrui; b) i creditori hanno
esperito azione revocatoria nei confronti del debitore alienante e siano risultati vittoriosi. La prima ipotesi è
una conseguenza del c.d. diritto di sequela che caratterizza le garanzie reali, nel senso che il vincolo sul bene
si trasferisce in capo al terzo che ha acquistato il bene, quindi naturalmente è possibile che il terzo subisca
l’espropriazione. Nella seconda ipotesi, il trasferimento e dichiarato inefficace nei loro confronti e i creditori
possono pignorare il bene come se fosse del debitore.
Viene qui in considerazione l’art. 2929bis, riguardante gli atti di disposizione a titolo gratuito.
L’ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA.
La ratio sottesa a questo procedimento è quella di consentire al creditore di conseguire il bene o la
prestazione cui ha effettivamente diritto. L’esecuzione in forma specifica trova una disciplina nel codice
di procedura, ma anche un riferimento molto importante nel codice civile, in particolare negli artt. 2930-
2933.
L’art. 2930 si occupa della prima forma di esecuzione forzata in forma specifica che analizzeremo, che è
quella per consegna di un bene mobile determinato o rilascio di un bene immobile. La norma afferma
che se non è adempiuto l’obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l’avente diritto
può ottenere la consegna i il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.
La seconda forma di esecuzione forzata in forma specifica riguarda gli obblighi di fare e di non fare. Per gli
obblighi di fare l’art. 2931 dispone che, se non è adempiuto un obbligo di fare, l’avente diritto può ottenere
che esso sia eseguito a spese dell’obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile. Per gli
obblighi di non fare, invece, è l’art. 2933 a prevedere che, se non è adempiuto un obbligo di non fare,
l’avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell’obbligato, ciò che è stato fatto in violazione
dell’obbligo, a meno che la distruzione della cosa non arrechi pregiudizio all’economia nazionale.
L’esecuzione forzata per consegna o rilascio.
E probabilmente la forma più semplice di esecuzione forzata. L’oggetto è un bene mobile o immobile
determinato, bene di cui nel titolo esecutivo e nel precetto è necessario fornire una descrizione almeno
sommaria.
L’esecuzione per consegna. La procedura dell’esecuzione per consegna è di fatto molto semplice: l’ufficiale
giudiziario, con il titolo esecutivo e con il precetto si reca sul luogo in cui le cose si trovano, le ricerca e ne fa
consegna al creditore o alla persona da questi designata. Si tratta, quindi, di un procedimento interamente
affidato all’ufficiale giudiziario. Le norme che vengono in rilievo sono gli artt. 605 e 606. Va segnalato
anche l’art. 607 che riguarda il caso in cui le cose da consegnare sono oggetto di pignoramento — in tal caso
la consegna non può aver luogo —: il creditore dovrà far valere le sue ragioni mediante opposizione a norma
degli artt. 619 e ss.
L’esecuzione per rilascio. Per quanto riguarda il rilascio, esso ha ad oggetto un bene immobile. Tipico
esempio è quello della convalida di uno sfratto in capo al debitore: in questo caso l’immobile deve essere
liberato e il possesso deve essere reso disponibile al creditore.
In questo caso la procedura è più complessa: ai sensi dell’art. 608, almeno dieci giorni prima, l’ufficiale
giudiziario deve notificare al debitore tenuto a rilasciare l’immobile un avviso che indichi il giorno e l’ora in
cui si procederà. Nel giorno e nell’ora stabiliti l’ufficiale giudiziario si recherà sul posto e, avvalendosi anche
dei poteri lato sensu coercitivi immette la parte istante — o una persona da lei designata — nel possesso
dell’immobile. L’immissione nel possesso avviene attraverso la consegna delle chiavi dell’immobile.
Di recente è stato aggiunto al codice l’art. 609, che riguarda i provvedimenti circa i mobili estranei
all’esecuzione.
Gli artt. 610 e 611 riguardano sia l’esecuzione per la consegna, sia quella per rilascio.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
L’art. 610, rubricato “Provvedimenti temporanei”, stabilisce che se nel corso dell’esecuzione sorgono
difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere al giudice dell’esecuzione, anche
verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti. Deve trattarsi di difficoltà puramente materiali, i soli di
cui può occuparsi il giudice dell’esecuzione. Se si tratta di contestazioni relative all’esistenza del diritto di
procedere all’esecuzione forzata, questo articolo non si applica.
L’art. 611, rubricato “Spese dell’esecuzione”, afferma che nel processo verbale l’ufficiale giudiziario deve
specificare tutte le spese anticipate dalla parte istante e che la liquidazione delle spese è fatta dal giudice
esecutivo con decreto che costituisce titolo esecutivo. Secondo la giurisprudenza questo decreto è
equivalente al decreto ingiuntivo e contro di esso il debitore può proporre opposizione. La norma segnala
anche un’ipotesi particolare di titolo esecutivo giudiziale, il decreto — e non la classica sentenza di condanna
— però vale come titolo esecutivo perché il legislatore gli attribuisce espressamente tale efficacia.
L’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare.
Gli obblighi di fare. Nell’ambito di tali obblighi si è soliti compiere una distinzione, a seconda che siano
obbligazioni di fare fungibili o infungibili.
Si parla di fungibilità quando la prestazione consistente nel realizzare qualcosa può essere indifferentemente
realizzata dal debitore o da un soggetto terzo. Come esempio, possiamo prendere la costruzione di un muro
che divide due proprietà. L’obbligo di realizzare una costruzione è un tipo di fare che non richiede
necessariamente il soggetto obbligato.
Si parla di infungibilità quando un obbligo di fare è caratterizzato dall’intuitus personae, potendo essere
realizzato soltanto dal soggetto obbligato. Il Torrente faceva l’esempio del cantate d’opera che si è
contrattualmente obbligato a cantare in un certo teatro. La realtà concreta, al di là di queste ipotesi di scuola,
presenta spesso esempi di fare infungibile. Il dibattito sull’infungibilità comincia nel 1970 con lo Statuto dei
lavoratori, quando viene previsto che, in caso di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro è tenuto a
reintegrare il lavoratore illegittimamente licenziato. In relazione all’obbligo di reintegrare il lavoratore si
inizia a discutere del problema della fungibilità o infungibilità di questo particolare fare che, a giudizio dei
più e della Corte di cassazione risulta del tutto infungibile, con la conseguenza che, in questo particolare
obbligo di reintegrazione, il datore di lavoro non può essere sostituito con nessun altro.
Il nostro ordinamento, fino al 2009, non ha previsto nulla questa situazione.
Gli obblighi di non fare. Per quanto riguarda gli obblighi di non fare, l’opinione quasi generale è che si
tratta comunque di obblighi infungibili, che però hanno un particolare destino: si trasformano in obblighi di
fare fungibile nel caso in cui vengano violati (es. distruzione del muro realizzato in violazione dell’obbligo di
non costruire).
Il legislatore si occupa esclusivamente degli obblighi di fare fungibili e degli obblighi di non fare nel
momento in cui, a causa dell’inadempimento, si sono trasformati in obblighi di fare.
Prima di analizzare le norme del codice di procedura dobbiamo occuparci di una norma del codice civile che
è stata inserita erroneamente tra gli obblighi di fare e di non fare. Si tratta dell’art. 2932, rubricata
“Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto”. La norma, infatti, non si riferisce ad una
ipotesi di esecuzione forzata, ma al fatto che, se le parti si impegnano attraverso un preliminare a stipulare un
definitivo e una delle parti non adempie, l’altra può rivolgersi al giudice e ottenere una sentenza che produca
gli effetti del contratto non concluso (sentenza costitutiva).
Per quanto riguarda le norme processuali dobbiamo fare riferimento agli artt. 612 e ss.
La prima cosa che notiamo nel primo comma dell’art. 612 è il riferimento alla sentenza, che sembra essere
l’unico titolo esecutivo che legittima questa forma di esecuzione. In realtà, anche in anni abbastanza recenti,
si è giunti alla conclusione – perché il legislatore l’ha previsto espressamente – che anche il verbale di
conciliazione stragiudiziale, in particolare se raggiunto attraverso un procedimento di mediazione che ha
avuto esito positivo, costituisce un idoneo titolo esecutivo.
Il ruolo dell’ufficiale giudiziario è minimo, venendo in considerazione solo in un momento successivo.
Infatti il procedimento si apre con il ricorso al giudice dell’esecuzione che, sentita la parte obbligata,
provvede mediante ordinanza, designando l’ufficiale giudiziario e i terzi che devono provvedere alla
realizzazione/distruzione dell’opera.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
L’obbligo di fare o di non fare deve essere ovviamente individuato dal titolo esecutivo. Sarà quindi il giudice
della cognizione ad individuare gli aspetti e i limiti del diritto del creditore, in quanto il provvedimento del
giudice dell’esecuzione ha una funzione meramente integrativa a questo riguardo, dovendo provvedere, ad
esempio, sulle cautele e le autorizzazioni e i permessi necessari all’adempimento dell’obbligo.
L’art. 613 tratta delle difficoltà sorte nel corso dell’esecuzione e prevede la facoltà dell’ufficiale giudiziario
di farsi assistere dalla forza pubblica, nonché quella di richiedere al giudice dell’esecuzione le opportune
disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell’esecuzione. In questo caso, il giudice
provvede con decreto. Quando si parla di difficoltà, si tratta di difficoltà materiali, anche se in giurisprudenza
il dibattito è aperto, non essendo facile individuare le difficoltà.
Le misure di coercizione indiretta. Per quanto riguarda gli obblighi di fare infungibili, fino al 2009,
l'ordinamento non prevedeva nulla. Nel 2009 viene introdotto l’art. 614bis sulle misure di coercizione
indiretta, che aveva una dizione abbastanza limitata, in quanto riguardava solamente i provvedimenti di
condanna relativi ad obblighi di fare e di non fare. Lo scarsissimo successo incontrato dalla norma, tanto più
stupefacente a fronte dei fiumi di inchiostro che la dottrina aveva versato, ha indotto il legislatore a
modificare la norma nel 2015, inserendola in un apposito titolo IVbis. Tuttavia, questo cambiamento non
sembra essere un cambiamento epocale, perché la norma continua a non avere una grandissima applicazione.
È un ampliamento della norma che in qualche misura riflette una disposizione contenuta nel codice del
processo amministrativo (art. 114.4 lett. e), che riguarda il giudizio di ottemperanza, ossia quel giudizio che
viene messo in moto quando un soggetto pubblico non procede volontariamente all’esecuzione di una
sentenza. La misura coercitiva, nell’ambito del processo amministrativo, ha un notevole successo. La
situazione delle misure di coercizione indiretta previste dal codice di procedura civile è, invece, molto
diversa, anche per il modo in cui la norma è configurata.
La norma prevede che, con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento
di somme di denaro, il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la
somma di denaro dovuta dell’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni
ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Ciò significa che il giudice che pronuncia la sentenza di
condanna che il creditore intende usare come titolo esecutivo contro il debitore può condannare il debitore al
pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva dell’obbligo o anche per
ogni unità di tempo con cui il ritardo è misurato. La funzione della penalità di mora, o condanna accessoria, è
quella di indurre l’obbligato all’adempimento.
In origine questo tipo di misura era prevista solo per gli obblighi di fare o di non fare ed era considerato lo
strumento ideale per ottenere l’adempimento spontaneo di un obbligo per cui il debitore non avrebbe potuto
essere sostituito. Nel 2015 l’ambito di applicazione della norma è stato esteso a qualunque condanna
all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro (quindi obblighi di consegna, di
rilascio, di fare e di non fare).
Il primo limite rispetto all’applicabilità della norma è dato dall’inciso “salvo che ciò sia manifestamente
iniquo”. La manifesta iniquità è una di quelle norme in bianco che può essere riempita di qualunque
contenuto. Il margine di discrezionalità lasciato al giudice dal legislatore è quindi molto ampio ed è proprio
questa una delle ragioni per cui questa norma non ha grande applicazione: la clausola della manifesta iniquità
può essere usata, infatti, per limitare il ricorso alla multa coercitiva.
Un altro grande limite relativo all’uso delle multe coercitive si trova nella parte finale del primo comma, che
esclude le controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e i rapporti di co.co.co., di cui all’art.
409. Il che è un po’ paradossale, considerando che tutto il dibattito sugli obblighi di fare o di non fare era
nato in relazione all’obbligo di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, reintegrazione che ormai
non esiste più.
L’ammontare della penalità di mora viene determinato dal giudice tenendo conto del valore della
controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza
utile. Il riferimento al danno quantificato o prevedibile sembra fuorviante perché una cosa è l’adempimento
dell’obbligazione, altra cosa è il danno.
Vi sono anche aspetti procedurali che limitano l’utilizzabilità della norma. Il giudice che deve pronunciare
la sentenza di condanna all’adempimento è il giudice della cognizione e non quello dell’esecuzione e non
può, ovviamente, provvedere d’ufficio, ma solo su istanza di parte. Inoltre, per i meccanismi che riguardano
il processo ordinario di cognizione, la domanda relativa all’inflizione ipotetica di questa condanna va
proposta subito per evitare di incorrere nei divieti di nuove domande che la disciplina del processo di
cognizione impone. Questo è un primo grande problema perché la parte dovrà prevedere un comportamento
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
e tutelarsi, chiedendo al giudice di pronunciare oltre alla condanna all’adempimento di un obbligo di fare,
anche una condanna pro futuro al pagamento di questa somma, nella speranza di indurre il debitore ad
adempiere all’obbligazione.
LE OPPOSIZIONI ESECUTIVE.
La struttura del processo esecutivo non si presta ad ospitare delle forme di cognizione, essendo caratterizzato
da un soggetto procedente, il creditore, e un soggetto passivo, il debitore, il quale è tendenzialmente in una
situazione di assoluta soggezione rispetto all’iniziativa del creditore. Non vi è spazio per un vero
contraddittorio all’interno del processo esecutivo, il quale, in sé e per sé non è strutturato in modo tale da
consentire al debitore di contrastare l’iniziativa dei creditori.
Per questo motivo, l’ordinamento deve mettere a disposizione del debitore e dei terzi che, loro malgrado, si
trovino coinvolti nel processo esecutivo, degli strumenti che consentano di reagire all’iniziativa del creditore
denunciando l’illegittimità dell’esecuzione o di singoli atti del processo esecutivo. Le opposizioni esecutive
servono proprio a questo. Sono, infatti, giudizi di cognizione che introducono un procedimento
autonomo, ma strettamente collegato alla procedura esecutiva. Non a caso, la proposizione delle
opposizioni serve in prima battuta come strumento per ottenere una sospensione dell’esecuzione.
Le opposizioni sono sostanzialmente di tre tipi: opposizioni all’esecuzione, opposizioni agli atti esecutivi
e opposizioni di terzi all’esecuzione, che non va confusa con l’opposizione di terzo ex art. 404, che è un
mezzo di impugnazione del processo di cognizione.
Tutti questi tipi di opposizione introducono un giudizio di cognizione e hanno una struttura bifasica.
Esistono, però, delle importantissime differenze tra i vari tipi di opposizione, in particolare tra l’opposizione
all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi.
In linea di principio l’opposizione all’esecuzione non incontra limiti particolari. Tuttavia, per quanto
riguarda l’espropriazione, l’ultimo comma dell’art. 615 afferma che l’opposizione diviene inammissibile se
proposta dopo che sia disposta la vendita o l’assegnazione, a meno che non sia fondata su fatti sopravvenuti
o anche quando l’opponente dimostri di non averla potuta proporre tempestivamente per causa a lui non
imputabile. Questa norma è stata aggiunta nel 2016 e non si concilia bene con la disciplina dell’opposizione
all’esecuzione che, appunto, non dovrebbe incontrare limiti temporali di proposizione.
Con l’opposizione agli altri esecutivi, invece, si contesta la regolarità formale di singoli atti esecutivi e,
secondo una certa interpretazione, anche dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione. Il termine di
proposizione è in genere molto breve.
L’altra grande differenza è la sentenza con cui vengono definite le opposizioni. Nel caso di opposizione
all’esecuzione si tratta di una sentenza di primo grado normalmente appellabile, mentre nel caso di
opposizione agli atti esecutivi si tratta di una sentenza non soggetta ad appello, ma assoggettabile a
ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
L’opposizione all’esecuzione.
L’art. 615 stabilisce che, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e
questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice
competente per materia o per valore e per territorio a norma dell’art. 27. L’oggetto principale
dell’opposizione all’esecuzione è, quindi, la contestazione del diritto di procedere all’esecuzione forzata.
Ovviamente può accadere che la contestazione riguardi il titolo esecutivo. In questo caso la contestazione del
diritto a procedere all’esecuzione passa attraverso la contestazione della legittimità del titolo esecutivo.
Questo tipo di opposizione può essere proposta quando manchi il titolo esecutivo perché ad esempio il
creditore ha preteso di iniziare l’opposizione forzata sulla base di una sentenza di accertamento o costitutiva.
Un’altra ipotesi è la inidoneità del titolo esecutivo utilizzato dal creditore a supportare il procedimento
esecutivo intrapreso. Ad esempio, possiamo pensare alla scrittura privata autenticata o riconosciuta o
verificata, che può costituire titolo esecutivo stragiudiziale solo per l’espropriazione: se viene usata per
l’esecuzione forzata per consegna o rilascio, il debitore è legittimato a proporre opposizione.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
Altra ipotesi importante è il difetto di legittimazione attiva o passiva del creditore o del debitore. Si tratta
dei fenomeni di successione dal lato attivo o passivo.
Vi è poi la violazione di specifici divieti, riguardanti la materia delle procedure concorsuali. Si tratta di
ipotesi in cui l’invalidità del titolo esecutivo avrebbe potuto essere rilevata anche d’ufficio dal giudice o,
addirittura, dall’ufficiale giudiziario che, accorgendosi di queste carenze del titolo esecutivo avrebbe potuto
rifiutare l’esecuzione. Si tratta di ipotesi poco utilizzate.
Le opposizioni di merito. Molto più importanti sono le opposizioni all’esecuzione c.d. di merito, con le
quali si contesta l’esistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata. Diritto che deve sussistere non
solo all’inizio della procedura esecutiva, ma deve sussistere per tutto lo svolgimento di essa. L’ipotesi più
banale è che il debito esisteva all’inizio del procedimento, ma è stato saldato nel corso del processo. In linea
di principio il debitore potrà proporre opposizione. In realtà il problema diventa abbastanza complesso
perché, in relazione a questo tipo di opposizioni di merito, occorre fare una distinzione a seconda che
l’esecuzione sia iniziata sulla base di un titolo esecutivo giudiziale o stragiudiziale. Se il titolo esecutivo è un
titolo giudiziale, occorre tenere conto delle preclusioni che derivano dal giudicato o anche solo dalla mera
litispendenza. Ricordiamo che il riferimento al giudicato è dato dalla preclusione delle questioni dedotte e
deducibili che sono state decise o avrebbero dovuto e potuto essere sollevate e decise dalla sentenza. Questo
significa che vi è una serie di circostanze e di elementi che non possono più essere messi in discussione.
Per quanto riguarda la litispendenza, essa è la situazione che deriva da un processo in cui è stata pronunciata
una sentenza di condanna di primo grado. Qui dobbiamo fare riferimento alle regole generali in materia di
nullità della sentenza. Il riferimento è a quanto previsto dall’art. 161. La norma afferma che la nullità delle
sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le
regole proprie di questi mezzi di impugnazione. Essa è rilevante nel contesto del discorso dell’opposizione
all’esecuzione perché, se l’opposizione è iniziata sulla base di una sentenza di condanna di primo grado, per
bloccare questo tipo di esecuzione il debitore non dovrà utilizzare l’opposizione all’esecuzione, ma dovrà
necessariamente chiedere la sospensione del procedimento esecutivo al giudice dell’appello e non a quello
dell’esecuzione. È un dato estremamente importante.
Per quanto riguarda l’ipotesi in cui il processo esecutivo sia iniziato sulla base di una sentenza passata in
giudicato, in sede di opposizione all’esecuzione potranno essere fatti valere soltanto i fatti impeditivi,
modificativi o estintivi successivi alla formazione del giudicato stesso.
Per i titoli esecutivi stragiudiziali non ci sono limiti di sorta, quindi con l’opposizione all’esecuzione
qualunque fatto può essere fatto valere come elemento che determina l’illegittimità dell’esecuzione in virtù
della circostanza che il diritto di procedere all’esecuzione non esisteva o è venuto meno nel corso della
procedura.
L’opposizione all’esecuzione è proponibile anche per tutto ciò che riguarda la pignorabilità dei beni, come
si ricava dal secondo comma dell’art. 615. Questa scelta del legislatore è abbastanza strana: se non fosse lui a
dirci che in questo caso è esperibile l’opposizione all’esecuzione, sembrerebbe più ragionevole pensare che
si tratti di un’ipotesi in cui il rimedio più adatto è l’opposizione agli atti esecutivi.
Il procedimento. Dal punto di vista del procedimento occorre fare una distinzione.
Questo tipo di procedimento può essere proposto prima dell’inizio vero e proprio del processo esecutivo. Gli
atti prodromici vengono in considerazione proprio perché, prima dell’inizio del processo esecutivo,
l’opposizione all’esecuzione può essere proposta come opposizione a precetto. In questo caso l’opposizione
si propone con atto di citazione davanti al giudice ordinariamente competente per materia e per valore e le
norme seguite sono quelle di un ordinario giudizio di cognizione, facendo però riferimento ai riti speciali nel
caso in cui la materia lo richieda.
Tornando al primo comma dell’art. 615, il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte
l’efficacia esecutiva del titolo, quindi adotta un provvedimento che impedisce il vero e proprio inizio
dell’esecuzione.
Quando invece l’esecuzione è già iniziata le cose si fanno più complicate. Questo tipo di opposizione si
propone con ricorso al giudice dell’esecuzione, il quale fissa un’apposita udienza di comparizione delle parti
e un termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. È a questo riguardo che viene in
considerazione la struttura bifasica dell’opposizione all’esecuzione, in quanto questa udienza di
comparizione regolata dalle norme sui procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 e ss.) è l'udienza in cui
si decide come il processo proseguirà. La giurisprudenza suole dire che questa prima fase del procedimento,
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
è una fase sommaria, ed è seguita da una fase di cognizione piena. Sottolinea anche che la struttura bifasica
non impedisce che comunque si tratti di un procedimento unitario. Il riferimento alla prima udienza è
importante perché se il giudice dell’esecuzione verifica che è competente l’ufficio giudiziario cui lui
appartiene, si limita a fissare un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, anche tenendo
conto di eventuali norme di rito speciale in relazione alla materia, con riduzione della metà dei termini. Se
invece risulta competente un ufficio giudiziario diverso da quello del giudice dell’esecuzione, questi fisserà
un termine perentorio entro il quale la causa dovrà essere riassunta davanti al giudice competente.
Proseguita o riassunta la causa di merito, questa segue le norme di un normale giudizio di cognizione, il si
conclude in ogni caso con una sentenza normalmente impugnabile con appello.
L’opposizione agli atti esecutivi.
Anche questo tipo di opposizione introduce un giudizio di cognizione autonomo, ma collegato al
procedimento di esecuzione.
L’art. 617 stabilisce al primo comma che le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo
e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’art. 480,
terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del
titolo esecutivo o del precetto. Il concetto di regolarità formale è molto ampio e comprende tanto la nullità,
quanto la mera irregolarità dell’atto. Il riferimento è senza dubbio alle norme sulla nullità degli atti, in
particolare all’art. 156, secondo comma, in base al quale può essere pronunciata la nullità di un atto quando
questo manca dei requisiti formali per il raggiungimento dello scopo per il conseguimento del quale l’atto in
quella forma è finalizzato. Peraltro, con riferimento al titolo esecutivo, è necessario stare molto attenti. Il
discorso sulla nullità dell’atto non vale per il titolo esecutivo, perché una nullità di questo dovrà essere fatta
valere solo attraverso l’opposizione all’esecuzione e non attraverso l’opposizione agli atti esecutivi. Il titolo
esecutivo è condizione necessaria e sufficiente per l’inizio e la prosecuzione dell’esecuzione forzata, quindi
la sua nullità o inesistenza, investendo direttamente il diritto di procedere all’esecuzione forzata, certamente
non può essere considerato una forma di irregolarità formale e non potrà essere dedotto con l’opposizione
agli atti esecutivi.
È diverso, invece, il caso del precetto per il quale questa distinzione non è necessaria. Possiamo pensare, ad
esempio, ad una incompleta e inesatta apposizione della formula del titolo esecutivo, oppure ad altri vizi
estrinseci che nulla hanno a che vedere con il diritto di procedere ad esecuzione incorporato nel titolo
esecutivo stesso.
L’opposizione agli atti esecutivi non è proponibile solo contro gli atti prodromici – titolo esecutivo, precetto
e notificazione di essi – ma lo è anche contro qualunque atto del procedimento esecutivo, compresi i
provvedimenti del giudice dell’esecuzione. Se così non fosse non esisterebbero rimedi atti a contrastare i
provvedimenti del giudice dell’esecuzione. Del resto, a volte è lo stesso legislatore che ci indica come
impugnazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione l’opposizione agli atti esecutivi. È il caso delle
controversie distributive ex art. 512, le quali sono risolte dal giudice dell’esecuzione con ordinanza
suscettibile di impugnazione attraverso l’opposizione agli atti esecutivi.
La peculiarità di questo tipo di opposizione è data dal fatto che la sua proposizione è soggetta a un termine
di decadenza molto breve (venti giorni). Questo aspetto differenzia l’opposizione agli atti esecutivi
dall’opposizione all’esecuzione, per la quale non sussiste alcun limite temporale, salvo il caso
dell’espropriazione (opposizione inammissibile se proposta dopo la vendita, salvo che l’opponente dimostri
di non averla potuta proporre prima per causa a lui non imputabile o per fatti sopravvenuti.
Trattandosi di far valere una nullità (intesa in senso molto lato), sono necessarie alcune considerazioni in
tema di rilevabilità della regolarità formale. Anche in questo caso occorre fare riferimento alle norme
generali, in particolare, l’art. 157, secondo cui, a meno che la legge non preveda la nullità come rilevabile
d’ufficio, questa deve essere fatta valere esclusivamente solo dalla parte nell’interesse della quale il requisito
mancante era stato stabilito. Tuttavia, la rilevabilità d’ufficio rispetto a un’ipotesi di nullità o irregolarità
formale di un atto della procedura esecutiva viene ammessa dalla giurisprudenza quando il requisito era
previsto nell’interesse generale – e non dell’esclusivo debitore – ed in questo caso non ci sarebbero limiti
temporali alla proposizione dell’opposizione agli atti. La tesi non convince molto, perché non si vede quali
possano essere le ipotesi in cui un requisito formale di un atto esecutivo possa essere posto nell’interesse
generale, considerando la particolare struttura del processo esecutivo.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
Legittimazione. Per quanto riguarda i legittimati attivi, essi sono non solo il debitore o il terzo coinvolto
nella procedura esecutiva – se si tratti di espropriazione mobiliare presso terzi –, ma anche tutti i soggetti
destinatari di singoli atti o provvedimenti del giudice, quindi anche i creditori. Nel caso in cui più soggetti
siano interessati alla pronuncia sulla regolarità o meno dell’atto si verifica un’ipotesi di litisconsorzio
necessario.
Il procedimento. Anche in questo caso abbiamo delle forme differenziate a seconda che l’opposizione
riguardi gli atti preliminari o si rivolga contro atti del procedimento esecutivo già iniziato.
Nel primo caso è necessario un atto di citazione proposto davanti al giudice competente per l’esecuzione.
Nel secondo caso, il secondo comma dell’art. 617 stabilisce che l’opposizione di propone con ricorso al
giudice dell’esecuzione. Si ha una applicazione del principio della struttura bifasica delle opposizioni
esecutive. Una volta proposta opposizione agli atti, il giudice dell’esecuzione fissa con decreto l’udienza di
comparizione delle parti dando, se necessario, i provvedimenti opportuni (art. 618). A questa udienza il
giudice dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene non dilazionabili, ovvero sospende la procedura. Infine
fissa un termine per l’instaurazione del giudizio di merito, previa iscrizione della causa a ruolo a cura della
parte interessata. Il dato importante che segna la differenza rispetto all’opposizione all’esecuzione è che, in
ogni caso, sull’opposizione agli atti esecutivi si pronuncia sempre e solo il giudice dell’esecuzione, senza che
si abbia una diversa allocazione della causa a seconda che l’ufficio giudiziario del giudice dell’esecuzione sia
competente o meno.
Altra particolarità che segna una differenza rispetto all’opposizione all’esecuzione e che la sentenza
pronunciata in relazione alla opposizione agli atti esecutivi è una sentenza espressamente dichiarata non
impugnabile dal secondo comma dell’art. 618. Si tratta però di una sentenza non impugnabile con gli
ordinari mezzi di impugnazione, con l’eccezione prevista dal legislatore nelle disposizioni di attuazione del
regolamento di competenza, ma impugnabile per ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., che è
anche esperibile per tutti i motivi di ricorso previsti dall’art. 360 c.p.c.
L’opposizione dei terzi.
Si tratta di una particolare opposizione, da non confondere con l’opposizione di terzo ex art. 404, alla quale è
legittimato il terzo che vanta la proprietà o altro diritto reale di godimento sul bene che è stato oggetto
della procedura esecutiva.
Si tratta di un’opposizione che non incontra limiti di tempo, ma che deve essere comunque proposta prima
che sia disposta la vendita o l’assegnazione (art. 619). Qui si seguono in linea di principio le norme previste
per l’opposizione all’esecuzione.
L’esito di questa particolare opposizione proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione può essere diverso.
È possibile che all’udienza fissata dal giudice le parti raggiungano un accordo, nel qual caso il giudice ne dà
atto con ordinanza adottando ogni provvedimento necessario per assicurare o la continuazione nel processo
esecutivo o per prevederne l’estinzione. Nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo, le norme
rinviano all’art. 616, quindi alla disciplina dell’opposizione all’esecuzione.
Il tempo. Ci sono delle norme particolari che riguardano il tempo della proposizione dell’opposizione.
L’opposizione può essere proposta fino a che non sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni. Peraltro,
l’art. 620 prevede anche un’opposizione tardiva che si verifica quando il giudice dell’esecuzione al quale
l’opposizione è stata proposta, non ha deciso di sospendere la procedura esecutiva, oppure quando
l’opposizione è proposta dopo la vendita. In questo caso, i diritti del terzo potranno essere fatti valere
esclusivamente sulla somma ricavata.
Per il terzo questa non è l’unica possibile difesa. È infatti possibile che questi, dopo la procedura esecutiva,
proponga un’azione di rivendica, specie se il bene è un immobile e quindi non è soggetto all’applicazione
della regola sul possesso di buona fede ex art. 1153. L’azione di rivendica è proposta, ovviamente, nei
confronti del soggetto che ha acquistato il bene in vendita forzata oppure nei confronti dell’assegnatario del
bene. I problemi di concorso tra le due forme di tutela sono particolarmente complessi. Sembra preferibile
per il terzo proporre l’opposizione ex art. 619, in quanto questa può garantirgli la sospensione della
procedura esecutiva.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
GLI EVENTI ANOMALI.
Nel processo di cognizione si parla di eventi anomali con riferimento a tre istituti: sospensione, interruzione
ed estinzione. Nella procedura esecutiva non esiste l’interruzione.
La sospensione.
Mentre nel processo di cognizione è effettivamente un evento anomalo, nel processo esecutivo è un istituto
molto importante perché consente di bloccare almeno temporaneamente la procedura esecutiva per
vedere se essa ha o meno un fondamento.
Secondo l’art. 623, salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è
impugnato un titolo esecutivo, l’esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del
giudice dell’esecuzione. La norma dice chiaramente che la sospensione può verificarsi quindi solo: a) per
espressa previsione di una norma di legge; b) per un provvedimento specifico del giudice
dell’esecuzione; c) per un provvedimento del giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo.
Quest’ultima ipotesi è particolarmente importante e si ricollega al discorso delle opposizioni di merito, ossia
quelle opposizioni che riguardano nello specifico l’esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Quando il titolo esecutivo è di formazione giudiziale occorre tenere conto delle preclusioni derivanti dal
giudicato e dalla litispendenza. Ciò significa che se il titolo è rappresentato da una sentenza di condanna, ad
esempio di primo grado, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo o, nel caso in cui la procedura sia
già iniziata, la sospensione della procedura esecutiva potrà essere richiesta non in sede di proposizione
dell’opposizione all’esecuzione, ma in sede di proposizione dell’appello. Quindi il debitore, nell’atto con cui
proporrà appello contro la sentenza di primo grado utilizzata come titolo esecutivo per promuovere
l’esecuzione forzata, farà istanza al giudice di appello al fine di ottenere l'inibitoria, cioè la sospensione
dell’efficacia, del titolo esecutivo oppure l’effettiva sospensione della procedura esecutiva, se già iniziata.
Tutto ciò si comprende dall’art. 615 primo comma, secondo il quale la sospensione dell’efficacia esecutiva
del titolo, nel caso in cui l’opposizione sia stata proposta contro uno degli atti prodromici, è legata alla
presenza di gravi motivi che rendano ragionevole in capo al giudice il disporre la sospensione. I gravi motivi
consentono la sospensione in caso di opposizione all’esecuzione, quindi opposizione proposta nel caso di
esecuzione già iniziata. Infatti, l’art. 624 primo comma afferma che se è proposta opposizione all’esecuzione
il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte il procedimento. I gravi motivi sono ciò
che determina la sospensione del processo esecutivo, oppure la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo
esecutivo, a seconda che l’istanza di sospensione intervenga a esecuzione già iniziata o prima.
Si ritiene che nella sospensione dell’esecuzione, a seguito di proposizione di opposizione agli atti
esecutivi, i giusti motivi non siano neppure necessari, posto che nell’udienza fissata dal giudice
dell’esecuzione per dettare i provvedimenti necessari e anche per assegnare alle parti un termine entro il
quale instaurare il giudizio di merito si parla genericamente di sospensione della procedura senza alcun
riferimento ai gravi motivi.
La sospensione è disposta dal giudice dell’esecuzione con ordinanza. Contro questa ordinanza è esperibile la
procedura del reclamo cautelare. Proprio in considerazione di questo particolare mezzo di impugnazione, la
tendenza è quella di considerare la sospensione dell’esecuzione come un provvedimento che ha natura in
senso lato cautelare, in quanto mira ad evitare che, attraverso l’esecuzione, si arrechi al debitore un
pregiudizio irreparabile.
L’art. 624.3 ci consente di comprendere come dalla sospensione della procedura esecutiva si possa arrivare
addirittura alla sua estinzione. La norma prevede che, se contro l’ordinanza che ha disposto la sospensione
non viene proposto reclamo, oppure se questa ordinanza viene confermata in sede di reclamo, o ancora se il
giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato dal giudice - si fa riferimento
all’opposizione all’esecuzione e alla situazione in cui il giudice, a seconda che il suo ufficio giudiziario sia
competente o meno, assegni o un termine per l'instaurazione del giudizio di merito, oppure un termine
perentorio per la riassunzione della causa di merito -, il giudice, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza
l’estinzione della procedura esecutiva. Nel disporre l’estinzione del processo, ovviamente, ordina anche la
cancellazione della trascrizione del pignoramento (immobiliare) e provvede sulle spese. Anche questa
ordinanza è suscettibile di reclamo.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
L’ultimo comma dell’art. 624 stabilisce che la norma si applica, in quanto compatibile, anche alla ipotesi di
sospensione del processo prevista dall’art. 618, cioè alla sospensione della procedura esecutiva a seguito di
opposizione agli atti esecutivi.
L’art. 624bis disciplina un’ipotesi particolare data dalla sospensione su istanza delle parti, in particolare di
tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. In questo caso, il giudice può disporre per una sola volta la
sospensione del processo per un periodo massimo di 24 mesi. Anche qui il giudice provvede sull’istanza
proposta dalle parti con un’ordinanza. Può provvedere anche inaudita altera parte in situazioni di urgenza.
Effetti della sospensione. Come nel processo di cognizione, la sospensione ha come effetto l’impossibilità
di compiere qualunque atto del procedimento, salvo specifica disposizione del giudice. La sospensione non
può, tuttavia, essere illimitata: nel disporre la sospensione il giudice fissa anche un termine perentorio entro
il quale la causa deve essere riassunta con ricorso. Il termine non può essere superiore a sei mesi dal
passaggio in giudicato della sentenza di primo grado resa sull’opposizione o dalla comunicazione della
sentenza di appello che abbia rigettato l’opposizione.
L’estinzione.
L’estinzione del processo esecutivo può avvenire per rinuncia delle parti, oppure per inattività delle parti.
Estinzione per rinuncia. Per quanto riguarda la rinuncia, l’art. 629 stabilisce che il processo si estingue se,
prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo
esecutivo rinunciano agli atti. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori
concorrenti (indipendentemente, quindi, dal possesso del titolo esecutivo).
Questa norma e quelle relative all’estinzione in generale, sembrano riferirsi solo all’espropriazione. Un
parziale riempimento di questa lacuna si ha solo relativamente all’esecuzione per consegna o rilascio, in
quanto l’art. 608bis prevede l’estinzione dell’esecuzione di cui all’art. 605 (per consegna o rilascio) per
rinuncia della parte istante. A parte questa disposizione, tutto il resto sembra riferirsi all’espropriazione. Non
si contempla nulla con specifico riferimento, ad esempio, all’estinzione per rinuncia nella esecuzione forzata
in forma specifica degli obblighi di fare o di non fare. La rinuncia è operativa in momenti diversi a seconda
dei soggetti che la formulano.
Estinzione per inattività. Più importante è l’estinzione per inattività delle parti. Come nel processo di
cognizione, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le
parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.
Le ipotesi possono essere diverse. Due ipotesi oltre alla mancata riassunzione del giudizio di merito una
volta proposta l’opposizione sono: la perdita di efficacia del pignoramento decorsi i quarantacinque giorni
senza che vengano compiuti ulteriori atti del procedimento, nonché l’ipotesi legata alla omesso o tardivo
deposito della nota di iscrizione a ruolo e di altri documenti.
L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata dal giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, con ordinanza non
oltre la prima udienza successiva al verificarsi della causa estintiva. Contro questa ordinanza è ammesso
reclamo nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza.
L’impugnazione avviene nelle forme del controllo da parte del collegio sulle ordinanze del giudice istruttore.
Infatti, la parte finale dell’art. 630 terzo comma afferma che il collegio provvede in camera di consiglio con
sentenza, osservando le norme di cui all’art. 178 (“Controllo del collegio sulle ordinanze”).
Altra forma interessante di inattività delle parti è quella che fa da pendant all’art. 181 primo comma. Si tratta
della mancata comparizione delle parti a due udienze successive. Ai sensi dell’art. 631, se nessuna delle
parti si presenta all’udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, il giudice dell’esecuzione
fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti. Se nessuna delle parti si
presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo.
Un’ipotesi recente di estinzione, introdotta nel 2015, riguarda l’art. 631bis, ossia l’omessa pubblicità sul
portale delle vendite pubbliche. Essa si ha quando l’avviso relativo alla vendita non è postato sul sito entro
il termine stabilito dal giudice. Va detto, tuttavia, che nella parte finale della norma si esclude che
l’estinzione possa conseguire al fatto che il mancato inserimento dell’avviso sia legato alla funzionalità della
piattaforma.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
Effetti dell’estinzione. Sono disciplinati dall’art. 632, il quale afferma che con l’ordinanza che pronuncia
l’estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento è si provvede a liquidare
le spese, comprese quelle relative al delegato alla vendita. Ciò che fa la differenza è il momento in cui viene
dichiarata l’estinzione: se si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, essa rende inefficaci gli
atti compiuti, se avviene dopo, la somma ricavata è consegnata al debitore.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
I PROCEDIMENTI SPECIALI.
Sono disciplinati dal libro quarto del codice civile. Questo libro è stato qualificato da Virgilio Andrioli come
una specie di Upim, in quanto contiene i procedimenti più diversi.
Molti dei procedimenti speciali contenuti nel libro quarto del codice sono qualificati come procedimenti
sommari.
Il significato di sommarietà della cognizione si comprende facendo riferimento alla cognizione piena, che è
propria del giudizio ordinario di primo grado. La cognizione piena è un tipo di cognizione che si svolge nel
pieno e assoluto rispetto delle garanzie fondamentali. La cognizione sommaria rappresenta qualcosa di
meno: è una cognizione che, almeno nella fase iniziale del procedimento, è meramente superficiale e solo in
un momento successivo, puramente eventuale, prevede una verifica del provvedimento attraverso un giudizio
di merito (a cognizione piena).
Molto spesso sommarietà della cognizione significa che non vi è in questa fase un pieno rispetto del
principio del contraddittorio, proprio perché nella sostanza per la concessione del provvedimento ci si basa
sulle affermazioni formulate dal soggetto richiedente il provvedimento stesso. Peraltro, quando il
provvedimento viene emanato sulla base di una cognizione sommaria e tendenzialmente inaudita altera
parte, il contraddittorio viene recuperato in un momento successivo.
Quando si parla di procedimento sommario non si intende un provvedimento unico: la sommarietà assume
caratteristiche diverse in funzione dei vari tipi di provvedimento ed è anche questo un elemento di cui va
tenuto conto nel valutare la pluralità di procedimenti di cui al libro quarto.
IL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE.
Il procedimento sommario di cognizione è disciplinato agli artt. 702bis-702quater. Si tratta di un
procedimento piuttosto nuovo, introdotto dal legislatore nel 2009, per tentare di far fronte alla necessità di
una definizione più rapida dei procedimenti.
Nel 2014 è stato introdotto l’art. 183bis, che si ricollega al processo sommario di cognizione.
Nonostante la denominazione, si tratta di un giudizio caratterizzato da una cognizione piena. L’aggettivo
“sommario” è riferito al fatto che il procedimento ha una struttura semplificata rispetto al giudizio ordinario
di cognizione.
Un’altra particolarità del procedimento è data dal fatto che la sua disciplina è collocata alla fine delle misure
cautelari, ossia di procedimenti finalizzati a far fronte a una situazione emergenziale che potrebbe
pregiudicare il soggetto titolare di un diritto nel tempo mediamente necessario per ottenere una tutela
attraverso un giudizio di merito o una procedura esecutiva. La scelta del legislatore è estremamente
discutibile perché questo tipo di procedimento non ha nulla a che fare con le misure cautelari, posto che si
tratta di un ordinario giudizio di cognizione piena, che ha solamente una scansione più accelerata rispetto a
quella del giudizio ordinario di cognizione.
L’art. 702bis enuncia l’ambito di applicazione del procedimento, facendo riferimento alle cause in cui il
tribunale giudica in composizione monocratica. In questi casi la domanda può essere proposta al tribunale
competente nelle forme del procedimento sommario di cognizione. Le cause in cui il tribunale giudica in
composizione monocratica sono quelle indicate dall’art. 50bis, che distingue tra le cause che sono di
competenza del collegio e quelle di competenza del giudice monocratico. Le cause in cui il tribunale decide
in composizione collegiale sono un numero abbastanza limitato: la regola, in base all’art. 50ter, è quella del
tribunale in composizione monocratica.
Ciò significa che le cause affidate alla competenza del giudice di pace non possono mai avvalersi di questo
modello procedimentale. Vi sono poi anche altri tipi di cause escluse: esse sono, in particolare, quelle cause
che devono essere trattate nelle forme dei riti speciali di cognizione. Tipico caso è quello delle cause di
lavoro e delle cause in materia di locazione. Le norme non dicono nulla di preciso, infatti il punto è
controverso. Vi sono, tuttavia, dei riferimenti normativi che inducono ad escludere che si possa utilizzare tale
modello procedimentale. Se facciamo riferimento all’art. 702bis primo comma, troviamo un riferimento
all’art. 163, quindi all’atto di citazione, e il processo di lavoro è introdotto da ricorso. Analogamente, l’art.
702ter terzo comma fa riferimento all’udienza ex art. 183, cioè l’udienza di prima comparizione e trattazione
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
della causa, mentre nel processo del lavoro c’è una specifica udienza (tendenzialmente l’unica) disciplinata
dall’art. 420 – udienza di discussione –. Da tutti questi elementi si desume che il rito sommario non è
utilizzabile per i riti speciali di cognizione.
Forma della domanda e costituzione delle parti (art. 702bis).
L’atto introduttivo di questo tipo di procedimento è un ricorso. Dal punto di vista dell’attore, l’atto
introduttivo prende il nome di ricorso. Per il convenuto, invece, prende il nome di comparsa di risposta,
mentre di norma di fronte a un ricorso si parla di memoria di replica. Il ricorso contiene nella sostanza quasi
tutti gli elementi previsti da un normale atto di citazione e deve essere sottoscritto a norma dell’art. 125 da un
difensore al quale la parte abbia conferito la procura alle liti.
Il ricorso segue poi il normale iter – deposito in cancelleria, fissazione dell’udienza di comparizione delle
parti e di un termine per la costituzione del convenuto –. Il convenuto si costituisce mediante comparsa di
risposta che ha esattamente lo stesso contenuto di quella del processo di cognizione.
La parte più significativa della comparsa di risposta è data, non solo dalla proposizione delle difese da parte
del convenuto, ma anche dal dovere di prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento
della domanda attraverso il normale meccanismo delle eccezioni. Il convenuto dovrà anche indicare i mezzi
di prova di cui intende avvalersi e i documenti, formulare le conclusioni, proporre eventuali domande
riconvenzionali, nonché le eventuali chiamate di terzi in garanzia.
L’elemento importante che va sottolineato è il fatto che il termine per la costituzione del convenuto è di soli
trenta giorni, mentre nel processo di cognizione ordinario è di settanta giorni, per il combinato disposto
degli artt. 163bis e 166; addirittura, il termine per la difesa del convenuto davanti al giudice di pace è di
quarantacinque giorni. La dottrina ha messo in evidenza questa differenza perché, soprattutto con riferimento
al procedimento dinanzi al giudice di pace e considerando la limitata competenza di questi, pare strano che
nel processo dinanzi a questo giudice il termine concesso al convenuto per difendersi sia superiore a quello
di cui gode in un procedimento sommario di cognizione davanti a un tribunale, per non parlare poi della
differenza rispetto al processo ordinario di cognizione. Balena solleva addirittura la possibilità che si sia in
presenza di un caso di illegittimità costituzionale.
Un’altra considerazione che possiamo fare è che l’iniziativa di avvalersi di questo procedimento spetta
esclusivamente all’attore: non è previsto che il convenuto reagisca in alcun modo rispetto a questa scelta
compiuta dall’attore e che potrebbe essere dettata da ragioni puramente strategiche.
Probabilmente il convenuto avrà la possibilità in udienza di persuadere il giudice che la causa non vada
trattata in maniera sommaria, ma questa possibilità ipotetica è poca cosa rispetto alla circostanza che,
normativamente, il convenuto si trovi nella situazione di dover subire questa iniziativa dell’attore senza avere
strumenti di reazione.
Non convince neanche la tesi di chi sostiene che questo tipo di procedimento è previsto solamente per le
cause poco complesse, quelle in cui c’è un’istruzione prevalentemente documentale. Queste sono
speculazioni della dottrina, perché non è scritto da nessuna parte: in linea di principio questo tipo di
procedimento è utilizzabile per qualunque causa, semplice o complessa, a scelta dell’attore. Tra l’altro,
occorre tenere presente che questo tipo di procedimento può essere utilizzato per qualunque tipo di azione –
di accertamento, costitutiva o di condanna –: non vi sono particolari limiti e questo rende ancora più
particolare la debolezza della posizione del convenuto di fronte a tali iniziative.
Il procedimento (art. 702ter).
All’udienza di comparizione possono verificarsi vari scenari. Come in tutte le prime udienze, il giudice
verificherà l’esistenza delle condizioni dell’azione e dei presupposti processuali.
La norma disciplina due ipotesi specifiche: il caso in cui il giudice rilevi di essere incompetente dal punto
di vista territoriale; il caso in cui il giudice rilevi che la domanda dell’attore non rientra tra quelle
proponibili con rito sommario di cognizione.
Nel primo caso, il giudice provvede a dichiarare la propria incompetenza con ordinanza impugnabile con il
regolamento di competenza.
Nel secondo caso – ad esempio quando si è davanti a una domanda di competenza del giudice di pace,
oppure che rientra nella competenza del tribunale in composizione collegiale –, la domanda viene dichiarata
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
inammissibile, ma l’ordinanza con cui si dichiara l’inammissibilità è espressamente dichiarata non
impugnabile.
Il tipo di accertamento più interessante è, tuttavia, quello che il giudice è tenuto a compiere a norma del terzo
comma. Il terzo comma afferma che, se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non
sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’art. 183. In tal caso si
applicano le disposizioni del libro II.
Può accadere, quindi, che durante la prima udienza il giudice si renda conto che la controversia non può
essere istruita in maniera sommaria. In questo caso il giudice provvede al mutamento del rito. Tuttavia,
mentre di norma il mutamento prevede un passaggio intermedio dal rito A al rito B, in questo caso è lo stesso
giudice che fissa l’udienza di prima comparizione e trattazione del giudizio ordinario di cognizione. Da quel
momento, troveranno applicazione le norme del rito ordinario di cognizione.
L’altra ipotesi è quella in cui il giudice si ritenga soddisfatto del ricorso e dei suoi contenuti sotto il profilo
dell’adeguatezza rispetto all’istruzione sommaria. Il quinto comma stabilisce che, se il giudice non provvede
ai sensi dei commi precedenti – quindi non si dichiara incompetente, non dichiara la domanda inammissibile
e non dispone la conversione del rito –, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità
non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione
rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto.
Questa norma è molto importante perché affida al giudice un potere particolarmente ampio, che è quello
di decidere in maniera ampiamente discrezionale come configurare la fase istruttoria. L’unico limite è
rappresentato dall’obbligatoria osservanza del principio del contraddittorio. È l’unica norma del nostro
processo civile che attribuisce al giudice un potere che i giudici degli altri ordinamenti non hanno più: il
potere di case management, ossia il potere di gestire managerialmente la specifica controversia. Ciò
significa che il giudice, in relazione alle peculiarità del caso concreto, ha la libertà di organizzare l’istruttoria
nella maniera che ritiene, non solo più opportuna, ma anche più efficiente, nella prospettiva di accelerare la
definizione del processo.
Naturalmente, questa norma non significa attribuire al giudice poteri istruttori ufficiosi, significa
semplicemente che il giudice è autorizzato a utilizzare le prove dedotte dalle parti nella maniera che ritiene
migliore e più idonea alla luce delle circostanze del caso concreto.
Esaurita la fase istruttoria, il giudice provvede con ordinanza di accoglimento o di rigetto delle domande. Si
tratta di un’ordinanza in tutto e per tutto equiparabile alla sentenza con la quale viene definito un normale
giudizio ordinario di cognizione. L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. In questa stessa ordinanza il giudice pronuncia
anche sulle spese.
Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione. Prima di occuparci dell’impugnazione
dell’ordinanza, dobbiamo analizzare una norma introdotta nel 2014, ossia la norma che prevede la possibilità
inversa di passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione. L’art. 183bis ci dice che, nelle
cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica il giudice dell’udienza di trattazione (ex art.
183), valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche
mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell’art. 702ter e invita
le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di
cui intende avvalersi e la relativa prova contraria. Questa norma ci dice che, in linea puramente teorica, nel
momento in cui la domanda è stata presentata al giudice nelle forme dell’atto di citazione introduttivo di un
giudizio ordinario di cognizione, sempre che si tratti di causa in cui il tribunale giudica in composizione
monocratica, alla prima udienza il giudice può disporre la conversione del rito. Qui compaiono degli
elementi che negli artt. 702bis e 702ter non compaiono: il riferimento è, in particolare, alla complessità della
lite e dell’istruzione probatoria. Probabilmente l’idea per cui tutti tendono a dire che il rito sommario di
cognizione funziona solo per le cause semplici è ciò che ha indotto il legislatore a introdurre questo inciso.
Anche qui ci troviamo in una situazione molto particolare: nel rito sommario di cognizione, l’iniziativa
spetta esclusivamente all’attore, il quale sceglie questa modalità procedurale senza che il convenuto possa
fare alcunché. Qui ci troviamo in una situazione abbastanza simile. La conversione è decisa dal giudice con
un tipo di valutazione abbastanza discrezionale ed è disposta con ordinanza non impugnabile: né l’attore, né
il convenuto hanno la possibilità di contrastare questa scelta.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
Ad ogni modo, questa norma è stata scarsamente utilizzata perché sono pochi i giudici disposti ad assumersi
una responsabilità di questo genere, ma soprattutto sono pochissimi i giudici che arrivano all’udienza ex art.
183 avendo ben presente il contenuto della causa da decidere.
Del resto, lo stesso procedimento sommario di cognizione, nonostante le aspettative ha una scarsa
applicazione pratica.
L’appello (art. 702quater).
L’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702ter è soggetta ad appello. Anche questo è uno dei tanti aspetti
criticabili del procedimento, in quanto è come se alla compressione dell’istruzione in primo grado si volesse
far fronte rendendo l’appello particolarmente ampio.
L’appello si propone nel termine molto breve di trenta giorni che decorre dalla comunicazione o dalla
notificazione, a seconda di quale delle due viene effettuata prima. Noi sappiamo che il termine breve per
l’impugnazione di norma decorre dalla notificazione, quindi questa è un’altra cosa che distingue il rito
sommario di cognizione. Resta comunque fermo il termine lungo di sei mesi che decorre dalla pubblicazione
della sentenza.
L’appello, in assenza di precisazioni normative, si propone con atto di citazione, altra stranezza rispetto a un
procedimento di primo grado che inizia con ricorso. Al giudizio di appello non si applica il filtro previsto
dagli artt. 348bis e 348ter, che prevedono che l’appello venga dichiarato inammissibile quando non ha
nessuna prospettiva di accoglimento.
La parte più critica della norma è quella che prevede la possibilità di nova in appello, cioè la possibilità di
dedurre nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili. Questa
possibilità è sparita nel rito ordinario (ma c’è ancora nel rito del lavoro), dopo una vita molto breve, ma è
stata introdotta in questo tipo di giudizio, quasi a voler ripristinare in appello una cognizione piena che non
c’è nel giudizio di primo grado.
La norma prosegue dicendo che, oltre ai mezzi di prova ritenuti dal collegio indispensabili, possono sempre
essere proposte le prove o i documenti che la parte dimostri di non aver potuto produrre in primo grado per
causa non imputabile a sua colpa.
Quanto alla indispensabilità delle prove, la Cassazione a sezioni unite nel 2017 ha chiarito cosa debba
intendersi per prova indispensabile. La Corte ha affermato che: “La nuova prova indispensabile è quella di
per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione attuale accolta dalla pronuncia di
primo grado, smentendo tale ricostruzione o confermando tale ricostruzione senza lasciare margine di
dubbio. Si considera indispensabile anche una prova che fornisce dimostrazione di ciò che era rimasto
sprovvisto di prova o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia
incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”.
Se l’ordinanza non viene impugnata con l’appello, ovviamente, passa in giudicato come una qualunque
sentenza e acquisisce gli effetti di cui all’art. 2909 c.c., quindi efficacia di cosa giudicata sostanziale che fa
stato tra le parti, gli eredi e i loro aventi causa (art. 702quater).
Il progetto di semplificazione.
Nel 2011, il d.lgs. 150/2011 ha tentato la c.d. semplificazione dei riti. Ha cioè considerato tutti quei
procedimenti in materia civile e commerciale che si trovavano fuori dal codice. Questi procedimenti molto
spesso avevano norme diverse, non erano riconducibili a un unico modello. Erano applicazioni un po’
fuorvianti della c.d. tutela giurisdizionale differenziata, ossia ad ogni tipo di situazione sostanziale, secondo
una certa scuola di pensiero, doveva corrispondere un particolare tipo di procedimento che, in caso di
violazione di quella situazione consentisse al soggetto di rivolgersi al giudice, trovando così una forma di
tutela adeguata.
Questo tipo di idea funziona solo fino a un certo punto, perché le situazioni sostanziali tutelabili sono
moltissime e sono costantemente in crescita. Il rischio è una proliferazione ad infinitum dei procedimenti.
Con questo decreto legislativo si è pensato di consolidarli, facendoli confluire verso tre modelli: il processo
ordinario di cognizione, il processo del lavoro e il procedimento sommario di cognizione.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
Il problema è stato che, ognuno di questi procedimenti che sono stati oggetto di riforma ha richiesto norme
particolari di adattamento dal vecchio procedimento al nuovo modello procedurale, con diverse
complicazioni.
Per questo motivo sono tutti d’accordo che il progetto di semplificazione è stato un completo fallimento.
Le prospettive di riforma del processo civile.
Ultimo rilievo che possiamo fare sul processo sommario di cognizione è dato dalle prospettive di riforma del
processo civile. Prospettive che, al momento, sono state abbandonate, ma che sono pur sempre molto
interessanti.
Il 9 gennaio di quest’anno è stato presentato in Senato dal Presidente del Consiglio e dal ministro Bonafede
un disegno di legge delega (n. 1662) destinato a conferire al governo una delega “per l’efficienza del
processo civile e la revisione della disciplina dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie”.
Da un lato, questo disegno si ispira al processo sommario di cognizione, dall’altro ne prevede la sparizione:
si prevede un unico modello di processo, il c.d. rito ordinario dinanzi al tribunale in composizione
monocratica – la riserva di collegialità rimarrebbe, ma sarebbe ancora più ridotta –, un modello unico, da
trattarsi anche dinanzi al giudice di pace, introdotto con ricorso e con molti elementi propri del rito sommario
di cognizione. Resta escluso uno degli elementi più importanti: il potere del giudice di decidere come debba
essere gestita la fase istruttoria.
Lo scopo di questo disegno di legge delega, che prevede questo rito esclusivo ed obbligatorio, è quello di
“assicurare la semplicità, la concentrazione della tutela giurisdizionale e l’effettività della tutela
giurisdizionale, oltre alla ragionevole durata del processo”.
Tra le varie norme di cui è prevista la modifica vi è anche un’importante modifica del giudizio d’appello, dal
quale verrebbe eliminato il filtro. Importantissime modifiche riguarderebbero poi la fase preprocessuale ,
quindi l’esperimento dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie.
IL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE.
Cognizione piena e cognizione sommaria.
Il significato di cognizione sommaria si apprezza meglio considerandolo in contrapposizione con la
cognizione ordinaria. Quest’ultima consiste in un tipo di accertamento compiuto dal giudice nella forma più
completa. Si dice infatti che è una cognizione piena ed esauriente, compiuta nel rispetto di tutte le garanzie
del procedimento e, in particolare, della garanzia del contraddittorio. In genere, la cognizione ordinaria
sfocia in una sentenza, quindi in un provvedimento dotato di una particolare forza, che prende il nome di
cosa giudicata sostanziale.
La cognizione sommaria è qualcosa di meno. Si è soliti indicarla come una cognizione più superficiale,
anche se in concreto poi essa prende aspetti variabili. Per questo non è così importante saper indicare le
diverse forme che la sommarietà assume in concreto.
Quando il provvedimento finale assume la forma di una sentenza si è quasi sempre certi che il procedimento
retrostante è a cognizione piena. Sarebbe però errato pensare che la cognizione piena si possa avere solo con
il giudizio ordinario di cognizione. Questo perché esistono anche dei procedimenti speciali di cognizione (es.
processo del lavoro, applicabile anche alle controversie in materia di locazioni). Quindi, anche se il
provvedimento ha una forma diversa dalla sentenza, non è detto che il procedimento retrostante abbia una
cognizione sommaria. Il fatto che il provvedimento finale sia un’ordinanza impone allo studioso di verificare
com’è effettivamente disciplinato il procedimento retrostante. Una riprova di tutto ciò si trova nel giudizio
sommario di cognizione: qui si parla di giudizio sommario (quanto a struttura) che si conclude con ordinanza
che, per espressa volontà del legislatore, è idonea ad acquistare autorità di cosa giudicata.
La sommarietà del procedimento assume forme diverse. Si distingue tra procedimenti sommari cautelari e
procedimenti sommari non cautelari.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
Sono procedimenti sommari cautelari quelli che hanno un carattere strumentale rispetto a un giudizio di
cognizione o un processo di esecuzione, nell’ottica di assicurare la fruttuosità dell’uno o dell’altro.
I procedimenti sommari non cautelari sono delle scorciatoie rispetto al processo ordinario. Consentono di
raggiungere il risultato più rapidamente rispetto a un ordinario giudizio di cognizione.
Per entrambi si pone un problema di stabilità del provvedimento finale, ma non si comprende l’utilità di
questa distinzione, posto che noi ci occupiamo specificamente sia dei procedimenti sommari di natura
cautelare, sia di quelli di natura non cautelare.
Tra i provvedimenti sommari di natura non cautelare, il più importante è il procedimento di ingiunzione,
detto anche procedimento monitorio.
Natura del procedimento di ingiunzione.
Si tratta un procedimento che ha natura molto risalente ed ha un’applicazione pratica molto importante,
essendo utilizzato per ovviare alla normale lentezza del procedimento ordinario.
Il procedimento monitorio mira ad ottenere un provvedimento che fa le veci di una sentenza di condanna, nel
senso che è utilizzabile come titolo esecutivo, in tempi molto più rapidi rispetto all’instaurazione di un
giudizio ordinario.
Va segnalato, inoltre, che il procedimento di ingiunzione è stato il primo procedimento a cui sono state
applicate le regole del c.d. PCT, ossia il processo civile telematico.
Il procedimento di ingiunzione è disciplinato dagli artt. 633 e ss. è applicabile per il recupero di tutti quei
crediti che abbiano ad oggetto una somma liquida di denaro, una quantità di cose fungibili o la consegna
di una cosa mobile determinata.
Nella pratica, si tratta di un procedimento che viene soprattutto utilizzato per il recupero di un credito
pecuniario, a condizione che si tratti di una somma liquida.
Il procedimento è esperibile a condizione che del credito vantato venga fornita una prova scritta. È
quindi indispensabile che il creditore sia in grado di provare i fatti costituivi del proprio credito mediante
prova scritta. Per questo motivo si parla di procedimento monitorio scritto.
A questo tipo di procedimento si contrappone il c.d. procedimento monitorio puro, in cui ci si basa solo ed
esclusivamente sulle allegazioni formulate dal creditore, cioè dal soggetto che richiede l’emanazione del
provvedimento. Nel caso italiano, invece, la mera affermazione dell’esistenza del diritto del creditore non è
sufficiente, essa deve essere supportata da prove scritte.
Quando il creditore fornisce, attraverso la prova scritta, dimostrazione dell’esistenza dei fatti costitutivi del
proprio credito, il giudice concede il provvedimento. In questo risiede la sommarietà del procedimento
monitorio.
In questa prima fase sommaria del procedimento compare, di fatto, solo il creditore in veste di richiedente. Il
giudice verifica sommariamente la fondatezza della sua pretesa, sulla base delle prove scritte, mentre in
questa fase non vi è alcuno spazio per il contraddittorio: il provvedimento, che prende il nome di decreto
ingiuntivo, viene pronunciato inaudita altera parte, senza che il debitore venga chiamato in causa. In questo
caso, quindi, la sommarietà consiste nell’assenza di un contraddittorio, che potrà essere recuperato, in via
meramente eventuale, in una seconda fase del procedimento a cognizione piena.
Il concetto di prova scritta.
È importante tenere conto che il concetto di prova scritta utilizzato dal legislatore con riferimento al
procedimento monitorio, è un concetto molto più ampio rispetto a quello utilizzato in riferimento al giudizio
ordinario di cognizione.
Ricordiamo che nel giudizio ordinario le prove scritte sono soggette a regole particolari che le qualificano e
consentono di utilizzarle in determinati contesti, o meglio, solo se la prova scritta risponde a determinati
requisiti. Nel procedimento monitorio, in considerazione del carattere sommario della sua prima fase, il
concetto è molto meno severo.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
In base all’art. 634, sono prove scritte idonee a norma dell’art. 633 le polizze e le promesse unilaterali per
scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti previsti dal codice civile. Se si pensa ai
procedimenti necessari per l’ammissione della scrittura privata nel procedimento ordinario, la differenza si
nota immediatamente.
Viene indicata poi tutta una serie di altre prove scritte utilizzabili nel contesto del procedimento monitorio
anche se non rispecchiano tutti i requisiti normalmente richiesti. In particolare, vengono in considerazione gli
estratti autentici delle scritture contabili purché vidimate e bollate nelle forme di legge e regolarmente tenute
che, nell’ambito del procedimento monitorio, fanno prova a favore dell’imprenditore anche nei rapporti con
un soggetto privato, mentre di regola queste possono essere utilizzate solamente nelle controversie tra
imprenditori (e tendenzialmente fanno prova contro l’imprenditore).
L’art. 635 riguarda la prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici.
I nn. 2 e 3 dell’art. 633 riguardano altre ipotesi in cui la prova scritta non è veramente necessaria. Il
riferimento di cui al n.2 è agli onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da
avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione
di un processo. Il n. 3 è, invece, relativo ai crediti che riguardano onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai
oppure ad altri esercenti una libera professione o arte per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
Questa norma crea un po’ di problemi perché oggi per le professioni regolamentate le tariffe non esistono
più: esse sono state sostituite da parametri ai quali occorre fare riferimento quando professionista e cliente
non abbiano concordato consensualmente l’entità dei compensi.
Ai sensi dell’art. 636, nei casi previsti dai nn. 2 e 3 dell’art. 633, le domande devono essere accompagnate
dalla parcella delle spese e prestazioni sottoscritta dal soggetto che l’ha redatta e corredata dal parere della
competente associazione professionale (es. Consiglio dell’ordine degli avvocati). Il parere non occorre se
l’ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie (non tariffe fissate tra
un minimo e un massimo).
La domanda.
La domanda si propone con ricorso al giudice competente per territorio e per valore (quindi giudice di
pace o tribunale in composizione monocratica). Tuttavia, per i crediti relativi ad attività svolte in occasione
di un processo o per quelli vantati dai liberi professionisti esistono dei fori concorrenti: in questi casi la
domanda può essere proposta o al giudice davanti al quale si è svolto il giudizio cui la richiesta di
pagamento si riferisce, oppure al giudice del luogo cui appartiene l’ordine professionale dove è iscritto
il professionista.
In ogni caso, nella determinazione della competenza per valore si applicano le regole ordinarie. La forma
della domanda resta sempre la stessa: il ricorso deve contenere tutti gli elementi di cui all’art. 125, compresa
l’indicazione dell’avvocato cui è stato conferito il mandato. L’art. 638 fa anche riferimento alla possibilità
che la parte si costituisca personalmente, in quelle ipotesi in cui ciò è possibile, ma nella prassi questo accade
molto raramente, quindi la norma ha scarsa rilevanza.
Il ricorso va depositato in cancelleria, insieme ai documenti che costituiscono la prova dei fatti costitutivi del
credito.
L’art. 640 considera la particolare ipotesi del rigetto della domanda. Il giudice, ovviamente, può rigettare la
domanda per qualunque ragione processuale o di merito (per incompetenza, difetto di giurisdizione, assenza
di uno dei presupposti processuali, ecc.). La norma, tuttavia, tratta dell’ipotesi particolare in cui il giudice
consideri insufficientemente giustificata la domanda: ciò significa che il ricorrente non è stato in grado di
fornire l’adeguata prova documentale che era richiesta dalle norme. In questo caso è previsto che il
cancelliere dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere all’integrazione della prova. Se l’invito non è
accolto o la domanda non può essere accolta per altre ragioni o non è ancora adeguatamente supportata, il
giudice la rigetta con decreto motivato. L’ultimo comma specifica che il rigetto non pregiudica la
riproposizione della domanda, sia in via monitoria, sia in via ordinaria.
L’art. 641 disciplina poi l’ipotesi dell’accoglimento della domanda. Il giudice, dopo aver compiuto un
accertamento sui presupposti ex art. 633, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito
del ricorso (ma è opinione consolidata che tale termine sia puramente ordinatorio), ingiunge all’altra parte –
il debitore – di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose richieste nel termine di
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
quaranta giorni (o nel termine maggiore o minore stabilito dal giudice), con l’espresso avvertimento che
nello stesso termine può essere proposta opposizione e che, in mancanza – di questa o di spontaneo
adempimento –, si procederà a esecuzione forzata. La pronuncia del decreto presuppone, oltre all’esistenza
dei presupposti di cui all’art. 633, che non vi siano ragioni di rito (es. vizio di competenza, difetto di
giurisdizione, carenza di interesse o legittimazione ad agire) o ragioni di merito (es. valutazione negativa
della prova) che la impediscano e che non si verifichi l’ipotesi di cui all’art. 640, ossia il rigetto derivante da
una scarsa documentazione, non integrata come richiesto dal giudice.
Chi presenta ricorso per ottenere decreto ingiuntivo lo fa nella prospettiva di poter procedere il prima
possibile all’esecuzione forzata: in sé e per sé il decreto non è immediatamente efficace. Ciò non toglie la
possibilità di richiedere la provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 642. La norma distingue due ipotesi:
l’ipotesi in cui il giudice deve concedere l’esecuzione provvisoria e l’ipotesi in cui può concederla.
La prima ipotesi si verifica quando il credito è fondato su cambiale, assegno bancario o circolare, certificato
di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio. In questo caso il giudice, su richiesta del ricorrente,
ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione
provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione.
La seconda ipotesi prevede la possibilità, ma non l’obbligo, di prevedere la provvisoria esecuzione se vi è
pericolo di grave pregiudizio nel ritardo o se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore
(es. riconoscimento di debito).
Nel caso in cui il giudice conceda immediata esecutorietà, il termine di quaranta giorni viene fissato solo ai
fini della proposizione dell’opposizione.
La norma sulla provvisoria esecuzione deroga all’art. 482, secondo il quale non si può iniziare l’esecuzione
forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso prima che siano decorsi dieci
giorni dalla notificazione di esso.
Il decreto va, infatti, notificato all’ingiunto ai sensi dell’art. 643, il quale afferma che copia autentica del
ricorso e del decreto sono notificati al debitore, mentre gli originali rimangono depositati in cancelleria.
Inoltre si stabilisce che la notificazione determina la pendenza della lite. Effetti tipici della litispendenza
sono gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Il decreto di ingiunzione perde efficacia se la notificazione non è eseguita nel termine di sessanta giorni
dalla pronuncia (art. 644). Occorre fare riferimento all’art. 188 disp. att.: nel caso in cui non si sia verificata
la notificazione, il debitore, con ricorso, può chiedere al giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo di
dichiararne l’inefficacia. Il giudice fisserà allora un’udienza per la comparizione delle parti e il termine entro
il quale ricorso e decreto devono essere notificati alla controparte. Se all’udienza viene accolta la domanda
del debitore, il giudice dichiara con ordinanza non impugnabile l’inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli
effetti.
Se l’istanza è rigettata, il debitore può proporre ordinaria domanda di accertamento negativo e instaurando il
giudizio ordinario di cognizione.
L’opposizione.
Dal punto di vista puramente descrittivo si può considerare un’impugnazione del decreto ingiuntivo. Essa è
la difesa concessa al debitore ingiunto ed è anche l’atto con il quale si riequilibra la posizione delle parti
e si compensa quella sommarietà caratteristica della prima fase del provvedimento. L’opposizione introduce
un ordinario giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla sussistenza o meno delle condizioni
del decreto, ma è dato dall’esistenza o meno del diritto di credito che il creditore aveva vantato chiedendo
l’emanazione del decreto ingiuntivo.
L’opposizione si propone con atto di citazione davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice
che ha emesso il decreto ingiuntivo (art. 645). A norma del secondo comma dell’articolo, il giudizio, in
seguito all’opposizione, si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito,
quindi il procedimento ordinario di cognizione, oppure se il credito deriva da lavoro o da locazione si
seguiranno gli artt. 409 ss.
Opposizione tempestiva e opposizione tardiva (art. 650). Prima di trattare le peculiarità dell’opposizione è
necessario distinguere tra opposizione tempestiva e opposizione tardiva.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
L’opposizione è tempestiva se proposta entro i canonici quaranta giorni assegnati dal giudice nel momento in
cui pronuncia il decreto ingiuntivo. L’opposizione tardiva è prevista dall’art. 650 solo nel caso in cui
l’intimato dimostri che non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione,
caso fortuito o forza maggiore.
La prima particolarità del procedimento di opposizione è che esso viene instaurato dal debitore ingiunto, il
quale dal punto di vista processuale è l’attore. Si ritiene però che, nonostante questa posizione processuale,
sia sempre il creditore il soggetto sul quale grava l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto di
credito secondo le regole ordinarie. Sul debitore grava solo l’onere di provare eventuali fatti impeditivi,
modificativi o estintivi del diritto di credito.
Altra peculiarità che si riconnette a questa particolare inversione dei ruoli che troviamo nel giudizio di
opposizione riguarda proprio le prove. Per la prova dell’esistenza del diritto di credito, il creditore opposto
dovrà fare riferimento alla disciplina ordinaria delle prove: il concetto di prova in senso ampio tipico del
giudizio sommario del procedimento di ingiunzione non trova applicazione in questa seconda fase.
Ulteriore particolarità risiede nell’esecutorietà del decreto per mancata opposizione o mancata attività
dell’opponente. Ai sensi dell’art. 647, se il debitore non propone opposizione entro il termine stabilito, o
non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara
esecutivo. In questo caso l’opposizione non può più essere proposta né proseguita, a meno che non ricorrano
le condizioni ex art. 650 per l’opposizione tardiva.
In pendenza di giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo, se non è già stato dotato ab origine di efficacia
esecutiva, può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo in base all’art. 648. Anche qui si distinguono
due ipotesi: l’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato provvisoriamente esecutivo dal
giudice e quella in cui può essere dichiarato tale.
Nel primo caso, il giudice deve concedere esecuzione provvisoria se la parte che la chiede offre cauzione.
Nel secondo caso, il giudice può concedere l’esecuzione se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di
pronta soluzione, sempre che l’esecuzione provvisoria non sia già stata concessa nella fase sommaria. Il
dibattito della dottrina è abbastanza controverso riguardo al significato di “pronta soluzione”, poiché la
locuzione non si riferisce al giudizio di opposizione, ma alla prova dedotta dall’opponente. La dottrina parla
genericamente di una prova documentale che non richiede una grande attività istruttoria.
Nel caso in cui il decreto ingiuntivo avesse già efficacia esecutiva, l’art. 649 prevede che il giudice, su
istanza dell’opponente e quando ricorrono gravi motivi (che dovrà valutare caso per caso), può sospendere
l’esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell’art. 642, con ordinanza non impugnabile.
Queste ipotesi sono molto importanti perché, dal punto di vista del creditore vi è il vantaggio di ottenere
rapidamente un titolo esecutivo, mentre dal punto di vista del debitore è altrettanto importante cercare di
bloccare l’inizio dell’esecuzione forzata attraverso questi meccanismi.
Altra particolarità è la possibilità che nel corso del giudizio di opposizione le parti si concilino. In questo
caso, in base all’art. 652, il giudice con ordinanza non impugnabile dichiara o conferma l’esecutività del
decreto, oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest’ultimo caso rimane ferma
la validità degli atti esecutivi compiuti e dell’ipoteca iscritta fino a concorrenza della somma o quantità
ridotta. Della riduzione, inoltre, deve darsi annotazione nei registri immobiliari.
Il giudizio di opposizione introduce un normale giudizio a cognizione piena. La sentenza che chiude il
giudizio di opposizione si sostituisce al decreto, sia che accolga l’opposizione, sia che la rigetti. L’art. 653
afferma che, se l’opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva,
oppure è dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo, il decreto che non ne sia già munito acquista
efficacia esecutiva. In questo caso, il decreto ingiuntivo acquista la particolare efficacia della sentenza
passata in giudicato. Se l’opposizione viene accolta, il decreto è immediatamente caducato, quindi perde
efficacia immediatamente. Se l’opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito dalla
sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti conservano i loro effetti.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
L’impugnazione.
Se non viene proposta opposizione, l’opposizione è stata rigettata o il giudizio si è estinto, si dice che il
decreto ingiuntivo acquisisce efficacia assolutamente equiparabile a quello di sentenza passata in giudicato,
ossia l’efficacia di cosa giudicata sostanziale ex art. 2909 c.c.
La dottrina e la giurisprudenza sono concordi su questa equivalenza, ma non troviamo da nessuna parte una
norma che enunci questo principio. L’unico indizio normativo che ci fa propendere per questa tesi è
contenuto nell’art. 656, che menziona le impugnazioni esperibili contro il decreto ingiuntivo. Secondo la
norma, il decreto di ingiunzione divenuto esecutivo a norma dell’art. 647 possa impugnarsi per revocazione
nei casi previsti dall’art. 395 nn. 1, 2, 5 e 6, nonché con opposizione di terzo nei casi previsti dall’art. 404
secondo comma. Quindi il decreto ingiuntivo non opposto o rispetto al quale l’opposizione è rigettata è
suscettibile di impugnazione straordinaria.
Se noi andiamo ad analizzare i motivi di revocazione straordinaria esperibili contro il decreto ingiuntivo,
vediamo che uno dei motivi di revocazione (il n. 5) è proprio il contrasto con una precedente sentenza
passata in giudicato: si desume il principio secondo cui il decreto ingiuntivo nelle tre ipotesi indicate ha
efficacia di una sentenza passata in giudicato.
LA CONVALIDA DI SFRATTO.
Si tratta di un procedimento molto tecnico, abbastanza complesso, ma con una rilevanza pratica notevole.
È un procedimento sommario in cui la sommarietà non significa assenza di contraddittorio nella prima fase
del procedimento, come invece accade nel procedimento monitorio.
Il procedimento per convalida di sfratto inizia con atto di citazione, quindi il contraddittorio è assicurato fin
dall’inizio. La sommarietà è legata alla struttura del procedimento stesso, ossia al fatto che determinate
conseguenze relative all’esito della procedura dipendono dal comportamento del convenuto. Questo
procedimento è una scorciatoia attraverso la quale il locatore può ottenere, rispetto ad un ordinario giudizio,
il rilascio della cosa che ha dato in locazione.
L’art. 657 parla, oltre che del locatore, anche del concedente. Il riferimento è ai contratti agrari, che però
oggi hanno scarsa rilevanza.
Il locatore è colui che concede, dietro il pagamento di un canone, il godimento di un immobile al conduttore.
Questa scorciatoia tende ad ottenere un provvedimento che condanni il conduttore al rilascio dell’immobile
locato.
L’ambito di applicazione della norma è individuato dall’art. 657, rubricato intimazione di licenza e di
sfratto per finita locazione, nonché dall’art. 658, rubricato intimazione di sfratto per morosità. Da qui si
comprende che il locatore può intimare il rilascio dell’immobile in due ipotesi: per finita locazione o per
morosità.
Per quanto riguarda la finita locazione, l’intimazione può essere fatta prima della scadenza del contratto o
anche dopo. Prima della scadenza del contratto l’intimazione dovrà rispettare i termini previsti dal
contratto. In questo caso il locatore può anche citare il conduttore per la convalida della licenza, ossia per la
convalida del provvedimento di rilascio dell’immobile. Dato che il rilascio può essere intimato anche prima
della locazione, siamo in presenza di un locatore che chiede, di fatto, la pronuncia di una condanna pro
futuro, ossia una tutela preventiva, che opera in casi specifici previsti dalla legge, operante rispetto ad un
futuro eventuale inadempimento. La condanna diventa operativa se e in quanto l’inadempimento si verifica.
Qui, ovviamente, non si tratta di inadempimento, ma della scadenza di un contratto.
L’intimazione è possibile anche dopo la scadenza del contratto, sempre che le disposizioni non prevedano
la proroga automatica del contratto e sempre che il locatore non abbia messo in atto i meccanismi che
ne prevedono la proroga di diritto.
L’intimazione di sfratto per morosità avviene per il mancato pagamento dei canoni. In questo caso, il
locatore può contestualmente richiedere che il giudice pronunci un provvedimento per il pagamento dei
canoni già scaduti.
Il giudice competente è il giudice del luogo in cui si trova l’immobile oggetto del contratto di locazione (in
applicazione degli artt. 21.1 e 447bis).
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
La forma dell’intimazione.
L’intimazione assume la forma di un normale atto di citazione, il quale è, però, privo di alcuni degli
elementi di cui all’art. 163, posto che l’art. 660.3 richiama solo l’art. 125. In particolare, l’intimazione non
deve contenere quel requisito previsto dal n. 7, ossia l’invito al convenuto a comparire, pena le decadenze di
cui all’art. 38 (le varie eccezioni di competenza) e 167 (decadenze relative a domande riconvenzionali e alle
eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio). Al posto di quanto previsto dall’art. 163.3 n. 7,
l’intimazione deve contenere l’invito a comparire all’udienza e l’avvertimento che, in caso di mancata
comparizione, il giudice convaliderà la licenza o lo sfratto.
Altra differenza rispetto all’ordinario atto di citazione è che il termine di comparizione è di almeno venti
giorni liberi (nel computo dei quali non si tiene conto né del dies a quo, né del dies ad quem), mentre di
norma il termine per la comparizione davanti al tribunale è di novanta giorni. Per quanto riguarda le cause di
pronta spedizione, ossia le cause che presentano profili di urgenza, il giudice può, su istanza dell’intimante,
abbreviare fino alla metà il termine.
La costituzione delle parti non segue le regole ordinarie, potendo avvenire anche mediante deposito
dell’intimazione da parte del locatore e, per il conduttore, deposito della comparsa di risposta in cancelleria,
oppure in alternativa presentando i documenti, ossia l’intimazione e la comparsa di risposta,
direttamente in udienza. Inoltre, per il conduttore non è neppure necessaria una formale costituzione
mediante difensore: se compare in udienza perché vuole opporsi alla convalida e svolgere particolari attività,
è sufficiente la comparizione personale.
L’intimazione deve essere notificata al conduttore. Se la notificazione non è fatta in mani proprie del
conduttore, è necessario che l’ufficiale giudiziario ne dia comunicazione all’intimato mediante
raccomandata. La raccomandata dovrà poi essere allegata all’intimazione.
L’udienza.
Questa fase può avere esiti diversi. La prima ipotesi è quella contemplata dall’art. 662, che disciplina la
mancata comparizione del locatore, sancendo che gli effetti dell’intimazione cessano se questi non
compare all’udienza fissata. Presumibilmente il giudice in questo caso adotterà una pronuncia in rito, quindi
dichiarerà il processo estinto per inattività della parte, oppure la domanda inammissibile o improcedibile.
Tuttavia, si deve ritenere che l’intimazione, anche se gli effetti processuali cessano, mantenga gli effetti
sostanziali e valga come atto che impedisce la rinnovazione del contratto di locazione.
Più complessa è l’ipotesi prevista dall’art. 663, sulla mancata comparizione o opposizione dell’intimato.
Se l’intimato non compare o non si oppone in udienza, il giudice convalida la licenza o lo sfratto mediante
ordinanza scritta in calce all’atto di citazione e dispone che con questa ordinanza sia apposta la formula
esecutiva.
Tuttavia, se appare probabile o risulta con certezza che il conduttore non ha avuto conoscenza della citazione
o non è potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, il giudice dispone la rinnovazione della
citazione e fissa una nuova udienza.
Se si tratta invece di sfratto per morosità, per la convalida è necessario che il locatore o il suo procuratore
attestino che la morosità persiste. Se questa attestazione manca o il locatore conferma che la morosità è
cessata lo sfratto non può essere intimato, ma il processo può proseguire come giudizio ordinario se l’attore
vuole in ogni caso la risoluzione del contratto per inadempimento.
Nello sfratto per morosità può essere anche chiesto congiuntamente un decreto ingiuntivo per i canoni
scaduti o quelli che scadranno fino all’effettiva esecuzione dello sfratto, oltre alle spese per l’intimazione.
Con la convalida dello sfratto il giudice pronuncia anche questo decreto ingiuntivo che è immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 654, ma suscettibile di opposizione da proporsi come normale opposizione a
decreto ingiuntivo.
In tutto ciò sta la sommarietà del procedimento, il quale si ricollega a una omissione dell’intimato, in quanto
o non c’è la comparizione all’udienza, o non c’è la proposizione dell’opposizione che consentirebbe di
bloccare l’iniziativa del locatore.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
In ogni caso, il giudice nella pronuncia della convalida dovrebbe, oltre che verificare le condizioni di cui
abbiamo parlato, compiere anche un accertamento in ordine ai presupposti processuali, nonché a ciò che
renderebbe la domanda fondata da un punto di vista sostanziale, ad esempio verificando che la morosità è
effettiva, che la disdetta data dal locatore sia valida, ecc.
L’art. 667 si occupa del comportamento attivo del conduttore ingiunto. Se il conduttore compare e si
oppone alla convalida, per qualunque ragione, sia essa processuale o di merito, il processo deve proseguire
come un normale giudizio di cognizione, previo mutamento del rito con ordinanza ex art. 426. Mediante
questa ordinanza, il giudice, avendo verificato che è stata instaurata mediante rito ordinario una causa
rientrante tra quelle da trattarsi con il rito del lavoro, dispone la fissazione dell’udienza ex art. 420 (udienza
di trattazione) e assegna alle parti un termine perentorio per l’integrazione degli atti introduttivi. Questo
stesso tipo di ordinanza si adotta in quanto il rito locatizio segue il rito del lavoro, in quanto compatibile,
secondo quanto dispone l’art. 447bis.
Prima di disporre il mutamento del rito, il giudice può emettere, ai sensi dell’art. 667 prima parte, due
provvedimenti: si tratta dei provvedimenti di cui all’art. 665 e 666.
Per quanto riguarda l’ipotesi di cui all’art. 665, se il conduttore intimato compare alla prima udienza e
propone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore e se non sussistono gravi
ragioni contrarie, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto.
L’ordinanza è immediatamente esecutiva, ma può essere subordinata ad una cauzione. Si tratta dell’ipotesi
che va sotto il nome di condanna con riserva di eccezioni. Essa è una condanna sommaria e provvisoria, in
quanto il suo destino dipende dall’esito del successivo svolgimento del processo.
L’altra ipotesi riguarda esclusivamente il caso in cui sia stata richiesta licenza di sfratto per morosità. In
questo caso il conduttore intimato può comparire e contestare la morosità solo per quanto riguarda
l’ammontare dei canoni. In questo caso, per quanto la norma non lo dica, c’è un’implicita ammissione di
inadempimento. Il giudice può disporre il pagamento della somma non contestata, concedendo al conduttore
un termine per adempiere. Anche qui, se il convenuto non adempie, il giudice convalida l’intimazione di
sfratto e, se il locatore l’aveva richiesto, emette un decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni. Qui la
similitudine è con l’ordinanza per il pagamento delle somme non contestate ex art. 186bis.
L’ordinanza di convalida.
L’opinione prevalente ritiene che l’ordinanza di convalida di licenza o di sfratto abbia efficacia
corrispondente a quella di una sentenza passata in giudicato, o meglio di una sentenza di condanna al rilascio
o, nel caso di sfratto per morosità, di una sentenza di condanna per risoluzione del contratto di locazione.
Contro l’ordinanza di convalida il legislatore prevede solo l’opposizione tardiva di cui all’art. 668, che è
possibile solo quando la convalida è stata pronunciata senza che il conduttore o intimato sia comparso
all’udienza e sempre che sia in grado di dimostrare di non aver avuto notizia della intimazione per vizi
della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Questa opposizione non è più proponibile decorsi dieci giorni dall’inizio dell’esecuzione forzata in forma
specifica per rilascio dell’immobile.
L’opposizione tardiva (dopo la convalida) si propone al tribunale del luogo dove si trova l’immobile e che ha
disposto il rilascio, nelle forme dell’opposizione a decreto ingiuntivo, sempre con l’applicazione del rito di
cui all’art. 447bis.
L’opposizione non sospende l’esecuzione, ma il giudice può disporre la sospensione per gravi motivi ed
eventualmente con cauzione.
Al di là dell’opposizione tardiva, si discute in dottrina su quali siano i rimedi contro l’ordinanza di convalida.
Balena menziona l’orientamento giurisprudenziale che tende a considerare l’ordinanza di convalida come
equivalente a una sentenza di primo grado suscettibile di impugnazioni ordinarie. Menziona anche
l’orientamento della Corte costituzionale, secondo la quale l’ordinanza sarebbe suscettibile di revocazione
ordinaria per errore di fatto e straordinaria per dolo di una parte in danno dell’altra, oltre che suscettibile di
opposizione di terzo ex art. 404.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
Infine, dobbiamo ricordare che, se il locatore, nel caso di sfratto per morosità, non aveva chiesto il decreto
ingiuntivo per i canoni non pagati, l’ordinanza di convalida in base all’art. 669 risolve la locazione, ma lascia
impregiudicata la questione dei canoni non pagati.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
INTRODUZIONE.
Il sistema attuale di diritto internazionale privato è ancora improntato al principio di cittadinanza. Questo
comporta che in materia di statuto personale, l’interprete italiano è portato ad applicare spesso una legge
straniera, con tutte le conseguenze che ne derivano. Si tratta di una fedeltà a una visione ottocentesca che mal
si concilia con la situazione attuale e che sembra superata già da tempo dalla tendenza degli altri stati e delle
organizzazioni internazionali che si occupano di tematiche internazionalprivatistiche, le quali utilizzano il
criterio della residenza abituale.
La residenza abituale è un criterio che ha fatto la sua comparsa nel secolo scorso nelle convenzioni adottate
dalla Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato e oggi è adottato da pressoché tutti i regolamenti
UE che si occupano di situazioni con implicazioni transfrontaliere sia dal punto di vista processuale, sia da
quello dell’individuazione della legge applicabile. Questo è un criterio di fatto, nel senso che si deve andare a
vedere dove la persona risiede con voluto carattere di abitualità.
È un criterio che è stato interpretato dalla giurisprudenza nazionale e della Corte di Giustizia nel senso di
fare riferimento a un dato di fatto, a prescindere dalle risultanze anagrafiche della residenza. Non è
sufficiente che la persona sia stabilita nel territorio dello stato, occorre anche l’abitualità, l’intenzione di
rimanere su quel territorio. Questo è un aspetto psicologico, soggettivo e difficile da accertare. Se un
soggetto si trasferisce in Francia con l’idea di restarci perché si trova bene e ha trovato un lavoro, ma
successivamente si trova a doversi spostare in un altro stato, anche per quei pochi mesi la sua residenza
abituale è stata in Francia. Questo perché quello che rileva non è il tempo della residenza, ma l’abitualità.
Pensiamo all’ipotesi in cui il soggetto si trasferisce in Francia provvisoriamente, avendo già in mente di
trasferirsi al più presto in Germania per lavorare. In realtà poi si trova benissimo a Parigi e ci sta un anno. In
questo caso, poiché l’intenzione iniziale era quella di stare provvisoriamente e rimane il proposito di andare
in Germania, anche se il periodo di permanenza è più lungo di quello dell’esempio precedente, non c’è il
carattere di abitualità.
La Comunità Europea (a partire dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla giurisdizione e il
riconoscimento delle sentenze in materia civile e commerciale) all’inizio aveva fatto suo un altro criterio
territoriale che è quello del domicilio. Il criterio del domicilio è un criterio più antico rispetto a quello della
residenza abituale ed è il criterio di collegamento impiegato nei Paesi di immigrazione fin dalle origini.
La Convenzione di Bruxelles utilizza questo criterio, in particolare il criterio del domicilio del convenuto.
Ben presto, tuttavia, la Comunità Europea lascia questo criterio per adottare quello della residenza abituale.
Nel 1980, infatti, la Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in assenza di
scelta dal parte dei contraenti della legge applicabile individua come criterio proprio quello della residenza
abituale della parte tenuta alla prestazione caratteristica. E da allora, il criterio che viene utilizzato dalla
normativa comunitaria in materia internazionalprivatistica diventa proprio questo. Con un’unica eccezione: i
regolamenti che derivano dalla Convenzione di Bruxelles hanno mantenuto fermo il criterio del domicilio. In
realtà il legislatore comunitario si era interrogato sull’opportunità di cambiare criterio, ma aveva deciso di
mantenere quello del domicilio, in quanto il criterio della residenza abituale meglio si attaglia alle questioni
di diritto di famiglia e di natura interpersonale, mentre la materia civile e commerciale, riguardando le
obbligazioni è forse meno adatta.
Oggi, se si dovesse riformare la l. 218/1995, probabilmente si opterebbe per il criterio della residenza
abituale, in luogo di quello della cittadinanza.
La conoscenza delle norme straniere.
La prima domanda che ci dobbiamo porre è se il diritto straniero deve essere considerato un diritto – e come
tale deve essere conosciuto d’ufficio dall’interprete, nella specie il giudice italiano – oppure, essendo un
diritto di un altro stato, sia equiparabile ad un fatto e quindi la regola sarebbe quella dell’onere probatorio a
carico delle parti.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
In passato, questo problema è stato affrontato e risolto in maniera differente dalla giurisprudenza e dalla
dottrina.
La dottrina riteneva che il diritto straniero fosse da considerare un diritto, esattamente come il diritto italiano,
e come tale dovesse essere conosciuto d’ufficio dal giudice. Non solo, la violazione o la falsa applicazione
del diritto straniero era ritenuta equiparabile alla violazione del diritto italiano, quindi veniva ad integrare un
vizio di legittimità della decisione, con la possibilità di fare ricorso in cassazione.
La giurisprudenza ricostruiva il diritto straniero come un fatto. La logica stava nella separatezza degli
ordinamenti giuridici. Il diritto italiano, quindi, non aveva niente a che fare con il diritto straniero e il
principio iura novit curia valeva solo per il diritto italiano. L’onere della prova era a carico della parte
interessata, quindi senza la prova il giudice doveva applicare il diritto italiano. Inoltre, la falsa o errata
applicazione del diritto straniero non integrava un vizio di legittimità, con conseguente impossibilità di
esperire un ricorso per cassazione.
La diversità di posizione si spiega anche dal punto di vista pratico: la dottrina ragiona in termini teorici; la
giurisprudenza no. A volte diventa molto difficile conoscere il diritto straniero.
In sede di riforma, nel 1995, il legislatore ha codificato il principio iura novit curia, partendo dal
presupposto che il diritto straniero è un diritto e stabilendo l’obbligo del giudice di conoscere il diritto
straniero. L’art. 14 della l. 218/1995, infatti, stabilisce che “1. L’accertamento della legge straniera è
compiuto d’ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle
convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può
altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate”. La norma parla di collaborazione di istituzioni ed
esperti nella ricerca di informazioni sul diritto straniero. Il secondo comma fa un cenno anche all’aiuto delle
parti. Aiuto che è diverso dall’onere probatorio. Se le parti non collaborano, infatti, non vengono meno
all’onere probatorio: semplicemente tengono un comportamento processuale di cui il giudice potrà poi tenere
conto. Se il giudice non riesce a conoscere la legge straniera, interviene il secondo comma dell’art. 14, in
base al quale “2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l’aiuto
delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la
medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana”. Quindi se nella norma di d.i.p.
vengono impiegati più criteri di collegamento (es. legge nazionale del soggetto, oppure legge del domicilio o
residenza del soggetto), il giudice potrà ricercare la soluzione del caso nell’ambito di uno di quegli
ordinamenti. Se il criterio è solo uno e la legge non può essere accertata, allora il giudice potrà utilizzare il la
lex fori.
I criteri di interpretazione delle norme straniere.
Conoscere ed applicare il diritto straniero significa conoscere non solo il diritto materiale, ma anche il d.i.p.
dell’ordinamento straniero. Una volta accertato il contenuto, tuttavia, occorre interpretarlo. Qui sorge un
altro problema che è quello dei criteri di interpretazione delle norme straniere.
L’art. 15 stabilisce che: “La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di
applicazione nel tempo”. Il giudice quindi applicherà le norme secondo i propri criteri interpretativi. Si
dice che è come se il giudice italiano si mettesse il cappello del giudice straniero e si ponesse nella sua ottica.
Il giudice straniero interpreta il diritto secondo i criteri propri dell’ordinamento.
Può capitare che il diritto straniero si riveli non conforme ai principi costituzionali italiani. In questo caso,
scatterà il limite dell’ordine pubblico. Il diritto straniero potrebbe anche risultare non conforme alla
costituzione straniera. Il giudice, ovviamente non può sindacare la conformità alla costituzione straniera.
Laddove l’ordinamento straniero non avesse un sistema accentrato di controllo di costituzionalità, ma avesse
un sistema diffuso, tale per cui ciascun giudice potrebbe controllare la conformità alla costituzione delle
norme legislative, allora, se è vero che il giudice italiano è come se si mettesse il cappello del giudice
straniero, potrebbe disapplicare la norma straniera ritenendola contraria alla costituzione straniera.
La qualificazione.
Un altro problema è quello di individuare la legge applicabile della persona apolide o con più cittadinanze.
È il problema della c.d. qualificazione, ossia di quell’operazione di interpretazione, necessaria quando
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
l’interprete ha di fronte dei termini giuridici. Il concetto di cittadinanza va ricostruito secondo un criterio
generale: essa è il vincolo che lega un cittadino ad uno Stato. Tuttavia, i criteri che regolano la cittadinanza
variano da Stato a Stato, nel senso che l’interprete italiano non può presumere che sia cittadino dello Stato X
un soggetto i cui genitori siano cittadini dello Stato X. Infatti, non tutti gli Stati utilizzano il criterio dello ius
sanguinis, come fa il diritto italiano. I sistemi di common law, ad esempio, utilizzano il criterio dello ius soli.
L’interprete dovrà quindi verificare caso per caso.
Se un soggetto è apolide – quindi non ha la cittadinanza – o è rifugiato – quindi ha la cittadinanza, ma di
fatto non ne usufruisce in quanto perseguitato in quello Stato – è protetto a livello internazionale. Vi sono
infatti due convenzioni: la prima è del 1951 e disciplina la protezione dei rifugiati, la seconda è del 1954 e
tratta della protezione degli apolidi. Sono convenzioni che hanno identico contenuto e stabiliscono che questi
soggetti sono sottoposti alla legge dello Stato di residenza o del domicilio. Proprio ispirandosi a queste
convenzioni, il legislatore all’art. 19 della l. 218/1995, rubricata “Apolidi, rifugiati e persone con più
cittadinanze” stabilisce che: “1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge
nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o, in
mancanza, la legge dello Stato di residenza”. Quindi, si applicano le stesse regole previste dalle due
convenzioni.
Una soluzione diversa viene ipotizzata per il pluricittadino. Questi è un soggetto che ha almeno due
cittadinanze. Qual è la legge che si applica a un soggetto che ha più cittadinanze laddove la norma di d.i.p.
richiami la legge nazionale? Se noi ci ponessimo nell’ottica internazionale, quando un soggetto ha più
cittadinanze, la cittadinanza che rileva è quella effettiva, ossia quella di cui il soggetto normalmente
usufruisce, vivendo e risiedendo. Laddove tale soggetto fosse in uno Stato straniero e avesse bisogno di
protezione, dovrebbe richiederla alle autorità consolari e diplomatiche dello Stato in cui risiede. Se il
soggetto è francese e tedesco, si trova in Spagna in difficoltà e vive a Parigi, parla francese e ha una famiglia
in Francia, dovrà chiedere all’ambasciata francese e non a quella tedesca. Da questo punto di vista il
legislatore si allinea alla soluzione internazionale, prevedendo che: “2. Se la persona ha più cittadinanze, si
applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto”.
L’ultima frase del secondo comma, tuttavia, aggiunge: “Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa
prevale”. Qui abbiamo un elemento di rottura perché viene fatta prevalere la cittadinanza italiana a
prescindere dall’effettività. Le spiegazioni di questa regola sono due: la prima, più teorica, è che essendoci la
cittadinanza italiana, non c’è un elemento di estraneità, quindi come tale il soggetto va sottoposto alla legge
italiana. Esiste poi una spiegazione più pratica: l’applicazione della legge italiana è più semplice e crea meno
problemi al giudice. Resta comunque il problema della difformità rispetto alla regola internazionale, quindi
si potrebbe ravvisare una violazione del principio internazionale di effettività. Ma c’è di più. Su una norma
analoga di un altro ordinamento è intervenuta la Corte di giustizia. Si tratta del leading case del 2003 Garcìa
Vello. Il sig. Garcìa Vello, spagnolo, risiedeva con la moglie belga in Belgio. Dalla coppia nascono due figli
che assumono la doppia cittadinanza. I figli vengono registrati dall’ufficiale civile belga con il cognome del
padre, secondo il diritto belga. I genitori, però, avrebbero voluto che i bambini assumessero anche il
cognome della madre, in conformità al diritto spagnolo, quindi chiedono di modificare l’atto di nascita. La
domanda viene respinta, in quanto nel d.i.p. belga è presente una norma che sottopone lo stato personale alla
legge nazionale e prevede che, ove presente, prevalga la cittadinanza belga. La coppia presenta ricorso alla
Corte di giustizia la quale ravvisa una discriminazione sulla base della cittadinanza. La Corte afferma che
non si può sminuire la cittadinanza attribuita da un altro Stato membro per il solo fatto che l’interessato
risiede nel foro di un altro Stato membro di cui pure ha la cittadinanza.
Si pone quindi il problema di come debbano comportarsi gli interpreti nei confronti di un soggetto che, oltre
alla cittadinanza italiana, abbia anche quella straniera. Le soluzioni possono essere due. L’interprete potrebbe
attenersi al dettato normativo della legge 218/1995 e quindi considerare il soggetto italiano, oppure
considerare prevalente la giurisprudenza della Corte di giustizia, disapplicando la norma nazionale e
considerando la cittadinanza effettiva del soggetto. Alcuni giudici hanno, fin dal 2004, optato per la seconda
soluzione, disapplicando l’ultima frase dell’art. 19.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
Le norme di d.i.p. materiale.
Occorre tenere presente che, accanto alle norme della l. 218/1995, le quali sono norme di diritto
internazionale privato classico (di conflitto, che risolvono il conflitto tra leggi), esistono norme diverse che
sono di diritto internazionale privato materiale. Queste sono norme che risolvono direttamente la
questione, senza rimandare all’ordinamento straniero, come fanno le norme classiche, ma rispondendo esse
stesse con una specifica disciplina. Un esempio è rappresentato dall’art. 116 c.c., che riguarda il matrimonio
dello straniero in Italia e detta una serie di regole. Secondo l’articolo, se lo straniero vuole sposarsi in Italia
deve produrre all’ufficiale dello stato civile un documento rilasciato dalle autorità consolari da cui risulti che
nulla osta alla celebrazione del matrimonio. Inoltre, l’art. 116 prevede la necessità che siano rispettate alcune
norme del codice civile italiano: si tratta delle norme riguardanti il possesso di stato libero, l’assenza di
determinati impedimenti o di vincoli familiari. Queste norme sono considerate norme di applicazione
necessaria, nel senso che vanno applicate agli italiani e agli stranieri.
Un’altra norma di d.i.p. materiale è rappresentata dall’art. 3 l. 898/1970 sul divorzio, che considera come
motivo di divorzio il fatto che il coniuge straniero abbia contratto nuovo matrimonio o abbia sciolto il
matrimonio all’estero.
L’ultimo esempio è rappresentato dalla disciplina dell’adozione internazionale contenuta nella l. 184/1983.
Questa legge disciplina sia l’adozione nazionale, sia quella internazionale.
Questo corpus normativo di d.i.p. si affianca alla l. 218/1995. Tuttavia, nel settore esistono sempre più norme
che discendono da convenzioni internazionali o da atti dell’UE.
Esempi di convenzioni di d.i.p. sono: la Convenzione di Bruxelles del 1968, concernente la competenza
giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; la Convenzione di Roma del
1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Sono convenzioni stipulate dalla Comunità
europea, la quale all’epoca non aveva competenza in materia di d.i.p. e ha dovuto ricorrere al metodo
classico di cooperazione internazionale, ossia alla stipulazione di un trattato.
Un altro esempio è la Convenzione dell’Aia del 1961 relativa alla competenza delle autorità e alla legge
applicabile in materia di protezione dei minori, stipulata nell’ambito della Conferenza dell’Aia di diritto
internazionale privato.
Con il passare del tempo, alla fine del secolo scorso, la comunitarizzazione del d.i.p. si è affermata con
sempre maggiore incisività, tant’è che troviamo nel TFUE una norma – l’art. 81 – che attribuisce all’UE la
competenza in materia di situazioni con implicazioni transfrontaliere. La competenza riguarda sia gli aspetti
processuali, sia la creazione di norme uniformi sulla legge applicabile.
Sulla base della nuova disciplina del TFUE, sono stati emanati diversi regolamenti. I primi risalgono al 2000
e riguardano la materia processuale. Lo stesso giorno sono stati emanati tre regolamenti che portano i nn.
1346, 1347 e 1348.
Il regolamento n. 1346/2000 riguarda le procedure di insolvenza.
Il regolamento n. 1347/2000 riguarda la materia del diritto di famiglia. Questa è una cosa molto
interessante, in quanto il diritto di famiglia non è materia dell’Unione europea, nel senso che il diritto
materiale di famiglia non è stato assegnato alla competenza dell’Unione. Gli Stati sono molto gelosi di
questo settore, essendo il settore del diritto di famiglia quello più improntato all’identità nazionale, per
questo fa specie che uno dei primi regolamenti abbia riguardato proprio questa materia. In realtà esso non
riguarda le norme materiali, ma gli aspetti processuali in materia matrimoniale, precisamente in materia di
divorzio e di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi. Si applica quindi ai processi di divorzio e alle
potestà dei genitori sui figli che si innestano nel processo di divorzio. Questo regolamento è noto con il nome
di regolamento Bruxelles II. Esiste un regolamento Bruxelles I, che però è stato emanato dopo.
Il regolamento Bruxelles II è stato sostituito dal regolamento 2201/2003 (regolamento Bruxelles II bis) il
quale, a sua volta, è stato recentemente integrato dal regolamento 2019/1111, che peraltro non è ancora in
vigore.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
Il regolamento n. 1348/2000 riguarda la notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti
giudiziali e stragiudiziali in materia civile e commerciale. Anche questo regolamento è stato sostituito dal
regolamento 1393/2007.
Alla fine del 2000 viene emanato un regolamento più generale che riguarda la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. È il c.d. regolamento n.
44/2001, c.d. Bruxelles I. Questo regolamento reca il n. 44/2001, pur essendo stato adottato nel 2000, perché
è stato pubblicato nella G.U. del 2001.
Non è un regolamento nuovo, ma la semplice trasposizione della Convenzione di Bruxelles del 1968.
Avendo acquisito competenza in materia, la Comunità ha deciso, infatti, di prendere quella convenzione e di
trasfonderla in un regolamento, in quanto questo è l’atto tipico della Comunità europea, ha portata generale
in tutti i suoi aspetti, ed è direttamente applicabile all’interno degli Stati membri. Non solo, essendo un atto
derivato è soggetto all’interpretazione e al controllo sulla corretta applicazione della Corte di Giustizia. Con
l’occasione si sono apportate alcune modifiche che si erano rese necessarie alla luce delle esperienze e delle
applicazioni da parte dei giudici nazionali. Questo regolamento, proprio perché trasfonde in regolamento la
nota convenzione di Bruxelles è noto come Bruxelles I (per questo il regolamento n. 1347 ha assunto il nome
di Bruxelles II).
C’è da dire che alla fine degli anni ’90, la comunità aveva portato avanti i lavori di una convenzione che
riguardava la giurisdizione e il riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale. Questa convenzione
era stata conclusa e la convenzione si sarebbe chiamata Bruxelles II, proprio perché andava a completare la
convenzione del 1968.
Dal momento però che la comunità aveva acquisito competenza in materia di d.i.p., il testo della
convenzione è stato abbandonato e si è deciso di trasfonderlo nel regolamento n. 1347, che di conseguenza è
stato chiamato Bruxelles II.
Il regolamento Bruxelles I è stato modificato e sostituito dal regolamento 1215/2012 (c.d. Bruxelles I bis).
Sempre nel 2001, è stato anche adottato il regolamento 1206 relativo alla cooperazione giudiziaria degli Stati
membri per l’assunzione delle prove in materia civile e commerciale.
Sono poi seguiti altri regolamenti: nel 2002 un regolamento che istituisce un atlante giudiziario europeo in
materia civile e commerciale accessibile via internet; nel 2004 un regolamento molto importante istituisce il
titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. È molto importante perché alcuni titoli esecutivi
vengono certificati come titoli esecutivi europei e possono circolare all’interno di tutti gli Stati membri senza
che sia necessario un ulteriore intervento da parte dell’autorità giudiziaria locale. Se il regolamento Bruxelles
I attua la libertà di circolazione delle sentenze all’interno dello spazio comunitario, questo regolamento n.
805/2004 rende possibile la circolazione di alcuni titoli esecutivi.
Negli anni 2006 e 2007 vengono adottati due regolamenti che creano due procedimenti europei autonomi
relativi rispettivamente all’ingiunzione di pagamento e alle controversie di modesta entità. Il regolamento
sull’istituzione del procedimento europeo di ingiunzione di pagamento del 2006 è stato modificato nel 2015;
mentre il regolamento sull’istituzione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità del
2007 è stato modificato dallo stesso regolamento del 2015.
Nel 2009 è seguito un regolamento relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.
Contemporaneamente, però, la comunità ha affrontato il tema della legge applicabile alle obbligazioni. Il
tema era già stato affrontato dalla Convenzione di Roma del 1980, relativa alla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali. Questa convenzione era entrata in vigore a stento perché non si riusciva ad arrivare
al numero minimo di ratifiche, ma in seguito ha iniziato a funzionare e ha avuto ampia applicazione.
La Comunità aveva deciso, quindi, di occuparsi anche delle obbligazioni extracontrattuali e aveva nel tempo
approntato un testo di convenzione che non ha mai visto la luce perché nel frattempo la Comunità ha
acquisito competenza in materia. Di conseguenza, nel 2007 si è deciso di adottare il regolamento n. 864, che
riguarda proprio la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. Mentre si stava definendo il testo di
questo regolamento si è iniziato anche a lavorare sulla trasformazione della Convenzione di Roma in
regolamento. Questo regolamento è stato adottato nel 2008 e reca il n. 593. Dato che questo regolamento è
l’erede della Convenzione di Roma, reca il nome regolamento Roma I, mentre il regolamento sulla legge
applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ha assunto il nome di regolamento Roma II.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
Sempre in materia di obbligazioni ricordiamo il regolamento n. 4/2009 in materia di obbligazioni
alimentari. A differenza degli altri due regolamenti – che si occupano solo di legge applicabile, in quanto gli
aspetti processuali sono già coperti dal regolamento Bruxelles I – in materia di obbligazioni alimentari si è
deciso di fare un regolamento completo, cioè si è voluto creare un vero e proprio sistema che disciplini tutte
le obbligazioni alimentari con implicazioni transfrontaliere. Questo regolamento riguarda, infatti, la
competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e la cooperazione in
materia di obbligazioni alimentari. Si occupa quindi di tutti gli aspetti relativi a questo tipo di obbligazioni.
Importante è anche un altro regolamento, del 2010, che riguarda la legge applicabile al divorzio e alla
separazione personale. Questo regolamento, n. 1259 – noto anche come Roma III – è molto importante.
Innanzitutto perché si occupa della legge applicabile in materia matrimoniale, completando il regolamento
Bruxelles II relativo agli aspetti processuali. Ma è anche importante perché è il primo regolamento frutto
della cooperazione rafforzata: questo regolamento non vincola gli Stati membri dell’Unione, ma solo
quegli Stati che hanno aderito alla cooperazione rafforzata.
Nel 2012 abbiamo un altro regolamento completo, questa volta in materia successoria, ossia il n. 650/2012
riguardante la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni,
l’accettazione e l’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e la creazione di un certificato
successorio europeo. Tutti gli aspetti sono disciplinati. La creazione di un certificato successorio europeo –
che ricorda il titolo esecutivo europeo di cui abbiamo parlato prima – consiste in ciò: una volta che un notaio
certifica la qualità di erede di un soggetto, questo certificato viene munito del sigillo di certificato
successorio europeo e può essere utilizzato da chi ne è titolare in tutti gli Stati membri per poter esercitare i
propri diritti successori in tutti gli Stati membri, senza la necessità di dover accertare nuovamente la presenza
di tutti i requisiti.
Nel 2016, infine, sono stati emanati altri due regolamenti completi che riguardano i rapporti patrimoniali
interpersonali. Sono due perché uno riguarda i regimi patrimoniali tra coniugi e l’altro riguarda gli effetti
patrimoniali delle unioni civili. Si tratta dei regolamenti nn. 1103 e 1104/2016, relativi alla competenza,
alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nelle due materie. Si è deciso di fare
due regolamenti perché non in tutti gli Stati membri esistono le unioni civili. Questa è una riprova del fatto
che l’UE non ha competenza nel diritto di famiglia.
Da questo excursus emerge come sia in corso un processo di unificazione del d.i.p. a livello europeo.
Questo processo di unificazione riguarda sia le controversie intracomunitarie, sia extracomunitarie. La
tendenza a sostituirsi agli Stati membri nel settore del d.i.p. è emersa chiaramente allorquando la Comunità
ha deciso di sostituirsi agli Stati anche nella stipulazione degli accordi internazionali in materia
internazionalprivatistica. Una volta, cioè, che ha esercitato questa competenza al proprio interno, la
Comunità-Unione ha deciso di esercitarla anche verso l’esterno. Dal momento che le convenzioni di d.i.p.
sono perlopiù adottate all’interno della Conferenza dell’Aia di d.i.p., la Comunità (organizzazione
internazionale) ha chiesto di poter aderire alla Conferenza dell’Aia (altra organizzazione internazionale). In
realtà lo statuto della Conferenza dell’Aia prevedeva la possibilità di adesione solo degli Stati. La Comunità
invece è un’organizzazione internazionale. Una volta avanzata la richiesta, la Conferenza stessa ha dovuto
procedere alla modifica del proprio trattato istitutivo consentendo anche la partecipazione-adesione di
un’organizzazione internazionale. La modifica non è generica: si è scelta una terminologia tale per cui, senza
farne il nome, ci si riferiva solo alla Comunità europea. Nel 2007 la Comunità aderisce alla Conferenza
dell’Aia di d.i.p. e da quel momento la competenza a stipulare i trattati redatti nell’ambito della conferenza
stessa viene tolta agli Stati e gestita a livello comunitario: le convenzioni dell’Aia vengono oggi firmate e
ratificate dall’UE e, di conseguenza, vengono applicate da tutti gli Stati membri.
Il rapporto tra le fonti sovranazionali di d.i.p. e la l. 218/1995. La comunitarizzazione del d.i.p.
La l. 218/1995 dà atto delle fonti sovranazionali. L’art. 2 al primo comma stabilisce che “1. Le disposizioni
della presente legge non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia”.
Si tratta di una norma di carattere pedagogico, che non aveva bisogno di essere inserita, posto che comunque
i trattati internazionali prevalgono su quelle nazionali. Nonostante ciò il legislatore ha ritenuto necessario
ricordare al giudice come comportarsi di fronte a un concorso tra fonti nazionali e internazionali. Questo
perché la giurisprudenza sul punto è molto oscillante: ci sono giudici che applicano correttamente la
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
gerarchia delle fonti del diritto; altri che ritengono che una convenzione possa essere richiamata ad
abundantiam, cioè per confermare la soluzione adottata dal legislatore italiano, a condizione che il contenuto
sia il medesimo; altri ancora che ritengono che una convenzione non sia applicabile magari non essendo a
conoscenza del fatto che la convenzione è stata ratificata dall’Italia e il legislatore con l’ordine di esecuzione
ne ha decretato l’inserimento nell’ordinamento italiano adattandolo alla convenzione.
Nello stesso solco, si colloca l’art. 117 Cost., secondo cui “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali”.
L’art. 117 Cost. ricorda che il legislatore degli obblighi internazionali, quindi se per un errore questo
rispetto viene meno, spetta all’interprete far rispettare la norma sovranazionale. Anche perché, violando la
norma sovranazionale, l’Italia si espone a responsabilità nei confronti degli altri Stati contraenti. A differenza
dell’art. 2 l. 218/1995, nell’art. 117 Cost. c’è un riferimento agli obblighi comunitari. Evidentemente nel
1995 il legislatore non poteva tenere conto dell’ordinamento comunitario, in quanto nel settore del d.i.p. non
esistevano regolamenti, posto che la competenza in questa materia sarebbe stata assunta dalla comunità in un
momento successivo. Oggi, quanto leggiamo l’art. 2, dobbiamo leggerlo includendo implicitamente
l’ordinamento comunitario, in questo modo “Le disposizioni della presente legge non pregiudicano
l’applicazione delle disposizioni della Comunità/Unione europea adottate e vincolanti per l’Italia”.
Come facciamo a sapere se l’Italia è parte di una convenzione? In passato c’erano metodi molto artigianali.
Si andava a cercare lo stato delle ratifiche su raccolte di trattati, i volumi pubblicati dalle Nazioni unite che
raccoglievano tutti i trattati stipulati dai vari Stati, riportavano lo stato delle ratifiche e riportavano i testi di
eventuali riserve o dichiarazioni interpretative. Si trattava di grossi volumi che venivano pubblicati con un
certo ritardo rispetto all’epoca cui si riferivano e ancora con maggiore ritardo arrivavano nelle biblioteche
italiane, per cui poteva capitare che passassero anni rispetto alla raccolta.
Si poteva anche chiamare il Ministero della giustizia per capire quali fossero i trattati vincolanti per l’Italia.
Oggi sono disponibili strumenti molto più rapidi e aggiornati: i siti del Ministero della giustizia e di quello
degli esteri, il sito dell’Unione europea, il sito del Consiglio d’Europa, il sito della Conferenza dell’Aia di
diritto internazionale privato. Questi riportano in tempo reale lo stato delle ratifiche, l’apposizione di riserve
da parte dei singoli Stati, le dichiarazioni interpretative, i casi in cui uno Stato parte abbia poi denunciato il
trattato, ecc.
Questo è utile anche per sapere con quali Stati siamo vincolati.
L’art. 2, al secondo comma, si occupa dell’interpretazione. L’interpretazione delle convenzioni è
disciplinata dalla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati. La Convenzione abbandona la
teoria subiettivistica dell’interpretazione – teoria secondo la quale al trattato si deve dare l’interpretazione
che meglio risponde all’intenzione delle parti – in favore della teoria dell’interpretazione obiettiva, che va a
cercare il significato più corrispondente al testo scritto, indipendentemente da quello che i redattori avevano
in mente quando hanno utilizzato quei termini. Il problema è che i trattati internazionali sono spesso scritti in
più lingue e non necessariamente tra quelle lingue c’è il testo italiano. Quindi, nell’interpretazione occorre
attenersi ai testi nelle lingue autentiche e cercare di dare un’interpretazione che sia conforme ai vari testi.
Negli altri casi noi possiamo trovare una traduzione non ufficiale nella legge che autorizza la ratifica e ordina
l’esecuzione del trattato. Ricordiamo che l’adattamento in forma speciale ai trattati avviene attraverso
l’ordine di esecuzione che è una legge attraverso la quale si dispone la piena e intera esecuzione della
convenzione. A questa legge viene allegata la traduzione non ufficiale della convenzione. La traduzione non
ufficiale può servire a farsi un’idea del testo, ma non è utile a interpretare correttamente la convenzione. Per
far ciò è necessario andare a vedere il testo in una delle lingue ufficiali.
Le convenzioni vanno, in linea di massima, interpretate in maniera estensiva. Se lo scopo della
convenzione è quello di seguire una disciplina uniforme, è chiaro che l’uniformità può essere assicurata solo
dando al testo una interpretazione uniforme in tutti gli Stati. Questo è semplice quando la convenzione
utilizza delle nozioni di fatto o tecniche, ma quando la convenzione utilizza termini giuridici è chiaro che il
problema si pone, in quanto uno stesso termine può essere inteso in sensi diversi nei vari ordinamenti.
Ecco perché inteviene l’art. 2 secondo comma.
La norma della l. 218/1995 dispone che “2. Nell’interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro
carattere internazionale e dell’esigenza della loro applicazione uniforme”.
L’interpretazione uniforme è lasciata agli Stati, a meno che il trattato stesso non attribuisca ad un organo il
compito di interpretare in maniera uniforme il testo della convenzione internazionale.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
Se è vero che al primo comma dell’art. 2 dobbiamo inserire il rispetto del diritto comunitario, ciò vale anche
per il secondo comma. Qui abbiamo un aiuto perché c’è un organo internazionale deputato
all’interpretazione autentica: la Corte di giustizia. La Corte di giustizia viene spesso interpellata in relazione
all’interpretazione di norme o singoli termini e fornisce l’interpretazione corretta. La fornisce al giudice
nazionale che, nell’incertezza, sospende il procedimento, ma essa è vincolante anche per gli interpreti di
tutti gli altri Stati membri.
L’utilizzo che la l. 218/1995 fa delle convenzioni è un utilizzo particolare, nel senso che, al di là dell’art. 2,
le ha nazionalizzate o incorporate nella stessa legge 218/1995. Le convenzioni, una volta introdotte nel
nostro ordinamento con il procedimento di adattamento, sono vincolanti per tutti gli interpreti. Esse
vincolano all’applicazione delle convenzioni negli ambiti (soggettivo e oggettivo) previsti dalle convenzioni
stesse. Tutte le convenzioni si premurano di delimitare il proprio ambito di applicazione soggettivo e
oggettivo. Il nostro legislatore, in relazione a certe convenzioni, ha deciso di estenderne l’ambito di
applicazione. Ritenuto che le soluzioni adottate fossero buone, ha deciso, cioè, di applicarle anche a soggetti
o a materie che le convenzioni invece intendevano escludere dal proprio ambito di applicazione.
In una ipotesi, in realtà, il nostro legislatore si appropria solo di alcune norme di una convenzione. Il
riferimento è all’art. 3 secondo comma della l. 218/1995. L’art. 3 riguarda l’ambito della giurisdizione
italiana. Il primo comma stabilisce che: “1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è
domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma
dell’art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge”.
Il secondo comma aggiunge che: “2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni
2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale […] anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio
di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della
Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la
competenza per territorio”. La Convenzione di Bruxelles stabilisce che le proprie norme sono applicabili
quando il convenuto è domiciliato in uno Stato membro. Conseguenza è che, quando il convenuto non è
domiciliato in uno Stato membro, ogni Stato membro applica le proprie norme nazionali sulla giurisdizione.
Il nostro legislatore ha ritenuto di applicare anche ai convenuti non domiciliati nei territori degli Stati
contraenti i titoli di giurisdizione previsti in alcune sezioni della convenzione. Si tratta delle sezioni dedicate
alla tutela della c.d. parte debole, ossia dei consumatori, dei lavoratori e degli assicurati.
A parte questo caso relativo a specifiche norme, ci sono situazioni in cui intere convenzioni vengono
incorporate e ritenute applicabili al di là dell’ambito previsto dalla convenzione stessa.
A proposito dell’ampliamento dell’ambito soggettivo, esemplare è l’art. 42 della l. 218/1995, che si occupa
della protezione dei minori. La norma dispone che: “1. La protezione dei minori è in ogni caso regolata
dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in
materia di protezione dei minori […]”. Quando nella nostra l. 218/1995 si dice “in ogni caso”, il legislatore
intende estendere l’ambito di applicazione della convenzione. Il secondo comma dell’art. 42 ci chiarisce cosa
vuol dire “in ogni caso”: “2. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate
minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonché alle persone la cui residenza abituale non si trova in
uno degli Stati contraenti”. L’ultima frase ricorda un po’ quella dell’art. 3 secondo comma: si amplia
l’ambito di applicazione soggettivo, estendendolo a soggetti che non hanno la residenza abituale in uno degli
stati contraenti, laddove la convenzione specifica di volersi applicare solo quando il minore ha residenza
abituale in uno Stato contraente. La convenzione limita ulteriormente il proprio ambito di applicazione dando
una definizione indiretta di minore. Ogni ordinamento può considerare minore un soggetto, stabilendo criteri
diversi. La convenzione dice di volersi applicare a soggetti che sono considerati minori sia dalla loro legge
nazionale che dalla loro legge di residenza abituale. Noi estendiamo l’ambito di applicazione della
convenzione perché diciamo che si applica “anche alle persone considerate minori solo dalla loro legge
nazionale”.
Una soluzione analoga è prevista dall’art. 59 della l. 218/1995, che si occupa di titoli di credito e fa
riferimento a due convenzioni, una in materia di vaglia cambiario e l’altra in materia di assegni bancari.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
Ma esiste un’altra estensione di ambito di applicazione, che riguarda l’ambito oggettivo di applicazione.
Un caso è quello che riguarda l’art. 45 sulle obbligazioni alimentari nella famiglia, che estende l’ambito di
applicazione oggettivo della Convenzione dell’Aia del 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni
alimentari. In realtà questa norma non c’è più perché è stata modificata in occasione dell’emanazione delle
norme sulle unioni civili nel 2017.
Particolarmente importante è l’altra ipotesi di estensione dell’ambito di applicazione oggettivo. L’art. 57
riguarda le obbligazioni contrattuali e stabilisce che: “Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso
regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni
internazionali, in quanto applicabili”. La Convenzione di Roma esclude dal proprio ambito di applicazione
oggettivo tutta una serie di contratti, ad es. alcuni contratti di assicurazione. Per questi contratti, il legislatore
può decidere una disciplina autonoma.
L’Italia, quando ha iniziato a lavorare in vista della riforma, aveva visto il testo della Convenzione di Roma,
che non era ancora entrata in vigore. Per questo motivo ha copiato e inserito nel progetto di l. 218/1995 tutte
le norme della convenzione. Questa tecnica era già stata seguita dal legislatore tedesco. La legge di riforma
tedesca del 1986 disciplinava le obbligazioni contrattuali esattamente come erano disciplinate nella
Convenzione di Roma. Hanno copiato il testo della convenzione perché non erano sicuri che questa sarebbe
entrata in vigore.
Nel 1991, tuttavia, la Convenzione di Roma finalmente entra in vigore. La commissione ministeriale si rende
conto che non è più utile inserire tutte le norme della convenzione, allora espunge tutte le norme copiate
dalla Convenzione di Roma e inserisce l’art. 57.
Noi abbiamo visto che sia la Convenzione di Bruxelles del 1968, sia la Convenzione di Roma del 1980 sono
state trasposte in regolamenti comunitari, quindi non esistono più. L’art. 3 e l’art. 57 non sono stati
modificati. Si tratta di capire se e come la Convenzione di Roma, piuttosto che il regolamento Roma I sono
applicabili. È chiaro che nel loro ambito di applicazione prevalgono i regolamenti, quindi se si tratta di una
materia o di soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti, questi si applicano. Il
problema sorge laddove si tratti di materie escluse dai regolamenti ma non dalla l. 218/1995. La domanda è:
se il convenuto non è domiciliato in uno stato membro e si tratta di una parte debole, in base all’art. 3.2 è
applicabile la Convenzione di Bruxelles o si deve intendere il riferimento come fatto al regolamento
Bruxelles? La stessa cosa vale per le obbligazioni contrattuali. Il regolamento Roma I esclude ancora dal suo
ambito di applicazione alcuni contratti. Per quei contratti esclusi il riferimento dell’art. 57 deve essere inteso
come alla Convenzione di Roma o al regolamento Roma I?
Il problema della trasformazione delle due convenzioni in regolamenti crea un problema interpretativo che la
dottrina ha risolto in maniera differente: secondo alcuni il richiamo è mobile, nel senso che oggi è ai
regolamenti, con la conseguenza che tutto quello che riguarda quella materia o quei soggetti rientrano
nell’ambito di applicazione dello strumento comunitario; altri ritengono che la norma abbia cristallizzato il
richiamo, quindi le norme delle convenzioni vengono fatte risuscitare dall’interprete quando devono essere
applicate.
Il problema di questo riferimento è stato risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2009, in
relazione all’art. 3 secondo comma. Secondo la Cassazione, il rinvio operato attiene esclusivamente alla
Convenzione di Bruxelles e non si estende al regolamento Bruxelles I. In sostanza, il giudice applica il
regolamento Bruxelles I, ma per le situazioni previste dal secondo comma dell’art. 3, il giudice deve tornare
ad applicare la Convenzione di Bruxelles.
Sulla stessa scia la Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata nel 2011 e nel 2012.
Se uno guarda il testo dei regolamenti, in realtà potrebbe giungere a conclusioni diverse.
L’art. 68 del reg. 44/2001 recita: “1. Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni
della convenzione di Bruxelles salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel
campo di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi
dell'articolo 299 del trattato. 2. Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri,
le disposizioni della convenzione di Bruxelles ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al
presente regolamento”. In sostanza, tutte le volte che noi troviamo un testo che fa riferimento alla
convenzione, noi dobbiamo intenderlo come fatto al regolamento. Tuttavia, alcuni interpreti hanno fatto
notare che il testo dell’art. 68 parla di rapporti reciproci tra Stati membri. Il che significa che, quando altri
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
atti comunitari fanno riferimento alla Convenzione di Bruxelles oggi quel riferimento va inteso come fatto al
regolamento, ma quello di cui stiamo discutendo noi non è un atto comunitario, ma la legge di uno stato che
fa riferimento alla convenzione. Per questo alcuni autori hanno affermato che l’art. 68 del regolamento
Bruxelles I non possa essere invocato ai fini della lettura del regolamento Bruxelles I.
Analoga norma è l’art. 24 del reg. Roma I. La norma – rubricata “Relazioni con la Convenzione di Roma”
– recita: “1. Il presente regolamento sostituisce la convenzione di Roma negli Stati membri, salvo per
quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale
convenzione e ai quali il presente regolamento non è applicabile a norma dell’articolo 299 del trattato. 2.
Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce le disposizioni della convenzione di Roma, ogni
riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento”. Qui la sostituzione è “negli Stati
membri”, quindi la critica prospettata da alcuni autori cade. Quindi possiamo concludere che la portata di
queste norme non possa essere circoscritta alla normativa comunitaria, ma vada estesa ai richiami operati
dalle norme nazionali, in particolare quelle che abbiamo visto finora.
Concludendo questo excursus sulle fonti internazionali possiamo dire che ormai i legislatori nazionali hanno
una funzione residuale rispetto all’UE, nel senso che la normativa statale di d.i.p. è sempre meno utilizzata e
sempre più residuale. Oramai, la maggior parte degli articoli della l. 218/1995 non è più in vigore.
I metodi di coordinamento.
Il nostro sistema di d.i.p., per quanto riguarda gli aspetti relativi alla legge applicabile, è un sistema che
miscela diversi metodi di coordinamento tra gli ordinamenti. Il d.i.p. regola i rapporti privatistici con
implicazioni transfrontaliere e in astratto potrebbe seguire modelli diversi.
Il primo metodo è quello della localizzazione spaziale. Il legislatore a priori decide che un certo rapporto si
deve intendere localizzato in un certo Stato perché con quello Stato ha un collegamento che il legislatore
ritiene decisivo. Ad esempio, lo stato nazionale di un soggetto, secondo il nostro legislatore, è spazialmente
localizzato nello Stato a cui il soggetto appartiene. Questo anche se il soggetto non vive nello Stato della
cittadinanza.
Il secondo metodo è quello del collegamento più stretto. Questo metodo si basa sul principio di
prossimità, quindi va a vedere nel caso concreto qual è l’ordinamento che ha maggiori connessioni con la
situazione. Ad esempio, secondo la l. 218/1995, i rapporti personali tra coniugi con cittadinanza diversa
sono regolati dalla legge dello Stato in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. A priori noi
non sappiamo quale sia, ma è necessario andare a vedere nel singolo caso concreto.
Esiste un terzo metodo, c.d. delle considerazioni materiali. Il legislatore in questo caso, quando individua la
legge applicabile ha in mente un certo risultato materiale. Questo scopo lo può raggiungere mettendo a
disposizione dell’interprete più leggi e tra queste leggi l’interprete andrà ad applicare quella che gli consente
nel caso concreto di arrivare al risultato che il legislatore intende raggiungere. Tipicamente questo metodo è
utilizzato per la disciplina degli aspetti formali degli atti.
Ad esempio, l’art. 28 l. 218/1995 parla della forma del matrimonio. Già la formulazione è chiara perché si
dice che “Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di
celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla
legge dello Stato di comune residenza in tale momento”. La finalità è garantire la validità formale del
matrimonio. Il legislatore mette a disposizione quattro criteri. Il giudice applicherà la legge che gli consentirà
di considerare formalmente valido il matrimonio e dovrà ispirarsi al c.d. favor validitatis. Lo scopo del
legislatore è quello di salvare quanto alla forma il negozio.
C’è un caso in cui il metodo delle considerazioni materiali è applicato alla sostanza. È il caso relativo
all’art. 35 l. 218/1995, relativo al riconoscimento del figlio. La norma recita: “1. Le condizioni per il
riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se più
favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene;
se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana”. Qui parliamo di sostanza, alla
forma è dedicato un altro comma dell’art. 35, infatti si parla di condizioni. I criteri principali sono due: si
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
applica la legge più favorevole al riconoscimento, in quanto questo istituto è promosso (indipendentemente
dalla volontà del figlio).
Ultimo e più nuovo metodo di coordinamento è il principio del mutuo riconoscimento. È un principio di
origine comunitaria, sorto in ambito commerciale. L’idea è che, se un prodotto viene immesso sul mercato in
un certo Paese e rispetta gli standard previsti da quel Paese, gli altri Stati dell’Unione devono accettare di
immetterlo nel proprio mercato, anche se i requisiti di produzione sono differenti. Questo perché si fidano
della bontà della disciplina dell’altro Stato e c’è un riconoscimento reciproco.
Questo principio ormai si è esteso anche alle sentenze. Qui, addirittura, è vietato andare a verificare il merito
della decisione del giudice dell’altro Stato membro.
Nella l. 218/1995 c’è una parziale applicazione nell’art. 65, sul riconoscimento di provvedimenti stranieri.
Secondo la norma: “1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone
nonché all’esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati
dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti
nell’ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari
all’ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”. Questo vuol dire che se c’è un
provvedimento emanato nello Stato membro, noi riconosciamo automaticamente quel provvedimento.
Riconosciamo automaticamente anche i provvedimenti emanati in uno Stato terzo, che però sono riconosciuti
in quello Stato membro.
Questi metodi di coordinamento sono miscelati nella l. 218/1995, la quale non ha seguito un unico approccio.
In realtà, il legislatore italiano avrebbe potuto adottare anche una soluzione più drastica. Ad esempio,
avrebbe potuto dire che anche le situazioni transnazionali sono regolate dal diritto italiano, trascurando la
natura transnazionale della situazione. In questo caso non c’è alcun coordinamento, nel senso che il
legislatore italiano equiparerebbe le situazioni transnazionali a quelle interne.
Il legislatore, in parte, fa questo. Ad es. nell’art. 116 c.c., in relazione al matrimonio. Lo straniero che vuole
sposarsi in Italia, oltre a dover produrre il nulla osta della propria autorità consolare, deve comunque
rispettare gli artt. 85-88 c.c., a prescindere da quello che dice la sua legge nazionale. Queste norme sono
applicabili indifferentemente agli italiani e agli stranieri. Sono le c.d. norme di applicazione necessaria.
In occasione della riforma del diritto della filiazione, addirittura il legislatore ha introdotto una norma – l’art.
36bis – in cui si dice che: “1. Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del
diritto italiano che: a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale; b) stabiliscono il
dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio; c) attribuiscono al giudice il potere
di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte
pregiudizievoli per il figlio”. Queste norme sono norme italiane di applicazione necessaria.
Una soluzione opposta è quella di dettare norme materiali specifiche per la situazione transnazionale.
L’adozione internazionale di minori, ad esempio, è disciplinata dalla legge sull’adozione. Qui non ci si
coordina con l’ordinamento straniero, ma si dettano norme, diverse dalle norme sull’adozione nazionale, ma
pur sempre italiane.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
I PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO
Molto spesso questo tipo di procedimenti viene fatto coincidere con la volontaria giurisdizione. Questa è una
giurisdizione inter volentes, tra soggetti che non sono divisi da una situazione di conflitto. È una nozione
tralatizia, nel senso che si continua a parlare di giurisdizione volontaria in contrapposizione a quella
contenziosa, anche se nel codice l’unica norma che la menzionava è sparita.
Con riferimento a queste ipotesi, che riguardano le materie più disparate (stato, capacità delle persone,
famiglia, assenza, scomparsa, morte presunta, ecc.), si dice che il giudice svolge un’attività che non è
propriamente giurisdizionale, ma è un’attività amministrativa, in quanto spesso si limita ad integrare con
un’autorizzazione una fattispecie normativa.
Si tratta di un procedimento particolarmente snello e semplificato.
L’atto introduttivo è un ricorso da proporre al tribunale in composizione collegiale. Il procedimento si
conclude, in genere, mediante decreto motivato o ordinanza.
Rispetto alla struttura, l’art. 738 si limita a prevedere che tra i componenti viene scelto dal presidente un
relatore che riferisce in camera di consiglio, che deve essere sentito il pubblico ministero nei casi previsti
dalla legge e, per quanto riguarda l’attività istruttoria, che il giudice può assumere informazioni. Da questa
constatazione deriva l’affermazione per cui in questo procedimento sarebbe particolarmente ampia e
frequente l’iniziativa ufficiosa del giudice nell’assunzione delle prove. Si tratterebbe per di più, di
un’istruttoria deformalizzata, in quanto il legislatore non dice nulla al riguardo e non lascia supporre che
debbano essere seguite le norme in tema di istruzione della causa che riguardano il procedimento ordinario.
Quanto al provvedimento finale, l’art. 739 prevede che contro i decreti si possa proporre reclamo al giudice
superiore rispetto a quello che ha pronunciato il provvedimento. I termini per la proposizione sono molto
brevi – si tratta di un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se questo è dato
in confronto di una sola parte, oppure dalla sua notificazione, se dato in confronto a più parti – e il reclamo
ha il carattere di un vero e proprio gravame, in quanto può essere proposto per qualunque motivo di rito o
di merito. In particolare, uno dei motivi più frequenti è l’emergere di nuove circostanze perché questi
provvedimenti sono pronunciati con la clausola rebus sic stantibus.
Contro il provvedimento emesso in sede di reclamo è tendenzialmente esclusa l’esperibilità di successive
impugnazioni, come prevede l’ultimo comma dell’art. 739.
L’art. 741 disciplina l’efficacia dei provvedimenti limitandosi a dire che se vi sono ragioni di urgenza, il
giudice può disporre che il decreto abbia efficacia immediata, altrimenti il decreto acquista efficacia quando
sono decorsi i termini senza che sia stato proposto reclamo. Ricordiamo che comunque si tratta di efficacia
relativa priva dell’autorità di cosa giudicata, proprio perché i provvedimenti sono in ogni tempo
modificabili e revocabili, ai sensi dell’art. 742.
Nel 1950 è stata aggiunto al codice l’art. 742bis, che voleva disciplinare l’ambito di applicazione dei
procedimenti camerali, ma ha creato un po’ di confusione.
La norma afferma che le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di
consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle
persone. La norma ha consentito l’utilizzazione del rito camerale per una serie di ipotesi che il legislatore
non aveva contemplato. Abbiamo detto che il procedimento camerale è un procedimento estremamente
snello e agile e, considerati i tempi della nostra giustizia civile, il legislatore ha spesso fatto ricorso a questo
tipo di procedimento quando si proponevano nuove situazioni sostanziali.
Si è quindi iniziato a parlare di procedimenti camerali su diritti, per distinguerli da quelli che avevano ad
oggetto la volontaria giurisdizione. L’espansione del modello camerale a queste controversie ha creato
reazioni contrastanti nell’ambito della dottrina, proprio perché tradizionalmente la tutela giurisdizionale dei
diritti è affidata al processo di cognizione che è ancorato a regole ben precise e predeterminate. I primi
interventi della Corte costituzionale hanno affermato, in realtà, la legittimità dei procedimenti camerali su
diritti, facendo leva sul fatto che il processo ordinario di cognizione e la cognizione piena non sono coperti
da una specifica garanzia costituzionale. In particolare, per il procedimento camerale relativo alla revisione
delle condizioni di divorzio, fin dagli anni Settanta, la Corte ha affermato che l’adozione del procedimento
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
camerale risponde a criteri di politica legislativa “inerenti alla valutazione che il legislatore ha compiuto in
relazione alla natura degli interessi regolati e alle opportunità di adottare determinate forme processuali.
Questa scelta è del tutto discrezionale e non consente alcun tipo di sindacato ad opera della Corte”.
Tuttavia, più volte investita di questioni di legittimità di vari tipi di procedimento camerale su diritti, la Corte
ha dettato una sorta di elenco di requisiti immancabili da applicare a un procedimento camerale avente ad
oggetto situazioni di diritto. Così la Corte ha sostenuto che uno di questi elementi è il rispetto del principio
della domanda e del contraddittorio, nonché la previsione di termini compatibili con l’esercizio del
diritto di difesa. La Corte costituzionale ha, inoltre, affermato che nel procedimento camerale su diritti deve
essere prevista la possibilità di acquisire prove precostituite e di assumere prove costituende, a
condizione che il modo di assunzione risulti compatibile con la struttura semplificata del procedimento.
Il dato più importante del procedimento camerale su diritti, tuttavia, riguarda la ricorribilità in cassazione
del provvedimento finale e, più specificamente, del provvedimento emanato in sede di reclamo ai sensi
dell’art. 111 settimo comma della Costituzione (c.d. ricorso straordinario per cassazione). Questo ha
contribuito ad aumentare in maniera significativa il carico di lavoro della Corte di cassazione.
Il legislatore ha continuato a utilizzare il modello camerale almeno fino al 2011, quando è entrata in vigore la
riforma sulla semplificazione dei riti, che non ha più contemplato il rito camerale come uno dei riti verso i
quali i vari procedimenti extra codice dovevano essere convogliati.
Una famosissima sentenza della Cassazione a sezioni unite del 1996 ha definito il rito camerale come un
“contenitore neutro nel quale possono trovare spazio sia i procedimenti di volontaria giurisdizione, sia
provvedimenti di natura contenziosa, ciascuno con le proprie peculiari caratteristiche sia strutturali che
funzionali, con il conseguente superamento degli innegabili conflitti tra profili formali o procedurali e profili
sostanziali connessi all’oggetto della controversia”.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
LA TUTELA CAUTELARE.
Si tratta di una forma di tutela che va ad aggiungersi a quella dichiarativa e a quella esecutiva. La tutela
cautelare che, secondo alcuni autori, si ricollega ad una specifica azione detta azione cautelare, è una forma
di tutela particolarmente importante, soprattutto nella prospettiva costituzionale dell’art. 24 Cost., che
garantisce il diritto di difesa e di azione.
La tutela cautelare ha come finalità precipua quella di assicurare che la durata del processo non vada a
danno del soggetto che ha ragione. Questo è importante, soprattutto negli ordinamenti come il nostro,
caratterizzati da una particolare lunghezza in termini di tempo di definizione delle cause.
Caratteristiche principali.
In primo luogo viene in considerazione la sommarietà. Questa tutela viene concessa senza che vi sia un
accertamento pieno di quelli che sono i suoi presupposti e, in particolare, un accertamento completo del
diritto per il quale la tutela viene chiesta. È evidente che, se così non fosse, verrebbe meno la funzione stessa
della tutela cautelare.
I presupposti sono identificabili nel periculum in mora e nel fumus boni iuris.
Il periculum in mora, o pericolo nel ritardo, fa riferimento alla finalità delle misure cautelari: evitare che nel
periodo di tempo di accertamento della sussistenza del diritto questo venga esposto a rischi di perdita o
diminuzione.
Fumus boni iuris significa verosimiglianza dell’esistenza del diritto per il quale la misura viene chiesta. Il
termine fumus fa riferimento a qualcosa che non postula un vero e proprio accertamento, ma fa riferimento
all’apparenza dell’esistenza del diritto.
Le misure cautelari hanno un contenuto molto vario, poiché mirano a fronteggiare i diversi tipi di pericoli
che si possono verificare in concreto.
Un’altra caratteristica è la loro assenza di autonomia, o meglio, il loro carattere strumentale. La tutela
cautelare è al servizio della tutela dichiarativa o, più raramente della tutela esecutiva. Possiamo dire, in
generale, che le misure cautelari mirano sempre e comunque atte a garantire l’effettività della tutela
giurisdizionale, sia quella di cognizione, sia quella esecutiva.
La conseguenza di questo carattere strumentale è un’altra caratteristica, quella della provvisorietà. La
misura cautelare dura tanto quanto il processo principale cui è strumentale. Una volta concluso il giudizio
ordinario di cognizione o il procedimento esecutivo il provvedimento cautelare sarà sostituito da una
sentenza o dalla misura esecutiva.
In virtù di alcune riforme legislative è necessario introdurre una distinzione riguardo al carattere della
strumentalità. Prima del 1990, il nostro sistema delineava le misure cautelari come una sorta di numero
chiuso, la cui disciplina era abbastanza scarna e lacunosa. In aggiunta a queste misure tipiche vi era una
norma di chiusura, ossia una misura atipica che era, ed è ancora oggi, il provvedimento d’urgenza (art. 700).
IL PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME.
Con la riforma del 1990 è stato introdotto il procedimento cautelare uniforme, disciplina processuale
unitaria che presenta varie novità. Tra queste novità vi è la previsione di uno strumento di controllo della
misura, il reclamo cautelare.
L’ambito di applicazione del procedimento cautelare uniforme è particolarmente ampio ed è individuato
dall’art. 669quaterdecies. La norma specifica che le disposizioni della sezione si applicano ai provvedimenti
previsti dalle sezioni II, III e V, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal
codice civile e dalle leggi speciali: esso si applica a tutte le misure cautelari, tranne che ai procedimenti di
istruzione preventiva, contenuti nella sezione IV.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
L’art. 669bis disciplina la forma della domanda. La domanda si propone con ricorso depositato nella
cancelleria del giudice competente.
È innanzitutto necessario identificare l’editio actionis, con riferimento al periculum in mora e al fumus boni
iuris, identificando almeno in maniera sommaria il diritto per il quale la tutela viene richiesta e qual è la
situazione di pericolo imminente alla quale il diritto è esposto.
Non sussiste alcun problema se la misura cautelare è richiesta quando già è pendente un giudizio di merito
per l’accertamento del diritto oggetto della misura cautelare. La situazione è diversa se la misura cautelare
viene richiesta ante causam. In questo caso, restano fermi i due presupposti, ma l’identificazione del diritto
dovrà essere più consistente: non basterà semplicemente l’illustrazione del fumus, in quanto qui non c’è un
giudizio di merito che consenta di comprendere in maniera quasi immediata qual è il diritto a tutela del quale
viene richiesta la misura cautelare.
Gli artt. 669ter e 669quater trattano della competenza.
Quando la domanda cautelare viene proposta in corso di causa è competente il giudice dinanzi al quale pende
il merito (art. 669quater). Analogamente, se la domanda cautelare è proposta ante causam, si propone al
giudice che ordinariamente sarebbe competente per il merito (art. 669ter). Con tre importanti eccezioni.
La prima riguarda il giudice di pace che non ha alcuna competenza cautelare. In questo caso, la domanda
cautelare dovrà essere proposta al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace.
La seconda riguarda gli arbitri, che nel nostro ordinamento non hanno potestà cautelare. La domanda
cautelare va posta al giudice che sarebbe competente per la controversia se le parti non avessero optato per la
convenzione di arbitrato (art. 669quinquies).
La terza ipotesi riguarda il giudice straniero. La domanda si propone dinanzi al giudice che sarebbe
competente per materia o per valore del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.
La domanda, di regola, si pone al giudice che ha emanato la sentenza. In linea di principio, si può dire che è
legittimata alla richiesta della misura cautelare la parte che è risultata vittoriosa nel giudizio. Va detto però
che anche la parte soccombente può essere legittimata se allega fatti o circostanze sopravvenuti, che non
potevano essere fatti valere nel processo che si è concluso con la sentenza.
Se l’impugnazione è già stata proposta, la misura cautelare si chiede al giudice dell’impugnazione. Questo
però vale solo nel caso di appello, revocazione, opposizione di terzo. Nel caso in cui l’impugnazione
proposta sia un ricorso per cassazione, la misura cautelare non potrà essere richiesta a questo giudice, ma
andrà richiesta al giudice a quo, che ha emanato il provvedimento oggetto di ricorso per cassazione. Dopo il
passaggio in giudicato della sentenza si torna ad applicare l’art. 669ter, che disciplina la competenza
anteriore alla causa.
Il procedimento.
L’art. 669sexies disciplina il procedimento. In linea di principio, l’emanazione della misura cautelare
presuppone l’instaurazione di un contraddittorio. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili
in relazione ai fini e ai presupposti del provvedimento richiesto.
Occorre sottolineare che, in linea di principio, l’emanazione della misura cautelare presuppone l’effettiva
instaurazione del contraddittorio presso il giudice, quindi la fissazione di un’udienza con decreto da
notificare all’altra parte con ricorso introduttivo.
Peraltro, è anche possibile che l’emanazione del provvedimento cautelare avvenga inaudita altera parte,
come prevede l’art. 669sexies al secondo comma. Il decreto deve essere motivato e deve fissare l’udienza per
sentire le parti. Le possibili ragioni che giustificano questa eccezione sono delineate dalla prima parte del
secondo comma: il decreto può essere attuato inaudita altera parte quando la convocazione della
controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento. Si tratta, in sostanza, di casi di
assoluta urgenza o di casi in cui, se il destinatario del provvedimento venisse a conoscenza della situazione,
metterebbe a rischio il diritto dell’istante. In questo caso, il contraddittorio viene recuperato in un’udienza
successiva all’emissione del provvedimento in cui il giudice dovrà confermare, modificare o annullare il
provvedimento.
Anche questo caso, come per il procedimento monitorio, la sommarietà non è legata alla assenza del
contraddittorio, ma alla verifica dei presupposti dell’esistenza del diritto.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
Tornando al procedimento, si fa riferimento ad atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai
fini, sempre in relazione comunque ai presupposti generali del procedimento cautelare.
Il provvedimento finale.
Può essere un provvedimento di rigetto o di accoglimento dell’istanza cautelare.
L’ordinanza di rigetto, disciplinata dall’art. 669septies, può essere pronunciata dal giudice per qualunque
motivo, di rito o di merito. In realtà, la norma parla solo di incompetenza, dando quasi l’impressione che
l’unico motivo in cui può pronunciarsi un rigetto sia questo. In realtà non è così. L’incompetenza viene in
rilievo solo per quanto riguarda la riproposizione dell’istanza, nel senso che se l’ordinanza di rigetto è
pronunciata per incompetenza, non è pregiudicata la riproposizione dell’istanza così com’è. Diversamente,
per la riproposizione dell’istanza è necessario addurre mutamenti nelle circostanze, oppure dedurre nuove
ragioni di fatto o di diritto.
In relazione al secondo e terzo comma della norma, che fanno riferimento alla pronuncia sulle spese, è
necessario notare che, se l’ordinanza è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice
provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare. Questo riferimento si spiega perché può
accadere che non abbia luogo un giudizio di merito. In questo caso le spese rimangono a carico dell’istante.
L’art. 669octies tratta dell’ordinanza di accoglimento. Questa, ove la domanda sia stata proposta prima
dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per
l’inizio del giudizio di merito. La norma ci dà la misura del carattere strumentale e accessorio del
provvedimento cautelare. In caso di mancata fissazione del termine da parte del giudice è di sessanta giorni
dalla pronuncia dell’ordinanza, se avvenuta in udienza, o dalla sua comunicazione. In assenza di
instaurazione del giudizio nel termine, il provvedimento cautelare perde efficacia.
Particolarmente importante è il sesto comma, secondo il quale le disposizioni di cui al presente articolo e al
primo comma dell’art. 669novies sull’inefficacia del provvedimento non si applicano ai provvedimenti
d’urgenza di cui all’art. 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della
sentenza di merito. Questa esclusione implica che, nell’ambito delle misure cautelari, occorre operare una
distinzione tra misure conservative e provvedimenti anticipatorii.
Le misure cautelari conservative sono caratterizzate da una strumentalità forte: la misura cautelare deve
necessariamente appoggiarsi a un giudizio di merito.
I provvedimenti anticipatorii sono caratterizzati da strumentalità debole o attenuata: si tratta dei
provvedimenti d’urgenza ex art. 700 e di quei provvedimenti cautelari idonei ad anticipare la sentenza di
merito. Questi ultimi sono idonei a far conseguire al soggetto quella utilità che gli potrebbe derivare alla fine
del processo dalla sentenza di merito.
La distinzione è molto importante perché, mentre le misure cautelari conservative perdono efficacia nel
momento in cui il giudizio di merito non venga instaurato o si estingua, i provvedimenti anticipatorii possono
rimanere in vigore ad nutum, senza limiti di durata, in quanto la parte non ha bisogno di instaurare
necessariamente il giudizio di merito.
Ciò non vuol dire che non debba farlo, ma solo che l’instaurazione è facoltativa. Peraltro, il legislatore
prevede delle strategie particolari per fare in modo che nessuna delle parti sia indotta a instaurare il giudizio
di merito. Una di queste strategie è data dall’obbligo per il giudice di provvedere già sulle spese della fase
cautelare.
Quand’anche venga instaurato il giudizio di merito a seguito di un provvedimento anticipatorio, la sua
estinzione non determina l’inefficacia di tale provvedimento, anche quando la relativa domanda è stata
proposta in corso di causa.
A ulteriore conferma della possibilità di sopravvivenza di questa misura cautelare interviene l’ultimo
comma, affermando che l’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un altro processo. Ciò
significa che se anche l’istante abbia ottenuto una misura cautelare, questa non potrà essere invocata in altro
processo per dimostrare l’esistenza del diritto, proprio perché non è un accertamento pieno e definitivo.
Eccettuato il caso delle misure cautelari a carattere anticipatorio, per tutte le altre viene in considerazione
l’art. 669novies, che disciplina le ipotesi di inefficacia del provvedimento cautelare.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
Le ipotesi di inefficacia sono varie:
a) Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio indicato dal giudice con l’ordinanza di
accoglimento, o in assenza di termine, in quello previsto dal codice di sessanta giorni;
b) Se il giudizio di merito iniziato si è estinto;
c) Se non è stata versata la cauzione al pagamento della quale era subordinato il provvedimento;
d) Se nel giudizio di merito, con sentenza anche non passata in giudicato, è stato dichiarato inesistente
il diritto a tutela del quale il provvedimento era stato richiesto, oppure se il provvedimento si è
concluso in mero rito.
In questi casi ci sono differenze per quanto riguarda la declaratoria di inefficacia.
Nei casi a) e b) è il giudice che ha emesso il provvedimento che dichiara la perdita di efficacia, se non c’è
contestazione, con ordinanza dichiara l’efficacia esecutiva e dà le disposizioni per la riduzione in pristino. Se
vi è contestazione lo strumento è quello della sentenza provvisoriamente esecutiva.
Nei casi c) e d) è lo stesso giudice che provvede alla declaratoria e all’adozione delle misure necessarie alla
riduzione in pristino e lo fa nella stessa sentenza con cui provvede nel merito. Se il giudice non lo fa nella
sentenza di merito, la declaratoria di inefficacia e la riduzione in pristino possono essere richieste con un
ricorso allo stesso giudice, il quale provvederà con ordinanza.
La revoca e la modifica del provvedimento.
Secondo l’art. 669decies, queste si possono richiedere allo stesso giudice che ha pronunciato il
provvedimento, se il giudizio di merito non è ancora iniziato o è stato dichiarato estinto, oppure al giudice
del merito nel caso in cui penda il giudizio di merito, anche se la misura è stata dichiarata ante causam.
Motivi della richiesta. Si può chiedere una revoca o una modifica per mutamenti delle circostanze o per fatti
anteriori al procedimento cautelare dei quali si abbia avuto conoscenza successivamente alla emanazione del
provvedimento cautelare. In quest’ultimo caso sarà necessaria la prova del momento in cui si è avuta la
conoscenza del provvedimento.
Significativa è la prima parte della norma che introduce la clausola “salvo che sia stato proposto reclamo ai
sensi dell’art. 669terdecies”. Infatti, sembra abbastanza difficile comprendere come sia concepibile ottenere
la revoca o la modifica del provvedimento proponendo reclamo.
Il reclamo.
Si tratta di un vero e proprio gravame, quindi di un’impugnazione a critica libera, proponibile anche
semplicemente denunciando l’ingiustizia della misura cautelare. Il reclamo, ai sensi dell’art. 669terdecies,
può essere proposto nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento,
ovvero dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore.
L’unico indice rispetto ai motivi per i quali l’impugnazione può essere proposta si trova al quarto comma, il
quale afferma che le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo devono
essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Ciò significa che se
vi sono dei motivi sopravvenuti che vengono in considerazione quando è stato proposto il reclamo, dovranno
essere fatti valere nel procedimento di reclamo e non potranno più essere motivo di richiesta di revoca o
modifica.
Il procedimento è quello in camera di consiglio, come si può notare dal richiamo agli artt. 737 e 738.
Si tratta di un’impugnazione che ha un carattere devolutivo e sostitutivo, quindi l’ordinanza non
impugnabile resa sul reclamo si sostituisce in pieno al provvedimento reclamato.
Il reclamo non ha efficacia sospensiva dell’esecuzione del provvedimento, ma il presidente del tribunale o
della Corte investiti del reclamo possono disporre la sospensione quando, per motivi sopravvenuti, il
provvedimento arrechi grave danno. Il concetto di grave danno è una clausola generale che dovrà essere
valutata con riferimento al caso concreto.
L’attuazione del provvedimento cautelare.
L’attuazione del provvedimento cautelare è disciplinata dall’art. 669duodecies. Salvo quanto disposto dagli
artt. 677 e ss. in ordine ai sequestri, l’attuazione dei provvedimenti cautelari aventi ad oggetto somme di
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
denaro avviene nelle forme degli artt. 491 e ss. in quanto compatibili, mentre l’attuazione delle misure
cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del
giudice che ha emanato il provvedimento cautelare. Il legislatore ha deciso di non usare il termine esecuzione
forzata in ordine ai provvedimenti cautelari, ma è ovvio che non siano utilizzabili forme diverse da queste.
Il legislatore ha voluto utilizzare il termine attuazione, prevedendo però che le misure cautelari che abbiano
ad oggetto una somma di denaro si eseguano nelle forme proprie dell’espropriazione, a condizione che siano
compatibili con la misura cautelare stessa. Per quanto riguarda le altre ipotesi, l’attuazione avviene in forma
breve: è lo stesso giudice che ha emesso la misura cautelare a decidere come avrà luogo il provvedimento.
Naturalmente, posto che nel diritto non ci si può inventare nulla, si ritiene che anche questa attuazione in via
breve si svolga avendo come punto di riferimento le norme sull’esecuzione forzata in forma specifica.
Queste, tuttavia, dovranno essere applicate non alla lettera, ma con gli adattamenti richiesti dal caso
concreto.
Ogni altra questione che riguardi l’attuazione dovrà essere proposta, se del caso, nel giudizio di merito.
I SEQUESTRI.
I sequestri sono essenzialmente due: il sequestro giudiziario (che a sua volta si distingue in due tipologie) e
il sequestro conservativo.
Le norme comuni dettate dal legislatore hanno poca ragion d’essere perché interviene il procedimento
cautelare uniforme.
Il sequestro giudiziario.
Il sequestro di beni. Secondo l’art. 670 n.1, il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario di beni mobili
o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è
opportuno provvedere alla loro custodia e alla loro gestione temporanea.
Questo è il c.d. sequestro di beni che, a norma dell’art. 677, si esegue in base agli artt. 605 e ss., in quanto
applicabili, ossia nelle forme proprie dell’esecuzione per consegna o rilascio. L’effetto del sequestro
giudiziario di beni è quello di determinare la sottrazione al sequestrato della disponibilità di un
determinato bene. È quindi utilizzato in funzione dell’esecuzione per consegna o rilascio.
Esempio. Tizio vanta un diritto che implica la disponibilità di un determinato bene, o meglio, l’esercizio di
un potere di fatto su di esso. Questo bene è, però, detenuto da Caio. Tizio agisce in giudizio contro Caio, ma
per tornare nella disponibilità del bene deve attendere la sentenza di condanna con la quale Caio viene
condannato al rilascio del bene. In una situazione come questa, nelle more del giudizio, Tizio può chiedere il
sequestro giudiziario del bene stesso. Il riferimento al tempo per ottenere la sentenza contro Caio fa
comprendere quale possa essere il periculum in mora. Esso può essere costituito dal perimento o
danneggiamento della cosa nel tempo necessario per la conclusione del processo. Prendiamo, ad esempio, un
bene immobile che richiede interventi di manutenzione. Se Caio non li compie, il valore del bene si ridurrà
moltissimo, con la conseguenza che, quand’anche Tizio ottenesse a suo favore una sentenza di condanna al
rilascio, otterrebbe un immobile di valore minore rispetto a quello iniziale.
C’è anche un rischio giuridico molto più importante, che riguarda i beni mobili: è il rischio del trasferimento
in applicazione dell’art. 1153 c.c. Supponiamo che Caio abbia il possesso o detenga un bene mobile di cui
Tizio si asserisce proprietario. Nelle more del giudizio instaurato contro di lui, Caio trasferisce a Sempronio
il bene in virtù di un atto astrattamente idoneo al trasferimento, con consegna del bene a Sempronio che lo
acquisisce in buona fede. L’art. 1153 fa acquistare a Sempronio, che è in buona fede, la proprietà bene a
titolo originario, anche se il suo dante causa non ne era proprietario. In un’ipotesi del genere dovrebbe
trovare applicazione l’art. 111 c.p.c., che disciplina l’ipotesi della successione a titolo particolare nel diritto
controverso. Questo articolo fa salvi gli effetti di buona fede, quindi Tizio non avrebbe più la possibilità di
recuperare il bene che gli spetta. In una fattispecie di questo genere, Tizio può chiedere il sequestro
giudiziario del bene.
Presupposti. Anche in questo caso sono il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Il fumus implica la necessità di provare, anche se solo sommariamente, il diritto dell’istante e, in genere,
un qualunque diritto che possa avere ad oggetto beni determinati, quindi cose fungibili, ma anche titoli di
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
credito (es. azioni), in quanto il titolo di credito è di solito incorporato in un documento, il quale è un bene
materiale.
Per quanto riguarda il periculum in mora, si suole dire che è richiesto, in genere, un pericolo molto basso,
ossia la semplice necessità della custodia o della gestione del bene, proprio perché il sequestro giudiziario
serve ad assicurare che, nelle more del processo, il bene oggetto del diritto in contestazione si mantenga
integro.
Il sequestro probatorio. Il n. 2 dell’art. 670 tratta del sequestro di libri, registri, documenti, modelli,
campioni e ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla
esibizione o alla comunicazione ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea. La norma ha
creato qualche problema in relazione al presupposto dell’esistenza di una controversia sul diritto
all’esibizione o comunicazione di un oggetto che possa essere utilizzato a fini probatori. Occorre compiere
un coordinamento con le norme sull’esibizione. Il riferimento è all’art. 210 che, in realtà, rinvia all’art. 118
sull’ispezione. In sostanza, sulla base di queste norme, l’ordine di esibizione risulta incoercibile. In base
all’art. 118, nel caso in cui vi sia un rifiuto del soggetto di esibire il documento, le conseguenze sono diverse.
Se rifiuta il terzo, il giudice gli infligge una pena pecuniaria tutto sommato modesta. Se il rifiuto proviene da
una parte, il giudice potrà desumere argomenti di prova ex art. 116 secondo comma, quindi considerare come
provati i fatti in senso sfavorevole alla parte che ha rifiutato l’esibizione.
Con il sequestro probatorio si vuole mettere al sicuro le prove che si intendono utilizzare nel processo,
nonché dimostrare che la prova è effettivamente nella disponibilità del soggetto contro il quale il
sequestro è rivolto. Secondo l’art. 94 disp. att., infatti, l’istanza di esibizione di un documento o di una cosa
in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e,
quando è necessario, l’offerta della prova che la parte o il terzo li possiede. Naturalmente, nel momento in
cui si svolge un giudizio di merito, se il giudice ordinerà l’esibizione, il sequestrato deciderà se adempiere o
meno, con le conseguenze che abbiamo appena visto.
La funzione di questo tipo di sequestro è, quindi, quella di consentire pro futuro, nell’ambito di un giudizio
di merito, la possibilità di utilizzare i documenti a fini probatori.
La custodia. In entrambi i tipi di sequestro viene in considerazione l’opportunità della custodia dei beni.
Secondo l’art. 676, il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà
cauzione, quindi in linea teorica potrebbe essere nominato custode anche il sequestrato. Naturalmente, in
questo caso, la sua veste cambia, in quanto assume i diritti e gli obblighi propri del custode.
In alternativa, è possibile il c.d. sequestro convenzionale a norma dell’art. 1798 c.c., che è il contratto con
il quale due o più persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità di cose rispetto alla quale è nata una
controversia, affinché la restituisca alla parte cui spetti legittimamente quando la controversia sarà definita. I
presupposti sono gli stessi del sequestro di beni: esistenza di una controversia tra le parti sull’esistenza di un
diritto su un certo bene. La differenza è data dalla stipulazione di un contratto e dall’affidamento del bene a
un terzo.
Il sequestro giudiziario può perdere efficacia per i motivi dettati dal procedimento uniforme: mancata
instaurazione del giudizio di merito nel termine fissato dal giudice; estinzione del giudizio di merito già
iniziato; riconoscimento dell’inesistenza del diritto del sequestrante con sentenza anche non passata in
giudicato.
Per il sequestro però vi è un’ipotesi ulteriore di perdita di efficacia. Secondo l’art. 675, il sequestro perde
efficacia se non è eseguito nel termine di trenta giorni dalla pronuncia del provvedimento.
Per quanto riguarda l’esecuzione, si fa riferimento alle norme dell’esecuzione per consegna o rilascio, ma in
una versione semplificata, in quanto si omette la notificazione del precetto.
Vi sono delle ipotesi particolari che danno lo spunto per le riflessioni della dottrina, come per esempio quella
del sequestro d’azienda. Essendo una universalità di beni, ci si chiede se oggetto di sequestro sia l’azienda in
sé o i singoli beni che la compongono.
Il sequestro conservativo.
Il sequestro conservativo trova la sua disciplina sia nel codice civile, sia nel codice di procedura.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
Per quanto riguarda il codice di procedura, l’art. 671 afferma che il giudice, su istanza del creditore che ha
fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni
mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il
pignoramento.
L’art. 2905 c.c. precisa che il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore secondo
le regole stabilite dal codice di procedura civile.
Lo scopo del sequestro conservativo è quello di tutelare le ragioni di un creditore che non dispone ancora
di un titolo esecutivo in virtù del quale espropriare i beni del debitore. È quindi necessario che il
creditore si procuri il titolo esecutivo e l’ordinamento predispone una tutela che gli consente di evitare che,
nelle more del giudizio necessario per procurarsi il titolo esecutivo, il debitore compia atti che riducano la
consistenza della sua garanzia patrimoniale. Se il patrimonio del debitore si riducesse, infatti, il creditore al
termine del processo non avrebbe nulla su cui soddisfarsi. Il sequestro conservativo è un modo per assicurare
la futura fruttuosità dell’esecuzione forzata nel tempo necessario al creditore per acquisire il titolo esecutivo.
Il sequestro conservativo è utilizzabile per tutti i diritti che si possono attuare coattivamente mediante
l’espropriazione, quindi per tutti i diritti di credito e, in particolare, per i crediti aventi ad oggetto somme di
denaro, anzi, si dice che il credito non deve neppure essere liquido, in quanto la liquidazione verrà effettuata
nel giudizio di merito da cui deriverà la sentenza-titolo esecutivo, e neppure certo perché, anche in questo
caso, la certezza deriva dalla sentenza. A quel punto, infatti, la sentenza dovrà rispondere dei requisiti di cui
all’art. 474, quindi essere utilizzabile per l’attuazione di un credito certo, liquido ed esigibile.
Normalmente il sequestro conservativo è rivolto contro il debitore, ma può anche riguardare un terzo. Ai
sensi del secondo comma dell’art. 2905, il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo
acquirente dei beni del debitore qualora sia stata proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia
dell’alienazione. Questa azione è l’azione revocatoria ex art. 2901. L’azione revocatoria è uno dei mezzi di
conservazione della garanzia patrimoniale del debitore. Ai sensi del primo comma dell’art. 2901, il creditore,
anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi
confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni
quando ricorrono particolari condizioni.
Presupposti. Per ciò che concerne il fumus abbiamo la necessità di elementi che dimostrino la altamente
probabile esistenza del diritto di credito a tutela del quale viene chiesto il sequestro.
Per il periculum è necessario qualcosa di più specifico: il fondato timore di perdere la garanzia del
credito. Non basta quindi un generico timore per integrare il presupposto. Per valutare se sussiste il fondato
timore occorre compiere un giudizio comparativo tra quello che è il patrimonio del debitore e l’entità
del credito a tutela del quale il creditore chiede il sequestro conservativo. Possiamo, ad esempio,
considerare l’ipotesi in cui il debitore è titolare di un solo bene immobile. Se nelle more del giudizio
necessario al creditore per procurarsi il titolo esecutivo il debitore si liberasse di questo unico bene, l’atto di
alienazione sarebbe estremamente pregiudizievole per il creditore. Se invece nel patrimonio del debitore vi è
una pluralità di beni il cui valore supera in maniera consistente il credito a tutela del quale viene richiesto il
sequestro, se anche vendesse un singolo immobile, la garanzia patrimoniale rimarrebbe comunque molto
consistente. Di conseguenza non avrebbe ragion d’essere un sequestro conservativo.
Anche con riferimento a questo sequestro trova applicazione l’art. 675, quindi il sequestro perde efficacia se
non è eseguito entro trenta giorni dalla pronuncia del provvedimento autorizzativo.
Il provvedimento che autorizza il sequestro conservativo, in genere si limita a dire che l’istante è autorizzato
a procedere al sequestro nel limite massimo di una somma che viene fissata dal giudice. Sarà poi il creditore,
sotto la propria responsabilità, a scegliere i beni da sottoporre a sequestro. Del resto, come afferma lo stesso
art. 671, il sequestro è ammissibile nei limiti in cui la legge ammette il pignoramento. Sarà quindi nella
responsabilità del creditore anche la scelta del tipo di espropriazione più idoneo nel caso concreto (artt. 678 e
679).
La responsabilità del creditore potrà anche integrare un’ipotesi di responsabilità aggravata e, quindi, la
condanna non solo alle spese, ma anche ai danni ai sensi dell’art. 96 secondo comma. Il fatto di intraprendere
una espropriazione immobiliare per un credito dall’entità molto ridotta potrebbe, ad esempio, determinare
una responsabilità di questo tipo.
L’esecuzione del sequestro, quindi, coincide con il pignoramento.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
Di fatto si tratta di una sorta di pignoramento anticipato, i cui effetti sono disciplinati dall’art. 2906 c.c., il
quale afferma che non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti
che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento. In
sostanza, anche qui abbiamo come effetto del sequestro l’inopponibilità di tutti gli atti di disposizione
compiuti dal debitore sequestrato su tutti i beni assoggettati a sequestro. Qui però c’è una grossa differenza
rispetto al pignoramento perché, in quel caso, dell’inefficacia si giovano sia il creditore procedente, sia i
creditori intervenuti nella procedura esecutiva (c.d. vincolo a porta aperta). Nel caso del sequestro, al
contrario, l’inefficacia relativa degli atti di disposizione è limitata al creditore sequestrante (c.d. vincolo
a porta chiusa).
La revoca e l’estinzione.
Essa non ha niente a che vedere con la revoca del procedimento cautelare uniforme. Quest’ultima può essere
richiesta per mutamenti sopravvenuti delle circostanze o per fatti anteriori alla misura cautelare di cui il
soggetto sia venuto a conoscenza dopo il provvedimento per cause di forza maggiore o comunque a lui non
imputabili.
La revoca del sequestro, ai sensi dell’art. 684, è un’ipotesi particolare sostanzialmente identica alla
conversione del pignoramento prevista dall’art. 495. Il debitore può sottrarsi al pignoramento di un bene
sostituendo al bene una somma di denaro. Analogamente, in questo caso, il debitore può ottenere dal giudice
la revoca del sequestro conservativo prestando idonea cauzione per l’ammontare del credito che ha dato
causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate.
Il sequestro si estingue, convertendosi in pignoramento, quando il creditore ottiene una sentenza di
condanna esecutiva. Ricordiamo che anche la sentenza in primo grado non passata in giudicato vale come
titolo esecutivo. Ci si può domandare se la conversione operi automaticamente o meno. L’opinione
prevalente tende ad affermare che la conversione sia automatica, tuttavia, sembra logico pensare che sia
necessario, per la produzione di questo automatismo, il deposito in cancelleria della sentenza esecutiva di
condanna del debitore. Al di là di questo, con la conversione del sequestro scattano tutti gli effetti tipici del
pignoramento, quindi, in particolare, anche quegli effetti di cui si avvantaggiano eventuali creditori che
intervengano nel procedimento, come l’inefficacia relativa degli atti di disposizione.
Il sequestro liberatorio.
Disciplinato dall’art. 687, si tratta dell’ipotesi in cui il debitore abbia offerto o messo a disposizione del
creditore per la sua liberazione una somma di denaro o delle cose. Il creditore rifiuta l’offerta del debitore e
si cade nell’ambito dell’istituto denominato mora credendi (artt. 1206 ss.). In questo caso il sequestro ha la
mera funzione di custodire la somma di denaro o le cose offerte al creditore fino al momento in cui si accerti
se l’adempimento o l’offerta erano effettivamente conformi al contenuto dell’obbligazione così come
previsto dal diritto sostanziale.
I PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA.
Si tratta di misure cautelari la cui finalità è quella di raccogliere prove prima del processo o anche quando è
altamente probabile che quelle stesse prove non possano essere assunte in un momento successivo.
L’assunzione preventiva delle prove è possibile solo per le prove costituende – e neanche tutte, in quanto
giuramento e confessione non possono essere assunti preventivamente –, mentre per le prove precostituite
non si pone un problema di acquisizione preventiva.
Le misure di istruzione preventiva sono misure cautelari che hanno una funzione conservativa, nel senso che
mirano a procurarsi e a conservare una prova che altrimenti potrebbe non essere più disponibile.
Si tratta però di misure cautelari sui generis, in quanto la loro disciplina si sottrae all’applicazione del rito
cautelare uniforme, come si evince dall’art. 669quaterdecies, tranne che per il caso dell’art. 669septies che
riguarda il provvedimento negativo, ossia quel provvedimento con cui viene rigettata l’istanza del
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
provvedimento cautelare – se il rigetto avviene per incompetenza la domanda cautelare può essere riproposta
senza limiti, quindi non c’è effetto preclusivo, mentre se il rigetto avviene per qualunque altra ragione di rito
o di merito, la riproponibilità è condizionata a mutamenti nelle circostanze o nuovi elementi di fatto o di
diritto –.
Altro aspetto importante è dato dall’assenza di qualunque onere di instaurazione del giudizio di merito
nel termine perentorio assegnato dal giudice (c.d. misure a strumentalità debole).
Possono essere assunte in via preventiva la prova testimoniale, l’ispezione e l’accertamento tecnico.
La prova testimoniale.
Per quanto riguarda la prova testimoniale, il riferimento è all’art. 692, il quale afferma che chi ha fondato
motivo di temere che stiano per mancare uno o più testimoni le cui deposizioni possono essere necessarie in
una causa da proporre può chiedere che ne sia ordinata l’audizione a futura memoria.
L’elemento importante è il fondato timore che il testimone non sia più disponibile nel momento in cui la
prova dovrebbe essere assunta. La parte istante deve quindi dimostrare il periculum, ma anche i fatti
oggetto della prova e l’esposizione sommaria delle domande e delle eccezioni cui la prova si riferisce, ossia
un’indicazione sommaria del fumus.
Trovate queste indicazioni, si propone l’istanza, ai sensi dell’art. 693, nella forma del ricorso, al giudice che
sarebbe competente per la causa di merito. Il ricorso deve contenere l’esplicazione dei motivi dell’urgenza
(periculum) e dei fatti sui quali devono essere interrogati i testimoni, nonché l’esposizione sommaria delle
domande e eccezioni alle quali la prova è preordinata (fumus boni iuris).
L’ispezione e l’accertamento tecnico.
Sono disciplinati entrambi dall’art. 696, il quale sancisce che chi ha urgenza di far verificare lo stato dei
luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli artt. 692 e ss., che sia disposto un
accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale. L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre
l’urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei
cui confronti l’istanza è proposta.
L’accertamento tecnico e l’ispezione possono avere ad oggetto cose o anche persone.
Per l’accertamento tecnico è particolarmente importante il secondo comma, dove si dice che esso può
comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica. Questa
aggiunta alla norma è stata determinata dalla poca chiarezza del termine verifica. La verifica non è una
semplice fotografia dell’oggetto della verifica stessa. Il professor Luiso, nel suo manuale, fa un esempio
estremamente chiaro. Tizio appalta la costruzione di un fabbricato a Caio. Una volta costruito il fabbricato,
Tizio si accorge che non è stato realizzato ad opera d’arte e presenta dei vizi. Chiede allora un accertamento
tecnico preventivo che descriva i vizi e valuti i danni causati dall’imperizia di Caio. In questo modo potrà far
riparare l’edificio, ma conservare la dimostrazione dei vizi da far valere nel giudizio contro Caio, nonché per
avere una valutazione dei danni da richiedere a titolo di accertamento.
Sia per l’ispezione, sia per l’accertamento tecnico preventivo, l’oggetto può anche essere una persona. Se si
tratta della persona contro la quale l’istanza è proposta, è tuttavia necessario il consenso. Questa norma è
stata riformulata a seguito di due sentenze della Corte costituzionale che avevano dichiarato illegittima la
versione originale della norma. Allo stato attuale, possiamo dire che né l’accertamento tecnico preventivo,
né l’ispezione sono di per sé coercibili. Tuttavia, bisogna considerare le conseguenze di un eventuale
rifiuto. La soluzione che sembra più ragionevole è quella di applicare l’art. 118 sulle conseguenze
dell’ispezione, il quale, al secondo e terzo comma, prevede che se la parte rifiuta di eseguire l’ordine senza
giusto motivo, il giudice può desumere da questo comportamento argomenti di prova a norma dell’art. 116
secondo comma.
Il procedimento.
Nel caso dei procedimenti di istruzione preventiva non si applica il rito cautelare uniforme, ad eccezione
dell’art. 669septies. Bisogna considerare che, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale, è
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
esperibile il reclamo cautelare, ma solo contro il provvedimento che ha respinto l’istanza, non anche contro
il provvedimento che abbia accolto l’istanza concedendo la misura cautelare.
Il provvedimento può essere richiesto ante causam, o anche nel corso di un processo già pendente. Nel primo
caso l’istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per il giudizio di merito; nel secondo
caso si propone al giudice dinanzi al quale pende già la causa.
Per le misure di istruzione preventiva può essere competente anche il giudice di pace, il quale non è
competente a decidere sulle altre misure cautelari. Questa regola è enunciata dall’art. 693.
In caso di eccezionale urgenza, il secondo comma dell’art. 693 prevede che l’istanza possa essere proposta
anche al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta. Possiamo pensare al caso di un teste
anziano è malato che risiede a 1000 km dal luogo del processo. In caso di eccezionale urgenza, l’istanza
potrà essere proposta anche al tribunale del luogo in cui il testimone risiede.
In condizioni normali, le misure di istruzione preventiva vengono adottate nel rispetto del principio del
contraddittorio tra le parti. Sulla base dell’art. 695 il giudice valuta l’esistenza dei presupposti e, in
particolare, la rilevanza della prova rispetto ai fatti da provare, fatti che a loro volta fanno riferimento a un
certo diritto (fumus boni iuris).
Questa valutazione può avvenire anche assumendo sommarie informazioni.
Nel momento in cui è proposto il ricorso, il presidente del tribunale fissa con decreto l’udienza di
comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto (art. 694).
A questa udienza, previa comparizione delle parti e assunte, se necessario, sommarie informazioni, il giudice
provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette la prova testimoniale, fissa l’udienza per
l’assunzione e designa il giudice che deve provvedervi (art. 695).
Nel caso in cui si tratti di accertamento tecnico preventivo o di ispezione, il giudice fisserà la data
definizione delle operazioni, avendo preventivamente individuato il consulente tecnico.
In caso di eccezionale urgenza, l’art. 697 prevede la possibilità di un provvedimento pronunciato inaudita
altera parte dal presidente del tribunale, il quale dispensa il ricorrente dalla notificazione alle altre parti. In
questo caso, tuttavia, mentre per le altre misure cautelari concesse inaudita altera parte mediante
procedimento cautelare uniforme esiste una fase successiva eventuale in cui si può recuperare il
contraddittorio, un meccanismo di questo genere non è previsto, almeno anteriormente all’assunzione.
L’ultimo comma dell’art. 697 ci dice, in realtà, che deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle
parti non presenti all’assunzione, non oltre il giorno successivo, quindi l’informativa volta al destinatario del
provvedimento avviene dopo l’assunzione della prova, assunzione che avviene nelle forme normali
disciplinate dagli artt. 202 e ss.
Molto importante è l’art. 698, relativo alla assunzione ed efficacia delle prove preventive. Il secondo
comma afferma che l’assunzione preventiva di una prova non pregiudica in nessun modo le questioni relative
alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito. Ciò significa
che, se il giudizio di merito e già pendente o viene instaurato, il fatto che una certa prova sia già stata assunta
in via preventiva è irrilevante, in quanto il giudice del merito dovrà provvedere alla valutazione dei due
elementi tipici delle prove: l’ammissibilità, che fa riferimento ai tipi di prova di cui il nostro ordinamento
consente l’assunzione, e la rilevanza, ossia l’idoneità della prova ad assumere una funzione dimostrativa
rispetto al fatto cui si riferisce. A dimostrazione di ciò, l’ultimo comma dell’articolo afferma che i processi
verbali delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel giudizio di merito
prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.
La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.
Si tratta di un istituto nuovo, introdotto nel 2005, disciplinato dall’art. 696bis. La norma è stata introdotta
partendo da una banale considerazione di quello che accade in pratica. Molto spesso nel processo di
cognizione l’unica questione realmente controversa tra le parti è una questione che solo un consulente
tecnico può risolvere. In questi casi il processo è un mero involucro, che serve solo ad acquisire la
consulenza tecnica. Una volta acquisita, non essendoci altre questioni controverse tra le parti, o esse
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
raggiungono una conciliazione, oppure il giudice pronuncia sentenza, limitandosi a recepire quanto accertato
nella consulenza tecnica.
Esempio. Tizio ha subito un tamponamento ad opera di Caio e sostiene che il danno è quantificabile in 3.000
euro. Caio non nega di aver colposamente tamponato Tizio, ma ritiene che il danno corrisponda a una somma
di 1.000 euro. La questione non è sull’an, ma sul quantum. In questo caso, il consulente tecnico nominato dal
giudice valuterebbe l’entità del danno e il giudice pronuncerebbe una sentenza in cui si limiterebbe a recepire
i risultati della consulenza.
L’art. 696bis vuole evitare che in situazioni di questo tipo sia instaurato un processo. La norma non ha
finalità cautelare vera e propria perché non è necessaria l’urgenza. Come sancisce la norma, consulenza
tecnica può, infatti, essere richiesta anche al di fuori delle condizioni previste dal primo comma dell’art. 696,
ossia la condizione di urgenza.
La consulenza tecnica può essere richiesta ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti
derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Le opinioni di
dottrina e giurisprudenza sono le più varie. Alcuni manuali criticano molto l’atteggiamento chiuso della
giurisprudenza a questo riguardo perché ritengono che un’interpretazione più ampia del concetto di fatto
illecito consentirebbe un maggiore uso della norma in funzione deflativa.
Per l’assunzione della consulenza tecnica preventiva si applicano gli artt. 191 e ss., in quanto compatibili.
Tuttavia, il riferimento è anche all’accertamento tecnico preventivo ex art. 696.
L’aspetto più interessante della norma è dato dall’ultima frase del primo comma, secondo cui il consulente,
prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Questo è
un altro elemento utile a dimostrare la finalità deflativa della norma. Quello del consulente tecnico è da
ritenersi un vero e proprio dovere, benché la norma non sia molto chiara.
Se le parti si conciliano, si forma processo verbale della conciliazione, al quale il giudice attribuisce con
decreto l’efficacia di titolo esecutivo. Vi è anche una sorta di favor in tema fiscale, in quanto il processo
verbale è esente dall’imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte, nell’ambito di un processo futuro, potrà chiedere che la
relazione del consulente sia acquisita agli atti. In questo caso il passaggio è più diretto, perché non sembra
necessaria una valutazione del nuovo giudice in ordine all’ammissibilità e alla rilevanza del processo
verbale, ma la parte può richiedere direttamente l’acquisizione.
Questo istituto è stato introdotto come passaggio obbligato anche per le controversie che riguardano il
risarcimento dei danni da responsabilità medica. La riforma del 2017 ha previsto la consulenza come
obbligatoria, in alternativa alla mediazione (anch’essa obbligatoria). Nel caso in cui la consulenza tecnica
preventiva non venga esperita e non venga esperito nemmeno il tentativo di mediazione, vi sono meccanismi
analoghi a quelli che il d.lgs. 28/2010 prevede nel caso in cui non si osservi l’obbligo di esperire in tentativo
preliminare di mediazione.
In ogni caso, decorsi sei mesi dal deposito dell’istanza di consulenza tecnica preventiva, la domanda diviene
procedibile. Il procedimento seguirà le norme del procedimento sommario di cognizione.
Altra ipotesi di applicazione della consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi è come passaggio
obbligato è quella dell’art. 445bis, in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e
disabilità, ecc.
IL PROVVEDIMENTO D’URGENZA.
Il provvedimento d’urgenza è disciplinato da un’unica norma, l’art. 700, essendo stati abrogati gli artt. 701 e
702.
Questo tipo di provvedimento è particolare, in quanto, già prima dell’introduzione del cautelare uniforme,
presentava delle peculiarità significative.
Il sistema delle nostre misure cautelari era, infatti, costruito come sistema di misure tipiche, con un’unica
misura atipica che fungeva da norma di chiusura. Laddove le prime non potevano essere utilizzate in ragione
della natura del periculum, poteva esservi spazio per la misura innominata di cui all’art. 700. Misura
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
innominata e atipica perché, sia il periculum, sia il contenuto concreto della norma rispondono a questi
caratteri di atipicità.
La norma afferma che, fuori dei casi regolati dalle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato
motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia
minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i
provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente
gli effetti della decisione sul merito.
Innanzitutto, dobbiamo constatare che il provvedimento d’urgenza ha una funzione sussidiaria, in quanto
entra in campo quando le altre misure cautelari non sono utilizzabili.
La nozione di fondato motivo deve essere elaborata tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle
misure cautelari e del fatto che la cognizione è di tipo sommario, ma che in questo caso il periculum presenti
requisiti tali da rendere fondata la preoccupazione dell’istante rispetto al pregiudizio imminente e irreparabile
che il suo diritto può subire.
Per quanto riguarda il diritto, sono stati scritti fiumi di inchiostro cercando di chiarirne il senso. L’opinione
prevalente è che si tratti di una situazione giuridica di vantaggio, riconosciuta dall’ordinamento come vero e
proprio diritto soggettivo. Non sarebbe quindi compreso l’interesse mero. Per quanto riguarda gli interessi
legittimi, il codice del processo amministrativo consente una tutela cautelare con una norma, l’art. 55, che è
abbastanza corrispondente all’art. 700, in quanto prevede l’emanazione di misure cautelari che appaiono,
secondo le circostanze, più idonee ad assicurare gli effetti della decisione sul ricorso.
L’espressione “tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria”, non si riferisce
semplicemente al giudizio ordinario di cognizione, perché non necessariamente la situazione di pregiudizio
imminente e irreparabile discende da questo tipo di giudizio. È possibile che la situazione si verifichi in un
procedimento di cognizione piena, ma speciale, come il rito del lavoro, o anche nell’ambito di un
procedimento a cognizione sommaria, anche se qui la dottrina avanza moltissimi dubbi.
I requisiti dell’imminenza e dell’irreparabilità del pregiudizio fanno riferimento a un dato temporale.
Deve, infatti, trattarsi di un pregiudizio che si verifica in un arco di tempo temporalmente breve. Per quanto
riguarda l’irreparabilità, non ci sono parametri fissi per la sua identificazione: questa valutazione dipenderà
dalle circostanze del caso concreto.
Questo spiega perché un discorso puramente teorico sul procedimento d’urgenza non ha molta ragion
d’essere. La tematica si apprezza molto di più studiando la casistica giurisprudenziale, che ricomprende le
materie più varie (societaria, lavoro, proprietà intellettuale,…). Un discorso simile può anche essere fatto in
relazione al contenuto del provvedimento d’urgenza, in quanto esso deve essere quello che appare, secondo
le circostanze, più idoneo ad assicurare gli effetti della decisione sul merito. Questo si ricollega all’altro dato
sulla natura anticipatoria del provvedimento d’urgenza: l’avverbio provvisoriamente fa proprio
riferimento a questa anticipazione. Gli effetti provvisori, come in tutti i provvedimenti anticipatorii, sono
comunque idonei a durare per un tempo indefinito, finché il soggetto non decide di instaurare il giudizio di
merito (ma non è detto che lo faccia).
LE AZIONI DI NUNCIAZIONE.
Si tratta dei procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto. È indispensabile fare riferimento
alla disciplina contenuta negli artt. 1171 e 1172 c.c.
L’art. 1171 disciplina la denunzia di nuova opera e stabilisce che il proprietario, il titolare di altro diritto
reale di godimento, o il possessore, che ha ragione di temere che da una nuova opera da altri intrapresa sul
proprio o sull’altrui fondo stia per derivare danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo
possesso, può denunziare all’autorità giudiziaria la nuova opera purché questa non sia terminata e non sia
trascorso un anno dal suo inizio.
L’art. 1172, che disciplina la denunzia di danno temuto, afferma che il proprietario, il titolare di altro
diritto reale di godimento, o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o
altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda
per ovviare al pericolo.
La legittimazione è concessa al proprietario, al titolare di altro diritto reale di godimento e al possessore.
La prima norma ha la finalità di vietare che venga continuata l’esecuzione dell’opera, mentre la seconda
quella di ottenere un provvedimento che neutralizzi il pericolo.
I presupposti sostanziali sono facilmente individuabili. Nel caso dell’art. 1171 si tratta del timore che possa
derivare un danno dalla nuova opera; nel caso dell’art. 1172 del timore del pericolo di un danno grave e
prossimo alla cosa.
Il procedimento.
Il procedimento è oramai ridotto a due sole norme, gli artt. 688 e 691.
Per quanto riguarda l’art. 688, si comprende che si tratta di misure cautelari completamente assoggettate al
procedimento cautelare uniforme. Il rinvio all’art. 669quater ci fa anche comprendere che si tratta di azioni
che possono essere proposte sia ante causam, sia nel corso del giudizio di merito. Nel primo caso, il ricorso
introduttivo andrà proposto al giudice competente a norma dell’art. 21 secondo comma, ossia il giudice del
luogo dove è avvenuto il fatto denunciato, mentre nel secondo caso, è competente lo stesso giudice del
merito.
Al di là di questo si applica in toto il rito cautelare uniforme. Ricordiamo anche che si tratta di misure a
carattere anticipatorio per la sopravvivenza delle quali non è necessaria l’instaurazione del giudizio di merito
(c.d. misure a strumentalità debole).
L’art. 691 – rubricato contravvenzione al divieto del giudice – stabilisce che se la parte alla quale è fatto
divieto di compiere l’atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all’ordine, il giudice, su ricorso
della parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del
contravventore.
Questa è un’altra indicazione dell’assoggettamento al rito cautelare uniforme, in quanto questa norma,
secondo Balena, integra e rafforza quanto previsto dall’art. 669duodecies in merito all’attuazione delle
misure cautelari. La parte finale di tale norma fa riferimento ai poteri del giudice che ha concesso la misura
cautelare di risolvere con ordinanza eventuali difficoltà che sorgano nel corso dell’esecuzione adottando i
provvedimenti ritenuti necessari.
I PROCEDIMENTI POSSESSORI.
Le azioni possessorie non sono vere e proprie misure cautelari, ma sono in parte assoggettate alla
disciplina del cautelare uniforme.
Prima di analizzare le norme del codice di procedura, dobbiamo fare riferimento al codice civile, in
particolare agli artt. 1168 e 1170, ossia alle azioni di reintegrazione, di manutenzione e di spoglio.
Ai sensi dell’art. 1168 – rubricato azione di reintegrazione – chi è stato violentemente od occultamente
spogliato del possesso può, entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore di esso la
reintegrazione nel possesso medesimo. L’azione è altresì concessa a chi ha la detenzione della cosa, a meno
che questa sia determinata da ragioni di servizio o di ospitalità.
Secondo l’art. 1170 – denominato azione di manutenzione – chi è stato molestato nel possesso di un
immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un’universalità di mobili può, entro un anno dalla
turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo. Anche colui che ha subito uno spoglio non
violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo.
La disciplina processuale di queste azioni è contenuta negli artt. 703-705.
Per quanto riguarda l’analisi dell’art. 703, dobbiamo innanzitutto ricordare che non si tratta di misure
cautelari vere e proprie, ma le analogie sono molte. Questo si comprende in particolare dal riferimento al rito
cautelare uniforme, presente nel secondo comma. Dopo la proposizione con ricorso al giudice competente
(quello del luogo in cui è avvenuto il fatto denunciato), il giudice provvede ai sensi degli artt. 669bis e ss., in
quanto compatibili.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
Altra analogia è riscontrabile nel terzo comma, che prevede la possibilità di esperire reclamo ex art.
669terdecies, contro l’ordinanza che concede o nega il provvedimento cautelare.
Le particolarità rispetto al rito cautelare uniforme sono le seguenti.
La prima è indicata dal quarto comma dell’art. 703, secondo il quale, nel concedere il provvedimento, il
giudice fissa il termine per la prosecuzione del giudizio di merito, ma solo se richiesto da una delle parti,
mentre per il cautelare vero e proprio non è necessaria l’istanza delle parti, ma è lo stesso giudice che fissa il
termine per l’introduzione del giudizio di merito.
La seconda è data dal fatto che si applica l’art. 669novies terzo comma. Ciò significa che il provvedimento a
tutela della detenzione perde efficacia se, con la sentenza di merito anche non passata in giudicato, è
dichiarato inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Questa è l’unica ipotesi
di perdita di efficacia del provvedimento, mentre l’art. 669novies prevede anche altre ipotesi.
Per quanto riguarda l’art. 704, esso fa riferimento alle domande di provvedimento possessorio nel corso
del giudizio petitorio. Il giudizio petitorio è il giudizio promosso dal titolare del diritto di proprietà rivolto
ad ottenere la difesa del suo diritto nelle forme di un giudizio ordinario di cognizione. Qui si fa riferimento al
gruppo di norme del codice civile che riguardano le azioni a difesa della proprietà o petitorie (artt. 948-
951). Queste azioni sono: l’azione di rivendicazione, l’azione negatoria (che mira ad ottenere la declaratoria
di inesistenza di diritti vantati da altri sulla cosa, quando si ha motivo di temerne pregiudizio), l’azione di
regolamento dei confini e l’azione per l’apposizione di termini.
Ai sensi dell’art. 704, ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del
giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest’ultimo. Quindi nel caso in cui sorga un
problema di turbativa del possesso e sia già pendente un giudizio petitorio, la relativa domanda deve essere
proposta nell’ambito del giudizio petitorio. Tuttavia, in considerazione dei tempi lunghi del giudizio
petitorio, l’azione di reintegrazione nel possesso può anche essere richiesta autonomamente al giudice
competente ex art. 703. Giudice che dà i provvedimenti temporanei indispensabili. Sarà poi onere di una
delle due parti proporre l’istanza al giudice del petitorio per la trattazione del merito.
A questo quadro si aggiunge l’art. 705, che disciplina il divieto di proporre giudizio petitorio. Il
convenuto – e solo lui – nel giudizio possessorio non potrà proporre giudizio petitorio, finché il primo
giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita. Egli può, tuttavia, proporre giudizio petitorio
quando dimostra che l’esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell’attore. La
regola è stata quindi attenuata da una pronuncia della Corte costituzionale, nel caso in cui da essa possa
derivare un pregiudizio irreparabile del convenuto.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
I PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO.
Per entrambi i procedimenti esiste un retroterra molto consistente disciplinato dal codice civile. In realtà le
norme del codice civile riguardano essenzialmente la separazione, in quanto il divorzio è diventato legale nel
nostro ordinamento solo nel 1970.
Le due normative sono state più volte modificate, in particolare nel 2006.
Le due procedure sono molto simili. Ci sono previsioni assolutamente corrispondenti, fenomeno accentuato
ancor di più nel 2006. Tuttavia, il legislatore ha voluto tenere le due procedure distinte, quindi formalmente
esse sono disciplinate da fonti diverse: la l. 898/1970 in tema di divorzio e il codice civile.
Separazione e divorzio non sono le sole procedure per ottenere lo scioglimento del vincolo coniugale. Dal
2014 vi sono importanti procedure stragiudiziali che consentono di ottenere separazione, divorzio, o la
modifica delle condizioni di questi senza passare attraverso il giudice. Si tratta della negoziazione assistita e
della procedura davanti all’ufficiale dello Stato civile.
Per quanto riguarda la separazione è necessario fare, in prima battuta, riferimento all’art. 150 c.c., che
prevede la separazione personale dei coniugi, la quale può essere giudiziale o consensuale.
In tema di divorzio, invece, non c’è rilevanza della volontà autonoma delle parti, non esiste un divorzio
consensuale, ma solo un procedimento giudiziale su domanda congiunta.
LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE E IL DIVORZIO.
Il diritto di chiedere la separazione giudiziale, il divorzio e l’omologazione della separazione consensuale
spetta ai coniugi.
I presupposti.
Per quanto riguarda la separazione giudiziale i presupposti sono disciplinati dall’art. 151 c.c., per il quale la
separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà delle parti,
fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio
all’educazione o alla prole. Questa dizione è importante perché è sparito dal nostro ordinamento quello che
era l’unico motivo per ottenere la separazione, ossia la colpa di un coniuge in danno dell’altro. Nel momento
attuale la colpa è irrilevante, anche se è possibile ottenere la pronuncia dell’addebito della separazione. In
base al secondo comma dell’articolo, il giudice pronunciando la separazione dichiara, se richiesto, a quale
dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che
derivano dal matrimonio.
La separazione con addebito ha delle conseguenze patrimoniali molto rilevanti. In particolare, in base all’art.
156 primo comma c.c., il coniuge al quale è stata addebitata la responsabilità della separazione è escluso
dalla attribuzione dell’assegno di mantenimento. Vi sono poi conseguenze negative anche in materia
successoria.
Per quanto riguarda il divorzio, questa espressione è usata atecnicamente, in quanto si parla di scioglimento
del matrimonio o di cessazione degli effetti civili.
I presupposti sono disciplinati dall’art. 3 l. 89/1970, lett. b). Il divorzio può essere pronunciato solo quando
la separazione giudiziale è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato o è stata omologata una
separazione consensuale, a condizione che, nel caso della separazione giudiziale siano trascorsi almeno 12
mesi di separazione ininterrotta dei coniugi che decorrono dalla comparizione di essi davanti al tribunale e,
nel caso della separazione consensuale e della negoziazione assistita quando siano trascorsi almeno 6 mesi
dalla comparizione delle parti davanti al presidente del tribunale o dal raggiungimento dell’accordo. Questi
termini sono il frutto della riduzione operata nel 2015.
La domanda.
Si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi. Su questo tema ci sono state
molte variazioni della normativa determinate da una sentenza della Corte costituzionale.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
Consideriamo, in prima battuta, l’art. 706, a norma del quale la domanda di separazione personale si propone
al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi, ovvero, in mancanza, del luogo in cui il
coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio.
Per quanto riguarda il divorzio, anche qui si prevedeva come criterio quello dell’ultima residenza comune,
ma la Corte costituzionale ha abrogato la norma per irrazionalità. Infatti, è ovvio che, dovendo il divorzio
essere preceduto dalla separazione, i coniugi non mantengono una residenza comune. Quindi la norma va
letta ora nel senso di prevedere che il giudice competente sia il giudice del luogo di residenza del coniuge
convenuto. Ricordiamo che il giudice competente in senso gerarchico è il tribunale.
Per quanto riguarda il contenuto della domanda, l’art. 706 richiede che il ricorso contenga l’esposizione
dei fatti sui quali la domanda si fonda.
Un po’ diversa la formulazione relativa alla domanda di divorzio, rispetto alla quale si richiede l’esposizione
dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del vincolo coniugale è fondata.
Sia per la separazione, sia per il divorzio, alla domanda deve essere allegata l’ultima dichiarazione dei
redditi dei coniugi e, soprattutto, l’indicazione dei figli dei coniugi.
Depositato il ricorso, nei cinque giorni successivi il presidente del tribunale fissa la data di comparizione dei
coniugi davanti a sé, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e quello per l’eventuale deposito
ad opera del coniuge convenuto della memoria difensiva.
Il testo delle norme - l’art. 706 per la separazione e l’art. 4 quinto comma l. 89/1970 per il divorzio – è
sostanzialmente identico.
L’udienza.
All’udienza i coniugi devono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore,
ai sensi dell’art. 707). In base all’art. 87, che tratta della difesa tecnica, l’assistenza è diversa dalla vera e
propria rappresentanza in giudizio: la prima significa avere un legale di fiducia con sé ma senza che sia stato
necessario conferirgli una procura alle liti. La prescrizione relativa all’assistenza del difensore dovrebbe
valere, secondo qualcuno, solo per il convenuto, in quanto l’attore attraverso la proposizione del ricorso si è
necessariamente costituito in giudizio, cosa fattibile, secondo le regole generali, solo con il patrocinio di un
difensore.
In ogni caso nella pratica, in genere, le parti compaiono sempre con il difensore di fiducia, quindi la
differenza tra rappresentanza e assistenza diventa quasi irrilevante.
Se il ricorrente non compare in udienza o rinuncia, secondo l’art. 707 secondo comma la domanda non ha
effetto. Qui però bisogna far riferimento alla legge sul divorzio, la quale prevede la stessa cosa, ma, per
quanto riguarda la mancata comparizione, fa salvi i gravi e comprovati motivi. L’opinione prevalente
ritiene che gravi e comprovati motivi possono giustificare l’assenza del ricorrente anche nel caso della
separazione. Addirittura si ritiene che la mancata comparizione per gravi e comprovati motivi del ricorrente
o del convenuto debba essere tenuta dal giudice in considerazione, eventualmente per quanto riguarda il
convenuto mediante una rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto e con la fissazione di una
nuova udienza.
All’udienza il presidente sente le parti prima separatamente e poi congiuntamente, tentando di conciliarle.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
In questa sede, secondo alcuni autori, non si tratta dell’attività svolta dal presidente al fine di riconciliare le
parti, ossia di persuadere le parti a ritornare pacificamente a vivere la vita coniugale. Il termine farebbe
riferimento alla possibilità per i coniugi di raggiungere un accordo sulle condizioni di separazione o di
divorzio in modo da convertire la separazione da giudiziale in consensuale e il divorzio contenzioso in
divorzio su domanda congiunta.
Se la cosa riesce si redige processo verbale, se non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi e i
loro difensori, adotta con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni
nell’interesse della prole e dei coniugi.
Occorre peraltro tenere presente che, prima dell’adozione di questi provvedimenti, la legge sul divorzio
prevede l’ascolto del figlio di almeno dodici anni o anche di età inferiore se capace di discernimento.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
L’ascolto del minore è finalizzato a stabilire quali saranno le modalità di affidamento, se congiunto o
esclusivo.
In questa stessa udienza e con la stessa ordinanza, il presidente del tribunale nomina l’istruttore e fissa
l’udienza di comparazione delle parti per la trattazione della causa.
I provvedimenti nell’interesse del coniuge e della prole. Sono specificamente disciplinati dall’art. 189
disp. att. e sono provvedimenti molto importanti perché hanno un regime particolare. La norma afferma che
queste ordinanze hanno efficacia di titolo esecutivo e sono caratterizzate dalla c.d. ultrattività, nel senso
che rimangono efficaci anche quando il giudizio si estingue e comunque finché non sono sostituite da un
altro provvedimento o del giudice istruttore o del presidente.
In base all’art. 709 e all’art. 4 della l. 89/1970, queste ordinanze, oltre a essere revocabili o modificabili dal
giudice istruttore, sono anche assoggettabili a reclamo da proporsi alla Corte d’appello che provvede in
camera di consiglio. Questi stessi provvedimenti possono essere adottati dal presidente del tribunale anche
nell’ipotesi in cui compaia all’udienza il ricorrente e non il convenuto.
Il riferimento al giudice istruttore e all’udienza necessaria per la trattazione della causa nel merito ci dà la
misura del fatto che, all’esaurimento della fase presidenziale, si passa a una fase contenziosa da trattarsi
secondo le norme del giudizio ordinario di cognizione. Il passaggio dalla fase presidenziale a quella di
trattazione nel merito, tuttavia, non è automatico. Sia per la separazione che per il divorzio si prevede che
con l’ordinanza presidenziale venga assegnato al ricorrente un termine per il deposito di una memoria
integrativa che ha, di fatto, il contenuto di un atto di citazione. Infatti, la memoria deve avere, ai sensi degli
artt. 709 c.p.c. e 4 l. 89/1970, il contenuto di cui all’art. 163 terzo comma nn. 2), 3), 4), 5) e 6). Il giudice
assegna anche al convenuto un termine per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, nonché
per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. Questo ci dà
chiaramente l’indicazione che il passaggio tra le due fasi non è automatico, ma postula il deposito di atti
sostanzialmente corrispondenti all’atto di citazione e alla comparsa di risposta.
A ulteriore conferma di quanto detto, vi è il richiamo agli artt. 180 e 183 contenuto sia nelle norme sulla
separazione (art. 709bis), sia in quelle sul divorzio (art. 4 undicesimo comma).
La sentenza.
Se la causa è matura per la decisione, ma devono essere ancora effettuate attività istruttorie rispetto a
domande cumulate nello stesso processo, il giudice può pronunciare sentenza di separazione o di divorzio.
È ovvio che in una causa di separazione o divorzio possono essere cumulate varie domande oltre a quella
principale: la domanda riguardante l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento, l’assegnazione della
casa coniugale, e così via. Sono domande accessorie sulle quali l’istruzione può essere molto più lunga
rispetto a quella della domanda principale.
Il legislatore consente, sia nel caso del divorzio, sia in quello della separazione, che sia pronunciata una
sentenza non definitiva sulla separazione o sullo scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio. Qui c’è una svista del legislatore, che ha qualificato come non definitiva una vera e propria
sentenza definitiva, cioè che decide in maniera totale e non più sindacabile, salvo impugnazione, la domanda
relativa alla separazione o al divorzio. Probabilmente, l’uso di questo attributo fa riferimento al fatto che il
processo deve continuare per le altre eventuali domande accessorie, ma, con riferimento alla domanda
principale, la sentenza è a tutti gli effetti definitiva.
Le impugnazioni.
Sia per il divorzio, sia per la separazione, il legislatore ammette l’appello deciso in camera di consiglio.
Dottrina e giurisprudenza hanno analizzato molto l’espressione “appello deciso in camera di consiglio”.
Sembra prevalere l’opinione per cui il riferimento alla camera di consiglio significa applicazione delle norme
comuni sui procedimenti camerali, ossia gli artt. 737 e ss.
Dal punto di vista pratico, la conseguenza più rilevante è che l’appello si proporrà non con atto di citazione,
ma con ricorso.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
LA SEPARAZIONE CONSENSUALE E IL DIVORZIO SU DOMANDA CONGIUNTA.
La separazione consensuale.
Per quanto riguarda la separazione consensuale, i riferimenti si trovano agli artt. 150 e 158 c.c.
L’art. 158, in particolare, afferma che la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza
l’omologazione del giudice. L’omologazione è il controllo del tribunale, preliminare alla idoneità
dell’accordo raggiunto dai coniugi sulle condizioni di separazione, che rende esecutivo l’accordo.
Ci si può interrogare su quale tipo di controllo venga svolto durante l’omologazione. La risposta è data dal
secondo comma dell’art. 158, che stabilisce che quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento
e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi, il giudice riconvoca i coniugi indicando
loro le modificazioni da adottare. In caso di inidoneità della soluzione può rifiutare, allo stato,
l’omologazione. In sostanza, quindi il controllo riguarda il mantenimento dei figli.
Il procedimento. Per quanto riguarda il procedimento, questo è dettato dall’art. 711. Anche in questo caso, il
presidente del tribunale deve compiere un tentativo di conciliazione, convocando le parti che presentano
domanda di separazione consensuale nelle forme del ricorso, il quale conterrà tutte le condizioni su cui esse
si sono accordate.
In questo caso, essendo la separazione consensuale, si presume che le parti abbiano raggiunto un accordo su
tutti gli aspetti dell’affidamento dei figli e della risoluzione dei rapporti patrimoniali. Quindi, in questo caso,
forse il legislatore intende far riferimento ad un vero e proprio tentativo di riconciliare i coniugi. Il tentativo
di conciliazione si limita, nella prassi, alla domanda rivolta ai coniugi “Avete intenzione di riconciliarvi?”, la
risposta nel 99% dei casi è no, e il tentativo di conciliazione si esaurisce.
Importante è il penultimo comma dell’art. 711, in base al quale la separazione consensuale acquista efficacia
con l’omologazione del tribunale che provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.
Il divorzio su domanda congiunta.
Per quanto riguarda il divorzio su domanda congiunta, viene in rilievo l’art. 4 l. 89/1970. Il sedicesimo
comma afferma che la domanda congiunta dei coniugi deve contenere compiutamente le condizioni inerenti
alla prole e ai rapporti economici ed è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio.
Qui si richiede quindi che il ricorso contenga una dettagliata e specifica previsione di tutte le condizioni
sulle quali le parti hanno raggiunto un accordo.
Il tribunale in composizione collegiale, sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e
valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli decide con sentenza.
La verifica del tribunale è quindi una verifica doppia: sui presupposti del divorzio – ossia la previa
separazione con sentenza passata in giudicato o separazione consensuale omologata dal tribunale, il tempo
necessario per fare il passo successivo – e sulla rispondenza delle condizioni pattuite all’interesse dei
figli. Se il controllo dà esito positivo, il tribunale pronuncia sentenza.
Se ritiene che le condizioni stabilite dalle parti, soprattutto per ciò che riguarda l’interesse dei figli, siano in
contrasto con l’interesse degli stessi, la procedura si trasforma in una sorta di giudizio ordinario, quindi si
procede alla nomina dell’istruttore e alla fissazione dell’udienza per la trattazione della causa.
Questa, infatti, è una procedura semplificata, che può funzionare solo quando il controllo del tribunale abbia
dato esito positivo.
La sentenza.
Nel caso in cui il controllo del tribunale abbia esito positivo, il legislatore non dice nulla riguardo alla
sentenza. Si è posto, quindi, il problema delle impugnazioni, le quali presuppongono la soccombenza di uno
dei due soggetti. Infatti, legittimato a proporre impugnazione è sempre e solo il soggetto che, rispetto a tutta
la sentenza o a un singolo capo, risulti soccombente. In questo caso non c’è una parte soccombente.
L’opinione prevalente è che questa sentenza nasca già passata in giudicato, quindi sia una sentenza che a
nessun titolo è suscettibile di impugnazioni. Questo ha tutta una serie di conseguenze in quanto, proprio sulla
base della sentenza pronunciata in primo ed unico grado, si può procedere alle annotazioni sui registri dello
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
stato civile e successivamente a contrarre un nuovo matrimonio, senza che occorra necessariamente aspettare
il passaggio del termine utile per la proposizione di eventuali impugnazioni (es. il termine lungo di sei mesi
che consente il passaggio in giudicato della sentenza nel caso in cui non vi sia stata la notificazione e non sia
scattato il termine breve).
LA REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO.
Per quanto riguarda la modificazione dei provvedimenti relativi alla separazione provvede l’art. 710,
mentre l’art. 9 l. 89/1970 provvede per il divorzio.
L’art. 710 afferma che le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di
consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione. Si
tratta dei provvedimenti originariamente contenuti nell’ordinanza del presidente del tribunale o nella
sentenza di separazione o di divorzio.
La modifica deve essere richiesta al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio ai sensi dell’art. 737.
La cosa interessante è che, mentre il codice di procedura non prevede particolari limitazioni rispetto ai motivi
deducibili per giustificare questa richiesta di modifica delle condizioni, la legge sul divorzio parla di
giustificati motivi.
L’ultima norma che andremo ad analizzare, perché interessante anche se poco applicata, è l’art. 709ter, che
prevede la soluzione delle controversie e i provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni. Tale
norma – che si ritiene valga anche per il divorzio – riguarda le controversie insorte tra i genitori in ordine
all’esercizio della responsabilità genitoriale e delle modalità dell’affidamento. Competente è il giudice
davanti al quale pende il giudizio di separazione o divorzio, oppure, se il giudizio si è già concluso, il
tribunale individuato secondo le regole di competenza che si applicano in questa materia. Per i procedimenti
di cui all’art. 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore, fermo restando che il minore
ha la residenza con il genitore affidatario.
Il dato interessante della norma si rinviene nelle sanzioni che il giudice può applicare. È proprio questa
varietà di sanzioni che ha fatto sì che la norma risulti pochissimo applicata. Le sanzioni possono essere:
l’ammonimento del genitore inadempiente, la condanna al risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori
nei confronti del minore, la condanna al risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti
dell’altro, la condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in
favore della Cassa delle ammende. La somma, che potrebbe sembrare simile a quella prevista dall’art. 614
bis, ossia una misura coercitiva finalizzata a indurre all’adempimento il genitore inadempiente, in realtà va a
favore della Cassa delle ammende, quindi si tratta di una vera e propria sanzione amministrativa pecuniaria.
Incomprensibile è poi l’ultimo comma, secondo il quale i provvedimenti assunti dal giudice sono
impugnabili nei modi ordinari. Non è chiaro come questa impugnazione sia possibile, se questi
provvedimenti possano avere una vita autonoma ed essere pronunciati dal giudice con ordinanza o debbano
essere pronunciati dal giudice con la sentenza pronunciata a conclusione del giudizio.
In ogni caso, la norma non ha mai avuto un’applicazione considerevole.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
IL RITO DEL LAVORO
LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO.
Per comprendere correttamente la collocazione sistematica del rito del lavoro è necessario tornare alla
distinzione tra procedimenti a cognizione piena ed esauriente e procedimenti a cognizione sommaria. Il rito
del lavoro è certamente un procedimento a cognizione piena ed esauriente, ma ha un carattere di
specialità. Ciò significa che ha un ambito di applicazione ben preciso, all’interno del quale le norme sul
procedimento ordinario di cognizione (artt. 163 e ss.) non trovano applicazione.
In linea generale questo rito si applica alle controversie individuali di lavoro e, in virtù dell’art. 447bis, alle
controversie in materia di locazione e di comodato di immobili, nonché in quelle di affitto di aziende. Si
applica anche in tutta una serie di altri casi in cui il decreto del 2011 sulla semplificazione dei riti prevede
che un certo procedimento sia ricondotto alle norme proprie del rito del lavoro.
Il c.d. procedimento sommario di cognizione, indipendentemente da questo nome fuorviante, è un
procedimento a cognizione piena. La differenza tra questo e il rito del lavoro è dato dal fatto che il
procedimento sommario di cognizione ha carattere alternativo rispetto al procedimento ordinario di
cognizione. Ricorrendo determinati presupposti e, in particolare, quando si tratti di una causa che rientra
nella competenza del tribunale in composizione monocratica l’attore è libero di scegliere se introdurre la
causa con atto di citazione ai sensi dell’art. 163, oppure con ricorso introduttivo ex art. 702bis. Così non è
per il rito del lavoro, il quale ha un carattere di assoluta esclusività e non prevede nessuna norma
integrativa mutuata dal procedimento ordinario di cognizione.
Il rito del lavoro è stato introdotto dal legislatore con L. 533/1973, rimpiazzando tutta una serie di norme che
risalivano all’epoca del fascismo, quindi all’epoca corporativa. La L. 533/1973 ha avuto una grandissima
importanza e ha un significato storico particolare, in quanto fu proprio negli anni Settanta del secolo scorso
che vennero combattute le grandi battaglie a tutela dei diritti del lavoratore.
Nel 1970 venne introdotto lo Statuto dei diritti del lavoratore, il quale contiene delle norme particolari che
hanno anche un risvolto processuale interessante. Il riferimento è all’art. 28 che prevede un procedimento
volto alla repressione della condotta antisindacale posta in essere dal datore di lavoro e all’art. 18 sul
procedimento di reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo. Successive riforme
hanno, di fatto, smantellato la rilevanza e l’operatività dell’art. 18, ma negli anni Settanta queste due norme
hanno molto impegnato dottrina e giurisprudenza.
Sempre nello stesso arco temporale e in questo clima volto ad assicurare ai lavoratori la tutela dei loro diritti
si colloca la nuova disciplina del rito del lavoro. Per molto tempo il procedimento del lavoro è stato
considerato una specie di faro che avrebbe dovuto guidare il legislatore in una riforma generale del processo
civile, in quanto nel processo del lavoro avevano idealmente trovato attuazione alcuni principi considerati
basilari nella disciplina di un processo civile efficiente: oralità (prevalenza della modalità orale sullo
scritto e dialogo tra le parti e il giudice), immediatezza (immediato e diretto contatto del giudice con le
prove) e concentrazione (assenza delle c.d. udienze di mero rinvio e teorica possibilità di conclusione in
unica udienza, addirittura con lettura del dispositivo).
Inizialmente il processo del lavoro ha funzionato molto bene, poi come spesso succede il fattore umano e
altri fattori logistici hanno diluito la sua effettività. Resta un modello di processo al quale in qualche misura
il legislatore si è ispirato per le varie riforme del processo ordinario di cognizione. Tuttavia, non si può più
dire che il rito del lavoro sia ancora oggi un modello di processo particolarmente funzionante.
L’ambito di applicazione.
L’ambito di applicazione è disciplinato dall’art. 409. La norma fa riferimento alle controversie individuali di
lavoro e le elenca ai vari numeri dell’articolo.
Il n. 1 si occupa delle controversie relative ai rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti
all’esercizio di un’impresa. Elemento significativo di questo tipo di rapporti di lavoro privato è la
subordinazione, che si ha quando il datore di lavoro esercita poteri direttivi, organizzativi e disciplinari
rispetto all’attività svolta dal lavoratore. Non è, peraltro, indispensabile che questo tipo di lavoro subordinato
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
sia collegato all’organizzazione di un’impresa. Il rapporto di lavoro domestico, di conseguenza, rientra in
questa qualificazione.
Il n. 2 si occupa delle controversie relative ai rapporti agrari c.d. associativi, ossia mezzadria, colonia
parziaria e compartecipazione agraria, ai quali si aggiunge l’affitto al coltivatore diretto. Sono ipotesi poco
ricorrenti, ma ciò che è significativo è che questo tipo di controversie rientra nella competenza di una delle
poche sezioni specializzate esistenti nel nostro ordinamento, ossia le sezione specializzate agrarie.
Ricordiamo che la nostra Costituzione vieta l’istituzione di giudici speciali per la trattazione di determinati
tipi di controversie, ma non vieta la creazione di sezioni specializzate, anche con la partecipazione di laici
estranei all’amministrazione della giustizia. In effetti, le sezioni specializzate agrarie operano con tre giudici
professionali e due giudici laici (geometri, agronomi, ecc.). Le sezioni specializzate agrarie operano in primo
grado e in appello. Altri esempi di sezioni specializzate sono le sezioni per i minorenni con competenza
civile e penale, nonché le sezioni specializzate per la tutela della proprietà civile e industriale che oggi
vengono genericamente chiamate come sezioni specializzate per le controversie commerciali.
I rapporti tra sezione ordinaria del tribunale e sezione specializzata sono molto particolari. La Cassazione ha
affermato che in alcuni casi il problema di stabilire se una certa causa appartiene a una sezione specializzata
o a quella ordinaria si configura come una vera e propria questione di competenza rispetto alla quale è
esperibile il regolamento di competenza (artt. 42 e 43). Altre volte, come vedremo riguardo alla c.d. sezione
lavoro all’interno dei tribunali, l’orientamento prevalente è nel senso che non è un vero problema di
competenza quello dei rapporti tra le due sezioni, ma semplicemente un problema della ripartizione del
carico di lavoro all’interno di un ufficio giudiziario. Vedi paragrafo “La giurisdizione e la competenza”
Il n. 3 disciplina i rapporti di parasubordinazione. La norma menziona i “rapporti di agenzia, di
rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera
continuativa e coordinata prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La
collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di
comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”. I requisiti dei
rapporti di parasubordinazione sono il carattere continuativo della prestazione, il suo carattere coordinato e la
prevalente personalità della prestazione offerta dal lavoratore. È necessario che le modalità di svolgimento
della prestazione siano stabilite di comune accordo tra le parti, quindi si tratta di un’attività svolta
autonomamente dal soggetto, in assenza di un rapporto di subordinazione gerarchica rispetto al datore di
lavoro. Per quanto riguarda il carattere continuativo deve trattarsi di una prestazione non episodica, non
occasionale, ma protratta nel tempo. La prevalente personalità riguarda, invece, il fatto che l’attività svolta
dal lavoratore deve qualitativamente essere l’elemento principale o predominante.
Possiamo fare l’esempio che fa il professor Luiso nel manuale perché è illuminante. Una società instaura un
rapporto con un commercialista per la tenuta della contabilità. Si tratta di un rapporto di parasubordinazione
perché il commercialista continua a lavorare come libero professionista ed è irrilevante che si avvalga di
segretarie per lo svolgimento di questa funzione. Ciò che conta è il suo personale contributo allo svolgimento
della prestazione.
Per quanto riguarda gli esempi menzionati dal codice, ossia i rapporti di agenzia e rappresentanza, dobbiamo
semplicemente ricordare che il rapporto di agenzia, oggetto di un contratto ai sensi dell’art. 1746, è quello
con il quale l’agente si impegna a promuovere dietro corrispettivo la conclusione di contratti in una
determinata zona per conto dell’azienda proponente. Per quanto riguarda la differenza tra agente e
rappresentante è che il primo è incaricato della promozione e della stipulazione di contratti per conto
dell’impresa, mentre il secondo è colui che ha lo specifico incarico di stipulare i contratti per conto
dell’azienda proponente.
I nn. 4 e 5 sono relativi, rispettivamente, ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici c.d.
economici e di altri enti pubblici. Sono rapporti che non hanno più particolare significato perché dal 1998 il
rapporto di impiego con le PA in generale è stato quasi completamente privatizzato, ossia assoggettato alle
norme di diritto privato, salvo per un numero limitato di categorie. Per queste limitate categorie (militari,
magistrati e docenti universitari) rimane la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che era quella
che in origine riguardava tutti i rapporti di pubblico impiego. Ricordiamo che, mentre in linea di principio la
giurisdizione del giudice amministrativo si limita a valutare la legittimità degli atti amministrativi,
nell’ambito della c.d. giurisdizione esclusiva la cognizione si estende anche ai diritti soggettivi della parte,
escludendo appunto la giurisdizione del giudice ordinario.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
Proprio con riferimento ai rapporti di pubblico impiego possiamo ricordare il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165,
recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’amministrazioni pubbliche e
successive modificazioni, nello specifico l’art. 63. L’articolo stabilisce la devoluzione al giudice ordinario in
funzione di giudice del lavoro di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle PA,
con l’eccezione dei casi che abbiamo menzionato. Interessante è la parte finale del primo comma, ove si dice
che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario “ancorché vengano in questione atti amministrativi
presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.
L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non
è causa di sospensione del processo”. La norma è importante perché nella cognizione di una controversia di
lavoro relativa a un pubblico dipendente è abbastanza normale che venga in considerazione un atto
amministrativo presupposto. Possiamo pensare all’esito del concorso in virtù del quale il pubblico
dipendente è stato assunto. Nel caso in cui il giudice ordinario ritenga che questo atto amministrativo sia
illegittimo non può, ovviamente, annullarlo. Tuttavia, egli può disapplicarlo, decidendo della controversia
come se quell’atto non esistesse. Vengono segnati così i confini dei poteri della giurisdizione ordinaria nei
confronti della pubblica amministrazione.
Molto importante è anche il secondo comma della norma: “Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei
diritti tutelati”. Generazioni su generazioni di studenti avevano imparato che il giudice ordinario non poteva
condannare la PA, né emanare provvedimenti costitutivi nei suoi confronti. Questo insegnamento è ormai
vanificato dal secondo comma dell’art. 63.
La giurisdizione e la competenza.
Con riferimento alla giurisdizione va rilevato che non esistono norme particolari. Va però segnalata una
disposizione contenuta nel regolamento n. 1215/2012 – il c.d. regolamento Bruxelles Ibis – relativo a
competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
L’art. 23 del regolamento stabilisce che: “Le disposizioni della presente sezione [Competenze in materia di
contratti individuali di lavoro] possono essere derogate solo da un accordo: 1) posteriore al sorgere della
controversia; o 2) che consenta al lavoratore di adire un’autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate
nella presente sezione”.
Per quanto riguarda la competenza, il riferimento è all’art. 413. La norma dice chiaramente che le
controversie individuali di lavoro sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice
del lavoro. Il discorso sulle sezioni specializzate agrarie va qui modificato con riferimento alle sezioni
lavoro. Quasi tutti i tribunali di una certa dimensione hanno una sezione ordinaria e almeno una sezione
lavoro. La sezione lavoro non è una sezione specializzata, ma un modo di ripartizione del lavoro all’interno
di un ufficio giudiziario. Quindi nei rapporti tra sezione ordinaria e sezione lavoro non sorgono problemi di
competenza in senso proprio. Questo per quanto riguarda la competenza verticale.
L’art. 413 fissa al terzo comma anche tre criteri per determinare la competenza orizzontale o per territorio,
individuando tre fori concorrenti: il luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro, il luogo in cui si trova
l’azienda (facendo riferimento alla sede effettiva in cui si concentrano la direzione e l’amministrazione
dell’azienda, sede che può anche non coincidere con la sede legale), nonché il luogo in cui si trova una
dipendenza dell’azienda presso la quale il lavoratore è addetto o prestava la sua opera al momento della
cessazione del rapporto.
Più di recente per le controversie relative ai rapporti di lavoro parasubordinato è stato individuato un foro
diverso, che non è concorrente con gli altri tre, ma è esclusivo. Il quarto comma stabilisce che “Competente
per territorio per le controversie previste dal n. 3 dell’art. 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il
domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio, ovvero del titolare degli altri rapporti di
collaborazione di cui al predetto n. 3 dell’art. 409”.
Per il pubblico impiego (quinto comma) è competente il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al
quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto. Ciò significa che non
trova applicazione il c.d. foro erariale previsto dall’art. 25, che prevede – per le cause nelle quali è parte
un’amministrazione dello Stato – la competenza del giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura
dello Stato, nel cui distretto su trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
L’art. 413 prevede, infine, una norma di chiusura: “Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei
commi precedenti, si applicano quelle dell’art. 18”. Il riferimento è, in realtà anche all’art. 19. Queste norme
disciplinano il foro generale delle persone fisiche e il foro generale delle persone giuridiche.
La norma conclude stabilendo la nullità assoluta delle clausole derogative della competenza per territorio.
Alcuni manuali sottolineano il possibile contrasto con l’art. 23 del regolamento Bruxelles Ibis riguardante,
come abbiamo detto, accordi di deroga della competenza in materia contrattuale, purché successivi al sorgere
della controversia. In realtà la norma del nostro codice non fa distinzione. Il riferimento è, a giudizio di
Silvestri, alle clausole derogative della competenza ex ante, ossia quelle clausole inserite in un contratto di
lavoro.
Il mutamento del rito.
Il rito del lavoro è un rito a cognizione piena ed esauriente, ma comunque speciale e deve essere utilizzato
quando venga in considerazione una controversia in una materia enunciata dall’art. 409. Dobbiamo quindi
chiederci cosa succede se una controversia che rientra in tale ambito sia iniziata per errore con le forme del
giudizio ordinario di cognizione o ricorra l’ipotesi inversa.
Si tratta di stabilire se il legislatore considera la scelta corretta del rito come una condizione di procedibilità
della domanda o meno, ossia come una condizione che, se soddisfatta, consente al giudice di arrivare ad una
decisione sul merito della controversia, intendendo per merito la fondatezza o infondatezza della domanda
proposta.
Se il legislatore avesse configurato la scelta del rito come condizione di procedibilità della domanda, nel caso
in cui il giudice si accorgesse, ex officio o su eccezione di parte, che il rito non è corretto avrebbe una sola
possibilità: dichiarare questo errore con una sentenza ex art. 279, ossia con una pronuncia su questioni di rito
a carattere impediente.
In realtà, se noi consideriamo gli artt. 426 e 427 capiamo che le cose non stanno così. L’errore nella scelta
del rito non è condizione di improcedibilità della domanda, essendo possibile il mutamento del rito.
Sorge spontanea una domanda. Sulla base di quali elementi si valuta se si è in presenza di una controversia
individuale di lavoro ex art. 409? Il giudice compie questa valutazione sulla base della domanda, quindi sulla
base delle allegazioni e della situazione sostanziale indicata nella domanda stessa. Se la verifica dà esito
negativo, il giudice non si limita a dire che il rito non è quello giusto chiudendo il processo con sentenza, ma
dispone il mutamento del rito.
Se invece la verifica dà esito positivo il processo va avanti, si procede con l’istruttoria sul merito e alla fine si
vedrà se il diritto vantato dall’attore sussiste o meno. Se sussiste il giudice verificherà in quella sede se è
effettivamente riconducibile a quel rapporto di lavoro che l’attore aveva dedotto proponendo la domanda con
rito del lavoro. Se il giudice accerta, invece, che il diritto esiste, ma non è riconducibile a un rapporto di
lavoro rigetterà la domanda nel merito. È quindi una verifica che viene compiuta in prima battuta sulla
domanda, ma che può essere ripetuta nel corso del processo.
Con riferimento a quelli che vengono chiamati passaggi di rito, si pone un problema. Bisogna vedere se c’è
solo un mutamento di rito legato al fatto di aver iniziato la causa con il rito sbagliato, o se c’è una vera e
propria questione di competenza in senso proprio, ad esempio un problema di competenza per valore.
Facciamo un esempio. Consideriamo una causa di valore inferiore a €5.000. Se la causa riguarda una
controversia individuale di lavoro ex art. 409 è comunque competente il tribunale. Se invece si tratta di una
causa ordinaria, per valore è competente il giudice di pace. Occorre, quindi, stare molto attenti nel capire se
quando si parla di difetto di competenza si fa riferimento al rito utilizzato o alla competenza in senso proprio.
Per il rilievo della competenza dobbiamo, innanzitutto, fare riferimento all’art. 428, che però qui fa
riferimento ad un’incompetenza territoriale. In questo caso il problema del passaggio di rito non si pone, in
quanto si tratta di una causa di lavoro proposta ad un giudice incompetente per territorio. La norma –
rubricata “Incompetenza del giudice” – afferma: “1. Quando una causa relativa ai rapporti di cui all’art.
409 sia stata proposta a un giudice incompetente, l’incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto
nella memoria difensiva di cui all’art. 416 ovvero rilevata d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di cui
all’art. 420. – 2. Quando l’incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il
giudice rimette la causa al tribunale in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non
superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale”. Questa è una mera ipotesi di proposizione
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
della domanda nelle forme corrette, ma dinanzi ad un giudice territorialmente incompetente e comporta
semplicemente una rimessione della causa verso il giudice effettivamente competente.
I veri passaggi di rito, cioè il passaggio dal rito ordinario al rito speciale e viceversa, sono regolati dagli artt.
426 e 427.
Nell’art. 426 – “Passaggio dal rito ordinario al rito speciale” – è previsto che il giudice fissi con ordinanza
l’udienza di cui all’art. 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all’eventuale
integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memoria e documenti in cancelleria. Questa norma
aveva un senso prima delle ultime riforme del processo civile, quando sussisteva ancora una grande
differenza per ciò che riguarda il regime delle preclusioni, molto rigoroso nel processo del lavoro rispetto al
giudizio ordinario. Questa fissazione del termine oggi non ha un gran senso. La cosa importante da ricordare
è che se si sono già verificate nel processo ordinario delle preclusioni rispetto allo svolgimento di
determinate attività, queste stesse attività non potranno essere poi compiute nel rito del lavoro nonostante
il passaggio di rito.
Secondo l’art. 427 – “Passaggio dal rito speciale al rito ordinario” – il giudice, quando rileva che una
causa promossa nelle forme del rito del lavoro non rientra tra le materie previste dall’art. 409, si trova di
fronte a due possibili ipotesi. Se la competenza per valore e per territorio è comunque del tribunale non c’è
nessun particolare problema, dovendo il giudice limitarsi a verificare che gli atti siano messi in regola con le
disposizioni tributarie (gli atti del processo del lavoro hanno un trattamento privilegiato che non coincide con
quello del processo ordinario). Se invece la competenza è di un altro giudice il giudice deve optare per una
rimessione con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta
giorni per la riassunzione con il rito ordinario. Quindi, nell’ipotesi precedente della causa di valore inferiore
a €5.000 promossa dinanzi al tribunale come causa di lavoro, ma in realtà legata ad un rapporto sostanziale
di tipo diverso, il giudice rimetterà le parti con ordinanza dinanzi al giudice di pace, fissando il termine per la
riassunzione con rito ordinario.
L’ultimo comma della norma afferma che in questo caso le prove acquisite durante il rito speciale
avranno l’efficacia consentita dalle norme ordinarie. Questa specificazione è necessaria in quanto la
materia probatoria nell’ambito del rito del lavoro prevede la possibilità di assumere prove anche al di là dei
limiti previsti per il rito ordinario. In particolare, il giudice dispone di ampi poteri di iniziativa istruttoria
esercitabili ex officio, cosa che non succede nel processo di cognizione ordinario. Per quanto riguarda le
prove di cui il giudice ha disposto ex officio l’assunzione, queste conservano comunque validità anche dopo
il passaggio di rito.
In ogni caso, i passaggi di rito sono disposti con ordinanza. Non avendo le ordinanze carattere decisorio
sono sempre modificabili o revocabili dal giudice sia d’ufficio, sia su istanza di parte. La questione della
correttezza del rito intrapreso può essere riconsiderata o riproposta di fatto fino alla pronuncia della sentenza.
L’instaurazione del processo. Gli atti introduttivi.
Gli atti introduttivi non si differenziano molto, quanto a contenuto, dagli atti introduttivi del processo
ordinario di cognizione, se non per il fatto che il rito del lavoro è un processo da ricorso.
Il ricorso introduttivo contiene l’editio actionis nei suoi vari elementi.
L’art. 414 afferma espressamente che: “La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
1) L’indicazione del giudice;
2) Il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha
sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se
ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, il
ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;
3) La determinazione dell’oggetto della domanda;
4) L’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative
conclusioni;
5) L’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei
documenti che si offrono in comunicazione”.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
Ai sensi dell’art. 415 il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti
in esso indicati. Il giudice fissa con decreto entro cinque giorni dal deposito la prima udienza di
discussione, nella quale le parti devono comparire personalmente. Il tutto è poi notificato al convenuto. Ciò
significa che la vocatio in ius è opera dell’ufficio, a differenza del giudizio ordinario che vede la vocatio
come parte integrante dell’atto di citazione.
Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione ex art. 420 non devono decorrere più di
sessanta giorni.
Per quanto riguarda la costituzione del convenuto, questa si compie depositando una memoria difensiva nei
termini di cui all’art. 416, quindi almeno dieci giorni prima dell’udienza. Nella memoria difensiva devono
essere proposte a pena di decadenza le eventuali domande riconvenzionali, nonché le eccezioni processuali
e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. Inoltre, sempre in questa memoria il convenuto deve prendere
posizione in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione circa i fatti affermati dall’attore a
fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, sempre
a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve
contestualmente depositare.
La costituzione e la difesa personale delle parti.
Secondo l’art. 417, in primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa
non eccede €129,11. È una norma assolutamente ridicola perché nessuna causa di lavoro ha un valore non
eccedente tale somma.
L’udienza di discussione della causa.
Disciplinata dall’art. 420, essa è il fulcro del processo del lavoro. Nell’idea del legislatore questa doveva
essere l’unica udienza del procedimento. Ovviamente la cosa in concreto non accade, in quanto se c’è
necessità di attività istruttoria è improbabile che questa venga svolta nell’udienza di cui stiamo parlando.
La ratio dell’idea dell’udienza unica si rifà ai principi che caratterizzano questo tipo di procedimento, ossia
oralità, immediatezza e concentrazione.
Il principio di oralità si riferisce a uno scambio dialettico tra le parti e i loro difensori ed il giudice.
Il principio di immediatezza comporta un rapporto privo di intermediazioni tra l’assunzione della prova e la
decisione finale. Ciò significa che il giudice dinanzi al quale le prove sono assunte deve essere anche il
giudice che prende la decisione. Il suo convincimento, infatti, si forma proprio sulla base delle prove alla cui
assunzione ha assistito.
Il principio di concentrazione, infine, postula che non vi siano interruzioni temporali tra l’assunzione delle
prove, la discussione finale e la deliberazione della sentenza. Questo ha lo scopo di garantire che la memoria
del giudicante che ha assistito all’assunzione delle prove non si volatilizzi con il passare del tempo.
Precisati i principi ispiratori al processo del lavoro torniamo all’udienza di discussione della causa.
Il primo comma indica gli adempimenti che deve compiere il giudice: l’interrogatorio libero delle parti e il
tentativo di conciliazione.
In anni più recenti alla norma è stata aggiunta una parte che impone al giudice di formulare una proposta
transattiva o conciliativa. Molti manuali mettono in evidenza l’assurdità di una previsione di questo tipo, in
quanto è improbabile che il giudice, sulla base dei soli atti introduttivi del giudizio riesca a formulare
ragionevolmente una proposta di tale genere. Ancora più assurda appare la previsione delle conseguenze,
non tanto della mancata comparizione personale delle parti, che vede dei precedenti già nel processo
ordinario, ma del rifiuto della proposta. La norma prevede, infatti, che se il rifiuto non è adeguatamente
giustificato il giudice può desumerne argomenti di prova (“comportamento valutabile dal giudice ai fini del
giudizio” ai sensi dell’art. 116). È assurdo prevedere una sanzione per un rifiuto in assenza di giustificati
motivi: in questa fase i giustificati motivi sono praticamente impossibili da configurare e non si capisce su
quali basi possano essere valutati dal giudice.
Il secondo comma afferma che “Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o
speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita per atto
pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è
valutata dal giudice ai fini della decisione”.
Su questa previsione ci sarebbe moltissimo da dire. È una previsione che, in linea di principio, tende a
vanificare il significato dell’interrogatorio libero della parte presente personalmente al processo. La
funzione dell’interrogatorio libero (o di chiarificazione) è quella di consentire al giudice di conoscere i fatti
della causa dalla viva voce della parte interessata. Questo si verifica più raramente se la parte può essere
sostituita da un rappresentante sostanziale.
Il medesimo problema si pone, ad esempio, nella mediazione, dove la più recente giurisprudenza della
Cassazione sostiene che la parte può essere sostituita dal soggetto che abbia una procura sostanziale, intesa
come una procura notarile conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nella mediazione, come
anche in questa ipotesi (ma anche nel processo ordinario) la giurisprudenza e parte della dottrina sostengono
che la parte può essere rappresentata dal suo stesso difensore, a condizione che il difensore abbia oltre alla
procura alle liti una procura sostanziale che gli consenta di transigere o conciliare la controversia.
Ovviamente, il difensore interpellato nell’interrogatorio libero non darà le stesse risposte che darebbe la parte
direttamente coinvolta nella controversia. È un problema molto discusso, sul quale esistono opinioni diverse.
Dobbiamo analizzare la struttura di questi primi atti e confrontarli con quelli del giudizio ordinario di
cognizione. L’art. 185 stabilisce che l’interrogatorio libero delle parti e il tentativo di conciliazione ha luogo
solo su richiesta congiunta delle parti. Anche qui le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un
procuratore generale o speciale, quindi il problema si pone negli stessi termini. L’art. 185bis prevede,
inoltre, la facoltà del giudice di formulare una proposta transattiva o conciliativa, indipendentemente da
qualunque istanza di parte. Le norme, esattamente come quelle del processo del lavoro, mirano ad
incentivare la possibilità delle parti di raggiungere un accordo, alleggerendo così il carico giudiziario. In
realtà, raramente si verifica la conciliazione perché, come è noto, i giudici di norma sono dei pessimi
conciliatori.
Se la conciliazione riesce si forma processo verbale e il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo
esecutivo (terzo comma). Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione,
ai sensi del quarto comma invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo.
Lo stesso accade nel caso in cui sorgano questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che il giudice
ritiene rilevanti: in tal caso il giudice decide anche con sentenza non definitiva. La norma chiarisce quali
sono queste questioni, parlando di questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre
pregiudiziali (condizioni dell’azione, ecc.) la cui decisione può definire il giudizio. In questo caso la
questione può essere decisa dal giudice nel senso di consentire la prosecuzione del rito (e quindi l’esame del
merito), con una sentenza che per questo motivo sarà non definitiva.
Tornando alla parte finale del primo comma dell’art. 420, se non ricorrono tutte queste ipotesi di pronuncia
nel merito o su questioni preliminari o pregiudiziali e quindi se l’udienza è destinata a proseguire con la
trattazione, “Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già
formulate, previa autorizzazione del giudice”. Il processo del lavoro è dominato dal c.d. principio di
preclusione, nel senso che vi sono determinate attività che vanno esaurite negli atti introduttivi o, per gravi
motivi e previa autorizzazione del giudice, in questa stessa udienza.
Se non ricorre nessuna delle ipotesi analizzate finora – non c’è conciliazione, la causa non è matura per la
decisione, non ci sono questioni preliminari o pregiudiziali a carattere impediente – il giudice ammette i
mezzi di prova proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che
siano rilevanti, disponendo con ordinanza per la loro assunzione (quinto comma). Il riferimento è alle prove
dedotte dalle parti negli atti introduttivi e ad eventuali prove che esse non avevano potuto dedurre per cause a
loro non imputabili. Il giudice provvede alla valutazione di ammissibilità e rilevanza della prova,
disponendone l’immediata assunzione. Qualora ciò non sia possibile, ove ricorrano giusti motivi, il giudice
fissa una nuova udienza concedendo alle parti il deposito in cancelleria di note difensive. Nel caso in cui
addirittura vengano ammessi nuovi mezzi di prova, viene sempre fissata una nuova udienza, ma viene
autorizzata la controparte a dedurre controprove. L’udienza successiva deve essere molto ravvicinata. Lo
stesso art. 420 prevede che essa debba tenersi non oltre dieci giorni dalla prima udienza. Nella prassi questo
non avviene mai.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
Interessante è l’ultimo comma dell’art. 420, il quale prevede che le udienze di mero rinvio sono vietate.
Anche questa è una di quelle norme che sono rispettate molto raramente.
I poteri istruttori del giudice.
Di norma il giudice, salvo limitate eccezioni, non può disporre d’ufficio l’assunzione di prove. Nel processo
del lavoro, invece, il giudice ha poteri istruttori molto ampi.
In realtà, il primo comma dell’art. 421 non riguarda i poteri istruttori del giudice, ma fa riferimento al
generico potere di qualunque giudice di segnalare le irregolarità degli atti e dei documenti e di promuoverne
la sanatoria, sempre che si tratti di vizi formali che non determinino la nullità dell’atto. Per questo tipo di vizi
il giudice assegna anche un termine per provvedervi.
Il secondo comma parla proprio dei poteri istruttori del giudice, dicendo che il giudice “può altresì disporre
in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile,
ad eccezione del giuramento decisorio, nonché della richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che
orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti”. Questi poteri istruttori sono stati oggetto di moltissimi
studi perché rappresentano un’eccezione rispetto alla regola secondo cui il giudice può formare il suo
convincimento solo ed esclusivamente sulle prove dedotte dalle parti.
In realtà, non siamo in presenza di poteri assolutamente arbitrari e incondizionati. Il giudice incontra dei
limiti nel disporre l’assunzione dei mezzi di prova che ritiene più opportuni per pervenire a una decisione nel
merito. Innanzitutto, secondo il principio per cui il giudice deve giudicare iuxta, alligata et probata partium,
i poteri istruttori del giudice possono essere esercitati solo in relazione ai fatti specificamente allegati dalle
parti. Ulteriormente, questi poteri istruttori sono esercitabili solo quando la fonte di prova emerge
direttamente dagli atti di parte. Infine, elemento più importante di tutti, l’esercizio di questi poteri ha un
carattere supplementare, integrativo e mai sostitutivo della necessaria attività delle parti. Ciò significa che
il giudice non potrà mai utilizzare questi poteri istruttori per sollevare una delle parti dall’onere della prova
che incombe su quella stessa parte. Di conseguenza, possiamo dire che questi poteri possono essere utilizzati
solo se una volta assunte le prove proposte dalle parti risultano ancora profili di incertezza.
Luiso richiama una norma che vale per il processo penale, ma chiarisce abbastanza bene i termini del
problema. Si tratta dell’art. 507 c.p.p., dove si dice che “Terminata l’acquisizione delle prove, il giudice, se
risulta assolutamente necessario, può disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di nuovi mezzi di prova”.
Possiamo, quindi, dire che anche nel processo civile, assunte le prove dedotte dalle parti, il giudice, se
risultano ancora degli elementi di incertezza, può esercitare questi suoi poteri di iniziativa istruttoria
ufficiosa. Ma questo solo dopo che ciascuna parte ha provveduto a fare assumere le prove indicate e senza
che l’uso dei poteri istruttori del giudice risulti essere stato utilizzato per esonerare una parte o l’altra
dall’onere probatorio che incombeva su di lei.
Dato interessante è la possibilità che questi poteri siano esercitabili anche fuori dei limiti stabiliti dal codice
civile, ad eccezione del giuramento decisorio. Anche se la norma non lo dice, si ritiene che questi limiti siano
di fatto i limiti posti dal codice civile all’utilizzazione della prova testimoniale. Ricordiamo che nel nostro
ordinamento la prova ritenuta più solida è quella documentale, quindi l’utilizzazione della prova testimoniale
incontra tutta una serie di limiti molto particolari. Ad esempio, in relazione ai contratti e alle rimessioni di
debito, l’art. 2721 pone un limite di valore molto basso che è ormai convenzionalmente superato anche nel
processo ordinario di cognizione. Altri limiti superabili dal giudice del lavoro riguardano la disciplina dei
patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento con disposizioni diverse a seconda che questi patti
siano anteriori o contemporanei, oppure successivi alla redazione del documento. Però si ritiene che i poteri
istruttori del giudice siano tali da consentire che nell’ambito della simulazione la prova per testi possa essere
fornita anche dalle parti e non solo dai terzi. Cadrebbe anche il limite di cui all’art. 2729 secondo comma,
che esclude l’utilizzabilità delle presunzioni semplici nei casi in cui è esclusa la prova per testi. Infine, con
riferimento alla prova documentale richiesta ad probationem o ad substantiam, si ritiene che la prova
testimoniale possa essere ugualmente disposta dal giudice del lavoro, ma solo quando la prova scritta sia
richiesta ad probationem, riguardando la prova scritta ad substantiam la stessa validità del documento e
quindi si tratta di un limite che neanche il giudice può superare.
Un’altra peculiarità dei poteri istruttori del giudice è prevista dall’ultimo comma dell’art. 421, secondo il
quale “il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione anche di quelle persone che siano
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
incapaci di testimoniare a norma dell’art. 246 o a cui sia vietato a norma dell’art. 247”. Si tratta dei limiti
soggettivi all’utilizzo della prova testimoniale.
Vi sono anche due prove peculiari nel rito del lavoro, ossia la richiesta di informazioni e osservazioni alle
associazioni sindacali (art. 425) e l’accesso sul luogo di lavoro (art. 421, penultimo comma). Ambedue
possono essere disposte solo su istanza di parte.
Con riferimento all’accesso sul luogo di lavoro c’è una differenza rispetto alla prova equivalente nel
processo ordinario – l’ispezione – che è una delle pochissime prove che il giudice può ordinare d’ufficio.
Le ordinanze interinali.
Nel processo ordinario di cognizione sono disciplinate dagli artt. 186bis e 186ter. Cronologicamente nascono
prima le ordinanze interinali del processo del lavoro, in quanto quelle del processo ordinario sono state
introdotte dalla riforma del 1990.
L’ordinanza per il pagamento delle somme non contestate. Ai sensi del primo comma dell’art. 423, il
giudice “su istanza di parte, in ogni stato e grado del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle
somme non contestate”. Il richiamo è all’art. 186bis. L’ordinanza può essere richiesta sia dall’attore che dal
convenuto, come dimostra la formula “su istanza di parte”. L’oggetto del provvedimento è chiaramente il
pagamento di una somma, in merito alla quale non vi sia stata contestazione. In merito all’elemento della
non contestazione sono stati versati fiumi di inchiostro. Alcuni hanno addirittura ritenuto che la non
contestazione riguardi i fatti costitutivi del diritto in virtù del quale si chiede il pagamento della somma, col
risultato che questa ordinanza potrebbe essere concessa solo quando vi è un riconoscimento anche implicito
dei fatti che fondano il diritto al pagamento della somma.
Secondo Luiso, la cui tesi sembra particolarmente attendibile, la non contestazione è qualcosa di molto più
semplice e riguarda sostanzialmente l’entità della somma richiesta. Facciamo un esempio. Tizio chiede a
Caio in giudizio il pagamento di 100. Di questi 100, 20 sarebbero dovuti per straordinari, 30 per ferie non
godute. Caio non contesta globalmente la somma, ma solo i 30 riguardanti le ferie. In questa ipotesi, Tizio
può chiedere al giudice un’ordinanza per il pagamento dei 70 non contestati.
Si tratta comunque di un tipo di provvedimento che non ha mai avuto molto successo.
È importante ricordare che questo provvedimento non può essere mai pronunciato in favore della parte
rimasta contumace. Il riferimento, in questo caso, non è all’art. 423, bensì all’art. 186bis, il quale afferma
che l’ordinanza può essere concessa solo a favore delle parti costituite. Ricordiamo che la contumacia è il
fenomeno che si verifica quando le parti non si costituiscono in giudizio, quindi non equivale a non
contestazione. Per questo la parte rimasta contumace non può chiedere questo tipo di provvedimento.
Naturalmente, questa ordinanza è un provvedimento provvisorio. La sentenza finale sul merito potrà
assorbire l’ordinanza confermandone il contenuto, oppure negare l’esistenza del diritto del beneficiario di
questa ordinanza e disporre la restituzione di quanto pagato in applicazione dell’ordinanza stessa.
L’ordinanza per il pagamento di una somma a titolo provvisionale. Prevista dal secondo comma dell’art.
423, riguarda la possibilità del giudice di “disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo
provvisorio, quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la
prova”. Anche in questo caso è necessaria l’istanza di parte.
Questo tipo di provvedimento può essere emesso solo ed esclusivamente a favore del lavoratore. È
abbastanza evidente che si tratti di un accertamento sommario sull’esistenza del diritto e del credito.
Possiamo anche notare la somiglianza con la condanna generica ex art. 278. La norma prevede che “Quando
è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il
collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla
prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione. In tal caso il collegio,
con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una
provvisionale nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova”.
L’art. 423 afferma al terzo comma che le due ordinanze costituiscono titolo esecutivo, ma aggiunge al
comma successivo che l’ordinanza per il pagamento di una somma a titolo provvisionale è revocabile con
sentenza che decide la causa. Il che è abbastanza ovvio, nel senso che il giudice nel momento in cui
pronuncia la sentenza sul merito dovrà rivalutare la questione, quindi vedere se effettivamente sussiste il
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
credito del lavoratore ed è adeguatamente provato, posto che il primo accertamento è un accertamento
sommario.
L’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi.
L’art. 420bis fa da pendant all’art. 64 del d.lgs. 165/2001 e prevede una particolare forma di accertamento
pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi. L’art. 420 bis
riguarda i contratti collettivi c.d. di diritto comune, cioè quelli che riguardano i rapporti di lavoro privato,
mentre l’art. 64 riguarda i rapporti di pubblico impiego.
Il meccanismo è interessante, in quanto richiama la questione pregiudiziale sottoposta al vaglio della Corte di
Giustizia dell’Unione europea che, proprio perché è un accertamento pregiudiziale, precede e condiziona la
decisione sul merito della controversia.
La norma stabilisce che: “Quando per la definizione di una controversia di cui all’art. 409 è necessario
risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle
clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione,
impartendo distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa
fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni”. Questa sentenza interpretativa è
impugnabile solo ed esclusivamente con ricorso immediato per cassazione, da proporsi entro sessanta giorni
dalla comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza stessa. In questo caso, il giudizio a quo viene
sospeso in attesa della decisione della Cassazione.
Se la sentenza pronunciata dal giudice a quo non viene impugnata passa in giudicato e l’interpretazione data
al contratto collettivo dal giudice della causa diventa vincolante. La vincolatività permane anche nel caso in
cui la decisione sul merito della causa venga impugnata con appello e con ricorso per cassazione. Altrettanto
vincolante è la sentenza della Cassazione nel caso di impugnazione della sentenza interpretativa del giudice a
quo. Quest’ultima resta vincolante anche se il procedimento si estingue e nel caso in cui la medesima
domanda venga riproposta tra le stesse parti.
Se una causa avente il medesimo oggetto viene proposta tra altre parti non si produce questo vincolo, ma il
meccanismo è lo stesso.
La fase decisoria nel rito del lavoro.
L’art. 429, rubricato “Pronuncia della sentenza”, presenta due distinte ipotesi.
La prima ipotesi è quella di una sostanzialmente semplice. In questo caso il giudice, esaurita la discussione
orale e ascoltate le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura sia
del dispositivo, sia dei motivi in fatto e in diritto a sostegno del dispositivo. La norma richiama l’art.
281sexies (“Decisione a seguito di trattazione orale”). Si tratta di una modalità semplificata.
La seconda ipotesi disciplina le cause più complesse e prevede che, esaurita la discussione e ascoltate le
conclusioni delle parti, il giudice si limiti a leggere il dispositivo della sentenza, fissando nello stesso
dispositivo un termine non superiore a sessanta giorni un termine per l’integrazione del dispositivo con la
motivazione. C’è da dire che l’ipotesi cui fa riferimento questa norma, richiamando con riguardo alla
discussione l’art. 420 – il quale parla di “causa matura per la decisione” e quindi della successiva discussione
orale – prevede la possibilità per il giudice, se lo ritiene necessario e su richiesta delle parti, di concedere alle
stesse parti un termine per il deposito di note difensive, rinviando la causa all’udienza immediatamente
successiva alla scadenza di tale termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. In realtà la
discussione della causa anche nel processo del lavoro avviene raramente: nella quasi totalità dei casi essa è
sostituita dallo scambio di note, previsto dallo stesso art. 429.
È importante fare alcune considerazioni sulla possibile scissione del dispositivo dalla motivazione. La
sentenza è tale nel suo complesso, ossia solo quando al dispositivo viene, nel termine indicato dalla norma (e
allegramente superato nella prassi), allegata la motivazione e vengono insieme depositati. La motivazione è
un elemento indispensabile della sentenza e di qualunque organo giurisdizionale e non. Dal punto di vista
processuale è fondamentale perché è da questa che la parte soccombente individua i possibili motivi di
impugnazione.
Tuttavia, qui ci troviamo in una situazione un po’ particolare, caratterizzata appunto dalla scissione del
dispositivo dalla motivazione. È importante sottolineare che, quando ciò si verifica, il dispositivo una volta
pronunciato non può essere modificato, corretto o integrato dal giudice. Con la pronuncia, infatti, il
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
giudice esaurisce la sua funzione. L’eventuale contrasto tra dispositivo e motivazione si risolve a favore del
primo.
Se il giudice omette di depositare la motivazione, si è in presenza di una sentenza che si può definire
realmente inesistente. Secondo la dottrina, in questo caso occorre ripercorrere integralmente la fase decisoria,
quindi ripetere la discussione o le note scritte di fronte a un giudice diverso, il quale, a conclusione di questa
fase pronuncerà il dispositivo e depositerà la motivazione della sentenza.
In relazione alla fase decisoria va segnalato l’ultimo comma dell’art. 429, che riguarda il pagamento di
somme di denaro per crediti di lavoro. La sentenza, in questo caso, deve determinate oltre agli interessi nella
misura legale “il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo
credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del
diritto”. Si tratta di una rivalutazione dei crediti del lavoratore.
Va anche menzionata la valutazione equitativa delle prestazioni, che si ha quando sia certo il diritto ma non
sia possibile determinare la somma dovuta. In questo caso il giudice la liquida con valutazione equitativa.
Ai sensi dell’art. 430, la sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia
e il cancelliere deve darne immediata comunicazione alle parti. Si tratta di un termine puramente ordinatorio
che viene il più delle volte disatteso.
L’esecutorietà della sentenza.
L’art. 431 disciplina l’esecutorietà della sentenza. Dobbiamo tenere presente che quando le norme sono
state emanate si era in una situazione in cui le sentenze di primo grado per definizione non erano esecutive.
Potevano essere provvisoriamente esecutive, ma difettavano ex lege di immediata esecutorietà. La situazione
è completamente cambiata: oggi, tutte le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive, per cui la
norma va attualizzata. Vi sono però delle differenze che riguardano il soggetto a favore del quale la sentenza
viene pronunciata, ossia il lavoratore o il datore di lavoro.
Se la condanna è a favore del lavoratore, questi può procedere ad esecuzione forzata anche sulla base del
solo dispositivo, quindi può utilizzare come titolo esecutivo il solo dispositivo. Diversamente, il datore di
lavoro per poter procedere ad esecuzione forzata nel caso in cui la condanna sia a lui favorevole dovrà
attendere il deposito dell’intera sentenza.
L’esecutorietà provvisoria della sentenza di condanna a favore del lavoratore può essere sospesa solo se alla
controparte deriva gravissimo danno (terzo comma). Diversamente, se la sentenza di condanna è a favore
del datore di lavoro, la sua esecutorietà può essere sospesa – genericamente – per gravi motivi. Sotto questo
profilo, la norma si avvicina all’art. 283, che disciplina la sospensione dell’esecutorietà della sentenza di
condanna resa nel processo ordinario di cognizione, in quanto l’art. 283 parla di “gravi e fondati motivi”. In
La sospensione dell’esecutorietà va richiesta al giudice d’appello.
L’ultimo comma dell’art. 431 richiama l’ultimo comma dell’art. 283, prevedendo che “se l’istanza per la
sospensione dell’esecutorietà è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non
impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore a €250 e non
superiore a €10.000. L’ordinanza è revocabile con sentenza che definisce il giudizio (d’appello)”.
L’appello.
Giudice competente è la Corte d’appello, nello specifico la sezione lavoro (che esiste in quasi tutte le Corti
d’appello).
L’atto introduttivo è un ricorso che deve contenere gli elementi di cui all’art. 434. Il meccanismo è sempre lo
stesso: ricorso, fissazione dell’udienza con decreto del presidente, termine per la costituzione dell’appellato,
udienza di discussione. La struttura è quindi identica a quella del giudizio di primo grado.
All’appello del rito del lavoro vengono applicate le norme sul filtro in appello (artt. 348bis e 348ter), ma la
parte più interessante è un istituto peculiare: l’appello con riserva dei motivi (art. 433, secondo comma).
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
Questo tipo di appello si ricollega alla possibilità del lavoratore risultato vittorioso in giudizio di iniziare
l’esecuzione sulla base del solo dispositivo. Infatti, se il lavoratore ha iniziato l’esecuzione della sentenza di
condanna sulla base del solo dispositivo, il datore di lavoro potrà proporre l’appello con riserva dei motivi. I
motivi di appello dovranno essere depositati entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi
dell’art. 434.
La proposizione dell’appello con riserva dei motivi serve semplicemente a richiedere la sospensione
dell’esecutorietà della sentenza.
Nel processo del lavoro sono ammissibili i c.d. nova in appello. Non sono ammesse nuove domande e nuove
eccezioni, ma sono ammesse nuove prove e nuovi documenti se indispensabili alla decisione della causa.
Ci siamo imbattuti nel problema delle prove indispensabili quando abbiamo parlato dell’appello nel giudizio
sommario di cognizione. Anche in questa forma di appello, quasi a recuperare quello che non si è verificato
nel giudizio di primo grado è prevista la possibilità di dedurre nuovi mezzi di prova, a condizione che
risultino indispensabili. Il concetto di indispensabilità è molto discusso da dottrina e giurisprudenza. In
proposito è illuminante una pronuncia delle Sezioni Unite del 2017 dove si chiarisce che “Il giudizio di
indispensabilità implica una valutazione sull’idoneità del mezzo istruttorio a dissipare ogni possibile
incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola
senza lasciare margine di dubbio, oppure provando quello che era rimasto non dimostrato o non
sufficientemente dimostrato”. In sostanza, la prova è indispensabile quando senza ombra di dubbio
conferma o nega la ricostruzione dei fatti offerta dal giudice di prime cure.
Il rito Fornero.
Il rito Fornero per i licenziamenti, previsto dalla l. 92/2012, è un procedimento estremamente articolato del
quale tutti auspicano l’abrogazione.
È un rito obbligatorio nel caso in cui si intenda impugnare un licenziamento, a condizione che esso riguardi
un rapporto di lavoro subordinato sorto anteriormente all’entrata in vigore del Jobs Act del 2015.
La parte che riguarda il rito è disciplinata dai commi 47 e ss.
Il procedimento inizia con un ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso deve contenere
gli elementi di cui all’art. 125 è seguito dalla fissazione dell’udienza di comparizione mediante decreto e
dalla notificazione del ricorso e del decreto al convenuto e dalla sua costituzione.
L’udienza di comparizione delle parti. La dicitura della norma riproduce quanto visto nel rito sommario
del lavoro e nei procedimenti cautelari. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione che ritiene indispensabili
richiesti dalle parti o disposti d’ufficio ex art. 421 c.p.c. Anche nell’ambito di questo procedimento, quindi, il
giudice potrà esercitare tutti quei poteri istruttori esercitabili d’ufficio che caratterizzano il rito del lavoro
(con i limiti già visti). Qui apparentemente il giudice dispone anche di un certo potere di case management
(gestione manageriale della causa), in quanto può “procedere nel modo che ritiene più opportuno alla
trattazione della controversia”.
A conclusione della trattazione provvede con ordinanza immediatamente esecutiva – esecutività che non può
essere sospesa fino alla definizione del giudizio di opposizione – accogliendo o rigettando la domanda.
Qui iniziano i problemi. Contro questa ordinanza può essere proposta opposizione con ricorso dinanzi al
tribunale che ha emesso il provvedimento entro un termine molto breve. L’opposizione da proporsi con
ricorso mette in moto il solito meccanismo che culmina con un’udienza di discussione prima della quale
l’opposto deve costituirsi e, nuovamente, il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione che ritiene indispensabili
richiesti dalle parti o disposti d’ufficio ex art. 421 c.p.c.
Qui ci sono elementi che ci fanno pensare a un provvedimento cautelare, ma non siamo nell’ambito della
tutela cautelare; il riferimento all’opposizione fa pensare all’opposizione a decreto ingiuntivo, quindi a un
procedimento che da sommario nella prima fase si trasforma in procedimento di cognizione ordinaria a tutti
gli effetti. Ma non è finita qui.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
Contro questa sentenza pronunciata sull’opposizione all’ordinanza pronunciata in primo grado non è
proponibile appello, ma reclamo davanti alla Corte d’appello, la quale fissa con decreto l’udienza di
discussione e, a conclusione dell’udienza di discussione provvede con sentenza.
In sintesi, abbiamo quindi uno stranissimo procedimento di primo grado che si conclude con ordinanza.
Contro questa ordinanza può essere proposta opposizione che somiglia vagamente all’opposizione a decreto
ingiuntivo, ma si sviluppa secondo le peculiarità proprie dell’udienza di discussione del rito del lavoro.
Contro la sentenza con cui si chiude questa seconda fase non è proponibile appello, ma reclamo alla Corte
d’appello. Anche la proposizione del reclamo mette in movimento un procedimento che assomiglia a tutti gli
effetti a un processo ordinario del lavoro, con un’udienza in cui il giudice provvede alla fase istruttoria in
base alle prove prodotte dalle o disposte d’ufficio. L’udienza si chiude con sentenza contro la quale è
ulteriormente proponibile il ricorso per cassazione.
Questo procedimento non ha logica. In esso sono confluiti istituti completamente diversi e sganciati dalla
problematica dell’accertamento della legittimità o meno di un licenziamento (qualche pezzo di tutela
cautelare, qualche pezzo di tutela del decreto ingiuntivo, il reclamo cautelare, il ricorso per cassazione).
Nel disegno di legge delega per la riforma del processo civile presentato e approvato dalla Camera poco
prima che iniziasse il lockdown dovuto al Covid-19 si proponeva la totale abrogazione del rito Fornero.
LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LOCAZIONE, DI COMODATO E DI AFFITTO.
Le norme del processo del lavoro trovano applicazione non solo in materia di controversie individuali di
lavoro, ma hanno un campo di applicazione più ampio.
L’art. 447bis prevede l’applicazione di questo rito anche alle controversie in materia di locazione e di
comodato di immobili, nonché alle controversie in materia di affitto di aziende.
Ricordiamo che il codice prevede il procedimento per convalida di licenza o di sfratto. Tuttavia questo non è
l’unico tipo di controversia che può nascere in materia di locazione, comodato e affitto.
Inoltre, anche nei casi in cui sarebbe esperibile il procedimento di convalida di sfratto, la parte ha facoltà di
scelta tra quel rito sommario e il rito a cognizione piena ma speciale regolato dalle norme sul rito del lavoro.
Il primo comma dell’art. 447 bis dispone che tali controversie sono disciplinate dalle norme sul rito del
lavoro “in quanto applicabili”.
La competenza verticale è ovviamente del tribunale. Dal punto di vista del territorio è competente il giudice
del luogo in cui si trova l’immobile. Il secondo comma prevede che sono nulle le clausole di deroga alla
competenza. La competenza del tribunale è funzionale, quindi inderogabile.
Quali sono le principali differenze rispetto al processo del lavoro? Innanzitutto il terzo comma dispone che
“il giudice può disporre d’ufficio, in qualsiasi momento, l’ispezione della cosa e l’ammissione di ogni mezzo
di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni, sia scritte che orali,
alle associazioni di categoria indicate dalle parti”.
Sulla base di questo comma comprendiamo che, anche qui come nel processo del lavoro, il giudice può
disporre d’ufficio l’ammissione di ogni mezzo di prova. Tuttavia, mentre nel processo del lavoro si fa
riferimento al possibile superamento dei limiti previsti dal codice civile, qui il riferimento manca. Di
conseguenza, è necessario che l’esercizio dei poteri istruttori avvenga nel rispetto dei limiti del codice
civile.
Lo stesso terzo comma parla delle informazioni che possono essere richieste alle associazioni di categoria
indicate dalle parti, mentre nel processo del lavoro la richiesta di informazioni può essere fatta alle
associazioni sindacali.
Infine, l’ispezione della cosa può essere disposta anche d’ufficio come nel processo ordinario, mentre
l’accesso al luogo di lavoro richiede sempre e comunque l’istanza di parte.
Anche in questo caso la pronuncia della sentenza avviene mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, va
sottolineato che, per quanto la sentenza sia provvisoriamente esecutiva, in questo caso si può procedere
all’esecuzione sulla base della sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della
sentenza. Non si distingue tra una parte che può procedere e una che non può, mentre nel processo del lavoro
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
si distingue tra lavoratore che può procedere all’esecuzione con il solo dispositivo e datore di lavoro che non
può.
Infine, l’efficacia esecutiva e l’esecuzione della sentenza possono essere sospese solo quando dalle stesse
possa derivare all’altra parte gravissimo danno. Si tratta di un’altra differenza importante perché nel processo
del lavoro il riferimento al gravissimo danno riguarda solo la sospensione dell’esecutorietà delle sentenze
pronunciate a favore del lavoratore.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
I METODI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE
(ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTIONS)
Si tratta di metodi che mirano a portare alla definizione della controversia senza che questa sia decisa da un
giudice, quindi si sviluppano prima e di solito al di fuori di un’aula di tribunale.
I metodi alternativi esistono da sempre. Noi ci occupiamo ovviamente di quelli che riguardano il momento
attuale.
I metodi alternativi di risoluzione delle controversie si sono sviluppati a partire dalla metà degli anni Settanta
del secolo scorso negli Stati Uniti per tutta una serie di circostanze particolari legate alla società americana.
Una società che è stata definita “litigiosa”, in quanto la tendenza a instaurare processi è molto forte. Era
molto forte soprattutto intorno alla metà del secolo scorso. Per questo si è iniziato a pensare alla possibilità di
dirottare una parte delle controversie che gravavano sulle corti statunitensi statali e federali verso metodi che
non implicassero necessariamente la pronuncia di una sentenza da parte del giudice.
La lettura di questo fenomeno può essere di due tipi: una in bonam partem, come tentativo di assicurare ai
cittadini una giustizia intesa in senso lato (possibilità di vedere la controversia risolta in tempi più rapidi e a
costi più ridotti di quanto non accadeva davanti al tribunale); una in malam partem, come volta a fare del
ricorso alla giustizia formale dello Stato una sorta di situazione elitaria, riservata ai casi che a torto o ragione
venivano considerati più importanti in ragione del valore della domanda.
Comunque si voglia leggere il fenomeno, i metodi alternativi si sono sviluppati in forma sempre più
numerosa e consolidata e sono approdati anche in Europa alla fine degli anni Novanta del secolo scorso.
L’UE ha subito colto le potenzialità di questi metodi alternativi, considerati come funzionali agli obiettivi
dell’Unione stessa, ossia libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali. Questo
perché nell’immaginario – ma la realtà è molto diversa – delle istituzioni europee i cittadini dei diversi Stati
membri dovrebbero intrattenere rapporti sempre più stretti, dai quali possono nascere controversie
transfrontaliere. I metodi alternativi possono costituire un valido metodo per la risoluzione di queste
controversie per superare i problemi che sorgono relativamente all’individuazione di un giudice dotato di
giurisdizione e della legge applicabile, soprattutto per il loro carattere privato.
Le alternative al processo, note come ADR (Alternative dispute resolutions) sono di due tipi: metodi
facilitativi e metodi aggiudicativi.
I metodi facilitativi sono volti a consentire alle parti, da sole o con l’interposizione di un soggetto terzo, di
raggiungere una soluzione consensuale in una controversia, soluzione che sono le parti stesse ad elaborare.
I metodi aggiudicativi sono quelli che portano ad una vera e propria decisione che individua chi ha ragione
e chi ha torto.
Basandoci su questa distinzione possiamo dire che nel nostro ordinamento l’unico metodo veramente
aggiudicativo è l’arbitrato, perché gli arbitri, proprio come i giudici dello Stato, pronunciano una decisione,
ossia stabiliscono chi ha ragione e chi ha torto nell’ambito di una controversia.
Nei metodi facilitativi la decisione non esiste, quindi non c’è una parte vittoriosa o una parte perdente. La
funzione di questi metodi è quella di consentire alle parti di raggiungere un accordo che entrambe
gradiscono. Metodi facilitativi sono la conciliazione e la mediazione.
In realtà, mediazione e conciliazione sono la stessa cosa, anche se a giudizio di Silvestri queste non sono
determinanti. Il problema della terminologia è legato al fatto che nella tradizione giuridica di civil law si è
sempre parlato soprattutto di conciliazione (ricordiamo la conciliazione giudiziale o stragiudiziale nel
processo di cognizione, il tentativo di conciliazione obbligatorio nelle cause di lavoro, ecc.). Il termine
mediazione deriva dal linguaggio della tradizione di common law, dove si preferisce usare il termine
mediation.
N.B. Nel nostro ordinamento, mediazione è sempre stato – fino all’avvento delle ADR – quel contratto per
mezzo del quale un soggetto si interpone tra due parti per la conclusione di un affare. Si tratta di fenomeni
completamente diversi (uno sostanziale e l’altro processuale) e regolati da fonti diverse.
Riassumere in poche battute tutto quello che si potrebbe dire a proposito delle ADR è impossibile.
Per quanto riguarda il nostro ordinamento possiamo dire che, al di là delle prime iniziative dell’Unione che
riguardano alcune raccomandazioni seguite da un Libro verde sui metodi alternativi, l’atto normativo più
importante è la direttiva sulla mediazione. A questa direttiva ha fatto seguito un’altra direttiva sui c.d. metodi
alternativi per le controversie dei consumatori. Possiamo dire che la promozione della mediazione nel nostro
ordinamento si deve proprio all’attuazione della direttiva sulle controversie civili e commerciali del 2008. Si
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
tratta di un documento molto interessante che fissa alcuni principi basilari, tra cui norme che condengono
definizioni.
In particolare, la definizione di mediazione data dalla direttiva è la seguente: per mediazione si intende il
procedimento mediante il quale le parti raggiungono una soluzione consensuale della controversia, con
l’intervento di un terzo neutrale e imparziale che opera da interfaccia tra le parti, ma che può essere
denominato in qualunque modo (mediatore, conciliatore, ecc.).
Nel nostro ordinamento, proprio in considerazione della tradizione della conciliazione, il legislatore, nel dare
attuazione alla direttiva con d.lgs. 28/2010, ha scelto una soluzione abbastanza strana. Ha denominato
mediazione il procedimento seguito davanti al mediatore e conciliazione l’accordo eventualmente raggiunto,
tant’è che subito dopo l’entrata in vigore del decreto si era diffuso l’orribile nome media-conciliazione.
In ogni caso, ciò che conta è la posizione del terzo neutrale che funge da catalizzatore, occupandosi di sentire
le ragioni delle parti e aiutandole a raggiungere un accordo.
Sul soddisfacimento delle esigenze delle parti sorgono diverse interpretazioni. Secondo la concezione
classica della mediazione, le parti devono essenzialmente trovare una soluzione che privilegi i loro reali
interessi. Non a caso si dice spesso che “la mediazione si svolge all’ombra del diritto”, non nel senso che è
protetta da un ombrello legislativo che la mette al riparo da pericoli di varia natura, ma nel senso che il diritto
è un’altra cosa, sta al di fuori della mediazione. Questa interpretazione sviluppata all’estremo è accettata e
diffusa solo negli USA, dove paradossalmente un accordo raggiunto in mediazione potrebbe addirittura
essere diverso, se non addirittura contrario a quello che un’applicazione rigorosa delle norme sulla fattispecie
determinerebbero.
Da noi questo non è possibile, in quanto la soluzione consensuale raggiunta dalle parti può essere differente
da quella che il giudice presumibilmente investito della controversia raggiungerebbe in punto di diritto,
tuttavia non può essere contra legem, se non altro perché l’accordo raggiunto dalle parti nella mediazione
deve essere certificato dai loro avvocati o dal giudice come conforme all’ordine pubblico e alle norme
imperative. È comunque certo che nell’ambito di un procedimento di mediazione le parti sono nella
posizione di esprimere quelli che sono i loro reali interessi, realizzando un buon contemperamento delle
esigenze di entrambe le parti.
Si dice che una soluzione consensuale concordata tra le parti è un tipo di soluzione che le parti sono disposte
a rispettare e ad attuare spontaneamente. Si dice anche che se le parti riescono a raggiungere un accordo si
mantiene aperto tra di loro un canale di comunicazione molto importante. Ad esempio se la controversia
sorge nell’ambito di rapporti commerciali tra due partner che in condizioni normali hanno lavorato insieme
benissimo, risolvendola in modo consensuale le parti possono tornare a cooperare senza problemi.
Affermazioni di questo genere appartengono a quella che è la retorica della mediazione e dei metodi
alternativi di risoluzione delle controversie. L’idea che la risoluzione delle controversie è utopistica. La
realtà è che molto spesso il ricorso a questi metodi ha funzione deflativa del carico giudiziario.
L’ordinamento italiano, infatti, nel momento in cui è stato necessario attuare la direttiva sulla mediazione ha
scelto di rendere la mediazione obbligatoria in un lungo elenco di cause civili e commerciali. Ciò significa
che in questi casi essa è configurata come condizione di procedibilità della domanda, in assenza della quale il
processo non può proseguire, quindi occorre che si fermi e che la parte più diligente si adoperi per soddisfare
la condizione di procedibilità prima di tornare davanti al giudice. Il giudice, nel caso in cui la condizione di
procedibilità non sia stata comunque soddisfatta, chiuderà il processo in rito.
La scelta del legislatore italiano è stata dunque in questa direzione, direzione che era lasciata aperta dalla
direttiva che non precludeva la possibilità di rendere obbligatorio il tentativo di mediazione. Questa scelta è
stata fatta solo dal legislatore italiano. Anche la Romania aveva adottato una scelta simile, tuttavia la Corte
costituzionale rumena aveva dichiarato incostituzionali le norme sulla mediazione obbligatoria.
In realtà, anche in Italia interviene la Corte costituzionale. Nel momento in cui entra in vigore il d.lgs.
28/2010 c’è una fortissima opposizione alla mediazione obbligatoria da parte soprattutto del ceto forense,
che addirittura sciopera contro tali norme. Dopo varie vicissitudini la questione arriva davanti alla Consulta,
alla quale viene posta la questione di costituzionalità dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione in
rapporto al diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. e, in collegamento con questo, al principio di
uguaglianza ex art. 3 Cost. La Corte arriva a una decisione particolare: dichiara illegittimo il tentativo
obbligatorio di mediazione per un vizio meramente formale, ossia perché il legislatore ha superato i limiti
della legge delega che aveva previsto l’attuazione della direttiva sulla mediazione.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
I giudici della Consulta hanno riflettuto a lungo per arrivare a una soluzione di questo tipo, la quale da un
lato abroga le norme sulla obbligatorietà del tentativo preliminare di mediazione, ma dall’altro non preclude
al legislatore la possibilità di reintrodurla.
In questo modo il legislatore si è trovato a distanza di pochi mesi nella possibilità di reintrodurre la
mediazione obbligatoria, con alcune modifiche. Il succo di queste modifiche è un “contentino” dato agli
avvocati, nel senso che, per evitare una nuova ostilità, il legislatore ha riconosciuto agli avvocati tutta una
serie di facoltà e di poteri prima non previsti.
Uno in particolare è il fatto che ora, fin dall’inizio del procedimento di mediazione, le parti devono
comparire davanti al mediatore assistite dal loro difensore di fiducia. In realtà, il discorso è più
complesso. Il fatto che le parti vadano in mediazione assistite dall’avvocato è una vera e propria negazione
dei sacri principi della mediazione. Si ritiene, infatti, che la mediazione, dovendo essere espressione della
volontà delle parti, cioè il luogo in cui le parti espongono al mediatore il loro punto di vista in assoluta libertà
nella prospettiva di raggiungere insieme all’avversario un accordo soddisfacente per entrambe, la presenza
dell’avvocato con la sua forma mentis particolare modifichi gli equilibri tra le parti. I puristi ritengono quindi
che la presenza dell’avvocato nella mediazione non sia qualcosa di particolarmente auspicabile.
In effetti, chi si occupa di mediazione dirà molto spesso che le parti partecipano personalmente al
procedimento di mediazione un po’ come convitati di pietra, nel senso che lasciano che le loro ragioni siano
sempre e comunque esposte dal difensore che le assiste, anche se qui è fondamentale il ruolo del mediatore
nel mitigare l’influenza dell’avvocato.
Si potrebbero fare dei sofismi tra assistenza del difensore e rappresentanza, che è quella che il difensore
svolge nel processo e che implica una pregnanza di facoltà e poteri che in linea di principio l’avvocato non
ha nel procedimento di mediazione.
Un altro contentino dato dal legislatore del 2013 nel ripristinare il tentativo obbligatorio di mediazione è la
previsione secondo la quale gli avvocati sono mediatori di diritto. Per diventare mediatore occorre seguire
un particolare percorso formativo. L’espressione all’inizio sembrava che per gli avvocati questo percorso
formativo non fosse necessario. Oggi anche gli avvocati devono seguire dei particolari corsi di formazione.
Questa nuova (e attualmente in vigore) disciplina sulla mediazione obbligatoria dimostra che, nel tentativo di
mantenere l’obbligatorietà della disciplina, il legislatore ha dovuto fare tutta una serie di concessioni alla
classe forense.
La sostanza del discorso è che sull’obbligatorietà del tentativo di mediazione la Corte costituzionale ha
sempre adottato soluzioni collaterali senza entrare nel merito del problema, dicendo ad esempio che rientra
nella discrezionalità del legislatore adottare le soluzioni che ritiene più adatte per un’efficiente gestione della
giustizia, che accesso alla giustizia non significa necessariamente accesso agli organi giurisdizionali, che le
forme alternative sono tollerabili nella misura in cui non ritardino o rendano più complicato l’accesso agli
organi giurisdizionali, e così via. Del resto, la stessa Corte di Lussemburgo ha sostenuto più volte – in cause
che riguardavano anche ricorsi di cittadini italiani – un orientamento simile, affermando che l’obbligatorietà
di tentativi di mediazione non è necessariamente contraria al diritto di azione e ai diritti garantiti ai soggetti
dalla CEDU e dalla Carta di Nizza: i tentativi obbligatori sono ammissibili se non precludono il ricorso agli
organi giurisdizionali nel caso in cui le parti non riescano ad addivenire a una soluzione.
Peraltro, a distanza di anni dall’entrata in vigore della mediazione, in Italia – come in altri ordinamenti
europei – è risultato che la mediazione non è particolarmente seguita. Da un lato questo è legato al fatto che
ogni ordinamento ha dato alle norme un’attuazione diversa. Ad esempio, rispetto all’esecutività dell’accordo
raggiunto dalle parti, mentre in Italia se c’è la sottoscrizione degli avvocati delle parti è automatica, in
Spagna per il conferimento dell’esecutorietà è necessario un exequatur notarile. Inoltre, lasciando da parte la
mediazione obbligatoria, quello che non riesce a decollare è la mediazione volontaria.
È certo che ai vari Stati membri e all’UE il successo delle ADR interessa soprattutto con riguardo alla
funzione deflativa che può svolgere.
Il problema è stato in minima parte ovviato per quanto riguarda il carico di lavoro delle corti di primo grado,
ma ha lasciato immutata la situazione delle corti d’appello e, soprattutto, della Cassazione, che rimane la
corte con il maggior carico di lavoro arretrato.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
La mediazione dei consumatori.
La direttiva in materia di ADR dei consumatori è stata adottata in Italia attraverso il d.lgs. 130/2015, che ha
istituito delle forme particolari di risoluzione alternativa delle controversie, implicando una modifica del
Codice del consumo. Questo ha portato a una serie di problemi (che comprenderemo leggendo il manuale di
Silvestri) in tema di compatibilità con le norme sulla mediazione.
Secondo Silvestri non c’era bisogno di un’altra direttiva che complicasse la situazione del panorama delle
ADR. La situazione nel nostro ordinamento, ma anche in altri, è di una pluralità forse eccessiva di metodi
alternativi di risoluzione delle controversie, in quanto molto spesso alle parti non è chiaro quale sia la forma
alternativa più adeguata alla controversia che si trovano davanti.
L’approccio del nostro legislatore rispetto alla mediazione.
Mentre la mediazione nelle cause civili e commerciali è disciplinata in maniera abbastanza dettagliata e a
questa disciplina normativa si è aggiunto un corpus giurisprudenziale molto articolato su vari aspetti della
mediazione, il nostro legislatore nazionale ignora completamente la mediazione familiare.
C’è solo un piccolissimo accenno in alcune norme del codice civile e nelle norme sulla negoziazione assistita
in ambito familiare, alla quale peraltro non fa riscontro una disciplina specifica a livello nazionale. Ci sono
delle discipline regionali, che però non hanno una valenza generale, proprio perché la materia delle
professioni regolamentate è stata affidata dalla riforma del Titolo V della Costituzione alla legislazione
concorrente. Le legislazioni regionali dovrebbero svilupparsi all’interno di un quadro normativo delineato
dal legislatore nazionale, cosa che non avviene.
Possiamo, quindi, notare il paradosso dell’esistenza di una regolamentazione dettagliata di cause che
riguardano perlopiù beni materiali (mediazione civile e commerciale) e della mancata esistenza di una
disciplina nazionale che riguarda situazioni ben più importanti (mediazione familiare).
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
L’ARBITRATO.
L’arbitrato è l’unico metodo di risoluzione delle controversie a carattere aggiudicativo presente nel nostro
ordinamento. Ciò significa che, come i giudici, anche gli arbitri decidono una controversia, emettendo un
lodo in base al quale si determina chi ha torto e chi ha ragione.
Gli arbitri sono soggetti terzi e imparziali che pronunciano una decisione, tant’è che molto spesso vengono
definiti come giudici privati, posto che l’arbitrato implica che siano le parti stesse o, più spesso,
un’istituzione arbitrale se queste non riescono a trovare un accordo a scegliere i soggetti che saranno arbitri
di quella controversia.
Si può dire che l’arbitrato sia un metodo di risoluzione della controversia fortemente determinato e
caratterizzato dall’autonomia delle parti.
Dal punto di vista sistematico, l’arbitrato è disciplinato alla fine del Libro quarto, o meglio, in quella che fino
a poco tempo fa era la fine del Libro quarto (artt. 806 e ss.). Il fatto che l’arbitrato sia collocato alla fine del
quarto libro ha un significato storico. Il codice di procedura civile è stato adottato in piena epoca fascista,
quindi ha subito gli influssi di una concezione statalista.
A partire dal novembre di quest’anno, le norme sull’arbitrato non saranno più le ultime, ma saranno quelle
sulle azioni collettive risarcitorie e inibitorie.
Tornando all’arbitrato, dobbiamo rilevare che nel corso degli ultimi anni la disciplina ha subito modifiche
piuttosto significative. Il senso di queste modifiche è stato quello di procedimentalizzare sempre più
l’arbitrato, quindi di dettarne una disciplina che per certi versi è estremamente dettagliata. Il che è, da un
lato, contro intuitivo e, dall’altro, mette l’arbitrato italiano in una posizione abbastanza marginale per come è
disciplinato rispetto ad altri ordinamenti. Abbiamo detto che l’arbitrato è espressione dell’autonomia delle
parti. Naturalmente questa autonomia dovrebbe implicare la possibilità di utilizzare un procedimento snello,
flessibile e adattabile alle esigenze delle parti. Non è così nel nostro ordinamento, dove la disciplina
codicistica dell’arbitrato è estremamente strutturata. Lo vedremo soprattutto nella disciplina delle
impugnazioni, in quanto le cause (tassative) di impugnazione per nullità del lodo ex art. 829 sono ben dodici.
Va anche segnalato il fatto che la disciplina italiana dell’arbitrato si discosta da quello che è lo stato dell’arte
della disciplina a livello internazionale degli arbitrati. Il riferimento è alla legge-modello Uncitral
(organismo collegato alle Nazioni Unite che ha il compito di realizzare leggi-modello alle quali gli Stati
possono fare riferimento nel disciplinare l’arbitrato di diritto interno e anche l’arbitrato internazionale. La
nostra disciplina dell’arbitrato non tiene assolutamente conto di tale legge-modello, ad esempio non concede
ai nostri arbitri il potere di adottare misure cautelari. Questo è un dato indicativo che dimostra
l’eccezionalismo (in senso negativo) della situazione italiana.
Nel codice manca una qualunque disciplina dell’arbitrato internazionale. Questa è una lacuna grave, in
considerazione del fatto che proprio a livello di controversie internazionali o transnazionali l’arbitrato è allo
stato uno dei metodi di risoluzione più utilizzati.
Le ultime riforme hanno reso sempre più simile la disciplina dell’arbitrato italiano a quella del processo,
almeno sotto certi aspetti.
Possiamo domandarci se il ricorso alla giustizia arbitrale ha senso in un ordinamento in cui l’art. 24 Cost.
parla di diritto di tutti all’accesso alla giustizia. La domanda è più che legittima e viene in rilievo anche
rispetto all’obbligatorietà del tentativo di mediazione. La Corte costituzionale ha avuto modo di occuparsi
anche dell’arbitrato, non tanto sotto al profilo della sua contrarietà con l’art. 24, che è stata riconosciuta solo
in relazione ai c.d. arbitrati obbligatori, ma ha canonizzato la forte somiglianza dell’arbitrato al procedimento
giurisdizionale con una serie di pronunce. In particolare, la pronuncia n. 376/2001 ha statuito
sull’illegittimità delle norme che non consentivano agli arbitri di sospendere il procedimento e sollevare la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte. La Corte, nel dire che anche gli arbitri possono
porre in questione la costituzionalità di norme di diritto, fa importanti affermazioni a livello di obiter dicta.
Secondo la Corte, “L’arbitrato costituisce un procedimento previsto e disciplinato dal codice civile per
l’applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto ai fini della risoluzione di una controversia con le
garanzie del contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria. Sotto l’aspetto
considerato, il giudizio arbitrale non si differenzia da quello che si svolge dinanzi agli organi statali della
giurisdizione, anche per quanto riguarda la ricerca e l’interpretazione delle norme applicabili alla
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
fattispecie”. Si afferma quindi un parallelismo tra la pronuncia che si può ottenere davanti a un giudice e
quella che si può ottenere davanti a un arbitro.
Del resto, lo stesso legislatore ha dettato una serie di norme dalle quali comprendiamo benissimo che il
parallelismo tra fenomeno giurisdizionale e fenomeno arbitrale è effettivamente molto forte.
L’attuale art. 824bis parla dell’efficacia del lodo, dicendo che esso ha, dalla data della sua ultima
sottoscrizione, gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria, salvo gli effetti
esecutivi. Per attribuire al lodo anche efficacia esecutiva occorre un passaggio ulteriore davanti al tribunale.
Anche l’art. 826 ci dà la misura di questo parallelismo. Questa norma consente la correzione del lodo in
presenza di errori materiali o di calcolo. È un procedimento che c’è anche per le sentenze.
Il ricorso all’arbitrato.
È ben difficile che in una controversia tra privati cittadini si ricorra all’arbitrato. Questo perché in genere è
più rapido del procedimento ordinario davanti al giudice, ma è anche particolarmente costoso. Questo spiega
perché sia un tipo di metodo di risoluzione molto utilizzato per le controversie commerciali.
La convenzione di arbitrato.
L’art. 806 stabilisce che “Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non
abbiano ad oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge”. Decodificando la norma, possiamo
dire che l’arbitrato è utilizzabile per la risoluzione di tutte le controversie relative a diritti disponibili,
sempre che il legislatore non abbia, in relazione a una specifica materia, posto un divieto di arbitrabilità.
In linea di massima le materie escluse sono materie in relazione alle quali le parti sono prive del potere di
transigere. Uno degli indici che suggeriscono che la materia è relativa a diritti indisponibili è dato dalla
partecipazione del Pm obbligatoria o facoltativa in considerazione dell’interesse pubblico. Per il ricorso
all’arbitrato – ma anche a tante altre forme di ADR – l’indisponibilità del diritto costituisce, quindi, un limite
invalicabile.
Un altro limite riguarda le controversie individuali di lavoro. In questi casi l’arbitrato è possibile solo se
espressamente previsto dalla legge o, come avviene di frequente, dai contratti o accordi collettivi.
I due articoli successivi parlano specificamente della convenzione di arbitrato, ossia della fonte
dell’arbitrato. Nella convenzione le parti possono manifestare la loro intenzione di far risolvere la
controversia da arbitri. Essa può assumere due forme: il compromesso e la clausola compromissoria.
Il compromesso (art. 807) è uno specifico contratto che richiede la forma scritta ad substantiam e, a pena
di nullità, deve determinare l’oggetto della controversia. La stipulazione ad opera delle parti di un
compromesso presuppone che vi sia già una controversia in atto.
La clausola compromissoria (art. 808) è propria di una situazione in cui il conflitto non c’è ancora. Si tratta
di una clausola inserita in un contratto avente un qualsivoglia oggetto, mediante la quale le parti si
impegnano a risolvere mediante arbitrato le eventuali controversie che derivano dal contratto stesso. Anche
in questo caso, è richiesta la forma scritta a pena di nullità. In particolare, la clausola compromissoria,
essendo considerata una clausola vessatoria (soprattutto nei contratti per adesione) richiede una
sottoscrizione specifica.
Il secondo comma dell’art. 808 sancisce il principio dell’autonomia della clausola compromissoria. Esso
recita: “La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al
contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare un contratto comprende il potere di convenire la
clausola compromissoria”. Questa ipotesi si riferisce al caso in cui il contratto di cui è parte la clausola sia
per qualsiasi ragione dichiarato nullo o venga annullato, oppure perda efficacia. Il vizio che riguarda il
contratto non necessariamente riguarda la clausola, essendo necessario valutare la situazione caso per caso.
L’esempio del Luiso è il seguente. Tizio e Caio stipulano un contratto di locazione all’interno del quale è
contenuta una clausola compromissoria. Alla scadenza del contratto Caio (conduttore) non rilascia
l’immobile. Tizio non può chiedere la convalida di sfratto per finita locazione, in quanto c’è una clausola
compromissoria. Saranno gli arbitri a dover decidere tutto ciò che riguarda il problema della restituzione
dell’immobile e l’eventuale risarcimento dei danni. Questo perché la clausola compromissoria è separabile
dal resto del contratto.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
L’arbitrato è utilizzabile nelle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili e, tipicamente, in materia
contrattuale. Tuttavia, una delle norme aggiunte nelle tante riforme dell’arbitrato è l’art. 808bis, relativo alla
materia non contrattuale. La norma stabilisce che “Le parti possono stabilire, con apposita convenzione,
che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati.
La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall’art. 807”. Si è
molto discusso di quali possano essere le materie non contrattuali nelle quali l’arbitrato può essere utilizzato.
Possiamo fare due esempi: uno riguarda la materia condominiale, dove possono sorgere controversie che non
hanno origine da un contratto, anzi, possono derivare da diritti reali vantati da un soggetto nei confronti di un
altro; l’altro è dato dalla materia successoria, ad esclusione delle controversie che derivano dalla successione
legittima.
L’arbitrato irrituale.
Nell’ambito dell’arbitrato viene operata una distinzione particolarmente importante: quella tra arbitrato
rituale e arbitrato irrituale. L’arbitrato rituale ha la sua integrale disciplina nel codice di procedura, mentre
all’arbitrato irrituale si riferisce specificamente la disciplina dell’art. 808ter. Si tratta di due fenomeni
completamente diversi.
Creato dalla giurisprudenza, l’arbitrato irrituale è stato riconosciuto solamente in seguito dal legislatore. È un
altro aspetto dell’eccezionalità italiana. Infatti, per quanto sull’arbitrato irrituale (o libero) siano stati versati
dalla dottrina fiumi di inchiostro, questa forma di arbitrato esiste solo in Italia. Tant’è vero che è
sostanzialmente impossibile che è impossibile tradurlo in qualsiasi altra lingua.
L’art. 808ter afferma: “Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a
quanto disposto dall’art. 824bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione
contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo”. Il nucleo della norma è questa
“definizione della controversia mediante determinazione contrattuale”. Questo significa che le parti,
mediante la convenzione di arbitrato, conferiscono all’arbitro il potere di elaborare una soluzione transattiva
della controversia e si impegnano ad assumere come propria, cioè come manifestazione della loro stessa
volontà, questa soluzione transattiva. Quindi, di fatto, le parti stipulano un contratto il cui contenuto non è
stato determinato da loro stesse, ma è stato determinato da un terzo, sul presupposto che le parti si sono
impegnate a riconoscerlo come manifestazione della loro diretta volontà. Siamo al di fuori dell’arbitrato
rituale, in quanto la norma parla specificamente di “deroga a quanto disposto dall’art. 824bis”, quindi non c’è
un lodo arbitrale, ma un contratto. Se le parti non hanno indicato espressamente che l’arbitrato è irrituale, il
legislatore presume che si tratti di un arbitrato rituale.
La differenza fondamentale è che la definizione della controversia realizzata dal terzo mediante
determinazione contrattuale è, appunto, un contratto e non un lodo. Si tratta quindi di qualcosa che dovrà
essere impugnato, nel caso in cui una delle parti non lo osservi, secondo le regole ordinarie, ossia
instaurando un giudizio di cognizione. Ciò significa che, a differenza del lodo che è soggetto a impugnazioni
specifiche per nullità, revocazione e opposizione di terzo, chi voglia impugnare il contratto frutto di un
arbitrato irrituale dovrà necessariamente farlo per i motivi indicati dallo stesso art. 808ter secondo comma, ai
quali si aggiungono i normali vizi in ragione dei quali un contratto può essere impugnato (incapacità delle
parti; vizi del consenso, quali errore, dolo o violenza).
C’è anche un’altra differenza. Il lodo rituale depositato e rispetto al quale il giudice ha concesso l’exequatur
può essere immediatamente utilizzato come titolo esecutivo. Diversamente, il lodo irrituale, nel caso in cui
una delle parti non adempia al contratto che ha posto fine alla controversia, richiederà che venga instaurato
un ordinario giudizio di cognizione per la condanna della parte inadempiente, oppure che venga
proposto decreto ingiuntivo se ne ricorrono i presupposti.
L’interpretazione e l’efficacia della convenzione d’arbitrato.
L’art. 808quater – rubricato “Interpretazione della convenzione d’arbitrato” stabilisce che: “Nel dubbio,
la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le
controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”. A giudizio di
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
Silvestri, la norma si riferisce, in particolare, alla clausola compromissoria, quindi a tutte le controversie
relative a quello specifico contratto in cui la clausola è contenuta
L’art. 808quinquies – intitolato “Efficacia della convenzione d’arbitrato” – afferma che: “La conclusione
del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito non toglie efficacia alla convenzione d’arbitrato”.
Ciò significa che, nel caso in cui l’arbitrato rituale si concluda senza pronuncia sul merito, quindi gli arbitri
decidano con una pronuncia in rito a carattere impediente (rilevando ad esempio il difetto di legittimazione
delle parti) la convenzione continua ad essere operativa.
Gli arbitri (artt. 809-815).
Di tutte le norme sugli arbitri, una norma su cui è necessario riflettere è data dall’art. 815 in tema di
ricusazione degli arbitri. La norma prevede delle cause di ricusazione che sono assolutamente analoghe a
quelle per cui è prevista la ricusazione del giudice. Naturalmente, in tutte le ipotesi in cui è prevista la
ricusazione dell’arbitro è anche possibile la sua astensione.
Il punto principale è che nel nostro ordinamento non è prevista la c.d. disclosure dell’arbitro. La maggior
parte dei regolamenti arbitrali – anche italiani – prevedono che gli arbitri, una volta nominati dalle parti,
sottoscrivano una particolare dichiarazione in cui affermano che non hanno in passato intrattenuto
rapporti personali o professionali con le parti della controversia. Non a caso, molto spesso i problemi
sorgono quando emerge la non veridicità di queste dichiarazioni.
Pensiamo, ad esempio, alla controversia tra due soggetti rappresentati dallo stesso grande studio legale. Può
porsi un problema di imparzialità dell’arbitro? È necessario dire nella dichiarazione che ci sono stati rapporti
di colleganza con l’avvocato di una delle parti? Si tratta di un problema molto studiato e molto importante,
soprattutto con riferimento ai c.d. arbitri di parte. È vero che l’arbitro è nominato dalla parte, ma non per
questo deve essere meno terzo, meno imparziale nello svolgere le sue funzioni.
La ricusazione si propone al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede l’arbitrato.
L’ultimo comma della norma è interessante, in quanto prevede che “La proposizione dell’istanza di
ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri. Tuttavia, se
l’istanza è accolta, l’attività compiuta dall’arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace”. Il che è
abbastanza ovvio, posto che la ricusazione serve a mettere in evidenza il difetto di terzietà e imparzialità
dell’arbitro.
L’art. 813ter disciplina la responsabilità degli arbitri per danni causati alle parti determinata da dolo o
colpa grave. Possiamo mettere in evidenza il parallelismo con le norme che riguardano la responsabilità
civile dei giudici. Tuttavia, a differenza di quanto specificato per gli arbitri, la responsabilità per colpa grave
dei giudici ha una specifica declinazione, consistendo nella manifesta violazione della legge o del diritto UE
o anche nel travisamento dei fatti o delle prove o nell’affermazione dell’esistenza di un fatto la cui esistenza
è incontestabilmente esclusa dagli atti del procedimento (o nell’ipotesi inversa). Questo è il frutto delle più
recenti modificazioni della legge sulla responsabilità civile dei magistrati (l. 117/1988).
Sempre con riferimento agli arbitri, l’art. 814 parla dei diritti degli arbitri e, in particolare, il riferimento è
al rimborso delle spese e all’onorario per l’opera prestata. Il riferimento è qui ai regolamenti arbitrali, in cui i
compensi degli arbitri sono regolamentati in maniera specifica, come del resto i costi del procedimento che si
articolano in base a scaglioni.
Il procedimento.
L’analisi delle norme mette in evidenza la grande autonomia lasciata alle parti nella determinazione dello
svolgimento del procedimento, a partire dall’individuazione della sede dell’arbitrato (ovviamente nel
territorio della Repubblica).
Se le parti non hanno determinato la sede dell’arbitrato, ai sensi dell’art. 816 questa è nel luogo in cui è stata
stipulata la convenzione di arbitrato. Ciò non significa, peraltro, che gli arbitri debbano sempre
necessariamente riunirsi in tale sede, potendo anche svolgere la loro attività in luoghi diversi dalla sede
dell’arbitrato e anche all’estero (ult. comma).
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
Un altro elemento che le parti possono determinare liberamente o, se non lo fanno in prima persona, gli
arbitri possono determinare riguarda la lingua dell’arbitrato e la disciplina del procedimento.
È molto importante nell’art. 816bis la norma che afferma l’obbligo di attuazione del principio del
contraddittorio. Gli arbitri devono, infatti, concedere alle parti “ragionevoli ed equivalenti possibilità di
difesa” (c.d. parità delle armi). La norma è importante perché uno degli elementi che concretizzano questa
equipollenza tra arbitrato e giurisdizione statale è proprio il rispetto di una delle norme fondamentali del
nostro ordinamento, ossia il principio del contraddittorio.
La norma prosegue facendo riferimento alla possibile assistenza dei difensori.
L’art. 816ter detta poi le disposizioni in tema di istruzione probatoria. La norma non presenta nessuna
particolare difficoltà.
Siamo dispensati dall’interpretazione degli artt. 816quater e quinquies. Tendenzialmente si suole dire che le
varie parti si devono polarizzare attorno agli interessi. Il problema è particolarmente complesso è Silvestri
non vuole che perdiamo tempo a cercare di capire le sofisticazioni dell’arbitrato multiparte.
Proseguendo nell’analisi delle norme, interessante è l’art. 818, il quale afferma che gli arbitri non possono
concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge. La “diversa
disposizione di legge” nel nostro ordinamento non esiste, tant’è che quando abbiamo analizzato la disciplina
dei provvedimenti cautelari abbiamo visto che per l’individuazione competente vi sono delle disposizioni
apposite che riguardano proprio il giudizio arbitrale. Nella normativa italiana, la potestà cautelare spetta
solamente al giudice. Non è così in altri ordinamenti che seguono la legge-modello Uncitral, in cui anche gli
arbitri possono concedere misure cautelari.
Nell’art. 817 – rubricato “Eccezione di incompetenza” – il primo comma fa riferimento a una espressione
tedesca, ossia la kompetenz-kompetenz. Secondo questa espressione gli arbitri sono giudici della propria
competenza, quindi, nel caso in cui venga sollevata un’eccezione di incompetenza nel procedimento
arbitrale sono gli arbitri stessi a pronunciarsi.
Il secondo comma, in maniera un po’ criptica, prevede che la disposizione si applichi anche se i poteri degli
arbitri sono contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del giudizio. Silvestri
non sa dirci a cosa si riferisca questa “contestazione”, ma magari studiando il manuale diventeremo
abilissimi nel comprendere il significato di questa norma.
L’eccezione di competenza deve essere sollevata subito. La norma, infatti, prosegue dicendo che “La parte
che non eccepisce nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi per
inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato, non può per questo motivo impugnare il
lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile”. È, quindi, indispensabile un’eccezione di incompetenza
tempestiva, al fine di non trovarsi preclusa la possibilità di impugnare il lodo per incompetenza sotto il
profilo dell’invalidità della clausola arbitrale.
L’art. 819ter disciplina i rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria. Per ragionare sul tema è necessario
partire dall’ultimo comma, secondo il quale “In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere
proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l’invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato”. Se
noi leggiamo la norma a contrario capiamo che, se non è già pendente un procedimento arbitrale, è possibile
proporre davanti ad un giudice una domanda di accertamento volta a far dichiarare l’invalidità o l’inefficacia
di una convenzione di arbitrato. Perché si dovrebbe proporre una domanda di questo genere? Perché una
volta che si disponga di una sentenza che dichiara l’invalidità o l’inefficacia della convenzione di arbitrato,
nel caso in cui l’avversario tenti di iniziare un procedimento di questo tipo si ha uno strumento che esclude
tassativamente la possibilità che l’arbitrato prosegua. Non si può invece bloccare un procedimento già
iniziato.
Il primo comma stabilisce che “La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa
davanti al giudice”. Ciò significa che, in relazione a una medesima controversia, la procedura giudiziaria e
quella arbitrale possono (almeno temporaneamente) coesistere. Naturalmente, noi sappiamo che se c’è una
convenzione di arbitrato la giurisdizione è esclusa. Qui viene in considerazione il seguito del primo comma
in cui si dice che “L’eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve
essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell’eccezione
esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio”. Supponiamo che,
in relazione alla medesima controversia, una parte abbia instaurato un procedimento arbitrale e l’altra un
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
normale giudizio davanti all’autorità giudiziaria. La parte che intende far valere la convenzione arbitrale e
quindi bloccare la prosecuzione del giudizio ordinario deve sollevare un’eccezione di incompetenza nella
prima difesa, ossia a pena di decadenza nella comparsa di risposta. Naturalmente, quando questa eccezione è
sollevata, trattandosi di una questione preliminare di rito, il giudice dovrà ovviamente pronunciarsi con
sentenza. Contro questa sentenza è esperibile il regolamento di competenza ex artt. 42 e 43.
Nel 2013 il secondo comma della norma è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui escludeva
l’applicabilità della c.d. translatio iudicii ai rapporti tra arbitrato e processo (art. 50). Nel momento attuale,
quindi, nel caso in cui venga dichiarata la giurisdizione del collegio arbitrale a danno del giudice dello Stato,
si verifica un fenomeno equivalente alla translatio iudicii. In sostanza, è possibile che gli effetti sostanziali e
processuali della domanda non vengano meno se la causa viene riassunta tempestivamente (nel termine
indicato dalla sentenza di regolamento di competenza), pena l’estinzione del giudizio. Questo vale in
entrambe le direzioni.
È necessario un accenno anche all’art. 819. Secondo la norma – “Questioni pregiudiziali di merito” – “Gli
arbitri risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia,
anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano
essere decise con efficacia di giudicato per legge”. Se le questioni sono ricomprese in materie che possono
essere oggetto di convenzione d’arbitrato e vi è un’istanza di una parte, queste sono decise con efficacia di
giudicato; se non sono comprese nella convenzione d’arbitrato, invece, è necessario il consenso di tutte le
parti.
È un meccanismo che abbiamo già incontrato studiando nella prima parte l’art. 34 sugli accertamenti
incidentali. Secondo la disposizione, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario
decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla
competenza di un giudice superiore, il giudice “rimette tutta la causa a quest’ultimo, assegnando alle parti
un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui”. Altrimenti, si tratta di questioni che
vengono decise incidenter tantum, cioè per passare alla decisione sul merito.
Questo principio si applica anche nell’arbitrato e per questioni che per loro natura non potrebbero essere
oggetto di convenzione d’arbitrato. Anzi, a maggior ragione, per questa loro impossibilità di essere parte di
tale convenzione, esse devono essere decise incidenter tantum. Tuttavia, se si tratta di questioni che per legge
devono essere decise con efficacia di giudicato, come ad esempio se si tratti di questioni di stato, la decisione
con efficacia di giudicato richiede l’istanza di tutte le parti.
L’arbitrato amministrato.
Prima di parlare dell’efficacia del lodo e delle sue impugnazioni possiamo fare un breve cenno relativamente
agli artt. 832 e ss. Queste norme disciplinano l’arbitrato secondo i regolamenti precostituiti. La tendenza
maggioritaria è quella di svolgere l’arbitrato presso un’istituzione arbitrale. Questo implica l’adozione del
regolamento approvato da quell’istituzione arbitrale, la possibilità di avvalersi di tutto l’apparato logistico
dell’istituzione arbitrale e anche una ragionevole previsione dei costi, proprio perché i regolamenti arbitrali
consentono di fare una previsione dei costi.
Nel caso in cui vi sia contrasto tra la convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento, prevale la
convenzione.
I regolamenti arbitrali sono perfettamente in linea con le norme del codice di procedura civile, anzi, talvolta
richiedono qualcosa di più. Possiamo fare l’esempio del problema della disclosure degli arbitri, ossia
dell’autocertificazione riguardante la loro indipendenza e imparzialità che è richiesta da moltissime
istituzioni arbitrali, ma non dal codice.
Una norma stranamente collocata in questa parte, ma ha una portata generale è l’art. 834, riguardante le
norme applicabili al merito. L’autonomia delle parti si manifesta non solo in relazione alla scelta delle norme
di procedura, che possono essere o le norme del codice, o le norme del regolamento arbitrale, o anche norme
diverse, ma anche in relazione alle norme applicabili al merito della controversia. Le parti possono anche
decidere che il merito, e quindi la fondatezza della domanda, siano valutati o alla luce del diritto sostanziale
italiano, o alla luce di una legge diversa. Questo nel caso in cui gli arbitri vengano incaricati di decidere
secondo diritto. Ma come dice lo stesso articolo 834, gli arbitri possono essere incaricati di pronunciare come
amichevoli compositori, quindi secondo equità. È interessante l’ultima parte del primo comma dell’art. 834,
dove si dice che ove le parti non provvedano, si applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
collegato. Questo riguarda soprattutto gli arbitrati internazionali, in cui molto spesso il diritto sostanziale
applicabile è il diritto del luogo in cui è stato stipulato il contratto, ma può anche essere il diritto di un paese
terzo.
Tornando al discorso dei regolamenti arbitrali, abbiamo detto che in genere la scelta fatta dalle parti è quella
dell’arbitrato amministrato. Più rara è la previsione del c.d. arbitrato ad hoc, quindi di un arbitrato che si
svolge secondo regole specificamente dettate dalle parti per quella specifica controversia.
Il lodo.
Vi sono diversi articoli sul lodo, ma si tratta di questioni che non pongono particolari problemi e sulle quali
in sede d’esame nessuno ha mai insistito più di tanto, perché si tratta di meccanismi tecnici che diventano
particolarmente familiari a chi si occupa specificamente di arbitrato. A Silvestri interessa che abbiamo una
visione generale.
Le norme rilevanti sono l’art. 824bis (“Efficacia del lodo”) e l’art. 825 (“Deposito del lodo”).
L’art. 824bis afferma che l’efficacia del lodo dalla data dell’ultima sottoscrizione coincide con l’efficacia di
una sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria, salvo uno specifico effetto, ossia l’efficacia esecutiva.
Il lodo ottiene efficacia esecutiva mediante il deposito da effettuarsi, insieme con l’atto contenente la
convenzione di arbitrato, nella cancelleria del tribunale nel cui ha sede l’arbitrato. Il tribunale concede il c.d.
exequatur con decreto, dopo aver verificato la regolarità formale del lodo. Il controllo quindi non è un
controllo di sostanza, non potendo il tribunale invalidare il lodo in questa sede ritenendo che il suo contenuto
abbia dei problemi.
L’art. 826 riguarda la correzione del lodo, assolutamente parallelo all’art. 287 in tema di correzione per errori
materiali o di calcolo.
Le impugnazioni.
La peculiarità dell’ordinamento italiano è data dal fatto che le possibilità di impugnativa del lodo sono
davvero molte.
Ai sensi dell’art. 827, le possibili impugnazioni sono tre: nullità, revocazione e opposizione di terzo.
Per quanto riguarda l’impugnazione per nullità, tutti i manuali lamentano la carenza di dettagli da parte del
legislatore, in quanto si parla semplicemente del fatto che l’impugnazione per nullità si propone con atto di
citazione dinanzi alla Corte d’appello nel cui distretto ha sede l’arbitrato, senza dire nulla sul procedimento.
La dottrina maggioritaria ritiene che, nonostante il fatto che l’impugnazione per nullità si proponga davanti
alla Corte d’appello, le norme da seguire siano quelle in materia di giudizio di primo grado, quasi che il
giudizio arbitrale fosse stato una sorta di prova generale. I termini di proposizione indicati dall’art. 828 sono
il solito termine breve – novanta giorni dalla notificazione del lodo – e il termine lungo – un anno dalla data
dell’ultima sottoscrizione del lodo –.
Le cause di nullità sono ben dodici. Importanti sono il n. 9 sull’inosservanza del principio del contraddittorio
nel regolamento arbitrale e il n. 11 quando il lodo contiene disposizioni contraddittorie. Si tratta di casi
tassativi, in quanto l’impugnazione per nullità è a critica vincolata.
L’art. 829 specifica, inoltre, due cose importanti. La prima è che la parte “che ha dato causa a un motivo di
nullità, o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una
regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il
lodo”. Inoltre, l’impugnazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa solo se
espressamente prevista dalle parti o dalla legge, mentre è sempre ammessa l’impugnazione del lodo per
violazione dell’ordine pubblico.
Per quanto riguarda la decisione dell’impugnazione è necessario fare una distinzione. In linea di principio, la
corte d’appello non solo elimina il lodo nel caso in cui lo consideri nullo, ma procede anche alla decisione
nel merito, quindi la pronuncia della corte ha efficacia rescindente e rescissoria (art. 830, secondo comma),
salvo che le parti abbiano previsto diversamente nella convenzione d’arbitrato. In tutti i casi non
espressamente previsti dall’art. 830, la decisione della Corte ha una mera efficacia rescindente. In questo
caso viene in considerazione il comma successivo: “Quando la corte d’appello non decide nel merito, alla
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
lOMoARcPSD|6975046
controversia si applica la convenzione di arbitrato, salvo che la nullità dipenda dalla sua invalidità o
inefficacia”. Qui occorre fare riferimento alla causa per cui la nullità è stata dichiarata. Se essa non ha niente
a che vedere con l’inefficacia o l’invalidità della clausola arbitrale, questa continua ad essere operativa,
quindi, dopo l’annullamento del primo lodo le parti potranno decidere di far decidere la stessa controversia
da un altro collegio arbitrale. Viceversa, quando la declaratoria di nullità del lodo è stata pronunciata per
ragioni che hanno a che fare con la nullità o inefficacia della convenzione di arbitrato, occorrerà che la
domanda venga proposta davanti al giudice ordinario.
Per quanto riguarda la revocazione e l’opposizione di terzo non c’è nulla da dire, in quanto si tratta delle
medesime impugnazioni esperibili contro un’ordinaria sentenza.
Scaricato da Debora Di Perna (deboradiperna@gmail.com)
Potrebbero piacerti anche
- Il custode giudiziario nelle esecuzioni immobiliariDa EverandIl custode giudiziario nelle esecuzioni immobiliariNessuna valutazione finora
- Procedura Civile (Parte 2)Documento142 pagineProcedura Civile (Parte 2)Debora Di PernaNessuna valutazione finora
- Appunti Diritto Processuale Civile MandrioliDocumento157 pagineAppunti Diritto Processuale Civile MandriolikinkyersNessuna valutazione finora
- Procedimenti CD A Cognizione Sommaria Contrapposti Al Processo A CognizioneDocumento12 pagineProcedimenti CD A Cognizione Sommaria Contrapposti Al Processo A CognizioneDavide FragioneNessuna valutazione finora
- Domanda GiudiceDocumento14 pagineDomanda GiudiceDavide FragioneNessuna valutazione finora
- Procedura Civile - Luiso Libro 1Documento48 pagineProcedura Civile - Luiso Libro 1ebrtzNessuna valutazione finora
- DIRITTO PRIVATO - OdtDocumento14 pagineDIRITTO PRIVATO - OdtAnonymous YL9b3qNessuna valutazione finora
- Riassunto - Elementi Di Diritto Civile - CaterinaDocumento27 pagineRiassunto - Elementi Di Diritto Civile - CaterinaAlessia PlanoNessuna valutazione finora
- Diritto Privato AppuntiDocumento21 pagineDiritto Privato AppuntiSteve PagliaroNessuna valutazione finora
- Appunti PROCEDURA Civile 25/10Documento8 pagineAppunti PROCEDURA Civile 25/10Giovanna ScolloNessuna valutazione finora
- Diritto Processuale CivileDocumento114 pagineDiritto Processuale CivileJackBrigaNessuna valutazione finora
- Diritto Processuale Civile Procedura Civile IIIDocumento83 pagineDiritto Processuale Civile Procedura Civile IIIvramin80Nessuna valutazione finora
- 8 Lezione 22 Ottobre 2020 PDFDocumento23 pagine8 Lezione 22 Ottobre 2020 PDFserena morlandoNessuna valutazione finora
- PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO, Questo Attualmente E' Disciplinato Dalla Costituzione eDocumento15 paginePRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO, Questo Attualmente E' Disciplinato Dalla Costituzione eDavide FragioneNessuna valutazione finora
- Atti ProcessualiDocumento9 pagineAtti Processualiagataleggieri1dNessuna valutazione finora
- DIRITTO ROMANO - A.A. 2019/2020 Prof. Mario GenoveseDocumento29 pagineDIRITTO ROMANO - A.A. 2019/2020 Prof. Mario Genoveserita condorelliNessuna valutazione finora
- Appunti Procedura Civile 13 - 18Documento31 pagineAppunti Procedura Civile 13 - 18Giovanna ScolloNessuna valutazione finora
- Diritto Processuale Civile PunziDocumento99 pagineDiritto Processuale Civile PunziMelodica MeccanicaNessuna valutazione finora
- 2 Situazioni Giuridiche SoggettiveDocumento8 pagine2 Situazioni Giuridiche SoggettiveLaura Martínez RamírezNessuna valutazione finora
- Procedura Civile 2Documento52 pagineProcedura Civile 2Rita CtNessuna valutazione finora
- Procedura Civile Verde 1 e Schemi VariDocumento49 pagineProcedura Civile Verde 1 e Schemi VariRaffaeleD.ArgentoNessuna valutazione finora
- Procedura Civile Lezione 4-1Documento12 pagineProcedura Civile Lezione 4-1arasiNessuna valutazione finora
- 2 Lezione Istituzioni Di Diritto Privato 5 10 2021Documento2 pagine2 Lezione Istituzioni Di Diritto Privato 5 10 2021alessandroNessuna valutazione finora
- Sbobine Lezioni Procedura Civile IIDocumento136 pagineSbobine Lezioni Procedura Civile IIValentinaNessuna valutazione finora
- Proc Civile - I II III Libro (Appunti)Documento131 pagineProc Civile - I II III Libro (Appunti)Erion Eri CikoNessuna valutazione finora
- PR - Civile 2020 SBOBINE 1 SEMESTREDocumento477 paginePR - Civile 2020 SBOBINE 1 SEMESTREOlena KarageorgiyNessuna valutazione finora
- Diritto Privato PDFDocumento226 pagineDiritto Privato PDFGiorgia ZaottiniNessuna valutazione finora
- DIRITTO CIVILE II - NIVARRA-convertitoDocumento90 pagineDIRITTO CIVILE II - NIVARRA-convertitoLoGalboMiriamNessuna valutazione finora
- 4 Lezione Di Diritto Privato 11 10 2021Documento3 pagine4 Lezione Di Diritto Privato 11 10 2021alessandroNessuna valutazione finora
- 1a Lezione (05.10.2021)Documento8 pagine1a Lezione (05.10.2021)Silvia FontanaNessuna valutazione finora
- 14) 2 AprileDocumento15 pagine14) 2 AprileFrNessuna valutazione finora
- Riassunto Luiso 1Documento181 pagineRiassunto Luiso 1Camilla De Pinto100% (1)
- Diritto Privato SbobineDocumento143 pagineDiritto Privato SbobineGian MarcoNessuna valutazione finora
- Diritto Processuale Civile 1 TuttoDocumento156 pagineDiritto Processuale Civile 1 TuttoErion Eri CikoNessuna valutazione finora
- 1 Parte Generale Diritto-Processuale-Civile-Riassunto-Procedura-Civile-Libro-Verde-I-Ult-EdDocumento93 pagine1 Parte Generale Diritto-Processuale-Civile-Riassunto-Procedura-Civile-Libro-Verde-I-Ult-EdFrancesca NataleNessuna valutazione finora
- La GiurisdizioneDocumento15 pagineLa GiurisdizioneleleNessuna valutazione finora
- Appunti Procedura Civile 7-12Documento30 pagineAppunti Procedura Civile 7-12Giovanna ScolloNessuna valutazione finora
- Mandrioli RiassuntoDocumento73 pagineMandrioli Riassuntoalteriuris100% (10)
- Paola LucarelliDocumento13 paginePaola LucarelliSpiderman8985Nessuna valutazione finora
- Docsity Procedura Penale Tonini Sintesi 2021 22Documento187 pagineDocsity Procedura Penale Tonini Sintesi 2021 22giovanni russoNessuna valutazione finora
- Docsity Preparazione Esame Procedura Civile I DondiDocumento92 pagineDocsity Preparazione Esame Procedura Civile I DondiMatt TorriNessuna valutazione finora
- Sbobine Diritto Privato 2020Documento124 pagineSbobine Diritto Privato 2020Silvy SannaNessuna valutazione finora
- Diritto PrivatoDocumento15 pagineDiritto PrivatoAdriana PiedraNessuna valutazione finora
- Riassunto Diritto Processuale Civile Parte GeneraleDocumento41 pagineRiassunto Diritto Processuale Civile Parte GeneraleGianmarco BrunoNessuna valutazione finora
- Seconda Parte Diritto Internazionale Privato e Processuale 2Documento25 pagineSeconda Parte Diritto Internazionale Privato e Processuale 2Emilio Plaza SerraNessuna valutazione finora
- Appunti Su Come Smontare L - Attuale Sistema Giuridico e Crearne Uno NuovoDocumento11 pagineAppunti Su Come Smontare L - Attuale Sistema Giuridico e Crearne Uno NuovoMauro NardoneNessuna valutazione finora
- Cosa È La Funzione GiurisdizionaleDocumento13 pagineCosa È La Funzione GiurisdizionaleAngelica Maria PellegrinoNessuna valutazione finora
- Le Fonti Del Diritto Processuale CivileDocumento3 pagineLe Fonti Del Diritto Processuale CivileleleNessuna valutazione finora
- Il ProcessoDocumento3 pagineIl ProcessoleleNessuna valutazione finora
- 9 MarzoDocumento13 pagine9 MarzoDavide FragioneNessuna valutazione finora
- Processo FormulareDocumento4 pagineProcesso FormulareTeresa GherardiNessuna valutazione finora
- Prescrizione e Decadenza DifferenzeDocumento5 paginePrescrizione e Decadenza Differenzewarren sabatiniNessuna valutazione finora
- Appunti Di Diritto Ed EconomiaDocumento72 pagineAppunti Di Diritto Ed EconomiaFrancesca GrecoNessuna valutazione finora
- Il Giudizio Di OttemperanzaDocumento15 pagineIl Giudizio Di OttemperanzaRosario AbateNessuna valutazione finora
- Il decreto ingiuntivo in ambito condominiale: Un'analisi giuridica dell'istituto passando dai doveri di una corretta contabilità dell'amministratore ai poteri del condomino di proporre opposizione.Da EverandIl decreto ingiuntivo in ambito condominiale: Un'analisi giuridica dell'istituto passando dai doveri di una corretta contabilità dell'amministratore ai poteri del condomino di proporre opposizione.Nessuna valutazione finora
- Riforma Orlando, la nuova prescrizione. Condanna appellata, poi assoluzione. La prescrizione è sospesa anche per 18 mesiDa EverandRiforma Orlando, la nuova prescrizione. Condanna appellata, poi assoluzione. La prescrizione è sospesa anche per 18 mesiNessuna valutazione finora
- SANZIONI AMMINISTRATIVE I presupposti, il ricorso e il giudizio di opposizione: Le sanzioni amministrative e il covid 19Da EverandSANZIONI AMMINISTRATIVE I presupposti, il ricorso e il giudizio di opposizione: Le sanzioni amministrative e il covid 19Nessuna valutazione finora
- 788804-b PeriziaDocumento30 pagine788804-b PeriziaEnzo MuscoNessuna valutazione finora
- Informazioni Su Questo LibroDocumento621 pagineInformazioni Su Questo LibroAlenka TabakovićNessuna valutazione finora
- Area Edificabile 550000 MQ Cologno Centro Perizia Dettagliata 263-15 - Pe - OK PDFDocumento15 pagineArea Edificabile 550000 MQ Cologno Centro Perizia Dettagliata 263-15 - Pe - OK PDFAndrea GiavenniNessuna valutazione finora
- (1831) Trattado Delle Nullità Di Diritto in Material Civile PDFDocumento351 pagine(1831) Trattado Delle Nullità Di Diritto in Material Civile PDFLuis M.R.Nessuna valutazione finora
- Vademecum Tutori-2Documento4 pagineVademecum Tutori-2frankynevin1Nessuna valutazione finora