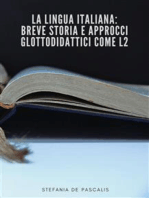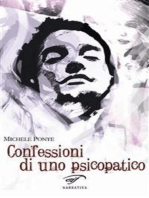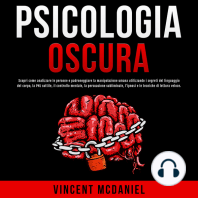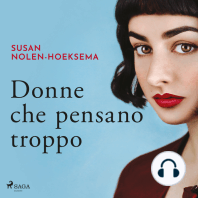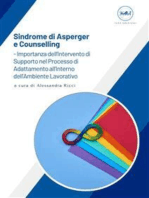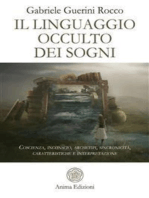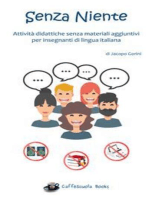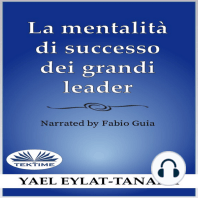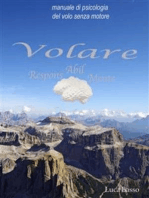Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Linguistica Italiana 2, Università Degli Studi Di Trieste
Caricato da
Emilio PolitoTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Linguistica Italiana 2, Università Degli Studi Di Trieste
Caricato da
Emilio PolitoCopyright:
Formati disponibili
Italiano 2 prof Ondelli
Lingua Italiana
Università degli studi di Trieste
37 pag.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
IL REPERTORIO DELL’ITALIANO
1) Di cosa è necessario tenere conto per definire il contesto situazionale?
Il contesto situazionale è l'insieme degli elementi extralinguisitici che hanno
un’influenza sulla comunicazione, sulla situazione linguistica. Secondo Jakobson il
contesto prevede la presenza di un emittente (colui che produce il testo) che
trasmette un messaggio (ciò che viene detto) a un destinatario (colui che lo riceve)
attraverso un codice (il sistema di trasmissione del messaggio, che deve essere
comune a emittente e destinatario) impostato su un canale (mezzo fisico usato per
trasmettere il testo; generalmente, per le lingue naturali, si tratta della scrittura o
dell’oralità). Il rumore inoltre consiste negli elementi di disturbo.
Halliday è il fautore di una tripartizione che considera i fattori contestuali che
influenzano l’atto comunicativo:
- field (campo), fa riferimento all’azione sociale che viene eseguita, all’ attività che
viene riconosciuta socialmente (pensiamo ad esempio alla compravendita, ovvero
un’azione sociale riconosciuta)
- tenor, ovvero chi partecipa a questa azione sociale, parlante di quale lingua, che
competenze possiede, età, sesso, …
- mode, ovvero come avviene questo scambio comunicativo, la differenza principale
è naturalmente quella tra oralità e scrittura.
2) Che differenza passa tra competenza linguistica tout court e competenza
comunicativa?
La competenza linguistica consiste nella conoscenza grammaticale e interiorizzata
che un parlante ha delle regole astratte della propria lingua materna
indipendentemente dal contesto.
La competenza comunicativa è invece la capacità di scegliere le soluzioni più adatte
per uno scambio comunicativo specifico, di cui si devono necessariamente considerare
i fattori contestuali che influenzano l’atto comunicativo, ovvero il FIELD (un’azione
sociale che viene eseguita; di solito un’attività generalmente riconosciuta
socialmente), TENOR (il partecipante all’azione sociale: lingua parlata, competenze
possedute, sesso, età, …), e del MODE (come avviene lo scambio comunicativo; di
solito oralità, scrittura), come teorizzato da Halliday.
Solo tenendo conto di questi fattori posso capire cosa sia la competenza comunicativa
in opposizione a quella linguistica: se basandoci soltanto su quest’ultima le due
seguenti frasi possono essere considerate corrette, facendo appello alla competenza
comunicativa ognuna è corretta solo in un determinato contesto comunicativo.
Mi è oltremodo difficile nascondere lo scarso interesse che per me riveste tale
argomento.
Che due balle!
3) Quali sono i cinque fattori che determinano la variazione linguistica?
Una teoria di successo soprattutto in Italia e nell’Europa continentale, è quella di
Coseriu, che elabora un sistema di prefissoidi di tipo classico per definire i fattori che
determinano il cambiamento della lingua:
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
diacronia: la variazi one della lingua lungo l’asse temporale (ora è normale usare
realizzare con il significato di “rendersi conto” ma prima nessuno lo avrebbe usato
in quell’accezione, infatti è un calco dall’inglese “to realize”)
diatopia: la variazione linguistica legata alla collocazione geografica dei parlanti,
anche all’interno dello stesso paese. L’Italia ha una diatopia altissima.
diafasia: la variazione del contesto situazionale in cui si inserisce l’atto
comunicativo; è una variazione pluridimensionale: essa infatti dipende sia dalla
variazione dei registri linguistici (ovvero dalla formalità), dati dal rapporto più o
meno prossimo tra emittente e ricevente, sia dall’attività sociale, intesa
principalmente come argomento (ad ogni attività sociale corrisponde un
determinato sottocodice, o lingua speciale, che implica specifiche scelte
morfologiche e sintattiche);
diamesia: variazione del mezzo di espressione (o canale) del messaggio. È stato
rilevato un avvicinamento tra scrittura e oralità nell’ultimo secolo.
diastratia: la condizione sociale dei parlanti la lingua varia in base alle differenze
culturali, al livello di scolarizzazione, ma anche alle differenze biologiche, come il
genere o l’età del parlante).
4) Cosa si intende in sociolinguistica per diacronia, diamesia, diasfasia,
diatopia e diastratia? Quali di queste dimensioni non sono contemplate
nello schema di Berruto e perché?
Diacronia: variazione linguistica nel corso del tempo
Diamesia: variazione linguistica relativa al mezzo di trasmissione, o canale, del
messaggio (scritto vs parlato)
Diafasia: variazione linguistica in base alla situazione comunicativa. È
pluridimensionale e tiene conto sia dell’argomento (uso di terminologia specifica o
cambiamento di registro) che del registro utilizzato (determinato dalla distanza tra
emittente e ricevente).
Diatopia: variazione linguistica in base alla collocazione geografica del parlante
Diastratia: variazione linguistica che tiene conto della condizione sociale dei parlanti
la lingua varia in base alle differenze culturali, al livello di scolarizzazione, ma anche
alle differenze biologiche, come il genere o l’età del parlante).
Le variazioni che non vengono prese in considerazione da Berruto sono quella
diatopica e diacronica. Il suo schema infatti è sincronico: la lingua viene analizzata
come un sistema chiuso in un determinato periodo di tempo, e la variante diatopica
viene data per scontata perché in nessuna zona italiana si parla un italiano
standard. Non esistono né una classe sociale né un luogo geografico dove si parli un
italiano standard.
5) Quali dimensioni di variazione Berruto considera imprescindibili
nell’esaminare qualunque testo in italiano? Perché?
Secondo Berruto, le dimensioni imprescindibili per analizzare qualsiasi testo in
italiano sono la diamesia, la diastratia, la diafasia. Non si può prescindere dalla
componente diamesica poiché qualsiasi realizzazione dell’italiano passa sempre
attraverso un canale, che può essere fonico-acustico o scritto. È necessario
considerare anche il fattore diastratico, poiché il tipo di lingua utilizzata da un
parlante dipende sempre da diversi parametri sociali quali l’età, il genere e il livello di
scolarizzazione; quest’ultimo determina anche la componente diafasica, poiché con
l’avanzare della scolarizzazione si imparano diversi registri linguistici e il loro uso in
base a diversi contesti e ai partecipanti allo scambio comunicativo.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
6) Illustrare il repertorio dell’italiano contemporaneo come definito da
Berruto nel 1987
Nel 1987, ne La sociolinguistica dell’italiano contemporaneo, Berruto propone uno
schema di tipo sincronico che descrive l’architettura e le variazioni dell’italiano
contemporaneo: le nove varietà linguistiche individuate vengono disposte lungo assi
complanari che individuano le tre dimensioni principali della variazione, ovvero la
diastratia (dal polo alto al polo basso / asse verticale), la diamesia (dallo “scritto
scritto” al “parlato parlato” / asse orizzontale) e la diafasia (dal polo formale-
formalizzato al polo informale / asse obliquo), che rappresentano un continuum. In
questo modello la dimensione diatopica viene considerata a priori e data per scontata
così come vengono ignorati i dialetti. All’origine non è presente nessuna varietà
perché non esiste una varietà di italiano NEUTRA.
Le prime due varietà individuate sono l’italiano standard letterario e il neo-
standard (o italiano regionale colto medio). Queste però tendono leggermente verso
l’alto e la sinistra per la diastratia e diafasia: sono formali, più scritte che parlate e
richiedono un certo livello di istruzione, oltre a un registro abbastanza alto. Questo
perché fino agli anni 80 il modello per l’italiano parlato è la letteratura, sono i testi
scritti.Il neostandard nasce dall’incontro tra lo standard letterario e l’italiano parlato, si
abbassa quindi in formalità, richiede un minore livello di scolarizzazione per la sua
gestione e si allontana dall’esclusività dello scritto.
Le altre varietà individuate, partendo dalla massima corrispondenza tra scritto,
formale e scolarizzazione sono: italiano formale aulico, italiano tecnico-
scientifico, italiano burocratico, (standard letterario, neostandard), italiano
parlato colloquiale, italiano regionale-popolare, italiano informale trascurato
e italiano gergale (gli ultimi due rappresentano dei sottocodici). Esiste anche un
sub-standard (caratteristiche espulse dallo standard, non accettabili nello standard).
Nel grafico manca l’aspetto diacronico perché Berruto fa una fotografia della
situazione dell’italiano degli anni 80 del 900’.
7) Quale è la differenza tra dilalia e diglossia? Perché Berruto definisce
dilalia la situazione italiana?
La diglossia è una particolare forma di bilinguismo, in cui coesistono due varietà di
lingua che si trovano in un rapporto gerarchico e complementare tra loro. Esiste una
varietà alta che corrisponde alla lingua standard, normativa e normalizzata nelle
grammatiche (quindi che si apprende a scuola), usata nello scritto e nei in contesti
formali e istituzionali (la liturgia, l’amministrazione, l’università, la maggior parte dei
mezzi di comunicazione…), e una varietà bassa acquisita spontaneamente dai
parlanti con l'esperienza diretta ovvero come prima lingua di socializzazione, riservata
ai contesti informali e alla comunicazione di tutti i giorni. Tra le due varietà non vi è
sovrapposizione, quindi quella alta non è mai usata nella comunicazione ordinaria e
non c’è stigmatizzazione sociale per chi sceglie di utilizzare la varietà bassa.
Esempi di diglossia sono rintracciabili in India e Svizzera (dove non c’è stigma sociale,
semplicemente le lingue sono usate in situazioni diverse). Sembrerebbe esserci la
medesima situazione in Italia (ci fu fino all’800), ma oggi è meglio parlare di dilalia.
La dilalia, una forma di bilinguismo endogeno a bassa distanza strutturale , è una
particolare forma di diglossia, in cui coesistono due distinte varietà linguistiche, ma
con parziale sovrapposizione: la lingua alta può infatti invadere il territorio della lingua
bassa, ma non può avvenire il contrario perché la varietà alta resta l’unica opzione
possibile in contesti formali e istituzionali. In molti casi c’è stigma sociale: la lingua
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
alta gode di più prestigio e la varietà bassa è considerata la varietà degli incolti, è
riservata a contesti bassi e condannata socialmente.
Berruto definisce quindi dilalia la situazione italiana, partendo dal presupposto per cui
il repertorio degli italiani è costituito dai due diasistemi dell’italiano e del dialetto.
Questi diasistemi non sono separati nettamente, poiché il diasistema dell’italiano
costituito dalle varietà più alte è aperto verso le varietà più basse (come mostrano ad
esempio l’italiano neo-standard e italiano regionale popolare), mentre il diasistema del
dialetto non può accedere alle varietà alte. Perciò la varietà alta dell’italiano sconfina
negli ambiti d’uso della varietà bassa, ma non viceversa: la varietà alta resta l’unica
disponibile nei contesti formali e istituzionali. Negli ultimi anni la situazione sta
cambiando, grazie alla nascita di enti locali che promuovono l’uso del dialetto.
8) Cosa intende Berruto per “continuum con addensamenti”? Fornire
qualche esempio.
Il concetto di continuum con addensamenti fa riferimento a un insieme di varietà
linguistiche caratterizzato dalla mancanza di confini netti tra una varietà e l’altra,
che anzi spesso si fondono e compenetrano l’una nell’altra. Proprio per questo le
varietà si individuano soltanto tramite i punti di addensamento, ossia i punti dove si
infittiscono i tratti linguistici caratterizzanti di quella varietà, dove si sovrappongono
diverse caratteristiche specifiche (italiano burocratico e tecnico-scientifico: parole
tecniche, tendenza all’ipotassi e periodare complesso, impersonalità, …); gli estremi
degli assi di Berruto rappresentano solo dei prototipi della lingua.
Lo stesso vale per l’opposizione scritto/parlato: esistono, ad esempio, testi orali ben
pianificati e accurati il cui registro è elevato, che assomigliano più a un testo scritto
(un discorso imparato a memoria ad esempio), e viceversa tesi scritti poco pianificati
che possono riprodurre le forme dell’orale (una mail poco importante).
Allo stesso modo sarebbe impossibile riconoscere un testo giuridico per la sola
presenza dell’imperfetto narrativo, che dovrà unirsi ad altre caratteristiche (le scelte
sintattiche e lessicali) per poter assegnare una varietà al testo.
9 ) Se gli assi dello schema di Berruto non individuano un gradatum ma un
continuum, come è possibile individuare i confini tra le varietà linguistiche?
Nonostante gli assi dello schema di Berruto non individuino un gradatum (in cui le
varietà sono almeno in parte discretizzabili, distinguibili) ma un continuum, è possibile
individuare i confini dell’uso della lingua grazie agli addensamenti, ossia i punti
lungo un asse in cui si infittiscono i tratti linguistici caratterizzanti, i nodi di
articolazione del continuum di varietà dell’italiano contemporaneo. Questi
addensamenti raggruppano tratti linguistici che possono appartenere ad una sola o a
più varietà. Proprio per questo per determinare le varietà è necessaria la compresenza
di più caratteristiche. Per fare qualche esempio, sia l’italiano burocratico che il tecnico
scientifico tendono alla spersonalizzazione (“L’esperimento ha avuto luogo/La
procedura si espleterà”); realizzazioni come il che polivalente, l’uso del clitico ci e del
participio presente appartengono tanto all’italiano giuridico quanto a quello
amministrativo; tra l’italiano dell’uso medio e nell’italiano parlato abbiamo in comune
le dislocazioni (ordine marcato delle parole).
10) Cosa si intende in sociolinguistica per varietà, registro, lingua speciale,
gergo, modalità dell’uso della lingua?
- Varietà linguistica: è definita dalle diverse attualizzazioni, ognuna distinta per
alcuni tratti dalle altre, in cui si manifesta concretamente il sistema linguistico nei suoi
impieghi presso una comunità.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
- Registro: livello di formalità della lingua. Si tratta di un livello espressivo proprio di
una situazione comunicativa (registro familiare, burocratico, giornalistico); determina
la variazione diafasica della lingua e la competenza comunicativa del parlante;
- Lingua speciale: anche detta sottocodice, è una varietà funzionale di lingua
naturale usata da un gruppo particolare di persone, più ristretto della totalità dei
parlanti, per soddisfare i bisogni comunicativi (in primo luogo quelli referenziali. Infatti,
se per il gergo lo scopo è rafforzare l’identità di gruppo e non farsi capire da chi non vi
appartiene, per il sottocodice questo è una conseguenza: lo scopo dei sottocodici è
semplicemente quello di essere più precisi possibile) di quel settore specialistico. È
una variante caratterizzata dall’uso di forme lessicali e sintattiche specifiche
(terminologie esclusive di quel settore o termini comuni ad altri settori ma usati con
accezione diversa). L’obiettivo è quello di rendere più veloce la comunicazione tra i
mem bri del gruppo in cui è utilizzata; comprende sia le varietà d’uso più ristretto e
specialistico, con un frequente uso di codici non verbali (es. formule cliniche;
linguaggio della chimica) che quelle meno rigidamente codificate, caratterizzate da un
limitato grado di specializzazione e quindi accessibili a un’ampia area d’utenza
(linguaggio televisivo, politico, giornalistico ecc.). In quest’ultimo caso è anche usata
la denominazione di linguaggi settoriali.
- Gergo: varietà colloquiale-espressiva propria di categorie o gruppi particolari di
utenti. È una forma di linguaggio utilizzata come mezzo per manifestare una sorta di
polemica contro la cultura standard, per affermare e rafforzare l’appartenenza al
gruppo e per impedire la partecipazione alla comunicazione ai membri estranei al
gruppo (è infatti tipicamente parlato dai criminali o dai soldati); oltre ai tratti
dell’italiano informale trascurato, prevede la sistematica sostituzione di numerosi
vocaboli della lingua con altri di origine straniera, o anche indigeni ma con
spostamento di significato oppure originati da deformazioni linguistiche o ancora
sostituiti da locuzioni metaforiche o allusive.
- Modalità dell’uso della lingua: è il fenomeno secondo cui la varietà linguistica
utilizzata non è determinata dall’argomento trattato nel testo, ma su base pragmatica,
ovvero dalla sua funzione e dalle condizioni in cui viene creato. Ad esempio, nei
giornali si trattano svariati argomenti, ma il linguaggio utilizzato resta sempre quello
giornalistico, dettato dal fatto che i giornalisti hanno poco tempo per scrivere e
devono rispettare certi vincoli.
11) Come si compone il repertorio degli italiani secondo Berruto?
Con “repertorio degli italiani” si intende l’insieme delle risorse e varietà linguistiche,
anche appartenenti a lingue o dialetti diversi, a disposizione della comunità linguistica
italiana, di chi vive in Italia. Berruto distingue 4 diverse varietà linguistiche
appartenenti al repertorio degli italiani:
1. L’italiano neo-standard (o regionale colto medio), marcato in diatopia,
che costituisce la larga base comune degli impieghi dell’italiano da ritenere
normali presso parlanti colti;
2. L’italiano regionale popolare, che risulta marcato non soltanto in diatopia
(contiene tratti sub-standard, è permeato da elementi locali e da interferenze con il
dialetto), ma anche in diastratia, in quanto varietà popolare, perciò tipica di
parlanti poco colti o incolti;
Partendo dal presupposto che l’Italia si trova in una situazione di dilalia (italiano e
dialetto coesistono, con sovrapposizione dell’italiano sui domini del dialetto),
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
generalmente il repertorio degli italiani non si limita all’italiano: sono infatti
individuabili due diasistemi, quello del dialetto e quello dell’italiano. Dunque, oltre alle
varietà dell’italiano, nel diasistema dialettale si distingue tra:
- dialetto italianizzato, in cui c’è un contatto tra italiano e dialetto, con prestiti
dall’italiano quando in dialetto mancano i termini per definire il concetto (non si ha
la creazione di una nuova lingua, in quanto la morfosintassi del dialetto resta
invariata. Si possono verificare fenomeni di code-switching e code-mixing); è il
meno rustico, usato nei grandi centri urbani e anche per parlare di concetti “alti”;
- dialetto locale rustico, che presenta la dialettizzazione di elementi lessicali ed è
spesso incomprensibile.
Quello che è comune a tutte le varietà è il common core, il nucleo linguistico
comune, che ci permette di comunicare. Gran parte del materiale linguistico usato dai
parlanti in realtà è condiviso: c’è una lingua comune che lega tutti gli italiani.
12) Quali sono le variazioni intervenute nel repertorio dell’italiano secondo
Antonelli al termine del primo decennio del XXI secolo?
A seguito dei grandi cambiamenti avvenuti tra gli anni ’80 (ovvero il primo momento
in cui si possa dire che la lingua italiana fosse degli italiani), e il nuovo secolo, n el
2010 Antonelli propone una nuova architettura dell’italiano contemporaneo, che
presenta delle variazioni rispetto al modello proposto da Berruto nel 1987 ne “La s
ociolinguistica dell’italiano contemporaneo”.
Innanzitutto si riducono le distanze tra le diverse varietà di italiano,
determinando un maggiore affollamento della zona centrale del grafico e un
abbassamento dei registri alti o viceversa (fenomeno di minore rilevanza)
innalzamento dei registri bassi; la causa principale sono i mezzi di comunicazione di
massa che hanno portato a un rovesciamento della situazione passata, in cui
mancavano termini per parlare di argomenti quotidiani, aggiunto al fatto che la
lingua inglese sia ormai imposta come lingua franca e in molti contesti di registro
elevato, di formalità, oggi si utilizza spesso l’inglese;
poi la diatopia entra nello schema, non viene più considerata come una
variazione a priori, ma viene posta in primo piano, nel quadrante alto della diastratia/
diafasia e anche della diamesia, invadendo il settore della lingua scritta;
l’italiano standard con un pronuncia assolutamente non marcata scompare,
persino per i giornalisti e gli attori: siamo tutti parlanti di una varietà regionale.
Scompare l’italiano letterario: chi vuole scrivere in modo aulico scrive con uno
stile giornalistico misto a un registro burocratico. Dunque, Antonelli vede il
faro nella scuola: l’italiano standard diventa l’italiano scolastico, e sale nel
quadrante alto dello schema, avvicinandosi sensibilmente all’italiano aulico-formale.
La scuola infatti continua a proporre un italiano abbastanza distante da quello parlato
e fortemente basato sull’italiano letterario standard (differenza tra norma e norma
interiorizzata);
l’italiano neo-standard o dell’uso medio diventa l’italiano di tutti i giorni,
anche nello scritto e un modello;
l’italiano tecnico-scientifico è promosso a varietà di maggiore prestigio e
l’italiano burocratico viene sostituito con quello aziendale, anche detto
corporatese: è l’italiano delle grandi realtà economiche, ricco di anglicismi, a metà
tra il burocratico ed il tecnico-scientifico, oggi il più prestigioso;
vengono distinti l’italiano regionale e quello popolare, che nel modello di
Berruto costituivano una sola varietà: il primo sarebbe quello che parliamo tutti, il
secondo starebbe scomparendo perché è quello che è stato imperfettamente appreso
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
da chi ha come madrelingua il dialetto e ha frequentato poco la scuola (italiano
fortemente permeato da tratti dialettali, sub-standard di una precisa zona
geografica).;
si avvicinano fino a sovrapporsi l’italiano regionale, l’italiano parlato
colloquiale e l’italiano informale trascurato; l’italiano parlato colloquiale si
avvicina al centro perché non è più tanto marcato da informalità ma può essere
parlato in quasi tutti i contesti;
compare una nuova varietà spiccatamente informale, l’italiano digitato, collocato
nel quadrante dell’italiano parlato: è il risultato della comunicazione mediata dai
computer (fenomeno iniziato nel nuovo secolo che vede gli italiano trasformarsi in
scrittori di massa): è un italiano scritto ma ha molte caratteristiche in comune con
l’oralità, è informale e diastraticamente trasparente.
13) In cosa consiste la variaz ione in diatopia? Fornire qualche esempio
Per variazione diatopica si intende la variazione linguistica su base geografica.
Quella italiana è stata per lo più studiata sotto l’etichetta di italiano regionale (o di
varietà regionale di italiano). In genere la dimensione diatopica è tanto più accentuata
quanto più è vasta l’estensione spaziale della lingua (si pensi alle differenze tra il
British English e l’angloamericano), ma non sempre è così, come dimostra appunto il
caso dell’italiano, dove la variazione geografica, molto accentuata, [è da rapportare
alla complessità della situazione dialettale] è da rapportare ad un’estensione spaziale
della lingua non molto elevata.
Un esempio di variazione diatopica è “…praticamente io sto a cercà ‘na sfitinzia”,
marcato in diatopia in quanto evidentemente è laziale o romano come provenienza e
nessun settentrionale pronuncerebbe questa frase (parola di moda negli anni '80 per
indicare una ragazza a Roma).
14) In cosa consiste la variazione in diamesia? Fornire qualche esempio
Per variazione diamesica si intende la capacità di una lingua di variare a seconda del
mezzo o canale adottato, sia esso scritto o parlato. L’Italia giunse abbastanza
precocemente a forme scritte più o meno unitarie. Lo testimoniano la rapida e
massiccia circolazione nazionale di testi quali la Divina Commedia, il Decameron e il
Canzoniere petrarchesco già nel Trecento, divenuti subito, soprattutto gli ultimi due,
modelli da imitare, e la realizzazione di fortunate opere grammaticali e lessicografiche
(la prima edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca risale al 1612), che
hanno canonizzato gli usi scritti, prendendo il fiorentino trecentesco come base per
l’italiano standard.
All’opposto, a una lingua parlata più o meno unitaria in Italia si arrivò soltanto dopo
l’Unità, in ritardo, dunque, rispetto ad altri paesi europei e, secondo molti, non prima
dello sviluppo della televisione, verso la metà del Novecento [(De Mauro 1993: 353)].
Lo scritto era appannaggio delle persone colte, per via dell’esteso analfabetismo che
caratterizzò l’Italia fino a parte del secolo scorso, e d’uso prevalentemente letterario e
formale. La gran parte degli usi parlati avveniva nei vari dialetti. Alcune varietà
diamesiche sono molto riconoscibili per via di formule rituali e parole deputate. Tra
queste, la conversazione telefonica, che segue schemi ricorrenti specialmente nelle
parti iniziale e conclusiva: basti pensare al segnale discorsivo fatico “Pronto”, in
apertura di telefonata, o a formule come: “chi parla?; chi lo desidera?; attenda in
linea; glielo passo subito”; ecc. Anche lo stile epistolare segue formule precise, almeno
per quanto riguarda l’intestazione della lettera, i saluti iniziali e finali.
La frase “…praticamente io sto a cercà ‘na sfitinzia”, ad esempio, è marcata dal punto
di vista diamesico poiché è più probabile trovarla nel parlato.
15) In cosa consiste la variazione in diafasia? Fornire qualche esempio
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
La variazione diafasica si manifesta attraverso le diverse situazioni comunicative e
consiste nei differenti modi in cui vengono realizzati i messaggi linguistici in
relazione ai caratteri dello specifico contesto presente nella situazione. I
fattori che intervengono a costituire e definire una situazione comunicativa, e che
sono in grado di determinare o influenzare nei suoi vari aspetti la maniera in cui la
lingua vi viene impiegata, sono molteplici e complessi, ma sono stati ricondotti da
Halliday (1978) a tre categorie fondamentali: il campo (field), il tenore (tenor) e il
modo (mode). Il campo comprende come un aspetto particolarmente importante
l’argomento del discorso, ciò di cui si parla (o si scrive). Il tenore è costituito dal
rapporto in cui si pongono i partecipanti all’interazione comunicativa e dai ruoli sociali
e comunicativi reciproci che essi rivestono o assumono nella situazione; si manifesta
principalmente nel grado di distanza sociale e comunicativa fra i partecipanti, ed è
connesso con le finalità che questi hanno. Comprende anche le manifestazioni
linguistiche della cortesia. Il terzo fattore, il modo, è dato dal mezzo o canale fisico
attraverso cui passa la comunicazione e dal tipo di contatto interazionale che vi si
realizza. L’interazione fra campo, tenore e modo dà luogo alle differenti opzioni che si
attualizzano in ogni concreta situazione comunicativa: dare del «tu» (opzione di
tenore) scrivendo una lettera (opzione di modo) di felicitazione per la laurea (opzione
di campo); dare del «Lei» (tenore) chiedendo in classe (modo) una spiegazione
all’insegnante di matematica (campo), e via dicendo, in tutta una gamma di possibilità
di impiego della lingua nella illimitata differenziazione delle singole situazioni
comunicative.
La frase “…praticamente io sto a cercà ‘na sfitinzia”, per esempio, è marcata come
livello basso in diafasia perché è evidentemente una frase viene utilizzata solo in
contesti familiari e amichevoli.
16) In cosa consiste la variazione in diastratia? Fornire qualche esempio
Le categorie più spesso utilizzate per fare emergere la variazione diastratica sono di
due tipi: il primo fa riferimento a fattori biologici (tra cui, oltre all’età, anche il
sesso), il secondo a caratteristiche sociali (che possono essere le più varie e sono
strettamente legate al tipo di organizzazione sociale). La considerazione per cui la
variazione linguistica è sempre legata e intrecciata a fattori sociali può valere anche
per ciò che riguarda l’età. Le giovani generazioni sono sempre state considerate un
fattore di innovazione di una comunità; all’opposto gli anziani, specie se con basso
livello di istruzione, sono visti come un elemento di conservazione delle forme
linguistiche più arcaiche. Anche la differenza di sesso è un aspetto significativo:
l’italiano delle donne in genere ha meno disfemismi e tecnicismi ed è caratterizzato da
un orientamento interazionale e interpersonale. Un esempio di variazione sociale è
l’italiano popolare, i cui tratti tipici sono riconducibili da una parte all’interferenza con
il dialetto (ad es., casi di trapasso di classe di parole o di genere grammaticale: la sale,
lo scatolo; oppure l’uso di alcune perifrasi aspettuali: sono dietro a finire il lavoro) e
dall’altra a fenomeni di semplificazione (ad es., la cosiddetta concordanza ad sensum,
come in la gente uscivano, il che polivalente, come in “la ragazza che le ho dato un
bacio”). La parola “riprovevole”, ad esempio, è marcata come medio-alta in distratia,
perché è necessario avere una certa competenza linguistica per conoscerla. La frase
“…praticamente io sto a cercà ‘na sfitinzia”, invece, è marcata come medio bassa in
diastratia, perché bisogna conoscere l’italiano per pronunciarla, ma evidentemente
non aver studiato chissà quanto per produrla.
17) Fornire qualche esempio di varietà che possono essere individuate in
diafasia, diamesia e diastratia.
18) Illustrare come per definire l’italiano “medio” si possa fare riferimento
ai concetti di neutralità (non marcatezza) del registro, correttezza
grammaticale e rilevanza statistica.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
Questa nuova variante di italiano detta “dell’uso medio”, identificata per la prima
volta da Sabatini in un articolo del 1985, è diversa dall’italiano letterario e scolastico,
perché sebbene in parte consista nel recupero di tratti sempre esistiti nella storia
dell’italiano (ad esempio la dislocazione a sinistra che troviamo già nel Placito
Capuano), sono anche rintracciabili innovazioni determinate dal fatto che la lingua
letteraria scritta abbia iniziato ad essere utilizzata oralmente (la sintassi molto più
semplice del parlato, ad esempio).
Berruto invece nell’87, nella sua Sociolinguistica, parla di italiano “neo-standard”,
etichetta poi abbandonata perché “neo-standard” farebbe pensare a un nuovo
modello di riferimento, ma il concetto è errato. Quando si pensa ad una medietà
linguistica, si dovrebbe riscontrare una neutralità del registro, ovvero un registro
non marcato, ma l’italiano dell’uso medio non occupa il centro degli assi proposti da
Berruto e da Antonelli: questa varietà è comunque influenzata dall’italiano letterario
scritto e insegnato a scuola (secondo Berruto), e dallo scritto giornalistico secondo
Antonelli. Non è, quindi, un registro propriamente non marcato, sebbene sia
sicuramente quello che più gli si avvicina; inoltre nell’orale la marcatezza fonologica
sussiste in ogni caso, poiché nella maggior parte de casi emerge l’appartenenza
geografica del parlante.
Gli stessi problemi si presentano quando si cerca di considerare la medietà linguistica
con il criterio della correttezza grammaticale (esempio del francese dell’Ile de
France), perché molto spesso analizzando un’espressione dell’italiano dell’uso medio
diremmo che è scorretta. L’uso effettivo della lingua (che è l’italiano medio) mostra un
reale distaccamento dalla norma interiorizzata a scuola: si nota un sensibile divario tra
norma codificata ed effettivo comportamento linguistico. Questo accade perché molti
atteggiamenti linguistici sono entrati nella norma ma ancora si fatica a determinarne
la correttezza, per la forte resistenza ancora proveniente dall’ambito educativo e
scolastico.
Anche il concetto della rilevanza statistica comporta qualche problema: sarebbe
“italiano medio” quello che viene rilevato dalla maggior parte degli italiani, ma in Italia
è difficile riscontrare un comportamento linguistico comune e condiviso poiché
sussiste una situazione linguistica di dilalia con le varianti regionali e a seconda delle
aree geografiche sono parlati dialetti totalmente diversi.
Dunque tutte queste considerazioni entrano in gioco nel definire l’italiano dell’uso
medio, ma nessuna è decisiva.
19) Perché l’italiano dell’uso medio (o neostandard) non occupa il centro
dello schema proposto da Berruto?
L’italiano dell’uso medio (o neo-standard) non occupa il centro dello schema di
Berruto poiché non è una varietà completamente non marcata ma si colloca più in
alto rispetto all’incontro degli assi linguistici di diastratia, diamesia e diafasia. Questo
perché in realtà l’italiano neo-standard rappresenta un’astrazione dell’italiano,
marcata non soltanto in diatopia, ma anche in diamesia, in diafasia e in
diastratia. Lo schema proposto da Berruto ci mostra come l’italiano dell’uso medio
non corrisponda a una varietà neutra (non marcata): lo IUM risulta decentrato e tende
verso l’italiano standard lettera rio e l’italiano burocratico lungo l’asse diafasico
(derivando in parte da un’evoluzione della varietà prestigiosa e letteraria, questa
eredità rimane), viene applicato perciò a una grande varietà di contesti, spesso
formali; lungo l’asse diastratico mostra ugualmente una tendenza centrifuga,
muovendosi verso il polo alto, presupponendo un buon grado di scolarizzazione dei
parlanti; inoltre si tratta di una varietà molto più diffusa all’orale che allo scritto,
anche per una questione di sanzione e incertezza della norma. Infine la varietà
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
dell’italiano neo-standard coincide sicuramente con la varietà statisticamente più
diffusa in Italia e presenta una grande quantità di elementi panitaliani, sebbene
esistano differenze significative legate soprattutto alla variazione diatopica.
20) Quali sono i principali tratti che caratterizzano la varietà individuata da
Sabatini che va sotto il nome di “italiano dell’uso medio”?
Nel 1985 Sabatini individua una nuova varietà dell’italiano che denomina “italiano
dell’uso medio” o neo-standard. Questa varietà di media formalità nell’uso parlato e
scritto si differenzia dallo standard perché è decisamente ricettiva dei tratti generali
del parlato ed è il risultato del processo di oralizzazione e ristandardizzazione
della varietà standard.
Le caratteristiche più importanti di questa varietà si riscontrano in ambito
fonetico/fonologico, ortografico, morfosintattico e lessicale.
Dal punto di vista della pronuncia/grafia, sembrerebbero in remissione la d eufonica
e la “i prospettica” (che era la norma comune in italiano e ora si trova soltanto in
forme cristallizzate come “per iscritto”).
Dal punto di vista della realizzazione fonetica pura e semplice ci sono aspetti a cui
nessun italiano fa caso, perché sono ormai entrati nell’uso comune: la pronuncia della
parola “piede” con la “e”chiusa invece che aperta, ad esempio.
Tra i fenomeni di morfologia, i cambiamenti principali riguardano soprattutto il
sistema pronominale, le cui innovazioni sono state rafforzate molto dall’uso parlato
della lingua. Un aspetto abbastanza comune è l’indebolimento dei dimostrativi che
assomigliano sempre di più agli articoli (es: vogliamo discutere di tutti quelli che sono i
problemi…). Per compensare, il dimostrativo viene allora rafforzato (questo qui/quello
qui invece di semplicemente questo/quello). Frequente è l’utilizzo di “questo” e
“quello” in funzione di pronome neutro, anziché ciò. Altro fenomeno comune è la
caduta della prima sillaba (stamattina/cos’è sto coso). Ancora, l’uso di “gli” come
pronome dativale per persona generica per “a lei-a lui-a loro”, l’uso dei pronomi forti e
l’abbandono dei pronomi soggetto deboli (“lui-lei diventano pronomi soggetto anche
se la scuola continua ad imporre l’uso di “egli-ella”); altro uso fortemente criticato,
bandito dalla scuola è il partitivo con le preposizioni (condisco l’insalata con olio e sale
e non con dell’olio e del sale/Esco con amici e non con degli amici); l’uso di verbi
procomplementari, ovvero i verbi che hanno al loro interno dei pronomi clitici
(prendersela, farcela, volerci, averci, esserci, poterne, andarsene..). La prevalenza dei
locativi ci/ce su vi/ve (ce ne sono) e l’uso del ci attualizzante (ce l’hai l’ombrello? /
vederci).
Tra ridondanza pronominale e sintassi di frase troviamo fenomeni come le
dislocazioni (a destra e sinistra), le frasi segmentate (“Quand’è che parti?”).
L’introduzione di nuove espressioni, che accompagnano quelle tradizionali (“come
mai” al posto di “perché”). Contemporaneamente abbiamo un altro fenomeno molto
frequente che è la riduzione del congiuntivo, spesso sostituito dall’indicativo
imperfetto (se lo sapevo non ci venivo), che è conseguenza di uno snellimento delle
strutture sintattiche e dell’influenza del parlato.
Sempre a livello pronominale o comunque di connettori o complementatori, il
fenomeno del “che polivalente” indica un abuso del che in relative laddove sarebbe
necessario il pronome flesso e in sostituzione a frasi con valore temporale, finale,
causale, in frasi scisse o come relativo invariabile con ripresa pronominale (la sera che
ci siamo incontrati/aspetta che te lo spiego/copriti che fa freddo/quand’è che parti? / la
valigia che ci ho messo i libri/Marco è un ragazzo che ci si può fidare). Altre possibilità
del “che” polivalente sono le riduzioni dei nessi, “Tieni conto che si fa tardi” invece di
“Tieni conto del fatto che si fa tardi” (tenere conto di qualcosa e non tenere conto che
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
qualcosa). Altri aspetti sono la sostituzione di “Cosa” al classico “che cosa”,
soprattutto al nord. Poi le concordanze ad sensum (“Il 20% degli Italiani sono
preoccupati”); sempre nella ridondanza pronominale, il dativo etico o meglio
benefattivo, “Stasera mi guarda un bel film”; ancora, la realizzazione dei costrutti
passivi con risorse alternative al passivo vero e proprio, come l’uso della terza plurale
(“Mi hanno rubato la macchina!”, oppure l’uso di “uno/tu” (“Uno si iscrive alla SSLMIT
e diventa pazzo”); l’uso aggettivale di niente per negare l’esistenza di qualcosa “oggi
niente gelato, niente treni”; la riduzione delle forme di cortesia per cui “ella” e “Loro”
vengono cancellati, eliminati.
Nella formazione del lessico, costrutti brachilogici, che prevedono l’eliminazione delle
preposizioni (“scuola guida”, “sala conferenze” “treni merci”), e strategie innovative
per realizzare costrutti elativi o enfatici (per esempio la ripetizione “Abiti in centro
centro?”); infine una serie di risorse a metà tra morfologia e lessico che fanno
parte dell’italiano dell’uso medio che si trova nei giornali, ma che scrivendo un testo di
registro elevato si tendono ad eliminare, come “Ci vuole” al posto di “essere
necessario” “si capisce” al posto di “è evidente”, “si vede” al posto di
“probabilmente”.
21) La dimensione diafasica individua registri e sottocodici: quali sono le
differenze?
Il registro è un tipo di varietà diafasica che fa riferimento al contesto situazionale,
soprattutto al grado di formalità e alla relazione che c'è tra gli interlocutori: esso non
si limita ad un campo specifico o a un gruppo di persone specifico, ma varia soltanto
a seconda del contesto.
Il sottocodice è invece una varietà diafasica funzionale della lingua naturale, che ha la
funzione di illustrare in maniera più precisa un certo settore delle esperienze umane.
Per questo è adottata nella sua interezza soltanto da un gruppo ristretto di
persone: gli specialisti di quel determinato settore di conoscenza. L’elemento
fondante dei sottocodici è il contenuto, l’argomento, inteso come settore di
conoscenze (medicina, informatica, linguistica) e le attività ad esso connesse (ricerca
medica). L’obiettivo è essere il più precisi possibile, cercare di descrivere le attività o il
campo di ricerca in questione nella maniera più precisa possibile, che non lasci adito a
dubbi. Il livello lessicale è dunque fondante nelle lingue speciali: contiene in genere un
repertorio lessicale aggiuntivo rispetto a quello della lingua naturale che è specifico,
monosemico e trasparente. Per questioni di influenza denotativa, infatti, le lingue
speciali tendono ad avere termini che idealmente sono costruiti a tavolino per essere
trasparenti dal punto di vista morfologico, mentre le strutture morfosintattiche non
sono nuove ma vengono usate in modo diverso rispetto a ciò che prevede il sistema
della lingua naturale.
Quindi, mentre il registro è legato alla situazione comunicativa ed è determinato da
fattori sociali e culturali, il sottocodice è legato all’ambito di attività, al campo,
all’argomento del discorso.
22) Cosa si intende per “sottocodice”?
Il sottocodice è una varietà funzionale della lingua naturale, che ha la funzione di
illustrare in maniera più precisa un certo settore delle esperienze umane ed è adottata
nella sua interezza da un ristretto gruppo di persone: gli specialisti di quel determinato
settore di conoscenza. L’elemento fondante dei sottocodici è il contenuto,
l’argomento, inteso come settore di conoscenze (medicina, informatica, linguistica) e
le attività ad esso connesse (ricerca medica). L’obiettivo è descrivere le attività o il
campo di ricerca in questione nella maniera più precisa possibile, affinché non si lasci
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
adito a dubbi. Il livello lessicale è dunque fondante nelle lingue speciali: contiene in
genere un repertorio lessicale aggiuntivo rispetto a quello della lingua naturale che è
specifico, monosemico (terminologia) e trasparente. Nel lessico delle lingue speciali
inoltre è frequente trovare i tecnicismi collaterali, che si distinguono da quelli veri e
propri, perché non hanno la caratteristica della monosemia. Si tratta di scelte
principalmente dettate da questioni di registro. (Quando un medico ci dice “Che dolore
accusiamo” non ci dice nulla di diverso rispetto a “Che dolore sentiamo”, si tratta
semplicemente di espressioni più ricercate che non sono più precise). Si tratta dunque
di falsi termini, di falsi tecnicismi. Nelle lingue giuridiche i termini tecnici veri e propri
solo il 4% sono termini tecnici veri e propri, anche se a noi sembra che la lingua
giuridica sia molto diversa rispetto alla lingua di tutti i giorni. Il resto sono tutti
tecnicismi collaterali.
Passando alla morfologia, un tratto caratteristico delle lingue speciali è una
nominalizzazione frequentissima. Questa è utile perché permette di compattare
l’informazione e garantisce una maggior impersonalità in quanto copre il soggetto.
Questo aumenta la difficoltà dei testi specialistici perché la descrizione statica è di più
difficile comprensione. I sottocodici sono interessati a fotografare la realtà e di
conseguenza è preponderante il presente indicativo. Infine, l’impersonalità
contribuisce all’oggettività delle informazioni. Si riscontra anche il fenomeno del
telegrafismo sintattico, che consiste nell’eliminazione di elementi funzionali come
articoli o preposizioni che possono essere recuperati dal contesto (treno-merci - non
c’è bisogno di inserire la preposizione).
Per la sintassi dei sottocodici, ci sono due tendenze opposte per le scienze umane e
le scienze dure. Le prime (testi giuridici, retorici, saggi, filosofia, scienze sociali,)
tendono a sovra sfruttare l’ipotassi e i periodi complicati, contribuendo all’iconismo
sintattico (la sintassi riflette la struttura semantica della frase, perciò si comprende
che nella principale è contenuta l’info più importante, mentre nelle subordinate c’è
il contorno). Lo stile commatico per cui una frase corrisponde ad un intero
paragrafo è molto usato e tende ad essere onnicomprensivo. Le scienze dure
invece tendono a sfruttare la paratassi, e amano la sovrapposizione di frasi
semplici. Da una parte c’è la tendenza ad essere esaustivi, dall’altra si cerca di
essere il più semplici e fruibili possibile.
Infine, per quanto riguarda la testualità, ovvero la strutturazione del testo, nei testi dei
sottocodici gli articoli di ricerca tendono a mantenere una progressione tematica
regolare con alternanza di tema-rema. C’è una forte strutturazione testuale, che tende
a evidenziare le parti compositive del testo. Si cerca di essere molto chiari nella
suddivisione testuale per permettere un orientamento più facile. La chiarezza è
ottenuta tramite l’esplicitazione dei connettivi, ad esempio.
23) Con quali modalità si possono formare termini specialistici?
I termini specialistici possono essere formati tramite diverse modalità.
Per questioni di influenza denotativa le lingue speciali tendono ad avere termini che
sono costruiti a tavolino per essere trasparenti dal punto di vista morfologico. Nelle
scienze dure solitamente i tecnicismi veri e propri si formano tramite regole di
formazione rigide, come la scelta di prefissi e suffissi che descrivano esattamente il
fenomeno (+ite= infiammazione – trache- alla trachea, faring- alla faringe, derma- alla
pelle, …). Oltre a creare termini ex-novo, un’altra modalità di formazione di termini
specialistici è la ridefinizione, ossia la risemantizzazione di una parola già esistente
(il “nodo” in nautica è l’unita di misura per la velocità, il “campo” in elettrotecnica è
diverso dal “campo da tennis”, il “fatto” in ambito giuridico è qualcosa che è
determinato dalla legge, e non può essere sostituito con avvenimento, accaduto).
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
Altre possibilità sono i prestiti orizzontali, cioè da altre discipline che dispongono di
altre lingue speciali (il termine “collasso” è passato dalla medicina all’astronomia),
l’uso di sigle (TAC, CLA, AIDS), l’uso di eponimi, cioè di parole che prendono il nome
da una persona (il newton come udm in fisica; il morbo di Parkinson, la sindrome di
Down), la creazione di parole composte (estratto conto, ricetrasmettitore), l’uso di
parole straniere (principalmente inglesi, basti pensare all’informtica).
24) Cosa si intende per tecnicismo proprio (o termine) e tecnicismo
collaterale?
I tecnicismi propri sono termini monosemici e morfologicamente trasparenti che
appartengono a un linguaggio settoriale, che identificano in maniera precisa e
univoca gli elementi del mondo esterno, soddisfacendo gli intenti di chiarezza e
puntualità propri dei sottocodici (es. leucociti, tracheite).
I tecnicismi collaterali sono scelte e accostamenti lessicali che non contribuiscono alla
definizione precisa di un’entità, ma sono soltanto preferenze linguistiche legate
un’esigenza di registro che generalmente aumenta la distanza tra specialista e non
specialista (es. accusare un dolore, per os, escutere un teste, 3 pillole al dì, pubblica
istruzione). Si tratta, in breve, di falsi tecnicismi.
25) Quali sono i tratti comuni ai sottocodici (o lingue speciali in senso
stretto) dell’italiano a livello di lessico, morfosintassi e testualità?
I sottocodici dell’italiano contengono in genere un repertorio lessicale aggiuntivo
rispetto a quello della lingua naturale che è specifico, monosemico (terminologia) e
morfologicamente trasparente. Nel lessico delle lingue speciali è frequente l’uso di
tecnicismi propri e collaterali (questi ultimi si distinguono da quelli veri e propri perché
non hanno la caratteristica della monosemia. Si tratta di scelte principalmente dettate
da questioni di registro, di espressioni più ricercate e non più precise).
Passando alla morfologia, un tratto caratteristico delle lingue speciali è una
nominalizzazione frequentissima. Questa è utile perché permette di compattare
l’informazione e garantisce una maggior impersonalità in quanto copre il soggetto.
Questo aumenta la difficoltà dei testi specialistici perché la descrizione statica è di più
difficile comprensione. I sottocodici sono interessati a fotografare la realtà e di
conseguenza è preponderante il presente indicativo. Infine, l’impersonalità
contribuisce all’oggettività delle informazioni. Si riscontra anche il fenomeno del
telegrafismo sintattico, che consiste nell’eliminazione di elementi funzionali come
articoli o preposizioni che possono essere recuperati dal contesto (treno-merci - non
c’è bisogno di inserire la preposizione).
Per la sintassi dei sottocodici, ci sono due tendenze opposte per le scienze umane e
le scienze dure. Le prime (testi giuridici, retorici, saggi, filosofia, scienze sociali,)
tendono a sovra sfruttare l’ipotassi e i periodi complicati, contribuendo all’iconismo
sintattico (la sintassi riflette la struttura semantica della frase, perciò si comprende
che nella principale è contenuta l’info più importante, mentre nelle subordinate c’è
il contorno). Lo stile commatico per cui una frase corrisponde ad un intero
paragrafo è molto usato e tende ad essere onnicomprensivo. Le scienze dure
invece tendono a sfruttare la paratassi, e amano la sovrapposizione di frasi
semplici. Da una parte c’è la tendenza ad essere esaustivi, dall’altra si cerca di
essere il più semplici e fruibili possibile.
Infine, per quanto riguarda la testualità, ovvero la strutturazione del testo, nei testi dei
sottocodici gli articoli di ricerca tendono a mantenere una progressione tematica
regolare con alternanza di tema-rema. C’è una forte strutturazione testuale, che tende
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
a evidenziare le parti compositive del testo. Si cerca di essere molto chiari nella
suddivisione testuale per permettere un orientamento più facile. La chiarezza è
ottenuta tramite l’esplicitazione dei connettivi, ad esempio.
26) Cosa si intende per dimensione verticale delle lingue speciali?
Cortelazzo ha ipotizzato la presenza di una dimensione verticale delle lingue speciali.
Questa farebbe riferimento al fatto che le lingue speciali sono soggette a variazione
diafasica, poiché sono anch’esse influenzate dalla componente
contestuale/situazionale. In teoria non dovrebbe esserci spazio per i registri, ma
effettivamente anche nei sottocodici esistono variazioni di registro, che sono
determinate dalla funzione comunicativa del testo, dalla formalità della situazione e
dalla relazione tra gli interlocutori, che potrebbero non essere entrambi specialisti di
un determinato settore di conoscenza.
Nell’ambito medico, ad esempio, durante un convegno si parlerà di “leucociti”; un
medico che chiede le analisi a un tecnico di laboratorio, però, dirà “bianchi”, mentre
un medico che parla con il paziente farà riferimento ai “globuli bianchi”. Queste
differenze creano svantaggi poiché danno vita a sinonimie all’interno della disciplina,
ma sono indispensabili laddove ci sia un contatto tra chi è esperto e chi non lo è. La
dimensione verticale è quindi la possibilità per i sottocodici di riferirsi allo stesso
fenomeno utilizzando diverse scelte linguistiche a seconda del contesto (si tratta
quindi anche di differenze di registro).
LINGUISTICA DEI CORPORA
1. Perché l’approccio generativista e la linguistica dei corpora sono in
genere ritenuti inconciliabili?
L’approccio generativista è un atteggiamento che assume il parlante in seguito a un
quesito che si pone sulla correttezza di una struttura o di un espendiente
linguistico. Il parlante è in grado di giudicare l’accettabilità grammaticale di un testo e
di generarne una quantità infinita di essi.
Quest’atteggiamento viene messo in contrapposizione con la linguistica dei corpora,
una disciplina che si basa sull’osservazione e analisi di una gran numero di fatti
linguistici che si sono già verificati. In pratica, l’obiettivo di tale disciplina è la
ricerca di elementi comuni (es. gli accademici della Crusca per creare il primo
vocabolario) contenuti in testi selezionati di un determinato tipo, analizzando esempi
pratici per poi ricavarne e descriverne la norma linguistica, ovvero il comportamento
linguistico di una certa comunità in certi contesti.
Di conseguenza i due approcci sono generalmente ritenuti opposti e quindi
inconciliabili.
2. è corretto definire un corpus come “un insieme di testi aventi una qualche
caratteristica in comune”?
Un corpus è una raccolta di testi (scritti orali o multimediali) o parti di essi in numero
finito (in formato elettronico) che vengono trattati in modo uniforme; tali testi
condividono alcune caratteristiche, quali ad esempio l’autore, la tipologia testuale, la
varietà o anche la stessa modalità di produzione. Con l’aiuto di informazioni aggiuntive
interne (di tipo linguistico, che ad esempio assegnano automaticamente la categoria
grammaticale a una parola) o esterne, i corpora possono essere gestibili ed
interrogabili informaticamente. Qualora le finalità dell’analisi siano prettamente
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
linguistiche (descrizione di lingue naturali o loro varietà), i testi scelti sono per lo più
autentici (non modificati) i e rappresentativi.
3. Che differenza passa tra i corpora e i cosiddetti “precorpora” (cioè
raccolte di testi anteriori all’avvento del computer)?
I precorpora sono raccolte di testi prodotte dagli estensori del Vocabolario della Crusca
prima dell’avvento del computer, quindi in formato non elettronico e sono
analizzati da esseri umani. Un certo numero di opere letterarie di autori di prestigio è
stato infatti preso in esame e confrontato da umani, con lo scopo di dare un significato
alle parole dei testi in base a come queste venivano usate. Tuttavia, non si può
affermare che il loro studio appartenga già alla linguistica dei corpora dato che non è
sufficiente unire diversi testi tra loro e analizzarli: manca l’elemento automatico.
E’ qui la differenza principale tra le due raccolte di testi: i corpora raccolgono testi in
formato elettronico e sono il vero oggetto di studio della linguistica dei corpora. Il
tratto fondamentale di questa scienza, che apparve negli anni 60’, non è il lavoro
soggettivo di un team di esseri umani, bensì un approccio che prevede l’analisi
tramite strumenti elettronici (elaborazione elettronica), quindi automatica, di
un numero di testi di grandi dimensioni che sfugge alla possibilità di controllo
dell’essere umano. L’obbiettivo principale è quello dell’oggettività, intesa come
replicabilità, unito alla fattibilità, ovvero il fatto di poter dimostrare una tesi in termini
di dispendio di tempo ed energia ragionevoli, ottenendo dei risultati concreti.
4. Quale può essere una definizione rigorosa di “corpus”?
Una definizione rigorosa e massimalista di “corpus” è quella di Manuel Barbera,
esposta in “Corpora e linguistica in rete”, che recita: “Un corpus è una raccolta
di testi (scritti orali o multimediali) o parti di essi in numero finito in formato
elettronico trattati in modo uniforme (ossia tokenizzati ed addizionati di markup
adeguato) così da essere gestibili ed interrogabili informaticamente; se (come spesso)
le finalità sono linguistiche (descrizione di lingue naturali o loro varietà), i testi sono
perlopiù scelti in modo da essere autentici e rappresentativi”.
5. Cosa si intende per tokenizzazione (o normalizzazione) e markup (o
tagging)? Quali sono le difficoltà?
Un token è un’occorrenza di una parola all’interno di un corpus. La tokenizzazione,
dunque, consiste nell’identificazione di tutte le parole presenti in un testo.
Il markup invece consiste in informazioni aggiuntive che possono essere interne o
esterne. Il markup interno è rappresentato da informazioni aggiuntive che vanno oltre
la semplice individuazione delle parole, informazioni che sfuggono alla semplice
differenza morfologica tra elementi lessicali.
La parola letto, ad esempio, può essere il mobile o il participio passato del verbo
leggere. Si tratta di informazioni interne alla lingua, che servono a distinguere le parti
del discorso. Il markup esterno consiste invece in informazioni che non riguardano
l’aspetto linguistico, si tratta di informazioni paratestuali, di contorno.
6. In cosa consistono le operazioni di lessicalizzazione e lemmatizzazione?
Quali sono le difficoltà?
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
La lessicalizzazione è un processo per cui una parola autonoma acquista il valore
di unità lessicale e semantica, ad esempio crescendo è un nome singolare maschile
(estratto dal campo musicale) lessicalizzato dal gerundio di crescere.
Per lemmatizzazione si intende invece il processo per cui una parola è ridotta alla
sua forma base, ad esempio crescendo è ricondotto alla sua forma base ovvero
crescere, ma come detto sopra può anche riferirsi ad un crescendo in quanto nome
singolare. Un altro esempio può essere dato dalla parola letto, inteso come mobile per
dormire o come participio passato del verbo leggere. Sono questi casi di omografia e
polisemia delle parole a generare difficoltà, ai quali occorre dunque prestare
attenzione.
7. Cosa si intende per ricerche corpus-based e corpus-driven?
La distinzione tra un approccio basato sui corpora (corpus-based) e uno diretto dai
corpora (corpus driven) è stata introdotta per la prima volta da Elena Tognini
Bonelli nel 2001.
Le ricerche corpus-based riguardano generalmente un approccio deduttivo in cui
l’analisi del corpus aiuta a confermare o confutare una teoria pre-esistente.
Praticamente, tramite l’analisi del corpus si testa la veridicità o la falsità di
un’ipotesi.
Le ricerche corpus-driven invece sono di tipo induttivo, vale a dire che il corpus
viene considerato come punto di partenza e attraverso l’analisi e l’interpretazione dei
suoi dati viene elaborata una teoria ex novo, rendendo così il corpus una teoria
linguistica di per sé.
Una linguistica basata sui corpora presenta però dei forti limiti, poiché se da un lato
il corpus è reale e rappresentativo degli usi della lingua e permette lo studio di
fenomeni circoscritti, dall’altro è impossibile che la propria ricerca conduca a risultati
al di fuori del campo di indagine.
8. Perché la lingua (intesa come langue saussuriana) non è un fenomeno
statisticamente osservabile?
La lingua non è definibile come qualcosa di stabile (così come la popolazione che la
parla), ma è l’insieme di tutti gli enunciati che sono stati, sono e saranno prodotti, sia
scritti che orali. È potenzialmente infinita, perché in continua crescita ed
evoluzione, di conseguenza nessuno studio statistico può dirsi veramente completo,
per quanto esteso possa essere, perché entrano in gioco fattori che interferiscono
costantemente nello studio oggettivo dei fenomeni linguistici (diacronia, diatopia,
diastratia, diamesia, diafasia).
9. Cosa significa il grafico seguente dal punto di vista della distribuzione
delle “parole” in un corpus?
Secondo il grafico, partendo da un campione di lingua italiana, il numero di parole
presenti in un corpus è inversamente proporzionale al numero di occorrenze della
stessa parola nel campione.
10. Come si possono “contare” le parole nell’esempio che segue?
Sopra la panca la capra campa
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
sotto la panca la capra crepa
Nell’esempio le parole sono 12, di cui 8 di esse sono ripetute (la, panca e capra),
mentre le altre compaiono una sola volta; in totale, si contano 7 diverse forme
grafiche (word types).
Le 12 occorrenze (tokens) indicano la grandezza del corpus, mentre le diverse forme
grafiche (types) rappresentano il vocabolario del corpus.
11. Qual è la differenza tra type (o forma grafica) e token (o occorrenza) in
un corpus?
All’interno di un corpus sono presenti i token, ovvero tutte le occorrenze, comprese
quelle che si ripetono, che indicano perciò la grandezza di un corpus.
I type, ovvero le forme grafiche, rappresentano il numero delle parole distinte
all’interno del corpus, e fanno quindi riferimento al vocabolario della raccolta.
12. Cos’è un vocabolario di frequenza?
Un vocabolario di frequenza è un vocabolario in cui viene segnalata una sola volta
una forma grafica e viene poi indicato quante volte questa parola compare dentro al
corpus. L’ordine con cui compaiono le parole (ossia la frequenza) è anche denominato
rango.
13. A prescindere (almeno in parte) dalle dimensioni, di quali misure occorre
tener conto per stabilire se un corpus può essere indagato con metodi
statistici?
Un corpus è affidabile e può essere indagato statisticamente se:
- il rapporto in percentuale tra il vocabolario e il numero di occorrenze (token-type
ratio) è inferiore al 20;
- il tasso di ripetizione medio delle parole che si ripetono è pari a 5;
- il numero di apax non è superiore al 50% del totale del vocabolario.
Se, al contrario, il corpus non rispetta questi standard e si nota la presenza di molte
parole diverse e molti apax, allora ci sono due possibilità: o il corpus è troppo
piccolo, e quindi poco affidabile, oppure si tratta di un corpus particolare che
richiede un tipo di trattamento diverso e più accurato (ad esempio un corpus di
poesie, il quale presenta un ricchezza lessicale molto maggiore rispetto alla prosa).
14. Sulla base della tabella qui sotto, che ne descrive la composizione, che
critiche possiamo fare alla composizione del Brown Corpus?
La prima critica che si può muovere alla composizione del Brown Corpus riguarda la
scelta dei tipi di testi, che è da considerare come ingiustificata e arbitraria. Inoltre,
l’elenco dei tipi di testo presenti nel corpus si rivela inutile, in quanto non aggiunge
informazioni in più riguardo le caratteristiche dei testi e soprattutto riguardo alla
lunghezza temporale del corpus (ovvero il range temporale dei testi scelti). Infine, la
scelta di osservare un milione di parole risulta del tutto arbitraria, poiché non c’è la
certezza che il numero sia sufficiente o meno. Lo stesso discorso vale anche per la
decisione, ingiustificata, di utilizzare campioni di 2000 parole e per la distribuzione dei
campioni per ogni categoria.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
DOMANDE SULL’ITALIANO AMMINISTRATIVO
1) In che senso l’italiano istituzionale è caratterizzato da forte
conservatorismo?
Si può affermare che l’italiano istituzionale è caratterizzato da forte conservatorismo
perché conserva tratti linguistici, in particolare sintattici, appartenenti ad un tipo di
scrittura che si è affermata molti anni fa con lo sviluppo della burocrazia, di cui la
complessità è erroneamente sinonimo di formalità. La lingua delle istituzioni
italiane è ancora molto faticosa e prolissa, fa uso di termini e parole cadute ormai
in disuso, non aiutano il lettore nella comprensione del messaggio, non è perciò una
lingua moderna che si è sviluppata con il modificarsi dell’italiano, ma si conserva
ancora nel passato. A livello europeo sono state proposte diverse iniziative affinché si
possa usufruire di testi più leggibili. Verso la fine degli anni ’90 in Italia sono state
emanate delle direttive con lo scopo di esortare i dipendenti pubblici a scrivere in
modo più comprensibile, sia tra di loro, sia quando si rivolgono alla popolazione.
Tali iniziative hanno raggiunto l’apice tra il 2000 e il 2010.
2) Si può dire che, mentre l’italiano in genere è molto cambiato dall’Unità
politica a oggi, l’italiano istituzionale sia cambiato molto poco? Perché?
Poco dopo la proclamazione dell'Unità d'Italia del 1861 è cominciato un processo di
italianizzazione che si è concretizzato soprattutto attraverso l'educazione
scolastica, quindi c'è stato un notevole aumento del numero dei parlanti, pur senza
abbandonare i dialetti. Tuttavia, forse il maggior apporto alla diffusione dell'italiano è
stato dato dai mezzi di comunicazione di massa, in modo particolare la radio e la
televisione, che sono letteralmente entrate nelle case degli italiani. L'italiano è poi
cambiato anche a causa della diversificazione dei domini, quindi delle specializzazioni
esistenti in diversi ambiti che hanno fatto sì che sviluppassero lessico e strutture
specifiche. Ma in ambito istituzionale, si può dire che l’italiano non si sia quasi
evoluto rispetto al 1861. Ciò è dovuto al conservatorismo tipico di questo ambito: c’è
la convinzione che per essere formale un testo debba essere necessariamente
complesso, di conseguenza si è mantenuta questa caratteristica. L’italiano
istituzionale è difatti caratterizzato da un registro alto, una lingua complicata, e la
comunicazione, che dovrebbe essere quella maggiormente curata perché portatrice di
un messaggio ben preciso, finisce in realtà per creare degli ostacoli, rendendo le
inform azioni inaccessibili al destinatario. Il linguaggio istituzionale è caratterizzato da
una forte astrazione terminologica: le categorie sono astratte, le leggi valgono per
tutti e per un lasso di tempo prolungato. Dal punto di vista lessicale, questo risulta
ancora una volta difficile, oscuro perché le scelte sono sempre quelle meno frequenti,
c’è una tendenza a scegliere le parole più eleganti. Le scelte sono di tipo
stereotipico, si tratta di clichés utilizzati in continuazione per inerzia, che non
rientrano nel vocabolario di base. Molto spesso si trovano parole inventate,
inesistenti che non esistono nemmeno nel lessico specialistico. Infine, è da segnalare
che l’informazione importante, che sia una decisione o una comunicazione, è
collocata sempre alla fine di un testo, solo dopo avere elencato la serie di motivi per
i quali questo testo viene scritto, comportando una seria difficoltà per il
destinatario a decodificare le informazioni contenute nel testo.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
3) A partire dal testo riportato sotto, spiegare perché l’italiano
istituzionale è cambiato molto poco dall’Unità a oggi
UFFICIO DEI DELEGATI SPECIALI PER LE FINANZE
AVVISO
In seguito ad autorizzazione del Ministero delle finanze si dichiara quanto segue:
I. Tutti i contribuenti ed in generale tutti i debitori verso la finanza, che sono presentemente in
mora,
vengono assolti dall'interesse di mora, o dal caposoldo, purché versino il dovuto importo entro
il
perentorio termine del giorno 28 corrente mese.
II. I contribuenti e debitori verso la Finanza, che sono presentemente in corso di termine
prorogato al
pagamento, vengono assolti dall'interesse legale, purché paghino il dovuto importo entro il
termine
concesso.
III. I contribuenti all'imposta rendite, i quali, sebbene invitati, non presentarono la notifica, o
non
somministrarono entro il prescritto termine gli altri dati loro richiesti, andranno esenti
dall'applicazione
della multa di cui è parola nel paragrafo 41 del …, purché producano la notifica, o
somministrino i
richiesti dati alla competente Commissione entro il perentorio termine del giorno 18 del
corrente mese.
Padova, 5 settembre IL DELEGATO SPECIALE
Il testo sopra riportato è datato in realtà 1866, ma il lettore odierno non lo distingue
da un testo attuale, perché questo presenta un linguaggio istituzionale usato ancora
oggi al quale chi legge è abituato. I tratti conservati principalmente e tipici di tale
linguaggio sono:
- l’aggettivo anteposto al nome (dovuto importo; perentorio termine; richiesti dati)
- scelta di termini in disuso (presentemente, caposoldo, mora)
- tendenza all’astrazione, preponderanza di nomi che indicano cose astratte,
minoranza di termini tecnici
- inerzia (ripetizione delle formule)
- ricerca dell’eleganza a scapito della chiarezza
- non curanza di chi è il destinatario, non si tiene conto di chi dovrà usufruire del
testo
A livello sintattico, il testo è complesso, con diversi gradi di subordinazione impliciti
ed espliciti. Sono presenti sovra informazioni, sarebbe consigliabile attenersi il più
possibile a “una frase=un’informazione”. L’informazione principale è posta in
fondo, comportando un’ulteriore difficoltà di decodifica.
4) Quali sono i tratti condivisi dai registri alti e dall’italiano istituzionale?
I registri alti condividono con l’italiano istituzionale la formalità delle scelte
lessicali, poco usate nel quotidiano e in generale negli ambiti diversi da quelli
istituzionali. La solennità delle parole e dei termini in disuso adottati dal
linguaggio delle istituzioni rende il discorso non opinabile, obiettivo delle istituzioni
dato che si occupano spesso di leggi che devono essere considerate indiscutibili.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
L’apparente inconfutabilità del contenuto del messaggio è resa anche attraverso
l’impiego della sintassi ipotattica, altra caratteristica comune ai registri alti: frasi
lunghe e ricche di subordinate (spesso relative) danno l’impressione di innalzare il
tono, la credibilità e la severità del discorso.
5) Illustrare le tre caratteristiche generali dell’italiano istituzionale
Le caratteristiche prototipiche dell’italiano istituzionale o amministrativo sono
complessità, oscurità e formalità.
- COMPLESSITA: la sintassi è poco lineare (che concentra in poche righe
moltissime informazioni), ed è presente una forte nominalizzazione. Le
subordinate confondono e non chiariscono l’informazione principale, che viene
oscurata dalle altre informazioni inutili e spesso ridondanti presenti all’interno
del testo. Inoltre, i termini desueti e dal significato poco chiaro aumentano il
grado di complessità del messaggio, ponendo il lettore in difficoltà
- OSCURITA: perché i termini impiegati sono spesso difficili da interpretare perché
desueti e con un significato poco chiaro. Le strutture usate sono ipotattiche e il
lettore, confuso dalle subordinate e in costante ricerca del soggetto, difficilmente
riesce a capire con chiarezza l’informazione principale.
- FORMALITA: il registro è elevato, conferendo al messaggio solennità, e quindi
inconfutabilità, di conseguenza il lettore è portato a non trascurare il testo e a
leggerlo con attenzione e serietà. Inoltre, la formalità è indice di un rapporto
gerarchico ben preciso tra chi scrive e chi legge.
Si tratta ormai di un fatto di abitudine culturale legato all’accettabilità: il lettore
si aspetta che un testo ufficiale sia complesso e oscuro perché attribuisce alla
complessità il carattere della formalità. Si è ormai portati a pensare che se un testo è
oscuro e nebuloso, allora sarà un testo importante.
6) In che senso l’italiano istituzionale può essere tacciato di
complessità?
L’italiano istituzionale è complesso per le seguenti caratteristiche:
- la sintassi è poco lineare e concentra in poche righe moltissime informazioni, le
subordinate confondono e non chiariscono l’informazione principale, che viene
oscurata dalle altre informazioni inutili e spesso ridondanti.
- i termini desueti, un registro elevato, la forte nominalizzazione e le
abbreviazioni, l’uso di tecnicismi, di astrazioni e di forestierismi o latinismi e
le formule stereotipate aumentano il grado di complessità del messaggio,
ponendo il lettore in difficoltà.
- la presenza di incisi e parentetiche interrompe il flusso della frase e aggiungono
ulteriori informazioni. Molto spesso questi incisi dividono il soggetto e il verbo, che
dovrebbero sempre stare insieme.
- Proposizioni di modo non finito: il gerundio non concorda in genere e numero col
nome a cui si riferisce, quindi sta al lettore comprendere.
- Uso dell’infinito con funzione iussiva, cioè al posto dell’imperativo. L’infinito
resta impersonale, conferendo ulteriore vaghezza.
- Forme di spersonalizzazione: tipiche del burocratese (ad esempio “è possibile”).
Si usano strutture impersonali, con il vantaggio di nascondere chi deve fare cosa o
chi ha fatto cosa.
- Uso della forma passiva: in molti casi non viene specificato il complemento
d’agente, contribuendo alla vaghezza del contenuto.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
- La presenza di frasi negative con valore attenuativo non aiuta la chiarezza del
messaggio
7) In che senso l’italiano istituzionale può essere tacciato di oscurità?
L’italiano istituzionale è oscuro per le seguenti caratteristiche:
- la sintassi è poco lineare e concentra in poche righe moltissime informazioni, le
subordinate confondono e non chiariscono l’informazione principale, che viene
oscurata dalle altre informazioni inutili e spesso ridondanti.
- i termini desueti, un registro elevato, la forte nominalizzazione e le
abbreviazioni, l’uso di tecnicismi, di astrazioni e di forestierismi o latinismi e
le formule stereotipate aumentano il grado di complessità del messaggio,
ponendo il lettore in difficoltà.
- la presenza di incisi e parentetiche interrompe il flusso della frase e aggiungono
ulteriori informazioni. Molto spesso questi incisi dividono il soggetto e il verbo, che
dovrebbero sempre stare insieme.
- Proposizioni di modo non finito: il gerundio non concorda in genere e numero col
nome a cui si riferisce, quindi sta al lettore comprendere.
- Uso dell’infinito con funzione iussiva, cioè al posto dell’imperativo. L’infinito
resta impersonale, conferendo ulteriore vaghezza.
- Forme di spersonalizzazione: tipiche del burocratese (ad esempio “è possibile”).
Si usano strutture impersonali, con il vantaggio di nascondere chi deve fare cosa o
chi ha fatto cosa.
- Uso della forma passiva: in molti casi non viene specificato il complemento
d’agente, contribuendo alla vaghezza del contenuto.
- La presenza di frasi negative con valore attenuativo non aiuta la chiarezza del
messaggio
8) Quale funzione può essere assegnata al tratto della formalità dell’italiano
istituzionale?
La principale funzione della formalità di un testo istituzionale è di aumentare o far
risaltare la distanza gerarchica tra l’emittente e il ricevente del testo. Un registro
elevato e formale contribuisce a definire i ruoli dei partecipanti all comunicazione e fa
sì che il testo non venga letto con superficialità dal lettore. Ma la formalità di un testo
è in realtà ormai un fatto di abitudine culturale legato all’accettabilità: il lettore
si aspetta che un testo ufficiale sia complesso e oscuro perché attribuisce alla
complessità il carattere della formalità. Si è ormai portati a pensare che se un testo è
oscuro e nebuloso, allora sarà un testo importante. Questo fatto però non favorisce la
comprensibilità del testo: si cerca l’eleganza a scapito della chiarezza.
9) Illustrare le tre regole fondamentali per redigere un testo efficace
Chi redige un testo che possa essere considerato efficace deve:
- Assumere la prospettiva del destinatario e facilitare il più possibile la sua
comprensione inserendo le informazioni più importanti per il destinatario in prima
posizione e comunicandole in modo chiaro e conciso;
- Evitare di essere prigionieri dall’inerzia, distaccarsi dalle formule fisse di testi
precedenti che non sempre sono adatte al contesto in cui scrivo il testo o non
pertinenti al messaggio da veicolare;
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
- Privilegiare la chiarezza a scapito dell’eleganza, veicolare il messaggio in
maniera chiara, semplificandolo in un italiano corretto ma non necessariamente
elegante. L’eleganza è raramente sinonimo di chiarezza e trasparenza testuale.
10) Cosa si intende per “mettersi dalla parte del destinatario” quando si
scrive un testo?
Quando si redige un testo bisogna ricordare che il destinatario potrebbe essere
completamente ignorante sull’argomento trattato. Nello scambio con un collega
posso utilizzare un linguaggio molto tecnico e poco esplicito mentre rapportandomi
con un pubblico ampio è bene scegliere un lessico più semplice. Bisogna inoltre
cercare di non dare niente per scontato e di porsi in posizione di completa
ignoranza sul tema per aiutare chi possiede scarse capacità di comprensione dei testi.
Inoltre è necessario ricordare che non tutti ragionano allo stesso modo, conclusioni
che possono sembrarci banali possono non essere così ovvie al destinatario, a
prescindere dal suo titolo di studio e dalle sue capacità di comprensione dei testi.
11) Quali possono essere le conseguenze dell’inerzia nella redazione di
testi istituzionali?
Quando viene redatto un testo istituzionale bisogna tener conto della sua funzione, ma
dato che i testi istituzionali non comunicano tutti la stessa cosa, spesso riciclare
materiale di testi precedenti può generare messaggi errati, perché tali formule
possono non essere pertinenti alla funzione del testo in questione. Spesso, anche a
causa dell’introduzione della videoscrittura che permette di copiare e incollare ampie
sezioni di testo in pochi istanti, sono riportate leggi e articoli per intero du cui invece
bisognerebbe fornire soltanto un riassunto. Per esempio si possono citare pertanto al
posto di quindi, entro e non oltre al posto di entro, insieme con invece di con.
12) Quali sono i tratti caratteristici dell’italiano istituzionale a livello di
lessico, morfologia, sintassi e testualità?
Il lessico dell’italiano istituzionale è caratterizzato da:
Astrazione dal punto di vista semantico e lessicale (clientela, utenti);
Largo impiego di tecnicismi (titolo di viaggio, alienate o distolte), o più
frequentemente falsi tecnicismi e tecnicismi collaterali;
Latinismi (ad hoc, una tantum, brevi manu);
Sigle (D.lgs per decreto legislativo) e abbreviazioni (c.m., p.v., f.f per facente
funzioni);
Alta frequenza di parole ricercate al posto dei loro sinonimi più comuni (acquistare
per comprare, modalità al posto di modo);
Possibile presenza di parole che non esistono sui vocabolari, che possono essere
tipiche di un linguaggio specifico (stazione impresenziata);
Lotta alle ripetizioni anche in contesti in cui l’uso di parole diverse per indicare lo
stesso referente può causare fraintendimenti.
Sul piano della morfologia l’italiano istituzionale presenta le seguenti caratteristiche:
Tendenza a nominalizzare (in partenza invece di che partono);
Presenza di verbi vuoti accompagnati da specificatori nominali (apporre una firma,
compiere un acquisto);
Spersonalizzazione del destinatario, che si traduce in un’alta incidenza di verbi
impersonali e passivi, spesso non accompagnati da agenti.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
Per quanto riguarda la sintassi, invece, si registrano:
Eccessiva lunghezza delle frasi (ricordiamo che oltre le 25 parole una frase è
considerata di difficile lettura)
Forte presenza di subordinate esplicite ed implicite, incisi e parentetiche che si
traduce in un’eccessiva complessità del periodo;
Eccessiva frammentazione del periodo e separazione di elementi che dovrebbero
susseguirsi all’interno di un periodo (incisi tra soggetto e predicato, tra ausiliare e
participio, tra modale e infinito)
Presenza di modi nominali del verbo (infiniti, gerundi e participi), che, essendo più
poveri di informazioni rispetto ai corrispettivi di modo finito, richiedono maggior
attenzione da parte del lettore per rintracciare l’agente.
La testualità è invece caratterizzata da:
Stile commatico: spesso un paragrafo è costituito da una singola, lunghissima frase
con elevato livello di subordinazione;
Eccessiva concentrazione delle informazioni, ad ogni informazione dovrebbe
corrispondere una frase;
Modello cattive notizie, l’informazione principale si trova in fondo al testo dopo una
lunga serie di motivi, giustificazioni o spiegazioni;
Modello sillogistico: si comincia con le premesse per poi arrivare alla conclusione.
13) Quali sono i tratti caratteristici dell’italiano istituzionale a livello di
lessico?
Il lessico dell’italiano istituzionale è caratterizzato da:
Astrazione dal punto di vista semantico e lessicale (clientela, utenti);
Largo impiego di tecnicismi (titolo di viaggio, alienate o distolte), o più
frequentemente falsi tecnicismi e tecnicismi collaterali;
Latinismi (ad hoc, una tantum, brevi manu);
Sigle (D.lgs per decreto legislativo) e abbreviazioni (c.m., p.v., f.f per facente
funzioni);
Alta frequenza di parole ricercate al posto dei loro sinonimi più comuni (acquistare
per comprare, modalità al posto di modo);
Possibile presenza di parole che non esistono sui vocabolari, che possono essere
tipiche di un linguaggio specifico (stazione impresenziata);
Lotta alle ripetizioni anche in contesti in cui l’uso di parole diverse per indicare lo
stesso referente può causare fraintendimenti.
14) Quali sono i tratti caratteristici dell’italiano istituzionale a livello di
morfologia?
Sul piano della morfologia l’italiano istituzionale presenta le seguenti caratteristiche:
Tendenza a nominalizzare (in partenza invece di che partono);
Presenza di verbi vuoti accompagnati da specificatori nominali (apporre una firma,
compiere un acquisto);
Spersonalizzazione del destinatario, che si traduce in un’alta incidenza di verbi
impersonali e passivi, spesso non accompagnati da agenti.
15) Quali sono i tratti caratteristici dell’italiano istituzionale a livello di
sintassi?
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
Per quanto riguarda la sintassi, invece, si registrano:
Eccessiva lunghezza delle frasi (ricordiamo che oltre le 25 parole una frase è
considerata di difficile lettura)
Forte presenza di subordinate esplicite ed implicite, incisi e parentetiche che si
traduce in un’eccessiva complessità del periodo;
Eccessiva frammentazione del periodo e separazione di elementi che dovrebbero
susseguirsi all’interno di un periodo (incisi tra soggetto e predicato, tra ausiliare e
participio, tra modale e infinito)
Presenza di modi nominali del verbo (infiniti, gerundi e participi), che, essendo più
poveri di informazioni rispetto ai corrispettivi di modo finito, richiedono maggior
attenzione da parte del lettore per rintracciare l’agente.
16) Quali sono i tratti caratteristici dell’italiano istituzionale a livello di
testualità?
La testualità è invece caratterizzata da:
Stile commatico: spesso un paragrafo è costituito da una singola, lunghissima frase
con elevato livello di subordinazione;
Eccessiva concentrazione delle informazioni, ad ogni informazione dovrebbe
corrispondere una frase;
Modello cattive notizie, l’informazione principale si trova in fondo al testo dopo una
lunga serie di motivi, giustificazioni o spiegazioni;
Modello sillogistico: si comincia con le premesse per poi arrivare alla conclusione.
17) Come viene trattato a livello linguistico il rapporto col destinatario
nell’italiano istituzionale?
Nell’italiano istituzionale, il rapporto con il destinatario presenta della difficoltà dal
punto di vista linguistico. In primo luogo, i destinatari generalmente appartengono
ad un pubblico vasto della stessa comunità nazionale ma che presenta differenze
linguistiche in prevalenza diatopiche e diastratiche: le istituzioni dovrebbero
tenere in considerazione queste differenze nella stesura di un testo. Ciò non avviene:
chi scrive non si pone nella posizione del destinatario, scegliendo quindi di restare
nell’ottica di un italiano elegante ma poco chiaro, che linguisticamente non è
funzionale perché spesso il messaggio è formulato in maniera confusa, mettendo in
difficoltà il destinatario. Nelle comunicazioni istituzionali spesso si parla per conto di
un intero ufficio di conseguenza c’è la tendenza a utilizzare forme impersonali, senza
indicare a chi legge chi deve fare cosa, rendendo ulteriormente oscura la
comprensione. D’altra parte, il ricevente oramai si aspetta che un testo istituzionale
sia formulato in maniera complessa perché nell’accezione italiana questo è sinonimo
di formalità, quindi il limite dei testi istituzionali è anche legato a un problema di
accettabilità;
18) Quali possono essere i problemi che emergono nella SELEZIONE delle
informazioni in un testo istituzionale?
Nel selezionare le informazioni in un testo istituzionale, chi scrive non si pone nei
panni del destinatario, scegliendo quindi di inserire dati che sono probabilmente
rilevanti per chi scrive ma non per chi legge, o addirittura inserendo dati confusi,
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
poco chiari, a volte errati. Ne consegue che il lettore si trova a leggere informazioni
che non lo riguardano, aumentando così il tempo dedicato alla lettura (minuti preziosi
considerando i tempi frenetici odierni); se poi tali informazioni sono formulate anche in
maniera confusa il lettore riscontrerà difficoltà nella comprensione, dovendo svolgere
un’attenta analisi per capire il messaggio; la comunicazione non è dunque avvenuta in
maniera ottimale, è lenta, difficoltosa per chi legge e può provocare un
fraintendimento delle informazioni con conseguenze anche gravi, dato che spesso i
testi istituzionali trattano di leggi o forniscono indicazioni amministrative importanti.
19) Quali possono essere i problemi che emergono nella DISPOSIZIONE delle
informazioni nell’italiano istituzionale?
Chi si occupa della stesura di un testo istituzionale, per inerzia, pigrizia o scarsa
competenza, e anche perché non si pone nei panni del destinatario, spesso
distribuisce le informazioni selezionate in maniera poco chiara e confusa. Infatti, si
tende a porre in primo luogo informazioni secondarie che non riguardano direttamente
il destinatario, lasciando l’informazione principale e che più interessa il lettore in
fondo. Il destinatario si trova così in difficoltà, perché non trova subito
l’informazione che cerca; chi legge si trova infatti a scorrere per prima una serie di
dati che, casomai, lo concernono secondariamente, richiedendogli ulteriore tempo e
concentrazione (dato che non si tratta nemmeno di informazioni formulate in maniera
tale da facilitarne la comprensione).
Sono spesso presenti incisi e parentetiche che interrompono il flusso della frase e
aggiungono ulteriori informazioni. Molto spesso questi incisi dividono il soggetto e il
verbo, che dovrebbero sempre stare insieme.
20) A livello di testualità, cosa si intende per disposizione sillogistica delle
informazioni (o phrase unique o modello “cattive notizie”)?
Per disposizione sillogistica delle informazioni, o modello “cattive notizie”, si
intende un modello di scrittura tipico degli avvisi il cui contenuto riguarda incovenienti
al mittente o al destinatario ed è caratterizzato da una struttura che include una o più
premesse e solo alla fine della comunicazione viene esplicitato il vero motivo per cui si
è scritto quel determinato avviso. Per facilitare la comprensione del destinatario,
l’informazione principale andrebbe spostata all’inizio del testo.
21) In cosa consiste lo “stile commatico”? Che problemi comporta?
Lo stile commatico prevede che ad un’intera frase corrisponda un intero paragrafo,
così come nei commi della legge. Si tratta di uno dei due elementi caratteristici della
sintassi delle lingue speciali o sottocodici: lo stile commatico, è tipico delle scienze
umane (filosofia, giurisprudenza, scienze sociali). Questo rende difficoltosa la
comprensione in quanto in un solo paragrafo si addensano una serie di
informazioni molto spesso scollegate tra di loro. La soluzione sarebbe quella di
optare per la stesura di paragrafi che contengano un’unica informazione chiara e di
facile lettura per il destinatario.
22) Perché titolo e oggetto di un testo hanno un’importanza fondamentale?
Quali caratteristiche devono avere?
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
Il titolo è fondamentale perché è uno strumento di codifica, di interpretazione del
testo. È importante che tratti l’argomento del testo in questione e lo riassuma: il
titolo “AVVISO” non è un buon esempio dato che non preannuncia nulla del contenuto
del testo, ed è scontato. La sottolineatura del titolo, allo stesso modo, non è
necessaria. Per quanto riguarda l’oggetto, questo deve rappresentare
l’informazione principale e oggettiva contenuta nel testo. Nelle lettere
generalmente il titolo coincide con l’oggetto. Nel caso in cui si abbia un oggetto molto
lungo, si può utilizzare l’espressione “Di cui all’oggetto”, un rinvio paratestuale utile
per abbreviare.
23) L’intertestualità è una delle caratteristiche della scrittura istituzionale.
Perché può rendere un testo meno efficace?
L’intertestualità è una delle caratteristiche della scrittura istituzionale che
appesantisce il testo rendendolo di conseguenza meno efficace. Si tratta di un
rinvio alle norme, una frase unica e piuttosto lunga formata quasi esclusivamente da
riferimenti alle norme. Spesso però il rinvio rimanda a riferimenti muti, che non
esplicano niente in merito ad una determinata legge e di cui non si conoscono i
contenuti.
24) A livello sintattico, quali sono le difficoltà comunicative determinate
dalle caratteristiche dei testi istituzionali?
A livello sintattico, possiamo distinguere le seguenti caratteristiche con relative
conseguenze, che determinano delle difficoltà nella corretta comprensione:
- prevalenza ipotassi: le frasi molto lunghe ricche di subordinate confondono chi
legge, disorientandolo a causa della poca chiarezza di chi è il soggetto che fa cosa;
- forte presenza di nominalizzazione: complica la comprensione perché si rischia un
accumulo di nomi non collegati tra loro
- grande uso di passivi e di forme impersonali: non esplicitando l’agente,
contribuiscono alla vaghezza del contenuto
- grande uso e abuso di subordinate con gerundio: il gerundio non concorda in genere
e numero col nome a cui si riferisce, quindi sta al lettore comprendere.
25) Quali caratteristiche rinveniamo nei testi istituzionali a livello della
morfologia?
A livello della morfologia possiamo affermare che i testi istituzionali si caratterizzano
per una forte nominalizzazione. Quest’ultima ha il vantaggio di compattare più
informazioni all’interno del testo, ma allo stesso tempo occulta l’agente. E’ pertanto
più difficoltoso capire chi fa cosa (Astensione dal lavoro, inesigibilità. riduzione,
integrazione). Generalmente è più facile capire un testo quando si riescono a
individuare degli agenti. Con la nominalizzazione si presenta un mondo come se fosse
una fotografia, ci sono meno verbi, meno dinamicità, meno azione. Si assiste dunque
ad un depotenziamento dei verbi, che sono perlopiù vuoti o semanticamente
generici (provvedere). Inoltre, questo tipo di testi generalmente abbonda di
negazioni e litoti: invece di affermare qualcosa, si nega il suo contrario. Questo tipo
di scelta ha lo scopo di attenuare la forza performativa degli enunciati (Non superiore
invece di dev’essere inferiore). Si trovano inoltre molte abbreviazioni, non sempre
facili da decifrare per il destinatario (S.V, per signoria vostra, espressione in disuso).
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
26) Quali sono le forme della spersonalizzazione nei testi istituzionali?
I testi amministrativi privilegiano le strutture passive, la nominalizzazione, le
forme impersonali. Tutte questi aspetti contribuiscono alla spersonalizzazione dei
testi e dunque ad una minore chiarezza ed efficacia per il destinatario che ha difficoltà
a recuperare il soggetto della frase. Una soluzione a queste forme è l’esplicitazione del
soggetto della frase.
Esempio di spersonalizzazione con il passivo: “Alla domanda dev’essere allegata la
dichiarazione sostitutiva”, meglio “Il richiedente deve allegare alla domanda una
dichiarazione sostitutiva”.
Esempio di spersonalizzazione con la nominalizzazione: “La strutturazione delle tasse
e dei contributi prevede il pagamento in due rate”, meglio “Gli studenti pagano le
tasse e i contributi in due rate”.
27) Quali sono le caratteristiche dei testi istituzionali a livello dei modi e
tempi verbali?
I testi amministrativi presentano una forte abbondanza di proposizioni di modo non
finito che fanno uso del gerundio e del participio passato.
- Per quanto riguarda il gerundio, si tratta di uno dei modi più complessi da
utilizzare in italiano. In molti casi viene usato scorrettamente (in italiano il gerundio
ha bisogno di avere lo stesso soggetto della principale).
- Per quanto riguarda il participio passato, questo permette di compattare più
informazioni in poco spazio.
Entrambi i tipi di proposizioni possono però generare ambiguità e difficoltà nel
recupero del soggetto, perciò la soluzione migliore per evitare certe costruzioni è
quella di trasformare i tempi di modo non finito in tempi di modo finito, esplicitando
così la frase. I testi istituzionali recuperano anche l’uso del congiuntivo, che oggi è
sempre più in disuso. Si trova una forte presenza del futuro deontico, utilizzato al
posto dell’imperativo per dare ordini su determinate procedure che il destinatario
deve compiere. Ancora una volta si cerca di attenuare la durezza del mio enunciato. Si
ritrova anche la presenza del participio presente, anch’esso assolutamente in
disuso ed evitabile tramite l’esplicitazione della frase.
28) Quali sono le caratteristiche dei testi istituzionali a livello del lessico?
Nei testi giuridici il tasso di tecnicismi è del 4%. Il linguaggio amministrativo è
fortemente debitore del linguaggio giuridico, il latino può essere frequentemente
presente in espressioni fisse che fanno parte della nostra tradizione.
Nei testi amministrativi troviamo:
- tecnicismi collaterali, parole tecniche utilizzate in testi specialistici, diversi dai
tecnicismi veri e propri (parole che hanno un unico significato preciso, termini).
Mentre gli altri sono solo di registro più elevato, non sono più precisi. Possono
creare problemi tecnicismi collaterali che assomigliano a parole comune, ma hanno
significati diversi. Esempi di tecnicismi: ci sono, esistono parole come
“ricongiunzione”, “riscatto”, “computo”. I primi due sono tecnicismi propri, non
posso eliminarli come “locazione” e “affitto”.
- Anche nelle parole grammaticali abbiamo la tendenza a selezionare il sinonimo
più complesso e articolato: “a condizione che” è molto più lungo di “se”. La
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
struttura verbo vuoto + specificatore: coda nominale che specifica il significato del
verbo vuoto.
- Nel lessico troviamo molto frequentemente parole astratte: “parentela”;
“liquidità”, “modalità”, “tipologia”. Cercare di riferirsi ad individui piuttosto che a
categorie astratte. Le sigle: non sempre trasparenti per il pubblico generico (dd, di
data), (u.s. ultimo scorso).
29) Analizzare il testo che segue individuando i tratti riconducibili alla
varietà definibile come “italiano istituzionale”.
30) Riscrivere il testo che segue in forma più efficace dal punto di vista
comunicativo.
31) Analizzare il testo che segue individuando i tratti riconducibili alla
varietà definibile come “italiano istituzionale” e riscriverlo in forma più
efficace dal punto di vista comunicativo.
L’ITALIANO DELLE TRADUZIONI
1) Descrivere brevemente gli “universali traduttivi”
Per universali traduttivi si intendono le tendenze e strategie adottate da qualsiasi
traduttore senza tener conto della coppia di lingue di riferimento.
Gli universali traduttivi si dividono in cinque categorie:
SEMPLIFICAZIONE. Si ottiene attraverso l’eliminazione di ripetizioni, una
sintassi più elementare e un lessico meno connotato. Tendenzialmente le
traduzioni sono caratterizzate da una lingua più semplice sia rispetto all’originale,
sia rispetto alla lingua d’arrivo. Si possono trovare delle espressioni meno
specifiche, ma più comprensibili che rendono il testo più fruibile per il lettore nella
lingua di arrivo. Le scelte lessicali tendono ad appiattirsi su varietà poco connotate
e a prediligere iperonimi, approssimazioni culturali e parafrasi esplicative
al posto di termini specifici.
ESPLICITAZIONE. L’esplicitazione riguarda l’aggiunta di informazioni da parte
del traduttore che nel testo originale erano lasciate implicite, favorendo una
maggiore comprensione da parte del lettore. Nelle traduzioni i nessi logici vengono
esplicitati attraverso l’inserimento di connettivi che esplicitano i legami tra le
varie parti del testo, facilitandone così la comprensione. Si inseriscono informazioni
aggiuntive e precisazioni attraverso l’uso di proposizioni relative e un forte uso di
aggettivi. In questo modo le informazioni implicite vengono in superficie, così da
proporre al lettore nella lingua di arrivo un testo di più facile lettura. Anche per
questo le traduzioni tendono ad essere più lunghe dei testi di partenza.
L’INTERFERENZA (o linguistic transfer) è la ripresa del testo fonte a livello di
struttura, ricalcata e profusa nel testo d’arrivo. Si tratta di trasferimento
linguistico, di interferenza, che si verifica nel caso in cui la lingua di partenza ha
una qualche influenza sulle strutture della lingua di arrivo a qualsiasi livello:
testuale, morfologico, lessicale, sintattico. Idealmente il calco delle strutture del
testo di partenza dovrebbe essere considerato un errore nelle traduzioni. Si
suppone dunque che il peso dell’interferenza vari molto a seconda
dell’esperienza del traduttore: più esperienza ha nelle traduzioni di testo, meno
forte sarà l’interferenza linguistica che traspare dai suoi testi. L’interferenza
dipende anche molto dal prestigio della lingua di partenza. Se si traduce da una
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
lingua estremamente prestigiosa la tentazione a farla trasparire nella traduzione
sarà maggiore, al contrario se si traduce poca conosciuta questa tentazione sarà
minore.
NORMALIZZAZIONE. È un mezzo attraverso il quale il traduttore tende ad
omologare il testo alla cultura di arrivo, rendendolo più convenzionale e
fruibile. Il traduttore cerca di rispettare la norma codificata della lingua di arrivo.
Eventuali peculiarità stilistiche del testo di partenza (per es. punteggiatura
irregolare, strutture sintattiche incomplete, l’imitazione della varietà orale della
lingua, l’impiego di espressioni originali o arcaiche) possono venire
“normalizzate” nella traduzione, che risulta più convenzionale nella cultura di
arrivo.
CONVERGENZA. La convergenza in un corpus di testi tradotti evidenzia quanto i
testi risultino meno differenti tra loro rispetto ai testi di un corpus non tradotto.
2) Che conseguenze prevede sul testo tradotto l’universale traduttivo della
semplificazione?
La semplificazione si ottiene attraverso l’eliminazione di ripetizioni, una sintassi più
elementare e un lessico meno connotato. Tendenzialmente le traduzioni sono
caratterizzate da una lingua più semplice sia rispetto all’originale, sia rispetto alla
lingua d’arrivo. Si possono trovare delle espressioni meno specifiche, ma più
comprensibili che rendono il testo più fruibile per il lettore nella lingua di arrivo. Le
scelte lessicali tendono ad appiattirsi su varietà poco connotate e a prediligere
iperonimi, approssimazioni culturali e parafrasi esplicative al posto di termini specifici.
3) Che conseguenze prevede sul testo tradotto l’universale traduttivo
dell’esplicitazione?
Riguarda l’aggiunta di informazioni da parte del traduttore che nel testo originale
erano lasciate implicite, favorendo una maggiore comprensione da parte del lettore.
Nelle traduzioni i nessi logici vengono esplicitati attraverso l’inserimento di connettivi
che esplicitano i legami tra le varie parti del testo, facilitandone così la comprensione.
Si inseriscono informazioni aggiuntive e precisazioni attraverso l’uso di proposizioni
relative e un forte uso di aggettivi. In questo modo le informazioni implicite vengono in
superficie, così da proporre al lettore nella lingua di arrivo un testo di più facile lettura.
Anche per questo le traduzioni tendono ad essere più lunghe dei testi di partenza.
Talvolta anche a livello sintattico e riguardante gli elementi funzionali si riscontra
un’incidenza minore di complementatori (I think you are a pretty girl > in italiano il
“che” sottinteso viene ripristinato: “Penso CHE tu sia una bella ragazza”).
4) Che conseguenze prevede sul testo tradotto l’universale traduttivo della
normalizzazione?
È un mezzo attraverso il quale il traduttore tende ad omologare il testo alla cultura di
arrivo, rendendolo più convenzionale e fruibile. Il traduttore cerca di rispettare la
norma codificata della lingua di arrivo. Eventuali peculiarità stilistiche del testo di
partenza (per es. punteggiatura irregolare, strutture sintattiche incomplete,
l’imitazione della varietà orale della lingua, l’impiego di espressioni originali o
arcaiche) possono venire “normalizzate” nella traduzione, che risulta più
convenzionale nella cultura di arrivo.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
In una traduzione, adottando la strategia della normalizzazione, anche detta
conservatorismo, convenzionalizzazione o “law of growing standardization” il
traduttore cerca di rispettare la norma codificata della lingua di arrivo.
Eventuali peculiarità stilistiche del testo di partenza (per es. punteggiatura irregolare,
strutture sintattiche incomplete, l’imitazione della varietà orale della lingua, l’impiego
di espressioni originali o arcaiche) vengono “normalizzate” nella traduzione, che
risulta più convenzionale in seno alla cultura di arrivo. Dalle statistiche si riscontra un
minor numero di hapax, una riduzione della creatività lessicale, un uso delle
collocazioni più classiche e diffuse (stipulare un contratto anziché fare un contratto), e
un maggior numero di frasi fatte e espressioni idiomatiche. In italiano si tende a
utilizzare la versione standard della lingua, quella scolastica, e l’interpretazione è
generalmente “migliorata” e più simile allo scritto.
5) Che conseguenze prevede sul testo tradotto l’universale traduttivo della
convergenza?
La convergenza in un corpus di testi tradotti evidenzia quanto i testi risultino meno
differenti tra loro rispetto ai testi di un corpus non tradotto.
È possibile constatare che i testi tradotti sono più simili tra loro rispetto a quanto i testi
originali sono simili tra loro. Le cause sono da ricercare nel fatto che le traduzioni
riflettono meno lo stile dell’autore originale e, pertanto, si avvicinano tutte ad un
modello standard di lingua. A livello pratico si può notare che i testi tradotti
presentano periodi lunghi e una densità lessicale media.
6) Che conseguenze prevede sul testo tradotto la “legge dell’interferenza
linguistica”?
La legge dell’interferenza linguistica prevede un’influenza sulla lingua d’arrivo da
parte della lingua di partenza. In realtà l’interferenza non è un universale in senso
stretto, perché dipende dalle lingue coinvolte e dal prestigio della lingua di partenza
rispetto a quello della lingua d’arrivo. Ci sono diverse espressioni di questa legge, tra
le quali possiamo notare la Unique Items Hypothesis che si basa sul fatto che gli
strumenti della lingua di arrivo di cui la lingua di partenza non è provvista appaiono
nei testi tradotti in maniera molto minore rispetto a testi omologhi scritti direttamente
nella lingua di arrivo. Inoltre, nei testi tradotti il numero di ripetizione è molto minore
rispetto agli originali perché i traduttori tendono a impiegare perifrasi e sinonimi anche
se il testo originale riporta molte volte la stessa parola. È interessante inoltre notare
che le traduzioni successive tendono ad avvicinarsi sempre di più al testo di partenza.
7) Cosa si intende per S-Univ ersals e T-Universals?
Un metodo universale di classificazione degli universali traduttivi non esiste. Il metodo
adottato da Chersterman, ad esempio, è la distinzione tra S-universals e T-
universals. I primi sono quelli che possono essere individuati solo comparando la
traduzione al testo di partenza, tra i quali figurano interferenza (ricalco delle
strutture del TP), standardizzazione e normalizzazione dei dialetti (lingua più
convenzionale), scelta di istanze narrative più semplici, esplicitazione, testo tradotto
più lungo dell’originale, traduzioni successive più vicine all’originale e riduzione delle
ripetizioni. T-universals sono invece quelle tendenze traduttive verificabili
comparando la traduzione a corpora analoghi della lingua di arrivo, quindi
anche a prescindere dal testo di partenza. Tra queste troviamo semplificazione,
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
convenzionalizzazione, strutture lessicali meno tipiche e stabili e
sottorappresentazione degli specific items della lingua di arrivo.
8) In che modo l’attrito linguistico può influenzare la qualità delle
traduzioni?
In alcuni casi nei parlanti quasi nativi sottoposti al contatto continuo con una lingua
straniera si verifica una modificazione della grammatica mentale della lingua
nativa. Questo fenomeno non coinvolge le strutture base della lingua, ma le
interfacce, ovvero il punto di incontro tra sintassi e grammatica. Un esempio è la
tendenza ad esplicitare in italiano il pronome personale soggetto, che di solito si
omette, perché sotto l’influenza di una lingua in cui non è possibile ometterlo.
9) Cosa sono i fenomeni di interfaccia?
I fenomeni di interfaccia sono quei fenomeni in cui sintassi semantica e pragmatica
interagiscono e che tradizionalmente individuano le aree più marginali o vulnerabili
del sistema. Un esempio è la tendenza ad esplicitare in italiano il pronome personale
soggetto, che di solito si omette, perché sotto l’influenza di una lingua in cui non è
possibile ometterlo.
In queste scelte traduttive si nota una differenza di tipo pragmatico: se si rende
esplicito il soggetto vuol dire fare distinzione, ma dal punto di vista grammaticale non
cambia nulla e risulta difficile gestire questo aspetto.
10) Sulla base degli studi disponibili, illustrare i principali tratti dell’italiano
delle traduzioni a livello del lessico.
Le caratteristiche dell’italiano delle traduzioni a livello del lessico si riscontrano nella
RISEMANTIZZAZIONE, nella COMPOSIZIONE, nei FRASEOLOGISMI e nella
NORMALIZZAZIONE.
- Le risemantizzazioni sono assunzioni, ma anche recuperi, di significati non
italiani, ad esempio realizzare nel significato di capire, dal francese.
- Per quanto riguarda la composizione, nell’italiano delle traduzioni si possono
trovare: calchi di struttura dalla lingua di partenza come calcio mercato,
acquascivolo, tossicodipendente (generalmente nelle lingue romanze la testa
precede il modificatore, in inglese invece il modificatore precede la testa) e
prefissi, tra i quali: co- (ad esempio coetaneo; generalmente indica collaborazione
o condivisione, di regola richiede di aggiungere -n davanti a una consonante), in-
(come indelicato, incontrollato; è sempre esistito ma oggi è aumentato il suo uso e
indica spesso qualcosa di negativo), auto- (riflessivo: autodifesa, autodenunciarsi,
anticausativo: autoaccensione, focalizzante: autogestione), in inglese le parole
cambiano, mentre in italiano si modificano (es. jump, hop, skip e saltare, saltellare,
salterellare) e questo prefisso che viene da self, colma un buco semantico in
italiano (riflessivo) ed è presente quando ci si aspetta una causa esterna oppure
focalizzante (se l’agente è diverso da quello atteso, ad esempio autogestione, fatta
dagli studenti) e inter- (reciproco:intercomprensione, prima indicava tra molti).
- I fraseologismi più comuni dell’italiano delle traduzioni sono: “Come posso
aiutarla?” (da “How can I help you?”), “Qual è il tuo nome?” (da “What is your
name?”), “Assolutamente” (da “Absolutely” con significato affermativo), “Dov’è il
problema?” (da “Where is the problem?”). Altre caratteristiche dei fraseologismi
dell’italiano delle traduzioni sono: interferenza sintagmatica (qualcuno la voleva
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
portare lontana da te, invece di “allontanare”), interferenza fraseologica,
idiomatismi (non è come andare in bicicletta, invece di “bere un bicchier d’acqua”),
unità fraseologiche (sono assolutamente convinta, invece di “del tutto certa”),
traduzioni approssimative come costrutti innaturali (può darsi che questo abbia
elevato il livello di stress, invece di “fatto aumentare lo stress”), improprietà
sintagmatiche (le immagini che hai visto è quello che dovrai affrontare, invece di
“mostrano ciò che”, anacoluto) e a livello semantico (permesso di lavoro, invece di
“dal lavoro”).
- Nel caso dell’italiano tradotto si parla anche di normalizzazione: in generale, nelle
traduzioni si nota la riduzione di disfemismi e volgarismi e l’assenza di variazione
diatopica.
11) Sulla base degli studi disponibili, illustrare i principali tratti dell’italiano
delle traduzioni a
livello della morfologia.
A livello della morfologia, i principali tratti dell’italiano sono:
- SISTEMA PRONOMINALE
• PRONOME FORTE VS PRONOME DEBOLE. Una delle caratteristiche dell’italiano è la
forte presenza di pronomi. Nelle traduzioni si ha una sovra rappresentazione
pronominale, in particolare delle forme forti, per cui nell’esempio “Quando Carlo è
entrato, lui era ubriaco” il pronome “lui” si può attribuire al fenomeno dell’interferenza
di lingue dove il soggetto è sempre espresso. Ma nella lingua italiana, quando come
nell’esempio il soggetto viene ripetuto, sembra non ci sia coreferenza, si pensa che
“lui” sia riferito a un’altra persona. Infatti, in italiano si esplicita il soggetto forte solo
quando questo cambia rispetto al pronome precedente.
• LORO DATIVALE. Nell’italiano dell’uso medio la forma “loro” dativale rappresenta un
po’ uno squilibrio del sistema, in quanto è un pronome in teoria debole, ma che si
comporta come un wepronome forte. Quando questo avviene, “loro” si trova in
posizione post-verbale, ma nell’italiano dell’uso medio viene sostituito da “gli”. “Loro”
ritorna nell’italiano tradotto per aderenza allo standard.
• LUI DATIVALE. Nella lingua italiana, si registrano casi sporadici di “lui” dativale senza
“a”. Come ad esempio: “Lei lo vide e diede lui una lettera”.
È un fenomeno che proveniente dalla lingua inglese e che influenza l’italiano, in cui i
pronomi (anche deboli) si trovano in posizione post-verbale.
Per quanto riguarda la morfologia verbale:
- FREQUENZA DEL CONGIUNTIVO. Il congiuntivo in italiano è considerato una marca
sociale, così come lo è la pronuncia in altri paesi. È tipico di un italiano formale,
elegante, ed è molto frequente, ad esempio, negli articoli di giornale tradotti anziché
in quelli originali.
- FREQUENZA DELLA PERIFRASI PROGRESSIVA. La perifrasi progressiva risulta in
crescita sia in italiano che in inglese. Nei testi tradotti in italiano se ne verifica un
aumento marcato, di conseguenza se ne deduce una forte influenza da parte della
lingua inglese. Un esempio che lo dimostra è la frase: “non ci sto capendo niente”.
Invece, in italiano la perifrasi progressiva ha dei vincoli maggiori, ovvero non è
possibile utilizzarla se non in senso puramente progressivo. Ad esempio, la frase:
“Questo libro sta avendo molto successo” è esplicativa di tale limite in quanto un libro
o ha successo oppure no, mentre è considerata accettabile perché ha acquisito il
significato di “avere successo in maniera crescente”.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
12) Sulla base degli studi disponibili, illustrare i principali tratti dell’italiano
delle traduzioni a
livello della sintassi.
I principali tratti dell’italiano delle traduzioni a livello della sintassi sono:
- Grazie per + infinito semplice. Nell’esempio “Grazie per rispondere subito” l’influenza
dell’inglese è evidente, dal momento che in italiano corrisponde a: “grazie per aver
risposto subito”.
- Minore grado di subordinazione e frasi più brevi. Un altro fenomeno che riguarda la
sintassi è quello dello snellimento dell’ipotassi. L’influenza dell’inglese va a rafforzare
una tendenza già in atto in Italia già dagli anni ’60. E’ molt o raro arrivare oltre al 2° o
3° grado di subordinazione. Normalmente tendiamo alla giustapposizione o alla
coordinazione o alle frasi semplici collegate con interpunzione.
13) Sulla base degli studi disponibili, illustrare i principali tratti dell’italiano
delle traduzioni a
livello della testualità.
A livello della testualità, l’italiano delle traduzioni presenta i seguenti tratti:
- largo uso di inaccusativi (molti studenti sono arrivati, Marco è andato…) e di
sostantivi con plurali indeterminati accompagnati da articolo 0 (cioè senza articolo).
-uso di operatori negativi come “niente” e “nessuno” (non mi ha visto nessuno) e di
“verba dicendi” (“Ahi!” esclamò\disse Giovanna).
-ampio uso di relative semplici (una piccola fortuna che gli avevano lasciato i suoi
genitori vs. una piccola fortuna che i suoi genitori avevano lasciato a sua zia – è
presente una dislocazione a destra del soggetto nella prima frase, rispetto alla
posizione non marcata del soggetto nella seconda)
- ampio uso di circostanziali dislocate a destra e a sinistra (What’s the trouble then?
-> Allora, qual è il problema?)
-ampio uso della resa grafica del focus contrastivo, ossia della messa in rilievo del
rema in frasi come “Perché Harry non era un ragazzo normale…” (“Because Harry
wasn’t a normal boy…”).
14) Sulla base degli studi disponibili, illustrare i principali tratti dell’italiano
delle traduzioni a livello di lessico, morfologia, sintassi e testualità
Vedi sopra
15) Perché è difficile ricondurre i tratti che differenziano testi tradotti e testi
originali a un preciso universale traduttivo? Fornire qualche esempio.
In primo luogo, gli italiani hanno una scarsa conoscenza della differenza tra l’italiano
delle traduzioni e la loro lingua, anche perché difficilmente entrano in contatto con
testi in lingua. Le caratteristiche delle traduzioni non corrispondono a quelle dei testi
scritti direttamente in lingua italiana, ma ciò non è immediato e percepibile poiché è
necessario un gran numero di testi per riuscire a osservare le differenze tra i due tipi
di italiano. In ogni caso, anche avvalendosi dell’analisi automatica della linguistica dei
corpora, è difficile individuare elementi chiari ed eventi, è più probabile piuttosto
individuare delle caratteristiche del traduttese che sono percepibili più che altro come
delle tendenze di fondo.
Ad esempio, dallo studio di Cortelazzo emerge che c’è un grosso divario nell’uso di
egli/ella tra l’italiano scritto generale e quello scritto delle traduzioni. Considerando
soltanto “egli”, questo viene usato nelle traduzioni circa il 43% delle volte, mentre
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
nell’italiano scritto in generale solo circa il 14%. Inoltre, sempre dallo studio sul corpus
di Cortelazzo, si evince che nelle traduzioni si fa un uso maggiore di pronomi personali
soggetto (mentre nello scritto generale vengono spesso omessi) e della perifrasi
composta stare seguito dal gerundio, probabilmente perché è una forma molto
comune in inglese (i’m eating, I’m feeling, I’m taking ecc.) che però in italiano scritto
viene molto spesso sostituita dal presente indicativo (mangio, mi sento, prendo ecc.).
WEBWRITING
1) Come è possibile definire la scrittura elettronica in relazione a mezzo
tecnico, modalità di produzione, modalità di ricezione, modalità di
trasmissione, volatilità?
La definizione di scrittura elettronica varia in base al punto di vista che si assume.
Il mezzo tecnico, vale a dire il computer, permette di generare un testo fruibile senza
limiti di tempo e di spazio da qualsiasi utente. Il risultato è un ipertesto che si
espande in profondità, permettendo al lettore di leggerne più parti e addirittura
scaricarlo.
La modalità di produzione di un testo elettronico, inoltre, è cambiata su diversi
aspetti:
- si tende a scrivere “a blocchi”, a paragrafi indipendenti, meno collegati tra loro;
- lo scrittore ha l’illusione che il proprio testo sia già ben scritto alla prima stesura
perché graficamente “pulito” e tenderà a correggerlo di meno;
- c’è un’ampia scelta di variazione tipografica del testo elettronico e quindi si
riscontra una più assidua differenziazione dei caratteri usati;
- il computer offre anche di default dei templates, ossia strutture redazionali
predeterminate, che tendiamo ad accettare passivamente.
- un testo che si trova su internet è un ipertesto, ovvero si espande in profondità, non
ha vincoli di tempo (può essere modificato nel tempo) né di spazio (non ci sono limiti
di lunghezza, e può essere letto fuori contesto cronologico). Chi ha una maggiore
dimestichezza con il pc, tende a sfruttare possibilità non disponibili su un testo su
carta, come l’inserzione di immagini, video, gif, link, ecc.
- il tempo di scrittura è decisamente minore, anche se dipende comunque dal tipo di
testo prodotto: in molti casi un testo viene scritto senza revisione o rilettura (come
accade in un forum); in altri casi il testo è prodotto rapidamente ma è revisionato
(esempio di un blog); in altri ancora la scrittura è convenzionale (siti web); infine, in
alcuni la scrittura è progettata per altri media (pdf).
In relazione alla modalità di ricezione, la scrittura elettronica presenta le seguenti
caratteristiche:
- la lettura veloce, definita a pelle di leopardo, in quanto il lettore dispone di
un’unica enciclopedia come Google, con il rischio di dimenticarsi dell’indipendenza
di ciascuna pagina web, e scorre velocemente il testo per raggiungere lo scopo
prefissato.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
- Lettura non consequenziale né lineare: esplorazione da parte del lettore, che
prosegue la sua ricerca finché non trova quello di cui ha bisogno e spesso può
avere difficoltà nell’orientarsi tra l’infinità di informazioni offerte dal Web;
- la difficoltà di lettura, vale a dire che la lettura su schermo risulta più complessa
in quanto stanca di più l’occhio del lettore;
- la possibilità di interazione, di avere un rapporto più attivo con il testo rispetto
alla passività ricettiva sulla carta;
- sul web è importante la qualità e l’efficacia dei contenuti che si vogliono
trasmettere dato che lo scrittore non ha intermediari, quindi la responsabilità è
solo di chi redige i testi.
- Uno scrittore integra dunque il testo con altri elementi tipici del web, come
l’impaginazione e la grafica.
Per quanto riguarda la modalità di trasmissione:
- i testi web si caratterizzano di un rapporto dialogico e di un’interazione
immediata. Devono dunque essere il più diretti possibile e molto più informali di un
testo su carta. Chi scrive deve tenere conto della poca pazienza di coloro che fruiranno
del testo finale: un lettore impiega in media 10 secondi per capire se il testo può
essere di suo interesse, attraverso una rapida scansione alla ricerca di frasi e parole
che possano attirare la sua attenzione, altrimenti passa immediatamente a un altro
sito.
- le frasi saranno di conseguenza semplici, brevi, concise, esaustive e si
privilegerà l’uso della paratassi e di forme attive con esplicitazione di soggetto. I
gerghi e le frasi fatte non sono utilizzati, così come le nominalizzazioni o gli incisi.
- si cercherà di essere il meno impersonali possibile perché i testi sul web si rivolgono
a un destinatario specifico. Il tono è colloquiale e diretto, e se è possibile si passa
dalla terza alla prima persona singolare.
- si effettua una divisione del testo in paragrafi, titolandoli in base alle unità
formative. I link permettono di asciugare il testo e quindi di ridurlo, ma fungono anche
da ancoraggio visivo: è importante che siano autoesplicativi e brevi.
- inoltre, si dovrà inserire un indice (che può trovarsi all’inizio), soprattutto se le
pagine sono lunghe, con collegamenti alla pagina corrispondente.
2) Che conseguenze hanno le modalità di produzione del testo sulle
caratteristiche della scrittura elettronica?
Per quanto riguarda la modalità di produzione, si può affermare che questa sia
cambiata su diversi aspetti con l’avvento della scrittura elettronica, provocando
diverse conseguenze:
- si tende a scrivere “a blocchi”, a paragrafi indipendenti, meno collegati tra loro;
- lo scrittore ha l’illusione che il proprio testo sia già ben scritto alla prima stesura
perché graficamente “pulito” e tenderà a correggerlo di meno;
- c’è un’ampia scelta di variazione tipografica del testo elettronico e quindi si
riscontra una più assidua differenziazione dei caratteri usati;
- il computer offre anche di default dei templates, ossia strutture redazionali
predeterminate, che tendiamo ad accettare passivamente.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
- un testo che si trova su internet è un ipertesto, ovvero si espande in profondità, non
ha vincoli di tempo (può essere modificato nel tempo) né di spazio (non ci sono limiti
di lunghezza, e può essere letto fuori contesto cronologico). Chi ha una maggiore
dimestichezza con il pc, tende a sfruttare possibilità non disponibili su un testo su
carta, come l’inserzione di immagini, video, gif, link, ecc.
- il tempo di scrittura è decisamente minore, anche se dipende comunque dal tipo di
testo prodotto: in molti casi un testo viene scritto senza revisione o rilettura (come
accade in un forum); in altri casi il testo è prodotto rapidamente ma è revisionato
(esempio di un blog); in altri ancora la scrittura è convenzionale (siti web); infine, in
alcuni la scrittura è progettata per altri media (pdf).
3) Che conseguenze hanno le modalità di ricezione del testo sulle
caratteristiche della scrittura elettronica?
In relazione alla modalità di ricezione, la scrittura elettronica presenta le seguenti
caratteristiche:
- la lettura veloce, definita a pelle di leopardo, in quanto il lettore dispone di
un’unica enciclopedia come Google, con il rischio di dimenticarsi dell’indipendenza
di ciascuna pagina web, e scorre velocemente il testo per raggiungere lo scopo
prefissato.
- Lettura non consequenziale né lineare: esplorazione da parte del lettore, che
prosegue la sua ricerca finché non trova quello di cui ha bisogno e spesso può
avere difficoltà nell’orientarsi tra l’infinità di informazioni offerte dal Web;
- la difficoltà di lettura, vale a dire che la lettura su schermo risulta più complessa
in quanto stanca di più l’occhio del lettore;
- la possibilità di interazione, di avere un rapporto più attivo con il testo rispetto
alla passività ricettiva sulla carta;
- sul web è importante la qualità e l’efficacia dei contenuti che si vogliono
trasmettere dato che lo scrittore non ha intermediari, quindi la responsabilità è
solo di chi redige i testi.
- Uno scrittore integra dunque il testo con altri elementi tipici del web, come
l’impaginazione e la grafica.
4) Quali sono le caratteristiche della lettura di testi online? Cosa ci dicono gli
studi di eyetracking?
La lettura di testi online avviene in maniera molto frenetica e approssimativa, in
quanto si tratta di un’esperienza diversa dalla lettura su carta: è più faticosa e più
lenta del 25% a causa di una risoluzione più bassa. L’utente online inoltre non
ammette la perdita di tempo, sceglie se restare su una determinata pagina web in
circa 10 secondi, in quanto l’offerta di pagine potenzialmente più interessanti è molto
ampia. Generalmente, quindi, non si sofferma sulle singole parole, ma sui segnali
testuali che catturano la sua attenzione (link, parole chiave, sottotitoli, ecc.).
Gli studi di eyetracking approfondiscono ancora meglio la modalità in cui l’utente
medio legge sul web, e lo fanno osservando tramite mappe termiche dove cade
l’occhio e per quanto tempo, se si cerca qualche elemento in particolare e se si tratta
di lettura vera e propria o di una semplice scorsa.
Dai risultati è emerso che, in una pagina in cui il testo è dominante, il pattern di
lettura più frequente è quello “a F”, in cui i punti di fissazione intensa si trovano
in alto a sinistra e, a scendere, lungo il margine sinistro.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
5) E’ vero che la lettura lineare e lo scanning distinguono la lettura su carta
e quella online?
Sia su web che su carta lettura e scanning coesistono, difatti anche per la lettura su
carta le pagine e gli articoli che non si trovano interessanti non vengono letti
interamente (secondo un recente studio, sul web si legge in media il 77% di un
articolo, su carta il 62%) In entrambi i casi inoltre sono apprezzate forme testuali, ad
esempio didascalie o liste, che rendono il testo più fruibile per il lettore.
Tuttavia, si individuano alcune differenze tra la lettura su carta e quella online: per
quanto riguarda le difficoltà che l’utente può riscontrare, in primo luogo è da
segnalare che leggere su schermo è più difficile che leggere su carta, perché affatica
maggiormente l’occhio del lettore nonostante questo esplori testo elettronico senza
scendere nel dettaglio. In secondo luogo, ricostruire il contesto sul web può
rappresentare un problema, perché l’utente può aprire diverse pagine con il rischio di
disorientarsi e non capire più in quale punto del web si trovi.
Per ciò che concerne la grafica e il layout invece, su schermo ogni frase deve essere
formata da un massimo di 15 parole (su carta invece 25). In più, se su carta è
sufficiente avere paragrafi, sul web è necessario tenere conto anche di altri aspetti
grafici: punti ancoraggio ed elementi messi in risalto sono la base per la lettura della
pagina web e per catturare l’attenzione del lettore.
6) Per quali motivi la struttura della “piramide rovesciata” risulta
particolarmente adatta alla lettura online? In cosa consiste?
In un testo normale la struttura è composta, in ordine, da una frase introduttiva, una
descrizione generale e, a concludere, l’informazione principale. Nella lettura online si
riscontra invece un “rovesciamento” di tale struttura, ciò avviene perché si tratta di
una lettura veloce che deve riuscire a fornire al lettore l’informazione di cui ha bisogno
in brevissimo tempo. Occorre quindi scrivere il titolo all’inizio, essendo la parte più
importante, successivamente si aggiungono dei particolari (sottotitoli), in seguito si
scrive il testo, e in conclusione si aggiungono, eventualmente, degli approfondimenti
ipertestuali contenuti in un link (il quale a sua volta svolge la funzione di ancoraggio
visivo). La piramide rovesciata è utilissima nei siti di informazione, e meno usata nei
siti di “narrativa”.
7) Che differenze intercorrono tra la strutturazione tradizionale di un testo
istituzionale su carta e la strutturazione più funzionale alla lettura online?
Nella strutturazione tradizionale di un testo si tende a mettere in seconda posizione
l’informazione principale e a privilegiare l’inserimento di informazioni secondarie,
premesse e dettagli. Si è abituati ad una strutturazione del testo che prevede
un’introduzione fatta da premesse, un corpo del testo con le informazioni utili seguito
da dettagli tecnici e infine una conclusione che riassume quanto detto in precedenza.
Per tipi di testi a carattere informativo è più funzionale una scrittura rovesciata che
presenti in primo luogo, tramite il titolo, l’informazione principale che è la più
importante per il lettore e da questa che scenda poi nel particolare, nelle spiegazioni
e negli approfondimenti attraverso un link.
8) Identificare le principali caratteristiche del seguente testo destinato alla
pubblicazione online e proporre una redazione più efficace.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: emil.89 (emilio.polito2000@gmail.com)
Potrebbero piacerti anche
- La lingua Italiana: breve storia e approcci glottodidattici come L2Da EverandLa lingua Italiana: breve storia e approcci glottodidattici come L2Nessuna valutazione finora
- Elementi Di Linguistica ItalianaDocumento34 pagineElementi Di Linguistica ItalianaMockingbird YuZa Sakigami100% (2)
- Varietà sociali nell'italiano contemporaneo: i gerghi come sottocodici non tecniciDa EverandVarietà sociali nell'italiano contemporaneo: i gerghi come sottocodici non tecniciNessuna valutazione finora
- Varietà Dell'italianoDocumento41 pagineVarietà Dell'italianoAbramo Di FucciaNessuna valutazione finora
- SOCIOLINGUISTICADocumento6 pagineSOCIOLINGUISTICAGeorge PoulopoulosNessuna valutazione finora
- L'Italiano e Le Sue VarietàDocumento16 pagineL'Italiano e Le Sue VarietàFrancescaFaverio100% (1)
- 978 88 6969 650 3 CH 02 - 7P6SHEHDocumento18 pagine978 88 6969 650 3 CH 02 - 7P6SHEHSindbad lombardiNessuna valutazione finora
- Prima Lezione Di SociolinguisticaDocumento20 paginePrima Lezione Di SociolinguisticaAntonina RagusaNessuna valutazione finora
- 6 - L'italiano Usi Strutture e Varietà - Le Tante Varietà Di Cui Si Servono Gli ItalianiDocumento10 pagine6 - L'italiano Usi Strutture e Varietà - Le Tante Varietà Di Cui Si Servono Gli ItalianiFrancesca FerraioliNessuna valutazione finora
- Sociolinguistica Nozioni Da ConscereDocumento12 pagineSociolinguistica Nozioni Da ConscereelionanaqoNessuna valutazione finora
- CONTATTODocumento23 pagineCONTATTOangela.peccioliNessuna valutazione finora
- Lingua e SocietàDocumento6 pagineLingua e SocietàEriseldaNessuna valutazione finora
- Giuliana Fiorentino Quale Italiano Parlano Le GrammaticheDocumento16 pagineGiuliana Fiorentino Quale Italiano Parlano Le GrammaticheMariana CruzNessuna valutazione finora
- LINGUISTICA ITALIANA LibroDocumento31 pagineLINGUISTICA ITALIANA LibroSofia CarpentieriNessuna valutazione finora
- Dispensa Ii SemestreDocumento47 pagineDispensa Ii SemestreSerena SchiliròNessuna valutazione finora
- Termini Per Lingua ItalianaDocumento54 pagineTermini Per Lingua ItalianaGiorgia GrecoNessuna valutazione finora
- Dialetto, Dialetti e Italiano.Documento7 pagineDialetto, Dialetti e Italiano.Fiorinda94Nessuna valutazione finora
- Linguistica CompletoDocumento63 pagineLinguistica CompletoAlessia MarianiNessuna valutazione finora
- (Ebook - ITA - SAGG - Filologia Bico, M. - Evoluzione Della Lingua e Della A PDFDocumento15 pagine(Ebook - ITA - SAGG - Filologia Bico, M. - Evoluzione Della Lingua e Della A PDFIoana Laura CaloeanNessuna valutazione finora
- Linguistica Di Contatto - OdtDocumento26 pagineLinguistica Di Contatto - OdtSylviaAubergineManzioneNessuna valutazione finora
- Onesti - DITALS - Profilo SociolinguisticoDocumento39 pagineOnesti - DITALS - Profilo SociolinguisticofloringabrielserbuNessuna valutazione finora
- Books 2010 2019 077-2014-1 5Documento32 pagineBooks 2010 2019 077-2014-1 5Annye AnNessuna valutazione finora
- Ma Nu AleDocumento45 pagineMa Nu AlechiccalavedaNessuna valutazione finora
- Bolognesi-IL SARDO TRA ISOLAMENTO E CONTATTO: UNA RIANALISI DI ALCUNI STEREOTIPI 1Documento47 pagineBolognesi-IL SARDO TRA ISOLAMENTO E CONTATTO: UNA RIANALISI DI ALCUNI STEREOTIPI 1Venerio Giuseppe AnarduNessuna valutazione finora
- Appunti Sociolinguistica Dell'italianoDocumento33 pagineAppunti Sociolinguistica Dell'italianoalessiochisari918Nessuna valutazione finora
- Appunti Geografia IDocumento65 pagineAppunti Geografia IAlessia MonacoNessuna valutazione finora
- Italiano l2Documento13 pagineItaliano l2Zsuzsa GyenesNessuna valutazione finora
- 1.manuale Di Sociolinguistica BerrutocerrutiDocumento29 pagine1.manuale Di Sociolinguistica BerrutocerrutiMatteoNessuna valutazione finora
- Appunti Di DialettologiaDocumento52 pagineAppunti Di DialettologiaCarola FiorindoNessuna valutazione finora
- G. Berruto, Varietà in "Enciclopedia Dell'Italiano"Documento5 pagineG. Berruto, Varietà in "Enciclopedia Dell'Italiano"letizia_836750097Nessuna valutazione finora
- Linguistica - Risposte AperteDocumento60 pagineLinguistica - Risposte Aperteenrica100% (1)
- Lingua ItalianaDocumento47 pagineLingua Italianathecorfiot5Nessuna valutazione finora
- La SociolinguisticaDocumento18 pagineLa SociolinguisticaInes mahdiNessuna valutazione finora
- Funzioni Lingua ItalianaDocumento23 pagineFunzioni Lingua ItalianapronaturaalNessuna valutazione finora
- Linguaggio Settoriale Del Project Management. Analisi Lessicale Del Glossario Dei Termini Di Project Management Della Guida Pmbok®Documento6 pagineLinguaggio Settoriale Del Project Management. Analisi Lessicale Del Glossario Dei Termini Di Project Management Della Guida Pmbok®MRzNessuna valutazione finora
- Riassunti Di Sociolinguistica PDFDocumento7 pagineRiassunti Di Sociolinguistica PDFanopticon100% (2)
- Riassunto BerrutoDocumento26 pagineRiassunto BerrutoClaudia CiminelliNessuna valutazione finora
- Italiano e DialettiDocumento14 pagineItaliano e DialettiCurso de ItalianoNessuna valutazione finora
- Manuale Di SociolinguisticaDocumento36 pagineManuale Di SociolinguisticaGiovanni PollastroNessuna valutazione finora
- Unità XII - PER UN APPROCCIO VARIETISTICO ALL'INSEGNAMENTO DELL'ITALIANO A STRANIERI Alberto A. Sobrero, Annarita MigliettaDocumento15 pagineUnità XII - PER UN APPROCCIO VARIETISTICO ALL'INSEGNAMENTO DELL'ITALIANO A STRANIERI Alberto A. Sobrero, Annarita MigliettaMaria CucurachiNessuna valutazione finora
- Linguistica ItalianaDocumento76 pagineLinguistica Italiana469cwvnb5sNessuna valutazione finora
- Linguistica1 PDFDocumento143 pagineLinguistica1 PDFIdaNessuna valutazione finora
- Linguistica TreDocumento13 pagineLinguistica TreElenia RicciNessuna valutazione finora
- Il BilinguismoDocumento10 pagineIl BilinguismoLara TrišićNessuna valutazione finora
- Manuele Di Sociolinguistica, Berruto CerrutiDocumento28 pagineManuele Di Sociolinguistica, Berruto CerrutiElvira PaganoNessuna valutazione finora
- Domande Sociolinguistica GPTDocumento6 pagineDomande Sociolinguistica GPTalex25Nessuna valutazione finora
- Riassunto LA LINGUA È UN'ORCHESTRA (M. Bricchi)Documento45 pagineRiassunto LA LINGUA È UN'ORCHESTRA (M. Bricchi)giancarlo SciortinoNessuna valutazione finora
- SociolinguisticaDocumento12 pagineSociolinguisticacacatuareaNessuna valutazione finora
- L Italiano Nella Societa Della Comunicazione Giuseppe AntonelliDocumento17 pagineL Italiano Nella Societa Della Comunicazione Giuseppe AntonelliClaudiaConteNessuna valutazione finora
- Elementi Di Linguistica ItalianaDocumento39 pagineElementi Di Linguistica ItalianaGIORGIA RONCANessuna valutazione finora
- Dialettogia - CorrettoDocumento62 pagineDialettogia - Correttoclara-meschini2001Nessuna valutazione finora
- Elementi Di Linguistica Italiana I Bonomi A Masini S Morgana M PiottiDocumento27 pagineElementi Di Linguistica Italiana I Bonomi A Masini S Morgana M PiottiMarghe Accardo Palumbo75% (4)
- DialettologiaDocumento35 pagineDialettologiaAlberto Ballesteros Aguado100% (1)
- Docsity Riassunto Libro Argomenti Scelti Di Glottologia e Linguistica Romano UnitoDocumento57 pagineDocsity Riassunto Libro Argomenti Scelti Di Glottologia e Linguistica Romano UnitoFabio MancusoNessuna valutazione finora
- Slide Sociolinguistica 2Documento5 pagineSlide Sociolinguistica 2Giada SollaiNessuna valutazione finora
- Introduzione SociolinguisticaDocumento22 pagineIntroduzione SociolinguisticaAnnachiara SibillanoNessuna valutazione finora
- La SociolinguisticaDocumento1 paginaLa Sociolinguisticalightwood1711Nessuna valutazione finora
- Elementi Di Linguistica ItalianaDocumento9 pagineElementi Di Linguistica ItalianaValeria KozakosNessuna valutazione finora
- L'italiano. LINGUISTICA ITALIANADocumento8 pagineL'italiano. LINGUISTICA ITALIANAgio consNessuna valutazione finora
- Lezione QCER.1 - Schema Appunti (MF)Documento4 pagineLezione QCER.1 - Schema Appunti (MF)DaniloMarenziNessuna valutazione finora
- Mappe GrammaticaDocumento4 pagineMappe GrammaticaMariaymiNessuna valutazione finora
- Screenshot 2021-10-01 at 17.47.13Documento54 pagineScreenshot 2021-10-01 at 17.47.13Yellowood uwuNessuna valutazione finora
- Linguistica GeneraleDocumento173 pagineLinguistica GeneralelaamotNessuna valutazione finora
- Pensa in Italiano! Think in Italian! Carte 1-50Da EverandPensa in Italiano! Think in Italian! Carte 1-50Valutazione: 3.5 su 5 stelle3.5/5 (3)
- Sveglia! Oltre 100 attività di conversazione e giochi per insegnanti di lingua italianaDa EverandSveglia! Oltre 100 attività di conversazione e giochi per insegnanti di lingua italianaValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Anatomia della Coscienza Quantica: La fisica dell'auto-guarigioneDa EverandAnatomia della Coscienza Quantica: La fisica dell'auto-guarigioneValutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (3)
- Psicologia Oscura: Scopri come analizzare le persone e padroneggiare la manipolazione umana utilizzando i segreti del linguaggio del corpo, la PNL sottile, il controllo mentale, la persuasione subliminale, l'ipnosi e le tecniche di lettura veloce.Da EverandPsicologia Oscura: Scopri come analizzare le persone e padroneggiare la manipolazione umana utilizzando i segreti del linguaggio del corpo, la PNL sottile, il controllo mentale, la persuasione subliminale, l'ipnosi e le tecniche di lettura veloce.Valutazione: 5 su 5 stelle5/5 (6)
- È facile smettere di fumare se sai come farlo: 20 milioni di copie venduteDa EverandÈ facile smettere di fumare se sai come farlo: 20 milioni di copie venduteValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (2)
- Imparare il Francese: Proverbi & Modi di dire (Proverbes et Expressions)Da EverandImparare il Francese: Proverbi & Modi di dire (Proverbes et Expressions)Nessuna valutazione finora
- Sindrome di Asperger e Counselling - Importanza dell’Intervento di Supporto nel Processo di Adattamento all’Interno dell’Ambiente LavorativoDa EverandSindrome di Asperger e Counselling - Importanza dell’Intervento di Supporto nel Processo di Adattamento all’Interno dell’Ambiente LavorativoNessuna valutazione finora
- Rompighiaccio e riempitempo: Brevi attività di conversazione per insegnanti di lingua italianaDa EverandRompighiaccio e riempitempo: Brevi attività di conversazione per insegnanti di lingua italianaValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (2)
- Le Tattiche del Cambiamento - Manuale di Psicoterapia StrategicaDa EverandLe Tattiche del Cambiamento - Manuale di Psicoterapia StrategicaValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- La Ribhu Gita: a cura di Luca OrabonaDa EverandLa Ribhu Gita: a cura di Luca OrabonaValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (1)
- Clil, Laboratorialità e Multimedialità. I Nuovi Orizzonti dell’Istruzione Tecnico-ProfessionaleDa EverandClil, Laboratorialità e Multimedialità. I Nuovi Orizzonti dell’Istruzione Tecnico-ProfessionaleNessuna valutazione finora
- Come un uomo pensa, così è - Sette Lezioni del pioniere del Movimento di Autoaiuto per raggiungere PROSPERITA’, FELICITA’, SUCCESSODa EverandCome un uomo pensa, così è - Sette Lezioni del pioniere del Movimento di Autoaiuto per raggiungere PROSPERITA’, FELICITA’, SUCCESSONessuna valutazione finora
- La concordanza dei tempi verbali. La grammatica senza segretiDa EverandLa concordanza dei tempi verbali. La grammatica senza segretiNessuna valutazione finora
- Il linguaggio occulto dei sogni: Coscienza, inconscio, archetipi, sincronicità, caratteristiche e interpretazioneDa EverandIl linguaggio occulto dei sogni: Coscienza, inconscio, archetipi, sincronicità, caratteristiche e interpretazioneValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Senza Niente: Attività didattiche senza materiali aggiuntivi per insegnanti di lingua italianaDa EverandSenza Niente: Attività didattiche senza materiali aggiuntivi per insegnanti di lingua italianaNessuna valutazione finora
- L’altra faccia della luna: Emozioni e PsicoanalisiDa EverandL’altra faccia della luna: Emozioni e PsicoanalisiNessuna valutazione finora
- Dall'amore cieco all'amore consapevole. Relazione tra la pedagogia e le costellazioni di Bert HellingerDa EverandDall'amore cieco all'amore consapevole. Relazione tra la pedagogia e le costellazioni di Bert HellingerNessuna valutazione finora
- La Mentalità Di Successo Dei Grandi Leader: Non è il denaroDa EverandLa Mentalità Di Successo Dei Grandi Leader: Non è il denaroNessuna valutazione finora
- É facile controllare l’alcol se sai come farlo: Quinta edizione con testo aggiornatoDa EverandÉ facile controllare l’alcol se sai come farlo: Quinta edizione con testo aggiornatoValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Idealmente: nuove forme di occupazione delle persone con disabilità psichicaDa EverandIdealmente: nuove forme di occupazione delle persone con disabilità psichicaNessuna valutazione finora
- I due volti dell’amore: Come far funzionare l'amore nei rapporti affettiviDa EverandI due volti dell’amore: Come far funzionare l'amore nei rapporti affettiviNessuna valutazione finora