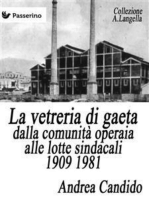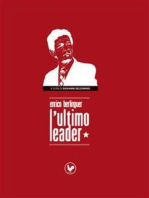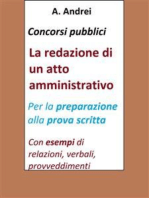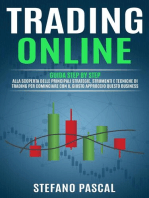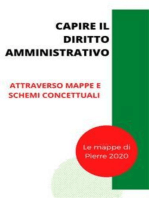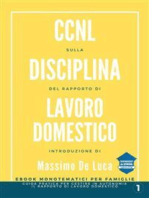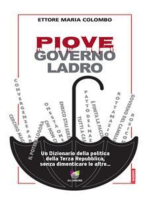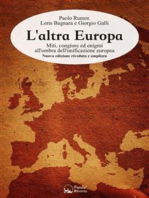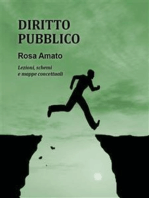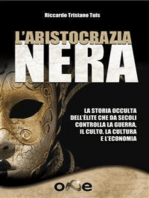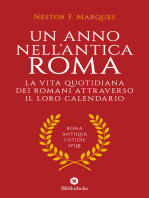Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
18.5 - Sinistra Storica
Caricato da
Alessio Avasilcai0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
80 visualizzazioni5 pagineAppunti sintetici sulla Sinistra Storica
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
DOCX, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoAppunti sintetici sulla Sinistra Storica
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
80 visualizzazioni5 pagine18.5 - Sinistra Storica
Caricato da
Alessio AvasilcaiAppunti sintetici sulla Sinistra Storica
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 5
18.
DALLA SINISTRA STORICA ALLA CRISI DI FINE
SECOLO
18. 1 Le riforme della Sinistra storica e il trasformismo
LA CADUTA DELLA DESTRA STORICA Con il pareggio di bilancio la Destra storica raggiunse il suo
obiettivo prioritario, ma lo fece stremando il Paese. Nel marzo del 1876 il governo fu battuto in Parlamento
dal voto contrario di una nuova opposizione che vedeva uniti membri dei due schieramenti di destra e di
sinistra.
LA «RIVOLUZIONE PARLAMENTARE Vittorio Emanuele II chiamò allora al governo un esponente della
Sinistra storica, Agostino Depretis (1813-87), che ottenne l'appoggio anche di molti deputati della Destra
storica. Egli sarebbe rimasto presi dente del Consiglio dal 1876 al 1887 con due interruzioni: nel 1878 e nel
1879-81.
IL «PERIODO UMBERTINO» A Vittorio Emanuele II, morto nel 1878, succedette il figlio Umberto I
(1844-1900). Durante il «periodo umbertino», l'Italia conobbe l'ammodernamento dello Stato e l'inizio di
un vero sviluppo industriale.
IL PROGRAMMA DI DEPRETIS II programma di Depretis prevedeva una nuova legge elettorale con
l'allargamento dei diritti politici, l'istruzione elementare laica, gratuita e obbligatoria, la promozione di
un'inchiesta agraria sulle condizioni dei contadini per capire quali iniziative adottare, l'abolizione della
tassa sul macinato, con una radicale riforma tributaria e una maggiore autonomia per gli enti locali,
attraverso l'elezione diretta dei sindaci, allora di nomina regia.
LA RIFORMA DELLA SCUOLA La legge Coppino (1877) estese l'obbligo dell'istruzione elementare a
tre anni e furono introdotte sanzioni pecuniarie nei confronti dei genitori che non avessero mandato i figli a
scuola. Tuttavia, la legge rimase in molte aree inapplicata per la mancanza di risorse dei Comuni e perché
molte famiglie contadine non potevano rinunciare al lavoro dei figli.
LA RIFORMA DEL SUFFRAGIO Nel 1882 il diritto di voto venne concesso ai cittadini maschi maggiori di
21 anni, che pagassero 19 lire d'imposta annua (meno della metà che in precedenza) o che sapessero leggere
o scrivere. Il suffragio veniva dunque svincolato dal censo e legato al titolo di studio. La scelta
privilegiava comunque i ceti urbani e benestanti del Centro-Nord ed escludeva gli analfabeti, cioè la
maggior parte della popolazione. Nonostante questi limiti, alle elezioni del 1882 poterono votare gli operai
specializzati e gli artigiani, con il risultato che vennero eletti dei deputati radicali e il primo deputato
socialista italiano, Andrea Costa (1851-1910).
LE RIFORME FISCALI E SOCIALI La riforma fiscale del 1884 abolì la tanto odiata tassa sul macinato, ma
costrinse il governo a introdurre nuove imposte sui beni di consumo, che continuarono a gravare soprattutto
sul ceti popolari. Nel 1883 fu istituita la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro e
nel 1886 venne approvata una legge per la tutela del lavoro minorile. La Sinistra storica non riuscì ad
attuare il decentramento amministrativo, che avrebbe potuto mitigare il centralismo promosso dai
governi della Destra storica.
TRASFORMISMO L'avvento della Sinistra storica era derivato da accordi politici tra i deputati di entrambi
gli schieramenti che vantavano la stessa base sociale e non presentavano differenze ideologiche marcate.
Questo aspetto si rese evidente quando, nelle elezioni del 1882, l'allargamento del suffragio rafforzo l’ala
radicale e Depretis si accordò con la Destra storica in quello che fu definito «trasformismo». Si creò allora
un grande blocco centrista che univa i deputati moderati di entrambi i gruppi politici, il cui obiettivo era
quello di isolare le due frange estreme del Parlamento per promuovere una politica moderata e
consolidare lo Stato liberale e monarchico.
LE MAGGIORANZE VARIABILI Questa strategia ere stata già messa in campo da Cavour, ma, a
differenza di allora, non produsse uno schieramento coeso. L'attività di governo, anziché corrispondere a un
programma definito, si risolse in una continua contrattazione, fatta di compromessi e accordi tra i deputati
su ogni decisione da votare e diede fuoco a maggioranze variabili, che nascevano intorno a singoli
provvedimenti per poi sgretolarsi subito dopo, spesso sulla base di pressioni esterne o di interessi
personali.
IL CLIENTELISMO La conseguenza principale fu il sostanziale immobilismo del governo. Per vedere
approvata una manovra, l'esecutivo era costretto a continue concessioni, finendo vittima di clientelismo e
corruzione.
18.2 La nuova politica economica: il protezionismo
IL DIVARIO CON I PAESI EUROPEI Il divario tra sistema produttivo dell'intera penisola e gli altri
Paesi europei rimaneva molto grande. L'arretratezza italiana era aggravata:
dalla mancanza delle necessarie infrastrutture;
dalla scarsità di fonti energetiche;
da una produzione manifatturiera ancora gestita da aziende di piccole e medie dimensioni.
Non si erano ancora create, insomma, quelle concentrazioni di capitali e di fabbriche indispensabili per
raggiungere una vera e propria industrializzazione.
«L’ESPANSIONE STROZZATA» Solo intorno agli anni Ottanta cominciò una lenta crescita industriale che
tuttavia generò uno sviluppo dai caratteri anomali (l'«espansione strozzata»), perché non riguardò i settori
produttivi, ma si legò soprattutto alla speculazione edilizia.
A guidare la prima fase dello sviluppo industriale fu lo Stato, che si fece promotore di numerose commesse
pubbliche destinate alla siderurgia: dalle quasi 4000 tonnellate di acciaio prodotte nel 1881, si passò così
alle 158.000 del 1889.
Per attirare investimenti stranieri, nel 1883 si abolì il corso forzoso introdotto dalla Destra storica e fu
ripristinata la convertibilità in oro della lira secondo principi del Gold Standard. L'operazione rientrava in
una più vasta serie di iniziative volte alla creazione di un sistema bancario e creditizio in grado di
finanziare la crescita industriale.
L'INCHIESTA JACINI E LE MISURE PROTEZIONISTICHE I governi della Sinistra storica adottarono
una politica economica protezionistica.
A determinare questa svolta furono anche i risultati di un'inchiesta sulla situazione delle campagne e le
condizioni di vita dei contadini (l'inchiesta Jacini), da cui emerse un quadro drammatico e allarmante.
Nel 1887 furono quindi istituite la tariffa doganale sulle materie prime e una barriera fiscale per i prodotti
industriali che miravano a proteggere le nascenti industrie e a sostenere l'agricoltura italiana.
GLI EFFETTI DEL PROTEZIONISMO Tra gli effetti principali di queste misure ci fu, nel Nord Italia, lo
sviluppo dell'industria pesante e l'ammodernamento delle grandi aziende cerealicole che avvantaggiò i
grandi proprietari terrieri. Questi ultimi in assenza di concorrenza straniera, alzarono il prezzo del pane,
penalizzando ancora una volta la popolazione povera, che vide quasi annullati gli effetti positivi
dell'abolizione della tassa sul macinato.
A essere danneggiati furono anche i produttori di colture specializzate (ortaggi olivi e alberi da frutta) e le
aziende vinicole del Centro-Sud, che non riuscirono più a esportare i loro prodotti, specialmente in Francia,
con cui si era scatenata una vera e propria guerra doganale. Al blocco delle esportazioni seguì una forte
disoccupazione, che fece aumentare l'emigrazione della manodopera agricola.
IL DECOLLO INDUSTRIALE Un vero e proprio decollo industriale si verificò solo dal 1896, con la fine
della «Grande depressione», e si concentrò nel Nord-Ovest, fra Torino, Milano e Genova, il triangolo
industriale italiano.
L'AUMENTO DEMOGRAFICO E L'EMIGRAZIONE Negli ultimi decenni del secolo si registrò un forte
incremento demografico che, a causa delle difficili condizioni generali, fu assorbito dall'intensa
emigrazione, talvolta stagionale, verso i Paesi europei, più spesso permanente verso Stati Uniti e Argentina.
Nel complesso tra il 1876 e il 1905 migrarono oltre tre milioni di persone, provenienti inizialmente dalle
regioni del Nord e, dopo il 1900, da quelle del Sud.
18.3 Una nuova politica estera: la Triplice alleanza e il colonialismo
LA TRIPLICE ALLEANZA Al Congresso di Berlino del 1878, l'Italia non era riuscita ad affermarsi
appieno tra le potenze europee ed era stata esclusa dalle politiche coloniali.
Per uscire dall'isolamento, la Sinistra storica accettò le proposte dal cancelliere Bismarck e il 20 maggio
1882 Depretis siglò la Triplice alleanza con la quale Germania, Austria e Italia concordavano di
intervenire in reciproco aiuto nel caso in cui una delle tre potenze fosse stata attaccata, mentre era ammessa
la neutralità nel caso di una guerra dichiarata da uno dei tre contraenti. L'accordo, però, sanciva la rinuncia
al completamento dell'Unità con il Trentino e il Friuli («Trento e Trieste») e pertanto suscitò le proteste dei
repubblicani e degli irredentisti.
I VANTAGGI ECONOMICI DELL'ALLEANZA Nonostante le opposizioni politiche, i vantaggi economici
dell'accordo non tardarono a farsi sentire, poiché l'afflusso di ingenti capitali tedeschi contribuì a finanziare
la nascente industria e nacquero nuove banche.
LE PRIME TAPPE DEL COLONIALISMO ITALIANO L’Italia avviò allora una propria politica coloniale
che intendeva rispondere al sentimento nazionalista dei vertici politici e militari e al problema della diffusa
disoccupazione.
Nel 1882, il governo acquistò la baia di Assab, sulla costa meridionale del mar Rosso, in Eritrea, e nel 1885.
Depretis autorizzò l'occupazione del porto di Massaua e dell'entroterra, un altopiano confinante con
l'Impero etiopico, uno dei più forti e vasti Stati africani sottoposto alla sovranità del negus.
L'Etiopia reagì sterminando un distaccamento militare italiano vicino a Dogali (1887); la sconfitta provocò
forti reazioni in Italia, soprattutto da parte della Sinistra radicale, contraria al colonialismo.
Il governo però procedette al rinnovo della Triplice alleanza e decise di completare almeno la conquista
delle coste eritrea e somala.
18.4 L’età crispina
IL PENSIERO POLITICO DI CRISPI Nel 1887 morì Agostino Depretis e il re pose alla presidenza del
Consiglio un altro uomo della Sinistra storica, Francesco Crispi (1818-1901). Ex garibaldino, ma
sostenitore dell'idea bismarckiana di «Stato forte», Crispi era un fervido nazionalista, sostenitore del
colonialismo. Egli intendeva rafforzare i poteri dell'esecutivo per attuare alcune importanti riforme.
LA RIFORMA DEGLI ENTI LOCALI La prima riforma riguardò le amministrazioni locali. Per mitigare
l'accentramento promosso dalla Destra storica, Crispi rese elettivi i sindaci dei Comuni più grandi, ma
rafforzò il potere di controllo dei prefetti.
LA RIFORMA LEGISLATIVA Fu approvato un nuovo codice penale, che aboliva la pena di morte e
riconosceva una pur limitata libertà di sciopero (1889). Anche queste concessioni furono bilanciate da una
legge sulla pubblica sicurezza che aumentò i poteri delle forze di polizia. La deriva autoritaria del governo
emerse chiaramente dalla sua azione repressiva contro gli irredentisti, contro il movimento operaio e i
sindacati e contro le associazioni cattoliche.
LA POLITICA ESTERA E IL COLONIALISMO IN AFRICA Riprese anche la politica coloniale in Africa.
Con il trattato di Uccialli (1889), il negus sembrò riconoscere i possedimenti italiani in Eritrea e accettare il
protettorato sull'Etiopia e sulla Somalia. Nel 1891 però, a causa dei costi crescenti delle operazioni
coloniali, Crispi perse la maggioranza parlamentare e fu costretto alle dimissioni.
IL PRIMO GOVERNO GIOLITTI (1892-93) A Crispi succedette prima un esponente della Destra
conservatrice, poi, a partire dal maggio del 1892, Giovanni Giolitti (1842 1928) che avrebbe guidato l'Italia
anche per buona parte dei decenni successivi (1903-14), tanto che dall'«età crispina» si passo all'«età
giolittiana».
Uomo della Sinistra storica, di cui rappresentava la linea liberale e costituzionale, Giolitti era convinto che
non si dovessero reprimere con la forza le opposizioni e i movimenti popolari, ma dare loro libero sfogo,
sempre garantendo l’ordine pubblico. Il suo atteggiamento era ispirato all'esigenza di allargare le basi dello
Stato, ancora di stampo elitario, e di raccogliere nuovi consensi tra le masse piccolo-borghesi e popolari.
I FASCI SICILIANI E LO SCANDALO DELLA BANCA ROMANA Tra il 1891 e il 1894, si svolse la
rivolta dei Fasci siciliani, un movimento di protesta di contadini e operai che rivendicava salari più alti e
un'equa distribuzione della terra: Giolitti evitò di ricorrere alla forza, suscitando l'irritazione dei
conservatori.
A far vacillare Giolitti intervenne lo scandalo della Banca Romana, coinvolta nel fallimento di alcune
imprese legate alla speculazione edilizia e accusata di gravi irregolarità: Giolitti fu ritenuto il
responsabile politico di tali fenomeni corruttivi.
LE DIMISSIONI DI GIOLITTI Accusato dalla Sinistra di avere coperto lo scandalo della Banca Romana e
dalla Destra di non essere in grado di tenere a bada la ribellione dei Fasci siciliani e le rivolte sociali del
Paese, Giolitti dovette dimettersi nel dicembre del 1893.
LA SVOLTA AUTORITARIA DEL SECONDO GOVERNO CRISPI (1893-96) Alla guida del Paese tornò
Crispi, che adottò immediatamente misure severissime contro i Fasci siciliani, proclamando lo stato
d'assedio in Sicilia: nel 1894, Crispi sciolse il neonato Partito socialista dei lavoratori italiani, soppresse
le Camere del lavoro e ridusse il corpo elettorale.
LA CRESCITA DELLE OPPOSIZIONI Rafforzate dalla ferma linea politica crispina, le opposizioni si
organizzarono nella Lega delle libertà e alle elezioni del 1895 i voti dei socialisti quasi triplicarono e
crebbero anche quelli dei radicali. La tensione sociale era altissima e Crispi, per uscire da questa
drammatica situazione, giocò di nuovo la carta dell'espansione coloniale.
LA GUERRA CONTRO L'ETIOPIA (1896) Crispi organizzò una campagna militare contro l'Etiopia
(1895-96), ma le truppe italiane vennero sconfitte (Amba Alagi, 1895; Macallè, 1896). La disfatta di Adua
(1° marzo 1896) sancì l'arresto dell'avventura coloniale dell'Italia, a cui rimase il solo possesso dell'Eritrea
e della Somalia. Travolto dal disastro, Crispi si dimise e uscì per sempre dalla scena politica.
18.5 La crisi di fine secolo
LA CRISI SOCIALE ED ECONOMICA La caduta di Crispi pose fine all'espansionismo coloniale italiano,
ma non arrestò i sentimenti reazionari e autoritari della classe politica.
Nel frattempo, i giornali pubblicavano inchieste di denuncia sulle sempre misere condizioni del popolo
italiano e la penisola era attraversata da profonde tensioni sociali. Nelle sommosse popolari del 1897 si
gridava «pane e lavoro».
I MOTI DI MILANO E LA REPRESSIONE DI BAVA BECCARIS La manifestazione più imponente
avvenne a Milano il 6 maggio 1898. In questa occasione, il governo autorizzò il generale Fiorenzo Bava
Beccaris all'uso dei cannoni contro i manifestanti che provocarono 82 morti.
PELLOUX E LE «LEGGI ECCEZIONALI» L'indignazione seguita ai fatti di Milano convinse il re
Umberto I a sostituire Bava Beccaris con il generale Luigi Pelloux. Questi decretò la fine dello stato
d'assedio e fece liberare i condannati politici. Ma la distensione durò pochi mesi e già nel febbre io 1899
Pelloux propose le «leggi eccezionali» per limitare il diritto sciopero, di associazione e la libertà di stampa.
Queste leggi illiberali furono respinte grazie all'ostruzionismo parlamentare dell'estrema Sinistra.
L'ASSASSINIO DI UMBERTO I Il nuovo governo uscito dalle elezioni del 1900, ritirò i progetti di legge
illiberali e preparò la strada per una vera distensione. Tuttavia il 29 luglio 1900 il re Umberto I fu
assassinato a Monza dall'anarchico Gaetano Bresci, che intendeva vendicare i morti di Milano del 1898.
VITTORIO EMANUELE III, ZANARDELLI E GIOLITTI Il nuovo re, Vittorio Emanuele III (1869-
1947), volle avviare il Paese sulla strada della pacificazione affidando l'incarico di presidente del Consiglio
al più autorevole esponente della Sinistra costituzionale, il liberale Zanardelli. Al suo fianco, come ministro
degli Interni tornò in campo Giolitti. Grazie all'azione congiunta dei massimi statisti liberali, l'italia poté
così consolidare le proprie istituzioni.
18.6 Socialismo e movimento operaio in Italia
LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO In Italia, il movimento operaio si organizzò in ritardo rispetto agli
altri Paesi europei, dove l'industrializzazione si era ormai affermata da decenni. Solo a partire dagli anni
Ottanta dell'Ottocento comparvero le prime forme associative.
Già dagli anni Sessanta, però, erano nate le società di mutuo soccorso, che sostenevano i lavoratori in caso
di infortuni, malattie e licenziamento. Queste associazioni, di ispirazione mazziniana, si basavano su scopi
solidaristici, senza avanzare rivendicazioni sociali, promuovendo piuttosto l'educazione del popolo.
L'ANARCHISMO ITALIANO E I PRIMI PARTITI OPERAI Intorno agli anni Settanta, cominciò a
diffondersi in Italia l'anarchismo, guidato, tra gli altri, da Andrea Costa. Le iniziative anarchiche, tuttavia,
fallirono e Costa fondo il Partito socialista rivoluzionario di Romagna (1881). Nello stesso anno nacque il
Partito operaio italiano, legato al mondo dei braccianti agricoli della Bassa padana.
IL SINDACALISMO Parallelamente vennero create le prime associazioni sindacali (federazioni di
mestiere) e nel 1891 a Milano nacque la prima Camera del lavoro; a tutela dei contadini si affermarono le
leghe di resistenza.
LA NASCITA DEL PARTITO DEI LAVORATORI ITALIANI La creazione di tutte queste associazioni sul
territorio fece nascere l'esigenza di un coordinamento nazionale. In quest'ottica fu fondato a Genova il
Partito del lavoratori italiani (1892), poi divenuto Partito socialista dei lavoratori italiani, sciolto da Crispi,
e, infine, Partito socialista italiano (1895).
I RIFERIMENTI DEL SOCIALISMO ITALIANO Tra gli esponenti di spicco del Partito socialista vi furono
il filosofo napoletano Antonio Labriola (1843-1904), amico di Engels e divulgatore del pensiero di Marx in
Italia, e l'intellettuale milanese Filippo Turati, compagno dell'esule russa Anna Kuliscioff, profonda
conoscitrice del socialismo europeo.
IL PROGRAMMA DI TURATI Turati mirava alla trasformazione della società dall'interno, senza
ricorrere a metodi rivoluzionari, anche se l'obiettivo finale restava quello del marxismo, ovvero la
socializzazione dei mezzi di produzione.
Il radicamento del Partito socialista italiano fu rapidissimo, ma presto, come accaduto negli altri Paesi
europei, si sviluppò al suo interno la discussione, e poi la scissione, tra la linea riformista, maggioritaria e
sostenuta da Turati, e la corrente massimalista, a carattere rivoluzionario.
Potrebbero piacerti anche
- La vetreria di Gaeta dalla comunità operaia alle lotte sindacali 1909 1981Da EverandLa vetreria di Gaeta dalla comunità operaia alle lotte sindacali 1909 1981Nessuna valutazione finora
- Sinistra StoricaDocumento5 pagineSinistra StoricasmataloneNessuna valutazione finora
- Dalla Sinistra Storica Alla Crisi Di Fine SecoloDocumento3 pagineDalla Sinistra Storica Alla Crisi Di Fine SecoloChiara TrovatoNessuna valutazione finora
- Storia contemporanea facile: attraverso mappe concettuali, schemi e riassuntiDa EverandStoria contemporanea facile: attraverso mappe concettuali, schemi e riassuntiNessuna valutazione finora
- L'Italia Da Depretis A GiolittiDocumento17 pagineL'Italia Da Depretis A GiolittiRiccardo ContuNessuna valutazione finora
- Rivoluzioni industriali: La nascita del mondo modernoDa EverandRivoluzioni industriali: La nascita del mondo modernoNessuna valutazione finora
- Dalla Destra Alla SinistraDocumento2 pagineDalla Destra Alla SinistraDiego Deplano100% (1)
- La Storia Italiana Del 1861-1900Documento3 pagineLa Storia Italiana Del 1861-1900pig36069Nessuna valutazione finora
- Dalla Sinistra Storica Alletc3a0 GiolittianaDocumento3 pagineDalla Sinistra Storica Alletc3a0 Giolittianaalessandra viscidoNessuna valutazione finora
- Sinistra StoricaDocumento3 pagineSinistra StoricaMattia ArculeoNessuna valutazione finora
- Risposte Aperte Storia Contemporanea 1Documento22 pagineRisposte Aperte Storia Contemporanea 1Alice MantelloNessuna valutazione finora
- Sinistra Storica Depretis e Fratm CrispiDocumento2 pagineSinistra Storica Depretis e Fratm CrispiRaffaela FroncilloNessuna valutazione finora
- Il Regno D'italiaDocumento3 pagineIl Regno D'italiaziofesteradams2Nessuna valutazione finora
- Italia Post UnitàDocumento9 pagineItalia Post UnitàSalvino CastroNessuna valutazione finora
- Destra e Sinistra StoricaDocumento41 pagineDestra e Sinistra StoricaMattia ArculeoNessuna valutazione finora
- L'Italia Da Depretis A Giolitti.Documento19 pagineL'Italia Da Depretis A Giolitti.Federico DelussuNessuna valutazione finora
- Destra StoricaDocumento8 pagineDestra StoricaGiada De NegriNessuna valutazione finora
- Corso Di Riallineamento Storia Profssa Picciau Destra e Sinistra StoricaDocumento41 pagineCorso Di Riallineamento Storia Profssa Picciau Destra e Sinistra StoricaAndrea MaiorinoNessuna valutazione finora
- Destra StoricaDocumento2 pagineDestra Storicaelisa santorelliNessuna valutazione finora
- L'italia Dopo L'unitàDocumento8 pagineL'italia Dopo L'unitàmesugiuliaNessuna valutazione finora
- Primo DopoguerraDocumento5 paginePrimo DopoguerraGiulia RappazzoNessuna valutazione finora
- Storia 4Documento6 pagineStoria 4mv8jhxfzh6Nessuna valutazione finora
- 2 - L'età GiolittianaDocumento7 pagine2 - L'età Giolittianasamuel.braviNessuna valutazione finora
- Stati Uniti e Giappone, Potenze Del XIX Secolo - Da Minghetti A DepretisDocumento5 pagineStati Uniti e Giappone, Potenze Del XIX Secolo - Da Minghetti A Depretislayla91Nessuna valutazione finora
- Il Sudtirolo Durante Il FascismoDocumento23 pagineIl Sudtirolo Durante Il FascismoGianni Pacella100% (1)
- Bella EpoqueDocumento6 pagineBella EpoquefarinolamattiaNessuna valutazione finora
- L'Italia Da Fine Ottocento A GiolittiDocumento19 pagineL'Italia Da Fine Ottocento A Giolitticornacchia.giovanniNessuna valutazione finora
- Dallo Stato Forte Di Crispi Alla Crisi Di Fine SecoloDocumento3 pagineDallo Stato Forte Di Crispi Alla Crisi Di Fine Secololucanavo29340% (1)
- ITALIA POST-UNITARIA Depretis CrispiDocumento4 pagineITALIA POST-UNITARIA Depretis CrispiMatteo CatalanoNessuna valutazione finora
- Italia 800 900Documento20 pagineItalia 800 900dalmasgiovanna2Nessuna valutazione finora
- 1870-1914 AppuntiDocumento10 pagine1870-1914 AppuntifinocchiettoNessuna valutazione finora
- UnidTest STORIADocumento56 pagineUnidTest STORIAAlessioSantoroNessuna valutazione finora
- Primo DopoguerraDocumento5 paginePrimo DopoguerraAlessia TammaNessuna valutazione finora
- Il Biennio RossoDocumento14 pagineIl Biennio RossoMaryna100% (1)
- Il Ruolo Del Credito Nell Economia ItalianaDocumento6 pagineIl Ruolo Del Credito Nell Economia ItalianaBoom BabyNessuna valutazione finora
- L'italia Dalla Sinistra Storica Alla Crisi Di Fine SecoloDocumento1 paginaL'italia Dalla Sinistra Storica Alla Crisi Di Fine SecoloPietro CiccarelliNessuna valutazione finora
- Destra Storica e Sinistra StoricaDocumento9 pagineDestra Storica e Sinistra StoricaRanieri MenichellaNessuna valutazione finora
- Sintesi Della Storia D'italia Dall'unità Alla Caduta Di Crispi.L'affermarsi Dell'indutrialismo e LaDocumento24 pagineSintesi Della Storia D'italia Dall'unità Alla Caduta Di Crispi.L'affermarsi Dell'indutrialismo e Lapietro servodidioNessuna valutazione finora
- Eta Di GiolittiDocumento9 pagineEta Di GiolittiermenegildaNessuna valutazione finora
- L'Italia Crispina e La Svolta GiolittianaDocumento4 pagineL'Italia Crispina e La Svolta GiolittianaDiego Deplano0% (1)
- Cap XIII - Seconda Rivoluzione IndustrialeDocumento4 pagineCap XIII - Seconda Rivoluzione IndustrialeAlessio AvasilcaiNessuna valutazione finora
- Destra e Sinistra StoricheDocumento3 pagineDestra e Sinistra StoricheAdrianaNessuna valutazione finora
- Storia DellDocumento8 pagineStoria DellGessica D'AgostinoNessuna valutazione finora
- Storia Italiana: Crispi e GiolittiDocumento8 pagineStoria Italiana: Crispi e GiolittiGianfranco Marini100% (1)
- Giolitti, Suffraggi, Prima Guerra Mondiale, Genocidio Degli ArmeniDocumento9 pagineGiolitti, Suffraggi, Prima Guerra Mondiale, Genocidio Degli Armeniabi012345012345Nessuna valutazione finora
- 2 Parte2U5 (188 1203)Documento16 pagine2 Parte2U5 (188 1203)Maria Francesca de MatteisNessuna valutazione finora
- Cap 17Documento2 pagineCap 17Raffaela FroncilloNessuna valutazione finora
- 1861 - 1876 Il Giovane Regno D'italia È Governato DaDocumento4 pagine1861 - 1876 Il Giovane Regno D'italia È Governato DaLuigi AstoquillcaNessuna valutazione finora
- Domande Storia 800Documento7 pagineDomande Storia 800Gianluca MeschiniNessuna valutazione finora
- FascismoDocumento23 pagineFascismoMaria Elena ApollonioNessuna valutazione finora
- Riassunto Sull'italia Da Depretis A GiolittiDocumento2 pagineRiassunto Sull'italia Da Depretis A GiolittiSalvatoreNessuna valutazione finora
- Eta GiolittianaDocumento4 pagineEta Giolittianaspyr3ktmNessuna valutazione finora
- Agostino Depretis - CrucianoDocumento2 pagineAgostino Depretis - CrucianoJoshua CrucianoNessuna valutazione finora
- Primo DopoguerraDocumento2 paginePrimo DopoguerraMattia LaiNessuna valutazione finora
- L'età Giolittiana (1901-1914) : Giolitti Al GovernoDocumento21 pagineL'età Giolittiana (1901-1914) : Giolitti Al GovernoFederica LavenutaNessuna valutazione finora
- Governare L'italia UnitaDocumento6 pagineGovernare L'italia UnitaAndrea ZinnàNessuna valutazione finora
- 1871-1900 (Italia)Documento11 pagine1871-1900 (Italia)il mio quello di mio padreNessuna valutazione finora
- Storia 5 Anno CompletaDocumento41 pagineStoria 5 Anno Completapaora paoraNessuna valutazione finora
- Grabriele D'Annunzio - SintesiDocumento2 pagineGrabriele D'Annunzio - SintesiAlessio Avasilcai100% (1)
- Ana 1Documento170 pagineAna 1Alessio AvasilcaiNessuna valutazione finora
- Terne Pitagoriche Primitive ParticolariDocumento21 pagineTerne Pitagoriche Primitive ParticolariAlessio AvasilcaiNessuna valutazione finora
- Hegel Fenomenologia Dello SpiritoDocumento4 pagineHegel Fenomenologia Dello SpiritoAlessio AvasilcaiNessuna valutazione finora
- Olimpiadi Di Fisica 2004: Associazione Per L'insegnamento Della FisicaDocumento12 pagineOlimpiadi Di Fisica 2004: Associazione Per L'insegnamento Della FisicaAlessio AvasilcaiNessuna valutazione finora
- Galilei, Cartesio e SpinozaDocumento3 pagineGalilei, Cartesio e SpinozaAlessio AvasilcaiNessuna valutazione finora
- Ora Aspetta Che Ti Sia Dato Il Via e Buon Lavoro !Documento9 pagineOra Aspetta Che Ti Sia Dato Il Via e Buon Lavoro !Alessio AvasilcaiNessuna valutazione finora
- Unione, Intersezione, Differenza e Intervalli 1 1 216Documento22 pagineUnione, Intersezione, Differenza e Intervalli 1 1 216Alessio AvasilcaiNessuna valutazione finora
- ScetticismoDocumento3 pagineScetticismoAlessio AvasilcaiNessuna valutazione finora
- Cap XIII - Seconda Rivoluzione IndustrialeDocumento4 pagineCap XIII - Seconda Rivoluzione IndustrialeAlessio AvasilcaiNessuna valutazione finora
- Novella Di Cisti Il FornaioDocumento1 paginaNovella Di Cisti Il FornaioAlessio AvasilcaiNessuna valutazione finora
- Equazioni Irrazionali PDFDocumento8 pagineEquazioni Irrazionali PDFAlessio AvasilcaiNessuna valutazione finora
- Mag Old 4storiaDocumento8 pagineMag Old 4storiaPaola SilvaNessuna valutazione finora
- Tesina Superuomo NietzscheDocumento13 pagineTesina Superuomo NietzscheMarco PierottiNessuna valutazione finora
- Casa Degli Italiani Libro 10 AnniDocumento108 pagineCasa Degli Italiani Libro 10 AnniEleonora TributNessuna valutazione finora
- METANODOTTO. CONSIGLIO COMUNALE TERAMO Del - 29-01-2015Documento51 pagineMETANODOTTO. CONSIGLIO COMUNALE TERAMO Del - 29-01-2015PrimaDaNoi.itNessuna valutazione finora
- L'Assurdità dei Sacrifici. Elogio della spesa pubblicaDa EverandL'Assurdità dei Sacrifici. Elogio della spesa pubblicaNessuna valutazione finora
- Apprendimento e competenze nelle metodologie didattiche innovative: i laboratori inclusivi: Quaderni didattici-Percorsi per l'inclusione-4/2021Da EverandApprendimento e competenze nelle metodologie didattiche innovative: i laboratori inclusivi: Quaderni didattici-Percorsi per l'inclusione-4/2021Nessuna valutazione finora
- Concorsi pubblici - La redazione di un atto amministrativo: Per la preparazione alla prova scrittaDa EverandConcorsi pubblici - La redazione di un atto amministrativo: Per la preparazione alla prova scrittaNessuna valutazione finora
- L'evoluzione della qualità. Il Total Quality Management (TQM)Da EverandL'evoluzione della qualità. Il Total Quality Management (TQM)Nessuna valutazione finora
- Da Maometto Al Burj Khalifa – Corso Rapido Su 2000 Anni Di Storia Del Medio OrienteDa EverandDa Maometto Al Burj Khalifa – Corso Rapido Su 2000 Anni Di Storia Del Medio OrienteNessuna valutazione finora
- TRADING ONLINE: Guida Step by Step alla Scoperta delle Principali Strategie, Strumenti e Tecniche di Trading per Cominciare con il Giusto Approccio questo Business.Da EverandTRADING ONLINE: Guida Step by Step alla Scoperta delle Principali Strategie, Strumenti e Tecniche di Trading per Cominciare con il Giusto Approccio questo Business.Nessuna valutazione finora
- Riassunto di Economia Politica: Sintesi e Ripasso per Superare l'Esame UniversitarioDa EverandRiassunto di Economia Politica: Sintesi e Ripasso per Superare l'Esame UniversitarioNessuna valutazione finora
- La tutela della Privacy - Sintesi aggiornata per concorsi pubblici: Il Codice di protezione dei dati personali, il diritto di accesso e la trasparenzaDa EverandLa tutela della Privacy - Sintesi aggiornata per concorsi pubblici: Il Codice di protezione dei dati personali, il diritto di accesso e la trasparenzaValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (1)
- 5 modi facili per potenziare la tua Intelligenza EmotivaDa Everand5 modi facili per potenziare la tua Intelligenza EmotivaNessuna valutazione finora
- Il caso Giorgia Meloni: Social network, cultura pop e comunicazione politicaDa EverandIl caso Giorgia Meloni: Social network, cultura pop e comunicazione politicaNessuna valutazione finora
- Capire il diritto amministrativo: attraverso schemi, mappe concettuali e schedeDa EverandCapire il diritto amministrativo: attraverso schemi, mappe concettuali e schedeNessuna valutazione finora
- Fake news dell'antica Roma: 2000 anni di propaganda, inganni e bugieDa EverandFake news dell'antica Roma: 2000 anni di propaganda, inganni e bugieNessuna valutazione finora
- CCNL sulla disciplina del Rapporto di Lavoro Domestico - 2022Da EverandCCNL sulla disciplina del Rapporto di Lavoro Domestico - 2022Nessuna valutazione finora
- Triadi: La minaccia occulta della criminalità cinese nel MondoDa EverandTriadi: La minaccia occulta della criminalità cinese nel MondoNessuna valutazione finora
- L'altra Europa: Miti, congiure ed enigmi all'ombra dell'unificazione europeaDa EverandL'altra Europa: Miti, congiure ed enigmi all'ombra dell'unificazione europeaValutazione: 2 su 5 stelle2/5 (1)
- Concorso DSGA Prova Teorico Pratica: Guida alla risoluzione di casi concreti attraverso la redazione di un attoDa EverandConcorso DSGA Prova Teorico Pratica: Guida alla risoluzione di casi concreti attraverso la redazione di un attoNessuna valutazione finora
- L’Aristocrazia Nera: La storia occulta dell’élite che da secoli controlla la guerra, il culto, la cultura e l’economiaDa EverandL’Aristocrazia Nera: La storia occulta dell’élite che da secoli controlla la guerra, il culto, la cultura e l’economiaNessuna valutazione finora
- Gesuiti: L’Ordine militare dietro alla Chiesa, alle Banche, ai servizi segreti e alla governance mondialeDa EverandGesuiti: L’Ordine militare dietro alla Chiesa, alle Banche, ai servizi segreti e alla governance mondialeNessuna valutazione finora
- 500 Funzionari MIBACT - La redazione di un atto amministrativoDa Everand500 Funzionari MIBACT - La redazione di un atto amministrativoNessuna valutazione finora
- Un Anno nell'antica Roma: La vita quotidiana dei romani attraverso il loro calendarioDa EverandUn Anno nell'antica Roma: La vita quotidiana dei romani attraverso il loro calendarioNessuna valutazione finora
- Storia del terrorismo in Italia. L'oblio delle vittime, il potere dei carneficiDa EverandStoria del terrorismo in Italia. L'oblio delle vittime, il potere dei carneficiNessuna valutazione finora
- Quando eravamo i padroni del mondo: Roma: l'impero infinitoDa EverandQuando eravamo i padroni del mondo: Roma: l'impero infinitoNessuna valutazione finora
- Guida Pratica Per L'investitore Principiante - Suggerimenti Per Investire MeglioDa EverandGuida Pratica Per L'investitore Principiante - Suggerimenti Per Investire MeglioNessuna valutazione finora