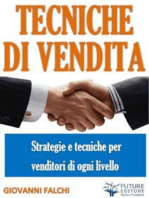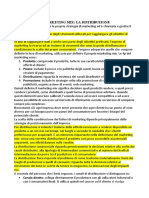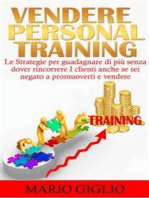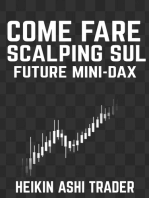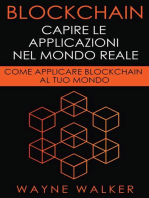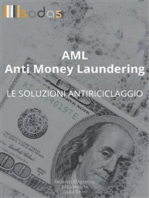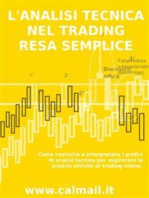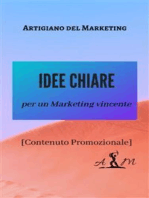Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Regole Pubblicità
Caricato da
Luca Paolo0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
5 visualizzazioni2 pagineRegole pubblicitarie
Titolo originale
Regole pubblicità
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
TXT, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoRegole pubblicitarie
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato TXT, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
5 visualizzazioni2 pagineRegole Pubblicità
Caricato da
Luca PaoloRegole pubblicitarie
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato TXT, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 2
Pubblicità commerciale, regole e controllidi Giuseppe CaforioLa pubblicità è una
forma di comunicazione che le aziende utilizzano per raggiungere molteplici
obbiettivi, che vanno dall'incremento delle vendite al miglioramento dell'immagine
dei loro prodotti e al contrasto dei concorrenti. L'importanza della pubblicità, o
meglio della comunicazione commerciale come più frequentemente viene chiamata, è
sotto gli occhi di tutti; essa è divenuta una delle componenti più rilevanti della
società dei consumi e del benessere. Le imprese si disputano la clientela non solo
attraverso un'offerta di qualità migliore a prezzi più convenienti, ma anche
attraverso la comunicazione di un'immagine dei prodotti che, agli occhi dei
consumatori, li distingua positivamente da quelli dei concorrenti: pubblicità e
attività promozionali in genere sono potenti armi nella battaglia competitiva tra
le imprese, hanno la funzione di incrementare la domanda spostando quote di mercato
da un'impresa all'altra, divenendo strumenti per lo svolgimento della competizione.
Data la natura e la funzione stessa della pubblicità, i primi soggetti che devono
rivendicare tutela, ed evitare di danneggiare i propri concorrenti, sono proprio
coloro che vi fanno ricorso. La pubblicità, infatti, se realizzata in modo non
corretto e responsabile, presenta tutte le caratteristiche per porre in essere
comportamenti lesivi dei concorrenti. Le imprese che si confrontano sul mercato
ricorrendo allo strumento pubblicitario hanno il diritto a che nessuno si
avvantaggi scorrettamente, utilizzando messaggi decettivi e tali da alterare la
sana e leale competizione che dovrebbe sempre caratterizzare il giusto mercato.
Quindi ciò che si deve vietare alla pubblicità è il ricorrere ad artifici,
forzature e condotte scorrette al solo fine di sottrarre ad ogni costo fette e
quote di mercato e consenso ai danni dei concorrenti. Non sono solo le imprese che
operano nel mercato ad essere coinvolte nella dinamica pubblicitaria, ma altro
protagonista è il consumatore, che fa parte del pubblico dei potenziali acquirenti.
L'utente - consumatore, destinatario naturale della pubblicità commerciale,
quotidianamente assoggettato alle conseguenze derivanti dalla portata
contenutistica dei relativi messaggi, è sostanzialmente partecipe del fenomeno
pubblicitario. L'interesse del consumatore si realizza nel momento in cui egli
compie un acquisto non viziato da turbative o imperfetta informazione. Egli ha il
diritto di effettuare scelte d'acquisto motivate e coscienti, sulla base di
informazioni e suggerimenti che siano corretti, onesti e veritieri. L'utilizzo di
questi tre aggettivi non è causale in quanto essi costituiscono i tre cardini
intorno ai quali deve ruotare una pubblicità per essere effettivamente funzionale
all'obbiettivo e alla finalità che si è posta, ossia svolgere una funzione
informativa; funzione cui verrebbe meno ove non si uniformasse a tali doveri
giuridici. Il consumatore si trova in una posizione di maggior debolezza e deve
pertanto essere maggiormente tutelato rispetto a coloro che utilizzano la
pubblicità quale comunicazione commerciale, capace di incidere in modo rilevante
nella formazione dello stimolo e nell'adozione del conseguente comportamento
d'acquisto. Si deve però tenere in considerazione che la pubblicità è comunicazione
di parte, utilizzata per la vendita di un solo bene o servizio e che le imprese
hanno la necessità di enfatizzare i vantaggi che un prodotto assicura ed offre al
consumatore rispetto agli altri, e di indurre il pubblico a ritenere che quella
sola marca sia conforme alla sua peculiare personale necessità. La pubblicità ha il
diritto di sedurre, l'importante è conoscere il limite oltrepassato il quale la
naturale propensione elogiativa di un messaggio sconfini nel mendacio pubblicitario
utilizzando l'inganno e inducendo in errore su quelle che sono le caratteristiche e
gli effetti di un prodotto. La disciplina pubblicitaria e le regole di
concorrenzaLa pubblicità oggi è uno dei più importanti strumenti della lotta
concorrenziale: alcuni dei più importanti atti tipici di concorrenza sleale vietati
dall'art. 2598 c.c. vengono compiuti principalmente mediante la comunicazione
dell'impresa al largo pubblico; tuttavia essa riguarda non solo gli interessi dei
concorrenti, ma anche l'interesse generale al buon funzionamento del mercato e
della concorrenza e gli interessi economici ed extraeconomici dei suoi destinatari:
i consumatori, i risparmiatori e più in generale i cittadini. Occorre perciò che
essa fornisca informazioni utili e che non sia ingannevole o fuorviante. In Italia
venne presto percepito che uno strumento potente come la pubblicità richiedeva una
qualche forma di controllo: le prime norme risalgono agli anni Venti ed esse
prevedevano perlopiù il ricorso alla censura preventiva dei messaggi pubblicitari,
limitata peraltro ad alcuni settori merceologici. Negli anni successivi alla fine
della guerra, nonostante la straordinaria crescita del fenomeno pubblicitario, gli
interventi legislativi furono molto scarsi. Per molto tempo è mancata invece una
disciplina che vietasse in modo generale la pubblicità ingannevole: si è finiti per
riconoscere che essa costituisce concorrenza sleale in quanto atto contrario ai
principi della correttezza professionale di cui all'art. 2598 n.3 c.c. Poiché la
legittimazione ad agire è riservata ex art. 2601 c.c. ai concorrenti e alle loro
associazioni professionali, oggetto di tutela della disciplina in discorso appare
evidente che erano solo gli interessi della classe imprenditoriale, cui sono
riconnessi solo in via strumentale ed eventuale gli interessi dei consumatori, che
sono i soggetti maggiormente pregiudicati dalla pubblicità ingannevole.
Potrebbero piacerti anche
- Appunti Diritto D'AutoreDocumento74 pagineAppunti Diritto D'Autorelucacpll98Nessuna valutazione finora
- Marketing MattiacciDocumento19 pagineMarketing MattiaccinicheloroNessuna valutazione finora
- Strategie di Marketing: Dalle Fondamenta alle Frontiere Future: Un Viaggio Completo attraverso Evoluzione, Innovazione e Sostenibilità nel Marketing ModernoDa EverandStrategie di Marketing: Dalle Fondamenta alle Frontiere Future: Un Viaggio Completo attraverso Evoluzione, Innovazione e Sostenibilità nel Marketing ModernoNessuna valutazione finora
- MARKETING STRATEGICO-unitoDocumento129 pagineMARKETING STRATEGICO-unitoGianvy Godz BiasiNessuna valutazione finora
- La pubblicità online: Le opportunità, le potenzialità e gli strumenti dell’Internet AdvertisingDa EverandLa pubblicità online: Le opportunità, le potenzialità e gli strumenti dell’Internet AdvertisingNessuna valutazione finora
- 01 Concetti Generali Introduttivi Sul MarketingDocumento24 pagine01 Concetti Generali Introduttivi Sul MarketingEliathan Canfield PradoNessuna valutazione finora
- Gestione del marketing per principianti: Come creare e affermare il suo marchio, costruire relazioni con i clienti e aumentare le vendite con la gestione del marketing.Da EverandGestione del marketing per principianti: Come creare e affermare il suo marchio, costruire relazioni con i clienti e aumentare le vendite con la gestione del marketing.Nessuna valutazione finora
- Capitolo 12Documento10 pagineCapitolo 12Danila MancinoNessuna valutazione finora
- Nasta TesiDocumento83 pagineNasta TesiFrancesco AndriellaNessuna valutazione finora
- Market Driven Management Marketing Strategico Ed OperativoDocumento76 pagineMarket Driven Management Marketing Strategico Ed OperativoMatteo F. Fumagalli0% (1)
- Politiche Di Marketing e Valori D'impresaDocumento98 paginePolitiche Di Marketing e Valori D'impresaCaterina TascaNessuna valutazione finora
- Manuale Marketing PDFDocumento135 pagineManuale Marketing PDFGiuliana Valvo0% (1)
- Dispensa Completa ETCADocumento56 pagineDispensa Completa ETCAalessandro.cancianiNessuna valutazione finora
- Il Marketing Mix-La DistribuzioneDocumento5 pagineIl Marketing Mix-La DistribuzionetoniaNessuna valutazione finora
- Ricerca Italiano - PubblicitaDocumento6 pagineRicerca Italiano - Pubblicita66p9d26kpkNessuna valutazione finora
- Marketing 14.03 1 ParteDocumento12 pagineMarketing 14.03 1 ParteLuca CovielloNessuna valutazione finora
- Sintesi Marketing - CalcagnoDocumento65 pagineSintesi Marketing - CalcagnoNunzio CalcagnoNessuna valutazione finora
- Politiche Di Marketing e Valori D Impresa Fiocca SebastianiDocumento80 paginePolitiche Di Marketing e Valori D Impresa Fiocca SebastianiAlice Odorizzi33% (3)
- MarketingDocumento110 pagineMarketingCristian BarabasNessuna valutazione finora
- GOREL - EsercitazioneDocumento5 pagineGOREL - EsercitazionewhitequeenNessuna valutazione finora
- Marketing Il Viaggio Di Una VitaDocumento7 pagineMarketing Il Viaggio Di Una VitaAndrea NoemiNessuna valutazione finora
- EQUILIBRIODELLDocumento1 paginaEQUILIBRIODELLinfo.nickvonoNessuna valutazione finora
- Fondamenti Di Marketing (Riassunto)Documento26 pagineFondamenti Di Marketing (Riassunto)SelMarie Nutelliina GomezNessuna valutazione finora
- Marketing Strategico PDFDocumento82 pagineMarketing Strategico PDFMattia MazzaNessuna valutazione finora
- Lezione: Fondamenti Di Marketing Definizione Di Market Definizione Di MarketingDocumento65 pagineLezione: Fondamenti Di Marketing Definizione Di Market Definizione Di MarketingCarolina PalaNessuna valutazione finora
- Libro Favaretto RiassuntoDocumento101 pagineLibro Favaretto RiassuntoGiorgiaFerrettiNessuna valutazione finora
- Economia e Gestione Delle Imprese CommercialiDocumento62 pagineEconomia e Gestione Delle Imprese Commercialiyafos46412Nessuna valutazione finora
- Manuale ARDENTIDocumento100 pagineManuale ARDENTIDiokan PorkmaddNessuna valutazione finora
- Gestione D'impresa - Scicutella CAPITOLO 11 PDFDocumento5 pagineGestione D'impresa - Scicutella CAPITOLO 11 PDFNicolaNessuna valutazione finora
- Il Marketing Virale: Lezioni Ed Esperienze Dal Mercato Musicale (2004)Documento26 pagineIl Marketing Virale: Lezioni Ed Esperienze Dal Mercato Musicale (2004)Alberto Cottica100% (6)
- Marketing Del TurismoDocumento10 pagineMarketing Del Turismosilvia99.manzatoNessuna valutazione finora
- Appunti Le Regole Del GiocoDocumento39 pagineAppunti Le Regole Del GiocobessaniNessuna valutazione finora
- Marketing Strategico PDFDocumento98 pagineMarketing Strategico PDFMattia MazzaNessuna valutazione finora
- L'approccio TES MarketingDocumento16 pagineL'approccio TES MarketingJessica VismaraNessuna valutazione finora
- Obblighi Informativi-ConsumatoreDocumento5 pagineObblighi Informativi-ConsumatoreAVA81Nessuna valutazione finora
- Principi Di Marketing - Kotler - ResumoDocumento43 paginePrincipi Di Marketing - Kotler - ResumoCaio César Costa Garcia100% (2)
- MarketingDocumento100 pagineMarketingandrea.mussoni51Nessuna valutazione finora
- Riassunto Compelto Del Libro Di MarketingDocumento75 pagineRiassunto Compelto Del Libro Di Marketingangelamorana18Nessuna valutazione finora
- Libro Marketing ?Documento216 pagineLibro Marketing ?Sara Di ScalaNessuna valutazione finora
- MarketingDocumento101 pagineMarketingantonellacerrikuNessuna valutazione finora
- Slides Secondaparte MarketingtradizionaleDocumento105 pagineSlides Secondaparte MarketingtradizionaleMaria VenturaNessuna valutazione finora
- La Distribuzione MarketingDocumento3 pagineLa Distribuzione Marketingnaticarlo3632Nessuna valutazione finora
- Apri MKT 2Documento92 pagineApri MKT 2giulia dellabiancaNessuna valutazione finora
- Marketing MixDocumento3 pagineMarketing MixNunzio GuarracinoNessuna valutazione finora
- Riassunto Libro MarketingDocumento99 pagineRiassunto Libro Marketingmattiferr2000Nessuna valutazione finora
- Imprese e ConsumatoriDocumento2 pagineImprese e ConsumatoriRosaNessuna valutazione finora
- Marketing RiassuntoDocumento92 pagineMarketing Riassuntovalestefano79Nessuna valutazione finora
- Philip Kotler 300 Risposte Sul MarketingDocumento16 paginePhilip Kotler 300 Risposte Sul MarketingMadalina LorelaiNessuna valutazione finora
- Riassunto Manuale Di Teorie e Tecniche Della PubblicitàDocumento59 pagineRiassunto Manuale Di Teorie e Tecniche Della PubblicitàGreta Panarella100% (2)
- Dispensa MISDDocumento50 pagineDispensa MISDandrebalc99Nessuna valutazione finora
- Appunti Di Economia Industriale - CorrettoDocumento197 pagineAppunti Di Economia Industriale - CorrettoDenis Hoxha100% (1)
- Lambin J J 2012 Marketing Driven Management Marketing Strategico e Operativo Mcgraw Hill PDFDocumento131 pagineLambin J J 2012 Marketing Driven Management Marketing Strategico e Operativo Mcgraw Hill PDFGiusy SaccoNessuna valutazione finora
- Riassunto-Marketing-Buono Per Rispondere Al PinguinoDocumento58 pagineRiassunto-Marketing-Buono Per Rispondere Al PinguinoJuls⚓Nessuna valutazione finora
- Articolo 4CDocumento4 pagineArticolo 4CMiro VujanovicNessuna valutazione finora
- Marketing PDFDocumento165 pagineMarketing PDFninaNessuna valutazione finora
- Marketing 14.03Documento10 pagineMarketing 14.03Luca CovielloNessuna valutazione finora
- L'evoluzione della qualità. Il Total Quality Management (TQM)Da EverandL'evoluzione della qualità. Il Total Quality Management (TQM)Nessuna valutazione finora
- Il controllo di gestione per la previsione della crisi d'impresaDa EverandIl controllo di gestione per la previsione della crisi d'impresaNessuna valutazione finora
- L'Assurdità dei Sacrifici. Elogio della spesa pubblicaDa EverandL'Assurdità dei Sacrifici. Elogio della spesa pubblicaNessuna valutazione finora
- Un modello alternativo di economia e di società: La costruzione dell'edificio della Dottrina Sociale della Chiesa e il modello di economia e società che ne discendeDa EverandUn modello alternativo di economia e di società: La costruzione dell'edificio della Dottrina Sociale della Chiesa e il modello di economia e società che ne discendeNessuna valutazione finora
- 5 modi facili per potenziare la tua Intelligenza EmotivaDa Everand5 modi facili per potenziare la tua Intelligenza EmotivaNessuna valutazione finora
- Ordinamento finanziario e contabile - Concorso Istruttore Enti locali: Sintesi aggiornata per concorsi a Istruttore e Istruttore direttivo Enti localiDa EverandOrdinamento finanziario e contabile - Concorso Istruttore Enti locali: Sintesi aggiornata per concorsi a Istruttore e Istruttore direttivo Enti localiValutazione: 3 su 5 stelle3/5 (1)
- AML Anti Money Laundering: le soluzioni antiriciclaggioDa EverandAML Anti Money Laundering: le soluzioni antiriciclaggioNessuna valutazione finora
- Diritto del lavoro: Sintesi ragionata di Diritto del lavoro per concorsi pubblici e esami universitariDa EverandDiritto del lavoro: Sintesi ragionata di Diritto del lavoro per concorsi pubblici e esami universitariNessuna valutazione finora
- Analisi tecnica e trading online - Indicatori e Oscillatori in ExcelDa EverandAnalisi tecnica e trading online - Indicatori e Oscillatori in ExcelNessuna valutazione finora
- Ordinamento degli Enti Locali: Concorsi per impiegato comunale nelle Aree: Amministrativa, Tecnica, Finanziaria e Contabile, SocialeDa EverandOrdinamento degli Enti Locali: Concorsi per impiegato comunale nelle Aree: Amministrativa, Tecnica, Finanziaria e Contabile, SocialeNessuna valutazione finora
- Il rapporto di lavoro nel pubblico impiego: Sintesi aggiornata per concorsi pubbliciDa EverandIl rapporto di lavoro nel pubblico impiego: Sintesi aggiornata per concorsi pubbliciNessuna valutazione finora
- LA SWOT ANALYSIS IN 4 STEP. Come sfruttare la matrice SWOT per fare la differenza nella carriera e nel business.Da EverandLA SWOT ANALYSIS IN 4 STEP. Come sfruttare la matrice SWOT per fare la differenza nella carriera e nel business.Valutazione: 4.5 su 5 stelle4.5/5 (2)
- Energy manager: Una professione vincente al servizio di imprese ed enti pubblici. Seconda edizioneDa EverandEnergy manager: Una professione vincente al servizio di imprese ed enti pubblici. Seconda edizioneNessuna valutazione finora
- L’analisi tecnica nel trading resa semplice. Come costruire e interpretare i grafici di analisi tecnica per migliorare la propria attività di trading online.Da EverandL’analisi tecnica nel trading resa semplice. Come costruire e interpretare i grafici di analisi tecnica per migliorare la propria attività di trading online.Nessuna valutazione finora
- Idee Chiare (Promo): per un Marketing vincente!Da EverandIdee Chiare (Promo): per un Marketing vincente!Nessuna valutazione finora
- Sicurezza sui luoghi di lavoro: Sintesi ragionata per concorsi pubblici: le norme di sicurezza sul lavoro: enti locali, sanità, scuoleDa EverandSicurezza sui luoghi di lavoro: Sintesi ragionata per concorsi pubblici: le norme di sicurezza sul lavoro: enti locali, sanità, scuoleNessuna valutazione finora