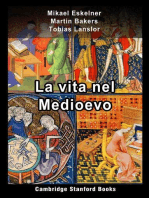Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Cina e Giappone
Caricato da
Cristina Gheorghe0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
53 visualizzazioni8 pagineCopyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
53 visualizzazioni8 pagineCina e Giappone
Caricato da
Cristina GheorgheCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 8
CAPITOLO 29
1603-1644, UNA DINASTINA DI “SHOUGUN” PER IL GIAPPONE, I QING IN CINA
di Hitomi Sato
1.Il mondo dell’Asia orientale all’alba della «prima età moderna»
Chiamare l’oggetto di questo capitolo il «mondo asiatico-orientale» invita a riflettere su
un’ottica maturata negli ultimi decenni del XX secolo tra gli storici. Piuttosto che descrivere
la storia di ogni singolo paese come un mondo a sé stante, staccato dal resto della regione,
la ricerca ha posto l’attenzione sulla comune dinamica di sviluppo storico tra diversi paesi,
senza per questo sminuire l’importanza delle particolarità di ogni formazione statuale. Nei
primi decenni del Seicento, al rapido incremento del commercio marittimo internazionale
nel secolo precedente, seguirono diverse risposte politiche e sociali. Il divieto delle attività
marittime, quale misura della Cina dei Ming e dei Qing, fu una linea comune nei diversi
paesi dell’Asia orientale, tra cui il Giappone, che limitò gli scambi con i paesi esteri. Nella
Cina Ming e nelle zone confinanti crebbero le potenze economico-politico-militari che
seppero sfruttare tale situazione, concentrando nelle proprie mani risorse politiche ed
economiche. Da tale dinamica uscì vincitore il popolo jusen, o jurchen, che fondò il vasto
Impero multietnico dei Qing, scuotendo l’intero sistema diplomatico nonché gli scambi nel
«mondo asiatico-orientale». In quella che gli storici europei chiamano la «prima età
moderna», i cinesi con il periodo del tardo impero e gli storici giapponesi con il periodo Edo,
ogni paese dovette scegliere la risposta da dare a tale situazione, modificando
profondamente la geografia politica di una regione che era già connessa ai processi di
mondializzazione.
2.I Manciù e i Qing. La fondazione dello Stato jurchen
Il popolo degli jusen o jurchen, appartenente al ceppo linguistico tunguso, era un gruppo di
tribù stanziate nel Nord-Est della Cina e della Siberia orientale, sottomesso alla dominazione
Ming. Si occupava della caccia e del commercio, in particolare delle pellicce di martora e del
ginseng, che erano tra i prodotti più richiesti nel mercato internazionale dell’epoca. Gli
jurchen ne controllavano sia la zona di produzione sia le vie d’acqua per il trasporto delle
merci, cosa che aveva permesso loro di diventare protagonisti assoluti di attività
economiche molto redditizie. Nei confronti dei gruppi jurchen, che i cinesi consideravano un
popolo primitivo, dedito alla caccia e a un’agricoltura rudimentale, l’imperatore Yongle
(1403-1424) e i suoi successori adottarono una politica di divide et impera, riconoscendo ai
potenti vari privilegi, tra i quali l’autorizzazione ufficiale di portare il tributo all’imperatore –
cosa che significava di fatto entrare in un rapporto commerciale vantaggioso con la Cina – e
l’assegnazione del titolo di ufficiale dell’Impero Ming. Visto il vantaggio economico di tale
sistema, il numero delle missioni degli jurchen per portare il tributo si incrementò
notevolmente con il tempo, fino a spingere l’autorità dei Ming a imporre restrizioni,
rilasciando le patenti a ogni persona avente diritto di partecipare alle missioni tributarie. Dal
tempo di Yongle, la popolazione era incorporata nel sistema militare dei Ming chiamato wei
suo (posto di guardia): ogni unità (wei) era composta da 5.600 uomini, e il ruolo di comando
era riconosciuto ai vari capi jurchen. Pare, tuttavia, che intorno alla metà del Cinquecento il
sistema wei suo fosse già quasi scomparso tra gli jurchen, e che al suo posto si affermassero
nuove confederazioni formate da diversi gruppi all’interno dello stesso popolo.
L’ascesa di Nurhaci avvenne quando la riorganizzazione dell’ordine politico del mondo
jurchen era in corso, spinta da una conflittualità tra i capi tribù sempre più accesa, causata
da un rapido incremento del commercio. Nurhaci era nato nella famiglia di un capo tribù e
nel 1583, appena diventato un capo indipendente, riuscì a unificare la maggior parte dei
gruppi del suo popolo. Il generale cinese Li Chengliang, governatore militare della provincia
di Liaodong, diede a Nurhaci un tacito assenso a espandere il proprio dominio, pensando di
tenere gli jurchen sotto controllo attraverso la sua collaborazione. Tuttavia, quando Li
Chengliang venne rimosso dalla carica di governatore miltare, la politica dei Ming mutò in
una direzione opposta e ostile a Nurhaci. Nel 1616 questi fu proclamato khan degli jurchen
e rinominò il proprio Stato come Aisin gurun (in lingua jurchen), ossia Jin posteriore (in
lingua cinese), appellandosi al ricordo storico della dinastia Jin (1115-1234), che aveva
controllato secoli prima la Manciuria e gran parte della Cina settentrionale. Tutti e due i
termini, Jin e khan, stavano a indicare la riunificazione dei popoli jurchen e mongoli sotto un
nuovo imperatore.
3.Le Otto Bandiere
Dal tempo di Nurhaci, il cardine istituzionale dello Stato jurchen era il sistema delle Otto
Bandiere. Si trattava di un’organizzazione militare nonché amministrativo-sociale, elaborata
da Nurhaci e originariamente volta a inquadrare gli jurchen, poi applicata ad altri popoli
come i mongoli e i cinesi. La popolazione venne divisa in otto corpi d’armata
chiamati gūsa («bandiera»), ognuno dei quali aveva una bandiera contraddistinta da uno di
quattro colori (il giallo, il bianco, il rosso e il blu), assieme alla presenza o meno della
decorazione dell’orlo. Il comando di ogni gūsa venne conferito a un membro della casa
reale, che assunse il titolo di beile. L’unità di base del sistema delle otto bandiere era
il niru («compagnia»), composto da qualche centinaio di uomini. Cinque niru costituivano
un jalan («reggimento»), e cinque jalan formavano un gūsa. L’assegnazione della quota di
forze militari e lavorative veniva effettuata in numero equo per ogni niru. I beile avevano il
diritto di partecipare al consiglio del governo dell’intero stato jurchen, oltre che controllare i
propri niru. Sulla natura del rapporto tra il khan, i beile e le bandiere, le opinioni degli storici
non sono perfettamente concordi. La valutazione di esso varia da un sistema federativo in
cui i beile assomiglierebbero a figure principesche autonome pari al khan, a quello
fortemente centralizzato sotto il comando del khan, a quello nel quale le suddette due
caratteristiche conviverebbero come parti integranti.
4.Verso un impero multietnico
Nurhaci nel 1619 aveva sconfitto gli eserciti Ming strappando all’Impero cinese molte città
ai confini settentrionali. Un’identica politica di aggressione fu adottata dal figlio, Huang Taiji,
che con una serie di campagne militari sottomise la Corea (1627) per poi tentare di invadere
la Cina senza successo. Si rivolse quindi verso Ovest, alla Mongolia interna, offrendosi come
capo dell’alleanza tra alcune tribù mongole e gli jurchen, contro Ligdan Khan, il capo tribù di
Chahar e l’ultimo legittimo khan dei mongoli. Riuniti i capi delle tribù insediate a ridosso
della Grande Muraglia, Huang Taiji fu in grado di sfidare gli eserciti Ming. Sotto il lungo
regno dell’imperatore Wanli (1573-1620), il governo dell’Impero cinese aveva attraversato
un periodo di profonda crisi: numerose rivolte anti-fiscali sia nelle campagne sia nelle città si
erano succedute a siccità e carestie. Le difficoltà economiche, amplificate dai costi altissimi
delle guerre contro i giapponesi in Corea, avevano reso più evidente l’inadeguatezza delle
misure governative. Huang Taiji mosse le sue truppe simultaneamente contro l’impero e le
tribù mongole di Ligdan Khan, che si sottomisero agli jurchen nel 1635, offrendo a Huang
Taiji il sigillo imperiale della dinastia Yuan. Munito così dell’autorità dei grandi khan, e
riconosciuto come tale anche dai mongoli e dai militari cinesi, Huang Taiji salì sul trono
imperiale. Nel 1635 adottò ufficialmente per gli jurchen il nome manciù, una
denominazione che servì a creare un’identità etnica separata dai vicini mongoli e cinesi.
L’anno dopo, nel 1636, dichiarò l’inizio della dinastia Qing – e poi del suo Stato, Daicing
gurun (Qing) –, sostituendo il vecchio titolo di Jin. Qing era un nome simbolico, che
significava «chiaro», «puro», e come nel caso del termine manciù, aveva lo scopo di
cancellare, agli occhi dei nuovi sudditi cinesi, il passato poco glorioso degli jurchen, ritenuti
per tutto il periodo Ming poco più che un popolo incivile.
I primi anni della dinastia Qing furono caratterizzati da una maggiore spinta verso la
centralizzazione dello Stato. La struttura dell’amministrazione provinciale rispettò il modello
precedente, ma vi fu sovrapposta una carica nuova, quella di governatore generale, affidata
di solito a personale manciù. Su modello cinese, venne creato l’Ufficio Letterale (fondato nel
1629, poi riorganizzato e rinominato come Le Accademie dei Tre Palazzi nel 1635), con il
compito di trasmettere le comunicazioni tra l’imperatore e le nazioni esterne, di stendere i
documenti e di tenere i memoriali di ogni evento. Poi, sempre sul modello degli uffici
centrali cinesi, nel 1631 vennero istituiti i Sei Ministeri, nonché il consolato e l’Ufficio degli
Affari Mongoli (1636). Due anni dopo, quest’ultimo fu rinominato Lifan Yuan (o Corte per gli
affari coloniali), un ufficio addetto ai rapporti con le regioni periferiche della Mongolia,
Turkestan e Tibet. Le nomine degli ufficiali vennero ridistribuite prestando attenzione
all’equilibrio tra le etnie manciù, mongole e han, l’etnia cinese maggioritaria. Alle riforme
fiscali già varate dai predecessori, il regime Qing aggiunse la raccolta e lo stoccaggio di
scorte cerealicole in appositi granai imperiali, una misura finalizzata a controllare i prezzi dei
generi di prima necessità e a evitare le ondate di insurrezioni contadine che portarono
diversi danni ai Ming.
La centralizzazione che investì gli uffici soggetti al controllo diretto del khan rappresentò,
almeno in una certa misura, una diminuzione dell’autorità politica delle bandiere e dei loro
capi. Quando Huang Taiji fu eletto khan, ampie zone della Cina erano ancora controllate da
funzionari e militari fedeli ai Ming. Ma nel 1642 la rivolta di Li Zicheng, alla guida di una delle
numerose rivolte contadine susseguitesi durante l’ultimo periodo della dinastia, causò la
crisi finale dei Ming. Due anni più tardi, le truppe guidate da Li Zicheng entrarono a Pechino
costringendo la corte a una fuga disordinata e l’ultimo imperatore al suicidio; il generale Wu
Sangui, stanziato nella regione del passo di Shanhai, si sottomise ai Qing, aprendo il passo
alle truppe guidate da Dorgon, reggente del nuovo imperatore Fulin dopo la morte di Huang
Taiji nel 1643. Entrato a Pechino e cacciati gli uomini di Li Zicheng, Dorgon dichiarò di
trasferirvi la capitale dei Qing per accogliervi l’imperatore.
Nei trent’anni successivi le armate Qing ridussero al silenzio le ampie sacche di resistenza
feudale nella Cina meridionale (venne occupata anche l’isola di Taiwan) e sospinsero
all’esterno dei vecchi confini imperiali le tribù mongole del Nord. Nel 1689, con il trattato di
Nerchinsk, l’abile imperatore Kangxi (1661-1722) fissava la linea di confine tra la Cina e
l’Impero zarista assicurandosi il controllo della regione dell’Amur. Il graduale inglobamento
della Cina (l’espansione sarebbe continuata fino al tardo Settecento) diede all’Impero
mancese una fisionomia ambigua. Se da un lato l’organizzazione politico-militare tipica dei
manciù restava l’ossatura fondamentale del dominio Qing, dall’altro essa doveva integrarsi
con la più raffinata cultura politica Ming. Si trattava di trasformare un esercito composto in
gran parte di nomadi razziatori in uno strumento disciplinato al servizio dell’imperatore. La
conquista della Cina spinse a riorganizzare il sistema delle otto bandiere in direzione di un
maggior controllo centrale: tre bandiere, le due bandiere gialle e quella bianca semplice
senza decorazione dell’orlo, furono classificate in una categoria superiore alle altre e poste
alle dirette dipendenze dell’imperatore (da qui il nome di Tre Bandiere Superiori, distinte
dalle altre Cinque Bandiere Inferiori). Tra le cariche amministrative civili, al contrario, l’élite
burocratica han conservò una posizione di vertice. Il tradizionale sistema amministrativo
cinese, che vietava (o riduceva al minimo) la concessione di terre pubbliche come
ricompensa di servizi, frenò la possibilità di una deriva feudale dell’impero alimentata dalle
ambizioni dei comandanti delle bandiere.
Le differenze di rango e di linguaggio – nel primo periodo Qing i decreti imperiali si
emanavano in cinese e in manciù, e spesso in mongolo e in tibetano – vennero organizzate
in modo da permettere i passaggi da un’identità etnica all’altra: manciù e han sedevano
assieme nel Gran Consiglio dell’imperatore, mentre persino il rigido sistema delle bandiere
accolse con il tempo giovani cinesi desiderosi di entrare nella carriera militare. Anche la
fisionomia dell’imperatore si adattò alla multietnicità del suo dominio, grazie a un abile
processo di amalgama: la raffigurazione confuciana dell’imperatore padre dei suoi popoli
venne infatti accostata dai discendenti di Huang Taiji a quella del khan mongolo come
signore universale chiamato a governare una «famiglia» di popolazioni etnicamente diverse.
Il consolidamento amministrativo seicentesco (contemporaneo a quello sperimentato da
Pietro il Grande in Russia) e la sua rappresentazione simbolica furono uno strumento di
coesione per la «famiglia multiculturale» dell’Impero Qing, che nel XVIII secolo, con la
sconfitta degli zungari, incorporarono il Tibet a una congerie di popoli diversissimi – han,
manciù, mongoli, coreani e altri ancora. Raggiunto l’apogeo sotto Qianlong (1735-1796),
quel sistema di dominio cominciò a declinare con l’arrivo degli inglesi e vide il collasso nel
1911.
5.Il Giappone. Avvento e sviluppo dello shogunato dei Tokugawa
Sorto tra il VI e l’VIII secolo dell’era cristiana, con la tradizione shintoista e la penetrazione
del buddismo, l’Impero giapponese dopo l’anno Mille conobbe una grande fioritura
culturale e una frammentazione politica dovuta alla costituzione di shoen, tenute
appartenenti a signori, santuari shintoisti e monasteri buddisti che formavano entità
autonome in cui i contadini si ponevano sotto la protezione di un ryoshu (chi deteneva
lo shoen) e dei suoi corpi armati formati dai bushi o samurai, che lentamente elaborarono
un loro codice d’onore. Dal XII secolo alla figura dell’imperatore, sempre più simbolica, si
affiancò quella di uno shogun, ovvero di un detentore dell’effettivo dominio militare e
politico (bakufu, o «governo della tenda») trasmesso all’interno di un solo clan signorile che
spesso scelse di costituire la propria corte in una città distinta dalla sede imperiale (Kyoto).
Con la fine dell’era Muromachi (1338-1573) e la crisi del clan Ashikaga, mentre l’arcipelago
entrava nella rete asiatica dei commerci esportando raffinati manufatti, per il Giappone si
aprì un periodo di aspre lotte interne e grande fioritura culturale e cerimoniale. Dalle
precedenti élite di guerrieri, monaci e funzionari, infatti, erano emersi i daimyō, circa 200
capi militari che godevano di una rendita superiore a 10.000 koku di riso (un koku
equivaleva a circa 150 chili di cereale) e costruivano insediamenti fortificati, controllando i
villaggi, dotandosi di un corpo di guerrieri e gareggiando per il prestigio. La produzione
agricola, gestita da contadini che promettendo fedeltà al signore potevano introdurre
migliorie nei campi, aumentò e con essa la popolazione giapponese, che nel Cinquecento
raggiunse i 17 milioni di abitanti.
Con la maggiore circolazione monetaria, l’avvento delle armi da fuoco e l’arrivo dei
portoghesi (1543), pochi daimyō ebbero le risorse per erigere forti in pietra e per acquistare
archibugi, e ciò esacerbò lo scontro politico. Da tali conflitti emerse tuttavia un signore della
guerra, Oda Nobunaga, che sottomise gli avversari, entrò a Kyoto (1573) ma senza
assumere il titolo di shogun. Oda rivolse la sua furia contro i monasteri buddisti che gli
avevano resistito, favorendo in cambio la penetrazione del cristianesimo e, sebbene non
riuscisse a sottomettere circa metà delle province, cominciò a confiscare le armi ai clan
guerrieri e avviò un censimento per riformare il sistema fiscale. Ma il suo assassinio del 1582
gettò l’arcipelago in un nuovo ciclo di lotte che fece emergere un suo affiliato, Toyotomi
Hideyoshi, che dall’imponente castello di Osaka conquistò il potere nel 1587, disarmando il
paese con la cosiddetta «caccia alle spade». Hideyoshi diede un assetto ai rapporti tra
centro e signori della guerra, permettendo ai daimyō di mantenere un raggio di potere nei
loro castelli, in cambio di un atto di sottomissione che comportava il recarsi periodicamente
e il risiedere presso la sua corte.
Nel 1598, durante la seconda spedizione organizzata per dare sfogo alle pulsioni militari e
conquistare la Corea, vassalla dei Ming, Hideyoshi morì. Della gestione del periodo post-
bellico si occupò un consiglio dei Cinque Anziani (gotairō), che doveva governare in nome
del figlio Hideyori. Ma l’avanzata di Tokugawa Ieyasu ruppe l’equilibrio nello schieramento
dei sostenitori della casa Toyotomi, causando la battaglia di Sekigahara (1600). Nel 1603
Ieyasu, il vincitore, fondò un nuovo shogunato a Edo (Tokyo). Eliminato Hideyori con due
assedi al castello di Osaka, nel 1615 emanò la legge Buke-shohatto («Codici per le case
militari») con lo scopo di definire i principi del nuovo bakufu, nel quale si dovevano
integrare due aspetti istituzionali apparentemente contraddittori: una forte concentrazione
di poteri politici e militari da un lato, e il riconoscimento di un’ampia autonomia
ai daimyō dall’altro. Per le case aristocratiche e la famiglia imperiale, invece, fu emanata la
legge Kinchū narabini kuge shohatto («Codici per la corte imperiale e per le case
aristocratiche»). Le loro funzioni principali dovevano essere le attività culturali e simboliche,
con l’esclusione di ogni sostanziale pretesa di potere politico.
L’elaborazione del nuovo bakufu fu portata a compimento dal terzo shogun Iemitsu. Egli
emanò un decreto per definire gli obblighi militari dei daimyō e hatamoto (i vassalli diretti
dello shogun), stabilendo il livello di ogni feudo in base alla rendita in koku. Inoltre egli
rilasciò i documenti di riconoscimento dei dominî a tutti i daimyō insieme, per dimostrare
che il rapporto di dipendenza che avevano nei suoi confronti non era un titolo individuale,
ma derivava dall’appartenenza cetuale al gruppo dei daimyō, sottomesso in quanto tale
allo shogun e inserito nella gerarchia politica del regime. Tra i provvedimenti di Iemitsu
quello di maggiore portata fu, nel 1635, la modifica del Buke-shohatto, che diede un chiaro
profilo istituzionale a una pratica che, come si è visto, era stata già introdotta: la residenza
alternata dei daimyō (sankin-kōtai). I daimyō del cosiddetto periodo di Edo furono
classificati in tre categorie:
1) gli shinpan facevano parte della parentela shogunale come discendenti di Ieyasu (tra
questi, le tre casate chiamate gosanke, ovvero i Tokugawa di Owari, Kishū e Mito, erano le
più importanti);
2) i fudai erano alleati dei Tokugawa di lunga tradizione;
3) i tozama erano i clan alleatisi intorno alla battaglia di Sekigahara o sottomessi dopo di
essa. Vi erano inclusi quindi i maggiori daimyō pari o superiori ai Tokugawa, da trattare con
più cautela.
Il sankin-kōtai era un segno di obbedienza all’autorità shogunale: ogni daimyō doveva
recarsi a Edo portando con sé doni e un nutrito seguito. Tale obbligo significava un continuo
onere fiscale e un aggravio di spese per gli equipaggiamenti, i vestiti, gli alloggi e i viveri di
tutti i partecipanti alla processione tra il dominio locale e la residenza shogunale in Edo. Il
sistema divenne pertanto il mezzo più efficace per controllare i daimyō, in particolare
quelli tozama.
Per quanto riguarda gli organi di governo, già dal tempo di Ieyasu, all’apice del bakufu, sotto
lo shogun, esisteva un numero imprecisato di persone influenti che coprivano la carica
di toshiyori (anziani), investiti delle competenze più importanti negli affari del governo,
senza alcuna forma di regolamento ufficiale. La riforma di tale sistema fu intrapresa da
Iemitsu. Egli creò gli ufficiali detti «i Sei», assegnando loro una parte dei compiti
dei toshiyori; poi istituì un regolamento d’ufficio per i toshiyori, che da quel momento
cominciarono a essere chiamati anche rōjū, per delimitare le loro competenze per iscritto in
quanto funzionari del governo. I rōjū e i Sei dipendevano direttamente dallo shogun, mentre
gli altri ufficiali di rango più basso, quali i bugyō (commissari, sovrintendenti), vennero posti
sotto la direzione dei rōjū.
6.Il divieto del cristianesimo e le relazioni con il mondo
Nei confronti del cristianesimo, Ieyasu distinse le missioni e i rapporti commerciali,
proibendo le prime e mantenendo i secondi con la Spagna e il Portogallo. La rotta cambiò
con il secondo shogun Hidetsugu, che vietò parzialmente il commercio con le navi
portoghesi e inglesi e di trasportare persone e armi giapponesi all’estero. Poi, nel 1624, egli
ruppe definitivamente le relazioni diplomatiche ufficiali con la Spagna. Iemitsu restrinse
ancora di più le possibilità di contatto tra i giapponesi e i paesi cristiani. Dopo l’aggressione a
una nave di commercio munita di documento shogunale da parte della flotta spagnola nelle
Filippine, Iemitsu vietò i viaggi all’estero delle navi che non fossero munite di una lettera
firmata dai rōjū e indirizzata al bugyō di Nagasaki. Quattro anni dopo, inoltre, promulgò il
divieto completo di viaggi all’estero dei giapponesi, proibendo contemporaneamente
il ritorno dei giapponesi già residenti all’estero. La rottura diplomatica e commerciale con il
Portogallo divenne definitiva con l’ordine di espulsione dei portoghesi emanato nel 1639,
dopo la sollevazione dei fedeli battezzati di Shimabara scoppiata in Kyūshū nel 1637, che
terminò nell’anno seguente con il massacro totale degli ultimi resistenti.
Dopo la rottura con il Portogallo, i paesi che mantennero rapporti commerciali con il
Giappone furono quindi l’Olanda e la Cina. Per cautelarsi, tuttavia, agli olandesi fu ordinato il
trasferimento del loro ufficio di commercio da Hirado all’isola artificiale di Dejima, sita nel
mare di Nagasaki, sotto il dominio diretto del bakufu. I porti aperti all’estero rimasero
quattro: Matzumae (in Ezo, oggi Hokkaido), Tsushiima, Satsuma (nel Kyūshū meridionale) e
Nagasaki. In seguito, tale restrizione è stata descritta come la chiusura del paese da ogni
contatto con il mondo esterno (sakoku). Ma la parola risale solo al 1801 e compare nella
traduzione giapponese di un libro di Engelbert Kämpfer. Il termine in realtà serviva a
indicare il sistema diplomatico selettivo del Giappone di allora, e non significa affatto la
chiusura totale per principio. Accanto a tale scelta di direzione nelle relazioni internazionali,
in Giappone andò elaborandosi un nuovo concetto dell’ordine del mondo asiatico. La
tradizionale distinzione cinese tra Hua(la civiltà cinese) e Yi (i popoli «barbarici») fu
rimodellata, adeguandola alle esigenze giapponesi per legittimare le relazioni con gli altri
paesi. Il Giappone fu posto al centro di tale universo ideologico, di cui facevano parte la
Corea, il Ryūkyū, l’Olanda, la Cina sotto il dominio «barbarico» dei Qing, e la popolazione
Ainu in Ezo, allora considerata come una terra straniera. Un fatto è certo: il Giappone
Tokugawa (1603-1868) conobbe una grande vitalità economica che comportò l’ascesa del
nuovo ceto dei chonin (i mercanti), arricchitosi con i dispendiosi consumi urbani dell’élite.
7.Fra centro e autonomie territoriali
Per indicare il sistema di governo sotto gli shogun Tokugawa è largamente in uso tra gli
storici il termine bakuhan. La parola deriva dalla contrazione delle parole bakufu e han (i
dominî dei daimyō). Ad ogni han lo shogunato riconobbe infatti un ampio spettro di
autonomie politico-economiche. Dalla seconda metà degli anni sessanta del XX secolo, gli
storici dibattono tuttavia intorno al concetto chiave di questo sistema, identificato con la
parola kōgi, che significa l’autorità pubblica spettante non alla persona dello shogun, bensì
al bakufu in qualità di governo del corpo politico dell’intero paese, posto sopra ogni
relazione personale di dipendenza e ogni singolo dominio signorile. Gli hansi sottomettono
al kōgi shogunale e ne condividono una parte nei confronti della popolazione del loro
territorio, come un piccolo kōgi. A ogni han dal centro sono inviati ispettori per controllare,
sorvegliare, e persino incoraggiare a sviluppare il buon governo e a migliorare la situazione
economico-sociale in ciascun contesto locale. Tale simbiosi tra un potere centralizzato e una
larga autonomia dei corpi politici territoriali rappresenta una delle caratteristiche più
significative del caso giapponese, che necessita di ulteriori confronti con i sistemi adottati in
altre parti del mondo in età moderna.
Potrebbero piacerti anche
- Cina e GiapponeDocumento8 pagineCina e GiapponeCristina GheorgheNessuna valutazione finora
- Storia Della Cina 2 Riassunto Cap.8Documento4 pagineStoria Della Cina 2 Riassunto Cap.8vittoria iaccarinoNessuna valutazione finora
- CinaDocumento6 pagineCinamonica ines avitabileNessuna valutazione finora
- Storia Della Cina Durante La Dinastia Qing 1644-1916Documento11 pagineStoria Della Cina Durante La Dinastia Qing 1644-1916Ilaria ClementeNessuna valutazione finora
- Letteratura CineseDocumento49 pagineLetteratura Cineseelisa attoliniNessuna valutazione finora
- Storia Della CinaDocumento64 pagineStoria Della CinapstrlNessuna valutazione finora
- La Ricerca Dell'equilibrio Politico in Europa e Lo Sviluppo Economico PDFDocumento6 pagineLa Ricerca Dell'equilibrio Politico in Europa e Lo Sviluppo Economico PDFBenedetta PiliaNessuna valutazione finora
- Storia Della CinaDocumento57 pagineStoria Della CinaTessNessuna valutazione finora
- Capitolo SeiDocumento6 pagineCapitolo SeiDario GiacaloneNessuna valutazione finora
- The Literati Era and Its Demise (1723-1840)Documento9 pagineThe Literati Era and Its Demise (1723-1840)francesca conteNessuna valutazione finora
- 1 MARCO POLO Marina MontesanoDocumento9 pagine1 MARCO POLO Marina MontesanoLudovica GaglianiNessuna valutazione finora
- Docsity Riassunto Del Mondo Del Principe SplendenteDocumento31 pagineDocsity Riassunto Del Mondo Del Principe SplendenteFredrik Ase IgnNessuna valutazione finora
- Il Mondo Del Principe SplendenteDocumento31 pagineIl Mondo Del Principe SplendenteVincenzo GaudioNessuna valutazione finora
- Capitolo QuattroDocumento9 pagineCapitolo QuattroDario GiacaloneNessuna valutazione finora
- La Letteratura Cinese BertuccioliDocumento10 pagineLa Letteratura Cinese BertuccioliAndrea GabrieleNessuna valutazione finora
- Da Costantino Alla Fine Dell'impero CarolingioDocumento11 pagineDa Costantino Alla Fine Dell'impero CarolingioAgeometretosmedeisNessuna valutazione finora
- Capitolo TreDocumento7 pagineCapitolo TreDario GiacaloneNessuna valutazione finora
- L29 Mutamenti, Chiusura e Decandenza Della Cina ImperialeDocumento2 pagineL29 Mutamenti, Chiusura e Decandenza Della Cina ImperialeTATIANA INNOCENTENessuna valutazione finora
- Letteratura CineseDocumento51 pagineLetteratura Cineseelisa attoliniNessuna valutazione finora
- Storia Del Diritto RomanoDocumento47 pagineStoria Del Diritto Romanopedrulo2Nessuna valutazione finora
- Storia MedievaleDocumento14 pagineStoria Medievalemery87100% (4)
- Riassunto Del Libro Storia Medievale Giovanni VitoloDocumento50 pagineRiassunto Del Libro Storia Medievale Giovanni VitoloEleonora CocciaNessuna valutazione finora
- Il massacro di Nanchino: Un terribile episodio della guerra sino-giapponeseDa EverandIl massacro di Nanchino: Un terribile episodio della guerra sino-giapponeseNessuna valutazione finora
- La Crisi Dei Grandi ImperiDocumento6 pagineLa Crisi Dei Grandi Imperiapi-285399009100% (1)
- La questione sino tibetana nel diritto internazionaleDa EverandLa questione sino tibetana nel diritto internazionaleNessuna valutazione finora
- I Longobardi in ItaliaDocumento2 pagineI Longobardi in ItaliaIvana CanonicoNessuna valutazione finora
- Copia Di 3.1 - L'ottocento Intro, Alessandro I e CulturaDocumento7 pagineCopia Di 3.1 - L'ottocento Intro, Alessandro I e CulturaSilvia GabrieleNessuna valutazione finora
- Riassunto Storia MedievaleDocumento129 pagineRiassunto Storia MedievaleFrancesco GalanteNessuna valutazione finora
- Storia e Civiltà Del GiapponeDocumento37 pagineStoria e Civiltà Del GiapponeDiana PalmaNessuna valutazione finora
- Santangelo RiassuntoDocumento32 pagineSantangelo RiassuntoDaniele MinnoneNessuna valutazione finora
- Storia MedievaleDocumento51 pagineStoria MedievaleGaia PasqualiNessuna valutazione finora
- Relazioni GlobaliDocumento50 pagineRelazioni GlobaliLaura VenghiNessuna valutazione finora
- Storia Moderna Riassunto ManualeDocumento193 pagineStoria Moderna Riassunto Manualeponticellimariarosaria5Nessuna valutazione finora
- S. Istituzioni Politiche e SocialiDocumento29 pagineS. Istituzioni Politiche e Socialif.ragni03Nessuna valutazione finora
- Il Giappone Moderno Dall'Ottocento Al 1945Documento29 pagineIl Giappone Moderno Dall'Ottocento Al 1945keyoh96394100% (1)
- Frammenti Di Ninjutsu StoricoDocumento15 pagineFrammenti Di Ninjutsu StoricoJames HigginsNessuna valutazione finora
- Parte Generale CardiniDocumento106 pagineParte Generale CardiniQuicksilver 98Nessuna valutazione finora
- Storia delle repubbliche italiane dei secoli di mezzo, v. 9Da EverandStoria delle repubbliche italiane dei secoli di mezzo, v. 9Nessuna valutazione finora
- 1il Termine Medioevo Significa Età Di MezzoDocumento3 pagine1il Termine Medioevo Significa Età Di Mezzoyeyegim885Nessuna valutazione finora
- Storia e Civiltà GiapponeDocumento70 pagineStoria e Civiltà GiapponeyamaluuncinettoNessuna valutazione finora
- StoriaDocumento8 pagineStoriah6mhpbbnfkNessuna valutazione finora
- Domande Storia MedievaleesameDocumento24 pagineDomande Storia Medievaleesameg.nencioni1Nessuna valutazione finora
- LongobardiDocumento6 pagineLongobardiFederica FaletraNessuna valutazione finora
- Capitolo TerzoDocumento9 pagineCapitolo Terzoeric sohnNessuna valutazione finora
- Giardina Sabbatucci VidottoDocumento50 pagineGiardina Sabbatucci VidottoFilippa Daniela Campagna0% (1)
- L'età Tardo AnticaDocumento18 pagineL'età Tardo AnticaLudovica SantoniNessuna valutazione finora
- GiapponeDocumento124 pagineGiapponeLASTSAMURAI10Nessuna valutazione finora
- Jackson Sorensen Teorie Delle Relazioni InternazionaliDocumento39 pagineJackson Sorensen Teorie Delle Relazioni InternazionaliGabriele DestefanoNessuna valutazione finora
- Mercanti Italiani e Vie Della Seta-LibreDocumento53 pagineMercanti Italiani e Vie Della Seta-LibreDanieleRicciNessuna valutazione finora
- L'impero RussoDocumento3 pagineL'impero RussoArianna DincaNessuna valutazione finora
- Turchia 2Documento11 pagineTurchia 2Ale MelliNessuna valutazione finora
- Filo 1 CompletoDocumento26 pagineFilo 1 CompletoGinevra JunsongNessuna valutazione finora
- Riassunto Di Storia Dell'alto MedioevoDocumento28 pagineRiassunto Di Storia Dell'alto MedioevoAlessandro ColleoniNessuna valutazione finora
- RinascimentoDocumento3 pagineRinascimentorachelegranci23Nessuna valutazione finora
- Manuale Di Storia MedievaleDocumento51 pagineManuale Di Storia MedievaleAndrea Gabriele100% (10)
- L Illuminismo Di Dorinda OutramDocumento8 pagineL Illuminismo Di Dorinda OutramDavide Agnocchetti100% (1)
- 27 Sett. - 18 Ott.Documento102 pagine27 Sett. - 18 Ott.Cristina GheorgheNessuna valutazione finora
- 27 Sett. - 18 Ott.Documento102 pagine27 Sett. - 18 Ott.Cristina GheorgheNessuna valutazione finora
- 27 Sett. - 18 Ott.Documento102 pagine27 Sett. - 18 Ott.Cristina GheorgheNessuna valutazione finora
- (Ebook-Ita) Hagakure - Il Codice Dei Samurai - Yamamoto Tsunetomo PDFDocumento78 pagine(Ebook-Ita) Hagakure - Il Codice Dei Samurai - Yamamoto Tsunetomo PDFAlberto Azzano50% (2)
- "Storia Del Giappone" Riassunto Capitolo 4Documento17 pagine"Storia Del Giappone" Riassunto Capitolo 4michiNessuna valutazione finora
- Frammenti Di Ninjutsu StoricoDocumento15 pagineFrammenti Di Ninjutsu StoricoJames HigginsNessuna valutazione finora
- Riassunto Storia Del Giappone 1Documento40 pagineRiassunto Storia Del Giappone 1LetiziaFerrariNessuna valutazione finora
- Ninja ToDocumento4 pagineNinja ToEbio NinjutsuNessuna valutazione finora
- Kendo Pratico by Gian Franco Moretti PDFDocumento130 pagineKendo Pratico by Gian Franco Moretti PDFJozef BenackaNessuna valutazione finora
- Heike MonogatariDocumento1 paginaHeike MonogatariRebecca HayesNessuna valutazione finora
- Periodo EdoDocumento2 paginePeriodo EdoAndrea BiancoNessuna valutazione finora
- Takuan SohoDocumento3 pagineTakuan SohoRebecca HayesNessuna valutazione finora