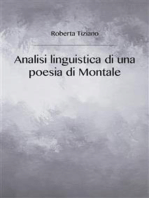Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Il Continuum
Il Continuum
Caricato da
martinaparisi212Titolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Il Continuum
Il Continuum
Caricato da
martinaparisi212Copyright:
Formati disponibili
Il continuum Un’altra importante nozione sociolinguistica che rimanda alle modalità con
cui i parlanti si muovono tra le diverse varietà del repertorio va sotto il nome di
“continuum”. Si tratta, in sostanza, del fatto che tali varietà, soprattutto quelle intermedie –
che si collocano fra i due poli estremi rappresentati dall’italiano più formale e dal dialetto
più stretto –, non sono sempre chiaramente distinte ma, in un certo senso, “sfumano” l’una
nell’altra, mostrando un grado di sovrapposizione che può anche essere notevolmente
ampio. Scrive Berruto (Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo, Firenze, La Nuova
Italia, 1987, p. 27):
L’uso della nozione di continuum in sociolinguistica si rifà alla concezione tradizionale del
‘continuum dialettale’, riferito alla variazione geografica, con cui si intende una serie di dialetti, di
solito geneticamente imparentati, tale che dialetti adiacenti siano fra loro reciprocamente
comprensibili, mentre non lo siano più i dialetti all’estremità della serie. In altri termini, i parlanti di
un dialetto A comprenderebbero bene il dialetto vicino B (e viceversa), i parlanti di B
comprenderebbero il dialetto C (e viceversa), ma i parlanti di A non comprendono più il dialetto,
poniamo, M, e viceversa.
Per chiarire ora il concetto di continuum, così com’è usato in sociolinguistica, facciamo
subito un esempio concreto.
1. non sono affatto a conoscenza di che cosa sia stato loro detto
2. non sono affatto a conoscenza di che cosa abbiano loro detto
3. non so affatto che cosa abbiano loro detto
4. non so affatto che cosa abbian loro detto
5. non so affatto che cosa hanno loro detto
6. non so mica che cosa gli hanno detto
7. non so mica che cosa gli han detto
8. non so mica cosa gli han detto
9. so mica cosa gli han detto
10. so mica cosa ci han detto
11. so mica cosa che ci han detto
Questi undici modi sinonimici di “dire la stessa cosa”, tutti possibili e tutti provenienti dallo
stesso repertorio (di area settentrionale, anzi piemontese), sono prodotti dall’interazione di
otto diverse variabili linguistiche (l’opposizione fra costruzione passiva e costruzione
attiva, sia stato/abbiano; le forme della negazione, non … affatto/non … mica/ … mica;
l’opposizione fra essere a conoscenza di e sapere; la forme del pronome neutro delle
interrogative, che cosa/cosa/cosa che; quella fra congiuntivo e indicativo per esprimere
incertezza; il troncamento delle vocali finali, abbiano/abbian, hanno/han; le forme del
pronome obliquo di terza persona plurale, loro/gli/ci, il parziale scempiamento delle
consonanti intense in detto) e, come si vede, differiscono l’uno dall’altro solo per modifiche
quasi impercettibili nella combinazione di tali variabili. Ma, mentre la differenza tra 1 e 2, 2
e 3, 3 e 4 è sempre minima, quella tra 1 e 6 è già abbastanza vistosa, mentre fra 1 e 11 è
ormai radicale (con 11 siamo infatti alle soglie della sezione dialettale del repertorio).
Semplificando di parecchio un’analisi che potrebbe essere anche piuttosto lunga e
complessa (ivi, p. 34),
le formulazioni 1 e 2 sarebbero in italiano (aulico) formale, 3 e 4 in italiano standard letterario, 5 e 6
in italiano neo-standard, 7 e 8 in italiano parlato colloquiale, 9 in italiano informale trascurato, 10 e 11
in italiano popolare […]. In realtà, il raggio di dispersione delle varietà è più ampio: lo standard,
globalmente inteso, può spaziare da 1 (massimo di formalità) a 8 (massimo di informalità, ma ancora
standard ‘allargato’), laddove 3 rappresenta forse lo standard non marcato; il parlato colloquiale può
ammettere, accanto alla forma più tipica che ne è forse 8, da (forse) 4 a 7 (se non anche 9), l’italiano
popolare spazia da 9 a 11 ecc.
Infine, se volessimo anche tentare un’assegnazione del continuum a parlanti (peraltro cosa assai
spinosa), potremmo dire che un parlante colto ben competente può svariare da 1 a 9 (anche se la
formulazione 9 andrà esclusa per non pochi parlanti colti), un parlante incolto svarierà fra 9 e 11, un
parlante medio svarierà fra 3 e 9 ecc.
Da questo esempio traspare molto bene sia la “concretezza” del continuum – a cui, nella
nostra normale attività di parlanti, facciamo caso poco o nulla –, sia la sua capacità di
“raccogliere” molte delle considerazioni già svolte a lezione.
Potrebbero piacerti anche
- Introduzione All'italiano ContemporaneoDocumento11 pagineIntroduzione All'italiano ContemporaneoEnzo Jesus Santilli100% (2)
- L'italiano ContemporaneoDocumento5 pagineL'italiano ContemporaneoLuca Balestrino100% (2)
- Linguistica: 100 Domande e RisposteDocumento31 pagineLinguistica: 100 Domande e Risposteannalisa marinoni100% (1)
- Elementi Di Linguistica ItalianaDocumento9 pagineElementi Di Linguistica ItalianaValeria KozakosNessuna valutazione finora
- Dialetto, Dialetti e Italiano.Documento7 pagineDialetto, Dialetti e Italiano.Fiorinda94Nessuna valutazione finora
- Linguistica - Risposte AperteDocumento60 pagineLinguistica - Risposte Aperteenrica100% (1)
- Garbini - Origine Dell'alfabeto PDFDocumento10 pagineGarbini - Origine Dell'alfabeto PDFGerardo LucchiniNessuna valutazione finora
- Dispensa Ii SemestreDocumento47 pagineDispensa Ii SemestreSerena SchiliròNessuna valutazione finora
- Ma Nu AleDocumento45 pagineMa Nu AlechiccalavedaNessuna valutazione finora
- Linguistica ItalianaDocumento76 pagineLinguistica Italiana469cwvnb5sNessuna valutazione finora
- Fanciullo CompletoDocumento33 pagineFanciullo CompletoNatalia PalmisanoNessuna valutazione finora
- 2013-2014 Ling - Gen.IDocumento24 pagine2013-2014 Ling - Gen.Io___oNessuna valutazione finora
- Varietà Dell'italianoDocumento41 pagineVarietà Dell'italianoAbramo Di FucciaNessuna valutazione finora
- Le Dimensioni Di Variazione Delle Lingue e Il Repertorio Dell'ItalianoDocumento24 pagineLe Dimensioni Di Variazione Delle Lingue e Il Repertorio Dell'ItalianoBrunaM.R.AflaloNessuna valutazione finora
- Elementi Di Linguistica ItalianaDocumento34 pagineElementi Di Linguistica ItalianaMockingbird YuZa Sakigami100% (2)
- Linguistica ItalianaDocumento108 pagineLinguistica ItalianaLeonardo G. StentaNessuna valutazione finora
- Onesti - DITALS - Profilo SociolinguisticoDocumento39 pagineOnesti - DITALS - Profilo SociolinguisticofloringabrielserbuNessuna valutazione finora
- Italiano e DialettiDocumento14 pagineItaliano e DialettiCurso de ItalianoNessuna valutazione finora
- GlottologiaDocumento57 pagineGlottologiaErica CotugnoNessuna valutazione finora
- 6 - L'italiano Usi Strutture e Varietà - Le Tante Varietà Di Cui Si Servono Gli ItalianiDocumento10 pagine6 - L'italiano Usi Strutture e Varietà - Le Tante Varietà Di Cui Si Servono Gli ItalianiFrancesca FerraioliNessuna valutazione finora
- LINGUISTICADocumento16 pagineLINGUISTICAVincenzo CarusoNessuna valutazione finora
- 15 58 1 PBDocumento23 pagine15 58 1 PBHamma HadrumèteNessuna valutazione finora
- Lo DucaDocumento47 pagineLo DucaAnonymous qv4o0lA3Nessuna valutazione finora
- Linguistica ItalianaDocumento38 pagineLinguistica ItalianaLorena SilvestriNessuna valutazione finora
- Linguistica Generale e GlottologiaDocumento88 pagineLinguistica Generale e Glottologiaguia.trifiroNessuna valutazione finora
- Giuliana Fiorentino Quale Italiano Parlano Le GrammaticheDocumento16 pagineGiuliana Fiorentino Quale Italiano Parlano Le GrammaticheMariana CruzNessuna valutazione finora
- Fonetica e Fonologia TeoriaDocumento17 pagineFonetica e Fonologia Teorialguerra73100% (1)
- Lingua 2Documento2 pagineLingua 2Robson AraujoNessuna valutazione finora
- Appunti Linguistica EsameDocumento4 pagineAppunti Linguistica EsameAleNessuna valutazione finora
- Domande Ling. GeneraleDocumento2 pagineDomande Ling. GeneraleSara Consiglio Lp100% (1)
- Glott. 2Documento3 pagineGlott. 2LucreziaManganelliNessuna valutazione finora
- GlottologiaDocumento15 pagineGlottologiaAnonymous JxbzuNzNYNessuna valutazione finora
- Mutamento MorfologicoDocumento7 pagineMutamento MorfologicoAlice.in.spaceNessuna valutazione finora
- L'italiano PDFDocumento61 pagineL'italiano PDFAuroraNessuna valutazione finora
- Introduzione SociolinguisticaDocumento22 pagineIntroduzione SociolinguisticaAnnachiara SibillanoNessuna valutazione finora
- Appunti GlottologiaDocumento13 pagineAppunti GlottologiaSabrina BongiovanniNessuna valutazione finora
- LINGUISTICA ITALIANA LibroDocumento31 pagineLINGUISTICA ITALIANA LibroSofia CarpentieriNessuna valutazione finora
- Riassunto LA LINGUA È UN'ORCHESTRA (M. Bricchi)Documento45 pagineRiassunto LA LINGUA È UN'ORCHESTRA (M. Bricchi)giancarlo SciortinoNessuna valutazione finora
- L'italiano NeostandardDocumento11 pagineL'italiano NeostandardCat 1714100% (1)
- RIASSUNTO "Dalle Parole Ai Dizionari"Documento115 pagineRIASSUNTO "Dalle Parole Ai Dizionari"Giorgia VecchiottiNessuna valutazione finora
- 978 88 6969 650 3 CH 02 - 7P6SHEHDocumento18 pagine978 88 6969 650 3 CH 02 - 7P6SHEHSindbad lombardiNessuna valutazione finora
- Paola Benincà - Istituzioni Di LinguisticaDocumento36 paginePaola Benincà - Istituzioni Di LinguisticaTiberiu TarabicNessuna valutazione finora
- Linguistica Generale e GlottologiaDocumento141 pagineLinguistica Generale e GlottologiaGiorgio FalcoNessuna valutazione finora
- Variabilita DiamesicaDocumento6 pagineVariabilita Diamesicadewjay41Nessuna valutazione finora
- Gramatiche FurlanfoneticheDocumento73 pagineGramatiche FurlanfoneticheKillgoreNessuna valutazione finora
- Capitolo 3 - Lingue VerbaliDocumento5 pagineCapitolo 3 - Lingue Verbalir5vdmyhy9nNessuna valutazione finora
- SOCIOLINGUISTICADocumento6 pagineSOCIOLINGUISTICAGeorge PoulopoulosNessuna valutazione finora
- Linguistica Italiana ManualeDocumento15 pagineLinguistica Italiana ManualeAmina MouminounNessuna valutazione finora
- Grammatica Storica FormentinDocumento16 pagineGrammatica Storica FormentinJulio JuanNessuna valutazione finora
- UntitledDocumento19 pagineUntitledAlice LonghiNessuna valutazione finora
- Bolognesi-IL SARDO TRA ISOLAMENTO E CONTATTO: UNA RIANALISI DI ALCUNI STEREOTIPI 1Documento47 pagineBolognesi-IL SARDO TRA ISOLAMENTO E CONTATTO: UNA RIANALISI DI ALCUNI STEREOTIPI 1Venerio Giuseppe AnarduNessuna valutazione finora
- Verbos Sintagmaticos en LombardoDocumento20 pagineVerbos Sintagmaticos en LombardoJared David Garcia SolanoNessuna valutazione finora
- La Scoperta Della Lingua Italiana-Italiano ContemporaneoDocumento37 pagineLa Scoperta Della Lingua Italiana-Italiano ContemporaneoAgnese BoriNessuna valutazione finora
- Linguistica Storica!Documento41 pagineLinguistica Storica!Kateryna TkachukNessuna valutazione finora
- La SociolinguisticaDocumento18 pagineLa SociolinguisticaInes mahdiNessuna valutazione finora
- Sociolinguistica Nozioni Da ConscereDocumento12 pagineSociolinguistica Nozioni Da ConscereelionanaqoNessuna valutazione finora
- Riassunto Libro SerianniDocumento23 pagineRiassunto Libro SerianniMarialuisa FinocchiaroNessuna valutazione finora
- Su Michele Loporcaro Gender From Latin TDocumento3 pagineSu Michele Loporcaro Gender From Latin TGabriel FaureNessuna valutazione finora
- Mordersi la lingua: Correttezza politica e post-veritàDa EverandMordersi la lingua: Correttezza politica e post-veritàNessuna valutazione finora
- Promessi SposiDocumento3 paginePromessi Sposidavis2aNessuna valutazione finora
- La Radiestesia e La Radionica - Doc Versione 1Documento5 pagineLa Radiestesia e La Radionica - Doc Versione 1polloNessuna valutazione finora
- Scopertadellaltro PDFDocumento65 pagineScopertadellaltro PDFzapremNessuna valutazione finora
- Bruniana & Campanelliana Vol. 12, No. 2, 2006 PDFDocumento308 pagineBruniana & Campanelliana Vol. 12, No. 2, 2006 PDFVetusta MaiestasNessuna valutazione finora
- Il Deutscher WerkbundDocumento2 pagineIl Deutscher WerkbundFederica2403Nessuna valutazione finora
- Gabriele Pedullà Su Niccolò Machiavelli e La Sua Teoria Militare - Il Manifesto 24.01.2013Documento1 paginaGabriele Pedullà Su Niccolò Machiavelli e La Sua Teoria Militare - Il Manifesto 24.01.2013glisfogliatiNessuna valutazione finora
- ALTA REZIA - Storia Dei RetiDocumento8 pagineALTA REZIA - Storia Dei RetiMax BergerNessuna valutazione finora
- Il Vernacoliere Maria TurchettoDocumento2 pagineIl Vernacoliere Maria Turchettomassimo69Nessuna valutazione finora
- Bernanos Soleil SatanDocumento45 pagineBernanos Soleil Satanirochese510% (1)
- 18 II TandaDocumento20 pagine18 II TandaeleshNessuna valutazione finora
- AccademiaItalianaDellaCucina 2011 01 Gennaio 223Documento81 pagineAccademiaItalianaDellaCucina 2011 01 Gennaio 223abd al-shakurNessuna valutazione finora
- ORIGAMIDocumento14 pagineORIGAMIMarta PetrellaNessuna valutazione finora
- Liburnia Settentrionale in Età RomanaDocumento233 pagineLiburnia Settentrionale in Età RomanaDavo Lo SchiavoNessuna valutazione finora
- Vendetta, PelecanosDocumento2 pagineVendetta, PelecanosPaolo PassarelloNessuna valutazione finora
- Rivoluzione Scientifica e Rivoluzione AstronomicaDocumento4 pagineRivoluzione Scientifica e Rivoluzione AstronomicaFederica D'AlelioNessuna valutazione finora