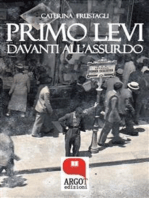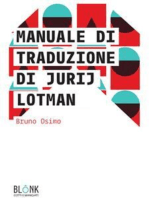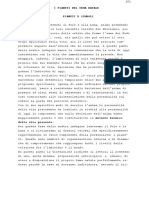Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
6 visualizzazioniPer Una Teoria Freudiana Della Letteratura
Per Una Teoria Freudiana Della Letteratura
Caricato da
Marta BaroneRiassunto
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato ODT, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Potrebbero piacerti anche
- Manuale Progettazione Su MisuraDocumento152 pagineManuale Progettazione Su Misuradino67% (3)
- Esperienze Nei Gruppi Bion PDFDocumento32 pagineEsperienze Nei Gruppi Bion PDFAndrea Cianetti100% (1)
- Due Secoli Di Pensiero LinguisticoDocumento54 pagineDue Secoli Di Pensiero LinguisticoFrancescaFaverioNessuna valutazione finora
- Giuseppe Cristofaro - Perchè Narrare Le FiabeDocumento25 pagineGiuseppe Cristofaro - Perchè Narrare Le Fiabestudente universitario100% (1)
- Terapia Della Gestalt IntegrataDocumento8 pagineTerapia Della Gestalt Integrataelenazlatkova100% (1)
- Cos e Un Testo LetterarioDocumento17 pagineCos e Un Testo LetterarioClau DecaNessuna valutazione finora
- Dispensa Su ProppDocumento10 pagineDispensa Su ProppsilvialucaaNessuna valutazione finora
- Linguaggio - e - Pensiero L'Ipotesi Di Sapir-WhorfDocumento46 pagineLinguaggio - e - Pensiero L'Ipotesi Di Sapir-WhorfGermana83% (6)
- Filosofia Del LinguaggioDocumento34 pagineFilosofia Del LinguaggioVincenzo GrassoNessuna valutazione finora
- Che Cos e Un Testo Letterario Di Chines e Varotti (Salvataggio Automatico)Documento17 pagineChe Cos e Un Testo Letterario Di Chines e Varotti (Salvataggio Automatico)Andrea PanzaNessuna valutazione finora
- FRENI, La Questione Del MitoDocumento22 pagineFRENI, La Questione Del MitoHen PantaNessuna valutazione finora
- Faschilli Filosofia Del Linguaggio CorrettoDocumento6 pagineFaschilli Filosofia Del Linguaggio CorrettoJorge Luis ZarazuaNessuna valutazione finora
- Zavatta Scienza Linguaggio Humboldt PDFDocumento31 pagineZavatta Scienza Linguaggio Humboldt PDFcapitankonigNessuna valutazione finora
- Filosofia Della Comunicazione e Del Linguaggio L 2Documento42 pagineFilosofia Della Comunicazione e Del Linguaggio L 2Eleonora ZitoNessuna valutazione finora
- Filosofia della mente: Spunti di riflessione sul processo traduttivoDa EverandFilosofia della mente: Spunti di riflessione sul processo traduttivoNessuna valutazione finora
- Sentimento e Forma Nella Teoria Del Simbolo Di Susanne K. LangerDocumento27 pagineSentimento e Forma Nella Teoria Del Simbolo Di Susanne K. LangernadjamoNessuna valutazione finora
- Riassunto Del Riassunto OraliraDocumento9 pagineRiassunto Del Riassunto Oraliraantoniotorrett2Nessuna valutazione finora
- Antoniel - 2012 - Il Concetto Di Metafora in Black, Ricoeur e BlumenbergDocumento55 pagineAntoniel - 2012 - Il Concetto Di Metafora in Black, Ricoeur e BlumenbergceprunNessuna valutazione finora
- Storia Della Critica LetterarDocumento25 pagineStoria Della Critica LetterarCarola FiorindoNessuna valutazione finora
- Northrop Frye e Michail BachtinDocumento14 pagineNorthrop Frye e Michail BachtinFabio SantosNessuna valutazione finora
- Il Potere Del Linguaggio PDFDocumento19 pagineIl Potere Del Linguaggio PDFCarla NatoliNessuna valutazione finora
- L'Immagine e La ParolaDocumento8 pagineL'Immagine e La ParolaShelley MarcuccioNessuna valutazione finora
- Primo Levi davanti all’assurdo. Dire l’indicibile: Il linguaggio della ShoahDa EverandPrimo Levi davanti all’assurdo. Dire l’indicibile: Il linguaggio della ShoahNessuna valutazione finora
- Lett. Comparate 2Documento7 pagineLett. Comparate 2domenicor941Nessuna valutazione finora
- BertoniDocumento5 pagineBertonidomenicor941Nessuna valutazione finora
- TesiElenaMascioliMasterEcampus24Giu PDFDocumento28 pagineTesiElenaMascioliMasterEcampus24Giu PDFElenaNessuna valutazione finora
- Ipotesi Di Sapir WhorfDocumento3 pagineIpotesi Di Sapir WhorfEnrica LibertiNessuna valutazione finora
- Sarah Kofman, Nietzsche MetaforaDocumento24 pagineSarah Kofman, Nietzsche MetaforaMachucaNessuna valutazione finora
- Rosenzweig - Cristina GuarnieriDocumento10 pagineRosenzweig - Cristina GuarnieriMarino Rama100% (1)
- Bernardelli e GrilloDocumento9 pagineBernardelli e Grillog.levatino8Nessuna valutazione finora
- Filologia Italiana MagistraleDocumento95 pagineFilologia Italiana MagistraleLucia CapognaNessuna valutazione finora
- Senso e DenotazioneDocumento1 paginaSenso e DenotazionetheourgikonNessuna valutazione finora
- Metafora e PsicoterapiaDocumento13 pagineMetafora e PsicoterapiaCrescita PersonaleNessuna valutazione finora
- Metafora Cognitiva Articolo Fil Analitica PDFDocumento32 pagineMetafora Cognitiva Articolo Fil Analitica PDFCarla NatoliNessuna valutazione finora
- 4.1 Ludwig Wittgenstein e Il Tractatus Logico Philosophicus.Documento8 pagine4.1 Ludwig Wittgenstein e Il Tractatus Logico Philosophicus.Andrea VolonninoNessuna valutazione finora
- I Saperi Del Tradurre - Capitolo IDocumento7 pagineI Saperi Del Tradurre - Capitolo ISara LeoneNessuna valutazione finora
- FedraDocumento6 pagineFedrarottenapple30% (1)
- Patologie Del Linguaggio e Della ComunicazioneDocumento29 paginePatologie Del Linguaggio e Della ComunicazioneFrancesco MerraNessuna valutazione finora
- La poetica della mente: Pensiero, linguaggio e comprensione figuratiDa EverandLa poetica della mente: Pensiero, linguaggio e comprensione figuratiNessuna valutazione finora
- Basso - Fenomenologia, Semiotica Ed Estetica PDFDocumento12 pagineBasso - Fenomenologia, Semiotica Ed Estetica PDFMichelle CabralNessuna valutazione finora
- Mounin, Teoria e Storia Della Traduzione - Part III - PDFDocumento6 pagineMounin, Teoria e Storia Della Traduzione - Part III - PDFmripari5280Nessuna valutazione finora
- Tractatus Logico-Philosophicus - WikipediaDocumento4 pagineTractatus Logico-Philosophicus - WikipediafabromNessuna valutazione finora
- Convegno Linguistica Relazione Di Vida-1Documento17 pagineConvegno Linguistica Relazione Di Vida-1Vida RusNessuna valutazione finora
- Che Cosa È La Letteratura Comparata - SteinerDocumento11 pagineChe Cosa È La Letteratura Comparata - SteinereosNessuna valutazione finora
- Dispense Su BarthesDocumento22 pagineDispense Su BarthesmicantenNessuna valutazione finora
- Heidegger e Lacan Ascolto Del LinguaggioDocumento5 pagineHeidegger e Lacan Ascolto Del LinguaggioMyriam PanicoNessuna valutazione finora
- Letteratura - IntroduzioneDocumento4 pagineLetteratura - IntroduzionesimoroncoNessuna valutazione finora
- Teoria Della TraduzioneDocumento11 pagineTeoria Della TraduzionemarcoNessuna valutazione finora
- Definizione Di SemanticaDocumento5 pagineDefinizione Di SemanticaalessiaNessuna valutazione finora
- Mineto Teoria Del Significato in HusserlDocumento16 pagineMineto Teoria Del Significato in HusserlCarla NatoliNessuna valutazione finora
- Nomen, OmenDocumento39 pagineNomen, OmennicosuarezNessuna valutazione finora
- Prima UnitàDocumento8 paginePrima UnitàLucia caponeNessuna valutazione finora
- 1 LetteraturaDocumento8 pagine1 LetteraturamarcociliegiaaNessuna valutazione finora
- Filologia RomanzaDocumento126 pagineFilologia Romanzag.lambertiniNessuna valutazione finora
- Manifesto Dellintersezionismo Speculare 4a Ediz.Documento177 pagineManifesto Dellintersezionismo Speculare 4a Ediz.PinoVentriglioNessuna valutazione finora
- P. Fabbri - La Prossemica A Lungo CorsoDocumento4 pagineP. Fabbri - La Prossemica A Lungo CorsoOoNessuna valutazione finora
- SociolinguisticaDocumento7 pagineSociolinguisticauomodibronzoNessuna valutazione finora
- La Molteplicta' Semantica Nel Linguaggio Dei Mistici Di Vida RusDocumento21 pagineLa Molteplicta' Semantica Nel Linguaggio Dei Mistici Di Vida RusVida RusNessuna valutazione finora
- Filologia RomanzaDocumento53 pagineFilologia RomanzaAnnamaria DuranteNessuna valutazione finora
- Modulo Linguistica Del TestoDocumento81 pagineModulo Linguistica Del Testoalda totaNessuna valutazione finora
- Karl Otto Apel Il Problema Del Linguaggio in Wittgenstein e HeideggerDocumento14 pagineKarl Otto Apel Il Problema Del Linguaggio in Wittgenstein e HeideggerraimpoNessuna valutazione finora
- Dalla Danza Al Teatro Della MascheraDocumento4 pagineDalla Danza Al Teatro Della MascheraGerard Fisa Biscarri100% (1)
- Il Nuovo NordestDocumento286 pagineIl Nuovo NordestanordestNessuna valutazione finora
- Erich Fromm - Il Bisogno Di Credere PDFDocumento96 pagineErich Fromm - Il Bisogno Di Credere PDFalfredo89100% (1)
- Personaggi Delle Fiabe e Archetipi JunghianiDocumento7 paginePersonaggi Delle Fiabe e Archetipi JunghianiquetzhalNessuna valutazione finora
- 178 40 PBDocumento469 pagine178 40 PBAlfonso FalconeNessuna valutazione finora
- Deleuze, Gilles - Anti Edipo E Mille Piani (16.11.1971)Documento12 pagineDeleuze, Gilles - Anti Edipo E Mille Piani (16.11.1971)criszam8Nessuna valutazione finora
- Creatività, Schizofrenia Ed Immagini in Blu - Di Giuseppe Costantino BudettaDocumento17 pagineCreatività, Schizofrenia Ed Immagini in Blu - Di Giuseppe Costantino BudettaNeuroscienze.net100% (1)
- Risoluzione Della Disapprovazione Parentale e Delle Dinamiche Di RelazioneDocumento27 pagineRisoluzione Della Disapprovazione Parentale e Delle Dinamiche Di RelazioneRoberto GiulianiNessuna valutazione finora
- 01 L'improvvisaz Nel JazzDocumento23 pagine01 L'improvvisaz Nel JazzFausto FerraiuoloNessuna valutazione finora
- Art Tec La Gestalt AnaliticaDocumento14 pagineArt Tec La Gestalt AnaliticaLuca La PortaNessuna valutazione finora
- Educare o IstruireDocumento17 pagineEducare o IstruireCinzcakeNessuna valutazione finora
- File Unico Diritti UmaniDocumento58 pagineFile Unico Diritti UmaniSilvia FontanaNessuna valutazione finora
- Psicologia Dei Gruppi - Domande ChiuseDocumento41 paginePsicologia Dei Gruppi - Domande ChiuseDario Brizi100% (1)
- Parte Seconda Cap.5 I PIANETI Nel Tema NataleDocumento19 pagineParte Seconda Cap.5 I PIANETI Nel Tema Natalemcc43Nessuna valutazione finora
- Tecniche Di Manipolazione MentaleDocumento9 pagineTecniche Di Manipolazione MentaleLisa SalviniNessuna valutazione finora
- ESERCIZI SPIRITUALI, Piccolo Manuale Di Auto-Aiuto (Guida Pratica Per IMPARARE Ad Imparare A Prendersi Cura Di Sé)Documento99 pagineESERCIZI SPIRITUALI, Piccolo Manuale Di Auto-Aiuto (Guida Pratica Per IMPARARE Ad Imparare A Prendersi Cura Di Sé)Zewale Il Pro-VocatoReNessuna valutazione finora
- Il SognoDocumento26 pagineIl SognomeriwenxiNessuna valutazione finora
Per Una Teoria Freudiana Della Letteratura
Per Una Teoria Freudiana Della Letteratura
Caricato da
Marta Barone0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
6 visualizzazioni5 pagineRiassunto
Titolo originale
Per una teoria freudiana della letteratura
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
ODT, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoRiassunto
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato ODT, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Scarica in formato odt, pdf o txt
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
6 visualizzazioni5 paginePer Una Teoria Freudiana Della Letteratura
Per Una Teoria Freudiana Della Letteratura
Caricato da
Marta BaroneRiassunto
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato ODT, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Scarica in formato odt, pdf o txt
Sei sulla pagina 1di 5
Per una teoria freudiana della letteratura
1) Delimitazioni di un campo e direzioni di un metodo
Dalla Lettura Freudiana della Phèdre lo studioso di letteratura deve ricorrere a Freud per ricavare non
una corretta psicologia dell’autore o dei personaggi, quanto invece modelli relativi alla coerenza del
linguaggio che è legato a sua volta al linguaggio dell’inconscio umano. Delle manifestazioni di questo da
parte del filosofo e cioè lapsus, sogno, sintomo nevrotico, motti di spirito, le prime tre sono forme del
linguaggio non comunicante, l’ultima invece implica comunicazione cosciente e volontaria.
L’opposizione tra il linguaggio comunicante e non trova la sua corrispondenza nelle opere di Freud
anche se non tutte hanno valenza nell’analisi dei rapporti inconscio-letteratura. Il libro sui motti di spirito
è valido in tale indagine per la questione del ritorno del represso ovvero la manifestazione linguistica
dell’inconscio come atto di comunicazione. Nonostante tutto la psicoanalisi freudiana non ha cessato di
essere un riferimento per la letteratura nella cultura di lingua francese nell’ultimo quindicennio. E’
importante considerare che gli studi teorici sulla letteratura hanno visto diversi metodi avvicendarsi sul
versante analitico; oggi è inevitabile che la questione di cosa la letteratura studia precede il modo, cioè
come, la letteratura viene studiate e analizzata. Roman Jakobson ha stabilito il sistema di fattori necessari
alla comunicazione linguistica dando maggior importanza alla funzione poetica. Con Jakobson
distinguiamo un MESSAGGIO verbale che sarà il componimento, un DESTINATORE che mette il
messaggio e può essere un amico come l’autore, un DESTINATARIO cioè colui che riceve il messaggio
e lo ascolta, un CONTESTO di realtà di riferimento (ciò di cui un testo parla), un CODICE linguistico,
un CONTATTO di natura fisica attraverso cui lo si trasmette come ad esempio la voce dell’autore e le
orecchie di coloro che ascoltano. Il tutto se consideriamo questo come lo scheda di un atto di
comunicazione consueto e ripetibile. Se invece si presuppone un’istituzione sociale durevole nel tempo
cambiano i fattori tutti all’infuori del MESSAGGIO. Le connessioni effettive di questi 6 campi di studio
tra fattori distinti di un fenomeno da analizzare risulta vantaggioso quanto il confondere fattori risulta
dannoso. Ritornando a Freud la psicoanalisi che nasce come rivoluzione della psicologia, doveva
rinnovare un settore di studi della letteratura rimasto per molto tempo limitato e cioè quello biografico.
Freud voleva solo formulare delle osservazioni psicologiche e biografiche e non di certo superare i limiti
di campo per sfociare dopo in scoperte relative all’arte. Le numerose incursioni di Freud nel campo
estetico dell’arte trovano la loro sede nel linguaggio, che seppur sia alla base dell’analisi del lapsus, del
sintomo, del sogno, ha bisogno di una sua cassa di risonanza che non può che essere la storia individuale
di un uomo. Se pensiamo al sintomo nevrotico la teoria psicoanalitica deve trovare a questo messaggio
un destinatore/destinatario che è il paziente mediante la mediazione di un altro destinatario che è lo
psicoanalista. Ma un messaggio che ha un suo destinatario deve essere almeno in parte autosufficiente e
sappiamo come le manifestazioni linguistiche dell’inconscio non lo siano. Lo stesso messaggio letterario
non può essere valutato come indipendente poiché la sua perfetta comprensione è sempre relativizzata al
contesto della fruizione da parte del destinatario, alle circostanze di realtà che hanno visto la sua
formulazione e anche al contesto storico da cui non è avulso. Di per sé, però, un messaggio è
comprensibile anche senza una conoscenza approfondita delle circostanze di realtà intorno alle quali
ruota. Se questo dovesse essere obbligatoriamente ricondotto alla biografia o psicologia del suo
destinatore allora questo non sarebbe certamente un messaggio letterario. Altra valenza assume il metodo
che fu introdotto da Charles Mauron e che prende il nome di psicocritica. Questo si fonda sulla
sovrapposizione tra passi diversi di opere di uno stesso autore. L’obiettivo ultimo è quello di individuare
delle costanti che si ricavano da più passi piuttosto che giungere ad un’interpretazione totale
dell’opera/e. Per cui il metodo può andare in due direzioni opposte: dal DESTINATORE al
MESSAGGIO o dal MESSAGGIO al DESTINATORE. La presenza di Freud oggi nella cultura francese
passa soprattutto attraverso il pensiero di Jacques Lacan, il vero e proprio motore che alimenta il
collegamento tra linguaggio dell’inconscio e linguaggio letterario. Secondo Lacan ogni informazione
dell’inconscio ha struttura di linguaggio che risponde a leggi proprie, anche se il soggetto del messaggio
non sempre ha la chiave per decifrarlo rimanendo così da decodificare.
2) Verso una definizione di ritorno del represso in letteratura
Dopo aver delineato nella pars destruens del discorso i punti in cui i due linguaggi differiscono, sarà ben
più complesso riuscire a elaborare un percorso di analisi costruttiva dei punti di contatto tra il linguaggio
dell’inconscio e quello della letteratura. A tal proposito ci vengono in soccorso tre scienze diverse di cui
la più esatta inevitabilmente risulta essere la linguistica e per di più nel suo ramo meno progredito e cioè
la semantica. Dal testo della Phèdre si estrapola una frase in cui ci si riferisce all’espressione “ritorno del
represso”, Di precisa provenienza freudiana fu usata dapprima per indicare la proibizione dell’incesto e
la repressione degli istinti sessuali. In un momento precedente si parlava anche di “ritorno del rimosso”.
Tale sostituzione terminologica è motivata dalla volontà di voler includere nella sfera del suo significato
anche contenuti di natura sociale e politica oltre che inconscia. Anche se in quel dato capitolo del testo
della Phèdre non è presente alcun riferimento alla rimozione relativa al testo letterario e quindi non solo
al contenuto inconscio, è possibile formularla in modo diverso: la letteratura o la poesia sono sede di un
ritorno del represso socialmente istituzionalizzato. Per cui l’espressione “ritorno del represso” assume di
fatto tre diverse accezioni: 1) ritorno del represso come presenza di qualità formali rivolte al linguaggio
dell’inconscio; 2) ritorno del represso come presenza di contenuti censurati dal punto di vista sociale
perché attinenti al campo del sesso; 3) ritorno del represso come presenza di contenuti censurati dalla
repressione politica e ideologica. In relazione alla tragedia di Racine le tre accezioni di “ritorno del
represso” sono inserite in maniera svariata anche se relativamente al desiderio perverso della moglie di
Teseo, sono le prime due accezioni, che tra l’altro combaciano nella Phèdre, ad essere pertinenti a tale
testo, diversamente dalla terza accezione che sfiora solo marginalmente il contenuto dell’opera. L’analisi
proposta da Francesco Orlando sulla Phèdre è un’analisi di tipo semantico che mira la sua attenzione
sulla diramazione dei significati e non sulle strutture sintattiche e fonetiche del testo. Questo ci permette
di soffermarci su un punto di contatto tra il linguaggio dell’inconscio e quello letterario rappresentato dal
“predominio della lettera” o “preponderanza del significante verbale”. Nell’analisi di Freud l’inconscio
si permette qualsiasi mescolanza di significati se i significanti offrono una quasi coincidenza
approssimativa. Lacan ha insistito sul punto per cui l’inconscio tratta i significati come cose e prende
tutto alla lettera mettendo in crisi lo stesso sistema della significazione. I segni verbali a cui nel testo
della Phèdre si fa riferimento sono monstre e cacher. Per monstre la cosa non pare solo certa ma evidente
perché Racine qui gioca sullo slittamento tra il senso morale e quello fisico letterale del termine. I mostri
mitici e la mostruosità del desiderio perverso di Fedra. Per cui un solo significante genera due diversi
significati. L’altro è il caso del verbo cacher che unisce la prostrazione di Fedra e la scomparsa di Teseo.
Ci accorgiamo che la preponderanza del significante sul significato può assumere due diversi aspetti:
prevaricazione sui significati e slittamento di significati diversi o la loro mescolanza e la valorizzazione
del suo corpo sonoro.
3) La lezione di Freud e il ritorno del represso formale
L’uso dei termini generici di “forma” e “contenuto” si rivela insufficiente ai fini del discorso intrapreso.
Infatti è limitato parlare del contenuto sulla sola faccia dei significati e della forma sulla faccia dei
significanti. Piuttosto che contrapporli è più utile collegarli e parlare di “forma del contenuto”. Come
conseguenza si volge lo sguardo al testo di Louis Hjemslev dove, in riferimento a tale espressione,
l’autore chiama la faccia dei significanti piano dell’espressione e la faccia dei significati. Su entrambi si
pone una materia priva di esistenza linguistica e distinta in materia dell’espressione in relazione al
contesto fonetico e materia del contenuto in relazione al contesto reale. Distinguere la forma del
contenuto dalla forma dell’espressione e la combinazione linguistica con le due sostanze in riferimento
alla teoria di Hjemslev è utile per un discorso letterario. Orlando per questo afferma che la sua analisi
della Phèdre è stata incentrata non sulla forma o sul contenuto bensì sulla forma del contenuto. Se
tentiamo di parlare di “materia del contenuto” che, secondo la teoria di Hjemslev è prima di valore
linguistico per cui è impossibile parlare di essa, possiamo notare con un esempio che se ne può parlare
solo in quanto è diventata sostanza di una forma che la genera. L’espressione francese je ne sais pa e le
parole inglese I don’t know nonostante siano diverse hanno un punto in comune e cioè la materia, il
senso e il pensiero. Per individuare una stessa materia del contenuto non è necessario riferirsi a
espressioni di lingue diverse, ma anche a quelle di una medesima lingua come, ad esempio, l’italiano con
le espressioni non lo so e lo ignoro. Ora dalla crisi della società borghese in atto dal pieno Ottocento,
numerosi artisti, critici, linguisti, filosofi, hanno osservato la reale distinzione tra la potenziale “materia
del contenuto” e la sostanza stessa. Freudianamente parlando la “materia del contenuto” è ogni ritorno
del represso inerente alla repressione sociale sul sesso. Dove prima si parlava genericamente di
contenuto ora è opportuno parlare di materia del contenuto. Tale precisazione terminologica trova la sua
perfetta esemplificazione nel testo di Freud sui motti di spirito. Freud si sofferma subito sulla questione:
cosa rende un motto di spirito tale. Adotta il procedimento della “riduzione” cioè prova ad esprimere la
stessa cosa con parole diverse. Rileva quindi che il carattere del motto di spirito va perduto perché esso è
legato alla forma e alla lettera della sua espressione; questo almeno per i motti di spirito con valore
verbale. Per quelli a cui si associa un corso di pensieri invece conclude che alterazioni verbali sono
immaginabili anche senza che il motto di spirito si dilegui almeno de iure ma non de facto. Freud chiama
quindi queste tecniche del motto di spirito che dipendono quindi dalla “forma del contenuto” e dalla
“forma dell’espressione”. La riduzione annienta completamente i motti di spirito conservandone solo il
loro significato generale. Ad esempio il termine “familionarmente” può essere ridotto in familiarmente ci
può riuscire un milionario, o ancora una frase più astratta ancora. In tutti e tre i casi avremo nel primo
caso un motto di spirito ma sostanze del contenuto e forme del contenuto totalmente diverse, un po’
come per je ne sais pas, I don’t know, non lo so, lo ignoro: materia concettuale in comune, estensione
diversa. Il procedimento della riduzione che permette di astrarre una “materia del contenuto” è alla base
di una distinzione fatta da Freud tra motti di spirito privi di contenuto valido e motti di spirito dotati di
contenuto valido. Tale distinzione è tra un caso di autosufficienza della forma e un caso di compresenza
di forma con un valore esterno attribuito alla “materia del contenuto”. Un’altra importante distinzione è
tra motti di spirito innocui e motti di spirito tendenziosi. Sulla prima distinzione sarebbe difficile già
stabilire quali testi letterari debbano essere studiati come motti di spirito. Una distinzione quindi inutile
perché permane l’indecisione sui confini della letteratura. Sulla distinzione tra innocui e tendenziosi
Freud ci fornisce nuove informazioni tra ciò che si pone come “materia del contenuto” e ciò che si
articola al livello della “forma del contenuto” e “forma dell’espressione”. La tendenza è una particolare
forma della “materia del contenuto”, il ritorno del represso a tale livello. Le tendenze possibili del motto
di spirito sono suddivise in oscene e ostili. Freud dimostra che il motto di spirito tendenzioso aggredisce
principalmente personaggi che rivestono ruoli autoritari; motivo per cui la critica è rivolta in maniera
velata all’autorità stessa così come alcuni sono aggressivi per falso obiettivo come quando si tende ad
attaccare qualcuno perché beneficia di uno stato di cose sociali che si vogliono biasimare. Alcuni attacchi
sono rivolti a personaggi portatori di valori la cui obiezione è sollevata attraverso il mezzo del motto di
spirito. Sorge a tal proposito il motto di spirito cinico così come quelli scettici che Freud individua nella
categoria di quelli che mettono in discussione le condizioni di verità o di conoscenza. E’ sulla categoria
dei motti di spirito osceni e ostili che è possibile stabilire una corrispondenza con le due definizioni di
“ritorno del represso” a cui abbiamo in precedenza fatto riferimento 2) ritorno del represso come
presenza di contenuti censurati dal punto di vista sociale perché attinenti al campo del sesso; 3) ritorno
del represso come presenza di contenuti censurati dalla repressione politica e ideologica. (Segue esempio
dell’uomo che si fa prestare dei soldi per mangiare salmone con maionese). Le descrizioni dell’apparato
psichico fatte da Freud presuppongono l’interiorizzazione nell’individuo della repressione che lo
trascende e sempre a livello sociale (censura, Super-Io). Da questo sembra che si riflettano i tre capisaldi
su cui si fonda il pensiero di Freud: 1) la conoscibilità dell’inconscio attraverso le sue manifestazioni
come linguaggio e altre caratteristiche; 2) la primarietà latente del sesso o meglio della distinzione del
“principio del piacere” e del “principio di realtà”; 3) la concezione della civiltà come evoluzione della
dialettica tra repressione e represso. Orlando conclude dicendo che un linguaggio comunicante ma
tributario dell’inconscio può essere tendenzioso nella sua forma. Attraverso la “tecnica” trovano
espressione quelle modalità di linguaggio e di pensiero che sono presenti nell’adulto soltanto
inconsciamente e posso emergere quando sono realmente negate. Il motto di spirito quindi va alla ricerca
di uno stesso piacere che è quello stesso ricercato dalla poesia dove figure retoriche come la metafora,
l’allitterazione, la rima, il ritornello hanno lo scopo di dare ragione all’attesa infantile.
4) La letteratura fra eccesso e difetto di retorica
Si dovrebbe iniziare a parlare di una retorica del linguaggio dell’inconscio così come si è da molto tempo
ormai parlato anche di retorica del linguaggio letterario. Tornando al discorso delle somiglianze tra i due
tipi di linguaggio dovremo dire che il motto di spirito sta dalla stessa parte della letteratura a differenza
del linguaggio del sogno, del lapsus, del sintomo nevrotico che restano nella categoria dei linguaggi non
comunicanti. La prima retorica avrà quindi l’obiettivo di comunicare, la seconda no. Prendendo il caso
del linguaggio del sogno diciamo significanti quelli che formano il “contenuto manifesto”, significati
quelli che formano il “contenuto latente”. Di questi i primi non hanno mai una corrispondenza
trasparente, priva di alterazioni, con i secondi. Se un significante soppianta un altro allora vuol dire che
c’è qualcosa di espresso e qualcosa di nascosto, motivo per cui per Freud fra “lavoro del motto di
spirito” e “lavoro del sogno” i procedimenti comuni sono: condensazione, spostamento, non senso,
rappresentazione indiretta. Un linguaggio caratterizzato da figure cioè da alterazione del rapporto tra
significante e significato deve necessariamente permettere la riduzione delle figure da parte del
destinatario altrimenti viene meno la stessa comunicabilità e per di più solo raramente la capacità del
destinatario di ridurre la figuralità di un’espressione coincide con la sostituzione di una formulazione più
esplicita. Orlando afferma quindi che se nei linguaggi non comunicanti il tasso di figuralità non può
scendere al di sotto di un livello minimo entro cui si instaurerebbe una comunicazione, nei linguaggi
comunicanti invece il superamento di tale soglia limite precluderebbe la comprensione della stessa
comunicazione verbale. Per dirla con Lacan, parlare di una retorica di tipo opaco equivale a parlare di un
linguaggio che si copre di figure che hanno una maggior somiglianza con i linguaggi dell’inconscio. In
un linguaggio letterario non deve essere tutto figura pena la stessa limpida comprensione del messaggio
da parte del destinatario. Riferendoci a testi il cui tasso di figuralità risulta essere molto elevato
(oscurantismo linguistico), si giunge ad un livello di intesa sommaria tra una letteratura di tipo lirico-
ermetico e un linguaggio che scivola nei meandri della psiche più oscura e dipendente dal meccanismo
della rimozione. Un tempo la retorica circoscriveva messaggi dal significato latente in determinate
porzioni di testo. La retorica moderna invece dispone di figure retoriche, figure di significato, figure di
suono, figure del racconto, figure del destinatore e del destinatario; in certi spazi tali figure occupano un
paio di righe ma esistono testi totalmente sottoposti alle convenzionalità retoriche. In questo ambito è
spontaneo stabilire un limite oscillante attraverso il cui superamento possiamo parlare di “non
letteratura” o in caso contrario di “letteratura”. Orlando si rifiuta di definire la letteratura su base
qualitativa poiché ritiene che l’unico criterio pertinente sia il tasso di figuralità e non ad esempio la
destinazione di un testo altrimenti nessuno potrebbe parlare di testo di natura politica, storica, filosofica,
morale o giornalistica. Così come ogni giudizio di valore estetico deve essere slegato da una valutazione
scientifica di un testo letterario altrimenti le nostre valutazioni sarebbero solo soggettive (il bello e il
brutto) e non di certo imparziali. Per cui diventa spontaneo e dipendente dalla condizione di
comprensibilità definire la letteratura qualsiasi linguaggio verbale dell’io cosciente, scritto od orale, che
renda in misura elevata all’inconscio la figura. È naturale anche parlare con maggior certezza di
linguaggio dell’inconscio quando la densità figurale è la massima possibile. La funzione della figura in
un testo letterario è quella di elargire piacere al destinatario, avvincerlo e sedurlo. Questo piacere si
annida nelle parole, nei suoi significanti verbali e nelle diverse interpretazioni di significato. Difatti
quando un motto di spirito ci suscita il riso non sappiamo distinguere quanta parte della sua
soddisfazione sia dovuta all’espressione spiritosa e quanta al “pensiero” dell’io cosciente che essa
traveste. Distinguendo “materie del contenuto” prive o dotate di valore, bisognerebbe soffermarsi
principalmente sullo stesso senso attribuito al termine “valore”. Urge ammettere che qualunque figura o
compagine figurale sia presente nel testo deve permettere al destinatario la possibilità di ridurre il testo o
di sostituirvi tutto ciò che non ha niente a che fare con la figuralità. Avremo quindi due giudizi di valore:
il primo in quanto discorso dell’io cosciente sulla letteratura, il secondo in quanto tributario
dell’inconscio.
5) Il ritorno del represso nella serie dei contenuti
I contenuti censurati dalla repressione sociale che grava sul sesso e dalla repressione ideologico-politica
apparvero corrispondenti alle tendenze ostili-oscene di Freud. L’esempio a cui ci siamo rivolti, lo studio
del testo tragico di Racine della Phèdre servirà proprio a indicare la corretta argomentazione del
discorso. Se si racconta per sommi capi la trama dell’opera, mantenendoci su un livello di astrazione
della “materia del contenuto”, la repressione sociale contro cui pecca il desiderio perverso di Fedra sarà
associato ad una forma di repressione ideologica. L’azione sarà ambientata in una società in cui
l’adulterio, l’incesto, la passione sfrenata sono apertamente vietate e condannate. Allora poniamo la
domanda se il ritorno del represso, caratterizzato dall’istinto perverso di Fedra, è di tipo ideologico?
Pensando alle scene del testo tragico vediamo come interiormente Fedra viva quest’istinto sicuramente
come illecito e per di più viene accolto solo con una resistenza estrema. Orlando in tale sezione si
sofferma precipuamente sul rapporto tra represso e repressione nella “sostanza del contenuto” di
un’opera letteraria che si configura diversamente dalla funzione-destinatario a seconda che il “ritorno del
represso” voglia significare: A) inconscio, B) conscio non accettato, C) accettato ma non propugnato, D)
propugnato ma non autorizzato, E) autorizzato. Ogni negazione di un termine che si presenta ad una data
altezza è la negazione stessa di tutti i termini che si trovano ad altezze inferiori di quella da cui siamo
partiti; lo stesso vale per la situazione opposta. Si passa da un livello massimo (inconscio) ad un livello
minimo (autorizzato) Finché il represso è confinato nell’inconscio, la contraddizione è tra inconscio e
conscio (A); una volta che viene penetrata la coscienza, è all’interno di essa (B); conquistato l’individuo
è tra questo e la società (C); coinvolta quest’ultima è fra minoranza politica e ordine costituito (D);
trovato posto nell’ordine costituito, è tra più codici di intrattenimento (E). (esempi di Emma Bovary,
Rolando di Roncisvalle e altri esempi delle situazioni B, C, D, E). Il ritorno del represso può dunque
essere come nella Phèdre, conscio ma non accettato, in una lotta tra repressione e represso. Nel caso in
cui sia la repressione a prevalere, il ritorno del represso potrà essere solo inconscio. Il letto del
Misanthrope di Molière tanto più sarà invitato a ridere, tanto meno prenderà coscienza di ciò che è stato
represso; per Orlando la coscienza ha la stessa funzione della negazione, meno sarà portato a ridere,
tanto più il represso diventerà conscio. Come altro esempio anche la mania di Arpagone dell’Avaro di
Molière è troppo degradante per essere accettata per cui è respinta nell’inconscio dell’io cosciente. Per
questi rapporti funzione-destinatario e funzione-destinatore si possono considerare anche le poetiche
delle varie epoche letterarie. Nel Romanticismo, nei movimenti letterari che vanno alla ricerca dell’arte
per l’arte, nella letteratura post-illuministica si ha un ritorno del represso conscio ma non accettato.; i
drammi spagnoli manifestano invece un represso autorizzato dal solo codice cavalleresco. Infine la
letteratura solo in un determinato caso smette di “ascoltare” l’inconscio e cioè quando si occupa della
realtà. Orlando fa appello quindi a non trascurare mai il desiderio di piacere che appartiene ad ogni uomo
e del quale la letteratura può portare un’”illuminazione di verità” e reagisce ad una realtà che a volte può
sembrare soffocante. Tornando quindi all’inizio di questo saggio sulla teoria della letteratura, dietro il
linguaggio, sia esso espressione della parola o del suono o del corpo, c’è il tentativo da parte dell’uomo
di esprimere ciò che nel fondo di un tempo rimane inesprimibile. L’autore lo definisce “il desiderio del
piacere” che appartiene a tutti ed è impossibile da ridurre o ancora da reprimere.
Potrebbero piacerti anche
- Manuale Progettazione Su MisuraDocumento152 pagineManuale Progettazione Su Misuradino67% (3)
- Esperienze Nei Gruppi Bion PDFDocumento32 pagineEsperienze Nei Gruppi Bion PDFAndrea Cianetti100% (1)
- Due Secoli Di Pensiero LinguisticoDocumento54 pagineDue Secoli Di Pensiero LinguisticoFrancescaFaverioNessuna valutazione finora
- Giuseppe Cristofaro - Perchè Narrare Le FiabeDocumento25 pagineGiuseppe Cristofaro - Perchè Narrare Le Fiabestudente universitario100% (1)
- Terapia Della Gestalt IntegrataDocumento8 pagineTerapia Della Gestalt Integrataelenazlatkova100% (1)
- Cos e Un Testo LetterarioDocumento17 pagineCos e Un Testo LetterarioClau DecaNessuna valutazione finora
- Dispensa Su ProppDocumento10 pagineDispensa Su ProppsilvialucaaNessuna valutazione finora
- Linguaggio - e - Pensiero L'Ipotesi Di Sapir-WhorfDocumento46 pagineLinguaggio - e - Pensiero L'Ipotesi Di Sapir-WhorfGermana83% (6)
- Filosofia Del LinguaggioDocumento34 pagineFilosofia Del LinguaggioVincenzo GrassoNessuna valutazione finora
- Che Cos e Un Testo Letterario Di Chines e Varotti (Salvataggio Automatico)Documento17 pagineChe Cos e Un Testo Letterario Di Chines e Varotti (Salvataggio Automatico)Andrea PanzaNessuna valutazione finora
- FRENI, La Questione Del MitoDocumento22 pagineFRENI, La Questione Del MitoHen PantaNessuna valutazione finora
- Faschilli Filosofia Del Linguaggio CorrettoDocumento6 pagineFaschilli Filosofia Del Linguaggio CorrettoJorge Luis ZarazuaNessuna valutazione finora
- Zavatta Scienza Linguaggio Humboldt PDFDocumento31 pagineZavatta Scienza Linguaggio Humboldt PDFcapitankonigNessuna valutazione finora
- Filosofia Della Comunicazione e Del Linguaggio L 2Documento42 pagineFilosofia Della Comunicazione e Del Linguaggio L 2Eleonora ZitoNessuna valutazione finora
- Filosofia della mente: Spunti di riflessione sul processo traduttivoDa EverandFilosofia della mente: Spunti di riflessione sul processo traduttivoNessuna valutazione finora
- Sentimento e Forma Nella Teoria Del Simbolo Di Susanne K. LangerDocumento27 pagineSentimento e Forma Nella Teoria Del Simbolo Di Susanne K. LangernadjamoNessuna valutazione finora
- Riassunto Del Riassunto OraliraDocumento9 pagineRiassunto Del Riassunto Oraliraantoniotorrett2Nessuna valutazione finora
- Antoniel - 2012 - Il Concetto Di Metafora in Black, Ricoeur e BlumenbergDocumento55 pagineAntoniel - 2012 - Il Concetto Di Metafora in Black, Ricoeur e BlumenbergceprunNessuna valutazione finora
- Storia Della Critica LetterarDocumento25 pagineStoria Della Critica LetterarCarola FiorindoNessuna valutazione finora
- Northrop Frye e Michail BachtinDocumento14 pagineNorthrop Frye e Michail BachtinFabio SantosNessuna valutazione finora
- Il Potere Del Linguaggio PDFDocumento19 pagineIl Potere Del Linguaggio PDFCarla NatoliNessuna valutazione finora
- L'Immagine e La ParolaDocumento8 pagineL'Immagine e La ParolaShelley MarcuccioNessuna valutazione finora
- Primo Levi davanti all’assurdo. Dire l’indicibile: Il linguaggio della ShoahDa EverandPrimo Levi davanti all’assurdo. Dire l’indicibile: Il linguaggio della ShoahNessuna valutazione finora
- Lett. Comparate 2Documento7 pagineLett. Comparate 2domenicor941Nessuna valutazione finora
- BertoniDocumento5 pagineBertonidomenicor941Nessuna valutazione finora
- TesiElenaMascioliMasterEcampus24Giu PDFDocumento28 pagineTesiElenaMascioliMasterEcampus24Giu PDFElenaNessuna valutazione finora
- Ipotesi Di Sapir WhorfDocumento3 pagineIpotesi Di Sapir WhorfEnrica LibertiNessuna valutazione finora
- Sarah Kofman, Nietzsche MetaforaDocumento24 pagineSarah Kofman, Nietzsche MetaforaMachucaNessuna valutazione finora
- Rosenzweig - Cristina GuarnieriDocumento10 pagineRosenzweig - Cristina GuarnieriMarino Rama100% (1)
- Bernardelli e GrilloDocumento9 pagineBernardelli e Grillog.levatino8Nessuna valutazione finora
- Filologia Italiana MagistraleDocumento95 pagineFilologia Italiana MagistraleLucia CapognaNessuna valutazione finora
- Senso e DenotazioneDocumento1 paginaSenso e DenotazionetheourgikonNessuna valutazione finora
- Metafora e PsicoterapiaDocumento13 pagineMetafora e PsicoterapiaCrescita PersonaleNessuna valutazione finora
- Metafora Cognitiva Articolo Fil Analitica PDFDocumento32 pagineMetafora Cognitiva Articolo Fil Analitica PDFCarla NatoliNessuna valutazione finora
- 4.1 Ludwig Wittgenstein e Il Tractatus Logico Philosophicus.Documento8 pagine4.1 Ludwig Wittgenstein e Il Tractatus Logico Philosophicus.Andrea VolonninoNessuna valutazione finora
- I Saperi Del Tradurre - Capitolo IDocumento7 pagineI Saperi Del Tradurre - Capitolo ISara LeoneNessuna valutazione finora
- FedraDocumento6 pagineFedrarottenapple30% (1)
- Patologie Del Linguaggio e Della ComunicazioneDocumento29 paginePatologie Del Linguaggio e Della ComunicazioneFrancesco MerraNessuna valutazione finora
- La poetica della mente: Pensiero, linguaggio e comprensione figuratiDa EverandLa poetica della mente: Pensiero, linguaggio e comprensione figuratiNessuna valutazione finora
- Basso - Fenomenologia, Semiotica Ed Estetica PDFDocumento12 pagineBasso - Fenomenologia, Semiotica Ed Estetica PDFMichelle CabralNessuna valutazione finora
- Mounin, Teoria e Storia Della Traduzione - Part III - PDFDocumento6 pagineMounin, Teoria e Storia Della Traduzione - Part III - PDFmripari5280Nessuna valutazione finora
- Tractatus Logico-Philosophicus - WikipediaDocumento4 pagineTractatus Logico-Philosophicus - WikipediafabromNessuna valutazione finora
- Convegno Linguistica Relazione Di Vida-1Documento17 pagineConvegno Linguistica Relazione Di Vida-1Vida RusNessuna valutazione finora
- Che Cosa È La Letteratura Comparata - SteinerDocumento11 pagineChe Cosa È La Letteratura Comparata - SteinereosNessuna valutazione finora
- Dispense Su BarthesDocumento22 pagineDispense Su BarthesmicantenNessuna valutazione finora
- Heidegger e Lacan Ascolto Del LinguaggioDocumento5 pagineHeidegger e Lacan Ascolto Del LinguaggioMyriam PanicoNessuna valutazione finora
- Letteratura - IntroduzioneDocumento4 pagineLetteratura - IntroduzionesimoroncoNessuna valutazione finora
- Teoria Della TraduzioneDocumento11 pagineTeoria Della TraduzionemarcoNessuna valutazione finora
- Definizione Di SemanticaDocumento5 pagineDefinizione Di SemanticaalessiaNessuna valutazione finora
- Mineto Teoria Del Significato in HusserlDocumento16 pagineMineto Teoria Del Significato in HusserlCarla NatoliNessuna valutazione finora
- Nomen, OmenDocumento39 pagineNomen, OmennicosuarezNessuna valutazione finora
- Prima UnitàDocumento8 paginePrima UnitàLucia caponeNessuna valutazione finora
- 1 LetteraturaDocumento8 pagine1 LetteraturamarcociliegiaaNessuna valutazione finora
- Filologia RomanzaDocumento126 pagineFilologia Romanzag.lambertiniNessuna valutazione finora
- Manifesto Dellintersezionismo Speculare 4a Ediz.Documento177 pagineManifesto Dellintersezionismo Speculare 4a Ediz.PinoVentriglioNessuna valutazione finora
- P. Fabbri - La Prossemica A Lungo CorsoDocumento4 pagineP. Fabbri - La Prossemica A Lungo CorsoOoNessuna valutazione finora
- SociolinguisticaDocumento7 pagineSociolinguisticauomodibronzoNessuna valutazione finora
- La Molteplicta' Semantica Nel Linguaggio Dei Mistici Di Vida RusDocumento21 pagineLa Molteplicta' Semantica Nel Linguaggio Dei Mistici Di Vida RusVida RusNessuna valutazione finora
- Filologia RomanzaDocumento53 pagineFilologia RomanzaAnnamaria DuranteNessuna valutazione finora
- Modulo Linguistica Del TestoDocumento81 pagineModulo Linguistica Del Testoalda totaNessuna valutazione finora
- Karl Otto Apel Il Problema Del Linguaggio in Wittgenstein e HeideggerDocumento14 pagineKarl Otto Apel Il Problema Del Linguaggio in Wittgenstein e HeideggerraimpoNessuna valutazione finora
- Dalla Danza Al Teatro Della MascheraDocumento4 pagineDalla Danza Al Teatro Della MascheraGerard Fisa Biscarri100% (1)
- Il Nuovo NordestDocumento286 pagineIl Nuovo NordestanordestNessuna valutazione finora
- Erich Fromm - Il Bisogno Di Credere PDFDocumento96 pagineErich Fromm - Il Bisogno Di Credere PDFalfredo89100% (1)
- Personaggi Delle Fiabe e Archetipi JunghianiDocumento7 paginePersonaggi Delle Fiabe e Archetipi JunghianiquetzhalNessuna valutazione finora
- 178 40 PBDocumento469 pagine178 40 PBAlfonso FalconeNessuna valutazione finora
- Deleuze, Gilles - Anti Edipo E Mille Piani (16.11.1971)Documento12 pagineDeleuze, Gilles - Anti Edipo E Mille Piani (16.11.1971)criszam8Nessuna valutazione finora
- Creatività, Schizofrenia Ed Immagini in Blu - Di Giuseppe Costantino BudettaDocumento17 pagineCreatività, Schizofrenia Ed Immagini in Blu - Di Giuseppe Costantino BudettaNeuroscienze.net100% (1)
- Risoluzione Della Disapprovazione Parentale e Delle Dinamiche Di RelazioneDocumento27 pagineRisoluzione Della Disapprovazione Parentale e Delle Dinamiche Di RelazioneRoberto GiulianiNessuna valutazione finora
- 01 L'improvvisaz Nel JazzDocumento23 pagine01 L'improvvisaz Nel JazzFausto FerraiuoloNessuna valutazione finora
- Art Tec La Gestalt AnaliticaDocumento14 pagineArt Tec La Gestalt AnaliticaLuca La PortaNessuna valutazione finora
- Educare o IstruireDocumento17 pagineEducare o IstruireCinzcakeNessuna valutazione finora
- File Unico Diritti UmaniDocumento58 pagineFile Unico Diritti UmaniSilvia FontanaNessuna valutazione finora
- Psicologia Dei Gruppi - Domande ChiuseDocumento41 paginePsicologia Dei Gruppi - Domande ChiuseDario Brizi100% (1)
- Parte Seconda Cap.5 I PIANETI Nel Tema NataleDocumento19 pagineParte Seconda Cap.5 I PIANETI Nel Tema Natalemcc43Nessuna valutazione finora
- Tecniche Di Manipolazione MentaleDocumento9 pagineTecniche Di Manipolazione MentaleLisa SalviniNessuna valutazione finora
- ESERCIZI SPIRITUALI, Piccolo Manuale Di Auto-Aiuto (Guida Pratica Per IMPARARE Ad Imparare A Prendersi Cura Di Sé)Documento99 pagineESERCIZI SPIRITUALI, Piccolo Manuale Di Auto-Aiuto (Guida Pratica Per IMPARARE Ad Imparare A Prendersi Cura Di Sé)Zewale Il Pro-VocatoReNessuna valutazione finora
- Il SognoDocumento26 pagineIl SognomeriwenxiNessuna valutazione finora