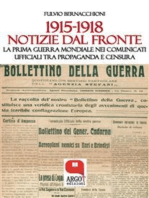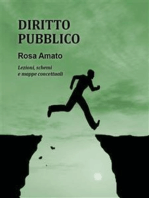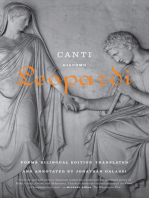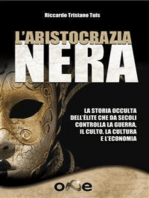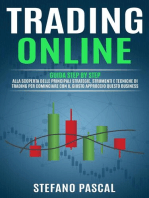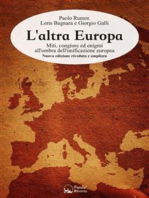Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
L'impero Italiano e L'alleanza Con Hitler
Caricato da
smurffffed0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
0 visualizzazioni3 pagineTitolo originale
L'impero italiano e l'alleanza con Hitler
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
0 visualizzazioni3 pagineL'impero Italiano e L'alleanza Con Hitler
Caricato da
smurffffedCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 3
Diversamente dalla Germania, uscita sconfitta dalla guerra e punita al tavolo della pace,
l’Italia mussoliniana non aveva da avanzare rivendicazioni territoriali capaci di
mobilitare l’opinione pubblica. Nonostante le delusioni subìte a Versailles, era pur
sempre una potenza vincitrice e aveva risolto in modo soddisfacente la spinosa
questione adriatica. Ma non per questo il fascismo poteva accantonare quella
vocazione nazionalista ed espansionista che faceva parte dei suoi caratteri originari e lo
portava a proporsi come il restauratore delle glorie di Roma antica.
Fino ai primi anni ’30, le aspirazioni imperiali del fascismo rimasero vaghe e si
tradussero, più che in una coerente direttiva di politica estera, in una generica
contestazione dell’assetto europeo uscito dai trattati di Versailles. Il che tuttavia non
impedì all’Italia di mantenere buoni rapporti con la Gran Bretagna e di restare
all’interno del sistema di sicurezza collettiva fondato sull’intesa fra le potenze vincitrici.
Questa fase, culminata negli accordi di Stresa dell’aprile 1935, si esaurì però con
l’attacco dell’Italia fascista all’Impero etiopico, allora l’unico grande Stato indipendente
del continente africano.
A spingere Mussolini verso un’impresa di cui pochi in Italia sentivano la necessità
furono motivi di politica internazionale e interna. Con la conquista dell’Etiopia il duce
intendeva innanzitutto dare uno sfogo alla vocazione imperiale del fascismo,
vendicando al contempo lo scacco subìto dall’Italia nel 1896 con la sconfitta di Adua. Ma
voleva anche creare una nuova occasione di mobilitazione popolare che facesse
passare in secondo piano i problemi economici e sociali del paese.
I governi francese e britannico erano disposti ad assecondare, almeno in parte, le mire
italiane. Ma non potevano accettare che uno Stato indipendente, membro della Società
delle Nazioni, fosse cancellato dalla carta geografica da un atto di aggressione. Così,
quando all’inizio di ottobre del 1935 l’Italia diede avvio all’invasione dell’Etiopia, Francia
e Gran Bretagna chiesero al Consiglio della Società delle Nazioni di adottare sanzioni
economiche, consistenti nel divieto di esportare in Italia merci necessarie all’industria
di guerra.
Approvate a schiacciante maggioranza pochi giorni dopo l’inizio dell’invasione, le
sanzioni ebbero un’efficacia molto limitata: sia perché il blocco non era esteso alle
materie prime, sia perché non impegnava gli Stati che non facevano parte della Società
delle Nazioni, come gli Stati Uniti e la Germania. Le decisioni prese ebbero però l’effetto
di approfondire la frattura fra il regime fascista e le democrazie europee e consentirono
a Mussolini di montare un’imponente campagna propagandistica tesa a presentare
l’Italia come vittima di una congiura internazionale. L’immagine dell’Italia “proletaria”
cui le nazioni plutocratiche, già padrone di sterminati imperi coloniali, volevano
impedire la conquista di un proprio “posto al sole” riuscì in effetti a far breccia
nell’opinione pubblica italiana, non escluse le classi popolari, alle quali fu fatto
intravedere il miraggio di nuovi posti di lavoro e di nuove opportunità di ricchezza da
conquistare oltremare. Le piazze si riempirono di folle inneggianti a Mussolini e alla
guerra. Studenti e attivisti di partito diedero vita a rumorose manifestazioni anti-inglesi.
Milioni di coppie, a cominciare da quella reale, accolsero l’invito del governo a donare
alla patria l’oro delle loro fedi nuziali.
Sul piano militare l’impresa fu più difficile del previsto: gli etiopi si batterono con
accanimento per più di sette mesi sotto la guida del negus Hailè Selassiè. Ma il loro
esercito, male organizzato e peggio equipaggiato, nulla poteva contro un corpo di
spedizione che giunse a impegnare circa 400 mila uomini e fece ampio ricorso ai mezzi
corazzati e all’aviazione, usata in più occasioni per bombardare le truppe nemiche con
gas letali. Il 5 maggio 1936, le truppe italiane, comandate dal maresciallo Pietro
Badoglio, entrarono in Addis Abeba. Quattro giorni dopo, Mussolini poteva annunciare
alle folle plaudenti «la riapparizione dell’Impero sui colli fatali di Roma» e offrire a re
Vittorio Emanuele III la corona di imperatore d’Etiopia.
Da un punto di vista economico la conquista dell’Etiopia, paese povero di risorse
naturali e poco adatto agli insediamenti agricoli, rappresentò per l’Italia un peso non
indifferente, cui si aggiunsero i problemi suscitati dalle sanzioni. Ma sul piano politico il
successo fu indiscutibile. Portando a termine una campagna coloniale vittoriosa,
imponendo la propria volontà alle democrazie occidentali e costringendole poi ad
accettare il fatto compiuto, Mussolini diede a molti la sensazione, illusoria, di aver
conquistato per l’Italia una posizione di grande potenza.
Inebriato dal successo, il duce credette di poter condurre una politica ambiziosa e
spregiudicata, sfruttando ogni occasione per allargare l’area di influenza italiana. In
questo piano rientrava anche l’avvicinamento dell’Italia alla Germania, cominciato
subito dopo la guerra d’Etiopia e sancito, nell’ottobre 1936, dalla firma di un patto di
amicizia cui fu dato il nome di Asse Roma Berlino. Rafforzato dal comune impegno
nella guerra civile spagnola e, nell’autunno ’37, dall’adesione italiana al cosiddetto patto
anti-Comintern, l’Asse Roma-Berlino non era ancora una vera alleanza militare.
Mussolini considerava infatti l’appoggio alla Germania non tanto come una scelta
irreversibile, quanto come uno strumento che, aumentando il peso contrattuale
dell’Italia, le consentisse di ottenere qualche ulteriore vantaggio in campo coloniale: il
tutto in attesa che il paese fosse preparato ad affrontare un conflitto in posizione di
forza.
Ma il dinamismo aggressivo della Germania non consentì a Mussolini i tempi e gli spazi
di manovra necessari per realizzare il suo programma. Credendo di potersi servire
dell’amicizia tedesca, il duce ne fu in realtà sempre più condizionato, al punto da dover
accettare passivamente tutte le iniziative di Hitler. Finché, nel maggio 1939, si decise
alla scelta che sarebbe risultata fatale al regime e al paese: la firma di un formale patto
di alleanza con la Germania, il “patto d’acciaio”, che legava definitivamente le sorti
dell’Italia a quelle dello Stato nazista.
La vittoriosa campagna contro l’Etiopia segnò per il regime fascista l’apogeo del
successo e della popolarità. Ma, svaniti gli entusiasmi che avevano accompagnato
l’impresa coloniale, il fronte apparentemente compatto dei consensi conobbe alcune
significative incrinature. A suscitare preoccupazione era soprattutto il nuovo indirizzo di
politica estera attuato da Mussolini e dal suo principale collaboratore di questi anni, il
genero Galeazzo Ciano, assurto poco più che trentenne alla carica di ministro degli
Esteri. L’aspetto che più inquietava l’opinione pubblica era l’amicizia con la Germania:
un’amicizia che urtava contro le tradizioni del Risorgimento e della Grande Guerra, e
soprattutto contro la diffusa antipatia di cui era oggetto lo Stato nazista. La politica
mussoliniana si mostrava inoltre avara di risultati immediati e faceva sembrare più
vicina l’eventualità di una nuova guerra europea. Non fu un caso se le uniche
manifestazioni di spontaneo entusiasmo popolare di questo periodo si ebbero in
coincidenza col ritorno di Mussolini dalla conferenza di Monaco del ’38, e furono rivolte
al duce in quanto presunto salvatore della pace.
Ma le aspirazioni alla pace contrastavano con i programmi di Mussolini. Il duce
auspicava per l’Italia un avvenire di imprese militari e pensava che gli italiani avrebbero
dovuto non solo armarsi adeguatamente, ma anche rinnovarsi nel profondo,
trasformandosi in un popolo di conquistatori e di guerrieri. Ciò implicava da parte del
duce un atteggiamento duro e quasi punitivo nei confronti della popolazione, in
particolare della borghesia, intesa non tanto come classe sociale quanto come
atteggiamento mentale che doveva essere definitivamente estirpato dal costume
nazionale.
Per avvicinarsi a questo obiettivo, il regime doveva diventare più totalitario di quanto
non fosse stato fino ad allora. Da qui scaturirono alcune modifiche istituzionali, che
andavano dalla creazione del ministero per la Cultura popolare all’accorpamento delle
organizzazioni giovanili nella Gioventù italiana del littorio (Gil), dall’ampliamento delle
funzioni del Partito fascista alla sostituzione, nel 1939, della Camera dei deputati con
una nuova Camera dei fasci e delle corporazioni dove, abolita ogni finzione elettorale, si
entrava semplicemente in virtù delle cariche ricoperte negli organi di regime.
A una medesima logica rispondevano alcune iniziative di carattere più che altro
formale, e quasi folkloristico, che tuttavia possono dare un’idea del clima di quegli anni:
la campagna contro l’uso del “lei” e contro tutti i termini stranieri; l’imposizione della
divisa ai funzionari pubblici; l’adozione del “passo romano” per conferire un aspetto più
marziale alle sfilate militari.
Ma la manifestazione più seria e più aberrante della stretta totalitaria voluta da
Mussolini fu l’introduzione di una serie di leggi discriminatorie nei confronti degli ebrei:
leggi che ricalcavano nelle grandi linee quelle naziste del ’35, escludendo gli israeliti
dagli uffici pubblici, limitandone l’accesso alle professioni e vietando i matrimoni misti.
Preannunciata da un manifesto di dieci scienziati e preparata da un’intensa campagna
di stampa, la legislazione razziale giunse tuttavia del tutto inattesa in un paese che non
aveva mai conosciuto forme di antisemitismo diffuso: anche perché la comunità
ebraica era assai poco numerosa e complessivamente ben integrata nella società.
Adottando queste misure, tanto gratuite quanto moralmente ripugnanti, Mussolini si
proponeva di inoculare nel popolo italiano il germe dell’orgoglio razziale e di fornirgli
così un nuovo motivo di aggressività e compattezza nazionale. Ma, anziché suscitare
consenso e mobilitazione, le leggi razziali furono accolte con indifferenza o con
perplessità dall’opinione pubblica; e aprirono per giunta un serio contrasto con la
Chiesa, contraria non tanto alla discriminazione in sé quanto alle sue motivazioni non
religiose, ma biologico-razziali.
In generale, lo sforzo compiuto da Mussolini sul finire degli anni ’30 per fare del regime
fascista un totalitarismo pienamente realizzato e per cambiare la mentalità degli
italiani ebbe risultati mediocri. L’unico settore della società in cui le aspirazioni
totalitarie ottennero qualche successo fu quello giovanile. I ragazzi cresciuti nelle
organizzazioni di regime, gli studenti inquadrati nei Gruppi universitari fascisti, i giovani
più impegnati intellettualmente che ogni anno partecipavano a migliaia ai “littoriali
della cultura” si abituarono a “pensare fascista”, a considerare il regime come una realtà
immutabile, come un quadro di riferimento obbligato nelle sue linee di fondo. Fu solo
con lo scoppio del conflitto e con i primi rovesci bellici che il fascismo cominciò a
perdere progressivamente il sostegno sul quale più contava: quello appunto dei
giovani. I quali, diventati nel frattempo soldati e ufficiali, vissero in prima persona il
fallimento di un regime che puntò tutto sulla politica di potenza.
Potrebbero piacerti anche
- Storia: LO SCONVOLGIMENTO DEL CONFLITTO E LA VITTORIA DELL'INTESADocumento5 pagineStoria: LO SCONVOLGIMENTO DEL CONFLITTO E LA VITTORIA DELL'INTESAfrancesca_b93Nessuna valutazione finora
- L'Italia fascista nella organizzazione sanitaria della guerra civile spagnolaDa EverandL'Italia fascista nella organizzazione sanitaria della guerra civile spagnolaNessuna valutazione finora
- La Storia Del FascismoDocumento7 pagineLa Storia Del FascismoCaterina FontanaNessuna valutazione finora
- 1915-1918. Notizie dal fronte: La Prima Guerra Mondiale nei comunicati ufficiali tra propaganda e censuraDa Everand1915-1918. Notizie dal fronte: La Prima Guerra Mondiale nei comunicati ufficiali tra propaganda e censuraNessuna valutazione finora
- 2 Guerra MondialeDocumento2 pagine2 Guerra Mondialefrancescabugiardi2000Nessuna valutazione finora
- I primi orientamenti di politica estera del fascismo: saggioDa EverandI primi orientamenti di politica estera del fascismo: saggioNessuna valutazione finora
- L Italia Nella Seconda Guerra MondialeDocumento16 pagineL Italia Nella Seconda Guerra MondialeNicolasNessuna valutazione finora
- Delitti e stragi dell'Italia fascista dal 1922 al 1945Da EverandDelitti e stragi dell'Italia fascista dal 1922 al 1945Nessuna valutazione finora
- Un Impero Per Il FascismoDocumento35 pagineUn Impero Per Il FascismoMilena CalabriaNessuna valutazione finora
- La Missione impossibile: Il PSU e la lotta al fascismoDa EverandLa Missione impossibile: Il PSU e la lotta al fascismoNessuna valutazione finora
- Una GuerraDocumento7 pagineUna GuerraGraziellaNessuna valutazione finora
- La Politica Estera Italiana (Alfredo Canavero)Documento3 pagineLa Politica Estera Italiana (Alfredo Canavero)Eurasia Rivista di Studi GeopoliticiNessuna valutazione finora
- 1800-1910 I Savoia alla reggia di Racconigi. Un secolo di interazioni tra la monarchia e il paese.: Il Trattato di RacconigiDa Everand1800-1910 I Savoia alla reggia di Racconigi. Un secolo di interazioni tra la monarchia e il paese.: Il Trattato di RacconigiNessuna valutazione finora
- Il Patto Di LondraDocumento2 pagineIl Patto Di LondralorenzodibiNessuna valutazione finora
- Italia Nella Prima Guerra MondialeDocumento33 pagineItalia Nella Prima Guerra MondialeLiaSNessuna valutazione finora
- RIASSUNTO - Breve Storia Della Repubblica Italiana - D.puccioDocumento8 pagineRIASSUNTO - Breve Storia Della Repubblica Italiana - D.puccioDiego BianchiNessuna valutazione finora
- Esame Si Storia Esame Si StoriaDocumento29 pagineEsame Si Storia Esame Si StoriaUn FollowerNessuna valutazione finora
- La Seconda Guerra MondialeDocumento2 pagineLa Seconda Guerra Mondialeoikawa tooru s favorite foodNessuna valutazione finora
- 1 Guerra MondialeDocumento2 pagine1 Guerra Mondialefior jaicNessuna valutazione finora
- Mussolini Il DuceDocumento38 pagineMussolini Il DuceDaniela LeoNessuna valutazione finora
- Amricanizazione de Italia - 2014 - BrunoLaura - LAmericanizzazionedeDocumento64 pagineAmricanizazione de Italia - 2014 - BrunoLaura - LAmericanizzazionedetaraselbulbaNessuna valutazione finora
- FASCISMODocumento3 pagineFASCISMOgabryminottiiiNessuna valutazione finora
- 2 Guerra MondialeDocumento8 pagine2 Guerra MondialeElisa MihailaNessuna valutazione finora
- Sto, Fascismo Anni 30Documento2 pagineSto, Fascismo Anni 30Ilaria BallarinNessuna valutazione finora
- Storia Contemporanea - RiassuntiDocumento59 pagineStoria Contemporanea - RiassuntiIlariaNessuna valutazione finora
- La Crisi Politica EuropeaDocumento2 pagineLa Crisi Politica EuropeasmurffffedNessuna valutazione finora
- 2 Guerra MondialeDocumento2 pagine2 Guerra MondialeAlessio ZaroliNessuna valutazione finora
- Fascismo: Eventi PrincipaliDocumento5 pagineFascismo: Eventi Principalicherry_booomNessuna valutazione finora
- Verso La Seconda Guerra MondialeDocumento3 pagineVerso La Seconda Guerra MondialeSofia CorridoriNessuna valutazione finora
- Schema Prima Guerra Mondiale.Documento4 pagineSchema Prima Guerra Mondiale.Matteo RoselliniNessuna valutazione finora
- Capitolo 17Documento4 pagineCapitolo 17linda.dececco09Nessuna valutazione finora
- La Guerra in ItaliaDocumento24 pagineLa Guerra in ItaliaALESSANDRA PIGNATARONessuna valutazione finora
- Lezione Storia 10032023Documento2 pagineLezione Storia 10032023ANTON ANDREA MOSCATELLINessuna valutazione finora
- Il FascismoDocumento5 pagineIl FascismoFlorin DumitruNessuna valutazione finora
- StoriaDocumento8 pagineStoriaDiana CattaneoNessuna valutazione finora
- LaGrandeGuerraeLaRivoluzione RussaDocumento4 pagineLaGrandeGuerraeLaRivoluzione RussaAndrea IoannoneNessuna valutazione finora
- Il Primo Dopoguerra in ItaliaDocumento5 pagineIl Primo Dopoguerra in ItaliaFlorin DumitruNessuna valutazione finora
- Avvenimenti Del 1938: La Notte Dei CristalliDocumento4 pagineAvvenimenti Del 1938: La Notte Dei Cristalliil mio quello di mio padreNessuna valutazione finora
- Storia Contemporanea 1Documento3 pagineStoria Contemporanea 1tomNessuna valutazione finora
- La Guerra Italiana Nei Balcani Aga RossiDocumento20 pagineLa Guerra Italiana Nei Balcani Aga RossibandarsNessuna valutazione finora
- Luigi Sturzo - La Comunità Internazionale e Il Diritto Di Guerra (1928)Documento395 pagineLuigi Sturzo - La Comunità Internazionale e Il Diritto Di Guerra (1928)zzzooo100% (1)
- Prima Parte Interrogazione StoriaDocumento3 paginePrima Parte Interrogazione Storiaznstht768zNessuna valutazione finora
- Seconda Guerra MondialeDocumento2 pagineSeconda Guerra MondialeFrancescoNessuna valutazione finora
- Seconda Guerra Mondiale PDFDocumento11 pagineSeconda Guerra Mondiale PDFMarcello Pera PerazziniNessuna valutazione finora
- Le Conseguenze Del I Conflitto MondialeDocumento5 pagineLe Conseguenze Del I Conflitto MondialeMaria DeserioNessuna valutazione finora
- L'Italia Dalla Neutralità All'entrata Nel Primo Conflitto MondialeDocumento2 pagineL'Italia Dalla Neutralità All'entrata Nel Primo Conflitto MondialelorenzodibiNessuna valutazione finora
- Italia FascistaDocumento7 pagineItalia FascistaGaia LionettiNessuna valutazione finora
- L'Italia in Guerra 1940-1943Documento19 pagineL'Italia in Guerra 1940-1943homersessualeNessuna valutazione finora
- Verso La GuerraDocumento3 pagineVerso La GuerraAndrea VenturiniNessuna valutazione finora
- StoriaDocumento5 pagineStoriaTeresa CuomoNessuna valutazione finora
- P. Togliatti Corso Sugli Avversari. Le L PDFDocumento34 pagineP. Togliatti Corso Sugli Avversari. Le L PDFFabio GarciaNessuna valutazione finora
- Il Carteggio Churchill - MussoliniDocumento12 pagineIl Carteggio Churchill - MussolinigliintrovabiliNessuna valutazione finora
- Dopoguerra ItalianoDocumento2 pagineDopoguerra ItalianoChristian D'AmbrosioNessuna valutazione finora
- La Nascita Della RepubblicaDocumento11 pagineLa Nascita Della RepubblicaabundioarnaldoNessuna valutazione finora
- Regime TotalitarioDocumento6 pagineRegime TotalitarioCescoLiveMnNessuna valutazione finora
- Internati Militari ItalianiDocumento21 pagineInternati Militari ItalianicarlgioNessuna valutazione finora
- FascismoDocumento7 pagineFascismocamillasorrentino74Nessuna valutazione finora
- La Guerra Civile SpagnolaDocumento3 pagineLa Guerra Civile SpagnolaSerena GiordanoNessuna valutazione finora
- Soluzione Tipologia C, Eugenio Borgna, La Nostalgia FeritaDocumento4 pagineSoluzione Tipologia C, Eugenio Borgna, La Nostalgia FeritaSkuola.net0% (1)
- I Viaggi Di Ulisse - L'isola Di Eolo (Libretto 3)Documento4 pagineI Viaggi Di Ulisse - L'isola Di Eolo (Libretto 3)Serena BlasiNessuna valutazione finora
- Problemi Attuali Di CristologiaDocumento4 pagineProblemi Attuali Di Cristologialezione27Nessuna valutazione finora
- Il Monitoraggio Emodinamico - PresentazioneDocumento46 pagineIl Monitoraggio Emodinamico - PresentazionecristinaNessuna valutazione finora
- Circonferenza, Corde, Angoli Al Centro, Angoli Alla CirconferenzaDocumento12 pagineCirconferenza, Corde, Angoli Al Centro, Angoli Alla CirconferenzaYounessNessuna valutazione finora
- Cechov - Il Monaco NeroDocumento24 pagineCechov - Il Monaco NeroLele PotrifNessuna valutazione finora
- Codice Civile PDFDocumento248 pagineCodice Civile PDFCampeanIvonaNessuna valutazione finora
- Morfosintassi LatinaDocumento67 pagineMorfosintassi LatinamikkeliNessuna valutazione finora
- Apprendimento e competenze nelle metodologie didattiche innovative: i laboratori inclusivi: Quaderni didattici-Percorsi per l'inclusione-4/2021Da EverandApprendimento e competenze nelle metodologie didattiche innovative: i laboratori inclusivi: Quaderni didattici-Percorsi per l'inclusione-4/2021Nessuna valutazione finora
- Concorso Istruttore Enti Locali - Servizi pubblici locali: Sintesi ragionata per concorsi pubbliciDa EverandConcorso Istruttore Enti Locali - Servizi pubblici locali: Sintesi ragionata per concorsi pubbliciNessuna valutazione finora
- CCNL sulla disciplina del Rapporto di Lavoro Domestico - 2022Da EverandCCNL sulla disciplina del Rapporto di Lavoro Domestico - 2022Nessuna valutazione finora
- Fake news dell'antica Roma: 2000 anni di propaganda, inganni e bugieDa EverandFake news dell'antica Roma: 2000 anni di propaganda, inganni e bugieNessuna valutazione finora
- Il caso Giorgia Meloni: Social network, cultura pop e comunicazione politicaDa EverandIl caso Giorgia Meloni: Social network, cultura pop e comunicazione politicaNessuna valutazione finora
- L’Aristocrazia Nera: La storia occulta dell’élite che da secoli controlla la guerra, il culto, la cultura e l’economiaDa EverandL’Aristocrazia Nera: La storia occulta dell’élite che da secoli controlla la guerra, il culto, la cultura e l’economiaNessuna valutazione finora
- TRADING ONLINE: Guida Step by Step alla Scoperta delle Principali Strategie, Strumenti e Tecniche di Trading per Cominciare con il Giusto Approccio questo Business.Da EverandTRADING ONLINE: Guida Step by Step alla Scoperta delle Principali Strategie, Strumenti e Tecniche di Trading per Cominciare con il Giusto Approccio questo Business.Nessuna valutazione finora
- Cryptotrading Pro: Fai Trading Per Guadagnare Con Strategie, Strumenti E Tecniche Di Gestione Del RischioDa EverandCryptotrading Pro: Fai Trading Per Guadagnare Con Strategie, Strumenti E Tecniche Di Gestione Del RischioNessuna valutazione finora
- Gesuiti: L’Ordine militare dietro alla Chiesa, alle Banche, ai servizi segreti e alla governance mondialeDa EverandGesuiti: L’Ordine militare dietro alla Chiesa, alle Banche, ai servizi segreti e alla governance mondialeNessuna valutazione finora
- Quando eravamo i padroni del mondo: Roma: l'impero infinitoDa EverandQuando eravamo i padroni del mondo: Roma: l'impero infinitoNessuna valutazione finora
- Ordinamento finanziario e contabile - Concorso Istruttore Enti locali: Sintesi aggiornata per concorsi a Istruttore e Istruttore direttivo Enti localiDa EverandOrdinamento finanziario e contabile - Concorso Istruttore Enti locali: Sintesi aggiornata per concorsi a Istruttore e Istruttore direttivo Enti localiValutazione: 3 su 5 stelle3/5 (1)
- L'altra Europa: Miti, congiure ed enigmi all'ombra dell'unificazione europeaDa EverandL'altra Europa: Miti, congiure ed enigmi all'ombra dell'unificazione europeaValutazione: 2 su 5 stelle2/5 (1)
- The secrets of the Italian language: I segreti della lingua italiana per stranieriDa EverandThe secrets of the Italian language: I segreti della lingua italiana per stranieriValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (5)
- Concorso DSGA Prova Teorico Pratica: Guida alla risoluzione di casi concreti attraverso la redazione di un attoDa EverandConcorso DSGA Prova Teorico Pratica: Guida alla risoluzione di casi concreti attraverso la redazione di un attoNessuna valutazione finora
- Concorsi pubblici - La redazione di un atto amministrativo: Per la preparazione alla prova scrittaDa EverandConcorsi pubblici - La redazione di un atto amministrativo: Per la preparazione alla prova scrittaNessuna valutazione finora