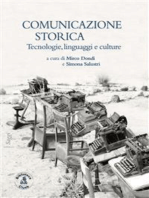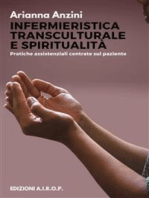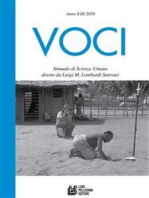Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Docsity Demografia Storica Corso Base F Rossi
Docsity Demografia Storica Corso Base F Rossi
Caricato da
giacomoTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Docsity Demografia Storica Corso Base F Rossi
Docsity Demografia Storica Corso Base F Rossi
Caricato da
giacomoCopyright:
Formati disponibili
Demografia storica, corso
base. - F. Rossi
Demografia
Università degli Studi di Padova
21 pag.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: giacomo-giacomazzi-1 (giacomo.giacomazzi.1@studenti.unipd.it)
DEMOGRAFIA STORICA - CORSO BASE
1. NOZIONI ELEMENTARI DI DEMOGRAFIA
1.1 Demografia, Storia, Demografia storica
1.1.1 Un ponte fra due discipline
La storia si occupa, tramite l’uso di fonti, della ricerca sui fatti del passato, che si
propone di descrivere ed interpretare.
La storiografia, a partire dagli anni Trenta e nel secondo Dopoguerra, vive
un’evoluzione ed un ridimensionamento anche rispetto ad aspetti legati al quotidiano
delle perone; si vede dunque lo sviluppo della storia sociale e della storia economica
La demografia si occupa invece dello studio della popolazione nei suoi aspetti
morfologici e dinamici, e delle cause e delle conseguenze della sua evoluzione nella
società.
Aspetti importanti:
- oggetto di studio, che sono le popolazioni umane
- metodi usati, prevalentemente quantitativi
- caratteristiche statiche e dinamiche e le loro relazioni
- aspetti biologico-sociali
Varie fasi dello studio: dalla rivelazione, alla costruzione di indicatori efficaci,
all’interpretazione; l’approccio può seguire la vita delle coorti o generazioni o
osservare i fatti accaduti in un dato periodo ed infine l’uso di dati aggregati o di dati
individuali
La demografia storica si situa a cavallo tra la storia e la demografia, come un ponte
che le collega; è opinione diffusa tra i demografi che non esista soluzione di
continuità fra demografia storica e demografia tout court, nel senso che non esiste
una interruzione temporale che segni la fine dell’una e l’inizio dell’altra.
La demografia storica può anche esser considerata una partizione della demografia,
tanto più che la disponibilità delle fonti può condizionare l’uso dei metodi; sia la
demografia che la demografia s. non sono riducibili ad un insieme di metodi, quanto
più ad un insieme di problemi che si affrontano con metodi che essa ha a
disposizione.
I tempi dei fatti demografici sono tempi lunghi, la cui unica unità di misura è la durata
di una generazione, o di una convivenza matrimoniale, o di una vita umana; questi
fatti possono appieno comprendersi solo quando vengono studiati in successione.
Pertanto la demografia è anche storia della popolazione. Altrettanto strumentale è la
distinzione fra storia della popolazione e demografia storica, quasi che la seconda
fosse destinata ad elaborare scientificamente il materiale di base, e la prima ad
offrirli, pronti per l’uso alle discipline storiche. Un legame fra la Demografia e la
Storia, nella recente concezione della storiografia cui si è fatto cenno, si può trovare
nell’oggetto di studio, che è sostanzialmente la vita delle persone, dalla nascita alla
morte, con i fatti principali che interessano uomini e donne: matrimonio, famiglia,
figli, spostamenti territoriali, vecchiaia. La demografia riesce a cogliere e a
descrivere le condizioni di vita della popolazione, le stesse cui sono interessate la
storia sociale e la storia economica. A maggior ragione, quando i dati collettivi sono
raccolti mettendo insieme storie individuali o familiari, descritte con il metodo della
ricostruzione nominativa di Henry negli anni 50-60 del 900.
1.1.2 Evoluzione degli interessi e dei metodi
Tappe fondamentali: fino agli anni 50 o 60 del 900, l’attenzione dei demografi storici
era rivolta soprattutto a problemi macrodemografici: l’ammontare della popolazione,
la densità e la distribuzione sul territorio, il tasso di incremento, le componenti
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: giacomo-giacomazzi-1 (giacomo.giacomazzi.1@studenti.unipd.it)
naturali: natalità, mortalità, fluttuazioni economiche e demografiche, crisi di mortalità.
Tutto ciò utilizzando in modo aggregativo le fonti disponibili: censimenti o rilevazioni
simili, serie storiche di nascite, matrimoni, morti. Questo modo di procedere
presentava varie difficoltà difficilmente superabili, dalla qualità delle fonti alla scarsa
profondità delle misure ottenibili.
A partire dalla metà del 900, ha iniziato a manifestarsi la necessità di conoscenze
ulteriori, non ottenibili con analisi macro, derivanti dalla mancanza di informazioni su
comportamenti individuali e sulla loro variabilità, celata dall’apparente uniformità dei
dati globali aggregati. Si sono sviluppati interessi cosiddetti microdemografici, come
quelli connessi alla fecondità, alla nuzialità, alla mortalità, alla migratorietà, alla
composizione delle famiglie. Un grande impulso a questi interessi è derivato dagli
studi di L. Henry, che ideò il metodo della analisi nominativa per la ricostruzione delle
storie familiari. Per la scuola francese, la Demografia storica si afferma e si sviluppa
proprio per impulso del nuovo metodo della ricostruzione nominativa.
L’analisi nominativa consiste nell’incrocio delle informazioni individuali presenti negli
atti di battesimo, matrimonio, sepoltura, per ricavarne altre informazioni non presenti
direttamente nei documenti. La novità del metodo sta nella scelta di famiglie di
villaggio o di una parrocchia, i cui dati sono poi elaborati ed analizzati in modo
aggregato.
Ci sono problemi non superabili, come il tempo per la ricognizione degli atti
necessari per la ricostruzione che si può fare solo per un numero limitato di famiglie,
una certa selezione non desiderata delle famiglie ricostruite, l’impossibile
adattamento del metodo per alcuni fenomeni. Le informazioni cui si può arrivare
sono ad ogni modo di grande interesse ed integrano quelle ottenibili da dati
aggregati.
Un limite delle tecniche nominative sta nella disponibilità di dati di movimento
naturale; in caso si può far ricorso ad uso di modelli di popolazioni stabili. La
popolazione stabile è la struttura per età cui tende una popolazione nella quale
sussistano condizioni di mortali per età e fecondità per età costanti, che determinano
anche un tasso di incremento costante. Il vantaggio di queste leggi, dimostrabili, è
che, con informazioni limitate e frammentarie sulla struttura e sulla dinamica, si può
ottenere, a certe condizioni, una stima buona della situazione complessiva della
popolazione: composizione per età, fecondità, mortalità.
Un altro limite alle tecniche nominative consiste nel fatto che si sa tutto di alcune
variabili relative alle famiglie ricostruite, ma non si conosce nulla dei parametri
generali della popolazione cui appartengono le famiglie ricostruite.
Limite superato attraverso la messa a punto di tecniche di ricostruzione aggregativa
della popolazione. Anni 70, Lee, Inverse projection, con la quale era possibile avere
ogni anno informazioni dettagliate sulla struttura per età della popolazione ed
indicatori più raffinati, come numero di figli per donna ecc. Nel 1985, una nuova
versione includeva anche i movimenti migratori. Con la back projection invece, sono
state rese possibili ricostruzioni delle popolazioni precedenti. Altri sviluppi più recenti
di modelli sono gli event history analysis, applicati a dati ottenuti da ricostruzioni
nominative. Sono modelli statistici complessi, che consistono nel valutare la
probabilità di un certo fenomeno in relazione ad altre variabili indipendenti.
1.2 Qualche nozione preliminare
1.2.1 Morfologia e dinamica della popolazione
Distinzione fra stato e movimento, indicati anche come morfologia e dinamica della
popolazione. Con il primo concetto si intende la situazione della popolazione con
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: giacomo-giacomazzi-1 (giacomo.giacomazzi.1@studenti.unipd.it)
riferimento a un dato territorio e a un certo istante di tempo; è possibile avere
informazioni sia sull’ammontare che su altre caratteristiche strutturali di una
popolazione. Con il secondo concetto si intende l’insieme delle variabili che fanno
cambiare numericamente o qualitativamente la popolazione. Si tratta di nascite e di
decessi, che costituiscono il movimento naturale, e delle immigrazioni ed
emigrazioni, che formano il movimento migratorio. Ad esse si aggiungono altre
variabili dl movimento naturale che NON fanno cambiare il numero della
popolazione, ma solo qualche caratteristica delle persone: matrimoni, separazioni e
divorzi, ma anche interruzioni di gravidanza e nascite di nati morti.
Le informazioni sull’ammontare e struttura sulle popolazione si raccolgono con il
censimento generale della popolazione. Per avere informazioni sulle variabili di
movimento, serve invece un’organizzazione capillare permanente che è lo Stato
civile, alla quale vanno denunciati gli eventi del movimento naturale. Vi è inoltre in
certi Paesi anche il Registro di popolazione - Anagrafe - continuamente aggiornato.
La popolazione residente di ogni comune è nota in qualsiasi istante di tempo: Pt + N
- M +I - E = P t+1
1.2.2 Un semplice esempio e una estensione - letto solo
1.2.3 Tassi generici di movimento naturale e migratorio - letto solo
1.2.4 Qualche formalizzazione e alcuni esempi - letto solo
1.3 Censimenti
1.3.1 Introduzione
Il censimento è un concetto immediato, che non ha bisogno di spiegazioni.
1.3.2 Caratteristiche dei censimenti
Definizione: operazione che consiste in un conteggio delle persone viventi in un dato
istante su un territorio e nella rilevazione di alcuni loro caratteri.
I censimenti moderni hanno alcune caratteristiche tipiche:
- rilevazione individuale/nominativa
- diretta
- generale/universale
- omogenea
- simultanea
- periodica
- obbligatoria
I censimenti del passato mancano di uno o più di questi caratteri; sono diversi gli
scopi per i quali la rilevazione viene effettuata. Oggi gli scopi sono scientifici e
amministrativi. Gli scopi in passato erano di tipo prettamente militare, fiscali o
annonario.
1.3.3 Organizzazione dei censimenti
L’organizzazione è abbastanza complessa;
Prima fase:
a. divisione del territorio in sezioni di censimento e struttura degli organi di rilevazione
b. preparazione dei questionari, principale è il foglio di famiglia
c. piano di spoglio e pubblicazione delle informazioni raccolte
Seconda fase: rilevazione vera e propria
Terza fase: controlli del materiale raccolto
Nuovi metodi di rilevazione:
a. ricorso ad indagini campionarie
b. utilizzo di fonti amministrative già esistenti
c. integrazione di fonti amministrative e indagini campionarie
1.3.4 Sfruttamento delle informazioni di tipo censuario
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: giacomo-giacomazzi-1 (giacomo.giacomazzi.1@studenti.unipd.it)
Popolazione residente e presente
Sesso - M/F o M/(M+F), rispettivamente rapporto di mascolinità e percentuale di
maschi sul totale
Età - G/(G+A+V)% ; A/(G+A+V)% ; V/(G+A+V)%
si possono tratte indicatori sintetici di struttura, come indice di vecchiaia e
indice di dipendenza - I.V.=V/G% ; I.D.= (G+V)/A% = G/A% + V/A %
1.3.5 Piramide delle età
Trasposizione grafica delle cifre che compongono la struttura della popolazione
1.3.5.1 Problemi nella costruzione della piramide delle età
a. La costruzione di una piramide delle età: viene solitamente usato l’istogramma;
sistema cartesiano con classi di età e frequenza per uomini e per donne e poi
vengono uniti
b. Piramidi con classi di età annuali o pluriennali: la procedura corretta vede la
divisione del numero di persone di ciascuna classe d’età per l’ampiezza della classe,
in modo da avere la dimensione media in ciascun anno di età della classe. Si
procederà con la costruzione di due istogrammi (M e F) per poi sovrapporli. (per
annualità)
c. Piramidi con valori assoluti o percentuali: confronto di struttura per sesso ed età di
due o più popolazioni - due diverse piramidi con scale orizzontali diverse. Viene più
semplice disegnare due grafici dopo aver trasformato i valori in percentuali; la
popolazione viene così divisa per il totale generale per ottenere la percentuale di
popolazione della classe di età corrispondente.
d. Piramidi con una terza variabile: utile con una terza variabile, differente da età e
sesso; possibile tracciare la piramide dividendo i campi per le variabili opportune.
1.3.5.2 Interpretazione della piramide delle età
Vi sono diversi modi per leggere la piramide:
A. Struttura per sesso ed età;
B. Storia degli ultimi 100 anni: i sopravviventi di un centinaio di generazioni, di uomini
e di donne, detti anche coorti di nascita; si può così notare il baby boom degli anni
55-75 in Italia ed altri fenomeni demografici o economici e l’andamento che la
popolazione ha in questi periodi. Allo stesso modo si possono studiare anche le
irregolarità demografiche, a causa di guerre o altri fattori determinanti. Sono tuttavia
meno visibili i fenomeni migratori.
C. Evoluzione nella transizione demografica: la forma della piramide mostra la
popolazione a che punto di transizione demografica si trova. Si intende la grande
trasformazione nei comportamenti della popolazione, avvenuta nei paesi sviluppati
dal 700 e attualmente in corso nei paesi in via di sviluppo, che ha portato attraverso
una diminuzione della mortalità prima e della natalità poi, da livelli in equilibrio della
popolazione e molto elevati, ad equilibrio ma molto bassi. Le conseguenze di questo
fenomeno / processo si sono riversate nella struttura per età della popolazione (più
vecchia).
D. Contributo delle componenti: chiaramente visibile nella forma della piramide il
contributo di natalità, mortalità, migrazioni.
1.3.6 Altri caratteri
1.3.6.1 Stato coniugale
Di limitato interesse, se non è incrociato con sesso ed età delle persone. La
disponibilità di informazioni sullo stato coniugale incrociata con l’età ed il sesso,
consente di ottenere, età per età, la percentuale di celibi, coniugati, vedovi e per la
parte femminile. -> cx =Cx/Mx x 100
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: giacomo-giacomazzi-1 (giacomo.giacomazzi.1@studenti.unipd.it)
1.3.6.2 Caratteri socioeconomici e professionali
Per informazioni generali ottenute con censimenti, e per conseguente condizione
sociale
1.3.7 Strutture familiari
La classificazione presentata per famiglie, fa riferimento al nucleo; famiglie con
nucleo, senza nucleo, con più nuclei.
Classificazione proposta da Laslett nel 1972, che vede la distinzione delle famiglie
secondo la complessità della struttura:
- semplici
- allargate o estese
- multiple
1.3.8 Velocità di incremento della popolazione
1.3.8.1 Tasso aritmetico
Una prima idea di incremento è data dai numeri indice: per confrontare la variazione
di due grandezze, si guarda quanto sarebbero diventate se ciascuna fosse partita
dal valore 100. - vedi specchietto -
1.3.8.2 Tasso geometrico
Capitalizzazione composta nella quale l’interesse maturato alla fine di ogni anno,
viene aggiunto al capitale e produrrà in seguito altro interesse.
1.3.8.3 Tasso esponenziale
Nemmeno l’accumulo di capitale alla fine di ciascun anno corrisponde al reale
processo di aumento della popolazione. Si intende dunque una capitalizzazione nel
continuo - vedi specchietto -
1.3.8.4 Tasso di raddoppio
Tempo in anni per cui la popolazione aumenta, con una costante del tasso. Ha
senso usarlo in società in sviluppo.
1.4 Mortalità
1.4.1 Tassi di mortalità generici e specifici
1.5 Fecondità
1.6 Nuzialità
1.6.1 Introduzione: tassi generici e specifici
Lo studio della nuzialità per le popolazioni del passato è forse più importante delle
popolazioni odierne a causa del forte legame con la fecondità, dal momento che le
nascite avvenivano per la maggior parte nel matrimonio; per tale motivo a modelli
diversi di nuzialità possono conseguire diversi livelli di fecondità. Il binomio nuzialità-
fecondità è stato in molti paesi il maggior responsabile della dinamica della
popolazione prima della transizione demografica. La nuzialità fornisce interessanti
elementi conoscitivi degli usi locali delle società sull’organizzazione familiare, sulla
trasmissione delle proprietà, sui legami fra famiglie ecc.
La misura più generale del fenomeno, analoga ai corrispondenti tassi di natalità e
mortalità, è il tasso generico di nuzialità - vedi specchietto
Questo tasso tuttavia ci fornisce solo un’idea dell’ordine di grandezza della nuzialità,
da confrontare con gli altri tassi generici, o da esaminare nella successione
temporale. Per un esame più approfondito dei costumi nuziali siamo interessati alla
conoscenza di due elementi sintetici del modello matrimoniale:
- quanti uomini e quante donne arrivano a sposarsi
- quando si sposano (età)
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: giacomo-giacomazzi-1 (giacomo.giacomazzi.1@studenti.unipd.it)
Seguendo l’impostazione di seguire una coorte di nati, si osserva quanti matrimoni si
celebrano per ogni mille persone della coorte, e a quale età in media si sposano. Se
vi sono ulteriori informazioni sull’ordine del matrimonio, interessa sapere quante
persone della coorte arrivano prima o poi a sposarsi e quando lo fanno.
Tali misure si ottengono costruendo tassi specifici di nuzialità per età, distintamente
per maschi e femmine - vedi specchietto
La distinzione tra i due sessi è opportuna, in quanto le età e l’accesso al matrimonio
possono essere, e concretamente spesso sono molto diversi fra maschi e femmine.
I tassi per classi di età - vedi specchietto - ancora in analogia con quelli di fecondità,
non sono influenzati da fenomeni di disturbo (morte o migrazioni) per cui sono
perfettamente comparabili nel tempo e nello spazio con misure analoghe
Immaginando tassi di questo tipo costruiti per una generazione di donne, delle quali
seguiamo la nuzialità da quando iniziano a sposarsi in poi; questi tassi possono
essere elaborati in modo da portare a due informazioni sintetiche essenziali: il tasso
di nuzialità totale (TNT) e l’età media delle prime nozze.
TNT esprimerà il numero totale di matrimoni celebrati a 1000 donne della coorte nel
corso della vita. Più interessante è la stessa misura se conosciamo la distinzione fra
primi matrimoni e nozze successive, così da costruire tassi specifici sx solo per le
prime nozze.
L’età media delle prime nozze - vedi specchietto
Misure di contemporanei, ovvero riferite ad una coorte immaginaria formata dal
contributo di molteplici coorti, mostrano ancora una volta che l’artificio della coorte
fittizia è assai comodo perché consente di avere misure riferite a contemporanei ma
facilmente costruibili ed interpretabili.
1.6.2 Nuzialità da soli dati di tipo censuario
Dati di questo tipo non sono disponibili per epoche anteriori ai primi decenni del 900.
Lavorando con soli dati di censimento, Hajnal escogitò un modo per ricavare a certe
condizioni misure di nuzialità simili a queste: una che sia conto di quanti si sposano
almeno una volta e una che rappresenti quando si sposano (età media delle prime
nozze). Con questo metodo, ha individuato due modelli sostanzialmente diversi di
nuzialità in Europa:
- uno caratterizzato da matrimoni tardivi e nuzialità bassa, con elevata percentuale di
donne nubili, localizzato nell’ovest europeo (da Trieste in poi)
- l’altro ad est (da Trieste in là) e nell’Europa mediterranea, con matrimoni precoci;
anticipi o ritardi nell’età del matrimonio o le modalità di estensione del matrimonio,
possono avere conseguenze importanti sul numero finale di figli.
Procedimento e condizioni del metodo di Hajnal:
I rapporti più interessanti ai fini delle elaborazioni successive, delle informazioni sulla
popolazione classificata per sesso, età e stato coniugale erano le percentuali,
calcolate alle varie età, di celibi sui maschi e di nubili sulle femmine; es - vedi
specchietto -
Dalla percentuale di celibi o nubili calcolata per un’età oltre la quale il matrimonio
non è più numericamente rilevante, si potrà ricavare la quota di donne o uomini che
sono arrivati al matrimonio entro questa età, ovvero la quota finale di sposati.
Per ottenere una stima dell’età media al primo matrimonio, la procedura proposta da
Hajal considera ancora le percentuali di celibi per età, ma è più complessa. Devono
valere anche in questo caso le condizioni di nuzialità costante negli anni che
precedono il censimento, oltre che di pari influenza della mortalità e della
migratorietà su già sposati e mai sposati. Se la nuzialità, negli anni che precedono il
censimento, i dati che abbiamo a disposizione esprimono la nuzialità delle coorti e
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: giacomo-giacomazzi-1 (giacomo.giacomazzi.1@studenti.unipd.it)
dei contemporanei. è come se le percentuali dei celibi cx descrivessero la riduzione
di una coorte iniziale di 100 celibi a causa dell’uscita dal gruppo per matrimonio alle
varie successive età. L’età media alle prime nozze è pari al numero medio di anni
che chi si sposa rimane nel gruppo prima di uscire. La formula è la seguente - vedi
specchietto -
La logica è simile a quella seguita nelle tavole di mortalità per il calcolo della vita
media alla nascita.
L’età media al matrimonio calcolata in questo modo è nota con l’acronimo di SMAM,
Singulate Mean Age at Marriage.
Da ribadire la condizione di invariata della nuzialità negli anni che precedono la
rivelazione: se questa non sussiste, il risultato che si ottiene non è riferibile né ai
contemporanei, né alle coorti.
1.7 Migrazioni
1.7.1 Introduzione
La modesta quantità di lavori storico-demografici sulle migrazioni è motivata solo
dalla scarsa disponibilità di informazioni dirette su questo fenomeno. Sono carenti
fonti storiche su eventi di spostamenti nel territorio; si trovano in occasioni particolari
come in presenza di nuovi intensi flussi migratori a lunga distanza o in presenza di
provvedimenti volti a favorire il ripopolamento di città decimate da epidemie. A
parziale giustificazione della scarsità di informazioni, si può aggiungere che una
rivelazione completa ed affidabile è difficile anche ai nostri giorni, nonostante gli
strumenti oggi a disposizione.
Le migrazioni non sono di minor importanza rispetto a nascite, morti e matrimoni
nella dinamica delle popolazioni. La scarsità di informazioni non significa che il
fenomeno non esista; è raro che in una comunità gli spostamenti sul territorio siano
del tutto trascurabili. Nella maggior parte dei casi non ci sono informazioni sufficienti
a dare una descrizione compiuta dei vari spostamenti che avvengono; è però
possibile ricavare informazioni indirette da altri elementi noti.
Le migrazioni possono essere di vari tipi, classificabili secondo diversi criteri, come
l’ambito territoriale, il motivo, la durata.
Distinguiamo così le migrazioni con l’estero da quelle interne se lo spostamento
supera o meno il confine dello stato nazionale; il motivo è spesso di natura
economica, diretta o indiretta ma può essere anche di altro tipo, come gli
spostamenti forzati per motivi razziali, religiosi, militari, ecc. Secondo la durata, si
distinguono migrazioni temporanee o permanenti.
L’importanza della mobilità territoriale si comprende appieno se si considerano non
solo le cause ma anche le conseguenze, che sono di tipo demografico, economico,
sociale. Oltre alla dimensione dei flussi, sono interessanti le caratteristiche della
migratorietà, che riguardano aspetti geografici, legati ai luoghi di origine e di
destinazione dei flussi e alla loro distanza, e aspetti socio-demografici di chi si
sposta: età, sesso, stato civile, istruzione, stato professionale, famiglie.
1.7.2 Qualche misura da dati correnti
vedi specchietto
Spesso sono note di una popolazione l’ammontare e le variabili naturali, ma non
quelle migratorie.
vedi specchietto
1.7.2 Altre informazioni sulle migrazioni
Dati sulle sole immigrazioni possono essere ricavati dai censimenti, sfruttando la
semplice informazione sul luogo di nascita o sulla cittadinanza dei censiti, sempre
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: giacomo-giacomazzi-1 (giacomo.giacomazzi.1@studenti.unipd.it)
presenti nei censimenti moderni, raramente in quelli degli stati preunitari.
Con il luogo di nascita che con la cittadinanza è possibile rilevare spesso solo gli
stranieri della prima generazione, in quanto i figli, la seconda generazione, sono in
parte nati in suolo italiano o hanno acquistato la cittadinanza nel Paese ospitante.
L’uso di dati nominativi consente di avere indicazioni, dirette o indirette, sugli
spostamenti delle persone sul territorio. Nel confronto nominativo di due S.A.
successivi, la mancanza nel secondo di una persona, presente nel primo, può
essere attribuita a morte o ad un’uscita dalla famiglia per matrimonio o emigrazione.
Analogamente la presenza di una nuova persona può essere dovuta all’arrivo per
matrimonio, o per immigrazione isolata. La scomparsa di una famiglia da un
documento a quello successivo, può essere causata solo dall’emigrazione dell’intera
famiglia ed analogamente per la comparsa di una nuova famiglia nei documenti.
Informazioni indirette sulle migrazioni possono essere ricavate sfruttando
opportunamente fonti di altra natura; dalla provenienza di date persone, riportata su
documenti di battesimo o sepoltura. Inoltre negli atti di matrimonio, le parrocchie ove
ciascuno sposo ha abitato prima delle nozze, vengono riportate, per le pubblicazioni.
Esse forniscono informazioni sull’ultima migrazione, nel primo caso su tutti gli
spostamenti, dalla pubertà alle nozze nel secondo caso. Si hanno così elementi utili
per le direzioni e le frequenze dei flussi.
2. RICOSTRUZIONI NOMINATIVE
2.1 Ricostruzione delle famiglie
2.1.1 Tecniche nominative
Del Panta e Rettaroli definiscono le tecniche nominative come una categoria di
“modalità di impiego delle fonti storico-demografiche che hanno in comune una
rilevazione dei dati di tipo nominativo, ed il successivo uso di tali caratteri in funzione
della ricostruzione di vicende, situazioni o biografie individuali”. La rilevazione e
l’utilizzo sono nominativi, ma i dati finali con i quali verranno presentati i risultati della
ricerca sono in forma aggregata, analoghi quindi ai risultati dell’analisi tradizionale. In
questa categoria rientra la ricostruzione nominativa delle famiglia proposta da Louis
Henry a partire dagli anni 50 del 900.
Lo scopo degli studi di Henry era di trovare livelli e modalità della fecondità naturale,
o comunque delle popolazioni del passato, in periodo pre-transizionale: per questo
aveva rivolto l’attenzione in due direzioni:
- ricerca di popolazioni che ancora all’epoca non usassero contraccezione
- ricostruzione della fecondità naturale a partire da dati storici
Per la prima, aveva trovato e studiato la fecondità degli Hutteriti, popolazione di
origine europea (tirolese), emigrati negli Stati Uniti negli anni 70 dell’800 e poi in
Canada, che per motivi religiosi non pratica alcuna forma di contraccezione.
Per la seconda, Henry mise a punto un metodo, la ricostruzione nominativa delle
famiglie, con il quale è possibile, da soli dati di flusso, poveri di informazioni, dirette,
arrivare a misure estremamente precise su eventi della storia familiare, quale
matrimonio, nascita di figli, morte, ecc. L’accostamento di atti individuali nominativi
della stessa persona, consente di ottenere informazioni non presenti negli atti: età
alle nozze, età della madre al parto, la distanza tra le nascite, l’età alla morte dei
bambini, gli anni di esposizione al rischio di procreare, la fine del matrimonio per
morte di un coniuge, la durata della vedovanza, ecc. Il procedimento consiste nella
ricostruzione delle vicende di ciascun nucleo familiare e successivamente nel calcolo
di misure di fecondità, sia rispetto alle donne sposate che rispetto al matrimonio,
nonché di nuzialità e mortalità, simili a quelle ottenute da dati aggregati e spesso
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: giacomo-giacomazzi-1 (giacomo.giacomazzi.1@studenti.unipd.it)
anche più raffinate.
2.1.2 Procedura di ricostruzione
Si parte dalle registrazioni parrocchiali di battesimo, matrimonio, sepoltura riferite ad
un certo periodo in una o più parrocchie, o dai corrispondenti atti civili.
- Tutte le informazioni contenute in ciascun atto vanno riportate in un’apposita
scheda predisposta: di battesimo, matrimonio, sepoltura; inoltre la scheda di
matrimonio dovrà esser duplicata.
- Si mettono insieme poi le schede di battesimo, matrimonio, sepoltura, relative alla
stessa persona, a formare un dossier di persona sposata. Ci saranno anche
accostamenti di due soli atti della medesima persona, per mancanza di matrimonio o
per perdita di un atto. Resteranno inoltre schede sciolte, relative a figli illegittimi o
esposti, a nati poi deceduti in altra parrocchia, a persone sepolte ma proveniente da
fuori parrocchia, a matrimoni di individui dei quali non è stato possibile associare altri
eventi.
- Si associano poi ai dossier, anche incompleti, dei due coniugi di ogni matrimonio, i
dossier anche incompleti, ed eventualmente anche schede singole - di battesimo, di
matrimonio, di sepoltura - relativi ai figli nati dal matrimonio.
Si comprenderà come già a questo punto possano sorgere alcuni problemi. Uno sta
nel collegamento degli atti relativi alla stessa persona; un altro nell’attribuire i nati
alla coppia sposata. I nomi e i cognomi scritti negli atti possono essere imprecisi o
addirittura diversi nelle varie età della vita, per non parlare dei possibili soprannomi,
usati in luogo dei nomi e cognomi; ci possono essere omonimie o nomi ripetuti per
bambini, figli della stessa coppia. Per superare almeno in parte questi problemi, si
può adottare un certo protocollo nell’attribuire due atti allo stesso individuo, o i figli
alla coppia, ad esempio se sono soddisfatte certe condizioni come date compatibili o
simili.
L’uso del computer può aiutare nell’operazione di linkage degli atti, ma non molto nei
casi più difficili, per cui è preferibile l’accostamento manuale.
- Per ogni matrimonio si compila una scheda per ricostruirne la storia; questa viene
chiamata scheda di famiglia che si compone di tre sezioni:
prima è la parte superiore, dove si trascrivono nomi e cognomi e tutte le altre
indicazioni presenti nel dossier di ciascun coniuge
seconda è a destra della parte rimanente, e va riempita con le indicazioni dei figli
nati da questa coppia nell’ordine, uno per ciascuna riga
terza è in basso a sinistra, che verrà compilata alla fine insieme a qualche altra
casella rimasta vuota nelle precedenti sezioni.
Si prepareranno schede di famiglia anche per matrimoni per i quali le informazioni
non sono complete, mancando uno o entrambi gli atti di battesimo dei coniugi e/o
informazioni sui figli nati, e per matrimoni dei quali non vi è l’atto, ma di cui siamo
venuti a conoscenza solo dalla nascita di uno o più figli dalla stessa coppia; in
questo caso si conviene elencare i figli a partire dalla sesta riga, lasciando in bianco
le prime cinque ad indicare la mancanza di informazioni della parte iniziale della
storia familiare. Nell’inserimento dei figli nella scheda di famiglia si presume la
presenza continuativa della coppia nella parrocchia, fino all’ultimo evento riportato.
Si compilano infine alcune caselle rimaste vuote nella prima e seconda sezione,
soprattutto l’intera sezione inferiore sinistra della scheda di famiglia. Nella prima
sezione si inseriscono le età al matrimonio dei due sposi, ottenute dalla differenza
tra la data di matrimonio e quella di nascita, la loro età al decesso, la data di fine
osservazione e la conseguente durata del matrimonio, l’età alla fine
dell’osservazione e per i risposati, la durata della vedovanza. Nella seconda sezione
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: giacomo-giacomazzi-1 (giacomo.giacomazzi.1@studenti.unipd.it)
si inseriscono il sesso e l’ordine di nascita di ciascun figlio e le loro eventuali età alla
morte e al matrimonio. La terza sezione è la più importante perché da questa si
ricavano i dati per lo studio della fecondità sia della dona che del matrimonio. Per
ciascun figlio nato, andranno scritte prima, nella riga corrispondente, l’età della
madre al parto, la durata del matrimonio e l’intervallo dal nato precedente.
Successivamente andranno riepilogati nel riquadro età (della madre) e nel riquadro
unione quanti figli sono nati in ciascuna classe di età quinquennale, insieme agli anni
vissuti dalla donna in ciascuna classe d’età o di durata; infine nell’ultimo riquadro, il
riepilogo dei figli avuti secondo il sesso. Se la scheda di famiglia è incompleta, si
scriveranno le informazioni , età, durate ecc che è possibile ricavare. Si avranno così
schede di famiglia, completate con le informazioni aggiunte successivamente. Di
queste schede, alcune descrivono l’intera storia familiare, dal matrimonio alla morte
del primo coniuge, per altre la storia non è completa, mancando delle parti; per altre
ancora, si è potuto ricostruire solo un frammento centrale dell’intera vita familiare.
Il motivo delle mancanze si deve a vicende migratorie delle famiglie: se una si
sposta, cambiando parrocchia, gli eventi che pure continuano ad accadere non sono
più registrati nella nostra parrocchia e la storia della famiglia si perde. Come pure
per casi di ingressi dell’esterno: si ha notizia degli eventi che accadono dopo l’arrivo,
ma non sappiamo cosa sia accaduto precedentemente. Rientrano in queste
categorie:
- i matrimoni tra sposi di parrocchie diverse: nozze vengono celebrate e registrate
nella parrocchia della sposa, ma la nuova famiglia spesso va a vivere nella
parrocchia dello sposo. Negli atti della parrocchia della donna, avremo a
disposizione la sua nascita, il suo battesimo ed il suo matrimonio; dagli atti della
parrocchia dell’uomo invece, abbiamo i figli eventualmente nati dalla coppia e la
morte del primo coniuge, poi anche dell’altro ma non il matrimonio, né altre
informazioni sulla donna.
Terminato il lavoro di ricostruzioni delle vicende familiari, avremo a disposizione 4 tipi
di famiglie, classificate secondo le informazioni a nostra disposizione, dove: - m -
noto inizio matrimonio - f - fine osservazione - e - famiglia dall’estero - o - interpello
aperto di osservazione
MF sta a significare un tipo di famiglia di cui abbiamo la storia completa, dal
matrimonio alla morte del primo coniuge
del tipo MO abbiamo la parte iniziare del matrimonio, fino ad un dato punto
Di EF conosciamo in pezzo di vita famigliare a partire da un dato momento in poi,
fino alla fine
Del tipo EO conosciamo solo un frammento centrale ma né parte iniziale né finale
Inoltre i tipi MF e MO possono essere ulteriormente suddivisi in sottotipi, a seconda
che sia o meno nota la data di nascita della donna, segnato con N per nota, P per
presunta e Q per ignota.
La distinzione è importante perché la conoscenza di tale informazione, permette di
ottenere le età precise al matrimonio e alla nascita dei figli. La mancanza di tale dato
invece, non permette tali calcoli e le schede non saranno utilizzabili per ottenere
misure di fecondità per età della donna, ma solo per il calcolo di misure di fecondità
del matrimonio secondo la durata dell’unione.
Il successo della ricostruzione dipende dal numero di famiglie MF, in quanto da
queste è possibile ottenere tutte le informazioni sulla fecondità della donna e su
quella del matrimonio, anche se il lavoro ha portato anche ad altri tipi di famiglie
ricostruite. Indicatore di rendimento della ricostruzione, costruito con rapporto
percentuale fra famiglie di tipo MF e totale dei matrimoni celebrati nella parrocchia
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: giacomo-giacomazzi-1 (giacomo.giacomazzi.1@studenti.unipd.it)
nel periodo osservato
(M = MF + MO)
tasso di rendimento della ricostruzione : MF / M X 100
L’eventuale presenza degli Stati delle Anime, oltre ai tre registri parrocchiali, è
preziosa per il controllo e l’integrazione delle informazioni raccolte con la
ricostruzione. Il collegamento della famiglia ricostruita con quanto risulta dagli S.A.
consente di vedere la situazione e le variazioni. Con l’indicazione dei legami di
parentela, presenti negli S.A. si può vedere la composizione e la tipologia delle
famiglie, entro cui sono presenti i nuclei ricostruiti.
2.2 Risultati
2.2.1 Misure di fecondità
Successivamente alla ricostruzione delle storie familiari, i dati vengono riaggregati
per ottenere misure di fecondità femminile legittima, o di fecondità dei matrimoni, o
altre misure.
I risultati di ciascuna ricostruzione presente nella scheda di famiglia vengono riportati
in apposite tavole di spoglio, una riga per donna; occorre tuttavia tener distinte le
donne coniugate fin da giovani rispetto a donne sposate da più anziane.
Vengono trascritti i dati riepilogativi che erano stati inseriti nella terza sezione della
scheda di famiglia, nella parte età della donna: per ogni classe quinquennale di età
si trascrivono gli anni vissuti, che vengono chiamati anni-donna o donne-anno (DA),
ed i figli avuti nel quinquennio (N). Secondo le indicazioni di Henry, vengono
trascurate le unioni durate meno di 5 anni ed i nati nelle classi di età iniziate ma non
terminate per fine unione. Si calcolano quindi tassi di fecondità legittima per ogni
glasse di età della madre, rapportando i nati in ogni classe agli anni vissuti dalla
donna nella classe - vedi specchietto -
Un’altra misura di fecondità legittima è ottenibile dal rapporto, da calcolare per
ciascuna classe di età alle nozze, tra il totale dei nati e le donne sposate della
ricostruzione.
Da rilevare è il grande effetto della nuzialità sulla fecondità delle donne sposate: un
ritardo di 10 anni nell’età delle nozze fa sì che la fecondità quasi si dimezzi.
La fecondità legittima per età al parto e il numero medio di figli per matrimonio sono
le misure più frequentemente utilizzate per confrontare i risultati delle ricostruzioni
nominative.
2.2.2 Altri risultati di ricostruzioni nominative
Altri possibili risultati derivabili dalle ricostruzioni:
1. in tema di fecondità, sfruttando le schede di famiglia e il riquadro unione, si possono
costruire tassi di fecondità per durata del matrimonio rapportando i nati in ciascuna
classe di durata alle donne-anno della stessa durata;
2. ricavabili, l’età media della madre alla nascita dei figli, distinguendo l’ordine di
nascita e il caso particolare dell’età media alla nascita dell’ultimo figlio, che
rappresenta la fine della fecondità e anche della fase di espansione della famiglia; è
possibile il calcolo della distanza fra il matrimonio e la prima nascita, intervallo
protogenesico, e di quelle fra i nati successivi, intervalli intergenesici.
3. studio della nuzialità, nei tempi in cui si accede al primo matrimonio, nonché agli
eventuali matrimoni successivi; si può accedere dunque all’età media al primo
matrimonio ed in caso la durata ed esito della vedovanza.
4. altro settore di ricerca è la mortalità, dove lo studio della mortalità infantile e
giovanile risulta più facile rispetto a quella degli adulti, perché più dispersiva. Inoltre
sono possibili anche delle misure raffinate come il calcolo delle probabilità di morte e
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: giacomo-giacomazzi-1 (giacomo.giacomazzi.1@studenti.unipd.it)
la creazione successiva di apposite tavole di mortalità, limitate ai primi 10 o 15 anni
di vita dell’individuo.
2.2.3 Osservazioni conclusive
La ricostruzione nominativa delle famiglie è un lavoro pesante che però porta a
risultati di estremo interesse, ottenuto tuttavia su un numero ridotto di casi.
Il problema: è la reale rappresentatività delle famiglie ricostruite. Si ha motivo di
ritenere che le famiglie di cui è stato possibile ricostruire l’intera storia familiare, non
siano rappresentative di tutte le famiglie; non sono dunque equiparabili a un
campione statisticamente rappresentativo rispetto all’intera popolazione. I timori si
indirizzano in tre direzioni:
1. rappresentatività della popolazione della zona esaminata rispetto a un territorio più
ampio
2. rappresentatività delle famiglie ricostruite rispetto a tutte le famiglie della zona
3. rappresentatività dei risultati ottenuti a causa della scarsa numerosità
Per quanto riguarda 1., le comunità di cui è stata fatta la ricostruzione sono poche e
sono scelte sul territorio in modo non casuale; per il punto 2. le famiglie ricostruite
sono selezionate rispetto al totale delle famiglie della zona, in quanto nel tipo MF
sono maggiormente rappresentate le famiglie sedentarie, rispetto a quelle mobili,
delle quali non è possibile avere la storia completa. è ragionevole ritenere che le
famiglie più sedentarie abbiano caratteristiche diverse dalle altre più mobili. Per il
punto 3. la bassa numerosità è una caratteristica del metodo, difficilmente
superabile.
La presenza degli S.A. nell’archivio parrocchiale consente di controllare se la
ricostruzione delle famiglie è uguale a quella che il parroco trovava ogni anno;
consente inoltre di seguire anche l’evoluzione delle forme familiari, così come
cambiano in alcune occasioni tipiche, come matrimoni di figli ecc. Questo costituisce
cinque un elemento importante di conoscenza che si aggiunge alle consuete
indicazioni di fecondità delle coppie.
2.3 Altri sviluppi
Sono da rilevare altri due aspetti:
- possibili indagini nominative mirate per uno scopo ben preciso, che non richiede la
trascrizione di tutti gli atti parrocchiali,ma solo una parte di essi
- ricostruzioni nominative sono usate per avere anche dati individuali su cui lavorare
con modelli e tecniche di analisi statistica multivariata di storia evenemenziale
3. COMPLEMENTI
3.1 Aspetti generali
3.1.1 Esame di serie storiche
Dati di stato: prevalentemente di origine civile, sono senza regolarità o cadenza
precisa; questo causa seri problemi di omogeneità delle informazioni, per quanto
riguarda il motivo della raccolta dei dati, le modalità seguite nella raccolta e l’ambito
territoriale di riferimento.
Dati di movimento naturale: sono frequenti come disponibilità di serie storiche di
eventi naturali da fonti civili o registrazioni parrocchiali.
In entrambi i casi è utile un’analisi preventiva dei dati
3.1.2 Stagionalità degli eventi
è rilevante il tempo dell’anno in cui avvengono i movimenti naturali; nei registri
parrocchiali la data di registrazione è uno degli elementi più sicuri in quanto ad essa
corrisponde la data dell’evento. La distribuzione degli eventi secondo il mese in cui
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: giacomo-giacomazzi-1 (giacomo.giacomazzi.1@studenti.unipd.it)
essi accadono può essere utile per ricavare informazioni sulla vita quotidiana, che
sono diverse a seconda dell’evento in esame. Per il matrimonio sono determinanti
l’osservanza del calendario liturgico e gli usi locali, spesso influenzati dall’economia
prevalente. Può essere la causa di morte a determinare la stagionalità dei decessi;
per le nascite concorrono fattori biologici tra cui il regime alimentare e alcuni fattori
sociali. In presenza di eventi eccezionali vengono ovviamente sconvolti i ritmi
stagionali della vita ed occorre allora esaminare caso per caso. Non è opportuno
vedere la stagionalità in singoli anni ma bisogna prendere in esame periodi più ampi.
Prima di esaminare i vari eventi in base al mese di accadimento, occorre procedere
a una correzione dei dati influenzati dalla diversa lunghezza dei mesi. Occorre quindi
ridurre le frequenze a mesi di uguale lunghezza e riportarle ad una misura tale che le
differenze fra mesi siano facilmente leggibili.
3.1.3 Standardizzazione indiretta
Un metodo per confrontare tassi di popolazioni diversi era quello chiamato della
popolazione tipo, o standardizzazione diretta. Per questa, servivano tassi per età di
due popolazioni e la struttura di una terza popolazione, per costruite dei tassi medi,
con un’unica struttura per età. Conoscendo la struttura per età di una popolazione e
dei decessi solo il totale, è comunque possibile costruire il tasso generico e si può
procedere ad un confronto con una situazione assunta come standard, ed il metodo
diviene dunque di standardizzazione indiretta. Si tratta di confrontare i decessi M
osservati nella popolazione, dei quali è noto solo il totale, frutto però di una mortalità
per età mx ignota, sulla popolazione Px. Ne risulta - vedi specchietto -
3.2 Fecondità
3.2.1 Numero medio di figli per matrimonio
1. Misure di fecondità delle donne, le più frequenti misure di fecondità, i tassi
specifici di fecondità per età, si costruiscono con dati correnti sulle nascite e con dati
sulla popolazione femminile: vedi specchietto
informazioni sulle nascite per età della madre non sono disponibili in Italia prima del
1930 ed anche i dati sulla popolazione per età sono noti fino a gran parte del XX
secolo solo dai censimenti. Le fonti storiche tradizionali, religiose e civili sono ricche
di dati di movimento: è frequente dunque trovare serie storiche, anche lunghe, di
nascite e di matrimoni. Con questi soli dati è possibile giungere, sotto alcune
condizioni a buone misure di fecondità, riferite ai matrimoni
Misure di fecondità dei matrimoni, disponendo delle nascite legittime
classificate secondo l’anno del matrimonio, è possibile costruire per un qualunque
anno t, tassi specifici di fecondità legittima per durata del matrimonio: vedi
specchietto
L’informazione sull’anno del matrimonio da cui provengono le nascite non è
disponibile fino al 1930; Gini propose un’altro metodo
Numero medio di figli per matrimonio, metodo di Gini, si può mostrare che il
numero medio di figli per matrimonio si può scrivere: vedi specchietto
Il numero medio di figli per matrimonio relativo ad un dato anno si può ottenere
anche dal rapporto tra i nati legittimi dell’anno e una media ponderata dei matrimoni
dai quali essi provengono. La media è ponderata secondo il contributo di ciascuna
annata di matrimoni alla fecondità dell’anno: contributo che sarà alto per i matrimoni
più recenti e sarà via via più basso quanto più i matrimoni sono anziani. I pesi da
usare per questa media non sono evidentemente disponibili. Gini suggeriva di usare
come pesi pi quelli di una situazione nota presumibilmente simile: quella di un altro
anno o di una popolazione diversa.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: giacomo-giacomazzi-1 (giacomo.giacomazzi.1@studenti.unipd.it)
Non è il semplice rapporto tra le nascite legittime di un anno ed i matrimoni dello
stesso anno o di anni prima. Si usa dunque un numero di matrimoni che Gini ha
chiamato virtuale, essendo ottenuto con il concorso di tutti i matrimoni che hanno
dato luogo a figli di quell’anno; solo i pesi per farne la media sono presi a prestito da
un’altra popolazione.
L’applicazione di questo metodo a dati storici è quanto mai opportuna; i problemi
sono la disponibilità dei pesi pi e l’adattabilità alle specifiche situazioni.
Il calcolo di tassi di fecondità dei matrimoni secondo la loro durata, ottenuto da
ricostruzioni nominative per la stessa epoca, fornisce informazioni sufficienti. Prima
della transizione demografica, in tempi normali le variazioni della fecondità secondo
la durata del matrimonio sono di scarsa rilevanza. La distribuzione più usata è quella
trovata a Fiesole tra i matrimoni celebrati nel periodo 1630-1680. Quando ha inizio
un qualche controllo delle nascite, occorre far ricorso al altre distribuzioni. Nella
stima della fecondità delle donne italiane, Livi Bacci ha usato per il periodo tra le due
guerre mondiali quella che Gini aveva trovato per il 1927, mentre per il periodo della
Seconda guerra agli anni Sessanta una distribuzione calcolata per il 1963. Questi
modelli hanno fecondità via via maggiore nei primi anni di matrimonio e più bassa in
quelli più lontani.
1. Le condizioni che i manuali riportano per una corretta applicazione del metodo sono:
2. l’invarianza nella frequenza della rottura di matrimoni e nella migratorie
3. l’invarianza nei tempi della nuzialità
4. l’invarianza nella distribuzione della fecondità matrimoniale
5. Più difficile è giudicare se le condizioni di disturbo quali guerre, epidemie e carestie,
che si verificano in certi periodi, non possano alterare le normali condizioni di
mortalità, nuzialità e fecondità.
6. - esempio - Parrocchie nei pressi di Venezia nel XVII e XVIII secolo - si vede che chi
viveva dei prodotti della pesca aveva fecondità più alta rispetto a chi viveva di
agricoltura ma mai come artigianato -
7. 3.2.2 Stima del Tasso di Fecondità Totale, metodo della media ponderata
8. Il TFT, si può ottenere anche senza avere le nascite distinte per età della madre.
vedi specchietto -
9. 3.2.3 Stima del Tasso di Fecondità Totale dal tasso di fecondità generale
10. Se disponibili informazioni sulle nascite e sulla popolazione femminile in età 15-49, è
possibile costruire un tasso di fecondità generale per mille donne all’anno, in età
fertile. Il tasso è meno comprensibile del TFT, si ipotizza : - vedi specchietto -
11. L’ipotesi di equidistribuzione delle donne nella fascia d’età 15-49 può essere
accettabile in condizioni di scarsa variabilità delle nascite da 15 a 50 anni prima, e di
bassa mortalità.
12. 3.2.4 Metodo dei figli propri
13. Metodo pensato per Paesi in via di sviluppo, tipicamente con statistiche correnti di
scarsa qualità, ma con buone rilevazioni censuarie.
14. Occorre disporre di dati di censimento individuali, con l’indicazione di sesso, età e
relazioni di parentela con il capo famiglia. Le fonti storiche di stato sono: liste, di
origine religiosa o civile, di persone, organizzate per famiglie.
15. Il metodo consiste nell’appaiare ad ogni persona di età inferiore ai 10 o 15 anni una
donna che, in base a compatibili relazioni di parentela ed età, ne sia
presumibilmente la madre.
16. Ripetendo questo procedimento per tutte le famiglie, si potranno avere figli
classificati per età ed età della madre. I bambini in età 0 anni, avranno madri in età
da 15 a 49, quelli in età 1, da 16 a 50 e così via.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: giacomo-giacomazzi-1 (giacomo.giacomazzi.1@studenti.unipd.it)
17. Ci saranno poi figli non disposti secondo la tabella organizzata, non associati ad una
madre.
18. Si potranno rapportare per ciascun anno di nascita dei figli, figli a donne, età per età.
Questi rapporti non sono tassi di fecondità, che tuttavia si posano ottenere - vedi
specchietto -
19. La migratorietà non dovrebbe influire molto sui risultati, come pure la concentrazione
sulle età tonde.
20. 3.2.5 Indici di Coale
21. Progetto di Princeton, sul declino della fecondità in Europa, 1964, negli Stati Uniti,
diretto da Coale, si è prospettata la necessità di costruire, con dati forniti da sistemi
statistici dell’epoca, indicatori efficaci, relativi a periodi relativamente estesi e
confrontabili tra i Paesi oggetto di studio. Caratteristiche di queste epoche sono la
disponibilità di buoni dati di stato, che forniscono informazioni su sesso, età e stato
coniugale della popolazione, anche disaggregate territorialmente, ma scarsi dettagli
sulle nascite, dal momento che altre informazioni non sono disponibili, essendo
raccolte e pubblicate nel corso del Novecento.
22. Il progetto di Princeton mirava a ottenere misure che:
23. a. descrivessero la fecondità di una popolazione rispetto ad un massimo empirico
possibile
24. b. rendessero minima l’influenza della struttura per età
25. c. fosse possibile scomporre la fecondità generale tra legittima, illegittima e
proporzionale delle coniugate.
26. Come Henry, scelse la popolazione degli Hutteriti + vedi specchietto
27.
28. 3.3 Mortalità
29. 3.3.1 Decessi per età
30. Misure corrette di mortalità si ottengono solo con tassi specifici, costruiti con dati sui
decessi per età e sulla popolazione per età. Sono note per lunghi periodi, molte
informazioni sui decessi, ma molto men note sono le informazioni sulla popolazione.
31. Distribuzione percentuale dei decessi per classi di età: la classificazione delle età di
morte adottata è non convenzionale; nella distribuzione percentuale dei morti
influisce la struttura per età delle popolazioni da cui provengono e talvolta con questi
calcoli si possono rilevare problemi di rilevazione passati.
32. 3.3.2 Tavole di mortalità da soli dati sui decessi
33. Per costruire tavole di mortalità servono informazioni sia sui decessi per età che
sulla popolazione per età, da cui questi provengono. Con questi dati è possibile
ricavare tassi di mortalità per età e probabilità di morte.
34. Frequente è avere la disponibilità di dati sui morti per età, ma nessuna informazione
sulla popolazione. In queste situazioni viene in aiuto il metodo dei decessi, messo a
punto da Halley. Si ipotizzava una popolazione stazionaria; il metodo può essere
esteso a popolazioni stabili
35. La popolazione stazionaria, viene originata da un flusso costante di nascite, che si
estingue età per età secondo la legge di mortalità della tavola, per cui il totale delle
nascite è pari ogni anno al totale dei decessi. Queste condizioni difficilmente si
trovano nella realtà.
36. Appare tuttavia poco plausibile l’ipotesi di una popolazione stazionaria, con tasso di
incremento pari a zero.
37. Con popolazione stabile, si ha un tasso di incremento r, cui segue la medesima
variazione delle nascite.
38. Se la popolazione ha un tasso di incremento positivo, il metodo originario sottostima
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: giacomo-giacomazzi-1 (giacomo.giacomazzi.1@studenti.unipd.it)
e0; avverrebbe una sovrastima nel caso di incremento negativo della popolazione.
39. 3.3.3 Tavole tipo di mortalità
40. Con i dati di popolazioni storiche usualmente a disposizione, ci si trova davanti ad
informazioni frammentarie sulla mortalità, limitate ad età di infanti o giovani e dati
mancanti o di scarsa qualità per altre età. Lo stesso per i demografi del 900 con
l’esame delle popolazioni dei paesi meno sviluppati. Un modo per studiare la
mortalità in queste condizioni fu quello di trovare modelli teorici di mortalità per età,
in modo da poter risalire, da poche informazioni, alla serie completa.
41. Esiste un legame tra il livello di mortalità ad un’età x e il livello ad un’altra età x+n; è
un legame non rigido, che se è alto nel primo caso, lo sarà anche nel secondo e
viceversa.
42. Questo è quanto fecero gli studiosi delle N.U. nel 1955, quando disponendo di 158
tavole di mortalità, trovarono legami tra probabilità di morte di età successive. da 5q0
a 5q80, tenendo in considerazione classi quinquennali, presentarono 24 tavole, a
sessi separati, corrispondenti ad e0 da 20 a 75 anni.
43. Queste tavole sono ricordate per il loro valore storico, in quanto si capì che erano
caratterizzate da alcuni inconvenienti. Coale e Demeny pubblicarono le loro
Regional Model Life Tables, che superavano i difetti presenti nelle tavole precedenti,
che erano:
44. - basso numero di tavole di partenza
45. - meccanismo di concatenazione nella costruzione delle 5qx
46. - insufficienza ddi una sola informazione che determina solo il livello di mortalità e
non la forma di questa
47. Partendo dunque da 326 tavole di tutto il mondo, essi individuarono prima gruppi
omogenei di tavole, osservando differenze simili delle probabilità 5qx rispetto ad un
profilo 5qx mediano. Con questa fase, si poterono eliminare tavole che mostravano
differenze anomale e inspiegabili; con le tavole rimaste furono definiti tre tipi/famiglie
di mortalità, Nord, Sud, Est, per origine delle tavole.
48. Nord: bassa mortalità in età infantile e oltre i 40 anni - 9 tavole
49. Sud: bassa mortalità tra 30 e 60 anni e alta altrove - 22 tavole
50. Est: mortalità alta nelle prime età e oltre i 50 anni - 31 tavole
51. Tavole rimanenti 130, rientrano nell’Ovest, di paesi extraeuropei, che non
presentavano un profilo ben definito
52. Per ogni regione, sono state costruite 25 tavole tipo, mediante 2 equazioni che
esprimono le probabilità di morte quinquennali 5qx, in funzione della vita media
all’età 10 + creazione di tavole di probabilità di morte femminile e maschile
53. + scelta di parametro di partenza e10 dettato dalla necessità di non legarsi alla
mortalità infantile, che potrebbe essere aleatoria e meno legata alla mortalità
generale, e di non ricorrere a stime concatenate.
54. Coale e Demeny hanno pubblicato per ciascuna regione la tavole, M e F, dei vari
livelli, riportando le note funzioni: qx, dx, lx Lx, TX, ex.
55. Diversi studiosi hanno presentato successivamente altre tavole tipo, costruite in
modo diverso ma sempre a partire da dati empirici. Si stacca da questi il metodo
Brass, che sfrutta una relazione fra funzioni biometriche di tavole di mortalità
diverse. Dato un modello di mortalità standard, si sfrutta una relazione tra le due
serie di qx, quella standard e quella di una qualsiasi popolazione; la relazione è
espressa da due parametri, che esprimono il livello e l’inclinazione. I due parametri si
stimano attraverso le informazioni note sulla popolazione di riferimento.
56. Sono le tavole più utilizzate, perché associati modelli di popolazione stabili. Una
popolazione stabile era presa come standard per le quattro tavole di mortalità.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: giacomo-giacomazzi-1 (giacomo.giacomazzi.1@studenti.unipd.it)
Tuttavia è importante riflettere sull’uso di tavole tipo di mortalità con dati storici.
57. Santini osserva che il loro adattamento anche alla mortalità di epoche precedenti
mostra risultati a volte soddisfacenti, a volte meno. è difficile disporre di buone tavole
di mortalità per popolazioni del passato, per poter confrontare la mortalità reale con
quella descritta dalle tavole e poter dare giudizio sulla bontà dell’adattamento.
L’adattamento sembra migliore, in linea di massima, quando si dispone di due
parametri di ingresso (e10).
58. Secondo Del Panta e Rettaroli, mancano tavole tipo specifiche per la mortalità del
passato.
59. L’Inverse projection differenziata (IPD), supera problematiche delle tavole; usando
nell’input del modello IPD classi di età dei decessi, anche se ampie, consente di
individuare livelli diversi di mortalità per le varie classi.
60. 3.3.4 Crisi di mortalità
61. Prima della transizione demografica erano frequenti in tutte le popolazioni, punte
improvvise di mortalità, che facevano aumentare il numero di decessi - crisi di
mortalità - con conseguenze gravi.
62. Definizione: brusco e violento rialzo della mortalità provocato da una causa non
normalmente presente nella popolazione
63. Gli effetti della crisi andranno valutati esaminando la dinamica dei decessi, dei
matrimoni e delle nascite, e non limitatamente al periodo di crisi. La gravità di
questa, sarà misurata tenendo conto di tutto: incidenza della mortalità e capacità di
recupero.
64. Occorrerà tener conto dei dati normalmente disponibili; la disponibilità delle serie
storiche di battesimi, matrimoni e sepolture nei registri parrocchiali facilita la misure
delle crisi. Non è raro che il decesso del parroco, faccia cessare le registrazioni.
65. Il primo indizio diurna crisi imminente è l’aumento dei decessi, che crescono fino a
raggiungere il massimo, per poi diminuire, sia per l’attenuarsi della mortalità, che per
la diminuzione della popolazione. Cala inoltre il numero dei matrimoni e diminuisce il
numero delle nascite. Alla fine della crisi di mortalità, la popolazione sarà diminuita
ma le famiglie ricominceranno ad avere figli e molti vedovi e vedove si risposeranno.
Si aggiunge talvolta la migrazione, dapprima in uscita, poi in entrata.
66. In generale una popolazione, se può, reagisce alla crisi facendo ricorso a mezzi che
facilitano l’incremento delle nascite, anticipando l’età del matrimonio, ridurre il tempo
di allattamento per ridurre l’intervallo fra le nascite.
67. Per valutare intensità di una crisi di mortalità:
68. bisogna determinare il numero normale di decessi, facendo ricorso a medie mobili -
medie mobili a 11 termini, censurate dei due termini più alti e più bassi - senza tener
in considerazione dell’anno della crisi o due anni - vedi specchietto
69. Il ricorso al modello di popolazione stabile, nella valutazione dell’entità delle
differenze, ha come obiettivo la comprensione delle capacità di recupero riproduttivo.
Se non vi riesce facendo ricorso a tutti i mezzi a disposizione, la crisi è da
considerare particolarmente grave.
70. - piccola crisi: 50% in più di decessi
71. - grande crisi: 300% in più di decessi
72. Inoltre, la mortalità per una causa è la frequenza dei decessi per quella causa, diviso
gli abitanti, rapportato ad un anno.
73. La morbilità è la frequenza degli ammalati per quella causa; la letalità è la frequenza
dei deceduti per quella causa sugli ammalati. Entrambe le misure non sono ricavabili
da dati parrocchiali; è più facile ricavarli da dati su ricoveri e decessi in ospedali o
lazzaretti
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: giacomo-giacomazzi-1 (giacomo.giacomazzi.1@studenti.unipd.it)
74.
75. 3.4 Analisi paleodemografica e indice d
76. 3.4.1 Analisi paleodemografica
77. Molte società del passato non dispongono di fonti scritte che permettano di far luce
sulle dinamiche demografiche. Nel mondo cristiano, solo successivamente al
Concilio di Trento e con l’introduzione di registri ecclesiastici, si iniziano ad avere
informazioni sulla vita di individui, famiglie e comunità, che possono essere
ricostruite con precisione. Per il periodo precedente invece, ci sono solo fonti fiscali o
sanitarie sporadiche, che possono fornire indizi sulle dinamiche di popolazione nel
passato, permettendo di ricostruire la mortalità, la fecondità e le strutture familiari per
periodi e luoghi limitati.
78. A causa della scarsità di fonti scritte, l’archeologia ha iniziato a giocare un ruolo
sempre più importante per la compressione delle dinamiche demografiche del
passato: il variare nel tempo delle dimensioni degli insediamenti e degli edifici
pubblici e le oscillazioni della produzione di alcuni manufatti, possono esser letti
come indici di accrescimento o diminuzione della popolazione. Per le epoche
preistoriche, prive di fonti scritte, l’archeologia è l’unica disciplina che può offrire
spunti sugli andamenti demografici.
79. I primi studi in chiave demografica dei reperti ossei furono avviati negli anni 40,
grazie a L. Angel; dagli anni 70 l’analisi paleodemografica comincia a diffondersi,
grazie alla messa a punto di nuovi metodi di analisi antropologica degli scheletri, che
hanno permesso di meglio definire con maggior precisione sesso ed età di morte
degli individui. Questi studi si arrestarono però negli anni 80, quando iniziò un certo
scetticismo nell’uso della necropoli come fonte per lo studio delle dinamiche
demografiche del passato.
80. 3.4.2 Indice d
81. Le critiche sollevate furono che l’età di morte degli adulti è difficilmente definibile con
precisione sulla base dell’osservazione delle ossa + mancanza di piccoli scheletri —
> mortalità giovanile risulta sottostimata.
82. Bocquet-Appel e Naji hanno testato un metodo per stimare i trend di mortalità
usando campioni scheletrici provenienti da necropoli preistoriche (2006). Questo
metodo propone di calcolare un indice d, dato dal rapporto tra il numero di individui
morti in età 5-19 (D5-19) e quelli di età 5 e più (D5+), ossia d= D5-19 / D5+
83. L’indice si basa sulla numerosità della classe di età 5-19 che è quella meglio
stimabile con i corretti metodi di analisi antropologica, escludendo gli individui di età
0-5 scarsamente rappresentati nelle necropoli.
84. Questo rapporto risulta utile se applicato a un esteso campione di individui e di
necropoli in modo da rilevare eventuali trasformazioni di lungo periodo. Se d cresce,
ciò significa che la proporzione di individui che muoiono tra i 5 e i 19 anni aumenta.
Ciò può essere connesso sia ad un aumento della mortalità che ad un aumento della
fecondità.
85. Il significato di d può variare in tre modi significativi:
86. - se la popolazione è stazionaria l’indice d corrisponde alla probabilità di morire fra il
quinto ed il ventesimo anno di età, perché D5+ corrisponde ai sopravviventi all’età
esatta di 5 della popolazione stazionaria associata alla tavola di eliminazione. Al
crescere di d la mortalità è più intensa, essendo le morti precoci più numerose
rispetto a quelle degli adulti e degli anziani
87. - in una popolazione affetta da ricorrenti crisi di mortalità, d potrebbe essere elevato
88. - in una popolazione in crescita, d aumenta perché le nascite superano i decessi e le
classi di età giovani diventano più numerose; in una popolazione in declino, d
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: giacomo-giacomazzi-1 (giacomo.giacomazzi.1@studenti.unipd.it)
tenderà a diminuire. Ciò accade se tasso di crescita o decrescita è almeno dell’1%.
89. I paleodemografi sono concordi nel ritenere che le popolazioni pre-industriali fossero
stazionarie nel lungo periodo, malgrado le frequenti oscillazioni, visibili nel breve
periodo. Nascite e morti si sarebbero così bilanciate e la struttura della popolazione
sarebbe rimasta costante. Le oscillazioni dell’indice d, che riflette la proporzione di
morti in età giovanile, possono essere collegate, usando le tavole di Coale e
Demeny, al variare di diversi parametri di mortalità.
90. 3.4.3 Un’applicazione
91. Caso della popolazione italiana tra I e XVII secolo d.c., 43 siti, 5506 individui di età
maggiore ai 5 anni. Per ogni macro periodo si dispone di almeno 1200 individui.
92. Dal campione studiato emerge che il valore d, è relativamente contenuto fra il I e il
IV secolo, più elevato nei 3 secoli successivi, mentre fra il IX e il XIII secolo ritorna ai
più bassi livelli caratteristici dell’impero romano. Nei 3 secoli della peste il valore di d
è molto più elevato. Si nota dunque un innalzamento dell’indice di concomitanza con
periodi caratterizzati da crisi di mortalità.
93. Sono valori da prendere con cautela, a causa di problemi insiti nell’uso di d come
unico indice della mortalità. Potrebbero darsi condizioni con mortalità infantile molto
elevata ma giovanile contenuta, e viceversa. In questo caso, l’indicatore d potrebbe
sottostimare l’intensità della mortalità.
94. L’andamento di d, è speculare rispetto a quello della popolazione: quando d cresce,
la popolazione diminuisce e viceversa. Il periodo successivo alla peste nera è
caratterizzato da necropoli con alti valori di d che si protrassero per diversi secoli.
95. Gli elevati valori di d in questo periodo sembrerebbero riflettere gli andamenti tipici di
una lunga crisi di mortalità innescati dalla peste e caratterizzati da fasi alterne di
elevata mortalità, seguiti da periodi di elevata natalità.
96. L’indice d sembra funzionare, offrendo spunti molto utili per comprendere alcuni
aspetti relativi alle dinamiche di popolazione del passato, soprattutto in periodi in cui
le fonti scritte sono carenti.
97.
98. 4. RICOSTRUZIONI AGGREGATIVE
99. 4.1 Introduzione - letta solo
100. 4.2 Ricostruzione per generazioni
101. 4.2.1 Procedura
102. Metodo usato da Bourgeois-Pichat per ricostruire la popolazione della Francia nel
700, è stato poi poco usato a causa della grande quantità di dati necessari per la sua
applicazione. Un vantaggio del metodo è che esso necessita soltanto di informazioni
sui decessi per età; un inconveniente è che ha bisogno di serie storiche lunghe,
almeno 100 anni. Se in più si possiedono dati sulle nascite, si può anche verificare
entità e direzione di eventuali flussi migratori.
103. Occorre partire da serie storiche di decessi per età Mx, disponibili per almeno 100
anni. Si può allora seguire ogni generazione di nati, osservandone i decessi età per
età fino alla loro estinzione, che supponiamo si attorno ai 100 anni.
104. La somma dei decessi di una generazione, età per età, da 0 a 99 anni, è pari in
assenza di migrazioni, ai nati N della generazione; ovvero per ogni coorte si ha -
vedi specchietto -
105. Seguendo la generazione, si possono calcolare i sopravviventi Sx ad ogni
compleanno x, sottraendo via via ai nati i morti alle età successive Mx. N - M0 = S1;
S1 - M1 = S2 —> Sx - Mx = S x+1
106. Sempre nella generazione, si può ottenere il numero medio dei viventi a ogni età x
(Px), calcolando la media dei sopravviventi nei due compleanni successivi x e x+1 —
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: giacomo-giacomazzi-1 (giacomo.giacomazzi.1@studenti.unipd.it)
> (Sx + Sx+1)/2 = Px
107. Fatto questo per tutte le generazioni, riaggregando i viventi P0, P1,P2, .. nello
stesso anno di calendario si ha la popolazione vivente media nell’anno, sia in totale
che età per età.
108. 4.2.2 Un esempio
109. Le classi di età decennali sono meno affidabili a causa della nota imprecisione delle
età negli atti di sepoltura; le generazioni che si seguono sono gruppi di 10 coorti,
nate in 10 anni adiacenti.
110. Dai nati delle coorti si ottengono, sottraendo via via i decessi nelle successive classi
di età, i sopravviventi all’inizio di ogni classe. Nella parte inferiore della tabella sono
state trascritte le cifre di sopravviventi per i tre gruppi di coorti ricostruite.
111. Si vedono poi i viventi in media in ciascuna classe d’età; questi sono ottenuti dalla
media dei sopravviventi all’inizio e alla fine di ciascuna classe, e come nell’altra
tabella, ci sono riportati i viventi in media nei 3 gruppi di coorti, in basso.
112. Idem per i viventi in media nelle classi decennali di età e in totale
113. 4.2.3 Osservazioni
114. Il procedimento illustrato è laborioso, ma non complicato; segue una logica
comprensibile se si pensa al processo di estinzione delle generazioni di nati.
115. Risultati apprezzabili si hanno solo le la qualità dei dati sui decessi è abbastanza
buona, in termini di completezza e di esattezza delle età; per quanto riguarda la
precisione dell’età di morte, è nota la propensione a dichiarare età approssimate alla
cifra tonda più vicina o più alta per gli anziani. Per questo è preferibile lavorare con
dati storici, usando classi quinquennali di età o decennali, e conseguentemente con
periodi di 5 o 10 anni.
116. Una condizione che era stata introdotta nella procedura era l’assenza di migrazioni.
Tuttavia questo limite può esser rimosso se si dispone della serie delle nascite. La
somma dei decessi della coorte dà il numero presunto dei nati, ma solo se abbiamo
a disposizione il vero numero dei nati, il confronto tra le due cifre ci po’ dare una
buona stima degli eventuali saldi migratori della generazioni.
117. Tuttavia non ci sono stime per l’ultimo centinaio di anni usando questo metodo; limite
al quale si può rimediare nel caso di un censimento alla fine del periodo osservato.
Si può ricorrere al tentativo di ridurre il periodo finale non coperto dalla ricostruzione.
118. Avendo stimato la popolazione classificata per età, in un certo numero di anni, è
possibile ora ottenere varie misure utili per informazioni più precise e più dettagliate.
119.
120. 4.3. Inverse projection
121. 4.3.1 Ricostruzione con I.P
122. Consente la ricostruzione in modo aggregato della popolazione per età e dei
principali parametri della popolazione, utilizzando solo le serie storiche di nascite e
decessi, oltre ad una popolazione iniziale per età. Esistono programmi informatici i
quali, dopo l’inserimento dei dati di partenza, forniscono popolazione per età, vita
media alla nascita, tasso di fecondità totale ed eventuali altri parametri da questi
derivati.
123. Il nome inverse projection deriva dal fatto che si tratta di proiezioni in cui l’inversione
è logica, non temporale; nella I.P con la popolazione iniziale per età, con nascite e
decessi, si vuole ottenere tassi di fecondità e probabilità di sopravvivenza.
124. 4.3.2 Procedura della I.P
125. Idea: individuare le variabili dinamiche (fecondità e mortalità) che hanno generato in
una popolazione le serie temporali di nascite e decessi osservate in un dato periodo.
Occorre conoscere una popolazione iniziale classificata per età e disporre di tavole
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: giacomo-giacomazzi-1 (giacomo.giacomazzi.1@studenti.unipd.it)
tipo di mortalità e modelli standard di fecondità.
126. In una popolazione in cui non ci siano migrazioni, la popolazione di ogni anno è data
da quella dell’anno precedente cui siano aggiunte le nascite e sottratti i decessi.
127. Il problema è determinare il modello di fecondità ed il modello di mortalità. +
distribuzione di decessi per età per calcolo delle probabilità di morte per età tratte da
vari successivi livelli di tavole di mortalità tipo —> interpolando il dato che abbiamo
su tavole di mortalità per ricavare una stima precisa - tavola di mortalità nuova da cui
si potranno ottenere i decessi alle varie età, per il calcolo della popolazione nell’anno
successivo
128. Procedimento che si ripete anno dopo anno con una specifica tavola di mortalità e di
popolazione per età
129. Sono dunque possibili parametri di struttura, come indice di vecchiaia o età media o
persone in varie classi di età
130. Nel 1985 Lee introduceva la migratorietà: conoscendo l’ammontare della
popolazione, si può ottenere un saldo migratorio nei vari intervalli. Ciò viene ripartito
tra gli anni di ciascun intervallo o equidistribuito, o distribuendolo secondo un tasso
costante di migratorietà.
131. Breschi nel 90 ha dimostrato la solidità del metodo I.P
132. Disponendo per un certo periodo dei seguenti dati di input:
133. - popolazione iniziale per età
134. - serie storica di nascite e decessi
135. - popolazione in anni intermedi
136. - famiglia di tavole tipo di mortalità
137. - modello di fecondità
138. - modelo di migratorietà
139. si possono ottenere, per ciascuno degli anni di proiezione:
140. - ammontare e struttura della popolazione per età
141. - tassi generici di natalità e di mortalità
142. - misure di mortalità: e0, mortalità infantile
143. - misure di fecondità e riproduttività: TFT, R, R0
144. - tassi generici di migratorietà
145. 4.3.3 Inverse projection differenziata
146. Limiti di I.P:
147. - necessità di distribuzione per età della popolazione di partenza
148. - non si sfruttano le età di morte
149. - dubbio se le tavole tipo di mortalità siano adatte a popolazioni storiche anteriori
all’800
150. L’inverse projection differenziata I.P.D., vede innovazioni, come l’uso dei dati sui
decessi per età. La distinzione dei decessi tra alcune ampie classi è importante e
opportuna; si possono usare tre gruppi: giovani, adulti e anziani o solo due: morti
infantili/giovani e adulti.
151. Deve esserci compatibilità tra la distribuzione per età della popolazione iniziale e
quella per età dei decessi.
152. Il vantaggio maggiore nell’uso dell’I.P.D. è la migliore aderenza del modello alla vera
mortalità. L’I.P.D consente di verificare l’adattamento delle tavole tipo alla mortalità
effettivamente trovata in popolazioni storiche.
153. L’I.PD. non è vincolato ad un unico livello di mortalità per le classi in cui i decessi
sono stati ripartiti.
154.
155. FINE
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: giacomo-giacomazzi-1 (giacomo.giacomazzi.1@studenti.unipd.it)
Potrebbero piacerti anche
- Manuale Di Storia Della Pedagogia (X Intero)Documento76 pagineManuale Di Storia Della Pedagogia (X Intero)MariaRitaDiLauro86% (7)
- Antropologia e MigrazioniDocumento41 pagineAntropologia e MigrazioniSimona BottiglieroNessuna valutazione finora
- Geografia CulturaleDocumento48 pagineGeografia Culturalegufo69100% (2)
- Riassunto Geografia UmanaDocumento35 pagineRiassunto Geografia UmanaEffeEffe100% (2)
- MOBILITà INCURSIONI ETNOGRAFICHEDocumento58 pagineMOBILITà INCURSIONI ETNOGRAFICHESimona Bottigliero100% (1)
- Giovanni Boccaccio Traduzione in Italiano Del de Genealogiis Traduz. Di E. SardellaroDocumento10 pagineGiovanni Boccaccio Traduzione in Italiano Del de Genealogiis Traduz. Di E. SardellaroEnzo Sardellaro50% (2)
- Riassunto Libro Demo TotaleDocumento114 pagineRiassunto Libro Demo TotaleMatteo GabbaniNessuna valutazione finora
- BiodemografiaDocumento31 pagineBiodemografiaAntonio ProficoNessuna valutazione finora
- Geografia Della Popolazione Modulo ADocumento49 pagineGeografia Della Popolazione Modulo ABenedetta CastagnaNessuna valutazione finora
- INTERCUTURAL EDUCATION CAP 2.en - ItDocumento18 pagineINTERCUTURAL EDUCATION CAP 2.en - ItJean Orlando RabemananjaraNessuna valutazione finora
- Sociologia Dei Processi InterculturaliDocumento15 pagineSociologia Dei Processi Interculturalimassimiliano canuNessuna valutazione finora
- Geografia Culturale MDocumento80 pagineGeografia Culturale MMarziaNessuna valutazione finora
- Geografia EconomicaDocumento29 pagineGeografia EconomicaAlessandra GenovesiNessuna valutazione finora
- Appunti Di Storia Contemporanea e Del Giornalismo CompletiDocumento131 pagineAppunti Di Storia Contemporanea e Del Giornalismo CompletiAlice MoreroNessuna valutazione finora
- Paolo Prodi - Appunti Lezioni Storia ModernaDocumento7 paginePaolo Prodi - Appunti Lezioni Storia ModernaGeremy LentiniNessuna valutazione finora
- Storia Sociale e Contemporanea Del 900Documento11 pagineStoria Sociale e Contemporanea Del 900Fabio VoglioloNessuna valutazione finora
- Sintesi Storia Moderna 1492 1848 Di Carlo CapraDocumento164 pagineSintesi Storia Moderna 1492 1848 Di Carlo CaprarossanoNessuna valutazione finora
- Una Costante Nella Storia Dell'umanità LE MIGRAZIONI Logo EUDocumento25 pagineUna Costante Nella Storia Dell'umanità LE MIGRAZIONI Logo EUBarbara MasciaveNessuna valutazione finora
- Geografia CulturaleDocumento20 pagineGeografia CulturaleJos PeanoNessuna valutazione finora
- BREIDENBACHDocumento7 pagineBREIDENBACHjin Soub HyunNessuna valutazione finora
- Fuori Controllo EriksenDocumento14 pagineFuori Controllo Eriksenedith.mcgill22Nessuna valutazione finora
- Antropologia Culturale B. MillerDocumento12 pagineAntropologia Culturale B. MillerPIA DENICE PETTINessuna valutazione finora
- Determinanti Della FertilitaDocumento4 pagineDeterminanti Della FertilitaRoberto BonoNessuna valutazione finora
- Economia e sociologia della notte: Percorsi e temi di analisiDa EverandEconomia e sociologia della notte: Percorsi e temi di analisiValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Il Futuro Al CentroDocumento29 pagineIl Futuro Al Centro6wz8sk9k4zNessuna valutazione finora
- Dispensa 2 Vereni Antropologia CulturaleDocumento66 pagineDispensa 2 Vereni Antropologia Culturaleapi-3735634Nessuna valutazione finora
- GiovagnoliDocumento18 pagineGiovagnolisaramerletti729Nessuna valutazione finora
- Meeting 2011 12 Migrazioni Capitolo DicembreDocumento15 pagineMeeting 2011 12 Migrazioni Capitolo DicembreMatteo BortolonNessuna valutazione finora
- Storia Contemporanea Monina Dams Roma TreDocumento142 pagineStoria Contemporanea Monina Dams Roma TreElgaNessuna valutazione finora
- Geografia Della PopolazioneDocumento34 pagineGeografia Della PopolazioneGiusy PellinoNessuna valutazione finora
- Riassunti Slides EuroprogettazioneDocumento32 pagineRiassunti Slides EuroprogettazioneMariaAntoniettaArpaiaNessuna valutazione finora
- Nomadismi CulturaliDocumento191 pagineNomadismi CulturaliMarTa Ki MorabitoNessuna valutazione finora
- RIASSUNTO Geo UmanaDocumento116 pagineRIASSUNTO Geo UmanaLudovica ManciniNessuna valutazione finora
- Progetto Di RicercaDocumento15 pagineProgetto Di RicercaLorenza BoninuNessuna valutazione finora
- I Conflitti Per La TerraDocumento21 pagineI Conflitti Per La TerraEdizioni AltravistaNessuna valutazione finora
- Storia Moderna e ContemporaneaDocumento21 pagineStoria Moderna e ContemporaneaEmma BoscainiNessuna valutazione finora
- Copia Di La Geografia Culturale (Modalità Compatibilità) PDFDocumento43 pagineCopia Di La Geografia Culturale (Modalità Compatibilità) PDFDanny_1Nessuna valutazione finora
- Teorie e Tecniche Della Comunicazione Di MassaDocumento100 pagineTeorie e Tecniche Della Comunicazione Di MassaDaveDevaNessuna valutazione finora
- CODE - A Ogni Generazione La Sua Protesta, A Ogni Protesta La Sua Narrativa - Conferenza 11-05-2023Documento4 pagineCODE - A Ogni Generazione La Sua Protesta, A Ogni Protesta La Sua Narrativa - Conferenza 11-05-2023• chris18 •Nessuna valutazione finora
- Dispense Geografia Prof Ssa Giannelli UnibaDocumento37 pagineDispense Geografia Prof Ssa Giannelli UnibaAngelo BaldariNessuna valutazione finora
- Appunti Geografia SlidesDocumento33 pagineAppunti Geografia Slidessftgukkie 97Nessuna valutazione finora
- Articolo Sette 2009-03 2010-01Documento14 pagineArticolo Sette 2009-03 2010-01rafsetteNessuna valutazione finora
- Cirese-Cultura Egemonica e Culture SubalterneDocumento20 pagineCirese-Cultura Egemonica e Culture SubalterneSakura95Nessuna valutazione finora
- Comunicazione storica: Tecnologie, linguaggi, cultureDa EverandComunicazione storica: Tecnologie, linguaggi, cultureNessuna valutazione finora
- Educazione InterculturaleDocumento36 pagineEducazione InterculturaleTommaso ImperioNessuna valutazione finora
- Infermieristica transculturale e spiritualità: Pratiche assistenziali centrate sul pazienteDa EverandInfermieristica transculturale e spiritualità: Pratiche assistenziali centrate sul pazienteNessuna valutazione finora
- Appunti Geografia Storica Dell'italiaDocumento41 pagineAppunti Geografia Storica Dell'italiaDilettaNessuna valutazione finora
- Politica ContemporaneaDocumento27 paginePolitica Contemporaneamatydirectioner01Nessuna valutazione finora
- Manuale Di GeografiaDocumento40 pagineManuale Di GeografiaLOMBARDO ADRIANANessuna valutazione finora
- Edoardo Grendi - DEL SENSO COMUNE STORIOGRAFICODocumento11 pagineEdoardo Grendi - DEL SENSO COMUNE STORIOGRAFICOrafaelfmenezesNessuna valutazione finora
- Sociologia Urbana e Del Territorio (Libro)Documento36 pagineSociologia Urbana e Del Territorio (Libro)giulia accorsiNessuna valutazione finora
- GEOGRAFIADocumento7 pagineGEOGRAFIAflaviapizzarelli3Nessuna valutazione finora
- Lez 1Documento7 pagineLez 1Stefano Tutor AccountNessuna valutazione finora
- 1 Lezione - Introduzione Al CorsoDocumento32 pagine1 Lezione - Introduzione Al CorsoANessuna valutazione finora
- Sociologia Del Cambiamento Nell'era DigitaleDocumento43 pagineSociologia Del Cambiamento Nell'era DigitaleElisa SintoniNessuna valutazione finora
- FareGeografiaPolitica AgnewMuscaràDocumento165 pagineFareGeografiaPolitica AgnewMuscaràsimoneNessuna valutazione finora
- Le MigrazioniDocumento7 pagineLe MigrazioniFrancesco ClementeNessuna valutazione finora
- Idos - Pregiudizi Popolari e BaconeDocumento2 pagineIdos - Pregiudizi Popolari e BaconeDanielaNessuna valutazione finora
- Storia RomanaDocumento101 pagineStoria RomanagiacomoNessuna valutazione finora
- Storia Romana 01-02-03 2022Documento32 pagineStoria Romana 01-02-03 2022giacomoNessuna valutazione finora
- Docsity Modelli Politici Di Roma Antica Luca Fezzi 1Documento41 pagineDocsity Modelli Politici Di Roma Antica Luca Fezzi 1giacomoNessuna valutazione finora
- Ripasso Storia RomanaDocumento14 pagineRipasso Storia RomanagiacomoNessuna valutazione finora
- Riassunto Storia RomanaDocumento6 pagineRiassunto Storia RomanagiacomoNessuna valutazione finora
- Farmaci Da Evitare Nella Sindrome Di BrugadaDocumento1 paginaFarmaci Da Evitare Nella Sindrome Di BrugadaireneppafNessuna valutazione finora
- Danganronpa IF (Light Novel) - ITADocumento95 pagineDanganronpa IF (Light Novel) - ITAnonlosoNessuna valutazione finora
- Annuario Statistico Italiano 1980Documento459 pagineAnnuario Statistico Italiano 1980Alex LombardiNessuna valutazione finora
- SDC Mecc 04-05 Stress 3 PDFDocumento63 pagineSDC Mecc 04-05 Stress 3 PDFsimoneNessuna valutazione finora
- DietaDocumento27 pagineDietaFrancescoUmaniNessuna valutazione finora