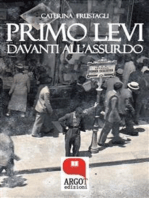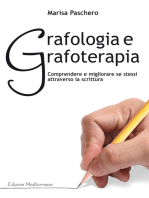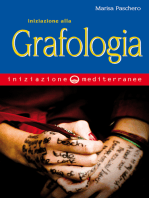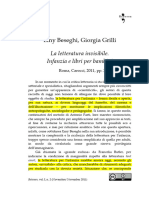Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Storia Di Un'autointerrogazione e Dei Suoi Esiti Operativi
Caricato da
Paolo Scelfo0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
53 visualizzazioni4 pagineTitolo originale
Storia di un’autointerrogazione e dei suoi esiti operativi
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
DOC, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOC, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
53 visualizzazioni4 pagineStoria Di Un'autointerrogazione e Dei Suoi Esiti Operativi
Caricato da
Paolo ScelfoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOC, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 4
A che cosa serve la letteratura?
Storia di
un’autointerrogazione e dei suoi esiti operativi
di Giuseppina Danese - Liceo "Primo Levi" di San Donato milanese
Generalmente adottiamo due punti di vista per guardare la
nostra esperienza: un punto di vista alto, che allontana per
poter valutare, e un punto di vista basso, che si immerge nel
flusso esperienziale nell’illusione di poterlo comprendere
meglio.Un terzo punto di vista è quello narrativo, che non
stabilisce criteri valutativi a priori, né si lascia sommergere dai
cosiddetti vissuti. Per me, insegnante di letteratura italiana nel
triennio del liceo, il punto di vista narrativo ha costituito un
approdo personale, la necessità di riflettere sui presupposti
teorici della letteratura, il bisogno di portare alla luce gli
assunti impliciti dei manuali in uso nei licei, ed infine la
scoperta di una didattica “utile”, cioè di una modalità di lavoro
capace di dare senso a ciò che si fa.
La crisi delle modalità routinarie che mettevo in atto è stata
determinata anche dalla decisione di non liquidare come
semplicistiche le domande, spesso implicite, degli adolescenti
davanti al testo letterario. Domande di natura teorica: “ qual è
e dov’è la verità in questo testo?”, e di natura pratica: “a che
cosa mi serve studiare la letteratura?”. Mi sono chiesta se,
attribuire ai testi letterari la funzione di laboratorio
sperimentale di verifica del contesto storico e/o della verifica
delle ipotesi sull’intenzionalità dell’autore stesso, fosse
congruente ai bisogni formativi degli studenti, se fosse proprio
questo lo specifico del sapere letterario. Per analizzare il testo
letterario usavo gli strumenti teorici e narratologici del
paradigma formalista e strutturalista, senza però averne chiari
i presupposti teorici.
Non voglio discutere qui problemi di teoria letteraria e
linguistica, ma soltanto porre all’attenzione che, questioni
relative alla verità del testo letterario, alla natura
dell’immaginario narrativo, alla distanza o analogia tra
letteratura e realtà, hanno un rapporto diretto con le valenze
formative della letteratura, con le modalità cognitive degli
adolescenti e con il loro stile di approccio ai testi. Inoltre la
questione del rapporto tra enti d’invenzione e realtà si pone
spontaneamente ed automaticamente all’esperienza di ogni
lettore, e quindi anche dell’adolescente.La contraddittorietà
dell’esperienza del lettore, che sa di trovarsi davanti ad eventi
e personaggi non veri, e la sensazione che gli stessi eventi e
personaggi siano veri, finendo con l’identificarsi con essi, è
stata indagata e spiegata in vari modi, in genere appuntando il
focus sull’aspetto di referenza.Lo strutturalismo e il
formalismo, presenti come assunti teorici, generalmente
impliciti nei manuali, sono i principali responsabili del
tecnicismo didattico e della perdita di valenza formativa della
letteratura, perché nell’ottica strutturalista il testo letterario
non va visto come espressione personale dell’autore, ma come
catena di rapporti formali. Nell’analisi del testo domina
incontrastato l’intreccio, che investe di sé ogni altro elemento.
Anche i personaggi sono meri agenti in rapporto alle unità
dell’intreccio. Porsi di fronte al testo secondo questi assunti
significa non rendere ragione del gioco della mente, dell’autore
e del lettore, gioco che rende immaginario alla mente ciò che
recepisce nello stesso momento in cui lo ricrea.
La ricezione dell’opera si pone quindi come l’altra faccia della
creazione dell’opera, il doppio volto del gioco creativo della
mente, ed è in questo territorio soggettivo ed aleatorio
l’aspetto comunicativo e formativo dell’opera letteraria di
fiction. Uso il termine inglese fiction, purtroppo oggi
desemantizzato, perché il suo significato, intraducibile in
italiano, rende meglio di ogni altro l’idea del racconto
d’invenzione come gioco della mente che crea un mondo
possibile. Fiction richiama sia la nozione del “fingere” (dal
latino fictio che ha il duplice significato di “composizione” e
“finzione”), sia quella di creare ( latino fictor, “artefice” nel
latino classico, “dio creatore” nel latino ecclesiastico).
L’opera di fiction si pone in rapporto con la realtà sia
falsificandola, rinominandola con la simulazione, stabilendo
con lei rapporti di contiguità, sia intervenendo su di essa,
ricreandola, trasformandola come se l’arte potesse rifondare la
realtà. Il gioco della mente dell’autore rende immaginario a sé
stessa un “mondo possibile” “come se ne potesse esistere uno
così”, mentre il gioco della mente del lettore partecipa alla
finzione “come se credesse all’esistenza di un mondo così”. E
se, secondo Ricoeur, esiste analogia tra “l’essere nella storia” e
“fare dei resoconti su di essa”, il discorso di fiction può essere
definito il resoconto dell’essere, del sostare
momentaneamente, in un mondo possibile.
Con questi presupposti il nodo da sciogliere, per me
insegnante, consisteva nel progettare un percorso didattico nel
quale l’adolescente potesse comprendere sé stesso e le sue
modalità di pensiero costruendo ipotesi per comprendere l’altro
da sé, cioè il mondo al quale l’autore dà vita nel testo
letterario. Ho elaborato una definizione di punto di vista che si
è rivelata funzionale sia al lavoro autobiografico che a quello
sul testo letterario: punto di vista come situazione interna del
vissuto dalla quale si guarda e si realizza la sintesi del
percepire e del pensare in senso lato, punto di vista come
funzione della mente che costruisce resoconti tra il conscio e
l’inconscio intorno all’esperienza del “qui e ora”, sintesi
continua, sempre in movimento, tra il passato e il futuro.
Con queste ipotesi di lavoro abbiamo giocato a scuola con il
pensiero-fiction, imparando a immaginare scenari per capire il
quadro di riferimento mentale dell’autore.C i siamo abituati a
porci domande su come quell’autore abbia costruito il suo
contesto di riferimento, insieme a chi, attraverso quali
esperienze, con quali riferimenti valoriali e rappresentazioni
sociali. Abbiamo imparato a interrogare la biografia dell’autore
e il suo contesto storico. Un aspetto importante del lavoro, per
le sue valenze trasformative, è l’addestramento a
rappresentarsi l’altro da sé, ad incontrare il terreno
dell’intenzionalità e quindi dell’alterità psichica, scontrandosi
con l’inattingibilità dell’altro, con l’impossibilità di
comprenderlo, immediatamente e “veramente”. E’ un lavoro di
immersione nella complessità della costruzione sociale dei
significati, che ci imbrigliano mentre ci sono necessari, li
cerchiamo mentre li rifiutiamo.
Il racconto autobiografico procede, a volte parallelamente a
quello di fiction, altre volte apparentemente svincolato da
esso. Il connubio autobiografia-letteratura consente di
formulare legittimamente obiettivi ambiziosi, perché fondati
sul sapere del “vissuto personale” dello studente:obiettivi
educativi e formativi:- acquisizione della consapevolezza
dell’identità personale come pluriappartenente;- acquisizione
di capacità empatiche attraverso la comprensione del punto di
vista dell’altro;- acquisizione della capacità di distinguere la
propria soggettività e riconoscerne le peculiarità
nell’apprendere;- acquisizione della capacità di lavorare in
gruppo;- acquisizione della capacità di negoziare significati;-
acquisizione della capacità di spostare e ampliare il punto di
vista;- acquisizione della capacità di rappresentarsi la
complessità dell’azione umana;- acquisizione della capacità di
tollerare l’incertezza nei processi di pensiero;- acquisire
motivazione intrinseca (star dentro il processo)
obiettivi di operatività cognitiva:- acquisizione della capacità di
usare assunti teorici come ipotesi di lavoro;- acquisizione della
capacità di porre e strutturare problemi complessi;-
acquisizione della capacità di gerarchizzare le operazioni
cognitive;- acquisizione della capacità di costruire contesti di
significati culturali.
Potrebbero piacerti anche
- Primo Levi davanti all’assurdo. Dire l’indicibile: Il linguaggio della ShoahDa EverandPrimo Levi davanti all’assurdo. Dire l’indicibile: Il linguaggio della ShoahNessuna valutazione finora
- Sinopoli - RiassuntoDocumento23 pagineSinopoli - RiassuntoIsabella MonzaniNessuna valutazione finora
- Esercizi Di Creativa ScritturaDocumento3 pagineEsercizi Di Creativa ScritturaValeria Della ChiesaNessuna valutazione finora
- Ermeneutica e Retorica GRILLIDocumento70 pagineErmeneutica e Retorica GRILLIAndrea BianchiniNessuna valutazione finora
- LaboratorioDocumento1 paginaLaboratorioanitadefilippi02Nessuna valutazione finora
- Cosa Possiamo Fare Con Il FuocoDocumento7 pagineCosa Possiamo Fare Con Il FuocoFrancesco De FilippiNessuna valutazione finora
- Letterature ComparateDocumento13 pagineLetterature ComparateLouisse RomaineNessuna valutazione finora
- 7641-Article Text-23146-1-10-20171222Documento13 pagine7641-Article Text-23146-1-10-20171222hadjira hamadacheNessuna valutazione finora
- L'Immaginario Nell'espressione Orale e ScrittaDocumento4 pagineL'Immaginario Nell'espressione Orale e ScrittaDipartimento Lingua- Circolo Didattico di VinciNessuna valutazione finora
- Letteratura Per LDocumento2 pagineLetteratura Per LIlenia MarascaNessuna valutazione finora
- Letteratura Per L'infanzia - TesiDocumento4 pagineLetteratura Per L'infanzia - TesirsovranoNessuna valutazione finora
- Il Secchio Di DuchampDocumento37 pagineIl Secchio Di DuchampgiumarilNessuna valutazione finora
- Articolo BachtinDocumento24 pagineArticolo BachtinValentina AmbrosioNessuna valutazione finora
- Letterature ComparateDocumento15 pagineLetterature ComparateIsabella MonzaniNessuna valutazione finora
- 35 GrispiniDocumento10 pagine35 GrispinimarioNessuna valutazione finora
- Percorsi della letteratura per l'infanzia: Tra leggere e interpretareDa EverandPercorsi della letteratura per l'infanzia: Tra leggere e interpretareValutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- MEANINGFUL METADESIGN: Sentimento, Senso e Scopo nell’era del design delle esperienzeDa EverandMEANINGFUL METADESIGN: Sentimento, Senso e Scopo nell’era del design delle esperienzeNessuna valutazione finora
- Per Lettera RiassuntoDocumento11 paginePer Lettera RiassuntoMarta DoryNessuna valutazione finora
- MittinoDocumento11 pagineMittinoVinicius RochaNessuna valutazione finora
- Epistéme e utopia. La poesia come significato ed immagine del mondoDa EverandEpistéme e utopia. La poesia come significato ed immagine del mondoNessuna valutazione finora
- La Lettura Ad Alta Voce. Fiabe Storie e Filastrocche Per La Scuola Dell'infanzia. Raimonda M.MoraniDocumento5 pagineLa Lettura Ad Alta Voce. Fiabe Storie e Filastrocche Per La Scuola Dell'infanzia. Raimonda M.Moranimorani9829Nessuna valutazione finora
- NARR - BIO - Le Scritture Famigliari Tra Memoria e Diari Del Presente - Duccio DemetrioDocumento20 pagineNARR - BIO - Le Scritture Famigliari Tra Memoria e Diari Del Presente - Duccio DemetrioalexrgnNessuna valutazione finora
- Nati Due Volte Di Giuseppe Pontiggia La ReticenzaDocumento10 pagineNati Due Volte Di Giuseppe Pontiggia La ReticenzamanfrediNessuna valutazione finora
- 04 TacconiDocumento13 pagine04 TacconiAnnalisa FedericiNessuna valutazione finora
- Saggio Fava BarsottiDocumento4 pagineSaggio Fava BarsottiAlessia CimarolliNessuna valutazione finora
- Marrone, Efficacia Simbolica Dello SpazioDocumento12 pagineMarrone, Efficacia Simbolica Dello SpazioFrancesco PassarielloNessuna valutazione finora
- Letteratura come arte della formazione. Modelli umanistici alla base di sviluppo personale e comportamenti organizzativiDa EverandLetteratura come arte della formazione. Modelli umanistici alla base di sviluppo personale e comportamenti organizzativiNessuna valutazione finora
- BertoniDocumento5 pagineBertonidomenicor941Nessuna valutazione finora
- Importanta LecturiiDocumento143 pagineImportanta LecturiiMarta AlbuNessuna valutazione finora
- Angelo Nobile - Pedagogia Della Letteratura GiovanileDocumento16 pagineAngelo Nobile - Pedagogia Della Letteratura Giovanilestudente universitario100% (1)
- Grafologia e Grafoterapia: Comprendere e miglirare se stessi attraverso la scritturaDa EverandGrafologia e Grafoterapia: Comprendere e miglirare se stessi attraverso la scritturaNessuna valutazione finora
- PERCORSI CRITICI SULLA LETTERATURA p403-420Documento7 paginePERCORSI CRITICI SULLA LETTERATURA p403-420Alessia CimarolliNessuna valutazione finora
- Aldo Giorgio Gargani PDFDocumento4 pagineAldo Giorgio Gargani PDFRaffaele IannuzziNessuna valutazione finora
- 16 Lombello DonatellaDocumento11 pagine16 Lombello DonatellaserenaNessuna valutazione finora
- L' Atto Della Lettura Di IserDocumento37 pagineL' Atto Della Lettura Di Iserpierlucamazzagatti03Nessuna valutazione finora
- Scrittura CreativaDocumento101 pagineScrittura CreativaLorena Zenti100% (1)
- Proust La Ricerca Del Tempo PerdutoDocumento4 pagineProust La Ricerca Del Tempo PerdutoAngeloNessuna valutazione finora
- Il Testo A Quattro ManiDocumento23 pagineIl Testo A Quattro ManiAnonymous DcaGyvzoSINessuna valutazione finora
- Semiotica Dei Nuovi MediaDocumento18 pagineSemiotica Dei Nuovi MediaTony ManoleNessuna valutazione finora
- Dispensa Su ProppDocumento10 pagineDispensa Su ProppsilvialucaaNessuna valutazione finora
- Un Laboratorio Di Scrittura CreativaDocumento13 pagineUn Laboratorio Di Scrittura CreativaKirmalieNessuna valutazione finora
- Pragmatica e InterculturalitàDocumento2 paginePragmatica e Interculturalitàlezione27Nessuna valutazione finora
- Quer Pasticciaccio Brutto Dell'identità. Intervista A Francesco RemottiDocumento3 pagineQuer Pasticciaccio Brutto Dell'identità. Intervista A Francesco RemottiBeatrice CatanzaroNessuna valutazione finora
- Appuntamento Con Il Destino: Faber est suae quisque fortunaeDa EverandAppuntamento Con Il Destino: Faber est suae quisque fortunaeNessuna valutazione finora
- La grafia dell'amore e dell'odio e altri metodi di conoscenza dell'essere umano.: Parte Prima.Da EverandLa grafia dell'amore e dell'odio e altri metodi di conoscenza dell'essere umano.: Parte Prima.Nessuna valutazione finora
- RIASSUNTO BarsottiDocumento82 pagineRIASSUNTO BarsottiGiorgia VecchiottiNessuna valutazione finora
- Roland Barthes Il Brusio Della LinguaDocumento4 pagineRoland Barthes Il Brusio Della LinguaAlessandra MarangoniNessuna valutazione finora
- Narrazione Ed Esperienza Tra Antropologia Ed EticaDocumento23 pagineNarrazione Ed Esperienza Tra Antropologia Ed EticaMaurizio GaruttiNessuna valutazione finora
- Guida Breve - CeseraniDocumento12 pagineGuida Breve - CeseranitoppanolisaNessuna valutazione finora
- Articolo Letteratura InvisibileDocumento4 pagineArticolo Letteratura Invisibilegentileanna984Nessuna valutazione finora
- Wolfgang IserDocumento24 pagineWolfgang IserAnonymous hyUqzpS100% (1)
- Storia Della Critica LetterarDocumento25 pagineStoria Della Critica LetterarCarola FiorindoNessuna valutazione finora
- Lett. Comparate 2Documento7 pagineLett. Comparate 2domenicor941Nessuna valutazione finora
- Riassunto LO SPETTRO DELL'INTERPRETAZIONE, W. ISERDocumento5 pagineRiassunto LO SPETTRO DELL'INTERPRETAZIONE, W. ISERPAOLANessuna valutazione finora
- Verifica Latino IV SC BDocumento2 pagineVerifica Latino IV SC BPaolo ScelfoNessuna valutazione finora
- Boycott NestléDocumento5 pagineBoycott NestléPaolo ScelfoNessuna valutazione finora
- Moore Sbeffeggia Lo Stupid White Man e La Corte Marziale USA Sbeffeggia Gli ObiettoriDocumento2 pagineMoore Sbeffeggia Lo Stupid White Man e La Corte Marziale USA Sbeffeggia Gli ObiettoriPaolo ScelfoNessuna valutazione finora
- 16 MastersDocumento3 pagine16 MastersPaolo ScelfoNessuna valutazione finora
- Alle Origini Del Pensiero Razionale Hans-Georg GadamerDocumento2 pagineAlle Origini Del Pensiero Razionale Hans-Georg GadamerPaolo ScelfoNessuna valutazione finora
- 25 FinaliDocumento3 pagine25 FinaliPaolo ScelfoNessuna valutazione finora
- Renato Serra - Purché Si Vada Numerose Sono Le Riflessioni Sulla GuerraDocumento2 pagineRenato Serra - Purché Si Vada Numerose Sono Le Riflessioni Sulla GuerraPaolo ScelfoNessuna valutazione finora
- Con Il Mes Il Rischio Di Passare Dalla Padella Alla BraceDocumento2 pagineCon Il Mes Il Rischio Di Passare Dalla Padella Alla BracePaolo ScelfoNessuna valutazione finora
- Papa: Enciclica, Anche La Globalizzazione Ha Bisogno Dell'AnimaDocumento7 paginePapa: Enciclica, Anche La Globalizzazione Ha Bisogno Dell'AnimaPaolo ScelfoNessuna valutazione finora
- Untitled 5Documento2 pagineUntitled 5Paolo ScelfoNessuna valutazione finora
- Rezzori Gregor Von, Edipo Vince A StalingradoDocumento156 pagineRezzori Gregor Von, Edipo Vince A StalingradoPaolo ScelfoNessuna valutazione finora
- Usi e Funzioni Del Participio Greco: Il Genitivo Assoluto: Liceo Ginnasio Statale "G. M. Dettori"Documento29 pagineUsi e Funzioni Del Participio Greco: Il Genitivo Assoluto: Liceo Ginnasio Statale "G. M. Dettori"Paolo ScelfoNessuna valutazione finora
- Esame Di Stato Di Istruzione Secondaria Superiore 2018: L'amiciziaDocumento3 pagineEsame Di Stato Di Istruzione Secondaria Superiore 2018: L'amiciziaPaolo ScelfoNessuna valutazione finora
- Fermate Il Mes, Voglio Scendere: Nuova Finanza PubblicaDocumento2 pagineFermate Il Mes, Voglio Scendere: Nuova Finanza PubblicaPaolo ScelfoNessuna valutazione finora
- Diritto e Morale in FICHTEDocumento2 pagineDiritto e Morale in FICHTEPaolo ScelfoNessuna valutazione finora
- Hotel RwandaDocumento6 pagineHotel RwandaPaolo ScelfoNessuna valutazione finora
- Deismo Da WikipediaDocumento4 pagineDeismo Da WikipediaPaolo ScelfoNessuna valutazione finora
- Giovanni Reale PlatoneDocumento30 pagineGiovanni Reale PlatonePaolo ScelfoNessuna valutazione finora
- File24 Verifica Storia Egizi Assiri Ebrei BabilonesiDocumento2 pagineFile24 Verifica Storia Egizi Assiri Ebrei BabilonesiPaolo ScelfoNessuna valutazione finora
- Guida Insegnanti AntisemitismoDocumento44 pagineGuida Insegnanti AntisemitismoPaolo ScelfoNessuna valutazione finora
- Analisi Del PeriodoDocumento1 paginaAnalisi Del PeriodoPaolo ScelfoNessuna valutazione finora
- Nichilismo, Téchne e Poesia Nel Pensiero Di Emanuele Severino.Documento252 pagineNichilismo, Téchne e Poesia Nel Pensiero Di Emanuele Severino.Paolo ScelfoNessuna valutazione finora
- Il Discorso Inaugurale Di ObamaDocumento3 pagineIl Discorso Inaugurale Di ObamaPaolo ScelfoNessuna valutazione finora
- Epistemologia Della StoriaDocumento2 pagineEpistemologia Della StoriaPaolo ScelfoNessuna valutazione finora
- Le Fonti Storiche (Scuola)Documento4 pagineLe Fonti Storiche (Scuola)Paolo ScelfoNessuna valutazione finora
- Le Democrazie Antiche A Confronto (Storia Scuola)Documento107 pagineLe Democrazie Antiche A Confronto (Storia Scuola)Paolo ScelfoNessuna valutazione finora
- Breve Storia Della Giustizia in GreciaDocumento3 pagineBreve Storia Della Giustizia in GreciaPaolo ScelfoNessuna valutazione finora
- Antonio Brusa, Il Nuovo Curricolo Di StoriaDocumento1 paginaAntonio Brusa, Il Nuovo Curricolo Di StoriaPaolo ScelfoNessuna valutazione finora
- Le Sfide Dell'insegnamento Della StoriaDocumento6 pagineLe Sfide Dell'insegnamento Della StoriaPaolo ScelfoNessuna valutazione finora
- I Concetti Di Denotazione e ConnotazioneDocumento2 pagineI Concetti Di Denotazione e ConnotazionePaolo ScelfoNessuna valutazione finora
- Massimo Scaligero Manuale Pratico Della MeditazioneDocumento76 pagineMassimo Scaligero Manuale Pratico Della MeditazioneMario Gallo0% (1)
- Il Rapporto Tra Mente e CervelloDocumento13 pagineIl Rapporto Tra Mente e CervelloGIUGAB6392Nessuna valutazione finora
- Linguaggio e Simboli Nel MesmerismusDocumento6 pagineLinguaggio e Simboli Nel MesmerismusMarco Paret100% (1)
- Pellerey Binder RassegnaCNOS 1984-2018Documento512 paginePellerey Binder RassegnaCNOS 1984-2018mbfreesdbNessuna valutazione finora
- Bruner PsicologiaDocumento14 pagineBruner PsicologiaGiorgiaNessuna valutazione finora
- Locke AbbagnanoDocumento7 pagineLocke AbbagnanoGiulia VillaNessuna valutazione finora
- Educare A ScrivereDocumento77 pagineEducare A ScrivereAngelaNessuna valutazione finora
- Sergio Manghi - Bateson e I CantiDocumento6 pagineSergio Manghi - Bateson e I CantiMarco Scribd100% (1)
- Mappe Concettuali Nella DidatticaDocumento117 pagineMappe Concettuali Nella Didatticalseva_1Nessuna valutazione finora
- Le Prime 7 Parole Della Genesi Nella BibbiaDocumento5 pagineLe Prime 7 Parole Della Genesi Nella BibbiaSalvatrice D'amicoNessuna valutazione finora