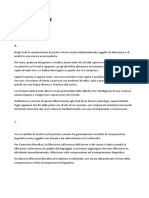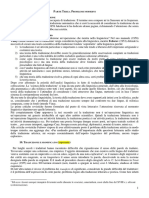Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Docsity La Filosofia Del Linguaggio Da Frege Ai Giorni Nostri
Caricato da
Luce ForconiTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Docsity La Filosofia Del Linguaggio Da Frege Ai Giorni Nostri
Caricato da
Luce ForconiCopyright:
Formati disponibili
La filosofia del linguaggio - Da
Frege ai giorni nostri
Filosofia del Linguaggio
Università degli Studi della Basilicata
21 pag.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Luce87123 (luceforconi@gmail.com)
La filosofia del linguaggio
Da Frege ai giorni nostri.
Introduzione
Riflessione filosofica sul linguaggio e “filosofia del linguaggio”
A partire dal Cratilo di Platone la filosofia si è occupata del linguaggio: della sua origine,
delle sue funzioni e, in particolare, delle diverse “parti del discorso” e delle loro funzioni e
dei diversi tipi di relazione semantica.
Se ne è occupata più intensamente in certi periodi (tardo Medioevo) e un po’ meno in altri
(Seicento), ma comunque il linguaggio non è mai uscito del tutto dall’orizzonte riflessivo
della filosofia. Eppure, quando oggi si parla di filosofia del linguaggio, si fa di solito
riferimento a ricerche la cui bibliografia risale molto di rado indietro nel tempo; certo,
vengono citate dottrine antiche come la distinzione di Leibniz tra intensione ed estensione,
la teoria “ideazionale” di Locke, tuttavia, si ha l’impressione che il riferimento a questi o ad
altri classici serva più che altro a nobilitare posizioni contemporanee.
Si possono addurre varie ragioni plausibili di questo distacco della filosofia del linguaggio
dalla tradizione filosofica.
Anzitutto, la filosofia del linguaggio ha instaurato fin dalle sue origini un rapporto
abbastanza stretto con la logica formale (inesistente prima di Frege) e la ricerca più recente
interagisce spesso con la linguistica generativa fondata da Chomsky alla fine degli anni
cinquanta.
Inoltre la filosofia del linguaggio è per molti aspetti interna alla tradizione filosofica analitica:
una tradizione che ha certamente dei precedenti insigni nella storia della filosofia
(Aristotele, Hume), ma che si svolge prevalentemente nel nostro secolo.
Infine, un’altra ragione di questo peculiare distacco della filosofia del linguaggio dalla
tradizione filosofica va cercata nel grado di consenso raggiunto in questa disciplina. I filosofi
del linguaggio hanno infatti convenuto sulla rilevanza di certi problemi e sulla centralità di
certi testi come contributi alla loro discussione difficili da definire in modo preciso, ma in cui
hanno gran parte le definizioni e le argomentazioni esplicite e l’uso di controesempi per
invalidare proposte di soluzione. Questo complesso consensuale lascia certamente fuori, per
una ragione o per l’altra, buona parte delle riflessioni filosofiche sul linguaggio pre-
freghiane.
Con questo non si vuole affermare che tra coloro che oggi si occupano del linguaggio da
filosofi il consenso sia universale, ma soltanto sottolineare quella che è stata ed è la
particolare autorevolezza di un gruppo relativamente piccolo di testi.
Da questo punto di vista è forse un po’ più facile capire anche il difficile rapporto tra la
filosofia del linguaggio e le attuali correnti ermeneutiche. Le differenze di stile filosofico sono
evidenti, ma a parte ciò, i problemi della filosofia del linguaggio analitica sono
sostanzialmente estranei all’ermeneutica. Ai filosofi infatti interessa ciò che le parole come
“cavallo” e “destriero” hanno in comune, agli ermeneuti interessa piuttosto ciò per cui sono
diverse.
Filosofia del linguaggio e filosofia linguistica
Il programma di ricerca della filosofia del linguaggio è a volte identificato con lo slogan i
“problemi filosofici sono problemi del linguaggio”.
Questa identificazione è, oggi, un errore perché la maggior parte dei filosofi del linguaggio
non pensa affatto che i problemi filosofici della giustizia, della giustificazione delle teorie
scientifiche, della natura dell’arte o del rapporto tra mente e corpo siano problemi del
linguaggio. Tuttavia è un errore che ha una giustificazione storica: le ricerche filosofiche sul
linguaggio sono di fatto nate per buona parte all’insegna di quello slogan che può essere
interpretato come i problemi filosofici nascono dal linguaggio: dalle sua imperfezioni e
opacità.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Luce87123 (luceforconi@gmail.com)
Le ricerche di Frege sono motivate dalla convinzione che il linguaggio naturale sia una fonte
inevitabile di inganni, e Wittgenstein avrebbe sostenuto più tardi che le confusioni più
fondamentali nascono dal fraintendimento del modo in cui funziona il linguaggio comune e
che tutta la filosofia è critica del linguaggio.
Nella formazione di queste idee ebbe importanza fondamentale l’insegnamento di Russel,
sulla necessità di distinguere tra forma grammaticale di un enunciato e forma logica, cioè
tra ciò che un enunciato sembra dire e ciò che effettivamente dice. Posizioni di questo
genere sono all’origine di una tendenza della filosofia linguistica: quella per cui i problemi
filosofici sono problemi di linguaggio, e che tocca alla filosofia non già risolverli, ma
eliminarli, sostituendo il linguaggio naturale con un linguaggio artificiale perfetto.
Ma lo slogan ha avuto anche un’altra interpretazione: i problemi filosofici sono problemi di
significato delle parole, e si risolvono accertando qual è il significato di certe parole.
Secondo Schlick, difensore di questa versione della filosofia, già Socrate aveva compreso
che in filosofia non si tratta di accertare i fatti, come nelle scienze, ma di chiarire i
significati.
I problemi filosofici sono problemi di linguaggio nel senso che riguardano il linguaggio, e si
risolvono mediante l’analisi del linguaggio.
Oggi la filosofia del linguaggio non esiste più:la tendenza dissolutoria è stata sconfitta dalla
convinzione che molti problemi filosofici possano essere riformulati in modo chiaro e del
tutto accettabile; la tendenza costruttiva è caduta sotto l’accusa di pensare che questioni
sostantive possano essere risolte attraverso l’analisi del linguaggio.
Ma la filosofia linguistica ha lasciato una cospicua eredità teorica, che costituisce in buona
parte il patrimonio di idee della filosofia del linguaggio. Nel perseguire un obiettivo che era
di risoluzione dei problemi di filosofia in generale, i filosofi linguistici hanno elaborato
concetti e teorie sul linguaggio che hanno tuttora corso. E così, probabilmente, molte idee
sul linguaggio non sarebbero nate se non fossero sembrate utili a trattare altri problemi
filosofici.
Filosofia del linguaggio e linguistica
Se è vero che la filosofia del linguaggio si è evoluta nel senso di una comprensione fine a se
stessa di che cos’è il linguaggio e come funziona, ci si può domandare se non sia diventata
identica alla linguistica. È facile, ma sbagliato, rispondere che la linguistica non si occupa
del “linguaggio” bensì delle lingue storico-naturali.
In primo luogo infatti, le idiosincrasie delle singole lingue non sono necessariamente
irrilevanti per la filosofia del linguaggio. Proprio in quanto essa mira a stabilire conclusioni
generali, non è indifferente che esse siano contraddette da fenomeni linguistici specifici di
questa o quella lingua. In secondo luogo, esiste una linguistica teorica, o generale, che
tratta le singole lingue storico-naturali essenzialmente come il materiale empirico di una
teoria generale del linguaggio verbale.
La grammatica universale è una teoria della facoltà del linguaggio, il modulo della mente
umana devoluto alla conoscenza linguistica: i principi della grammatica universale
dovrebbero, in linea di principio, poter essere messi in relazione con le caratteristiche fisiche
del cervello.
Questi cenni bastano ad evidenziare le ambizioni di universalità del programma di ricerca di
Chomsky, ambizioni che, peraltro, non sono prerogativa esclusiva della linguistica generale.
La filosofia del linguaggio non può dunque essere distinta dalla linguistica per il fatto di
essere teorica anziché storica, interessata al linguaggio in generale piuttosto che alle
singole lingue o a gruppi di lingue, pura anziché empirica; e farebbe bene a non
distinguersene per il fatto di ignorare i fenomeni linguistici e le peculiarità delle singole
lingue.
Si è visto come la filosofia linguistica fosse dominata da preoccupazioni filosofiche
extralinguistiche. Di conseguenza, essa si è spesso impegnata in analisi di notevole rilievo
per la filosofia, ma di scarso interesse linguistico: è chiaro che non interessa più di tanto alla
linguistica il ruolo dell’aggettivo “volontario” o quello dell’enunciato “io provo dolore”; la
linguistica non si occupa di espressioni singole, ma di classi di espressioni.
Per i filosofi che avessero a cuore la liberazione della filosofia, e della scienza, dalle oscurità
e confusioni del linguaggio naturale, la teoria del linguaggio era anzitutto teoria dei
linguaggi artificiali della logica, opportunamente incrementati per accrescerne il potere
espressivo.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Luce87123 (luceforconi@gmail.com)
Tutta la prima fase del pensiero di Carnap(Costruzione logica del mondo, 1928 – Sintassi
logica del linguaggio, 1934), si svolgeva in questo spirito.
Non sempre questo atteggiamento comportava un puro e semplice rifiuto del linguaggio
naturale, ma, rispetto al linguaggio naturale, le teorie del linguaggio finivano per assumere
un ruolo prescrittivi più che descrittivo. Di conseguenza, le teorie del linguaggio elaborate
da questi filosofi avevano solo di rado e indirettamente rilievo per la linguistica, che,
ovviamente, non può non farsi carico di tutti i tratti di presunta “indisciplina” delle lingue
naturali.
Peraltro, la filosofia del linguaggio si è differenziata dalla linguistica anche per una ragione
in un certo senso opposta, cioè per il suo impegno teorico su aspetti della conoscenza del
linguaggio di cui la linguistica riconosceva l’importanza, ma che non riusciva a occupare in
modo soddisfacente: anzitutto la semantica, o teoria del significato.
Questa lacuna è stata largamente occupata dalla filosofia del linguaggio, e le ragioni, in
primo luogo, sono che il problema del significato appartiene alla tradizione filosofica; in
secondo luogo i problemi filosofici che interessavano ai filosofi linguistici si ponevano come
problemi del significato di certe parole o di certe frasi, e sollecitavano, per essere affrontati
adeguatamente, una teoria del significato delle parole e delle frasi.
La filosofia del linguaggio ha quindi svolto una funzione di supplenza rispetto alla linguistica
nell’area della teoria semantica, e contemporaneamente è stata il luogo principale della
discussione metodologica ed epistemologica su di essa.
Il paradigma dominante
Introduzione
Il paradigma dominante nella filosofia del linguaggio del Novecento può essere
caratterizzato dalla congiunzione di tre tesi, due positive e una negativa:
1. il significato di un enunciato dichiarativo si identifica con le sue condizioni di verità,
cioè con la specificazione delle circostanze in cui l’enunciato è vero. L’enunciato
dichiarativo è dunque l’unità linguistica privilegiata: la teoria semantica è
essenzialmente una teoria del significato degli enunciati.
2. il valore semantico di un’espressione complessa dipende funzionalmente dai valori
semantici dei suoi costituenti (composizionalità del significato); il modo della
dipendenza è determinato dalla struttura sintattica dell’espressione complessa.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Luce87123 (luceforconi@gmail.com)
3. immagini, rappresentazioni o altri enti mentali eventualmente associati alle
espressioni linguistiche non sono i significati delle espressioni, e l’elaborazione
mentale delle espressioni linguistiche (la comprensione come processo mentale) non
è rilevante per la determinazione del significato delle espressioni stesse.
Le tesi 1 e 2 si devono a Frege.
La filosofia del linguaggio di Frege: termini singolari
Gottlob Frege (1848-1925) fu uno dei fondatori della logica contemporanea ed alcuni
decenni dopo la sua morte è stato considerato anche il fondatore di una disciplina
filosofica detta “filosofia del linguaggio”. A Frege si devono nozioni centrali del
paradigma dominante, come l’analisi della predicazione e degli enunciati quantificati,
l’idea della composizionalità del significato e la coppia senso/denotazione; e fu Frege a
porre per primo problemi canonici come quelle del significato delle descrizioni definite o
quello dei contesti di atteggiamento preposizionale.
Buona parte delle idee semantiche di Frege sono esposte in tre brevi saggi degli anni
1891-1892, Funzione e concetto, Senso e denotazione e Concetto e oggetto.
Frege chiama “nomi propri” quelli che oggi si chiamano di solito termini singolari, cioè le
espressioni linguistiche che designano uno e un solo oggetto (es. Vercelli, l’uomo più ricco di
Vercelli, Aldo Rossi).
Ad ogni nome proprio sono associati, secondo Frege, un senso e una denotazione.
La denotazione del nome è l’oggetto designato (nell’esempio, la città di Vercelli, l’uomo più
ricco della città, la persona che porta quel nome).
Il senso è il “modo in cui un oggetto viene dato” dal nome; può essere concepito come il
contenuto cognitivo associato al nome, ovvero come uno dei vari modi in cui un oggetto può
essere determinato, in quanto “da luogo ad un particolare nome” di quell’oggetto.
È chiaro che uno stesso oggetto può essere designato da più espressioni linguistiche,
ciascuna delle quali costituisce uno specifico percorso per giungere a quell’oggetto.
L’attuale Regina d’Inghilterra può essere designata mediante l’espressione Elisabetta II o
appunto la regina d’Inghilterra, ciascuna di queste espressioni presenta la sua denotazione
(che è la stessa in tutti i casi) in un suo modo specifico, che è il suo senso.
Secondo Frege non basta dire che espressioni diverse (nomi diversi) hanno la stessa
denotazione, ma dobbiamo associare a ciascuna espressione un senso, cioè un modo in cui
essa presenta la sua denotazione; questo perché, sempre secondo Frege, le parole non sono
strumenti di conoscenza ne veicoli della comunicazione, lo diventano soltanto in quanto
associate a una denotazione.
Il senso di un’espressione quindi non è altro che il modo particolare in cui essa rinvia alla
sua denotazione.
Due espressioni distinte possono avere lo stesso senso: perciò il senso non è un altro modo
di chiamare ciò per cui un’espressione linguistica si differenzia da un’altra.
Dal senso di un’espressione linguistica va tenuta distinta la rappresentazione connessa
all’espressione, cioè l’ente mentale che l’espressione può richiamare nella nostra mente;
infatti le rappresentazioni sono inevitabilmente soggettive perché ciascuno di noi associa a
una stessa espressione una rappresentazione diversa.
Ma il linguaggio deve essere capace di esprimere un contenuto oggettivo se la
comunicazione dev’ essere possibile, per esempio per comunicarci reciprocamente un
contenuto di conoscenza.
L’imperfezione del linguaggio naturale consente la formazione di espressioni anomale, che
hanno un senso ma non una denotazione (es. il corpo celeste più lontano). In un linguaggio
perfetto ciò non dovrebbe avvenire: nessun segno infatti potrebbe essere introdotto o
formato senza che gli venisse garantita una denotazione, ma noi nel linguaggio naturale in
qualche modo parliamo sul presupposto che i termini singolari che usiamo abbiano una
denotazione.
Gli enunciati e il principio di composizionalità
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Luce87123 (luceforconi@gmail.com)
Anche gli enunciati (dichiarativi) hanno un senso e una denotazione: il senso di un
enunciato è il pensiero che esso esprime, la sua denotazione è il suo valore di verità (cioè il
Vero, se l’enunciato è Vero, o il Falso, se è falso).
Secondo il principio di composizionalità di Frege il valore semantico (senso e denotazione) di
qualsiasi espressione complessa è funzione dei valori semantici dei suoi costituenti.
Frege constata come un enunciato esprime un pensiero, e si domanda se il pensiero
espresso possa essere la denotazione dell’enunciato. Se così fosse, il pensiero espresso non
dovrebbe mutare, ove si sostituisse, nell’enunciato, una sua parte con un’altra di uguale
denotazione. Questa assunzione presuppone il principio di composizionalità.
Consideriamo ad esempio l’enunciato:
1. La stella del mattino è un corpo illuminato dal sole
Se sostituiamo “la stella del mattino” con “la stella della sera” (che ha la stessa
denotazione, entrambi i termini denotano il pianete Venere) otteniamo
2. la stella della sera è un corpo illuminato dal sole
che esprime ovviamente un pensiero diverso. Quindi, se la denotazione rispetta il principio
di composizionalità, la denotazione di un enunciato non può essere il pensiero espresso.
A sostegno della sua tesi secondo cui la denotazione è il valore di verità, Frege porta due
argomentazioni di tipo induttivo.
La prima muove dalla constatazione che siamo interessati alla denotazione dei costituenti di
un enunciato quando e soltanto quando siamo interessati a sapere se l’enunciato è vero o
falso.
La seconda argomentazione parte invece dall’osservazione che il valore di verità di un
enunciato non cambia quando si sostituiscono costituenti di uguale denotazione: (1) e (2)
hanno lo stesso valore di verità (sono entrambi veri).
Il principio di composizionalità ci dice che la denotazione di un enunciato è qualcosa che
non cambia per sostituzione di costituenti equidenotanti: quindi il valore di verità, avendo
questa proprietà di invarianza, è un candidato legittimo (diversamente dal pensiero
espresso) ad essere identificato con la denotazione dell’enunciato.
Secondo Frege di un enunciato non interessa mai soltanto la denotazione, ma il modo
particolare in cui esso denota quel determinato valore di verità. “La conoscenza è nella
connessione del pensiero con la sua denotazione, ossia con il suo valore di verità”.
Il principio di composizionalità sta alla base di buona parte della ricerca semantica
contemporanea. Una sua (importante) motivazione è quella che sarebbe difficile capire,
senza ammettere un principio di composizionalità del significato, come è possibile che noi
comprendiamo frasi che non abbiamo mai sentito, senza che ci vengano spiegate e alla sola
condizione di conoscerne le parole.
Evidentemente noi calcoliamo il significato delle espressioni nuove a partire dai significati
delle loro sottoespressioni, che già conosciamo. Il significato di un’espressione complessa è
in questo senso funzione dei significati dei suoi costituenti: la conoscenza dei significati dei
costituenti basta a determinare, sulla base della struttura sintattica dell’espressione, il
significato dell’espressione complessa.
Il senso di un enunciato è l pensiero che esso esprime. I pensieri non devono essere
concepiti come enti mentali e perciò soggettivi, ma come enti oggettivi che possono essere
patrimonio comune di più persone.
Frege giustifica l’oggettività dei pensieri con l’identificazione di senso e verità. Tale
giustificazione dipende infatti da quella che oggi chiamiamo una concezione realistica della
verità, cioè dall’idea che un enunciato è vero o falso a seconda di come stanno le cose,
indipendentemente dal fatto che noi sappiamo come stanno o possiamo saperlo.
Di conseguenza, le condizioni di verità di un enunciato sono indipendenti dal fatto che esso
sia formulato, compreso, ecc.. e in ciò consiste, per Frege, l’oggettività del pensiero che
l’enunciato esprime. Dunque l’oggettività dei pensieri non è altro che l’oggettività delle
condizioni di verità degli enunciati.
Limiti della composizionalità
Non sempre il valore semantico è del tutto in funzione dei valori semantici delle parti. È il
caso dei contesti enunciativi che Frege chiama indiretti, come:
• Copernico credeva che le orbite dei pianeti fossero cerchi (3)
Contiene, come suo costituente, l’enunciato (4)
5
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Luce87123 (luceforconi@gmail.com)
• Le orbite dei pianeti sono cerchi
Ora, (4) è falso (denota il Falso); tuttavia, se lo sostituiamo – nel contesto di (3) – con un
altro enunciato anch’esso falso, dunque di identica denotazione, non necessariamente
otteniamo un enunciato che ha lo stesso valore di verità di (3).
Queste eccezioni alla composizionalità avrebbero potuto indurre Frege a rivedere le sue idee
sul senso e la denotazione degli enunciati. Invece, egli ritenne di correggerle soltanto per il
caso particolare dei contesti indiretti.
In un contesto come (3), un sottoenunciato come (4), secondo Frege, non denota la sua
denotazione abituale (cioè un valore di verità), ma denota un pensiero, e precisamente il
pensiero che esso normalmente esprime, vale a dire il suo senso abituale.
Se ammettiamo che le cose stiano così, il principio di composizionalità è salvo anche nel
caso dei contesti indiretti: se infatti in questi contesti sostituiamo un sottoenunciato con un
altro che abbia lo stesso senso (cioè la stessa denotazione indiretta) il valore di verità
dell’intero enunciato non cambia.
Predicati e concetti
Nel saggio Funzione e concetto, Frege cerca di chiarire la nozione matematica di funzione, e
mostra che essa è di applicazione più generale di quanto i matematici credano. Si dice
abitualmente che
(6) 2 . x3 + x
è funzione di x, o che
(7) 2 . 23 + 2
è funzione di 2.
Ma l’espressione (7) non designa certamente una funzione: essa è un simbolo complesso
che denota un numero (il num. 18). Se (7) fosse l’espressione di una funzione, le funzioni
non sarebbero altro che numeri.
L’essenza della funzione sta nella forma comune a (6) e (7), che potremmo rappresentare
con
(8) 2 . ()3 + ()
come (8) fa vedere, una funzione è essenzialmente incompleta; quel che si ottiene
completando la funzione è il suo valore per un determinato argomento. Chiamiamo decorso
di valori di una funzione l’insieme dei suoi valori per i suoi argomenti.
Non tutte le funzioni hanno per valori dei numeri: vi sono funzioni il cui valore è un valore di
verità (il Vero o il Falso).
Secondo Frege ciò che in logica è chiamato concetto è intimamente connesso con ciò che
noi chiamiamo funzione. Un concetto è una funzione il cui valore è sempre un valore di
verità.
Anche il linguaggio naturale è capace di esprimere funzioni. Per esempio, l’espressione la
“capitale di……….” Può essere considerata designare una funzione, che fa corrispondere a
ciascuna nazione la sua capitale.
E il linguaggio naturale è pure capace di esprimere concetti, cioè funzioni il cui valore è
valore di verità. Per esempio, l’espressione “………è la capitale della Francia” denota una
funzione che assume il valore Vero per l’argomento Parigi, e Falso per tutti gli altri
argomenti.
Le espressioni “………… è un uomo” sono dette predicati. I predicati risultano essere
espressioni linguistiche che denotano un particolare tipo di funzioni: funzioni i cui valori
sono valori di verità, cioè concetti.
Il predicato “……….è un uomo” denota il concetto uomo, cioè una funzione che assegna ad
un argomento il Vero se l’argomento è un uomo, e il Falso altrimenti. C’è dunque una certa
asimmetria tra il trattamento del soggetto e il trattamento del predicato: ma per Frege è
cruciale che non sia così, i predicati devono denotare funzioni, cioè enti insaturi. Solo così,
infatti, è possibile spiegare il nesso preposizionale, ciò che tiene insieme una proposizione:
una proposizione si ottiene saturando un concetto con un oggetto.
Russel: forma grammaticale e forma logica
Il filosofo e matematico inglese Bertrand Russel (1872 – 1970), autore dei Principi della
Matematica, nell’articolo Sulla denotazione attaccò il quadro concettuale freghiano di Senso
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Luce87123 (luceforconi@gmail.com)
e denotazione, contrapponendogli un’analisi del linguaggio che fa a meno del concetto di
senso perché la sola proprietà semantica rilevante per il valore di verità degli enunciati è la
denotazione.
Secondo Russel, riflettendo sugli enunciati che contengono descrizioni, indefinite (un uomo)
o definite (l’autore di Waverley), la forma grammaticale superficiale di questi enunciati
maschera la loro vera forma logica, cioè la loro struttura semantica effettiva. La forma
logica degli enunciati contenenti descrizioni indefinite viene ricondotta da Russel alla
quantificazione esistenziale.
Per esempio, “ho incontrato un uomo” può essere parafrasato in “esiste un x tale che x è un
uomo e ho incontrato x”. Nella parafrasi, che esprime in modo trasparente la forma logica
dell’enunciato, l’espressione “un uomo” non compare più come costituente.
Attraverso la parafrasi proposta da Russel, l’enunciato “l’attuale re di Francia è calvo” viene
ridotto ad una formulazione in cui compaiono soltanto espressioni (predicati) che denotano
proprietà di individui, oltre all’apparato della quantificazione. Potrebbero comparirvi anche
nomi propri, cioè espressioni che non denotano proprietà bensì individui. Ma, anche qui, non
è scontato che le espressioni la cui apparenza grammaticale è quella di nomi propri siano
davvero tali, siano cioè logicamente propri.
Il concetto di nome proprio, per Russel, è quindi un concetto semantico che ha una sua
fondazione epistemologica, basata sulla distinzione tra conoscenza diretta e conoscenza per
descrizione. Molte cose sono conosciute solo attraverso le loro proprietà, cioè attraverso una
loro descrizione: così, ad esempio, conosciamo Socrate non direttamente, ma come quel
tale filosofo ateniese, maestro di Platone ecc…
La concezione puramente denotativa del linguaggio di Russel contribuì alla lunga eclissi
della nozione freghiana di senso. Essa influì potentemente sulla formazione del Tractus
logico-philosophicus di Wittgenstein per almeno tre aspetti: per la distinzione tra forma
grammaticale e forma logica, per l’idea di analisi e per l’idea che la proposizione analizzata
sia essenzialmente una connessione di nomi che denotano direttamente individui o
proprietà.
Il Tractatus logico-philosophicus: teoria della raffigurazione
Le riflessioni sul linguaggio di Wittgenstein sono sintetizzate nel Tractus logico-
philosophicus, dove lo scopo principale è rispondere alla domanda in che cosa le
proposizioni della logica si distinguono da tutte la altre del linguaggio. Wittgenstein formula
una teoria generale del linguaggio, in cui si tratta di cogliere l’essenza della proposizione;
concepisce una proposizione semplice come una struttura relazionale (del tipo Rabc), che
asserisce che certi oggetti (a, b, c,) stanno tra loro nella relazione R: per esempio, che a si
trova tra b e c.
Ma una proposizione ha anche una forma (es. la forma Rabc potrebbe essere indicata da
Xxyz), e Wittgenstein si chiedeva in che modo una proposizione può comunicarci la sua
forma. La forma deve essere esibita dalla proposizione: come una fotografia esibisce la
struttura della situazione che essa raffigura allo stesso modo una proposizione mostra la
struttura di ciò che asserisce.
Wittgenstein arriva quindi a pensare una proposizione come un’immagine. Solo concependo
la proposizione come un’immagine riusciamo a rendere ragione del fatto che essa può
comunicarci un’informazione nuova. Essa ci dice, sulla realtà, qualcosa che non sapevamo
prima; e ce lo dice usando soltanto le sue parti costitutive, le parole, e la loro disposizione.
Una proposizione deve comunicare con espressioni vecchie un senso nuovo.
Wittgenstein ci invita a compiere un processo di astrazione, dalle immagini nel senso
comune del termine alla proposizione come immagine logica; e cerca di farci vedere che,
nel processo, l’essenza della raffigurazione non va perduto.
Il massimo livello di astrazione è raggiunto da una forma di raffigurazione che rappresenta
relazioni in generale: questa è la forma logica, e un’immagine che abbia come forma di
raffigurazione la forma logica è detta immagine logica. Ogni immagine è anche logica
perché, perché ogni immagine consta di elementi in qualche relazione; la forma logica è la
forma della realtà, ma l’immagine soltanto logica dei fatti è il pensiero. Il pensiero è il
sistema di raffigurazione in cui le immagini hanno in comune con i fatti raffigurati soltanto la
struttura nel senso più astratto del termine.
Ma in che modo una proposizione, che si presenta come una lista di parole, può essere
un’immagine, cioè un fatto strutturato che raffigura un altro fatto?
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Luce87123 (luceforconi@gmail.com)
Wittgenstein concepisce la proposizione come una concatenazione di nomi o segni semplici
che significano oggetti del mondo. Gli oggetti, come i nomi, sono tutti insaturi: sono
essenzialmente entità combinabili, non indiscriminatamente ma a certe condizioni.
Solo nella connessione della proposizione un nome ha significato, perché il significato di un
nome – l’oggetto che esso denota – si dà soltanto in configurazioni, in combinazioni con altri
oggetti raffigurate da proposizioni.
Affinché il senso di una proposizione sia determinato occorre che la sua analisi abbia fine, e
perciò devono esservi oggetti semplici che ne costituiscono il punto d’arrivo. Per
Wittgenstein il senso di una proposizione è ciò che si conosce quando si comprende la
proposizione, dunque lo stato di cose raffigurato, ovvero il modo in cui le cose stanno se la
proposizione è vera. La proposizione mostra come stanno le cose e dice che le cose stanno
così. Può essere vera, o falsa, e per sapere se sia vera occorre confrontarla con la realtà. Ma
per comprenderla non è necessario sapere che è vera o che è falsa; comprenderla è sapere
che accada se essa è vara.
A questo modo Wittgenstein istituisce il rapporto tra significato enunciativo e verità, che
sarà centrale nel paradigma dominante.
Senso e condizione di verità
Nel linguaggio, oltre alle proposizioni semplici, ve ne sono altre dette complesse. Queste
proposizioni, come le negazioni, le congiunzioni, le disgiunzioni, contengono espressioni
dette costanti logiche (non, e, o, ecc..) che secondo Russel significano oggetti logici mentre
per Wittgenstein, invece, le costanti logiche non hanno valore designativi. Le costanti
logiche hanno la sola funzione di determinare in che modo il senso di una proposizione
complessa in cui compaiono dipende dal senso delle proposizioni più semplici di cui essa è
costituita. Il senso di ogni proposizione complessa, infatti, dipende dal senso delle
proposizioni elementari di cui è costituita.
Nel Tractus, il principio di composizionalità risulta essere una conseguenza della definizione
del senso della proposizione. Una proposizione è sensata se e solo se mostra di quali stati di
cose asserisce la sussistenza o la non sussistenza. Dunque, affinché una proposizione sia
sensata, bisogna che si veda dalla proposizione stessa quali stati di cose sussistono (o non
sussistono) se la proposizione è vera; cioè quali proposizioni elementari sono vere (o false)
se la proposizione è vera.
Il senso dell’intera proposizione (la sua possibilità di verità) dipende dai sensi delle
proposizioni costituenti (dalle loro possibilità di verità). Se abbiamo a che fare con una
proposizione sensata, dobbiamo essere in grado di calcolare per quali valori di verità dei
costituenti elementari la proposizione è vera e per quali è falsa. La proposizione è una
funzione di verità delle proposizioni elementari.
Il Tractus chiama le possibilità di verità dei costituenti elementari condizioni di verità delle
proposizioni, e sostiene che la proposizione è l’espressione delle sue condizioni di verità.
Tra i possibili gruppi di condizioni di verità vi sono due casi estremi: quello di una
proposizione vera per qualsiasi combinazione di valori di verità dei suoi costituenti
elementari e quello di una proposizione falsa per qualsiasi combinazione. Il primo caso è
quello della tautologia (es. o nevica o non nevica) il secondo quello della contraddizione (es.
piove e non piove).
Le proposizioni della logica si distinguono da tutte le altre perché sono vere comunque
stiano le cose: la loro verità è indipendente dai fatti del mondo, e perciò può essere
determinata senza confrontarle col mondo, diversamente da quanto avviene nel caso delle
altre proposizioni. Esse non hanno alcun contenuto raffigurativo: non sono immagini della
realtà, non trattano di nulla, non dicono nulla.
Ma se si può asserire che una situazione sussiste, dev’essere possibile asserire che essa non
sussiste: dev’essere possibile, cioè, dire come starebbero le cose se non si dessero le
condizioni della rappresentazione, il che è assurdo.
Questa drastica posizione di Wittgenstein sul simbolismo dev’essere ricondotta al fatto che
per il Tractatus c’è un solo linguaggio (il linguaggio) e non c’è quindi un altro linguaggio in
cui descriverne le proprietà.
Il neopositivismo e l’interpretazione empiristica del Tractatus
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Luce87123 (luceforconi@gmail.com)
I neopositivisti pensavano che il linguaggio di cui parlava il Tractatus fosse un linguaggio
ideale: essi davano per scontato che le proprietà che Wittgenstein attribuiva al linguaggio,
con la sua teoria della raffigurazione e della vero-funzionalità, non potessero essere ascritte
al linguaggio naturale. Inoltre, i neopositivisti tendevano a leggere il Tractatus in senso
empiristico, interpretando la riduzione di tutte le proposizioni a funzioni di verità di
proposizioni elementari come una fondazione dell’edificio della scienza su una base di
enunciati d’esperienza.
Carnap non ritiene di dissentire da Wittgenstein quando afferma che ogni enunciato della
scienza è in ultima analisi un enunciato sulle relazioni che sussistono tra le esperienze
elementari sicchè ogni conoscenza che ha un contenuto si riconduce all’esperienza.
La verificabilità empirica è dunque, per i neopositivisti, criterio di significanza.
Stabilire il significato di un enunciato equivale a stabilire le regole secondo cui l’enunciato
va usato, e questo, a sua volta, è lo stesso che stabilire la maniera in cui esso può essere
verificato (o falsificato). Il significato di un enunciato è il metodo della sua verificazione.
I neopositivisti usarono il criterio della verificabilità empirica come strumento di lotta
antimetafisica. Per loro gli enunciati della metafisica non sono falsi bensì insensati, o perché
sono mal formati sintatticamente, o perché fanno uso di segni privi di significato; e un segno
è privo di significato se non è specificato il suo criterio di applicazione, cioè se non sono
specificate le condizioni di verità delle proposizioni più semplici in cui il segno compare, cioè
se le suddette proposizioni semplici non sono logicamente equivalenti ad enunciati di
esperienza immediata (proposizioni protocollari), i quali a loro volta sono intrinsecamente
sensati.
Da tutto ciò si denota come il neopositivismo, e in particolare il pensiero di Carnap,
rappresenti in filosofia del linguaggio, lo svolgimento di un’interpretazione empiristica della
Prima Tesi del paradigma dominante, in cui il concetto di condizione di verità è sostituito da
quello di verificazione empirica.
Questa dottrina semantica, che di solito viene chiamata verificazionismo, trovò sempre
minor consenso a partire dalla metà degli anni cinquanta.
Tarski: un metodo per l’esplicitazione delle condizioni di verità
È merito storico di Alfred Tarski (1902–1985) aver reso possibile l’estensione dell’analisi ad
enunciati quantificati di qualsiasi complessità, e aver fornito un metodo di determinazione
delle condizioni di verità degli enunciati semplici più facilmente applicabili al linguaggio
naturale.
Entrambi questi risultati sono, in un certo senso, un corollario della Teoria della verità di
Tarski.
Come già per Aristotele, anche per Tarski la verità è una proprietà degli enunciati di un
linguaggio. Ma quali condizioni bisogna soddisfare, definendo una proprietà di enunciati, per
poter dire che ciò che abbiamo definito è la verità? Tarski propone, come condizione di
adeguatezza materiale di una definizione di verità, la seguente: una definizione di vero (per
il linguaggio L) è materialmente adeguata se e solo se da essa sono deducibili tutti gli
enunciati della forma
(T) N è vero (in L) se e solo se p,
dove N è il nome di un dato enunciato di L, e p è la sua traduzione nel metalinguaggio in cui
la definizione è formulata (e rispetto al quale L è il linguaggio-oggetto).
Lo schema (T) cattura, secondo Tarski, il nucleo minimo delle nostre intuizioni sulla verità:
quali che siano le nostre idee filosofiche al riguardo, siamo tutti d’accorso ad esempio che,
se l’enunciato “Platone era allievo di Socrate” è vero, allora Platone era allievo di Socrate, e
viceversa se Platone era allievo di Socrate allora l’enunciato “Platone era allievo di Socrate”
è vero.
Tarski pensava che lo schema (T) esplicasse la concezione classica della verità (quella per
cui vero è sinonimo di realtà).
Il procedimento di Tarski per definire il predicato di verità per questo linguaggio è piuttosto
complesso. Basti dire che Tarski definisce la nozione ausiliaria di soddisfazione, definisce il
predicato di verità per L1 sulla base della soddisfazione, e fa vedere che questa definizione
implica tutti i bicondizionali della forma (T).
La nozione di soddisfazione (e indirettamente quella di verità) è definita da Tarski come
relazione tra formule e oggetti o sequenze di oggetti. Intuitivamente, per esempio, una
coppia di oggetti (a,b) soddisfa la formula Pxy se )e solo se) a e b sono nella relazione
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Luce87123 (luceforconi@gmail.com)
denotata da P. il passaggio attraverso la nozione di soddisfazione è richiesto dalla struttura
del linguaggio.
Bisogna evitare di confondere la concezione tarskiana della verità e la particolare
definizione di vero (in L1) che Tarski propose per esemplificare la sua concezione.
L’espressione “teoria della verità” è usata ambiguamente, per designare ora l’una ora l’altra
cosa.
I rapporti tra le due sono complesse: la definizione proposta da Tarski non è certamente la
sola che sia conforme alla sua concezione della verità, e d’altra parte il criterio di
adeguatezza materiale non è una definizione della verità, ma, appunto un criterio per
definizione di verità.
In ogni caso, è stata la definizione di “vero (in L1) a imporsi come modello di analisi
semantica. Per un certo periodo, l’analisi semantica di un linguaggio venne più o meno
identificata con la sua interpretazione semantica, nel senso della connessione delle
espressioni semplici del linguaggio con le loro denotazioni in un dominio: e la teoria
semantica venne identificata con la teoria della denotazione o del riferimento.
Questa è la concezione che viene accolta dalla definizione di Morris, secondo cui la
semantica “tratta del rapporto dei segni coi loro designata e così con gli oggetti che,
eventualmente, essi denotano”.
La teoria semantica di Carnap
All’interno di una semantica di tipo tarskiano, gli enunciati modali come (12)
“necessariamente 9 è maggiore di 7” non ammettono un’analisi composizionale: il valore di
verità di (12) non è funzione delle denotazioni dei suoi costituenti.
Dunque (12) non è composizionale rispetto alla denotazione, che è come dire che una teoria
puramente referenziale non è in grado di dar conto della struttura semantica di (12), e in
generale degli enunciati modali.
La coppia freghiana senso/denotazione deve essere sostituita da concetti rigorosamente
definiti. Carnai definisce questi concetti intensione ed estensione.
Ciò posto, Carnai definisce le condizioni di identità per l’estensione e l’intensione, cioè le
circostanze in cui due espressioni linguistiche hanno la stessa estensione (o la stessa
intensione). Cominciando dagli enunciati, diciamo che due enunciati p e q hanno la stessa
estensione se valgono o non valgono entrambi nella descrizione di stato vera; dunque p e q
hanno la stessa estensione se e solo se sono entrambi veri, o entrambi falsi. L’estensione di
un enunciato può quindi identificarsi con il suo valore di verità (V o F), com’era in Frege per
la denotazione. Diciamo invece che p e q hanno la stessa intensione se p vale in tutte le
descrizioni di stato in cui vale q, e viceversa. Intuitivamente, p e q hanno la stessa
intensione se sono veri negli stessi mondi possibili, cioè nelle stesse circostanze. Conoscere
l’intensione di un enunciato è sapere in quali circostanze esso è vero. A questo modo,
Carnai formalizza l’idea centrale del paradigma dominante, secondo cui il significato di un
enunciato di identifica con le sue condizioni di verità.
Carnai definisce le condizioni di identità estensionale e intenzionale anche per le altre
categorie di espressioni semanticamente autonome, in generale, due espressioni hanno la
stessa intensione se e solo se hanno la stessa estensione in tutte le descrizioni di stato.
In termini di definizione diretta, l’estensione di un termine singolare è un individuo, quella di
un predicato è una classe; l’intensione di un enunciato è detta proposizione, quella di un
predicato proprietà, quella di un termine singolare concetto individuale.
Atteggiamenti proposizionali
L’efficacia dell’apparato teorico di Carnap non si estende a tutti i contesti non estensionali,
cioè a tutti quegli enunciati la cui estensione non è funzione delle estensioni costituenti.
I contesti di atteggiamento preposizionale non sono composizionali nemmeno rispetto
all’intensione. Per ovviare a questa difficoltà, Carnai introduce un nuovo concetto: quello di
struttura intensionale, e prova a sostenere che enunciati come (18), pur non essendo
composizionali rispetto all’intensione, lo sono rispetto alla struttura intensionale. Risulta,
infatti che ’68 + 57 = 125’ e ‘3 + 3 0 6’, pur avendo la stessa intesione, non hanno la stessa
struttura intensionale ( e per questo (18) e (19) non sono semanticamente equivalenti). La
10
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Luce87123 (luceforconi@gmail.com)
proposta di Carnai, pur essendo stata ripresa anche in seguito, è risultata abbastanza presto
inadeguata.
Il lessico e i postulati di significato
Gli enunciati veri in tutte le descrizioni di stato sono detti ‘L-veri’ (cioè logicamente veri);
Carnai presenta il concetto di L-verità come un equivalente rigoroso del concetto kantiano di
verità analitica. Tuttavia, come fece subito notare Quine, solo una parte degli enunciati
comunemente detti ‘analitici’ risultano L-veri nel sistema di Significato e necessità.
In altre parole, il significato originario di Carnai non prevede vincoli di compatibilità tra
enunciati atomici: se due enunciati sono atomici possono valere nella stessa descrizione di
stato, quale che sia il significato intuitivo dei predicati che vi compaiono. Il sistema, quindi,
non è in grado di di distinguere tra enunciati veri in virtù del significato delle parole e
enunciati in forza dei fatti del mondo; e dunque non costituisce un’esplicazione completa
delle nostre intuizioni semantiche. Per ovviare a questo inconveniente, Carnai elabora la
teoria dei postulati di significato, che rappresenta il solo contributo alla semantica lessicale.
Un postulato di significato è la stipulazione di una relazione tra estensioni di predicati.
Asserendo un postulato come
(20) per ogni x, se x è scapolo allora x non è sposato
noi stipuliamo che le estensioni di ‘scapolo’ e ‘sposato’ siano disgiunte (cioè non abbiano
elementi comuni). Se scegliamo di far valere (20) in tutte le descrizioni di stato – cioè di fare
di (20) un vincolo sulle intensioni di ‘scapolo’ e ‘sposato’ – avremo come conseguenza che
nessuna descrizione di stato potrà contenere sia ‘a è scapolo’ sia ‘ a è sposato’ (per
qualsiasi a).
un enunciato come ‘Se Giorgio è scapolo, allora non è sposato’ varrà allora in tutte le
descrizioni di stato; e la nozione di verità analitica coinciderà con quella di L-verità, se
avremo asserito postulati di significato che catturino tutte le relazioni semantiche tra unità
lessicali. E’ chiaro, infatti, che le varie relazioni di senso, oggetto tradizionale della
semantica linguistica, come l’iponimia (rosa è iponimo di fiore), la sinonimia (pulpito è
sinonimo di pergamo), l’antonimia (scapolo e sposato sono antonimi), possono essere
espressi da postulati di significato.
La semantica dei mondi possibili e il programma di Montague
Le analisi semantiche di Carnapo non si applicano direttamente al linguaggio naturale; si
applicano a linguaggi formali artificiali (come il nostro linguaggio L), e al linguaggio naturale
nella misura in cui esso è riconducibile ad un linguaggio formale.
Un allievo americano di carnai, Richard Montague concepì l’ambizioso progetto di un’analisi
semantica diretta di una lingua naturale (l’inglese) che raggiungesse lo stesso grado di
rigore delle teorie semantiche per i linguaggi formali, tanto da poter essere considerata a
tutti gli effetti un teoria matematica.
La teoria fu elaborata originariamente per dimostrare le proprietà formali (completezza,
consistenza, ecc.) dei sistemi di logica modale, che analizzano le relazioni logiche tra
enunciati formali con operatori come ‘E’ necessario che’, ‘E’ possibile che’ : sono esempi di
tali relazioni l’mplicazione tra ‘E’ necessario che p’ e ‘p’ e quella tra ‘p’ e ‘E’ possibile che p’,
ben note ai filosofi medievali. In una semantica dei mondi possibili, un’espressione
linguistica è interpretata relativamente ad un mondo possibile.
Veniamo allora alla teoria di Montague (detta spesso grammatica di Montague). Della teoria
esistono due versioni principali: la prima esposta in L’inglese come linguaggio formale
(1968), e la seconda, oggi più spesso applicata, in Il corretto trattamento della
quantificazione nell’inglese comune. Montagne riteneva che una lingua naturale come
l’inglese potesse essere trattata a tutti gli effetti come un linguaggio formale, e che la sua
interpretazione semantica non differisse, in linea di principio, da quella di un linguaggio
logico; quindi era possibile esplicitare completamente i nessi semantici riconosciuti da un
parlante competente, cioè formulare una teoria in cui tali nessi fossero dimostrabili. In una
grammatica di Montague si possono distinguere tre componenti: un modulo grammaticale,
che genera le espressioni ben formate della ingua; un modulo di traduzione, che assegna a
ciascuna struttura sintattica la sua traduzione in un linguaggio logico di ordine superiore al
primo (“logica intensionale”); e un modulo di interpretazione, in cui le formule del
11
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Luce87123 (luceforconi@gmail.com)
linguaggio logico sono interpretate in strutture algebriche complesse (basate sulla teoria
degli insiemi) in modo tale che risultino determinate le condizioni di verità delle formule
corrispondenti agli enunciati inglesi, cioè i loro nessi implicativi.
Nelle formulazioni più mature della teoria, tutte le interpretazioni sono intenzionali; il valore
semantico che un’interpretazione assegna ad un’espressione linguistica è un’estensione,
cioè una funzione che assegna una denotazione a una coppia costituita da un mondo
possibile e un contesto d’uso. Nei sistemi di Montagne, il passaggio attraverso un linguaggio
logico non è essenziale: è possibile definire una funzione che interpreta direttamente le
strutture sintattiche generate dal primo modulo. Dunque l’inglese è davvero trattato come
un linguaggio formale.
Si parla di una grammatica di Montagne per intendere il trattamento di un determinato
frammento di una lingua secondo i principi sopra specificati; mentre la grammatica di
Montagne è il metodo generale di trattamento del linguaggio naturale.
Il metodo di Montagne realizza pienamente l’idea di composizionalità della semantica.
L’interpretazione di un’espressione complessa è infatti sempre una funzione delle
interpretazioni dei suoi costituenti, che dipende solo dalla struttura sintattica
dell’espressione complessa.
L’interpretazione di ciascun costituente dipende solo da quelle dei suoi costituenti
immediati.
Si parla in questo caso di composizionalità regola per regola: l’interpretazione procede
passo a passo, interpretando ogni costituente sulla base della regola sintattica mediante la
quale è formato e delle interpretazioni dei suoi costituenti immediati.
La realizzazione di questa perfetta composizionalità comporta qualche sacrificio, tra l’altro
per quanto riguarda la plausibilità delle analisi sintattiche, ma alle critiche dei chomskiani,
Montagne restava indifferente.
In realtà, ciò che divideva Montagne dai chomskyani era soprattutto un’idea profondamente
divers adei compiti della teoria linguistica. Per Montagne, la semantica deve certo dar conto
delle intuizioni dei parlanti ma non deve preoccuparsi di riprodurre ipotetici processi mentali
soggiacenti all’interpretazione semantica di un enunciato da parte di un parlante.
L’idea che una regola sintattica o una regola di interpretazione semantica debbano essere
plausibilmente imputabili a una mente finita come quella umana è del tutto estranea a
Montagne, per cui la semantica è parte della matematica, non della psicologia.
12
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Luce87123 (luceforconi@gmail.com)
Tre filosofi
Introduzione
La riflessione sul linguaggio degli anni cinquanta-sessanta è dominata da tre grandi figure:
Wittgenstein, Austin, Quine. In realtà, l’influenza di Wittgenstein precede le altre, perché
comincia a esercitarsi attraverso l’insegnamento a Cambridge e con la pubblicazione
postuma delle ricerche filosofiche (1953).
Anche Austin agisce soprattutto attraverso l’insegnamento a Oxford e le due influenze
sembrano per un certo periodo convergere determinando uno stile caratteristico della
filosofia britannica (filosofia analitica, linguistica, del linguaggio).
Oggi però sembra chiaro che le posizioni di Austin e del ‘secondo’ Wittgenstein furono
sempre molto diverse, nonostante il comune interesse per il linguaggio quotidiano.
Il pensiero di Quine invece rappresenta un risultato dell‘ emigrazione americana del
neopositivismo e del suo incontro-scontro con istanze del pragmatismo.
Il ‘secondo’ Wittgenstein
Wittgenstein fu sempre interessato ai problemi della filosofia in generale e non pensò mai
che il suo fine ultimo fosse la formulazione di una teoria del linguaggio.
Tuttavia è indubbio che il Tractatus logico-philosophicus contenga una tale teoria, sia pure
finalizzata alla chiarificazione di problemi quali la natura della logica o lo statuto dell’etica.
Ma nella seconda fase della vita di Wittgenstein le cose cambiano e negli anni 1929-1933
egli si libera gradualmente dell’idea stessa di teoria generale del linguaggio perché non gli
appare più come una condizione preliminare delle analisi filosofiche che intende svolgere,
ma gli sembra il frutto di un pregiudizio metafisico.
Con tutto ciò, le ricerche filosofiche (1953) contengono, oltre che una miriade di
osservazioni acute e profonde su singoli fenomeni linguistici, anche idee che è difficile non
prendere come elementi di una teoria del linguaggio, o come indicazioni sulla forma di una
tale teoria, come la proposta di sostituire alle domande sul significato, domande sulla
spiegazione del significato.
La critica del Tractatus
13
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Luce87123 (luceforconi@gmail.com)
Il Tractatus riconduceva il linguaggio a un insieme di proposizioni elementari. Queste, a loro
volta, sono nessi di nomi la cui connessione riproduce la struttura dello stato di cose di cui
la proposizione è immagine.
I nomi denotano oggetti, ed è grazie al rapporto di denotazione tra nomi e oggetti, e
all’identità di struttura tra proposizione e stato di cose, che la preposizione è in grado di
presentare lo stato di cose.
Il concetto freghiano di denotazione (il rapporto tra un nome e ciò che esso designa) e l’idea
che le unità linguistiche vere, profonde, siano tutti nomi propri, cioè espressioni che
designano singoli oggetti, sono elementi cardinali del quadro teorico del Tractatus.
Nelle più tarde ricerche filosofiche Wittgenstein fa vedere diffusamente come al rapporto di
denotazione non si possa attribuire il ruolo di fondare la semanticità del linguaggio.
Sembra che le definizioni estensive siano in grado di istituire i significati delle parole, in
realtà una definizione ostensiva viene interpretata a partire dalla funzione che si sa che
essa deve svolgere, e sullo sfondo di una già acquisita padronanza del linguaggio: essa
spiega l’uso della parola, quando sia già chiaro quale funzione la parola debba svolgere, in
generale, nel linguaggio.
L’idea di denotazione appare a Wittgenstein come il risultato di un’ipersemplificazione
filosofica rispetto ai molteplici usi di un nome e comunque una semplificazione inaccettabile
dal momento che non si possono trattare tutte le parole come nomi.
L’uniformità nel modo di presentarsi delle parole maschera la varietà delle loro funzioni, che
Wittgenstein paragona alla varietà della funzioni degli attrezzi che si trovano in una cassetta
di utensili; si assomigliano tutte, e tutte sono fatte per essere afferrate con le mani , ma
operano tutte diversamente.
L’assimilazione di tutte le parole a nomi, e di tutte le funzioni semantiche al rapporto di
denominazione, è una delle fonti principali di errori filosofici, secondo Wittgenstein, perché
induce per esempio a guardare al vocabolario psicologico per ogni nome, e dunque
presumere, per ciascuno di essi, uno stato o processo mentale che esso designa.
La critica del Tractatus investe anche la teoria delle proposizioni e delle loro relazioni. Il
Tractatus vincolava strettamente la forma delle proposizioni elementari e quelle delle
proposizioni complesse. Quanto alle relazioni tra proposizioni, esse sono relazioni logiche o
non sono: le proposizioni elementari sono assolutamente indipendenti l’una dall’altra.
Quest’ultimo è il primo aspetto della dottrina del Tractatus a essere investito dalla critica di
Wittgenstein: due proposizioni elementari possono contraddirsi, dunque c’è una costruzione
logica che non lavora con l’aiuto delle funzioni di verità.
A partire dalla metà degli anni trenta, Wittgenstein userà sempre più spesso il termine
grammatica per intendere l’insieme delle regole d’uso delle espressioni di un linguaggio.
Anche l’idea di proposizione elementare verrà abbandonata da Wittgenstein nel corso degli
anni trenta, perché anch’essa fa torto alla varietà di linguaggio.
La teoria delle proposizioni elementari era parte di una filosofia del linguaggio che
privilegiava in modo esclusivo la sua funzione descrittiva. Nelle ricerche, questa diventa una
funzione tra molte altre: dare ordini, far congetture intorno a un avvenimento, inventare una
storia, ecc…
Somiglianze di famiglia e giochi linguistici. Grammatica
Il distacco di Wittgenstein dalla filosofia del linguaggio del Tractatus ha forse la sua radice
principale nell’abbandono dell’atteggiamento essenzialista, cioè della pretesa di catturare
filosoficamente l’essenza del linguaggio e della proposizione.
Wittegenstein non pensa più che determinare l’essenza del linguaggio, della proposizione e
della regola sia una condizione per poter analizzare il linguaggio, parlare di proposizione e
identificare regole, e giunge a ipotizzare che possa trattarsi di un compito impossibile, non
è detto che ci sia l’essenza del linguaggio. Ogni volta che abbiamo a che fare con un nome
comune come appunto linguaggio, proposizione noi diamo per scontato che esso sia
applicato sulla base di un’essenza comune, condivisa da tutti gli oggetti o fenomeni per cui
il nome è utilizzato
La dottrina delle somiglianze di famiglia è stata considerata una nuova teoria dei concetti,
e come tale è all’origine della teoria dei prototipi di E.Rosch, una teoria empirica
psicologico-cognitiva che riguarda la rappresentazione mentale del significato dei termini
universali.
14
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Luce87123 (luceforconi@gmail.com)
Essa si svolge di pari passo con lo sviluppo della concezione radicalmente pluralista del
linguaggio che si impernia sull’idea di gioco linguistico. Non ci sono molti tipi di parole e
molti tipi di proposizioni: ci sono molti linguaggi.
L’espressione gioco linguistico è usata da Wittgenstein in modo non uniforme. Essa si
riferisce di volta in volta a: a) situazioni immaginarie e molto semplificate di uso di linguaggi
rudimentali, che vengono schizzate per evidenziare questo o quell’aspetto del nostro uso
del linguaggio; b) usi specializzati del linguaggio, in connessione con determinati scopi o
nell’ambito di determinate attività; c) un uso complessivo del linguaggio.
In tutti questi impieghi, pur così diversi, l’idea di giuoco rimanda all’idea di regola: i giochi
linguistici sono costituiti da regole per l’uso di certe espressioni in certe circostanze. Il
compito della filosofia è la descrizione di queste regole.
Wittgenstein parla spesso del significato di una parola anche come del suo ruolo nel calcolo,
perché pensa il gioco linguistico in analogia con un sistema formale. In seguito abbandonerà
questo modo d’espressione, che mal si adatta a descrivere situazioni di uso del linguaggio in
cui non tutto è regolato, e le regole possono cambiare.
Sono comunque tutti modi più o meno equivalenti di alludere al fatto che il significato di una
parola è il modo in cui essa è usata, è dato dalle regole del suo uso.
È chiaro che i concetti di uso e di grammatica sono a malapena l’inizio di una teoria del
linguaggio; l’indicazione di descrivere l’uso, o di chiarire la grammatica di ‘espressione
linguistica non ci dice granchè su quali proprietà o relazioni dell’espressione debbano essere
prese in considerazione.
Ma Wittgenstein non era interessato alla teoria del linguaggio in questo senso: dal suo punto
di vista, l’indicazione ha soprattutto un valore negativo e terapeutico. Guardare all’uso è
innanzitutto non presumere di sapere già che tipo di significato ha una parola, e in secondo
luogo non è generalizzare all’intero linguaggio un unico modello semantico, per esempio
quello della denotazione, cercando quindi in ogni caso qualcosa che stia all’espressione in
questione.
La critica del mentalismo. Non c’è un linguaggio privato
Nelle ricerche filosofiche Wittgenstein combatte senza tregue due tesi, a entrambi le quali è
stato dato il nome di mentalismo. La prima è una tesi psicologica, secondo cui i termini della
psicologia ‘ingenua’ sono nomi di stati o processi mentali. La seconda è una tesi semantica,
cioè l’idea che i significati delle parole siano, in generale, enti mentali.
Si tratta di due tesi distinte, non solo nel senso che si può condividere la prima e non la
seconda, ma anche nel senso che è diverso, ad esempio, sostenere che l’intenzione è uno
stato mentale e invece sostenere che il significato della parola ‘intenzione’ è un ente
mentale, quale che sia il suo rapporto con la cosa stessa, con l’intenzione.
Contro la tesi psicologica Wittgenstein sostiene che la comprensione del linguaggio non è un
processo psichico perché le esperienze vissute, i fenomeni psichici non sono la
comprensione.
Contro la tesi semantica invece Wittgenstein prova a immaginare un linguaggio le cui
espressioni assumono significato per il fatto di essere associate ad esperienze vissute del
soggetto che istituisce il linguaggio. Questo tipo di linguaggio, per ragioni di principio,
conterrebbe delle espressioni i cui significati sarebbero inaccessibili a tutti tranne che al
soggetto interessato. È il cosiddetto argomento contro il linguaggio privato, che per
Wittgenstein non è un linguaggio. Questo argomento ha svariate conseguenze, soprattutto
in filosofia.
L’immagine del linguaggio che è certamente implicata, e forse anche presupposta,
dall’argomento contro il linguaggio privato è quella di una collezione di strumenti
intrinsecamente pubblici, a cui è essenziale la possibilità di essere usati scorrettamente,
non rispetto a valori funzionali precostituiti, ma rispetto ad una norma depositata nell’uso di
una comunità.
La filosofia del linguaggio di Dummet
Il filosofo inglese M.A.E. Dummet ha tentato una complessa mediazione tra le istanze del
paradigma dominante e alcuni aspetti del pensiero secondo Wittgenstein. Del paradigma
15
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Luce87123 (luceforconi@gmail.com)
dominante egli condivide anzitutto il progetto di una teoria del significato, mentre
soprattutto da Wittgenstein egli deriva i requisiti che una tale teoria deve soddisfare. In
primo luogo, per Dummet una teoria del significato deve essere una teoria della
comprensione. In secondo luogo, la teoria deve rendere conto del carattere pubblico del
significato: deve cioè rappresentare la conoscenza del significato come una competenza
controllabile, che deve dunque manifestarsi in comportamenti pubblici.
La tesi, secondo Dummet, è giustificata dal fatto che l’enunciato è l’unità linguistica minima
con cui è possibile compiere un atto linguistico, cioè un atto concreto di comunicazione.
Dummet aderisce al paradigma dominante anche per l’insistenza sul carattere sistematico
della teoria del significato. La comprensione del linguaggio ha natura composizionale: la
nostra capacità di comprendere un’infinità di enunciati mai incontrati prima non può che
derivare dalla padronanza di principi che riguardano il modo in cui le singole parole
contribuiscono a determinare il significato di enunciati in cui compaiono.
Una teoria del significato consta dunque di una teoria del senso (che ne costituisce il
nucleo) e di una teoria della forza (che si occupa delle condizioni a cui un enunciato
costituisce un’asserzione). Frege e il paradigma dominante hanno ritenuto che la nozione
centrale della teoria del senso sia quella di verità: il senso di un enunciato si identifica con
le sue condizioni di verità. Il contributo principale di Dummet consiste nel domandarsi se, ed
eventualmente in che senso questa concezione è compatibile con i requisiti che una teoria
del significato deve soddisfare: anzitutto con l’idea che essa debba dar conto della
comprensione del linguaggio, e con il carattere pubblico del significato.
Dummet propone di identificare la verità con l’asseribilità: la conoscenza del senso di un
enunciato si identificherà allora con la conoscenza delle sue condizioni di asseribilità.
Comprendere un enunciato non è conoscere la condizione che lo renderebbe vero nel senso
del realismo, è, invece, sapere in quali casi saremmo disposti ad asserire l’enunciato, cioè
che cosa vale, per noi, come giustificazione dell’enunciato. La concezione di Dummet
comporta il rischio dell’olismo semantico, comporta cioè che il senso di un enunciato possa
essere fatto dipendere dall’intero linguaggio a cui esso appartiene. Ma Dummet rifiuta
l’olismo, e quindi la sua posizione sembra quindi sostenibile solo a condizione che la
giustificazione di un enunciato sia sempre riconducibile ad una giustificazione che riflette la
struttura di un enunciato.
L’analisi del linguaggio comune
Il centro del lavoro filosofico di J.L. Austin (1911-1960) è rappresentato dall’analisi del
linguaggio comune. Austin pensava che ogni indagine filosofica dovesse cominciare da un
inventario il più possibile completo del materiale linguistico pertinente al problema scelto: si
trattava di cogliere tutte le parole, e le costruzioni linguistiche, che l’uso comune associa al
problema.
Disegnare la mappa di un territorio concettuale ripercorrendo le distinzioni tracciate dal
linguaggio comune è, per Austin, quasi tutto il lavoro del filosofo. Quasi tutto, perché il
linguaggio comune (a) è organizzato dal punto di vista di interessi pratici più che teoretici,
(b) è fondamentalmente prescientifico, (c) incorpora a volte ‘superstizioni, errori e fantasie
di tutti i generi’.
Di conseguenza, esso non è l’ultima parola in filosofia. Tuttavia, ricorda Austin, è la prima.
In realtà accertare le circostanze d’uso di un’espressione linguistica non è operazione che
non dia luogo a controversie.
Austin era consapevole del fatto che l’analisi del linguaggio comune poteva avere esiti
divergenti, ma invitava a non drammatizzare.
Differenti determinazioni delle circostanze d’uso corrispondono a schemi concettuali diversi:
accertare e localizzare le divergenze è comunque illuminante.
Austin, quindi, non pensava né che l’uso comune fosse assolutamente autorevole (esso è la
prima parola, non l’ultima), né che la sua determinazione fosse univoca. Pensava invece che
la riflessione sull’uso delle parole avesse molti vantaggi, non ultimo dei quali l’isolamento e
la precisazione dei punti di contrasto tra visioni del mondo. L’analisi del linguaggio comune,
da questo punto di vista, condivide molte motivazioni del ‘passaggio al modo formale di
Carnap’ e ‘dell’ascesa semantica’ di Quine.
16
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Luce87123 (luceforconi@gmail.com)
Performativi e atti linguistici
Nel saggio ‘Le altre menti’ (1946) Austin riflette sui problemi che oggi vanno sotto il titolo
generale di ‘autorità della prima persona’: posso sbagliare quando asserisco enunciati (in
prima persona) come ‘provo dolore’ o ‘vedo qualcosa di rosso?’. Nel corso di queste
riflessioni, Austin fu indotto a sottolineare il carattere non descrittivo di enunciazioni come
‘lo so’. Quando dico ‘lo so’ non sto descrivendo il mio stato interiore come uno stato di
eccezionale conoscenza, sto dando agli altri la mia parola, cioè sto dando loro la mia
autorità per asserire ciò che dico di sapere. Analogamente, quando dico ‘lo prometto’ non
sto descrivendo una mia azione, ma la sto compiendo. Queste ‘frasi rituali’ a rigore non
possono essere false, anche se può risultare che le circostanze non erano tali da consentire
il compimento del rito: non posso regalare X (dicendo ti regalo X) se X non è mio.
Austin diede formulazione compiuta e indipendente a queste idee, introducendo qualche
cambiamento terminologico. Chiamò performativi (cioè esecutivi) quegli enunciati che non
descrivono né constatano alcunché (e perciò non sono né veri né falsi), ma la cui emissione
comporta o si identifica con l’esecuzione di un’azione. Dicendo ‘scommetto dieci euro che
domani piove’ non si asserisce nulla, ma si fa qualcosa (una scommessa): si compie una
vera e propria azione, che modifica la realtà. Perché ciò avvenga, tuttavia, occorre che si
diano alcune condizioni (dette condizioni di felicità del performativo): bisogna che vi sia una
procedura socialmente accettata di cui l’emissione dell’enunciato fa parte, che essa sia
svolta correttamente e completamente, e che l’enunciato sia emesso nelle circostanze
appropriate e dalle persone appropriate.
Se queste condizioni non sono soddisfatte, l’atto è nullo. Inoltre, se chi emette l’enunciato
non ha l’atteggiamento giusto o non si comporta in seguito coerentemente con quanto ha
detto, il performativo è sì riuscito ma, dice Austin, abusato. Sono invece constativi i normali
enunciati descrittivi, che sono veri o falsi.
Austin cercò di caratterizzare i performativi in base alla forma sintattica, al materiale
lessicale, senza ottenere però risultati soddisfacenti e così queste difficoltà, lo indussero ad
abbandonare la teoria dei performativi per un punto di vista più generale secondo cui ogni
enunciazione ha un aspetto performativo, o, come egli disse, illocutorio.
È questa la teoria degli atti linguistici.
Un atto linguistico è un azione di uso del linguaggio da parte di un parlante (scrivente ecc…
): Austin considera l’atto linguistico il ‘solo fenomeno reale’ del linguaggio, e dunque il solo
oggetto proprio di una teoria del linguaggio.
Compiendo un atto linguistico si compiono contemporaneamente tre atti distinti: un atto
locutorio (l’atto di dire determinate parole), un atto illocutorio (l’atto che si compie nel dire
quella frase: nel nostro caso l’assunzione di un impegno) e un atto perlocutorio, cioè
un’azione sull’interlocutore, che ha su di lui determinati effetti.
A sua volta, l’atto locutorio ha tre aspetti: fonetico (la produzione di una sequenza di suoni),
fatico (la produzione di parole o frasi in quanto appartenenti a una determinata lingua,
determinata da un lessico o una grammatica) e retico (l’uso di quelle parole o frasi con un
determinato senso e riferimento).
Austin intendeva (a) trattare le asserzioni, (b) riformulare la dottrina del senso e del
riferimento; a questo modo egli candidava la teoria degli atti linguistici al ruolo di teoria
generale del linguaggio, di cui la semantica dominante, opportunamente rielaborata,
avrebbe costituito un capitolo.
Austin aveva distinto cinque classi di atti linguistici consistenti nel proferimento di un
enunciato, sulla base della forza illocutoria dell’enunciato proferito: verdettivi, come le
sentenze, esercitivi, come le nomine, commissivi, come le promesse, comportativi, come le
scuse, espositivi, come le dimostrazioni. Le asserzioni sono un tipo di espositivi: risultano
quindi un sottocaso di un sottocaso di atto linguistico.
Una classificazione parzialmente diversa fu proposta in seguito dal filosofo americano J.R.
Searle, il quale sottoponeva a revisione la teoria austiniana delle condizioni di felicità degli
atti allocutivi, analizzando dettagliatamente l’atto della promessa, di cui individuò nove
condizioni di riuscita.
Più nettamente di Austin, Searle rifiutò la distinzione tra semantica e pragmatica, ritenendo
che significare, e dire qualcosa che è dotato di significato, siano aspetti dell’illocuzione, e
rientrino perciò nel campo della teoria degli atti linguistici.
17
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Luce87123 (luceforconi@gmail.com)
Grice: significato e intenzioni
Nella teoria degli atti linguistici di Searle, un posto centrale è occupato dal concetto di
intenzione: la descrizione di un atto linguistico fa riferimento essenziale alle intenzioni dl
parlante.
Un professore di Oxford, H.P.Grice (1913-1988), in una serie di articoli degli anni cinquanta
e sessanta, aveva proposto una riduzione della nozione di significato a quella di intenzione.
‘il parlante A significa qualcosa mediante l’espressione X’ è analizzato come ‘A intende che
l’emissione di X produca un certo effetto nell’interlocutore, in forza del riconoscimento di
questa intenzione’. Definito così il significato che un parlante intende veicolare in una data
occasione, Grice riconduce a questo gli altri usi di ‘significato non-naturale’: ‘x significa
qualcosa (in una determinata occasione), ecc…
la nozione di intenzioni del parlante entra in modo essenziale anche nell’altra proposta
teorica importante di Grice, la cosiddetta teoria della conversazione.
La teoria della conversazione vuol dar conto dei molti aspetti del ‘significato globale’ di
un’enunciazione che non sono catturati da un’analisi semantica in termini di condizioni di
verità.
Secondo Grice si tratta di derivare le eccedenze comunicative da una caratterizzazione
sistematica dell’interazione tra il significato convenzionale di un’espressione linguistica e il
contesto della conversazione.
Per Grice, la conversazione è un’impresa razionale cooperativa, retta da un principio che
impone di rendere il proprio contributo ad una conversazione funzionale al suo buon
andamento. Il principio si specifica in quattro gruppi di massime: della quantità (es. non
essere reticente), della qualità (es. non dire ciò che credi essere falso), della relazione (sii
pertinente), del modo (es. evita l’ambiguità).
Le massime possono essere ovviamente violate, e questa parte implicita della
comunicazione è detta da Grice implicatura: implicatura conversazionale, se dipendente
dall’interazione tra il significato convenzionale delle parole dette e la struttura della
conversazione, implicatura particolarizzata, se dipendente dallo specifico contesto che si
immagina.
Accanto alle implicature conversazionali, Grice colloca le implicature convenzionali, che
sono parte del significato convenzionale di ciò che è detto: per esempio, l’opposizione tra p
e q è un’implicatura convenzionale degli enunciati della forma ‘p ma q’ (ed è ciò che
distingue la parola ma dalla parola e).
La nozione di implicatura convenzionale ripropone la distinzione di Frege tra senso e tono:
come il tono, l’implicatura convenzionale è quell’aspetto del significato di un’espressione
che non fa una differenza per le condizioni di verità degli enunciati in cui essa compare, e
però è parte di ciò che l’espressione comunica in qualsiasi contesto.
Quine: la critica della nozione di significato
Il filosofo statunitense W.V.O. Quine divenne uno dei principali affossatori del movimento
filosofico dei neopositivisti, di cui criticò alcune tesi centrali: il convenzionalismo, il
riduzionismo, la netta separazione tra indagini concettuali (di pertinenza della filosofia) e
indagini fattuali (compito delle scienze naturali). Con tutto ciò, Quine restò sempre fedele
non solo alle istanze di chiarezza e rigore argomentativi caratteristiche del neopositivismo,
ma all’idea che le scienze della natura, la matematica e la logica siano il nocciolo duro della
conoscenza umana, e costituiscono un modello linguistico oltre che epistemico.
Agli inizi degli anni quaranta Quine interviene nella discussione sulla teoria semantica
mostrando che la nozione intuitiva di significato non è riducibile a quella di riferimento; di
conseguenza, una teoria del riferimento come la semantica tarskiana non è in grado di
catturare completamente le nostre intuizioni sul significato.
Quine invece di cercare un’esplicazione scientificamente accettabile della nozione intuitiva
di significato, fece vedere nel saggio ‘Due dogmi dell’empirismo’ che nessun concetto
siffatto poteva essere definito. Quine sostiene che la teoria del significato più che occuparsi
di misteriosi enti detti ‘significati’, deve dar conto della relazione di sinonimia (identità di
significato) tra espressioni linguistiche, e della proprietà detta analiticità (un’asserzione è
18
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Luce87123 (luceforconi@gmail.com)
analitica se è vera in virtù del significato delle parole che la costituiscono, e non in virtù di
come stanno le cose nel mondo).
L’analiticità è spiegata in termini di sinonimia, la sinonimia è definita in termini di
intersostituibilità in un linguaggio intenzionali, ma la decisione sull’ intersostituibilità nei
contesti (intenzionali) della forma ‘necessariamente p’ dipende dal riconoscimento
dell’analiticità di p.
L’argomentazione di Quine è stata criticata da molti, ma, nel complesso, è risultata
persuasiva, e ha gettato un discredito quasi definitivo sulla venerabile distinzione tra
enunciati analitici e enunciati sintetici.
Quine ha voluto dire che la nozione di significato teorizzata dai neopositivisti e dagli analisti
del linguaggio è insostenibile.
Essa si fonda sulla possibilità di identificare certe informazioni come pertinenti per il
significato di una parola; cioè sulla possibilità di distinguere in modo sistematico tra
enunciati analitici e sintetici.
Le nostre intuizioni di sinonimia e analiticità non sostengono, per Quine, una tale distinzione
sistematica. Esse sostengono soltanto una gradazione tra le informazioni, e tra gli enunciati
che le esprimono.
Tutte le verità sono tali sia in virtù del linguaggio, sia dei fatti.
Quine era giunto a questa concezione già alcuni anni prima, in ‘Verità per
convenzione’ (1936); rifiutando la fondazioni convenzionalistica della logica, egli
riconduceva la dicotomia tra verità a priori (come quella della logica) e verità a posteriori a
un contrasto tra asserzioni accettate con maggiore o minore fermezza.
Cade quindi, sotto la critica di Quine, il programma dell’analisi del linguaggio nella misura in
cui esso presupponeva una rigida demarcazione tra concettuale e fattuale; cade di
conseguenza l’idea di una netta separazione tra filosofia e scienza, e cade, forse
soprattutto, una forma della distinzione tra linguaggio e teoria: all’interno di un linguaggio si
possono distinguere enunciati veri da enunciati falsi, ma non si possono distinguere
enunciati costitutivi dei significati delle parole (i gatti sono animali) e enunciati applicativi
dei significati delle parole (i gatti dell’isola di Man hanno la coda mozza).
Si apre così la porta alla cosiddetta tesi dell’incommensurabilità delle teorie, che
presuppone le rilevanza semantica di tutti gli asserti di una teoria.
Indeterminatezza del significato e del riferimento
Si può pensare di determinare il significato di un’espressione linguistica specificando le
connessioni intralinguistiche che lo costituiscono.
La critica di Quine alla distinzione analitico/sintetica mostra che questa strada non è
percorribile. Alternativamente si può pensare di determinare il significato di un espressione
attraverso le sue connessioni con la realtà extralinguistica, cioè con l’esperienza.
Il progetto di una riduzione dei significati all’esperienza sensibile era stato parte del
programma dei neopositivisti; Quine aveva criticato l’esecuzione che ne aveva dato Carnai
mostrando che la riduzione proposta era incompleta. Le due idee, della distinzione analitico/
sintetico e della riducibilità dei significati a una base puramente empirica hanno secondo
Quine una radice comune: la tesi secondo cui la verità di un enunciato è determinata da due
fattori separabili, uno linguistico e uno fattuale o empirico.
In Parola e oggetto (1960) Quine prova a prendere sul serio l’idea di una fondazione
empiristica dei significati. Egli immagina una situazione in cui si debba interpretare un
linguaggio soltanto sulla base del comportamento di chi lo parla, e dei dati percettivi che si
suppongono ugualmente disponibili ai parlanti e all’interprete.
È la situazione della traduzione radicale: una traduzione tra due lingue che non hanno canali
culturali di comunicazione, perché appartengono a culture che si immaginano
completamente separate.
Si tratta cioè di una situazione in cui l’assegnazione di significati alle espressioni di un
linguaggio non ha altra base che le connessioni del linguaggio con l’esperienza, quali
risultano accessibili ad un osservatore.
In tale situazione, la traduzione secondo Quine sarebbe indeterminata: sarebbero possibili
più manuali di traduzione diversi, incompatibili tra loro e invece ugualmente compatibili con
19
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Luce87123 (luceforconi@gmail.com)
tutti i dati disponibili, cioè con tutti i comportamenti linguistici e non linguistici dei parlanti
e con tutti i dati percettivi disponibili al traduttore.
Cioè che interessa a Quine non è la traduzione ma il significato: egli intende sostenere che il
significato e il riferimento delle espressioni di un linguaggio non possono essere determinati
sulla sola base del comportamento linguistico dei parlanti in relazione a dati percettivi che si
presumano comuni a parlanti e interprete.
Il problema non è la vaghezza del gesto d’ostensione, ma il fatto che un gesto d’ostensione
non può esplicitare la concettualizzazione che presuppone: lo stimolo percettivo che viene
indicato può essere concettualizzato in modi molto diversi. La determinatezza è possibile,
secondo Quine, solo a partire da una teoria di sfondo: attribuzioni di significato e riferimento
alle espressioni di un linguaggio sono possibili solo in un altro linguaggio, che si suppone
interpretato e condiviso.
Un’attribuzione determinata di significato è possibile solo come traduzione in un linguaggio
interpretato e condiviso. Non c’è interpretazione come messa in corrispondenza diretta tra
linguaggio e mondo: un’attribuzione di significato è sempre relativa a un linguaggio
interpretato. Un’attribuzione assoluta di significati o di riferimenti, dice Quine, è insensata:
‘quel che ha senso è dire non quali sono in assoluto gli oggetti di una teoria, ma in che
modo una teoria è interpretabile o reinterpretabile in un’altra’.
Il disciplinamento del linguaggio naturale
Risulta dalle analisi di Quine che ogni attribuzione di significato è relativa a una teoria di
sfondo e di fatto, la teoria che fa da sfondo ai linguaggi speciali delle scienze non è altro che
il linguaggio naturale.
Il riconoscimento del primato del linguaggio naturale non comporta tuttavia, nel caso di
Quine, che esso vada trattato come sacrosanto, al contrario, esso merita, e al tempo stesso
richiede di essere disciplinato, per liberarlo da anomalie e conflitti che tendono a ostacolare
la comunicazione, storpiare la deduzione e offuscare la costruzione delle teorie.
In quest’opera di disciplinamento del linguaggio naturale, la stella polare di Quine è
rappresentata dal linguaggio della logica elementare, che possiede pregi esemplari di
chiarezza, economia e trasparenza ontologica; il linguaggio naturale dev’essere il più
possibile ricondotto al linguaggio della logica.
Non si tratta di sostituirlo, ma piuttosto di ritrovare nello stesso linguaggio naturale, fin dove
è possibile, quella struttura logica che il linguaggio simbolico esibisce con piena evidenza, e
i cui elementi costitutivi sono la predicazione, la quantificazione, le funzioni di verità, le
variabili e i termini generali. Si tratta quindi di far vedere come espressioni naturali
apparentemente non riconducibili a forme di prim’ordine possono essere parafrasate da
espressioni sempre più naturali, che equivalgono a quelle di partenza e però esibiscono in
maniera più trasparente una struttura filosoficamente e logicamente accettabile.
Queste parafrasi sono dette da Quine forme canoniche.
Per questo aspetto della sua proposta Quine appartiene pienamente alla tradizione di Russel
e del Tractatus, in cui si distingue tra forma apparente (superficiale, logica) e forma reale
(profonda, logica) delle espressioni del linguaggio naturale, e si assegna all’analisi filosofica
il compito di rilevare la forma logica al di sotto della forma grammaticale superficiale.
In alcuni casi il linguaggio naturale non può essere redento dall’oscurità grazie alla parafrasi
in forma canonica. Ci sono cose che il linguaggio ci lascia dire, che dovremmo
semplicemente evitare di dire.
Come già Frege, così Quine non è alieno da atteggiamenti eliminativi nei confronti del
linguaggio naturale e per questo aspetto egli è un erede della filosofia linguistica, e il suo
lavoro appartiene alla metafisica (analitica) più che alla filosofia del linguaggio.
Davidson
Donald Davidson ha proposto un’idea di teoria semantica basata sulla teoria della verità di
Tarski; egli sostiene che dare le condizioni necessarie e sufficienti per la verità di un
enunciato è un modo di darne il significato.
20
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Luce87123 (luceforconi@gmail.com)
Esplicitare le condizioni di verità degli enunciati di un linguaggio L è formulare una teoria
della verità per L: dove per teoria della verità si intende un insieme di assiomi che implica,
per ogni enunciato del linguaggio, un’enunciazione delle condizioni alle qual esso è vero.
Dal punto di vista di Davidson gli assiomi della teoria devono intendersi come ipotesi sul
significato delle espressioni di base del linguaggio di cui si vuol dare la semantica: esse
sono convalidate se i bicondizionali che ne vengono dedotti esprimono effettivamente le
condizioni di verità degli enunciati di L. ciò presuppone che il metalinguaggio in cui la teoria
è formulata sia compreso, e che si sappia che cosa vuol dire vero: solo così è possibile
confermare o smentire la teoria, verificando se effettivamente i lati sinistri dei bicondizionali
sono veri esattamente quando valgono i corrispondenti lati destri.
In Tarski, si sa già che i bicondizionali sono veri; in Davidson, si tratta di stabilire se lo sono:
una teoria della verità interpretata come teoria del significato per una lingua naturale è una
teoria empirica.
Secondo Davidson, la costruzione di una teoria della verità (intesa come semantica) per un
linguaggio dev’essere concepita come un tentativo di interpretazione radicale: il tentativo di
mettere a disposizione di un interprete tutte le informazioni di cui ha bisogno per
comprendere una lingua che, inizialmente, non capisce affatto. La costruzione della teoria
deve basarsi soltanto sulle manifestazioni di assenso o dissenso dei parlanti alieni, e sui
fatti, che si suppongono ugualmente accessibili al parlante e all’interprete.
Naturalmente, il parlante con cui abbiamo a che fare potrebbe sbagliarsi o mentire; d’altra
parte, almeno all’inizio, non abbiamo altra scelta che ritenerlo veritiero.
È questa l’assunzione del principio di carità di Quine.
Davidsono ritiene che l’obiezione possa essere superata se si assume un punto di vista
olistico: considerando insieme tutti i T-bicondizionali per gli enunciati del linguaggio
conosceremmo il ruolo di ciascuna parte significante dell’enunciato, e le connessioni logiche
tra questo enunciato e altri.
L’interpretazione radicale di Davidsono è un esperimento mentale, che dovrebbe mostrare
su che cosa si fonda l’interpretazione semantica di un linguaggio.
Quine aveva desunto dall’analisi della traduzione radicale l’indeterminatezza del significato.
Davidson lo nega, ma la sdrammatizza. Ogni teoria della verità empiricamente confermata
costituisce un’interpretazione del linguaggio, anche se sarà sempre possibile costruirne
altre, ugualmente confermate, che articolino diversamente rapporti tra significati e
credenze.
Davidson ha sostenuto che l’interpretazione è un’operazione che ciascun parlante compie
nei confronti di ciascun altro parlante nel corso di ciascuna interazione linguistica, e questi
sono anche i limiti della sua validità, dal momento che non si dovrebbe dare per scontato
che essa si applichi ad una lingua, condivisa da una comunità linguistica.
In scritti ancora più recenti, Davidson ha identificato nell’interpretazione la base della
nozione di oggettività. L’idea di pensiero oggettivo, infatti, è essenzialmente connessa con
quella di possibile errore: e la nozione di errore nasce quando un soggetto A associa il
comportamento linguistico di un altro soggetto B con uno stimolo esterno accessibile anche
ad A (triangolazione).
Nell’attuale teoria del linguaggio di Davidson, la triangolazione è alla base sia
dell’apprendimento della prima lingua, sia dell’interpretazione radicale, sia della
comunicazione. La possibilità del linguaggio si fonda sul fatto che noi esseri umani reagiamo
al mondo in modi simili, cioè identifichiamo come salienti gli stessi aspetti del mondo:
l’uniformità delle nostre risposte percettive è ciò che ci consente di coordinare le nostre
risposte verbali.
21
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: Luce87123 (luceforconi@gmail.com)
Potrebbero piacerti anche
- Semantica e pragmatica: un'introduzione: Da Grice ai giorni nostriDa EverandSemantica e pragmatica: un'introduzione: Da Grice ai giorni nostriNessuna valutazione finora
- Appunti Per Un Percorso Sulla Filosofia Del LinguaggioDocumento38 pagineAppunti Per Un Percorso Sulla Filosofia Del LinguaggiolsmokkeNessuna valutazione finora
- Faschilli Filosofia Del Linguaggio CorrettoDocumento6 pagineFaschilli Filosofia Del Linguaggio CorrettoJorge Luis ZarazuaNessuna valutazione finora
- 2013-2014 Ling - Gen.IDocumento24 pagine2013-2014 Ling - Gen.Io___oNessuna valutazione finora
- Nuova Introduzione Alla Filologia RomanzaDocumento13 pagineNuova Introduzione Alla Filologia RomanzaPaolo YogurtNessuna valutazione finora
- Appunti Filosofia Del LinguaggioDocumento47 pagineAppunti Filosofia Del LinguaggioGiuseppe Gabriel CardiNessuna valutazione finora
- Strutt Ural Is MoDocumento44 pagineStrutt Ural Is MoGiovanni AlloccaNessuna valutazione finora
- Linguaggio - e - Pensiero L'Ipotesi Di Sapir-WhorfDocumento46 pagineLinguaggio - e - Pensiero L'Ipotesi Di Sapir-WhorfGermana80% (5)
- 336-Article Text-651-1-10-20160630Documento15 pagine336-Article Text-651-1-10-20160630tulio silvaNessuna valutazione finora
- COSERIU - Linguistica Del TestoDocumento11 pagineCOSERIU - Linguistica Del Testoo___oNessuna valutazione finora
- La Linguistica Testuale Dell'italianoDocumento40 pagineLa Linguistica Testuale Dell'italianoHannah Laxis-TamNessuna valutazione finora
- RovaiDocumento70 pagineRovaiMonica CellaNessuna valutazione finora
- Zavatta Scienza Linguaggio Humboldt PDFDocumento31 pagineZavatta Scienza Linguaggio Humboldt PDFcapitankonigNessuna valutazione finora
- Due Secoli Di Pensiero LinguisticoDocumento54 pagineDue Secoli Di Pensiero LinguisticoFrancescaFaverioNessuna valutazione finora
- Storia Della LinguisticaDocumento24 pagineStoria Della LinguisticaMariarosaria VitielloNessuna valutazione finora
- Fondamenti Di GlottodidatticaDocumento50 pagineFondamenti Di Glottodidatticasuperkikketta98Nessuna valutazione finora
- It Cont Lexicologie CURS Sinteza, R. Toma, An 3. Sem1, 91pgDocumento91 pagineIt Cont Lexicologie CURS Sinteza, R. Toma, An 3. Sem1, 91pgamariah1Nessuna valutazione finora
- Lingua 2Documento2 pagineLingua 2Robson AraujoNessuna valutazione finora
- Appunti VariDocumento81 pagineAppunti VariAgnese BartocciNessuna valutazione finora
- Breve Storia Della Linguistica Di Giorgio Graffi PDFDocumento9 pagineBreve Storia Della Linguistica Di Giorgio Graffi PDFPatrick Gallinotti0% (1)
- Modulo 2 ManualeDocumento10 pagineModulo 2 ManualeGiuseppe FabrisNessuna valutazione finora
- Lingua 1Documento2 pagineLingua 1Robson AraujoNessuna valutazione finora
- Docsity Linguaggio Tra Natura e Storia de MauroDocumento17 pagineDocsity Linguaggio Tra Natura e Storia de MauroGiorgia SibiliaNessuna valutazione finora
- Dispense Marrone Dalla Semiologia Alla SemioticaDocumento45 pagineDispense Marrone Dalla Semiologia Alla SemioticaMartina CasaleNessuna valutazione finora
- SaussureDocumento13 pagineSaussureaurora_m87Nessuna valutazione finora
- Il Potere Del Linguaggio PDFDocumento19 pagineIl Potere Del Linguaggio PDFCarla NatoliNessuna valutazione finora
- La Linguistica GeneraleDocumento19 pagineLa Linguistica GeneraleNew LifeNessuna valutazione finora
- Varvaro Linguistica RomanzaDocumento73 pagineVarvaro Linguistica RomanzaSalvatore CascellaNessuna valutazione finora
- Artigo PT ItDocumento7 pagineArtigo PT ItIsabella SozzaNessuna valutazione finora
- Filosofia Del LinguaggioDocumento12 pagineFilosofia Del LinguaggioSigi GiuliaNessuna valutazione finora
- Capire Le Parole 1Documento17 pagineCapire Le Parole 1Susan ÁngelesNessuna valutazione finora
- GlottologiaDocumento15 pagineGlottologiaAnonymous JxbzuNzNYNessuna valutazione finora
- SintaksaDocumento89 pagineSintaksaivanbuljanNessuna valutazione finora
- Ipotesi Di Sapir WhorfDocumento3 pagineIpotesi Di Sapir WhorfEnrica LibertiNessuna valutazione finora
- Modulo Linguistica Del TestoDocumento81 pagineModulo Linguistica Del Testoalda totaNessuna valutazione finora
- Linguistica ItalianaDocumento108 pagineLinguistica ItalianaLeonardo G. StentaNessuna valutazione finora
- ACAT IngleseDocumento30 pagineACAT IngleseGiulia CefisNessuna valutazione finora
- Linguistica Del Testo E. CoseriuDocumento5 pagineLinguistica Del Testo E. Coseriumaddy FNessuna valutazione finora
- Mounin, Teoria e Storia Della Traduzione - Part III - PDFDocumento6 pagineMounin, Teoria e Storia Della Traduzione - Part III - PDFmripari5280Nessuna valutazione finora
- 4.3. Frege Semantica e Filosofia Del LinguaggioDocumento60 pagine4.3. Frege Semantica e Filosofia Del LinguaggioGiulia ColleoniNessuna valutazione finora
- Fondamenti Di GlottodidatticaDocumento19 pagineFondamenti Di GlottodidatticaEleonora T100% (2)
- GlottologiaDocumento48 pagineGlottologiaANDREA MAURIZIO MAMMARELLANessuna valutazione finora
- La Grammatica Tra Acquisizione e ApprendimetoDocumento26 pagineLa Grammatica Tra Acquisizione e Apprendimetoludovica paolessiNessuna valutazione finora
- Patologie Del Linguaggio e Della ComunicazioneDocumento29 paginePatologie Del Linguaggio e Della ComunicazioneFrancesco MerraNessuna valutazione finora
- Linguistica Descrittiva e Storica - Lezione 1Documento2 pagineLinguistica Descrittiva e Storica - Lezione 1hxxmqfjh6cNessuna valutazione finora
- Filologia Italiana MagistraleDocumento95 pagineFilologia Italiana MagistraleLucia CapognaNessuna valutazione finora
- LEZIONI FILOSOFIA DELLE LINGUE MarinaDocumento12 pagineLEZIONI FILOSOFIA DELLE LINGUE MarinaFlavia PalumboNessuna valutazione finora
- Appunti Linguistica GeneraleDocumento72 pagineAppunti Linguistica GeneraleChiara PasquettiNessuna valutazione finora
- Neuropsicologia Del LinguaggioDocumento8 pagineNeuropsicologia Del LinguaggioGaia StefanelliNessuna valutazione finora
- Teoria Della Taduzione Salmon IIDocumento17 pagineTeoria Della Taduzione Salmon IIparodilidiaNessuna valutazione finora
- Uno Sguardo Alla Linguistica TestualeDocumento19 pagineUno Sguardo Alla Linguistica TestualeelenigeorgiadouNessuna valutazione finora
- Teatro e Teatro Di Figura Nella Didatti Dell'italiano L2Documento249 pagineTeatro e Teatro Di Figura Nella Didatti Dell'italiano L2Alessio LuciaNessuna valutazione finora
- Prima UnitàDocumento8 paginePrima UnitàLucia caponeNessuna valutazione finora
- 1965 I Fondamenti Della Filosofia Del LinguaggioDocumento116 pagine1965 I Fondamenti Della Filosofia Del LinguaggioMicNessuna valutazione finora
- Paola Benincà - Istituzioni Di LinguisticaDocumento36 paginePaola Benincà - Istituzioni Di LinguisticaTiberiu TarabicNessuna valutazione finora
- Traduzione Letteraria - PrassiDocumento34 pagineTraduzione Letteraria - PrassiJoanna Maurici100% (1)
- Apel - Il Problema Del Linguaggio in Wittgenstein e HeideggerDocumento10 pagineApel - Il Problema Del Linguaggio in Wittgenstein e HeideggerStefano PisanoNessuna valutazione finora
- Terminologia semiotica e scienza della traduzione: Esempi nella combinazione inglese-italianoDa EverandTerminologia semiotica e scienza della traduzione: Esempi nella combinazione inglese-italianoNessuna valutazione finora
- Il Razionale e L Assurdo PDFDocumento49 pagineIl Razionale e L Assurdo PDFmIauditNessuna valutazione finora
- Tesi Una Lampada Nella Notte - L''Ars Inventiva Per Triginta Statuas' Di Giordano BrunoDocumento169 pagineTesi Una Lampada Nella Notte - L''Ars Inventiva Per Triginta Statuas' Di Giordano Brunomontag20% (1)
- Come Scrivere Un Articolo Di GiornaleDocumento32 pagineCome Scrivere Un Articolo Di GiornalemistergiapNessuna valutazione finora
- Petrarca - Matematica Per La Musica e Il Suono - Cap. 1 (Insiemistica e Logica)Documento21 paginePetrarca - Matematica Per La Musica e Il Suono - Cap. 1 (Insiemistica e Logica)Alessio SabellaNessuna valutazione finora
- GeometriaDocumento48 pagineGeometriagece25Nessuna valutazione finora
- Brevissima Introduzione Alla Filosofia Del Linguaggio - Filosofia Del Linguaggio 2022Documento4 pagineBrevissima Introduzione Alla Filosofia Del Linguaggio - Filosofia Del Linguaggio 2022Forma AnonimaNessuna valutazione finora
- ARI1 U1 Mappa PDFDocumento2 pagineARI1 U1 Mappa PDFlorenaNessuna valutazione finora
- LORENZONI - Storia Della Filosofia Vol. 1Documento210 pagineLORENZONI - Storia Della Filosofia Vol. 1Antonio de Curtis100% (1)
- Fenomenologia Dell'Immagine Dispense Parte Generale 2016 2017 Prof. Romano GasparottiDocumento36 pagineFenomenologia Dell'Immagine Dispense Parte Generale 2016 2017 Prof. Romano GasparottiGlauco GiustoNessuna valutazione finora
- Logica ProposizionaleDocumento16 pagineLogica ProposizionaleStefanoMartinoNessuna valutazione finora
- Ripasso MatematicaDocumento120 pagineRipasso MatematicaolivigoNessuna valutazione finora