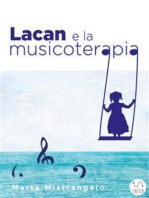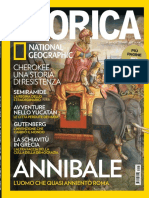Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
This Content Downloaded From 210.13.81.57 On Sun, 14 Nov 2021 05:07:09 UTC
Caricato da
Yali LinTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
This Content Downloaded From 210.13.81.57 On Sun, 14 Nov 2021 05:07:09 UTC
Caricato da
Yali LinCopyright:
Formati disponibili
IL SILENZIO: LE DIMENSIONI SOCIALI
Author(s): GIOVANNI GASPARINI
Source: Studi di Sociologia , aprile-giugno 1995, Anno 33, Fasc. 2 (aprile-giugno 1995), pp.
111-129
Published by: Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/23004390
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
https://about.jstor.org/terms
Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore is collaborating with
JSTOR to digitize, preserve and extend access to Studi di Sociologia
This content downloaded from
210.13.81.57 on Sun, 14 Nov 2021 05:07:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
IL SILENZIO: LE DIMENSIONI SOCIALI
La pulizia ed il silenzio sono indici di civilta. Rispettia
(iscrizione su una piastrella,
a cura del Comune di Capri, Parco Augusto
I - IL SILENZIO E L'ASSENZA DI SILENZIO
II silenzio e definite) solitamente nei vocabolari in termini negat
assenza o privazione: assenza di rumore, di suoni, di voci, di parole, d
sonore.
II silenzio rappresenta la cessazione e l'opposto del par
suoni o rumori. La parola, fondamentale segno e attributo d
puo considerare come un suono articolato espressivo di un'id
care dei contenuti mentali. II suono, a sua volta, e definito
una sensazione percepita dall'organo dell'udito, «dovuta a
l'aria o in altri mezzi elastici con frequenze da 16 a 20m
Zolli 1985). II rumore, d'altra parte, rinvia a fenomeni a
sgradevoli e molesti o nocivi, evocando per contrasto la mus
«combinare i suoni in modo da produrre un'impressione est
Si puo notare en passant che la musica, caratteristica for
non verbale, si serve da parte sua di un'alternanza di suoni
durata: queste ultime sono chiamate anche «silenzi» (di un
ecc.).
II silenzio sembra cosl associato all'idea di astensione da qualche cosa, che
e appunto l'azione umana, la poiesis sul mondo, per quella parte e quella dimen
sione fondamentale che si esprime attraverso la parola e l'emissione di energia
traducibile in percezioni sonore captate dall'udito: in questo senso, al limite, il
silenzio diventa «silenzio di morte» e tende a identificarsi con 1'assenza di co
municazione o l'incapacita sopraggiunta di comunicare, temporanea o definitiva
che essa sia.
Non e un caso, probabilmente, che la voce «Silenzio» sia inesistente o nel
migliore dei casi estremamente ridotta nelle principali enciclopedie, come la
This content downloaded from
210.13.81.57 on Sun, 14 Nov 2021 05:07:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
112 GIOVANNI GASPARINI
Treccani, la Einaudi, l'Enciclopedia Europea Garzanti, la Britannica
paedia Universalis, per non citarne che alcune. In effetti, come si affer
breve nota nel Thesaurus riepilogativo dell'Encyclopaedia Universal
impossibile parlare di cio che e assenza o abolizione di qualunque pa
clopaedia Universalis 1978). Essendo assenza o negazione della parola
a definire e a esprimere, il silenzio viene assimilato cosi alia indete
(Dizionario Enciclopedico Italiano 1960, vol. XI).
In realta, come cercheremo di argomentare, il silenzio e anch'esso
mente uno strumento di comunicazione interpersonale e sociale, es
significati e di situazioni relative a certi contesti. II silenzio si puo con
un fenomeno interstiziale nei nostri sistemi sociali: questo vuol dire c
gamente ad altri fenomeni o situazioni interstiziali, come ad esem
(Gasparini 1992), esso non gode di uno statuto esplicito ed espress
tende piuttosto ad essere trascurato e rimosso, con la conseguenza di
1'analisi e alia concettualizzazione scientifica.
II carattere di eccezione e astensione implicito nel silenzio si riv
nei verbi ad esso collegati: «tacere» (cosi come i verbi corrispondenti n
cipali lingue europee) allude al cessare o all'astenersi dal parlare, ment
un verbo che esprima in senso positivo e profondo il fenomeno e il ge
stare in silenzio. Proprio a questo riguardo, la lingua latina impiegava
lere, verbo intransitivo che puo avere un soggetto impersonale, accan
verbo tacere (Dupuy - Miquel 1990).
Il silenzio ha accezioni, significati e sfumature diverse, potendo co
riferito a contesti naturali, individuali e sociali differenti: il silenzio
sere un fatto tanto di natura che di cultura.
C'e un silenzio della natura o nella natura che e dato dall'assenza di
dallo «stato di un luogo in cui non e percepibile alcun suono, per un c
po» (Robert 1985). E il silenzio che persiste in certe aree naturali rima
paro dell'antropizzazione e della civilta industriale o appositamente
con la creazione di riserve e di parchi naturali. E il silenzio delle resid
wildlife del pianeta, dei deserti soprattutto, che sono per eccellenza lu
trassegnati da scarsa accessibility, solitudine e silenzio.
E, ancora, il silenzio degli spazi infiniti sperimentato o immaginat
parla Pascal nei suoi Pensieri con un senso di sgomento e di angos
1963) o a cui allude Leopardi nella poesia L'infinito (Leopardi 1953).
attuale dell'esplorazione dello spazio, il silenzio degli spazi cosmici puo
re in modo assai pregnante questo tipo di silenzio.
Il silenzio della natura e nella natura assume significato in rapp
sperienza umana, tanto individuale che sociale. Ad esempio, un ind
provare a contatto con questo silenzio (o meglio, con questi silenzi, ch
in effetti assumere forme e gradazioni differenti) emozioni, sensazion
giamenti diversi: rilassamento, pace, quiete interiore, solitudine (con l
valenze di autoespressione e di privazione) , grandezza/piccolezza, s
raviglia, timore, ansia, angoscia, paura, oppressione.
This content downloaded from
210.13.81.57 on Sun, 14 Nov 2021 05:07:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
IL SILENZIO: LE DIMENSIONI SOCIALI 113
Per contrasto, l'esperienza corrente e diffusa della vita vissuta nei
urbano-metropolitani delle nostre societa pone in evidenza i problemi
e anche di notevole gravita che vanno sotto il nome di inquinamento
o acustico, responsabili dell'insorgenza di patologie dell'apparato au
nevrosi, oltre che di un oggettivo degrado della qualita della vita.
Se si considera in termini globali il silenzio nell'accezione che si ri
ia dimensione individuale, lo si identifica in un'azione che consiste app
non parlare. In questa accezione, piu precisamente, il silenzio puo r
una serie di aspetti quali: il fatto che un soggetto non emetta suoni; l
l'atteggiamento di chi resta muto per un certo tempo; il momento stes
tace; e ancora, in senso lato, lo stato di una persona che non ha la poss
volonta di esprimersi (Robert 1985). Per estensione, il silenzio allude a
situazioni in cui c'e da parte di un soggetto omissione di comunicazion
verbali, ma anche di altro tipo, in particolare di quella scritta.
Nella nostra prospettiva di analisi, e opportuno distinguere qui sch
mente tra due situazioni che si configurano come contrapposte: nella
silenzio e frutto di una scelta autonoma e consapevole ed e, appunt
guenza di una decisione dell'attore di astenersi dalla parola o dalla c
ne nelle loro diverse espressioni oggi possibili (comunicazione faccia a
lefonica, per lettera, per telefax, per via informatica, attraverso i me
municazione di massa, ecc.); nell'altra, il silenzio rappresenta l'esito
strizione o di vincoli posti all'attore e che possono assumere gradazion
Tra queste due situazioni contrapposte, si colloca una vasta zona de
ne e della relazionalita sociale, nella quale i comportamenti di silenzio
— come vedremo — nell'osservanza di regole sociali e di pratiche corr
nesse alia partecipazione a determinate unita sociali o a certe fasi e
della vita collettiva.
Nel primo caso, il silenzio, fenomeno tipicamente polisemico, puo corri
spondere a motivazioni individuali diverse, che saranno esplorate con riferi
mento ad una serie di contesti sociali. Tra le altre, non va trascurata qui una mo
tivazione particolare, che rientra in una strategia di gestione del tempo di atte
sa: si tratta cioe di un silenzio che corrisponde ad un comportamento utilizzato
dall'attore per far aspettare altri soggetti, privandoli di elementi di comunica
zione ad essi utili o indispensabili, e per indurli a comportamenti consoni ai pro
pri fini. Casi analoghi e talora parzialmente sovrapposti sono quelli che riguar
dano la scelta di un silenzio attuato per temporeggiare — quindi per rinviare
una decisione —, oppure perche non si vogliono fornire informazioni all'interlo
cutore, o ancora perche non s'intende prendere posizione: il silenzio diventa qui
gesto deliberato di ritiro dalla parola, di non uso dello strumento verbale finaliz
zato a influire sulle scelte e sulla situazione di altri attori con cui si e in
rapporto.
Nel secondo caso sopra evocato, quello del silenzio come esito di costrizio
ni o vincoli o condizionamenti, una situazione estrema che si puo configurare e
This content downloaded from
210.13.81.57 on Sun, 14 Nov 2021 05:07:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
114 GIOVANNI GASPARINI
quella in cui un attore e privato della parola, «ridotto al silenzio», com
guenza dello stato di soggezione o subordinazione rispetto ad altri attori
stema sociale, come nel caso di un prigioniero, di uno schiavo, di una
sottoposta a coercizione o violenza fisica, psicologica o morale.
II silenzio diventa qui mutismo, impossibility o incapacita di par
esprimersi attraverso il linguaggio. Nel Vangelo di Luca viene raccontato
sodio di Zaccaria, che Dio priva della parola (per dargli un segno e punirl
sua scarsa fede, che l'ha fatto dubitare della possibility di una gravidanza
va della moglie Elisabetta) fino alia nascita del figlio, Giovanni che diven
Battista (Lc 1: 18-20, 62-64): si tratta di un mutismo temporaneo, di dur
coscritta.
Altri casi di mutismo si possono individuare ad esempio nelle situazioni in
cui una persona viene a contatto con una lingua sconosciuta o non compresa di
un paese straniero: il silenzio nell'interazione esprime in questo caso incom
prensione e probabilmente imbarazzo, dovuto alia difficolta di comunicare ver
balmente.
A prescindere da questi casi estremi, il silenzio nella sua accezione di rap
porto tra un attore e un contesto sociale puo essere esplorato in situazioni e uni
ta sociali diverse, nonche attraverso motivazioni differenti, come ora ci accin
giamo a fare.
II - GLISPAZI SOCIALI DEL SILENZIO
2.1. Tre specie di silenzio
Rivolgiamo ora l'attenzione al silenzio in quanto elemento che co
a certe regole sociali, connesse al funzionamento di alcune unita soc
lizzarsi di determinate situazioni della vita collettiva.
Una distinzione generale puo essere operata al riguardo tra cont
denominiamo rispettivamente di silenzio generalizzato, di silenzio q
silenzio interattivo. II primo caso (silenzio generalizzato) corrispond
in cui il silenzio e richiesto e compete a tutti gli attori presenti, com
esempio, nel corso di una cerimonia o di un incontro si osserva un
lenzio, per commemorare una o piu persone che sono morte.
Il secondo caso (silenzio qualificato) rappresenta per cosi dire
con eccezioni precisate o qualificate e si verifica allorche in un dato
ritiene che esso debba essere osservato da tutti ad eccezione di uno
ri in posizione-chiave, ad esempio il conferenziere che gli astan
ascoltare o il pianista che esegue un concerto.
Infine, il terzo caso, quello del silenzio denominato interattivo,
dinamiche tipiche dell'interazione verbale fra due o piu soggetti coi
This content downloaded from
210.13.81.57 onf:ffff:ffff on Thu, 01 Jan 1976 12:34:56 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
IL SILENZIO: LE DIMENSIONI SOCIALI 115
conversazione, dove i silenzi punteggiano il discorso e le stesse alte
proche di uso e astensione dalla parola da parte degli interlocutori
no il dialogare: si tratta di una forma di silenzio che in effetti con
vrappone alia problematica della comunicazione verbale e che ci
accennare soltanto.
II silenzio generalizzato esprime implicitamente l'idea di una oss
regole che si ritengono comuni a tutti, quindi di una certa eguagli
nerality degli attori di fronte alle norme che impongono il sile
questo caso infatti quello che si nota di primo acchito e il fatto ch
ge necessariamente simultaneity di comportamenti fra gli attori p
lenzio diventa dunque, insieme, elemento di un processo normativo
che impone il silenzio — ed espressione di un comportamento temp
taneo: il silenzio richiede sincronizzazione e va osservato da tutti in certi mo
menti o in certe fasce temporali, non consente quindi quella che viene chiamata
una situazione di flessibilita temporale (Gasparini 1994).
L'osservanza del silenzio assume, in certe unita e ambiti sociali, il significa
to di adesione alle norme imposte da un'organizzazione: e, ad esempio, il caso
dei conventi di clausura, in cui e prescritto l'obbligo del silenzio per una parte
del giorno; e ancora il caso delle caserme dove ad una certa ora alia sera viene
«suonato il silenzio», con la tromba. In quest'ultimo caso, il silenzio e annuncia
to da un segnale sonoro, emesso da uno strumento musicale, che indica il mo
menta a partire dal quale si deve osservare la prescrizione di astenersi dal parla
re e dal fare rumore nelle camerate e in caserma.
Anche nelle situazioni di silenzio qualificato vigono norme che vengono so
litamente rispettate e che costituiscono la base delle attese di comportamento
degli attori presenti: ma esse riguardano situazioni in cui la dinamica fondamen
tale prevede che il silenzio di quasi tutti gli attori consenta ad uno o pochi altri
— aventi un ruolo distinto e centrale — di parlare o di produrre suoni.
In altri termini, si tratta per lo piu di situazioni in cui il silenzio e finalizza
to all'ascolto e dove l'audizione riveste un carattere ritenuto importante o pre
giato: gli individui che compongono il pubblico intervenuto ad un concerto o ad
una rappresentazione teatrale si astengono dal parlare appunto per poter ascol
tare — e lasciare che ciascuno degli astanti ascolti — le parole, il canto e i suoni
prodotti dagli attori o dai musicisti.
E evidente che, specialmente quando si assiste ad una performance musicale
che per la sua stessa natura esalta il senso dell'udito ed esige concentrazione da
parte di chi ascolta, una buona audizione richiede assoluto silenzio nel corso del
l'esecuzione: la musica, che e tessitura armoniosa di suoni, e incompatibile con i
rumori e con 1'assenza di silenzio in sala. Soltanto alia fine dell'esecuzione, o di
alcune sue parti convenzionalmente precisate, gli spettatori sono legittimati a
rompere il silenzio: essi lo fanno generalmente attraverso un gesto che produce
rumore, 1'applauso. A questo tipico mezzo espressivo non verbale si possono ac
compagnare, sempre alia fine dell'esecuzione, espressioni verbali di apprezza
This content downloaded from
210.13.81.57 on Sun, 14 Nov 2021 05:07:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
116 GIOVANNI GASPARINI
mento riguardo alia performance eseguita e la rottura del silenzio. Dive
so dei concerti rock e simili, dove la funzione di una corretta audizio
re sminuita a vantaggio di altre quali la partecipazione corale e rum
vento, il coinvolgimento del pubblico nel cantare o nel ritmare le can
In altri casi, come quello della conferenza o simili (seminario,
ecc.), il silenzio e richiesto e «atteso» ai fini di consentire al conferen
tore di svolgere la propria comunicazione orale, in un arco di tempo ch
e fissato dal presidente-moderatore o dall'organizzatore dell'incontro,
ge in questi casi il ruolo di «gestore del tempo» (maitre du temps, si d
efficacemente in francese) e che puo quindi togliere e dare la parola,
tenza e di solito amplificata nella sala dall'uso del microfono. Spess
casi, alia fine della conferenza o delle relazioni previste (se si tratta d
gno), il presidente-moderatore da la parola agli intervenuti, al pubbli
miti di tempo solitamente modesti e comunque molto inferiori rispet
rata delle relazioni: e a questo punto che l'intervenuto, cioe l'attore qu
e legittimato a rompere il silenzio impostogli dall'ascolto e dall'org
inerente alia conferenza o convegno, attenuandone in qualche modo la
rale asimmetria comunicativa.
II terzo tipo di silenzio evocato, quello denominato silenzio interat
guarda anch'esso situazioni di comunicazione fra attori ed esigenze
ma in una logica di tipo fondamentalmente simmetrico o comunque m
asimmetrica della precedente. Si tratta, come si e detto, dei silenzi ch
cano e si succedono normalmente nelle situazioni interattive tra d
piu) individui in dialogo. Nel caso di conversazioni telefoniche, do
senso presente e appunto quello dell'udito, questa forma di silenzio e p
mente funzionale alio svolgimento dell'interazione, nel senso che 1
del parlare di entrambi gli attori produce rumore e incomprensione;
tuazione inoltre i silenzi simultanei di entrambi gli interlocutori poss
re particolarmente imbarazzanti e insostenibili per piu di pochi secon
dimostra ad esempio una ricerca svolta sui rapporti tra una grand
servizi pubblici francesi e i suoi clienti (Girin 1992).
2.2. IIsilenzio in alcune unita ed esperienze sociali
Si possono qui evocare anzitutto chiese e conventi, come luoghi fis
sieme spazi sociali in cui gli atteggiamenti di silenzio trovano fondam
credenze religiose e nel denso rapporto che s'instaura tra tali atteggia
sacroNel mondo cristiano l'ingresso in un luogo di culto viene spe
to ad un invito al silenzio, scritto su appositi cartelli all'entrata, moti
1 Viene qui omessa, per ragioni di spazio, una esplicita trattazione del rapporto tra
sacro.
This content downloaded from
210.13.81.57 on Sun, 14 Nov 2021 05:07:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
IL SILENZIO: LE DIMENSIONI SOCIALI 117
l'opportunita di favorire il raccoglimento personale e di non disturbar
degli altri fedeli. Nella celebrazione della messa, il rito si svolge attor
trama di parole e di silenzi, in cui si ritrovano i tre tipi sopra menzio
lenzio generalizzato, volto a sottolineare la solennita di certi momenti
consacrazione eucaristica del pane e del vino) e il raccoglimento in asco
dopo la proclamazione della parola di Dio nelle letture), si affiancan
lenzio qualificato — quando il celebrante pronuncia l'omelia — e di
terattivo, nelle parti in cui si realizza un dialogo tra celebrante e fedeli
Per quanto riguarda i conventi, particolare rilievo assume il silenz
sperienza del monachesimo cristiano. La Regola benedettina, a cui fann
tre regole di comunita monacali (Benedetto da Norcia 1981; Regies
1982), da molto risalto al significato del silenzio e alle prescrizioni
durante certe fasce temporali come la notte e durante i pasti comunit
lenzio sono collegati atteggiamenti di prudenza, di umilta, di vigilanza
to e di attenzione 2.
Dimensione religiosa e civile o profana convivono fianco a fianco i
sociali come i nostri, impregnati alia radice dalle istituzioni e dai valor
stianesimo ma sempre piu laici nelle loro manifestazioni e nei com
dei loro membri.
Se prendiamo, ad esempio, i funerali, che solitamente nella nostra
sono associati al mantenimento di un atteggiamento di silenzio o di us
della parola da parte degli intervenuti, essi vengono celebrati anche co
vile, al di fuori delle chiese, oppure si svolgono in chiesa con un rilev
to della dimensione civile: come quando alle esequie intervengono auto
e militari.
Il silenzio in quanto atteggiamento che indica rispetto nei confronti della
morte e presente o implicitamente richiesto anche nei cimiteri in genere e nei
luoghi dove sorgono sacrari e monumenti commemorativi (memorials nella ter
minologia inglese adottata anche dal francese) eretti per perpetuare il ricordo
del sacrificio di tante persone morte per una causa o un ideale di cui la memoria
collettiva si e impadronita. A quest'ultimo riguardo si possono citare i sacrari
dedicati alle vittime della prima guerra mondiale — ad esempio, Redipuglia in
Italia — o i memorials edificati in vari paesi per ricordare l'Olocausto degli ebrei
durante la II Guerra mondiale.
Un altro esempio significativo e dato dal minuto di silenzio che in certe oc
casioni e contesti tutti gli astanti osservano in relazione ad una o piu persone de
cedute di cui si vuole onorare la memoria o perpetuare il ricordo: i contesti pos
sono essere molto diversi, da una sala in cui si svolge una conferenza o un incon
2 L'importanza del silenzio in quanto esercizio di prudenza, umilta e dominio di se nei rapporti
umani e sottolineata anche in una letteratura tradizionale che fa del tacere un'arte complementare a
quella della parola. Esemplare e, al riguardo, L'art de se taire, principalement en matiere de religion, pub
blicata dall'abate Dinouart nel 1771 (Dinouart 1989).
This content downloaded from
210.13.81.57 on Sun, 14 Nov 2021 05:07:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
118 GIOVANNI GASPARINI
tro, a una piazza in cui e in atto un raduno politico o religioso, dallo stadi
sta per iniziare una partita di calcio o un evento sportivo di grande r
(come le Olimpiadi Invernali 1994 di Lillehammer, in cui e stato osser
minuto di silenzio per ricordare le vittime della guerra a Sarajevo, sede a
sa dei Giochi Olimpici dieci anni prima) alia sede del Parlamento in cui si
una personality scomparsa. II breve momento in cui tutti si astengono c
poraneamente dalla parola puo assumere significati diversi a seconda dei
delle credenze di ciascuno, esprimendo appunto quella relazione tra sacro
fano a cui si e accennato: il silenzio, a condizione di non rappresentar
mento vuoto, potra essere riempito da atteggiamenti come ad esempio la
renza, il ricordo, la riflessione, la preghiera.
In effetti, il problema e la presenza della morte, cosl come per conti
quello della sofferenza e della malattia, rappresentano elementi che sollec
anche nei sistemi sociali come quelli contemporanei, forme di rispetto ch
ducono nella predisposizione di aree o spazi sociali di silenzio e nell'el
ne di norme relative o di codici di comportamento condivisi.
Tra le unita sociali piu coinvolte al riguardo, figurano alcune organiz
ni particolarmente complesse, gli ospedali e le case di cura, che pur essen
namente inserite nelle dinamiche tipiche di agenzie di servizio moderne
logicamente equipaggiate, mantengono o tendono a preservare alcuni
di salvaguardia del silenzio: si puo citare il fatto che nelle aree urbane gl
dali sono circondati da «zone di silenzio» e da prescrizioni riguardo al
che dovrebbero garantire ai degenti l'assenza o la minimizzazione dei
esterni; e si puo indicare la prassi del silenzio da osservare nelle camere d
certe ore del giorno e nel periodo notturno, cosi come la severa limitazio
termini temporali alle visite dei parenti, la quale ha peraltro altri obiett
zionali come l'espletamento delle cure da parte del personale medico e
dico dell'ospedale.
In generale, le motivazioni sottostanti all'osservanza del silenzio si po
ricondurre negli ospedali e unita sociali simili (cliniche, case di cura,
esigenze di cura e di riposo del paziente, e al rispetto della sofferenza su
rettamente dei suoi cari, specialmente nelle fasi piu gravi e di fronte
spettiva imminente della morte.
Sempre piu di rado, come e noto, le persone muoiono nella propr
circondate dalla presenza dei familiari, come era invece normale in secoli
ti. Anche nelle abitazioni in genere si pongono comunque problemi conne
pratica e all'osservanza del silenzio, proprio a motivo dell'assenza di silenz
si manifesta nei caseggiati e negli immobili residenziali, specie dell
urbane.
In effetti, l'invasione del rumore e del frastuono all'esterno e all'i
delle abitazioni ha sollecitato una regolamentazione delle fonti di rumore
limitazione delle emissioni relative. All'inquinamento acustico, tipico pro
delle aree urbane che porta talora a misure di limitazione del traffico in
This content downloaded from
210.13.81.57 on Sun, 14 Nov 2021 05:07:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
IL SILENZIO: LE DIMENSIONI SOCIALI 119
ore del giorno o della notte, fanno riscontro i regolamenti delle ca
mlni che disciplinano, ad esempio, l'uso di strumenti musicali
bambini negli spazi comuni, a tutela delle esigenze di riposo (diurn
to notturno) e di privacy di ogni residente. Su un piano diverso da
tivo, si puo notare che e in aumento l'esigenza di case e appartame
di stanze che consentano l'isolamento acustico (attraverso ad esemp
zione dei doppi vetri), di camere d'albergo che siano poco rumorose
Ancora, si osserva che le norme che prescrivono di astenersi da
ne di rumori e di osservare il silenzio rivestono un ruolo di rilievo n
che gestiscono su uno spazio delimitato collettivita temporanee di a
usufruiscono di un periodo di vacanze o di tempo libero: a prescind
berghi, appena citati, si possono ricordare campeggi e villaggi turi
canze, colonie e convitti per giovani, dove l'osservanza del silen
per, ed e ritenuta funzionale a, permettere a ciascuno di esplicare
gli altri l'opportunita di una valida fruizione del proprio tempo di
In alcuni casi — quello di colonie o soggiorni per bambini o r
canto alia funzione di consentire a tutti il riposo e l'esplicazione de
tivita puo essere presente una funzione di disciplina e di socializzaz
determinata organizzazione temporale della giornata, con il col
particolare tra silenzio (o astensione da rumori) e tempo della sera-
to il sincronizzatore del sonno di tutti. Questo elemento di discipli
verificabile ancora, nonostante le trasformazioni in atto che vanno
di una maggiore elasticita e flessibilita, in tutte le organizzazioni c
no una componente di coercitivita nei confronti dei propri membr
tre agli ospedali si possono citare qui le caserme — dove il silenzio
sempre avuto un significato particolarmente forte —, le case di ri
ri per anziani, le prigioni e le altre istituzioni totali.
Un caso particolare e diverso, tra le unita sociali in cui si es
menti o esigenze di silenzio, e rappresentato dalla biblioteca. Is
chissima e ancora oggi essenziale nella conservazione della memoria
culturale, la biblioteca ha legami speciali con il silenzio: essa e p
luogo di silenzio, spazio nei quale puo essere compresente un numer
vato di attori fisicamente contigui i quali si astengono dal parl
rumore.
I regolamenti delle biblioteche non sono molto cambiati da
vista: il silenzio e ritenuto elemento essenziale dello spazio
so puo essere considerato addirittura «un lusso» di cui la b
(Masson - Salvan 1963), isola di tranquillita nei mare del frast
Le silence est de rigueur e la scritta che campeggia nella sal
delle piu prestigiose biblioteche francesi, quella dell'Institu
ques (o Sciences Po) a Parigi, nei palazzo storico di rue Saint-G
La norma che prescrive il silenzio in tutte le bibliotech
meno attraverso espliciti richiami scritti all'ingresso delle sal
This content downloaded from
210.13.81.57 on Sun, 14 Nov 2021 05:07:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
120 GIOVANNI GASPARINI
voli — e verosimilmente una di quelle piu osservate dai lettori e insieme
osservare dai bibliotecari. La funzione manifesta del rispetto del silen
biblioteche e quella di consentire a ciascuno la lettura e lo studio dei propr
attivita ritenuta incompatibile con il rumore e l'esercizio della parola deg
presenti: ognuno e tenuto a rispettare il lavoro degli altri, la condizione
essendo il silenzio.
Siamo qui in presenza di un silenzio generalizzato, per usare la ter
gia usata in precedenza, ma — si badi — di un silenzio nel quale ogni
persona partecipante svolge una propria particolare attivita, che corrispo
propri fini e motivazioni specifiche, anche se e in un certo senso accomu
le altre dai fatto della lettura e dalla ricerca su libri e pubblicazioni.
L'elemento che unisce i diver si frequentatori di una biblioteca consis
fatto che tutti esprimono l'esigenza e l'interesse di leggere materiali app
ti alia biblioteca stessa, ma si ferma qui; al di la, ci sono obiettivi, motiv
modi di fruizione del materiale bibliografico, ed infine libri, che sono di
per ciascun utente. Ci troviamo quindi in una situazione ben diversa n
da quella del silenzio qualificato, in cui il comportamento di silenzio e pu
to ad un obiettivo specifico condiviso da tutti, come la fruizione di un co
o l'ascolto di una conferenza, ma anche da quella forma di silenzio genera
che richiede simultaneity di comportamenti finalizzati, come nel minuto
lenzio osservato in certe circostanze.
Nel caso della biblioteca, il silenzio e ritenuto funzionale all'attivita p
nale della lettura, dello studio e della ricerca sui libri: un'attivita che e co
plata esplicitamente tra l'altro da una serie di ruoli sociali e professional!
sono quelli di studente, di docente, di ricercatore, di scrittore. Cosi, la b
ca non e forse soltanto la concreta realizzazione di una memoria e di un p
nio sociale e culturale, ne solo un'isola di silenzio relitta nell'invadenz
more urbano: essa e anche la testimonianza della permanenza di un lavoro
lo dello studioso, che, nonostante lo scorrere dei secoli e malgrado la disp
ta attuale di tecnologie moderne come quelle informatiche, resta legato a
dell'apprendimento graduale e alia concentrazione silenziosa che e richiest
la lettura e della consultazione dei libri.
Gli esempi finora evocati riguardano unita o contesti sociali in cui si
zano essenzialmente forme di silenzio generalizzato. Fra le unita socia
assume invece particolare importanza il silenzio qualificato vanno citate l
le, le agenzie o le unita formative di qualunque tipo, le Universita. Si tra
organizzazioni o istituzioni nelle quali e centrale lo svolgersi di un pro
formazione e apprendimento: per la sua buona riuscita si adotta norm
uno schema, secondo il quale un attore in posizione centrale — insegnant
matore, docente — park ad una serie di altri attori — scolari, studenti, s
che si sottopongono a periodi di formazione —, dai quali ci si attend
mente e in primo luogo che ascoltino in silenzio il contenuto della lezione
modulo formativo.
This content downloaded from
210.13.81.57 on Sun, 14 Nov 2021 05:07:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
IL SILENZIO: LE DIMENSIONI SOCIALI 121
L'osservanza del silenzio durante le lezioni, esclusi i moment! o
cui gli studenti sono invitati a intervenire, e elemento che e dotat
mente di una propria logica funzionale — volta a consentire la trasmi
contenuti formativi — ma che rientra anche, specie ai primi livelli de
zazione scolastica, in un processo globale di socializzazione dell'alunn
e alle norme consolidate da trasmettergli.
II silenzio qualificato assume poi rilevanza in tutte quelle situazion
tive della vita quotidiana — non necessariamente legate all'inseriment
sociali date — in cui viene trasmesso un messaggio specifico attravers
0 il suono e in cui la qualita dell'ascolto risulta determinante per la pa
ne all'evento in questioner si tratta quindi, come si e in parte gia vist
certi, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, conferenze e cong
ri tipi, cerimonie e riti religiosi nonche civili, per citarne alcuni.
Per quanto riguarda infine le situazioni di silenzio interattivo, che
sentano la trama di fondo delle interazioni verbali nella vita quotidian
no indicare anche alcune unita sociali in cui una opportuna disciplina d
forma costituisce il presupposto per lo svolgimento della loro attivita
al Parlamento, a proposito dello svolgimento dei dibattiti, in cui a tut
mentari e concesso di prendere la parola ma secondo regole e tempi di
dai regolamenti e dalla presidenza; ai tribunali, in cui l'andamento
menti impone alle varie parti determinate alternanze di presa di parola
zio; alle comunicazioni che si verificano tra i controllori di volo negli
1 piloti degli aerei, dove la comunicazione verbale via radio — essenzia
sicurezza dei voli — richiede un'alternanza reciproca di parola e di sile
Nelle organizzazioni di servizio, in quelle soprattutto che svolg
zione a contatto con domande poste direttamente dagli utenti in luog
o in uffici e sportelli, l'osservanza del silenzio alternato da parte dei d
dell'organizzazione consente di ascoltare le richieste o le lamentele deg
per poter quindi organizzare verbalmente una risposta.
Nelle aziende in genere, un tipo di unita sociali di cui e nota la ril
senziale nei nostri sistemi contemporanei, la problematica del silenzio
bra particolarmente rilevante o pertinente in linea generale, non solo
imprese industriali si possono considerare fra le principali responsabi
indirette (attraverso i loro prodotti) della produzione di rumore e del
mento acustico che affligge le aree metropolitane, ma anche a causa d
colta di caratterizzare al loro interno — e quindi nelle interazioni fra
membri e i diversi ruoli aziendali — situazioni tipiche di silenzio gene
qualificato o interattivo.
Ill - LE FUNZIONI SOCIALI EI VALORI CONNESSI AL SILENZIO
Abbiamo trattato del silenzio in connessione a situazioni, contesti ed
sociali ben diversi. Il silenzio e un fenomeno polisemico e improntato ad
This content downloaded from
210.13.81.57 on Sun, 14 Nov 2021 05:07:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
122 GIOVANNI GASPARINI
sica ambiguita (cfr. Cauquelin 1993; Lavelle 1947); tipica forma «debo
municazione (Lauretano 1989), esso si inquadra in determinate logich
duali e sociali, prestandosi a veicolare ed esprimere una serie di contenut
saggi, norme e valori differenti.
In sede conclusiva, ci sembra utile far emergere alcuni elementi tras
di lettura, riferiti in particolare alle funzioni sociali e ai valori che si po
tribute o legare al fenomeno del silenzio.
Alia luce dell'indagine svolta, possiamo anzitutto registrare una g
piuttosto ampia di funzioni svolte dal silenzio, intese come conseguenze
vamente operand connesse all'esistenza di ruoli, processi e azioni soc
«producono silenzio». Abbiamo cosl una serie di funzioni che corrispondo
obiettivi degli attori individuali ma che sono comuni a vasti gruppi o ma
soggetti, quali le seguenti: la possibility di consentire lo svolgimento di
ze profondamente personali come quelle legate al sacro e alle credenze re
alia riflessione e meditazione; il rispetto del riposo e delle esigenze d
mento, con le relative implicazioni riguardanti le normative in fatto di ru
inquinamento acustico; lo stimolo della creativita richiesta per certe atti
professioni; la fruizione di certe esperienze culturali (come quelle indicat
posito del silenzio qualificato), estetiche (che riguardano, ad esempio, il r
to con gli ambienti naturali) e di comunicazione (tipiche del silenzi
rattivo).
Altre funzioni riguardano la socializzazione ai processi e alle norme tipiche
di certe unita o ambiti sociali, come i conventi e gli edifici religiosi o anche le bi
blioteche, senza dimenticare le scuole; in questo ambito rientra pure la funzione
consistente nel non svelare o tradire elementi non comuriicabili o segreti dell'or
ganizzazione a cui si appartiene, come nel caso del prigioniero che non fornisce
informazioni al nemico neppure sotto minaccia di tortura e maltrattamenti, o
dell'iniziato di una setta o gruppo religioso che non svela ad estranei i riti del
suo culto.
A queste funzioni se ne aggiungono altre, considerate sempre in un'ottica
sociologica ma con riferimento ad un altro versante del silenzio, dove si espri
mono rapporti di potere tra due o piu soggetti. Pensiamo qui in particolare alle
conseguenze sociali che puo avere un silenzio di reticenza e di paura generalizza
to, come quello che spesso i regimi dittatoriali riescono a imporre e che consiste
nell'accettazione supina o nella mancata denuncia di condizioni ispirate all'in
giustizia o alia menzogna. E pensiamo al silenzio come esito di condizionamenti
e coercizioni, alle situazioni sociali in cui attori e gruppi vengono ridotti al silen
zio, privati della possibility di parola e di comunicazione. E, ancora, abbiamo
presente un silenzio che nei rapporti interpersonali e sociali si configura come
rifiuto o procrastinamento di una comunicazione dovuta o attesa, che viene usa
to per mantenere un vantaggio nei confronti degli interlocutori o per esercitare
una pressione psicologica: un esempio di grande efficacia ci viene da un episodio
dei Promessi sposi, allorche Manzoni, descrivendo la storia di Gertrude, mostra
This content downloaded from
210.13.81.57 on Sun, 14 Nov 2021 05:07:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
IL SILENZIO: LE DIMENSIONI SOCIALI 123
come l'atteggiamento di silenzio osservato dai genitori della futura monaca di
Monza, un silenzio di riprovazione e di rimprovero, rappresenti l'elemento
chiave di una strategia tesa a costringere moralmente la figlia ad entrare in con
vento (Manzoni 1984).
Accanto alle funzioni, centrale risulta — in un'ottica di lettura complessiva
e trasversale del fenomeno del silenzio — l'aspetto rappresentato dai valori. A
questo riguardo, la letteratura filosofica e quella religiosa sottolineano l'impor
tanza primaria del silenzio come aspetto o elemento dell'esperienza umana e re
ligiosa (cfr. Baldini - Zucal 1989).
Va chiarito in proposito che il silenzio e valorizzato in connessione e in ter
mini complementari rispetto alia parola: esso non e considerato cioe in contrap
posizione assoluta alia parola ma in alternanza ad essa. Anche chi, come Picard,
autore di un'opera filosofico-sapienziale classica sul silenzio, ritiene che esso ap
partenga alia struttura fondamentale dell'uomo e rappresenti un fenomeno ori
ginario, irriducibile a qualunque altro, riconosce che la condizione umana e lega
ta anzitutto alia parola e che essa «ha la supremazia sul silenzio» (Picard 1951:
5). Nella rivelazione cristiana, parola e silenzio stabiliscono una feconda intera
zione: la parola-Verbo che si incarna in Gesu Cristo esce dai silenzi eterni di
Dio e si trasforma in buona notizia o novella cioe Evangelo, il cui annuncio tro
va appunto nel silenzio uno spazio di ascolto fondamentale (Derungs 1991). Si
lenzio e parola rappresentano due elementi interattivi e sinergici della comuni
cazione che si realizza in generale nel messaggio e nell'esperienza religiosa, an
che a prescindere dai silenzio ascetico e da quello mistico che contraddistinguo
no esperienze non comuni o eccezionali.
In termini non molto dissimili, il rapporto tra parola e silenzio e centrale e
continuamente ricorrente nell'espressione poetica, non solo per l'alternanza e il
gioco dei pieni e dei vuoti (lo scritto e il non scritto di ogni riga e di ogni pagina,
il nero sul foglio bianco), ma per il rapporto tra detto e non detto, tra dicibile e
non dicibile, per lo scarto tra parola e ispirazione di cui molta poesia da testimo
nianza (cfr. Picard 1951; Beschin 1989). La poesia alta, dopo aver parlato, ten
de al silenzio, conscia del proprio limite: ne L'infinito Giacomo Leopardi parla
appunto, significativamente, del silenzio, anzi di «sovrumani silenzi», per evo
care l'idea dell'infinito e dell'eterno; si noti en passant la contiguita avvertita qui
dai poeta tra silenzio e spazio, nel senso che il primo e immaginato connesso a
«interminati spazi» posti al di la della siepe che fornisce l'ispirazione a Leopardi
(Leopardi 1953). E T.S. Eliot nei Quattro quartetti, componimento poetico che
e pure a tratti meditazione teologica, afferma testualmente che «le parole, dopo
il discorso, raggiungono il silenzio» (Eliot 1976).
L'espressione poetica, cosi come i riferimenti all'esperienza religiosa, allu
dono al silenzio come pienezza: si tratta cioe di un silenzio pieno, ricco, che e ri
tenuto generatore, catalizzatore o contenitore di esperienze qualificate, pregiate
e significative. Ed e in parte a questo aspetto del silenzio come valore in se che
si puo collegare una disamina dei valori connessi al silenzio. Essi, considerati in
This content downloaded from
210.13.81.57 on Sun, 14 Nov 2021 05:07:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
124 GIOVANNI GASPARINI
un'ottica sociologica, rinviano essenzialmente ad elementi normativi cond
a prassi diffuse nei sistemi sociali.
Non si puo affrontare questa problematica senza ribadire una premes
ziale, quella che prende atto del carattere interstiziale ed «eccezionale» de
zio nella cultura corrente e nella trama strutturale delle nostre societa. I
senso, due osservazioni si impongono: la prima e che l'industrializzaz
suoi successivi sviluppi hanno drasticamente compresso i tempi e gli spaz
lenzio, espellendolo non solo dai contesti urbani e metropolitan! ma in ce
sura anche dalle aree naturali. La seconda si riferisce al fatto che si sono
pati processi e forme di informazione e comunicazione talmente pervasiv
vrabbondanti da svuotare tendenzialmente di significato il silenzio, al
oppone — appunto — il «valore» della comunicazione, ritenuta una p
necessita dell'attore che opera nei contesti sociali moderni.
Non e un caso che l'azienda, principale veicolo di trasmissione della cu
industriale, rappresenti probabilmente l'unita sociale piu estranea, sia in
ni strutturali che di valori e modelli di comportamento relativi, alle log
le esigenze del silenzio. I criteri di efficienza e di produttivita a cui l
orienta la sua azione sono in contrasto con i caratteri di astensione dall'a
di apparente inutilita e di gratuita spesso assegnati al silenzio.
Un altro elemento complementare da tener presente e rappresent
processo di colonizzazione dello spazio e quindi del tempo che si e ver
specialmente nell'ultimo secolo, in relazione alle tecnologie e ai prodo
rati dalle aziende industriali. La rivoluzione industriale e i suoi sviluppi s
sivi hanno cambiato il mondo non solo perche hanno mutato il modo di p
re e perche hanno prodotto stupefacenti congegni tecnologici, ma anche
hanno ridotto — se non quasi eliminato — gli spazi in cui si esprimeva si
cosl come certe fasce temporali tipicamente assegnate al silenzio, quali la
Scrivendo all'interno di una societa industrializzata ma precedente ali
stra (che si puo considerare industriale avanzata o postindustriale), l
deU'immediato dopoguerra, Picard rilevava che «Nulla ha tanto mutat
za dell'uomo quanto la perdita del silenzio», il quale un tempo era un elem
«naturale come l'aria» e ricopriva tutte le cose (Picard 1951: 267). E d
fondare sociologicamente una simile affermazione-intuizione, ma, do
mezzo secolo, non si puo non rilevare la progressiva, irresistibile marcia
battimento e di compressione del silenzio a livello sia dello spazio che
po. Basti citare alcuni indicatori come la formidabile crescita demografic
sviluppo delle concentrazioni urbane a livello mondiale (che si preved
ranno dal 30% nei 1900 a quasi la meta della popolazione mondiale n
2000: cfr. George 1991); il livello di guardia raggiunto dal traffico, dalla
rizzazione e dall'inquinamento da rumore, specialmente nei contesti u
ti; la progressiva distruzione o danneggiamento delle aree naturali; le pos
delle moderne tecnologie di trasporto e di comunicazione di accedere
ogni punto dello spazio, con le relative conseguenze in termini di emissio
This content downloaded from
210.13.81.57 on Sun, 14 Nov 2021 05:07:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
IL SILENZIO: LE DIMENSIONI SOCIALI 125
rumori anche in aree precedentemente dominate dal silenzio e in fasce tempora
li riservate piu o meno rigorosamente al silenzio, in particolare a quello necessa
rio per il riposo notturno; e ancora, lo sviluppo straordinario di mezzi di comu
nicazione di massa rumorosi come la radio e la televisione.
Si pensi ad esempio alle quasi illimitate potenzialita che hanno aerei ed eli
cotteri di penetrare in aree scarsamente accessibili o solitarie e quindi preceden
temente non contaminate dal rumore; oppure alia eliminazione del silenzio che
puo operare l'uso del telefono cellulare sia in aree naturali contraddistinte dal si
lenzio che in contesti sociali nei quali — come si e esemplificato in precedenza
— sono in atto norme e comportamenti che prevedono l'astensione da rumori e
dall'uso della parola. Ad esempio, l'installazione di un telefono e normalmente
ritenuta incompatibile con lo spazio rappresentato dalla sala di lettura di una bi
blioteca o con quello di una chiesa (silenzio generalizzato), o ancora con quello
di un teatro nel quale si sta rappresentando un'opera (silenzio qualificato): ora,
il telefono cellulare potrebbe facilmente violare, con i suoi squilli e con la con
versazione a voce alta che richiede, il silenzio di questi luoghi. Un uso indiscri
minato dei telefoni portatili, nelle prime fasi della loro diffusione, ha provocato
appunto l'emissione di nuove norme da parte di certe unita sociali, come quelle
che hanno vietato il loro uso durante le rappresentazioni teatrali (e il caso della
Scala a Milano) o durante i dibattiti parlamentari in aula. E il telefono cellulare
puo aumentare suoni e rumori di spazi pubblici o semipubblici, come quando
viene usato per la strada o in una sala di attesa dell'aeroporto o sul treno, con le
relative conseguenze sui presenti e sulle loro attivita (ad esempio di lettura, di
riflessione, di fruizione dello spazio).
Il silenzio diventa cosl, in particolare, un carattere pregiato degli spazi na
turali entro o ai margini delle aree urbane, dove talvolta vengono attivate limi
tazioni alPemissione di rumori (ad esempio, con l'uso di transistors o registratori)
da parte dei frequentatori. La relazione del silenzio e del rumore con lo spazio e
sottolineata anche dall'iscrizione posta in epigrafe a questo articolo, che figura
in un piccolo parco ai margini della cittadina di Capri,in splendida posizione a
dominio del mare: in essa si invita al rispetto del silenzio, identificato come un
«indice di civilta» (da intendersi probabilmente come comportamento civico e
urbano), analogamente alia pulizia. Si opera qui un sintomatico parallelo tra il
conservare un ambiente naturale pulito — non inquinato da sporcizia e rifiuti
— e il mantenimento in esso del silenzio, che si puo contrapporre all'inquina
mento da rumore: entrambi gli aspetti risultano finalizzati ad una fruizione ade
guata da parte di tutti degli spazi comuni del parco.
Da quanto precede possono trarre elementi di valorizzazione del silenzio
— nelle sue varie espressioni — nella societa contemporanea. Ed e anzitutto
con riferimento alia locuzione generale e comprensiva di «qualita della vita» che
questo processo puo essere sviluppato. Come e noto, una componente importan
te del movimento per la qualita della vita e data dall'attenzione all'ambiente na
turale, a fronte della minaccia di una sua contaminazione o distruzione. Essa ha
This content downloaded from
210.13.81.57 on Sun, 14 Nov 2021 05:07:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
126 GIOVANNI GASPARINI
guadagnato in questi anni un consenso crescente, a giudicare almeno da u
rie di indicatori diversi quali 1'importanza anche in sede politica assunta
vimenti ecologici e dei «Verdi» in diversi paesi, la creazione e la valori
di parchi, riserve naturali e aree naturali protette (che opera sia a livello
nale che mondiale, attraverso l'iscrizione di certi luoghi sull'elenco del pa
nio mondiale protetto dall'Unesco, dove essi sono presenti insieme a siti
ticolare valore culturale), la crescente domanda e fruizione da parte del p
di spazi naturali, in particolare appunto di aree protette. Ora, il silenzio
delle modalita basilari per l'accesso e la fruizione di tali aree: la sua os
viene solitamente richiamata — accanto ad altre norme di comportam
all'ingresso degli spazi naturali protetti, alio scopo di non turbare gli equ
biologici ivi esistenti.
Piu in generale, anche a prescindere dall'esistenza di parchi e riserve
rali, si osserva che il silenzio esprime e mantiene con lo spazio, con i luog
rapporto particolare. II silenzio si accorda con i luoghi naturali piu che co
li in cui la presenza degli artefatti umani e visibile e la concentrazione di
ti cospicua: cosi, un certo livello di rumore considerato normale o comun
cettato normalmente in contesto urbano puo essere ritenuto inaccettabil
contesto naturale o in cui la dimensione naturale assume preminenza, com
montagna. Ancora: il silenzio puo essere spesso associato alia solitudine —
nel caso di conventi o di eremi —, al vivere o al soggiornare in luoghi de
quasi, ad un isolamento nello spazio che puo essere frutto di scelta o, al c
rio, di coercizione.
II silenzio legato alia solitudine o all'isolamento, in quanto sia pers
positivamente dall'attore interessato, puo rientrare in un obiettivo di qu
vita, dove vengono valorizzati gli aspetti della concentrazione, riflessione
ditazione personale, ritenuti elementi irrinunciabili dell'esperienza um
che in contesti sociali in cui si realizza un bombardamento della comunicazione
e un'invasione del rumore.
Tali aspetti risultano poi centrali per lo svolgimento di alcune attivita e
ruoli sociali e professionali, dove il silenzio rappresenta in effetti una compo
nente importante se non basilare: lo studioso, lo scrittore, l'artista, lo scienziato
stesso, colui che svolge in genere un lavoro intellettuale abbisogna di tempi e fa
si di silenzio, piu o meno lunghi e ritmati secondo date esigenze. Si tratta di un
silenzio di concentrazione che consente di leggere e di studiare, di scrivere, di
pensare: un silenzio che e funzionale — se non addirittura essenziale, in molti
casi — alio sviluppo e all'esercizio della creativita (cfr. Fabbrini 1993).
Il silenzio di concentrazione si avvale spesso di spazi qualificati o determi
nati, che sono in un certo senso impregnati di silenzio: si e gia illustrato il caso
della biblioteca come ambito sociale e spaziale nel quale vige la regola del silen
zio, ritenuto condizione di base per l'attivita di studio, che e il compito di stu
denti e studiosi, fonte di accumulazioni e di nuovi sviluppi creativi nel campo
della conoscenza. Altri ambiti spaziali si pongono in questa stessa linea di con
This content downloaded from
210.13.81.57 on Sun, 14 Nov 2021 05:07:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
IL SILENZIO: LE DIMENSIONI SOCIALI 127
sentire o stimolare la concentrazione: si possono citare Vatelier di un ar
studio di uno scrittore o di un intellettuale, talvolta un laboratorio scie
cosi come quegli spazi domestici che vengono ritagliati dai singoli per g
una possibilita di concentrazione, di isolamento e di silenzio.
E sempre a proposito del silenzio di concentrazione, va ricordato
dell'atleta impegnato in una competizione sportiva: lo sciatore prima
scesa, il centometrista negli attimi precedenti lo sparo, cosi come il calc
che si appresta a tirare un calcio di rigore o il pallacestista che sta per e
un tiro libero dalla lunetta. Il silenzio di concentrazione permette evide
te un coordinamento armonioso fra pensiero e parola, tra conoscenze e
In conclusione, dunque, il silenzio appare come un fenomeno tutt'alt
irrilevante dal punto di vista sociologico: si tratta di una dimensione ch
frequentemente temi e prospettive da altri punti di vista come quello f
o religioso ma che non si puo ridurre ad essi.
In modo particolare, la nostra esplorazione sul silenzio ha fatto eme
che esso e si un fenomeno interstiziale, ma nel senso che le logiche dom
correnti dei sistemi contemporanei tendono a relegarlo in ambiti spazio
rali marginali e poco visibili, non in quello di una sua oggettiva irri
subalternita ad altri aspetti della vita sociale.
Dall'analisi che si e qui sviluppata, il silenzio appare come una rea
cettata, polivalente e polisemica, ricca di agganci con la vita sociale e con
zionamento di diverse unita sociali, cosl come con certi valori che, a
reazione agli effetti perversi dell'industrializzazione e della modernita,
acquistando consenso nelle societa contemporanee.
GIOVANNI GASPARINI
Dipartimento di Sociologia
Universita Cattolica di Milano
This content downloaded from
210.13.81.57 on Sun, 14 Nov 2021 05:07:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
GIOVANNI GASPARINI
BIBLIOGRAFIA
Baldini M. - Zucal S. (a cura di)
(1989) Le forme delsilenzio e della parola, Morcelliana, Brescia.
Benedetto da Norcia
(1981) Regula tnonasteriorum, a cura delle Benedettine di Viboldone, S.Giuliano Milan
Beschin G.
(1989) Poesia e silenzio, in Baldini M. - Zucal S. (1989).
Cauquelin A.
(1993) Temps du silence, in SfezL., Dictionnaire critique de la communication, Puf, Paris, 1.1.
Cortelazzo M. - Zolli P.
(1975) Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, Bologna, 5 voll.
Derungs U.G.G.
(1991) Parola e silenzio, in «Servitium», LXXVII, novembre-dicembre.
DinouartJ.A.T.
(1989) L'arte di tacere, Sellprio, Palermo.
Dizionario Enciclopedico Italiano
(1960) Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma.
Dupuy M. - Miquel P.
(1980) Silence, in Dictionnaire de spiritualite, Beauchesne, Paris, t. XIV.
Eliot T.S.
(1976) Quattro quartetti (1942), Garzanti, Milano.
Encyclopaedia Universalis
(1978) XX. Thesaurus-Index, Paris.
Fabbrini A.
(1993) IIsilenzio, in Balbo L. (a cura di), Friendly/93, Anabasi, Milano.
Gasparini G.
(1992) L'attesa: un tempo interstiziale?, in «Studi di Sociologia», XXX, 1.
(1994) La dimensione sociale del tempo, F. Angeli, Milano.
George P.
(1991) Citta, in Enciclopedia delle Scienze Sociali, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana,
Roma, vol. I.
GirinJ.
(1992) Verite, justice et relations, in EDF-GDF Bonjour. L'interation agent-client a I'accueil,
Contrat de connaissance Cnrs-Pirttem/EDF n° Convention 1F1182, Paris.
LauretanoB.
(1989) IIlinguaggio silenzioso, in Baldini M. - Zucal S. (1989).
Lavelle L.
(1947) La parole et I'ecriture, L'Artisan du Livre, Paris.
Leopardi G.
(1953) Canti, Rizzoli-Bur, Milano.
Lexis
(1976) Larousse, Paris.
Manzoni A.
(1984) IPromessi Sposi, Fabbri, Milano.
This content downloaded from
210.13.81.57 on Sun, 14 Nov 2021 05:07:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
IL SILENZIO: LE DIMENSIONI SOCXALI 129
Masson A. - Salvan P.
(1963) Les bibliotheques, Puf, Paris.
Pascal B.
(1963) Pensees, in Oeuvres completes, Seuil, Paris.
Picard M.
(1951) II mondo delsilenzio, Ed. di Comunita, Milano.
Regies des moities
(1982) Seuil, Paris.
Robert P.
(1985) Le grand Robert de la langue frangaise, Diet. Robert, Paris, t. VII.
This content downloaded from
210.13.81.57 on Sun, 14 Nov 2021 05:07:09 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Potrebbero piacerti anche
- Riassunto Semiotica Dei Media Ruggero EugeniDocumento27 pagineRiassunto Semiotica Dei Media Ruggero EugeniElena Dondossola100% (2)
- Paesaggio SonoroDocumento28 paginePaesaggio SonoroFabiana Marotta100% (1)
- La Comunicazione MultimodaleDocumento12 pagineLa Comunicazione MultimodaleapedandolaNessuna valutazione finora
- Urmet Schemi Impianti Citofonia Elettronica 4n FiliDocumento66 pagineUrmet Schemi Impianti Citofonia Elettronica 4n FililucianoNessuna valutazione finora
- Basi Della SemioticaDocumento28 pagineBasi Della SemioticachriscNessuna valutazione finora
- Gesto e Comunicazione Non Verbale (Fabio Peloso)Documento18 pagineGesto e Comunicazione Non Verbale (Fabio Peloso)Alessandro GranatoNessuna valutazione finora
- Sergio Lanza - L'Ascolto Della MusicaDocumento23 pagineSergio Lanza - L'Ascolto Della MusicaLuca Verdicchio100% (1)
- Psicologia MusicaleDocumento13 paginePsicologia MusicaleSimoneGoffredoAmorusoNessuna valutazione finora
- Comunicazione EfficaceDocumento69 pagineComunicazione EfficaceMariaRitaDiLauroNessuna valutazione finora
- Urmet Domus GeneralDocumento78 pagineUrmet Domus GeneralsantanielloarturoNessuna valutazione finora
- Tecnoalarm Manuale TP888 PDFDocumento68 pagineTecnoalarm Manuale TP888 PDFalroma111266Nessuna valutazione finora
- Storia Della Televisione PDFDocumento25 pagineStoria Della Televisione PDFemanueleNessuna valutazione finora
- Lezione 9 19 Dec 2022Documento4 pagineLezione 9 19 Dec 2022Giada RocchiNessuna valutazione finora
- Il Silenzio e La VoceDocumento8 pagineIl Silenzio e La VocePaolo SeriNessuna valutazione finora
- Heidegger e Lacan Ascolto Del LinguaggioDocumento5 pagineHeidegger e Lacan Ascolto Del LinguaggioMyriam PanicoNessuna valutazione finora
- Apuntes Semiotica.Documento13 pagineApuntes Semiotica.Joaco GarciaNessuna valutazione finora
- Antropologia Dei SensiDocumento17 pagineAntropologia Dei SensiVincenzo MateraNessuna valutazione finora
- 1-Che Cos'è La MusicoterapiaDocumento5 pagine1-Che Cos'è La MusicoterapiaginaNessuna valutazione finora
- "Osservare" I Suoni: Note Sul Concetto Di Paesaggio Sonoro - Antro Di ChironeDocumento5 pagine"Osservare" I Suoni: Note Sul Concetto Di Paesaggio Sonoro - Antro Di ChironefrancmoNessuna valutazione finora
- Sociologia Della CulturaDocumento26 pagineSociologia Della CulturaGonzalo BorondoNessuna valutazione finora
- 1992 - Educare All'AscoltoDocumento7 pagine1992 - Educare All'AscoltoGabriele De RitisNessuna valutazione finora
- La ComunicazioneDocumento5 pagineLa ComunicazionealessioanginiNessuna valutazione finora
- SeminarioDocumento2 pagineSeminarioMartina MolloNessuna valutazione finora
- Tesi FNL A Del Linguaggio Non VerbaleDocumento31 pagineTesi FNL A Del Linguaggio Non VerbalePiero IngrossoNessuna valutazione finora
- 2011 - L'etica Nel Dominio Della Tecnica StrutturaleDocumento12 pagine2011 - L'etica Nel Dominio Della Tecnica StrutturaleAlessio ChiericoNessuna valutazione finora
- Paccagnella - Sociologia Della ComunicazioneDocumento9 paginePaccagnella - Sociologia Della ComunicazioneCristina GarciaNessuna valutazione finora
- GNS-2010 MontesperelliDocumento8 pagineGNS-2010 MontesperelliAndrea CumanNessuna valutazione finora
- Anche Francesco le diceva: Una riflessione sociolinguistica sull’uso delle parolacceDa EverandAnche Francesco le diceva: Una riflessione sociolinguistica sull’uso delle parolacceNessuna valutazione finora
- Linguistica GeneraleDocumento61 pagineLinguistica Generalegiorgia.sorr03Nessuna valutazione finora
- P. Fabbri - La Prossemica A Lungo CorsoDocumento4 pagineP. Fabbri - La Prossemica A Lungo CorsoOoNessuna valutazione finora
- Sociolinguistica Stereotipi PDFDocumento44 pagineSociolinguistica Stereotipi PDFXenia OktogonNessuna valutazione finora
- Ferdinand de Saussure Una Lezione Tra Scacchi, Codici e Comunicazione - L'Unità 24.02.2013Documento1 paginaFerdinand de Saussure Una Lezione Tra Scacchi, Codici e Comunicazione - L'Unità 24.02.2013glisfogliatiNessuna valutazione finora
- Andrea Inzerillo - Dal Video Al Cinema. Il Disaccordo Televisivo Di Cinico TV PDFDocumento11 pagineAndrea Inzerillo - Dal Video Al Cinema. Il Disaccordo Televisivo Di Cinico TV PDFMinotauro Di ChietiNessuna valutazione finora
- Il Silenzio in Musica QuartaDocumento14 pagineIl Silenzio in Musica QuartaAdele Lina SammarcoNessuna valutazione finora
- La Prossemica VocaleDocumento6 pagineLa Prossemica VocaleEjNessuna valutazione finora
- Musica e Psicologia - Lo Stato Della Questione PDFDocumento21 pagineMusica e Psicologia - Lo Stato Della Questione PDFRita PanzaNessuna valutazione finora
- Esperienze in Musicoterapia Vol IIDocumento188 pagineEsperienze in Musicoterapia Vol IIparisipromoNessuna valutazione finora
- 01 Semiologia Della Musica I Parte 2012-2013Documento101 pagine01 Semiologia Della Musica I Parte 2012-2013Anna IannacconeNessuna valutazione finora
- Linguistica GeneraleDocumento73 pagineLinguistica GeneraleInes MarinoNessuna valutazione finora
- Giuseppe-DAcunto Toccare La Parola Barthes Sul Senso OttusoDocumento11 pagineGiuseppe-DAcunto Toccare La Parola Barthes Sul Senso OttusoFederico VirgilioNessuna valutazione finora
- Appunti Filologia Romanza Benozzo UnicoDocumento4 pagineAppunti Filologia Romanza Benozzo Unicog8zh5ggs5rNessuna valutazione finora
- Manuale Di SemioticaDocumento69 pagineManuale Di SemioticaInes MarinoNessuna valutazione finora
- Linguistica GeneraleDocumento93 pagineLinguistica GeneralemoniaNessuna valutazione finora
- Riassunto Completo Aa 20152016 Proff Berruto e CerrutiDocumento88 pagineRiassunto Completo Aa 20152016 Proff Berruto e CerrutiMartina CasaleNessuna valutazione finora
- Antropologia CulturaleDocumento22 pagineAntropologia CulturaleVirginia VoarinoNessuna valutazione finora
- Il Binomio Lingua CulturaDocumento10 pagineIl Binomio Lingua CulturaAnonymous j2fVR6Nessuna valutazione finora
- Semiologia MusicaleDocumento37 pagineSemiologia MusicaleGiuseppe StoppielloNessuna valutazione finora
- Corso SociolinguisticaDocumento178 pagineCorso SociolinguisticaMary BiondiNessuna valutazione finora
- Corrado Teoria Della Condensazione Psico Emozionale LinguisticaDocumento73 pagineCorrado Teoria Della Condensazione Psico Emozionale LinguisticaLuciano DuòNessuna valutazione finora
- Matteo Valdarchi - Però Non Ti Turbare e Resta in SilenzioDocumento9 pagineMatteo Valdarchi - Però Non Ti Turbare e Resta in SilenzioMatteo ValdarchiNessuna valutazione finora
- Capitolo 1Documento13 pagineCapitolo 1Chiara SantoroNessuna valutazione finora
- Glosario SociologicoDocumento14 pagineGlosario SociologicoEunice MartínezNessuna valutazione finora
- 1 - Canali-Della-Comunicazione-Non-VerbaleDocumento13 pagine1 - Canali-Della-Comunicazione-Non-VerbaleDavide SaggeseNessuna valutazione finora
- PROPRIETà DEL LINGUAGGIODocumento16 paginePROPRIETà DEL LINGUAGGIOCarmen GurradoNessuna valutazione finora
- Dispensa Didattica FarmaciaDocumento53 pagineDispensa Didattica FarmaciaGianfilippo MarzialeNessuna valutazione finora
- LinguisticaDocumento27 pagineLinguisticanoemuccia.ngNessuna valutazione finora
- Noi Primitivi Riassunto Dettagliato Del Testo Di RemottiDocumento14 pagineNoi Primitivi Riassunto Dettagliato Del Testo Di RemottiPaolo SeriNessuna valutazione finora
- Linguistica Generale - Cap I IntroduzioneDocumento7 pagineLinguistica Generale - Cap I IntroduzioneMichael Thomas BorsattoNessuna valutazione finora
- IlLinguaggioUmanoComeRelazione, TLM PoliticheServiziSociali Unive17 PDFDocumento297 pagineIlLinguaggioUmanoComeRelazione, TLM PoliticheServiziSociali Unive17 PDFRossano BrunettiNessuna valutazione finora
- La Parola SilenzioDocumento19 pagineLa Parola SilenzioYali LinNessuna valutazione finora
- BaldiniDocumento8 pagineBaldiniYali LinNessuna valutazione finora
- 116079-Texto Do Artigo-212747-1-10-20160606Documento26 pagine116079-Texto Do Artigo-212747-1-10-20160606Yali LinNessuna valutazione finora
- 1238 Articolo 4634 1 10 20110708Documento21 pagine1238 Articolo 4634 1 10 20110708Yali LinNessuna valutazione finora
- 99 Pallotti Metodi CADocumento23 pagine99 Pallotti Metodi CAYali LinNessuna valutazione finora
- 完-l'espressione dell'incertezza nella lingua dei segni italianaDocumento36 pagine完-l'espressione dell'incertezza nella lingua dei segni italianaYali LinNessuna valutazione finora
- LGM CNVDocumento4 pagineLGM CNVYali LinNessuna valutazione finora
- Tesi FabriziaMaglio h08lp7j1Documento42 pagineTesi FabriziaMaglio h08lp7j1Yali LinNessuna valutazione finora
- Anolli - Psicologia Della ComunicazioneDocumento64 pagineAnolli - Psicologia Della Comunicazionemaria100% (1)
- Tecniche ComunicazioneDocumento30 pagineTecniche ComunicazioneLuca BalestrinoNessuna valutazione finora
- 00 357 Tipo5p 603.91.491 It 01 01.18 L Lg#ap 603.91.491 01 01.18Documento328 pagine00 357 Tipo5p 603.91.491 It 01 01.18 L Lg#ap 603.91.491 01 01.18Andrea AlessandrelliNessuna valutazione finora
- 83 191 Giulietta 603.93.021 It 01 12.16 L Lg#ap 603.93.021 01 12.16Documento260 pagine83 191 Giulietta 603.93.021 It 01 12.16 L Lg#ap 603.93.021 01 12.16Stefano ChilàNessuna valutazione finora
- TV Metz 32 Pollici Recensioni Questo Televisore Si Distingue Tra La CompetizioneccmhyDocumento2 pagineTV Metz 32 Pollici Recensioni Questo Televisore Si Distingue Tra La Competizioneccmhyheavenmimosa47Nessuna valutazione finora
- Centrali Di Allarme Multifunzione Per Sistemi Di Sicurezza MANUALE DI UNITÀ CENTRALE MADE in ITALYDocumento20 pagineCentrali Di Allarme Multifunzione Per Sistemi Di Sicurezza MANUALE DI UNITÀ CENTRALE MADE in ITALYLucio BrunoNessuna valutazione finora
- Midland BT2Documento2 pagineMidland BT2Valter FranceschiNessuna valutazione finora
- The Ultimate Guide To Text and Phone Game + 3 Capitoli Bonus in ItalianoDocumento175 pagineThe Ultimate Guide To Text and Phone Game + 3 Capitoli Bonus in ItalianoLuca BernabeiNessuna valutazione finora
- VoipDocumento21 pagineVoipdgadaleta75Nessuna valutazione finora
- Blue&me Fiat 500Documento82 pagineBlue&me Fiat 500Alberto MorelliNessuna valutazione finora
- Combinatore Telefonico CombivoxDocumento17 pagineCombinatore Telefonico Combivoxmollica_giovanni1Nessuna valutazione finora
- Manuale Combinatore BortolottiDocumento24 pagineManuale Combinatore Bortolottimollica_giovanni1Nessuna valutazione finora
- Domande BDocumento594 pagineDomande BAurora CupaNessuna valutazione finora
- GD90 ItaDocumento64 pagineGD90 Itaiz2bktNessuna valutazione finora
- Bentel Absoluta 42 V 3.5 PDFDocumento116 pagineBentel Absoluta 42 V 3.5 PDFAndreaNessuna valutazione finora
- IRiparo Pellicola Autorigenerante ZAGG Per Salvare Il Vetro Del Tuo TelefonoDocumento2 pagineIRiparo Pellicola Autorigenerante ZAGG Per Salvare Il Vetro Del Tuo TelefonoMarketingInformaticoNessuna valutazione finora
- istisbliKE-13.0 MANUALE ABSOLUTA 3.60 PDFDocumento124 pagineistisbliKE-13.0 MANUALE ABSOLUTA 3.60 PDFGiuseppe RomanoNessuna valutazione finora
- Interphone Btmototo ItalianoDocumento22 pagineInterphone Btmototo ItalianoÓscar LópezNessuna valutazione finora
- Gigaset A 510 IpDocumento196 pagineGigaset A 510 Ipedtwk2011Nessuna valutazione finora
- National GeographicDocumento129 pagineNational GeographicCosmin GullyNessuna valutazione finora
- LOGGSM Ver. 4.5 LOGGSM COMBINATORE TELEFONICO SU RETE GSM MANUALE DI INSTALLAZIONE E USO. Leggere Attentamente Questo Manuale Prima Dell UsoDocumento18 pagineLOGGSM Ver. 4.5 LOGGSM COMBINATORE TELEFONICO SU RETE GSM MANUALE DI INSTALLAZIONE E USO. Leggere Attentamente Questo Manuale Prima Dell UsoandreaNessuna valutazione finora
- Manuale Tecnico WILMADocumento88 pagineManuale Tecnico WILMAUmberto RuggieroNessuna valutazione finora
- PLC Manuale Siemens s7 200Documento473 paginePLC Manuale Siemens s7 200regio49Nessuna valutazione finora
- Quick Guide-Telefono AnalogicoDocumento4 pagineQuick Guide-Telefono AnalogicoGianluca CasellaNessuna valutazione finora
- Manuale FritzBox 7530Documento294 pagineManuale FritzBox 7530Raffaele ManciniNessuna valutazione finora
- ManualeDocumento25 pagineManualeMichelangelo VNessuna valutazione finora
- Joe Lametta - KriptoniteDocumento240 pagineJoe Lametta - KriptoniteMichele ZampiniNessuna valutazione finora