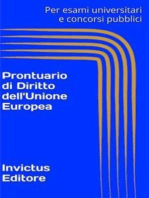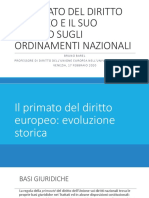Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Regole Europee e Giustizia Civil1
Regole Europee e Giustizia Civil1
Caricato da
robella19920 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
9 visualizzazioni42 pagineTitolo originale
REGOLE EUROPEE E GIUSTIZIA CIVIL1.doc
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
DOC, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOC, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
9 visualizzazioni42 pagineRegole Europee e Giustizia Civil1
Regole Europee e Giustizia Civil1
Caricato da
robella1992Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOC, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 42
REGOLE EUROPEE E GIUSTIZIA CIVILE (a cura di Paolo Biavati e
Michele Angelo Lupoi) I REGOLAMENTI EUROPEI IN MATERIA DI
PROCESSO CIVILE. PROFILI INTRODUTTIVI. 1. I rapporti tra il diritto
comunitario e il diritto processuale nazionale. Il rapporto tra il diritto
comunitario e il diritto nazionale, per quanto riguarda le materie oggetto
della formazione europea, connotato da due criteri: 1) supremazia del
diritto comunitario su quello nazionale 2) immediata applicazione del
diritto comunitario da parte dei giudici nazionali. a questa regola non
si sottrae il diritto processuale. La materia si evoluta sulla base di
diverse fonti: - Trattato di Roma istitutivo della Comunit Europea (1957)
allart 293 (gi 220) promuoveva il riconoscimento e la circolazione
delle decisioni giudiziarie tra i paesi membri, come importante elemento
di supporto alle 4 libert fondamentali. - Convenzione sulla competenza
giurisdizionale e il riconoscimento e lesecuzione delle sentenze in
materia civile e commerciale sottoscritto a Bruxelles nel 1968 -
Protocollo di Lussemburgo del 1971 attribu il compito di interpretare
in modo uniforme la Convenzione di Bruxelles alla Corte di giustizia
delle Comunit europee. - Giurisprudenza della Corte di giustizia in
applicazione delle norme comunitarie - Direttive dedicate ai profili di
diritto sostanziale che hanno poi investito la formazione processuale. -
Trattato di Amsterdam (entrato in vigore nel 1999) la cooperazione
giudiziaria civile diventata oggetto di una precisa politica dellUE. NB:
dal momento dellentrata in vigore del Trattato di Amsterdam ha preso
vita un fenomeno diverso: limpatto del diritto europeo sulla giustizia
civile, da occasionale ed episodico, diventato oggetto di una politica
sistematica scandita da programmi pluriennali. 2. Lautonomia
procedurale. Il rapporto tra i diritti processuali nazionali e il diritto
comunitario pu essere riassunto intorno al concetto di autonomia
procedurale e di supremazia del diritto comunitario: - autonomia
procedurale significa che da un lato i legislatori nazionali hanno
piena libert di modellare le regole di procedura civile e i rispettivi
ordinamenti giudiziari - supremazia del diritto comunitario la
normazione di derivazione comunitaria beneficia della forza del proprio
ordinamento ed quindi dotata di supremazia rispetto al diritto
processuale interno. Si pu quindi parlare di un rapporto di autonomia
supremazia: i diritti processuali interni sono autonomi (anche se
devono garantire uno standard minimo di tutela) e le norme di
procedura derivanti dal diritto comunitario hanno valore prevalente
rispetto alle disposizioni meramente nazionali. ne risulta che le
disposizioni interne (liberamente determinate dai legislatori nazionali)
devono essere sottoposte ad un vaglio di compatibilit con il diritto
europeo. NB: se questo vaglio non superato, le norme in questione
sono inapplicabili, per lo meno nei rapporti interni allUnione. La
ricostruzione di questo rapporto, inizialmente di origine
giurisprudenziale, oggi cristallizzata allinterno del Trattato di Lisbona
2007, secondo cui la cooperazione in materia civile rientra tra le materie
di competenza concorrente tra lUnione e gli Stati membri. 3. I
regolamenti europei. Secondo lart 65 del TCE, lintervento dellUnione
in materia di cooperazione civile poteva avvenire attraverso diversi
strumenti, anche se i regolamenti hanno finito per essere lo strumento
prevalente. prima generazione regolamenti seconda generazione
Regolamenti di prima generazione sono i regolamenti che
trasferiscono nel contesto europeo convenzioni europee o
internazionali preesistenti. qui ci si trova di fronte a normative
collaudate, spesso fondate su un rilevante corpo di precedenti
giurisprudenziali: i testi sono pi omogenei e linterpretazione pi
facile. Regolamenti di seconda generazione sono i regolamenti che
affrontano ex novo determinati istituti. sono spesso frutto di
soluzioni di compromesso e quindi pongono problemi interpretativi e
applicativi maggiori, ma allo stesso tempo alzano il livello di incisivit
della normazione europea. Lintervento dellUnione nella cooperazione
giudiziaria civile non destinato solo agli operatori tecnici, ma anche ai
cittadini e alle imprese per questo assume grande rilevanza il profilo
dellinformazione, che si caratterizza per: a) rete giudiziaria europea
che ha il fine di mettere in contatto le autorit giudiziarie dei diversi stati
membri per facilitare i rapporti reciproci e lo scambio di informazioni e
dati b) atlante giudiziario europeo raccoglie i dati e le notizie
sullorganizzazione giudiziaria dei singoli Stati membri, per facilitare un
corretto funzionamento della cooperazione transnazionale (vi si accede
da un apposito sito internet). 4. La struttura dei regolamenti: profili
generali. Esistono alcuni problemi generali riguardanti tutti i singoli
regolamenti. estensione territoriale degli effetti dei regolamenti europei
Problemi relativi carattere provvisorio dei testi regolamentari ai
regolamenti rapporto tra i regolamenti e la normativa nazionale tecnica
normativa dei regolamenti estensione territoriale degli effetti dei
regolamenti europei la materia della cooperazione civile fu introdotta
dal Trattato di Amsterdam e inserita nel titolo IV del TCE (visti, asili,
immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle
persone)., ossia un contenitore che comprendeva anche materie molto
sensibili. alcuni Stati membri presero le distanze da questa
situazione: ne usc un quadro ampiamente disomogeneo, in cui 3 stati
assunsero un atteggiamento dissonante: - UK e Irlanda si sono
riservate il diritto di partecipare di volta in volta alladozione e
allapplicazione dei singoli regolamenti (opt in). di fatto hanno aderito
a tutti i regolamenti emanati. - Danimarca si escluse a priori dalla
successiva attivit di normazione relativa al titolo IV del Trattato. ha
comunque accettato lapplicazione di due regolamenti (44/2001 e
1348/2000) tramite due specifiche convenzioni con la CE. carattere
provvisorio dei testi regolamentari la revisione dei regolamenti
prevista come un evento fisiologico, destinato a correggere e
modificare limpostazione data nella prima formulazione, alla luce
dellesperienza applicativa. limpostazione cos radicata che il
riesame espressamente previsto anche per i regolamenti che
sostituiscono le prime versioni. rapporto tra i regolamenti e la
normativa nazionale i testi regolamentari, in numerosi punti,
prevedono che le norme nazionali vengano a supportare la loro
applicazione. le lacune (volute) dei regolamenti possono essere
colmate sia da un lavoro interpretativo, sia da norme nazionali
espresse. NB: questa previsione opportuna e funzionale ad una leale e
proficua applicazione del diritto europeo. tecnica normativa dei
regolamenti i regolamenti fanno largo uso di definizioni (che hanno
lobiettivo di fornire un lessico comune ad operatori di diversi paesi e
culture) e di formulari standard di impiego obbligatorio. ricondurre il
diritto a moduli e caselle da riempire, da un lato pone il giurista in
difficolt che abituato a esprimersi senza vincoli, ma dallaltro ha il
pregio di permettere il superamento delle barriere linguistiche e di
favorire la gestione telematica del processo. 5. Regolamenti e policy
giudiziaria dellUnione. 6. I regolamenti e larmonizzazione dei diritti
processuali nazionali. 7. Il ruolo interpretativo della Corte di Giustizia.
Nel dare forma al diritto vivente europeo, un ruolo di rilevo assoluto lha
avuto la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Levoluzione del diritto
processuale avvenuta soprattutto grazie al lavoro della Corte, che ha
potuto plasmare le regole del processo in modo pi diretto rispetto alle
faticose intese politiche alla base delle determinazioni del legislatore
europeo. Allo stesso tempo la Corte di Giustizia ha subito una grave
limitazione nel suo compito ermeneutico in rapporto ai regolamenti
processuali europei. La materia regolata dallart 68 TCE, che deroga le
disposizioni dellart 234 TCE sul rinvio pregiudiziale davanti alla Corte
di Giustizia. 234 TCE attribuisce in esclusiva al giudice europeo il
compito di interpretare il diritto comunitario tutte le volte che davanti al
giudice nazionale sorge una questione di incertezza. il rinvio
pregiudiziale pu essere proposto dai giudici nazionali non di ultima
istanza, contro le cui decisioni non sia possibile un successivo livello di
impugnazione. Lart 68 TCE, restringe lambito di operativit del rinvio
pregiudiziale sotto tre profili: 1) impone una limitazione di materia,
escludendo le misure in materia di mantenimento dellordine pubblico e
di salvaguardia di sicurezza interna 2) esclude i giudici di livello
intermedio dalla possibilit di effettuare il rinvio, affidando questo
compito alle Corti supreme nazionali 3) ad avviso di molta parte della
dottrina, attenua lobbligo di rinvio anche per i giudici di ultima istanza
da obbligo a mera facolt. ne segue che per portare il dubbio
interpretativo sui regolamenti europei davanti alla Corte di Giustizia,
necessario che il processo percorra tutte le sue istanze, con il rispetto
dei tempi di ogni sistema. NB: per questo le pronunce pregiudiziali sui
regolamenti europei sono del tutto sporadiche. 8. Il trattato di Lisbona. Il
13 dicembre 2007 stato siglato il Trattato di Lisbona sul
funzionamento dellunione (TFU), che modifica il TCE. Questo trattato
ha delle ricadute sul diritto processuale europeo: a) la politica europea
in materia giudiziaria viene espressamente attribuita alla competenza
concorrente dellUnione e degli Stati membri b) la politica europea in
materia giudiziaria viene ridefinita e ampliata c) viene abrogato lart 68 e
quindi si sono eliminate le restrizioni soggettive finora esistenti in
rapporto alla possibilit per i giudici di istanza intermedia di effettuare il
rinvio pregiudiziale rimangono in vita solo le limitazioni relative
allordine pubblico interno dei paesi membri. IL REGOLAMENTO CE
44/2001 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE, IL
RICONOSCIMENTO E LESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA
CIVILE E COMMERCIALE. 1. Introduzione. Tra i regolamenti europei, il
regolamento 44/2001 (Bruxelles I) quello pi applicato. Questo
regolamento rappresenta levoluzione della convenzione di Bruxelles
del 1968, con cui i primi sei Stati membri dellUnione iniziarono
quellopera di semplificazione delle formalit del reciproco
riconoscimento e dellesecuzione dei provvedimenti giurisdizionali (che
in anni recenti ha portato alla creazione del titolo esecutivo europeo).
alla convenzione di Bruxelles va riconosciuto il merito di aver gettato le
basi di quello spazio giuridico europeo che si sviluppato e
consolidato dopo il Trattato di Amsterdam. Il regolamento 44/2001 ha
preso il posto della Convenzione di Bruxelles. Di essa ne ha recepito il
la struttura doppia e la filosofia, in un ottica di continuit
nellinnovazione. 2. Ambito di applicazione: la materia civile e
commerciale. Sul piano oggettivo, il regolamento 44/2001 si applica alla
materia civile commerciale, a prescindere dalla natura dellorgano
giudiziario adito. lart 1 esclude espressamente dallambito oggettivo di
applicazione del regolamento: - la materia fiscale - la materia doganale
solo se loggetto principale della controversia - la materia
amministrativa ricomprende tutte le controversie in cui sia parte una
PA che agisca nellesercizio della potest dimperio, a prescindere dai
criteri di ripartizione di competenza tra le corti degli Stati membri. 3. Le
materie escluse. Sempre ai sensi dellart 1, oltre alla materia fiscale,
doganale e amministrativa, sono escluse altre materie (riconducibili
allambito civile e commerciale) se costituiscono loggetto principale
della controversia. Esse sono: a) lo stato e la capacit delle persone
fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni
lesclusione motivata dalla differenza di trattamento sostanziale da
parte degli Stati membri b) i fallimenti, i concordati e la procedure affini
lesclusione motivata dalla mancanza di omogeneit nelle posizioni
degli Stati membri e dalla volont di disciplinare la materia
dellinsolvenza transnazionale in una sede specifica c) la sicurezza
sociale d) l'arbitrato lesclusione motivata con lopportunit di non
interferire con la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento
e sullesecuzione di un lodo arbitrale. 4. Le norme sulla giurisdizione:
introduzione. Il regolamento 44/2001 recepisce il sistema giurisdizionale
creato dalla Convenzione di Bruxelles e basato sulleliminazione dei fori
esorbitanti (privi di un significativo rapporto con le parti o con la
controversia). Sul piano dei criteri applicabili, il regolamento prefigura
tre diverse possibilit: - il convenuto domiciliato in uno Stato membro
deve essere citato in giudizio in uno dei fori direttamente previsti dal
regolamento - il convenuto domiciliato in uno Stato terzo soggetto alla
lex fori dei singoli stati contraenti - le norme previste da una
convenzione in materie speciali di cui uno Stato membro parte,
prevalgono sulle analoghe previsioni del regolamento. NB: come regola
generale irrilevante il domicilio o la nazionalit dellattore ai fini
giurisdizionali. Nei confronti dei convenuti domiciliati in uno Stato
membro, il regolamento predispone: - un criterio di competenza
generale utilizzabile a prescindere dalloggetto della controversia -
alcuni criteri speciali che attribuiscono giurisdizione in alternativa al
criterio generale - alcuni criteri con natura esclusiva per specifiche
materie, che prevalgono su qualsiasi altro criterio - alcuni criteri con
natura quasi esclusiva, individuati in maniera autonoma dal legislatore
comunitario per alcune materie. 5. Il foro generale. Come regola
generale un convenuto deve essere citato nello Stato in cui
domiciliato al momento della proposizione della domanda sono
irrilevanti sia la nazionalit che il domicilio eletto del convenuto. Il
legislatore ha stabilito come individuare il domicilio: a) persone fisiche
il giudice adito deve applicare la propria legge nazionale. Se per
deve stabilire che il convenuto domiciliato in unaltro Stato, dovr
applicare la legge di quello Stato. NB: in caso di contrasto tra legge
nazionale e legge straniera, la legge nazionale a prevalere b) persone
giuridiche il legislatore comunitario allart 60 ha individuato una
nozione autonoma di domicilio delle societ e delle persone giuridiche,
da intendersi (in via alternativa e cumulativa) come il luogo in cui si
trova la sede statutaria, o lamministrazione centrale o il centro di
attivit principale. 6. I criteri speciali di competenza: lart 5. Il
regolamento agli art 5 e 6 individua alcuni fori speciali che lattore, con
scelta insindacabile, pu adire in via alternativa a quello generale del
domicilio del convenuto. Si tratta di ipotesi tassative ed interpretate in
modo restrittivo per evitare di svuotare di contenuto il foro generale
previsto dallart 2. I principali fori speciali sono: materia contrattuale
la disciplina stata innovata nel passaggio dalla Convenzione di
Bruxelles al regolamento 44/2001. Ad oggi sono previste due ipotesi,
una generale e una riservata ad alcune specifiche tipologie di contratti:
a) ipotesi generale la persona domiciliata nel territorio di uno Stato
membro pu essere convenuta in un altro Stato membro davanti al
giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio stata o deve
essere eseguita; b) ipotesi speciali si applicano a due tipologie di
contratti: - contratti di compravendita di beni il luogo di esecuzione
dell'obbligazione dedotta in giudizio il luogo, situato in uno Stato
membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati
in base al contratto. - contratti di prestazione di servizi il luogo di
esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio , il luogo, situato in
uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere
prestati in base al contratto. NB: lipotesi a) si applica nei casi in cui non
applicabile la lettera b). materia alimentare nelle controversie
relative ad obbligazioni alimentari viene attribuita giurisdizione al
giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la
residenza abituale. se si tratta di una domanda accessoria ad
un'azione relativa allo stato delle persone, essa deve essere posta al
giudice competente a conoscere quest'ultima secondo la legge
nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla
cittadinanza di una delle parti. NB: deve esserci coincidenza tra colui
che pone la domanda e il soggetto che ha diritto agli alimenti. materia di
fatti illeciti in relazione agli illeciti civili dolosi o colposi, la norma
attribuisce giurisdizione speciale al giudice del luogo in cui l'evento
dannoso avvenuto o pu avvenire; NB: il luogo in cui levento
dannoso avvenuto va inteso in alternativa, sia come il luogo in cui si
manifestato levento dannoso, sia il luogo in cui stata posta in essere
la condotta lesiva. materia dellattivit di una sede secondaria nelle
controversie che riguardano lattivit di una succursale, di unagenzia o
di qualsiasi altra sede di attivit, si attribuisce giurisdizione speciale al
giudice del luogo in cui situata, a condizione che sia la societ madre
che la sede secondaria siano localizzate in uno Stato membro. Lart 5
prevede poi altri criteri speciali, i quali per sono di rarissima
applicazione, e riguardano: - la materia del risarcimento del danno o
della restituzione da reato - la materia del trust - alcune questioni del
diritto della navigazione. 7. La giurisdizione speciale per motivi di
connessione. I criteri speciali degli art 6 e 7 collegano lesercizio della
giurisdizione ad una connessione tra domande, nellottica di
concentrare pi azioni davanti ai giudici di un solo Stato membro e di
ottenere una decisione unitaria su fattispecie complesse sul piano
oggettivo e soggettivo. litisconsorzio passivo casi di fori speciali
chiamata di terzo domanda riconvenzionale litisconsorzio passivo un
convenuto domiciliato in uno Stato membro pu essere citato davanti ai
giudici di un altro Stato membro se in esso vi domiciliato un altro
convenuto. questo cumulo soggettivo ammissibile solo se tra le
domande esiste un nesso cos stretto da rendere opportuna una
trattazione e una decisione unica. La verifica dellesistenza di questo
nesso spetta al giudice nazionale. chiamata di terzo un convenuto
domiciliato in uno Stato membro pu essere citato in giudizio, a titolo di
chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice di uno
Stato diverso competente sulla domanda principale domanda
riconvenzionale il giudice di uno Stato membro competente sulla
domanda principale pu conoscere anche della domanda
riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la
domanda principale, proposta nei confronti di un soggetto non
domiciliato nel foro. i tempi e i modi di proposizione della domanda
riconvenzionale sono determinati dalla lex fori. 8. La giurisdizione
protettiva. Il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno dettare
norme di favore per la controparte debole in un determinato rapporto
questa tutela si traduce nella possibilit di accedere ad un pi ampio
novero di fori rispetto alla controparte forte. Contratti che sono contratti
di assicurazione oggetto della contratti conclusi dai consumatori
giurisdizione protettiva contratti individuali di lavoro contratti di
assicurazione la disciplina dei fori relativi alle controversie in materia
di contratti di assicurazione prevede che l'assicuratore domiciliato nel
territorio di uno Stato membro pu essere convenuto: - davanti ai
giudici dello Stato in cui domiciliato - davanti al giudice del luogo in
cui domiciliato l'attore se l'azione proposta dal contraente
dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario - davanti al
giudice di uno Stato membro presso il quale sia stata proposta l'azione
contro l'assicuratore al quale affidata la delega del contratto di
assicurazione se si tratta di un coassicuratore - davanti al giudice del
luogo in cui si verificato l'evento dannoso se si tratta di
assicurazione della responsabilit civile o di assicurazione sugli
immobili - davanti al giudice presso il quale stata proposta l'azione
esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale
giudice lo consenta se si tratta di assicurazione della responsabilit
civile NB: lassicuratore invece, pu agire in giudizio solo nel foro del
domicilio del convenuto, salva la possibilit di proporre domanda
riconvenzionale davanti al giudice adito dalla sua controparte. contratti
conclusi dai consumatori il consumatore pu scegliere se adire il
giudice nel foro del domicilio della controparte o nel foro del suo
domicilio. NB: il professionista invece pu adire solo il giudice del foro
del domicilio del consumatore convenuto. contratti individuali di lavoro
il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro pu
essere convenuto: 1) davanti ai giudici dello Stato membro in cui
domiciliato 2) in un altro Stato membro: a) davanti al giudice del luogo
in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attivit o a quello
dell'ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente, b) qualora il lavoratore
non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attivit in un solo
paese, davanti al giudice del luogo in cui o era situata la sede d'attivit
presso la quale stato assunto. NB: il datore di lavoro vincolato ad
agire nel foro del domicilio del lavoratore, salva la possibilit di
proporre domanda riconvenzionale nel foro in cui stata proposta la
domanda principale. 9. I fori esclusi. Lart 22 elenca una serie di criteri
di competenza che, in specifiche materie, escludono loperare del
criterio generale e di quelli speciali, in relazione allo stretto legame tra
la controversia e il foro. I fori esclusivi sono: 1) in materia di diritti reali
immobiliari e di contratti d'affitto di immobili i giudici dello Stato
membro in cui l'immobile situato 2) in materia di validit, nullit o
scioglimento delle societ o persone giuridiche, aventi la sede nel
territorio di uno Stato membro, o riguardo alla validit delle decisioni
dei rispettivi organi i giudici di detto Stato membro 3) n materia di
validit delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri i giudici
dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti; 4) in materia
di registrazione o di validit di brevetti, marchi, disegni e modelli e di
altri diritti analoghi per i quali prescritto il deposito ovvero la
registrazione i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito
o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da
considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di
una convenzione internazionale. salva la competenza dell'ufficio
europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio di brevetti
europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, i giudici di
ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva, a prescindere dal
domicilio, in materia di registrazione o di validit di un brevetto europeo
rilasciato per tale Stato; 5) in materia di esecuzione delle decisioni i
giudici dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'esecuzione. 10.
La giurisdizione in materia cautelare. In materia cautelare, il giudice
competente sulla domanda di merito implicitamente competente ad
emettere ogni provvedimento cautelare previsto dalla lex fori, a
prescindere dal luogo in cui lo stesso deve essere attuato. Inoltre,
anche in difetto di competenza sul merito, i provvedimenti provvisori o
cautelari possono essere chiesti al giudice dello Stato in cui gli stessi
devono essere eseguiti. provvedimenti cautelari o provvisori definiti
dalla corte di giustizia come le misure destinate a conservare una
situazione di fatto o di diritto, al fine di salvaguardare i diritti il cui
riconoscimento demandato al giudice del merito. NB: devono avere
natura provvisoria. 11. La giurisdizione fondata sul consenso tra le
parti. Il regolamento ha previsto la possibilit per le parti (se almeno
una domiciliata in uno Stato membro) di stipulare accordi per
attribuire la giurisdizione al giudice di uno o pi Stati dellUnione. Le
parti possono scegliere di attribuire al giudice da loro individuato una
giurisdizione solo concorrente con quella dei giudici altrimenti
competenti. Inoltre laccordo valido solo tra le parti e non nei confronti
dei terzi. I requisiti formali dellaccordo (definito clausola di proroga)
prevedono che laccordo sia: - scritto o confermato per iscritto -
concluso in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno
stabilito tra loro - concluso nella forma ammessa da un uso conosciuto
e rispettato dagli operatori di settore, che le parti conoscevano o
dovevano conoscere nel commercio internazionale art 24 oltre che
nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del
presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il
convenuto comparso competente. NB: questa norma non si applica
se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza o se esiste un
altro giudice esclusivamente competente. 12. Leccezione di difetto di
giurisdizione. Leccezione di difetto di giurisdizione, come regola
generale, pu essere sollevata solo dal convenuto costituito in giudizio.
Solo quando la controversia soggetta ad una competenza esclusiva
(art 22), il giudice pu rilevare dufficio il proprio difetto di giurisdizione,
nonostante laccettazione del convenuto. Se il convenuto rimasto
contumace, il giudice adito deve verificare la sua competenza e
dichiararsi (eventualmente) incompetente. 13. Litispendenza e
connessione tra cause. norme sul coordinamento litispendenza
comunitaria (art 27) di procedimenti pendenti in Stati membri diversi
connessione internazionale (art 28) litispendenza comunitaria la
contemporanea pendenza, davanti ai giudici di Stati membri differenti e
tra le stesse parti, di domande con lo stesso oggetto e lo stesso titolo
(art 27). la corte di giustizia ha ampliato la nozione di questo istituto
prevedendo la sua applicazione ogni volta che vi una situazione di
contemporanea pendenza della stessa causa davanti ai giudici di Stati
membri diversi, a prescindere dalla natura dellorgano giudicante e dal
domicilio delle parti in uno Stato terzo. Le norme sulla litispendenza
comunitaria sono applicabili solo a provvedimenti idonei ad acquisire
lautorit di cosa giudicata o comunque a dare una stabile
regolamentazione di un rapporto giuridico questo perch solo da un
accertamento incontrovertibile pu derivare un ostacolo definitivo alla
circolazione dei provvedimenti attraverso le frontiere. Nel caso di
litispendenza comunitaria, il giudice successivamente adito deve
sospendere dufficio il procedimento finch sia accertata la competenza
del giudice adito in precedenza in questo caso il giudice
successivamente adito deve dichiarare la sua incompetenza a favore
del primo. connessione internazionale la connessione internazionale
tra cause si verifica quando davanti ai giudici di Stati membri diversi
pendono nello stesso momento cause connesse con un legame cos
stretto da rendere opportuna una trattazione e una decisione unica.
in questi casi il giudice della causa instaurata per seconda pu decidere
di sospendere il suo processo in attesa della decisione della prima
azione. NB: la norma ammette anche la riunione tra i procedimenti
connessi se il giudice adito per primo competente a conoscere di
entrambe le domande. 14. Riconoscimento ed esecuzione delle
decisioni rese in altri Stati membri. Sul principio della circolazione delle
decisioni attraverso le frontiere, il regolamento 44/2001 sancisce il
principio dellautomatico riconoscimento delle decisioni emesse dai
giudici degli Stati membri, stabilendo che solo in caso di contestazione
si debba accertare per vi giudiziale lesistenza di eventuali motivi
ostativi al riconoscimento. per lesecuzione dei provvedimenti
stranieri necessaria la concessione dellexequatur. Le norme del
regolamento si applicano non solo alle sentenze, ma a tutte le decisioni
rese da un organo giurisdizionale dotate di esecutivit (ad esclusione di
quelle con contenuto processuale). Il procedimento per il
riconoscimento (in caso di contestazione) o per lexequatur ha carattere
monitorio: - linteressato deposita un ricorso al giudice indicato come
competente dal regolamento, allegando i documenti necessari - il
giudice, compiuti gli adempimenti formali, deve concedere con decreto
il riconoscimento o lexequatur - infine il provvedimento viene notificato
alla controparte. Entro un mese dalla notificazione del provvedimento,
la controparte pu proporre opposizione: si instaura cos il
procedimento di accertamento nel quale si possono solo valutare i
motivi di diniego, essendo escluso ogni riesame della decisione
straniera. NB: in caso di accoglimento parziale dellopposizione si
prevede la possibilit di un riconoscimento o di un exequatur parziale.
15. I motivi di diniego al riconoscimento o allesecuzione. I motivi che
escludono il riconoscimento o lesecuzione di una decisione straniera
sono limitati e hanno natura tassativa. Secondo lart 34, le decisioni non
sono riconosciute: a) se il riconoscimento contrario all'ordine
pubblico dello Stato membro richiesto; b) se la domanda giudiziale (o
un atto equivalente) non stato notificato o comunicato al convenuto
contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie
difese c) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le stesse
parti nello Stato membro richiesto; d) se sono in contrasto con una
decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato
membro o in un paese terzo, in una controversia avente lo stesso
oggetto e lo stesso titolo, se tale decisione presenta le condizioni
necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto. ai
sensi dellart 35, il riconoscimento o lesecuzione possono essere
rifiutati: a) se il giudice dorigine ha violato le norme del regolamento in
materia di contratti di assicurazione o conclusi dai consumatori b) se ha
violato i criteri di competenza esclusiva previsti dallart 22 a dallart 72
NB: fuori da queste ipotesi vi il divieto di riesame della giurisdizione
del primo giudice assoluto. IL REGOLAMENTO CE 2201/2003,
RELATIVO ALLA COMPETENZA, AL RICONOSCIMENTO E
ALLESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI
RESPONSABILITA GENITORIALE. 1. Genesi e filosofia del regolamento.
Ladozione di questo regolamento non nasce sulla base di intenti
comunitari del legislatore dellUnione, ma la risposta a una necessaria
preoccupazione per il buon funzionamento del mercato interno. La
realt sociale ci mostra un aumento di separazioni, divorzi e filiazioni
fuori e dentro il matrimonio tra coppie transnazionali favorire la libera
circolazione delle persone e dei lavoratori allinterno dellUnione
postula che le persone possano portare con se anche le situazioni
personali che le riguardano. 2. Le tappe che hanno condotto al
regolamento 2201/2003. Le tappe che hanno condotto al regolamento
2201/2003 possono essere cos riassunte: a) convenzione di Bruxelles
1998 (Bruxelles II) regolava la competenza, il riconoscimento e
lesecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilit genitoriale b) regolamento 1347/2000 ha
sostanzialmente assorbito la Convenzione di Bruxelles II c) regolamento
2201/2003 ha sostanzialmente assorbito il regolamento 1347/2000
nonostante il regolamento del 2003 abbia assorbito quello del 2000, tra i
due esistono delle differenze: regolamento 1347/2000 regolamento
2201/2003 La presenza dei figli un corollario al matrimonio Il
matrimonio uneventualit (pur frequente) in materia di filiazione Si
applicava limitatamente ai procedimenti relativi alla potest genitoriale
sui figli di entrambi i coniugi, instaurati in occasione dei procedimenti in
materia matrimoniale si applica alla responsabilit genitoriale, a
prescindere sia dalla contestualit della decisione di questultima con
un procedimento matrimoniale, sia dallesistenza di un matrimonio Si
applicava solo ai figli di entrambi i coniugi applicabile ai minori anche
quando essi non siano figli di entrambi i genitori o di entrambi i coniugi
3. Principi ispiratori e ambito di applicazione. Il regolamento 2201/2003,
allart 1 prevede espressamente che esso operi, indipendentemente dal
tipo di autorit giurisdizionale, nelle materie civili relative: a) al divorzio,
alla separazione personale e allannullamento del matrimonio b)
allattribuzione, allesercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale
della responsabilit genitoriale Per risolvere a preventivamente dubbi
interpretativi, lart 2 ha fornito la definizione di responsabilit genitoriale
complesso di diritti e doveri di cui investita una persona fisica o
giuridica in base ad una decisione giudiziaria, o alla legge o ad un
accordo in vigore riguardante la persona o i beni del minore e
comprende anche il diritto di affidamento e il diritto di visita. 4. Il regime
di riparto della competenza giurisdizionale. Per lindividuazione dei fori
competenti, il regolamento 2201/2003 caratterizzato da una certa
orizzontalit nella distribuzione dei fori. criteri materia di divorzio,
separazione e annullamento del matrimonio di competenza generale
materia di competenza genitoriale criteri di competenza generale in
materia di divorzio, separazione personale e annullamento del
matrimonio lart 3 attribuisce alternativamente la competenza: a) al
giudice dello Stato membro nel cui territorio si trova: - la residenza
abituale dei coniugi - l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di
essi vi risiede ancora - la residenza abituale del convenuto - in caso di
domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi - la
residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un
anno immediatamente prima della domanda - la residenza abituale
dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per 6 mesi immediatamente
prima della domanda ed cittadino dello Stato membro stesso ( nel
caso del Regno Unito e dell'Irlanda, al giudice dello Stato membro dove
ha il proprio "domicile"). b) al giudice dello Stato membro in cui i due
coniugi sono cittadini ( nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, al
giudice dello Stato membro del "domicile" di entrambi i coniugi). il
giudice competente in base all'articolo 3 competente anche per
esaminare la domanda riconvenzionale, se essa rientra nel campo
d'applicazione del presente regolamento. NB: i criteri di competenza
giurisdizionale in materia matrimoniale hanno natura esclusiva e quindi
inderogabile. criteri di competenza generale in materia di responsabilit
genitoriale la competenza spetta al giudice dello Stato membro in cui
il minore ha la sua residenza abituale. in via eccezionale le autorit
giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito,
se ritengono che l'autorit giurisdizionale di un altro Stato membro (con
il quale il minore ha un legame particolare) sia pi adatto a trattare il
caso o una sua parte e ove ci corrisponda all'interesse superiore del
minore, possono: a) interrompere l'esame del caso o della parte in
questione e invitare le parti a presentare domanda all'autorit
giurisdizionale dell'altro Stato membro b) chiedere all'autorit
giurisdizionale dell'altro Stato membro di assumere la competenza 5. Il
riconoscimento delle decisioni. Riconoscimento delle decisioni (art 21)
in materia vi il riconoscimento automatico delle decisioni: la
decisione pronunciata in uno Stato membro riconosciuta negli altri
Stati membri senza che sia necessario il ricordo ad alcun procedimento
(principio generale). sono poi previsti una serie di motivi, tipici e
tassativi, che possono essere causa di diniego del riconoscimento: art
22: motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio,
separazione personale o annullamento del matrimonio la decisione di
divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non
riconosciuta nei casi seguenti: a) se il riconoscimento
manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro
richiesto; b) quando resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale
o un atto equivalente non stato notificato o comunicato al convenuto
contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie
difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato
inequivocabilmente la decisione; c) se la decisione incompatibile con
una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato
membro richiesto; o d) se la decisione incompatibile con una
decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro
o in un paese terzo, purch la decisione anteriore soddisfi le condizioni
prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto. art 22:
motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilit
genitoriale le decisioni relative alla responsabilit genitoriale non
sono riconosciute nei casi seguenti: a) se, tenuto conto dell'interesse
superiore del minore, il riconoscimento manifestamente contrario
all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; b) se, salvo i casi
d'urgenza, la decisione stata resa senza che il minore abbia avuto la
possibilit di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di
procedura dello Stato membro richiesto; c) quando resa in
contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non
stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e
in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato
accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la
decisione; d) su richiesta di colui che ritiene che la decisione sia lesiva
della propria responsabilit genitoriale, se stata emessa senza dargli
la possibilit di essere ascoltato; e) se la decisione incompatibile con
una decisione successiva sulla responsabilit genitoriale emessa nello
Stato membro richiesto; f) se la decisione incompatibile con una
decisione successiva sulla responsabilit genitoriale emessa in un altro
Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risieda, la quale soddisfi
le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro
richiesto; NB: un motivo di diniego anche il mancato ascolto del
minore, salvo i casi in cui non lo si ritenga opportuno dellinteresse del
minore stesso. 6. Lesecuzione delle decisioni. esecuzione relative
allesercizio della responsabilit genitoriale su un minore delle decisioni
in materia di diritto di visita e di ritorno del minore esecuzione delle
decisioni relative allesercizio della responsabilit genitoriale su un
minore sottoposta alla previa attivazione di una procedura che ha
lobiettivo di apporre la formula esecutiva negli Stati diversi da quello
nel quale stato pronunciato. esecuzione delle decisioni in materia di
diritto di visita e di ritorno del minore non soggetta ad alcun
provvedimento di exequatur, essendo richiesta soltanto lesibizione di
alcuni documenti. un regime speciale e privilegiato in quanto
prevede lautomaticit e limmediatezza del riconoscimento e
dellesecuzione, senza che sia possibile proporre opposizione o che sia
necessario un procedimento ad hoc per ottenere lexequatur delle
decisioni che stabiliscono il diritto di visita a favore del genitore non
affidatario o dispongono il ritorno del minore illecitamente sottratto. 7. I
rapporti tra il regolamento 2201/2003 e le altre convenzioni
internazionali. Il rapporto tra il regolamento 2201/2003 e alcune
convenzioni internazionali che si occupano degli stessi temi
disciplinato dagli art 60 e 61 del regolamento, che prevedono la
preminenza del regolamento rispetto a determinate convenzioni sulle
stesse materie. IL REGOLAMENTO CE 805/2004 SUL TITOLO
ESECUTIVO EUROPEO PER I CREDITI NON CONTESTATI E IL
REGOLAMENTO 1896/2006 SUL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE
EUROPEO. 1. Le premesse allemanazione dei regolamenti e la loro
funzione. Nellottica di agevolare sempre pi la circolazione dei
provvedimenti giudiziari, il Consiglio dEuropa nel 2000 adott un
Progetto di Programma di misure relative alattuazione del principio del
riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e
commerciale (definito semplicemente Programma). Il Programma aveva
come obiettivo finale il completo superamento di ogni formalit di
exequatur e prevedeva unattuazione in diverse fasi. Le prime due fasi
del Programma sono state attuate attraverso i regolamenti: - 805/2004
titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati - 1896/2006
procedimento di ingiunzione europeo. questi regolamenti evolvono la
generale disciplina in tema di riconoscimento ed esecuzione delle
decisioni giudiziarie dettata dal regolamento 44/2001. circolazione delle
titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (Tee) decisioni
giudiziarie procedimento di ingiunzione europeo (Ipe) Titolo esecutivo
europeo per i crediti non contestati (Tee) prevede unesecuzione
immediata del titolo giudiziale straniero senza la necessit di un
provvedimento certificativo o autorizzativo dello Stato ad quem.
procedimento GENERALE. procedimento di ingiunzione europeo (Ipe)
lingiunzione di pagamento ottenuta in base ad un procedimento
identico in tutto il territorio comunitario ed quindi idonea per natura
a circolare in tutto il territorio dellUnione senza bisogno dellexequatur.
procedimento SPECIALE. I due regolamenti si distinguono per la loro
differente fase di applicazione: - titolo esecutivo europeo per i crediti
non contestati (805/2004) si applica nella fase successiva
allemissione della decisione esecutiva - procedimento di ingiunzione
europeo (1896/2006) si applica nella fase precedente allemissione
della decisione esecutiva. 2. Il titolo esecutivo europeo: ambito di
applicazione. regolamento 805/2004 istitutivo del Tee consente di
chiedere lesecuzione immediata in un altro Stato membro dei
provvedimenti aventi ad oggetto crediti pecuniari, liquidi, esigibili e non
contestati, senza che sia necessario un provvedimento certificativo o
autorizzativo da parte dello stesso. Si identificano come crediti non
contestati: - i crediti che il debitore ha espressamente riconosciuto con
una dichiarazione resa nel corso del procedimento giudiziario, con
transazione approvata dal giudice o in un atto pubblico - i crediti che il
debitore non ha contestato nel corso del procedimento giudiziario in
conformit con le norme processuali vigenti nello Stato di origine - i
crediti oggetto di procedimenti nei quali il debitore, pur avendo
inizialmente sollevato la contestazione, non poi comparso o non si sia
fatto rappresentare in udienza ( se questo comportamento equivale ad
ammissione tacita) 3. Il rilascio della certificazione. Il Tee
caratterizzato dallassenza di controllo sulla sussistenza dei motivi
ostativi alla circolazione della decisione dotata di forza esecutiva, negli
altri Stati membri. I controlli effettuati al momento della richiesta di
exequatur sono qui sostituiti da una certificazione rilasciata dal giudice
a quo. Una volta attribuita la certificazione di Tee, la decisione ha forza
esecutiva sullintero territorio comunitario. ammessa la
certificazione parziale quando la decisione/transazione giudiziaria/atto
pubblico soddisfi solo in parte i requisiti del regolamento 805/2004. 4.
Le condizioni per la certificazione. La disciplina regolamentare in esame
incentrata sulla fiducia negli ordinamenti processuali e nei giudici
degli altri Stati membri un presupposto ineccepibile in astratto ma
di difficile accettazione in concreto. Per tutelare la posizione del
convenuto, il capo III del regolamento prevede che la certificazione del
Tee sia condizionata al rispetto di un ampio novero di garanzie
processuali minime. La certificabilit del futuro titolo giudiziale va
preparata dallinizio solo gli atti introduttivi del giudizio con un
determinato contenuto potranno dare luogo a decisioni esportabili
come titolo giudiziario esecutivo europeo. requisiti per la certificabilit
dati minimi essenziali per la corretta informazione del convenuto del
titolo giudiziale modalit tassative di notificazione dati minimi essenziali
per la corretta informazione del convenuto latto introduttivo deve
contenere lindicazione: - delle parti - dellimporto della somma
richiesta, con lindicazione del tasso di interesse - dei motivi della
domanda - dei termini e delle modalit delleventuale contestazione del
convenuto - delle conseguenze che derivano dalla mancata
contestazione. modalit tassative di notificazione il regolamento
prevede due diverse serie di modalit notificatorie, entrambe da
considerarsi rituali la distinzione si basa sulla circostanza che sia
fornita o meno la prova delleffettivo ricevimento dellatto introduttivo
da parte del debitore. Le norme sul contenuto dellatto introduttivo e
sulle notifiche costituiscono le garanzie minimali pretese dal legislatore
comunitario per dare (fin dallorigine) limpostazione di Tee alla
decisione che concluder il processo cos introdotto. Il certificato di Tee
pu essere oggetto di rettifica o revoca, su istanza presentata al giudice
dorigine: - rettifica avviene quando, a causa di un errore materiale, vi
divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato - revoca
avviene quando stato concesso per errore, tenuto conto dei requisiti
stabiliti nel presente regolamento. 5. Lingiunzione di pagamento
europea: ambito di applicazione. regolamento 1896/2006 istitutivo del
Ipe il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento per i crediti
non contestati ha come obiettivo il superamento delle formalit di
exequatur operando sul diverso piano delluniformazione delle
legislazioni processuali. Il procedimento europeo di ingiunzione nasce
per soddisfare le esigenze di tutela degli operatori commerciali (ma
anche dei creditori civili) nei rapporti economici internazionali grazie
a questo procedimento, coloro che operano negli Stati dellUnione
sanno di poter fare affidamento sullesistenza in ogni paese dello
stesso procedimento per la riscossione dei crediti non contestati. il
ricorrente pu comunque far valere il credito anche utilizzando
leventuale strumento processuale nazionale. NB: il regolamento si
applica alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale
(quindi a quelle dove almeno una delle parti ha il domicilio/residenza in
uno Stato diverso dallo Stato membro del giudice adito). 6. Modelli di
ingiunzione e scelta del legislatore europeo. procedimento europeo
onere probatorio e/o di allegazione del ricorrente di ingiunzione
struttura del procedimento onere probatorio e/o di allegazione del
ricorrente il procedimento di ingiunzione di pagamento appartiene
alla categoria dellingiunzione senza prova. nellingiunzione senza
prova vi la totale assenza di qualsiasi esame nel merito della domanda
da parte del giudice, il quale deve emettere lingiunzione di pagamento
ogni qual volta il ricorso ammissibile e sussistono le condizioni
formali di base. struttura del procedimento il procedimento di
ingiunzione di pagamento appartiene alla categoria dei procedimenti a
fase unica. la fase unica caratterizzata dal fatto che il giudice
pronunci una sola decisione sul merito della domanda (o emetta
lingiunzione di pagamento) al termine della fase inaudita altera parte:
se il termine prescritto per lopposizione trascorre senza che il creditore
abbia contestato il credito, questunica decisione diventa definitiva
acquisendo la stabilit di effetti tipica del giudicato. 7. I presupposti per
la tutela monitoria europea. soggetti abilitati a richiederla ingiunzione di
pagamento crediti per i quali pu essere richiesta soggetti abilitati a
richiederla possono chiedere un ingiunzione di pagamento europea
davanti al giudice territorialmente competente a norma del regolamento
44/2001 coloro che vantano crediti pecuniari di natura civile o
commerciale per un importo specifico e che siano giunti alla scadenza
al momento della presentazione della domanda. NB: questi soggetti
hanno comunque diritto ad attivarsi per il recupero degli stessi crediti
utilizzando un altro procedimento (ordinario o sommario) previsto dalla
legislazione dello Stato membro. crediti per i quali pu essere richiesta
lingiunzione di pagamento pu essere utilizzata, senza alcun limite
di valore, per ottenere il pagamento di crediti civili e commerciali certi,
liquidi ed esigibili che abbiano ad oggetto il pagamento di una somma
di denaro. 8. Il procedimento. Lemissione del provvedimento
subordinata: - alla sola verifica dei presupposti per lapplicabilit al
caso concreto della disciplina monitoria europea - alla presenza delle
condizioni formali relative al contenuto dellistanza NB: lemissione del
provvedimento non prevede una preventiva valutazione nel merito del
diritto vantato. presupposti per mancanza dei presupposti di
ammissibilit lammissibilit dellemissione i presupposti di
ammissibilit sono presenti solo parzialmente del provvedimento
sussistenza dei presupposti di ammissibilit mancanza dei presupposti
di ammissibilit se il giudice ritiene che manchino 1/+ condizioni
formali pu dare al ricorrente la possibilit di completare o rettificare la
domanda, salvo che la stessa non sia manifestatamente infondata o
irricevibile. i presupposti di ammissibilit sono presenti solo
parzialmente se il giudice ritiene che le condizioni per lemissione
siano presenti solo in parte, invita il ricorrente a manifestare
lintenzione di accettare o rifiutare unemissione parziale. NB: in difetto
di integrazione della domanda o di mancata accettazione di
unemissione parziale, il ricorso dovr essere rigettato con
provvedimento motivato non impugnabile e non idoneo a creare
stabilit negli effetti. il creditore potr riproporre la domanda in via
monitoria o instaurare un giudizio ordinario. sussistenza dei
presupposti di ammissibilit se sussistono i presupposti per
lammissibilit e sono soddisfatte le condizioni formali previste dal
regolamento, il giudice emette lingiunzione di pagamento europea
entro 30gg. Lingiunzione di pagamento europea, una volta emessa
deve essere recapitata al debitore. Ricevuto latto, il debitore ha due
possibilit: - pagare al ricorrente limporto richiesto (comprensivo di
interessi e spese) - opporsi allingiunzione nel termine di 30gg dal
ricevimento dellatto formulata lopposizione si apre un giudizio
modellato secondo le scansioni e le formule del rito ordinario di ciascun
paese membro, salvo che il ricorrente non avesse preventivamente
specificato nella domanda introduttiva di voler interrompere la
controversia in caso di opposizione del debitore. IL REGOLAMENTO CE
1206/2001 SULLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA NELLASSUNZIONE
DELLE PROVE CIVILI. 1. Dalla convenzione dellAia del 1970 al
regolamento 1206/2001. La cooperazione giudiziaria rappresenta lunica
via per ottenere lassunzione delle prove situate allestero senza non
possibile raccogliere le prove senza intaccare la sovranit dello Stato
in cui la prova si trova. Il tema della cooperazione internazionale
nellassunzione delle prove stato ampiamente trattato: - Convenzione
dellAia relativa allassunzione delle prove allestero nelle materie
civili e commerciali - Regolamento 1206/2001 ha riproposto limpianto
normativo della convenzione, eliminando i pesanti condizionamenti
politici il regolamento prevale sulle disposizioni contenute in accordi
bilaterali e multilaterali con lo stesso oggetto (quindi anche sulla
convenzione dellAia). NB: agli Stati comunque concesso concludere
convenzioni bilaterali che introducono forme di cooperazione ancora
pi avanzate. 2. Campo di applicazione del regolamento. delimitazioni
dellambito soggettivo di applicazione del regolamento 1206/2001
oggettivo delimitazioni SOGGETTIVE le procedure descritte nel
regolamento non sono applicabili alla Danimarca nei rapporti tra
Danimarca e gli altri Stati membri dellUnione continueranno ad
applicarsi le regole previste dalla Convenzione dellAia, visto che stata
ratificata dalla Danimarca. delimitazioni OGGETTIVE dal punto di
vista oggettivo, il campo di applicazione del regolamento circoscritto
alla nozione di materia civile e commerciale tuttavia i problemi
interpretativi gi sollevati in sede di applicazione della Convenzione
dellAia si sono riproposti. Per risolverli si fatto riferimento: a) art 1 del
regolamento 44/2001 b) Corte di Giustizia 3. Lassunzione ad opera del
giudice richiesto secondo la lex loci. modalit operative forma attiva
dellassunzione delle prove forma passiva forma ATTIVA lassunzione
della prova avviene ad opera del giudice richiesto forma PASSIVA
lassunzione della prova avviene ad opera del giudice richiedente che
procede direttamente allincombente istruttorio (dopo essere stato
autorizzato dallo Stato richiesto) forma ATTIVA lassunzione della
prova avviene ad opera del giudice richiesto. la regola generale
prevede che il giudice richiesto proceda allassunzione delle prove
applicando le proprie leggi nazionali (lex loci actus). NB: il principio
della prevalenza della legge dello Stato richiesto completato da due
norme: a) art 14.2 che limita i casi in cui la richiesta di assistenza pu
essere rifiutata dal giudice richiesto b) art 10.3 che consente al
giudice richiedente di specificare che lassunzione della prova debba
avvenire secondo una procedura particolare, che ovviamente sar
quella prevista dalla propria legge nazionale 4. Lassunzione secondo
una procedura particolare, secondo la lex fori. Le modalit operative
appena descritte non sempre possono garantire il maggiore grado di
efficacia. Pu accadere che le modalit previste dal diritto straniero
siano tali da impedire lutilizzabilit della prova assunta allinterno
dellordinamento giuridico che regola il processo. Lart 10.3 prevede
una seconda procedura che attenua la prevalenza della lex loci in favore
della lex fori al giudice richiedente consentito richiedere che
lassunzione della prova venga effettuata dal giudice estero secondo un
procedimento difforme rispetto a quello previsto dalla lex loci e
descritto nella richiesta di assistenza. luso di questa norma permette
che la prova sia assunta dal giudice straniero, ma applicando la legge
nazionale dello Stato membro dove si sta svolgendo il processo, per
ottenere una prova del tutto identica a quella che si sarebbe formata
allinterno dei confini nazionali. Linconveniente maggiore di questa
procedura collegato con la necessit che il giudice richiesto applichi
direttamente e senza particolari ausili una normativa processuale a lui
non familiare. NB: la procedura secondo la lex fori, pur essendo
vincolante per lautorit giudiziaria destinataria della stessa, pu essere
rifiutata per: - la presenza di notevoli difficolt tecniche - per
lincompatibilit con la lex loci. 5. Lassunzione diretta ad opera del
giudice richiedente. forma PASSIVA lassunzione della prova avviene
ad opera del giudice richiedente che procede direttamente
allincombente istruttorio (dopo essere stato autorizzato dallo Stato
richiesto). La forma passiva permette al giudice davanti al quale pende
il giudizio di recarsi personalmente nel territorio di un altro Stato
membro per assumere direttamente la prova in questo modo la prova
non solo viene assunta secondo la lex fori, ma anche dallo stesso
giudice titolare del procedimento (o un suo delegato). Anche in questa
fattispecie, lapertura delle frontiere territoriali al giudice straniero non
priva di cautele e garanzie per la tutela dello Stato che ne assicura
lassistenza: - imprescindibile lautorizzazione dellorgano centrale o
dellautorit dello Stato membro richiesto, il quale ha anche la
possibilit di subordinare lattivit istruttoria a determinate condizioni
e/o modalit e di nominare un magistrato interno per verificarne il
rispetto - lassunzione diretta soggiace alla condizione che essa possa
avvenire indipendentemente dalluso di misure coercitive. La richiesta
di assunzione diretta delle prove pu essere rifiutata nel caso in cui: -
risulti incompleta - esuli dallambito di applicazione del regolamento -
violi i principi fondamentali della legislazione dello Stato dove avviene
lesecuzione. 6. Rapporti tra autorit richiesta, giudice a quo e parti del
processo. La presenza delle parti e del giudice richiedente davanti al
giudice richiesto ha lo scopo di rendere pi efficace lattivit istruttoria
compiuta allestero. presenza alle giudice richiedente attivit istruttorie
compiute allestero parti giudice richiedente il regolamento prevede
un duplice livello di presenza alle attivit istruttorie compiute allestero:
a) mera assistenza il giudice richiedente ha il diritto di presenziare
allassunzione della prova allestero tramite un delegato. la mera
assistenza alle operazioni compiute da giudice richiesto non necessita
di alcun provvedimento autorizzativo da parte dellautorit dello Stato
membro dove verr assunta la prova. E sufficiente che nella richiesta, il
giudice richiedente informi della sua presenza o di quella di un suo
delegato. NB: linformazione condizione necessaria e sufficiente per
consentire la presenza del giudice. b) partecipazione attiva nel caso il
giudice richiedente voglia partecipare attivamente, non sufficiente la
semplice informazione, ma necessaria unapposita autorizzazione
dellautorit giudiziaria dello Stato richiesto. parti il regolamento
prevede un duplice livello di presenza alle attivit istruttorie compiute
allestero: a) mera assistenza la possibilit di assistere non richiede
autorizzazioni da parte del giudice ed ammessa se prevista dalla
legge dello Stato dellautorit richiedente ed comunicata allautorit
richiesta. b) partecipazione attiva deve essere preventivamente
autorizzata dallautorit richiesta, che indicher le condizioni alle quali
la partecipazione ammessa. 7. La comunicazione tra diverse autorit
giudiziarie. Il regolamento ha poi disciplinato la comunicazione tra i vari
soggetti che intervengono nel procedimento di assunzione delle prove
allestero. soggetti tra cui si svolge la comunicazione disciplina del
dialogo forme e strumenti impiegati nel dialogo tra le autorit giudiziarie
tra le autorit giudiziarie regime linguistico del procedimento di
assunzione della prova uso dei formulari a) soggetti tra cui si svolge la
comunicazione il regolamento introduce un meccanismo di
comunicazione tendenzialmente diretto tra due soggetti (giudice a quo e
autorit giudiziaria richiesta) senza che debbano preventivamente
essere coinvolte le autorit centrali, le quali mantengono mere funzioni
di coordinamento e di controllo (solo eccezionalmente svolgono un
ruolo diretto). b) forme e strumenti impiegati nel dialogo tra le autorit
giudiziarie il regolamento insiste spesso sulluso di nuove tecnologie
della comunicazione, sia nel momento della trasmissione della
richiesta, sia nellesecuzione dellassunzione della prova. c) regime
linguistico del procedimento di assunzione della prova la richiesta
deve essere redatta nella lingua ufficiale dello Stato membro dove deve
avvenire listruttoria. solo eccezionalmente possibile inoltrare
richieste in altre lingue, a patto che lo Stato membro richiesto abbia
dichiarato di accettarle. d) uso dei formulari il regolamento ha
introdotto un meccanismo di comunicazione tra le autorit giudiziarie
basato sullo scambio di formulari, al fine di agevolare la comunicazione
e attenuare i rischi derivanti dallesistenza di troppe lingue ufficiali. IL
REGOLAMENTO CE 1393/2007 RELATIVO ALLA NOTIFICAZIONE E
ALLA COMUNICAZIONE NEGLI STATI MEMBRI DEGLI ATTI GIUDIZIARI
ED EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE. 1.
Premessa. Il regolamento 1393/2007 si occupa della disciplina della
notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari in
materia civile e commerciale. sostituisce il regolamento 1348/2000. 2.
Le notifiche transnazionali tra convenzione dellAia e regolamento. Il
principio della sovranit nazionale un limite nel campo delle notifiche
transnazionali, in quanto impedisce agli organi preposti alla
notificazione di esercitare allestero la propria funzione. lattivit
notificazione di un organo statale in un altro Paese si configurerebbe
come un inammissibile esercizio di un potere pubblico offensivo
dellaltrui sovranit. NB: questa situazione ha portato ad una
regolamentazione della materia. Rispetto alle notifiche transnazionali,
accanto ai numerosi accordi bilaterali, lo strumento multilaterale di
maggior rilievo stata la Convenzione dellAia del 1965, la quale poi ha
ispirato i successivi regolamenti comunitari. Convenzione dellAia del
1965 non si limita a regolare la trasmissione e la consegna degli atti
da notificare, ma ne regola anche gli effetti. la trasmissione degli atti
pu avvenire: - per via consolare o diplomatica - attraverso la
trasmissione diretta dallautorit richiedente dello Stato di origine ad
unautorit centrale dello Stato di destinazione, il quale assume il
compito di ricevere tutte le richieste di notificazione e comunicazione e
di eseguirle nella forma prevista dalla legge interna o nella forma
chiesta dal richiedente, se non incompatibile con la legge interna -
attraverso linvio degli atti giudiziari tramite posta da parte dellautorit
dello Stato richiedente, salvo che lo Stato destinatario non dichiari di
opporsi a questo sistema. Rispetto al contenuto della Convenzione
dellAia, il legislatore comunitario si prefissato due obiettivi: 1)
semplificare la procedura di notificazione degli atti allestero si
elimina il passaggio per il tramite della autorit centrali e si stabiliscono
relazioni pi dirette attraverso la previsione di una pluralit di organi
mittenti e riceventi decentrati. Lautorit centrale mantiene compiti di
supervisione. 2) rendere omogenea ed equivalente la tutela della
giustizia al momento della notifica del primo atto la notifica non viene
vista come un atto pubblicistico, ma come unattivit che ha al centro lo
svolgimento di rapporti tra privati. In questo modo i limiti alla
trasmissione transfrontaliera degli atti giudiziari vengono visti come un
limite alla tutela dei diritti: leffettivit delle notifiche equivale quindi
alleffettivit della tutela giurisdizionale per i cittadini. 3. Lambito di
applicazione del regolamento. Il regolamento 1393/2007 ha un ambito di
applicazione sostanzialmente identico a quello della Convenzione
dellAia del 1965. art 1 il regolamento 1393/2007 si applica in materia
civile e commerciale qualora un atto giudiziario o stragiudiziale debba
essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o
comunicato al destinatario, a meno che il recapito risulti ignoto. Il
regolamento non si applica nel caso in cui non sia noto il recapito del
destinatario dellatto che deve essere comunicato o notificato in
questo modo non si fa ricadere sullo Stato richiesto oneri ulteriori per le
ricerche dei destinatari con recapito sconosciuto. NB: se il recapito del
destinatario noto, ma questultimo irreperibile, si applicher il
regolamento e la notificazione dovr essere fatta nelle forme dello Stato
richiesto. 4. Modalit di notificazione e di trasmissione degli atti
allestero. Il regolamento non adotta un concetto autonomo di
notificazione e non disegna un sistema di notificazioni omogeneo. La
novit del regolamento costituita dalla realizzazione della
trasmissione diretta a livello decentrato tra organi operanti in ambito
locale, con la conseguente omissione del passaggio per il tramite
dellautorit centrale. organi mittenti e organi riceventi sono
designati da ciascuno Stato. Lautorit centrale non viene eliminata, e
mantiene alcuni compiti: - fornire informazioni agli organi mittenti -
suggerire soluzioni per superare eventuali difficolt che possono
manifestarsi in occasione della trasmissione degli atti - surrogare un
organo mittente nella trasmissione dellatto allorgano ricevente, su
richiesta dellorgano mittente solo in casi eccezionali 5. La forma
principale di trasmissione degli atti. Tutto il tessuto della notifica
transnazionale percorso da notizie e comunicazioni che gli organi
pubblici coinvolti sono tenuti a scambiarsi e trasmettersi. modalit di
trasmissione degli modalit principale atti previste dal regolamento 4
modalit facoltative forma principale di trasmissione degli atti il
regolamento 1393/2007, ai fini di una rapida esecuzione, consente di
trasmettere latto con qualsiasi mezzo appropriato e prevede lesonero
dallobbligo di legalizzazione degli atti e dei documenti trasmessi. Non
prevista una possibilit di rifiuto della notificazione dellorgano
ricevente, se non in due casi: - la domanda esula in modo manifesto
dallambito di applicazione del regolamento - il mancato rispetto dei
requisiti di forma rende impossibile la notifica. Il regolamento indica le
modalit secondo cui lorgano dello Stato destinatario deve procedere
alla notificazione o alla comunicazione dellatto: - devono essere
effettuate secondo la disciplina dello Stato richiesto e potranno essere
eseguite rispettando la particolare modalit richiesta dallorgano
mittente (se compatibile con la legislazione dello Stato destinatario) -
devono essere effettuate nel pi breve tempo possibile - la data da
prendere in considerazione per il perfezionamento della notifica viene
stabilita applicando la legge dello Stato destinatario - al richiedente non
potranno essere richiesti il pagamento o il rimborso di tasse o spese
diverse da quelle che vengono sostenute in caso di notificazioni interne
allo Stato richiesto 6. La lingua dellatto. La questione della lingua nella
quale latto viene notificato al destinatario di grande importanza. Il
regolamento prevede che il richiedente informato dallorgano mittente
(al quale viene consegnato latto per la trasmissione) che il destinatario
pu rifiutare di ricevere latto (immediatamente o comunque entro una
settimana) se non compilato nella lingua dello Stato richiesto o in una
lingua compresa dal destinatario. NB: in caso di mancato rispetto dei
requisiti linguistici possibile una sanatoria dellirregolarit attraverso
una rinnovazione dellatto debitamente tradotto, il quale produrr effetti
dal momento della rinnovazione dellatto. 7. Forme facoltative di
trasmissione degli atti: la trasmissione (diretta e indiretta) per via
consolare o diplomatica, la domanda diretta di notificazione e la
notificazione a mezzo del servizio postale. trasmissione diretta per via
consolare o diplomatica forme facoltative di trasmissione indiretta per
via consolare o diplomatica trasmissione degli atti domanda diretta di
notificazione notificazione a mezzo del servizio postale trasmissione
DIRETTA per via consolare o diplomatica lautorit consolare pu
procedere direttamente alla consegna dellatto. trasmissione INDIRETTA
per via consolare o diplomatica lautorit consolare pu avvalersi
(con i loro consenso e secondo le convenzioni eventualmente in vigore)
degli organi dello Stato ricevente, anche trasmettendo latto mediante
spedizione per raccomandata con ricevuta di ritorno. domanda diretta di
notificazione consiste nella possibilit delle parti private di inoltrare
direttamente la richiesta di notificazione ai pubblici ufficiali, ai
funzionari e alle persone competenti dello Stato destinatario senza
chiedere lintervento dellorgano ricevente. notificazione a mezzo del
servizio postale ogni Stato membro ha la facolt di effettuare la
notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari direttamente per
posta alle persone residenti in un altro Stato membro, utilizzando la
raccomandata con ricevuta di ritorno. 8. La mancata comparizione del
convenuto. Per evitare che il processo si svolga con un convenuto
contumace in modo involontario, il regolamento ha previsto una
particolare disciplina allart 19. Se latto di citazione stato trasmesso
ad un altro Stato membro per la notificazione/comunicazione ed il
convenuto non comparso, il giudice deve sospendere il procedimento
fino a che lattore non dimostri che il destinatario della notifica sia stato
effettivamente raggiunto e che abbia avuto un lasso di tempo utile per
esercitare i suoi diritti di difesa. 9. Il rapporto tra il regolamento e le
convenzioni internazionali. Il rapporto tra il regolamento e le
convenzioni internazionali risolto dallart 20. art 20 vi la
prevalenza del regolamento rispetto agli accordi internazionali bilaterali
o multilaterali e rispetto alle intese di cui sono parti contraenti gli Stati
membri. inoltre il regolamento ammette la conclusione di nuovi
accordi o la sopravvivenza di accordi pregressi se compatibili con il
regolamento e se accelerano o semplificano la trasmissione degli atti.
10. Considerazioni conclusive. Il regolamento 1393/2007 segna un
passo in avanti rispetto alla Convenzione dellAia in quanto, invece di
puntare sul carattere di atto statale autoritativo della notificazione,
coltiva il suo profilo di servizio reso nei confronti delle parti, rafforzando
il rapporto diretto tra le autorit notificanti e tra queste e i cittadini. IL
REGOLAMENTO CE 861/2007 SUL PROCEDIMENTO PER LE
CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITA E LE ADR IN AMBITO
COMUNITARIO. 1. Introduzione: laccesso alla giustizia per le small
claims. Lattenzione degli organi comunitari per le controversie di
modesta entit si rivolta soprattutto alle problematiche connesse
allaccesso alla giustizia. Infatti i costi, i tempi e la complessit dei
procedimenti giurisdizionali possono facilmente indurre le parti a
rinunciare ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. La
Commissione europea intervenuta ripetutamente sul tema per
individuare soluzioni idonee ad offrire unefficace tutela ai piccoli
litiganti lazione si orientata su due aspetti: 1) la semplificazione dei
procedimenti giudiziari e delle circolazione delle relative decisioni
allinterno degli stati dellunione 2) la promozione dei procedimenti non
giurisdizionali di risoluzione delle liti di modesto valore (ADR
Alternative Dispute Resolutions) 2. La semplificazione dei procedimenti
per le controversie di modesta entit e il regolamento 861/2007: genesi
e struttura. La semplificazione dei procedimenti per la composizione
delle liti di modesta entit stato oggetto di diversi interventi
comunitari che hanno portato allemanazione del regolamento 861/2007
che ha istituito il procedimento europeo per le controversie di modesta
entit. Il regolamento 861/2007 ha una duplice valenza normativa
(espressa dallart1): a) istituisce un procedimento europeo per il
controversie di modesta entit diretto a semplificare e accelerare la
risoluzione di tali liti b) elimina i procedimenti intermedi necessari per il
riconoscimento e lesecuzione in uno Stato membro di sentenze rese in
un altro Stato membro I caratteri principali del regolamento 861/2007
sono: - la previsione di un procedimento facoltativo e alternativo
rispetto a quelli nazionali le parti sono libere di ricorrere a questo
procedimento o a quello previsti dagli Stati membri per questo tipo di
controversie - il dettare una regolamentazione uniforme che si applica a
tutti gli aspetti espressamente disciplinati, mentre per gli altri si attua
un rinvio alle norme processuali dello Stato di svolgimento del giudizio.
a dispetto del nome, il procedimento europeo un procedimento
nazionale che si svolge davanti alle autorit giudiziarie di uno degli Stati
membri, che applicano, per quanto non diversamente regolato, le norme
del foro. NB: il procedimento europeo deve essere improntato sui
principi del giusto processo e del contraddittorio. 3. Ambito di
applicazione. Il campo di applicazione del regolamento individuato
con riferimento alle controversie transfrontaliere in materia civile e
commerciale con valore massimo di 2.000 fanno eccezione le
categorie di liti indicate nel paragrafo 2 dellart 2 del regolamento. il
regolamento si riferisce solo alle controversie transfrontaliere: quelle in
cui almeno una delle parti ha il domicilio o la residenza in uno Stato
diverso da quello in cui ha sede lorgano giurisdizionale adito. NB: il
regolamento non disciplina la competenza giurisdizionale per il
procedimento europeo e quindi dovr essere determinata sulla base del
regolamento 44/2001. 4. Lo svolgimento del processo. Il capo II del
regolamento 861/2007 disciplina lo svolgimento del procedimento
europeo per le controversie di modesta entit. In funzione della
semplificazione della procedura prevista: - la trattazione in forma
scritta - la predisposizione di moduli standard di proposizione della
domanda e della replica - lattribuzione al giudice di rilevanti poteri
discrezionali nella gestione del procedimento. grazie a questi
elementi di flessibilit, il giudice pu adattare il procedimento al
carattere e alla difficolt della controversia, eliminando tutti i passaggi
non indispensabili per la decisione. In relazione alle small claims
esistono due obiettivi prioritari: - riduzione delle spese della lite
realizzata rendendo lassistenza del difensore meramente facoltativa e
riducendo i costi legati alla traduzione - riduzione delliter processuale
si prevedono tempi rapidi per la conclusione del giudizio, resi
possibili dallassenza di formalit e dal carattere scritto del
procedimento che assicura maggiore celerit. 5. La sentenza e le
impugnazioni. La sentenza pronunciata nel procedimento europeo
immediatamente esecutiva, indipendentemente dalla facolt di
impugnazione e di riesame e salva la possibilit di sospensione.
Impugnazione la possibilit dellimpugnazione della sentenza resa
nel procedimento europeo demandata alla determinazione degli
ordinamenti nazionali, che dovranno comunicare alla Commissione i
mezzi di impugnazione esperibili e i relativi termini. NB: non prevista
alcuna limitazione circa i rimedi che possono essere utilizzati contro la
sentenza. Riesame della sentenza listanza di riesame proponibile
davanti ai giudici dello Stato in cui la decisione stata pronunciata. Se
il giudice accerta la sussistenza di uno dei motivi che consentono il
riesame, la sentenza viene dichiarata nulla, purch il convenuto abbia
agito tempestivamente per far valere il vizio. NB: non autonomamente
regolata lipotesi di decisione viziata da errore manifesto, quindi anche
in caso di errore manifesto si dovr procedere con la normale
impugnazione. 6. Il riconoscimento e lesecuzione delle sentenze. Il
capo III del regolamento contiene la disciplina del riconoscimento e
dellesecuzione delle decisioni rese mediante il procedimento europeo.
Il riconoscimento e lesecutoriet delle sentenze rese tramite il
procedimento per le small claims sono del tutto automatici per garantire
la libera circolazione allinterno dello spazio giudiziario europeo. E solo
necessario il certificato di esecutoriet emesso dallautorit giudiziaria
che ha pronunciato la sentenza. la fase di esecuzione forzata in
senso stretto esula dalla portata del regolamento, che rinvia alle norme
processuali dello Stato nel quale la decisione deve essere eseguita. 7.
Valutazioni conclusive. Il regolamento sul procedimento europeo per
controversie di modesta entit realizza lobiettivo di eliminare le
procedure intermedie per il riconoscimento e lesecuzione delle
sentenze e ne favorisce la circolazione. IL REGOLAMENTO CE 1/2003 IN
MATERIA DI CONCORRENZA: ASPETTI PROCESSUALI. 1. Cenni
introduttivi sul regolamento 1/2003. Il trattato CE, agli art 81 e 82
prevede i divieti antitrust che sanzionano le intese illegittime e labuso
di posizione dominante tali norme hanno lo scopo di tutelare la
concorrenza sul mercato impedendo le condotte distorsive. il
legislatore ha previsto lattuazione di questi divieti allart 83 del trattato,
sul quale si sono poi fondati i successivi regolamenti procedurali: - il
regolamento CE 17/1962 - il regolamento CE 1/2003 nuovo
regolamento che ha sostituito quello del 1962. Le norme del nuovo
regolamento CE 1/2003 hanno in parte confermato e in parte innovato
quanto previsto dal regolamento del 1962 le due maggiori novit
introdotte sono: 1) la sostituzione del sistema autorizzatorio previgente
con il sistema ad eccezione legale in precedenza, per ottenere
lesenzione dai divieti prevista dallart 81.3 del trattato, le imprese
dovevano comunicare preventivamente alla Commissione gli accordi
che potevano ricadere nellapplicazione del decreto, mentre con il
nuovo sistema questa richiesta stata eliminata e lautorizzazione
implicita: se per, in seguito ai controlli dellautorit, emerge una
carenza dei presupposti per lesenzione, limpresa sar sanzionata per
lerrata valutazione compiuta in relazione alla liceit dellaccordo. 2)
rafforzato decentramento nellapplicazione diretta dei precetti
comunitari stata ampliata la delega alle autorit e ai giudici
nazionali per lapplicazione diretta e integrale degli art 81 e 82. Il
decentramento prevede inoltre articolati meccanismi di coordinamento
tra le varie autorit di controllo (amministrative e giurisdizionali) che
dovrebbero garantire luniforme applicazione delle norme. 2. Analisi
normativa: il riparto delle competenze. Il regolamento 1/2003
composto da 45 articoli suddivisi in capitoli. eccezione legale primo
capitolo onere della prova rapporto tra le norme antitrust nazionali e
comunitarie eccezione legale consiste nellautomatica illiceit delle
condotte vietate e nella liceit delle condotte esentate dallart 81.3,
senza che occorra una previa decisione della Commissione. onere della
prova la disciplina prevede che lonere della prova sia a carico di
soggetti diversi, a seconda di cosa viene invocato: - violazione dei
divieti lonere della prova a carico della parte o dellautorit che
invoca la violazione del divieto - esenzione lonere della prova a
carico dellimpresa che la richiede, la quale deve provare lesistenza dei
presupposti. rapporto tra le norme antitrust nazionali e comunitarie le
norme applicabili dalle autorit nazionali che indagano su accordi
potenzialmente pregiudizievoli per il commercio negli stati membri
vanno individuate in modo certo. in queste ipotesi il regolamento
prevede che oltre alla normativa nazionale, venga applicata
parallelamente anche quella comunitaria. NB: le norme nazionali non
possono essere pi permissive di quelle UE, ma possono essere pi
severe. Secondo il regolamento CE 1/2003, gli organi competenti
allapplicazione dei divieti antitrust a livello nazionale e comunitario
sono: a) la Commissione b) le autorit nazionali c) le giurisdizioni in
tutti i casi prevista la competenza ad applicare direttamente i divieti
comunitari. NB: per le autorit nazionali, la competenza allapplicazione
dei divieti comunitari, limitata ai casi individuali e alladozione di
decisioni tipizzate. Gli Stati hanno la titolarit esclusiva della
designazione delle autorit competenti allapplicazione dei divieti
comunitari antitrust tali autorit possono essere individuate sia tra le
giurisdizioni che tra le autorit amministrative. in Italia questa
autorit lautorit garante della concorrenza e del mercato (che
appartiene alle autorit amministrative indipendenti). Sia le autorit che
le giurisdizioni operano secondo regole procedurali interne alla Stato e
sono regolamentate esclusivamente da norme nazionali, ispirate al
modello comunitario con vari gradi di approssimazione. Ad integrazione
delle previsioni del regolamento CE 1/2003, sono state adottate le
comunicazioni sulla cooperazione tra le autorit e la Commissione e tra
la Commissione e le giurisdizioni nazionali, che disciplinano pi nel
dettaglio linterpretazione dei vari criteri di attribuzione e
coordinamento. Il network antitrust creato dal regolamento CE 1/2003,
caratterizzato anche dallampia circolazione di informazioni tra gli
organi di controllo. Questo per pone delicate questioni di rispetto dei
diritti delle parti, soprattutto riguardo le garanzie del contraddittorio e
della difesa, che devono essere equivalenti in ogni luogo e in ogni
momento del controllo. lart 12 del regolamento consente alle autorit
nazionali e alla Commissione di scambiarsi qualsiasi informazione da
utilizzare come mezzo di prova nei procedimenti di applicazione degli
art 81 e 82 del trattato, ma solo in relazione alloggetto dellindagine per
la quale sono state raccolte le informazioni. 3. I rapporti con i processi
giurisdizionali. La cooperazione tra la commissione e le giurisdizioni
nazionali disciplinata dallart 15 del regolamento e da unapposita
comunicazione, con un ampio rinvio al diritto processuale nazionale. La
comunicazione prevede che il giudice non possa adottare una decisione
contrastante con quella della commissione sullo stesso caso a
questo fine previsto uno scambio di informazioni tra i due organi e la
possibilit di sospensione del processo nazionale in attesa della
decisione della Commissione. Allinterno del processo giurisdizionale le
autorit nazionali e la Commissione possono presentare dufficio
osservazioni scritte al giudice nazionale in relazione allapplicazione dei
divieti comunitari antitrust, ai fini dellapplicazione uniforme degli art 81
e 82 del trattato. 4. I poteri di indagine e gli aspetti probatori. Il quinto
capitolo del regolamento CE 1/2003 dedicato ai poteri di indagine della
Commissione, da applicare nei singoli procedimenti. Essi si
distinguono in: ricognitivi in senso ampio (indagini di settore e relazioni
sul mercato) e inquisitori. I poteri di indagine della Commissione
comprendono: a) la possibilit di richiedere alle imprese le informazioni
che le sono necessarie per garantire lapplicazione dei divieti
comunitari antitrust b) la possibilit di disporre accertamenti o ispezioni
presso limpresa c) la possibilit di disporre accertamenti o ispezioni
presso locali non aziendali (compresi i domicili di amministratori e
personale dellimpresa) se si sospetta che in quei luoghi vi siano
documenti utili allaccertamento. NB: i diritti delle imprese nel
procedimento davanti alla Commissione sono disciplinati sia dal
regolamento CE 1/2003, sia da provvedimenti comunitari specifici. 5.
Decisioni e sanzioni. Le principali decisioni che la Commissione pu
adottare nella sua attivit di applicazione dei divieti antitrust sono: a) la
contestazione dellinfrazione, con ordine di eliminarla adottando tutti i
rimedi adeguati b) ladozione dufficio di misure cautelari temporanee e
rinnovabili, in casi di urgenza c) laccettazione di impegni presentati
dalle imprese a fronte delle preoccupazioni espresse dalla
Commissione intenzionata a contestare una violazione ex art 7
laccettazione dellimpegno lo rende obbligatorio, pone fine al
procedimento ed evita ladozione di una decisione che accerti la
violazione d) la dichiarazione di inapplicabilit dellart 81 ad un accordo.
Le sanzioni vengono irrogate dalla Commissione con decisione
impugnabile, e possono essere: - ammenda entrambe calcolate in
percentuale - penalit di mora al fatturato dellimpresa la sanzione
quantificata discrezionalmente dalla Commissione allesito del
procedimento, tenendo conto della gravit e della durata dellinfrazione.
Il regime delle prescrizioni disciplinato dallart 25. La prescrizione
decorre dal giorno in cui commessa la violazione oppure da quando
cessata, se si trattava di uninfrazione continuata. I termini di
prescrizione sono: 3 anni per violazione della richiesta di
informazione o accertamenti 5 anni per tutte le altre violazioni.
REG CE N 4 DEL 2009
Dallo scorso 18 giugno entrato in vigore il reg. CE 4/2009
approvato il 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge
applicabile, al riconoscimento e allesecuzione delle decisioni e alla
cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Tale
regolamento istituisce una serie
dimisure volte a facilitare il recupero dei crediti alimentari transfron
talieri derivanti dallerelazioni di famiglia, parentela, matrimonio o af
finit (si pensi, ad esempio, allipotesi in cui una coppia divorzia ed
il genitore trasferito allestero si rifiuti di prestare il sostegno
finanziario dovuto).
Il reg. CE 4/2009 sostituisce le disposizioni in materia di
obbligazioni alimentari del reg. CE 44/2001 concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e lesecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale. Inoltre, sostituisce il reg.
CE 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti
non contestati, tranne per i titoli esecutivi europei riguardanti
obbligazioni alimentari emessi in uno Stato membro non vincolato
dal protocollo aggiuntivo della Convenzione dellAja del 23
novembre 2007 sullesazione internazionale di prestazioni
alimentari nei confronti dei figli e degli altri membri della famiglia.
Per determinare la legge applicabile alle obbligazioni alimentari
nella famiglia bisogna fare riferimento allart. 15 del reg. CE 4/2009,
mentre per individuare lautorit competente a pronunciarsi si deve
tener conto delle disposizioni contenute negli artt. 3 e ss.
In merito al riconoscimento e
allesecuzione dei provvedimenti stranieri, il nuovo regolamento
prevede che, nella maggior parte dei casi, le decisioni emesse in
uno Stato membro saranno esecutive in un altro Stato membro
senza che siano necessari procedimenti intermedi; in tal modo le
procedure saranno pi rapide e le famiglie risparmieranno denaro.
Nellaccertamento e nel recupero delle obbligazioni alimentari le
parti sono assistite da una Autorit centrale nominata da ciascuno
degli Stati membri.
Il Ministero della Giustizia ha comunicato che il Dipartimento per la
giustizia minorile lAutorit centrale per lItalia incaricata di
adempiere agli obblighi previsti dal regolamento n. 4/2009.
Al Dipartimento indicato come Autorit centrale dovranno essere
inviate le istanze provenienti dai Paesi dellUnione europea
(esclusa la Danimarca), mentre per le obbligazioni alimentari
derivanti da pronunce di Paesi extra Unione europea, che
aderiscono alla Convenzione di New York del 20 giugno 1956, la
competenza competenza affidata al Ministero dellInterno ed, in
particolare, al Dipartimento per le libert civili e limmigrazione.
Le Autorit centrali devono fornire assistenza alle parti,
relativamente alle domande oggetto del regolamento. Inoltre,
devono cooperare fra di loro, promuovere la cooperazione tra le
altre Autorit competenti per realizzare gli obiettivi del
regolamento, e ricercare la soluzione ai problemi derivanti
dallapplicazione.
Per agevolare lapplicazione del regolamento e rafforzare la
cooperazione, le Autorit centrali devono servirsi della rete
giudiziaria in materia civile e commerciale
l sequestro conservativo su conti bancari secondo il
regolamento UE n. 655/2014
Il regolamento UE n. 655/2014 ha istituito lordinanza europea di
sequestro conservativo su conti bancari (OESC), che pu essere
riconosciuta ed eseguita negli Stati membri senza procedure
di exequatur. Con questa misura cautelare si vuole facilitare il
recupero dei crediti nello spazio giuridico europeo. Il legislatore si
posto lobiettivo di bilanciare le istanze di tutela del credito con
quelle di garanzia del diritto di difesa del debitore. La data di
entrata in vigore il 18 gennaio del 2017.
1. Premessa
Il 27 giugno 2014 stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dellUnione Europea il regolamento n. 655/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
che istituisce la procedura per lordinanza europea di
sequestro conservativo su conti bancari (dora in avanti
OESC).
Il recupero di beni e somme di denaro che si trovano
allestero rappresenta nella prassi operativa uno dei
problemi pi annosi.
Nella legislazione comunitaria (artt. 31 reg. Bruxelles I e 35
reg. Bruxelles I-bis) il creditore dispone della facolt di
ottenere dei provvedimenti cautelari nello Stato di
esecuzione per prevenire eventuali attivit fraudolente del
debitore. Tali strumenti, tuttavia, non sempre sono
pienamente efficaci e richiedono complesse e costose
operazioni di ricerca.
Il regolamento in esame il risultato di un iter complesso,
intrapreso dalla Commissione europea con il Libro Verde
del 24 ottobre 2006. Lobiettivo dei lavori stato quello di
ovviare alla frammentazione delle regole e strumenti
vigenti per il recupero del credito nello spazio giuridico
europeo. Il regolamento n. 655/2014, strumento
comunitario di cooperazione giudiziaria in materia civile, si
colloca nel quadro dello spazio di libert, sicurezza e
giustizia e la sua base giuridica risiede nellart. 81, par. 2,
TFUE.
Si tratta del primo regolamento europeo interamente
ispirato allarmonizzazione di una procedura in materia di
esecuzione di misure cautelari. Ci denota una significativa
evoluzione della materia del diritto processuale civile
internazionale che, a partire dal regolamento CE n.
805/2004, ha superato la necessit di ricorrere alla
procedura di exequatur per dare esecuzione in uno Stato
membro ai provvedimenti emanati in un altro Stato
comunitario.
Il regolamento UE n. 655/2014 si applicher a decorrere dal
18 gennaio 2017 a tutti gli Stati membri, eccettuati la
Danimarca ed il Regno Unito.
2. Oggetto e ambito dapplicazione del regolamento UE n.
655/2014
La procedura consente ad un creditore di ottenere
unOESC, che impedisca al debitore di compromettere la
successiva esecuzione del credito mediante il
trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dellimporto
specificato nellordinanza, di somme che sono detenute dal
debitore, o in suo nome, in un conto bancario presso uno
Stato membro (art. 1).
LOESC autonoma, concorrente ed alternativa rispetto ai
rimedi cautelari di diritto interno.
Il regolamento si applica ai crediti pecuniari in materia
civile e commerciale con carattere transnazionale ai sensi
dellart. 3.
Il regolamento non si applica, ex art. 2, alla materia fiscale,
doganale o amministrativa e agli acta iure imperii. Non
rientrano nel suo campo di applicazione neppure i diritti
patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale tra coniugi
o da rapporti con effetti assimilabili al matrimonio, i
testamenti e le successioni, i crediti nei confronti di un
debitore assoggettato ad una procedura concorsuale, la
sicurezza sociale e larbitrato.
Un caso transnazionale se il conto bancario, su cui si
intende effettuare il sequestro mediante lOESC, tenuto in
uno Stato membro che non sia quello dellautorit
giudiziaria presso cui stata presentata la domanda di
OESC o quello in cui il creditore domiciliato (art. 3).
3. La procedura per ottenere unordinanza di sequestro
conservativo
Gli artt. 5 e 6 disciplinano le condizioni per avvalersi
dellOESC e la relativa competenza giurisdizionale.
Il creditore pu domandare lOESC sia prima dellavvio di
un procedimento di merito contro il debitore in uno Stato
membro, sia nel corso del processo di merito, fino a
quando stata emessa la decisione giudiziaria o stata
approvata o conclusa una transazione giudiziaria. La
competenza spetta al giudice che dovrebbe pronunciarsi
sul merito (art. 6, par. 1).
Dopo che il creditore ha ottenuto, in uno Stato membro, un
titolo esecutivo, competente sar invece il giudice che ha
emesso il titolo (art. 6, par. 3).
Lemissione dellOESC presuppone che il creditore abbia
fornito prove sufficienti in ordine al fumus boni iuris e
alpericulum in mora (art. 7).
La domanda di ordinanza deve essere depositata
utilizzando il modulo elaborato ex art. 52, par. 2, e deve
contenere le informazioni di cui allart. 8.
Lautorit giudiziaria decide con una procedura scritta sulla
base delle informazioni e prove fornite dal creditore nella
domanda, se le ritiene insufficienti pu chiedere al
creditore di fornire ulteriori prove documentali (art. 9).
LOESC viene emessa inaudita altera parte (art. 11) entro 10
giorni, ovvero 5 giorni dal deposito della domanda, se il
diritto del creditore risulta da sentenza, transazione o atto
pubblico (art. 18). Ai sensi dellart. 22, lOESC
riconosciuta ed esecutiva negli altri Stati membri senza
alcuna procedura di esecutivit (c.d. exequatur).
Lordinanza devessere trasmessa tempestivamente alla
banca dove tenuto il conto corrente del debitore affinch
questultima provveda al blocco dellimporto indicato (art.
23).
La notifica o comunicazione dellOESC al debitore, ex art.
28, avviene solo dopo la sua esecuzione. La ratio della
disciplina quella di garantire leffetto sorpresa della
misura cautelare europea cos da prevenire eventuali atti
fraudolenti del debitore.
A tutela del debitore tuttavia previsto che nel caso in cui
il creditore non sia munito di titolo esecutivo, esso debba
costituire una garanzia di importo sufficiente per impedire
abusi della procedura ed assicurare il risarcimento di
eventuali danni patiti dal debitore in conseguenza
dellordinanza (art. 12).
inoltre disciplinata allart. 13 una responsabilit per colpa
in capo al creditore.
Nel capo IV del regolamento sono poi disciplinati i mezzi di
ricorso avverso lOESC a tutela del debitore, con i quali
esso pu esercitare il suo diritto di difesa, chiedendone la
revoca o modifica della stessa o la limitazione o
cessazione dellesecuzione. Se la legislazione nazionale lo
consente il debitore pu inoltre fornire garanzie in
sostituzione del sequestro sino alla concorrenza
dellimporto dellordinanza.
4. La ricerca allestero dei beni del debitore.
Nel regolamento in esame assume grande importanza il
tema della trasparenza dei patrimoni.
Allart. 14 disciplinata la richiesta di informazioni sui
conti bancari. Il creditore presenta la richiesta nella
domanda di OESC, giustificando i motivi per cui ritiene che
il debitore detenga uno o pi conti presso una banca in un
determinato Stato membro.
Il meccanismo di cui allart. 14 pu essere avviato dal
creditore indipendentemente dal fatto che disponga o
meno del titolo esecutivo.
Nel primo caso la richiesta verr trasmessa dallautorit
giudiziaria, presso cui depositata la domanda di OESC,
allautorit di informazione dello Stato membro di
esecuzione, affinch questultima ottenga le informazioni
necessarie per individuare i conti correnti del debitore.
Se invece il creditore non dispone ancora del titolo
esecutivo, la richiesta di informazioni pu essere da lui
effettuata purch limporto del credito sia rilevante e a
condizione che esso fornisca la prova dellurgente
necessit di acquisire le informazioni sui conti bancari del
debitore, altrimenti lesecuzione del credito potrebbe
essere compromessa.
I dati personali, che vengono comunicati dalle autorit
competenti, possono essere utilizzati e trattati soltanto per un
periodo limitato e per i fini sottesi allemissione dellOESC,
ci previsto a garanzia del diritto alla riservatezza e della
dignit del debitore (art. 47).
5. Considerazioni finali.
Il legislatore comunitario ha cercato di bilanciare istanze
differenti, da un lato il diritto del creditore alleffettivit
dellesecuzione, dallaltro il diritto del debitore alla tutela
dei dati personali e del contraddittorio.
Soltanto lesperienza applicativa potr dire se lOESC
consentir un recupero del credito celere ed effettivo, tale
da giustificare la compressione della privacy e dei diritti di
difesa del debitore, che caratterizzano questo nuovo
istituto.
REG UE N 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al
riconoscimento e allesecuzione delle decisioni e allaccettazione e
allesecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione
di un certificato successorio europeo
Il Regolamento (UE) N. 650/2012, rispetto al quale la Danimarca ha
esercitato la facolt di opt-out e Regno Unito e Irlanda non hanno
esercitato la facolt di opt-in, persegue uno degli obiettivi tipici del
diritto dellUnione Europea, cio quello di contribuire al corretto
funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera
circolazione delle persone. In particolare, il Regolamento si occupa di
coloro i quali incontrano difficolt nellesercizio dei loro diritti
nellambito di una successione con implicazioni transfrontaliere, in
modo tale che, da un lato, ai cittadini sia assicurata la possibilit di
organizzare in anticipo la propria successione, e, dallaltro siano
garantiti i diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto e
dei creditori delleredit.
A tal fine, il Regolamento racchiude, in maniera organica, disposizioni
relative alla legge applicabile alla successione ed alla competenza in
materia successoria, oltre a norme in tema di riconoscimento,
esecutivit ed esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni
giudiziarie in materia successoria. Infine, il Regolamento istituisce il
certificato successorio europeo, utilizzabile da eredi, legatari, esecutori
testamentari o amministratori delleredit che, in un altro Stato
membro, abbiano necessit di far valere la loro qualit o di esercitare
diritti e poteri quali beneficiari o manager della massa ereditaria.
Le norme del Regolamento si applicano alle successioni occorse
successivamente al 17 agosto 2015, con eccezione degli articoli 77 e 78,
in materia di informazioni messe a disposizione dei cittadini e di
obblighi di comunicazione degli Stati alla Commissione, che trovano
applicazione dal 16 gennaio 2014, e degli articoli 79, 80 e 81, applicabili
dal 5 luglio 2012 e rispettivamente relativi allelenco delle altre
autorit e dei professionisti legali inclusi nella definizione di organo
giurisdizionale (prevista dallarticolo 3, paragrafo 2), allelaborazione e
modifica successiva degli attestati e dei moduli contemplati da varie
norme del Regolamento stesso ed alla istituzione di un Comitato che
assista la Commissione ai sensi del Regolamento (UE) 182/2011.
Ambito di applicazione
Le norme comunitarie interessano le successioni caratterizzate da
elementi di internazionalit, i quali possono rilevare da un punto di vista
soggettivo, come, ad esempio, laddove il defunto sia cittadino di uno
Stato diverso da quello in cui localizzata la sua ultima residenza, o da
un punto di vista oggettivo, laddove nel patrimonio del de cuius vi siano
beni localizzati in pi stati membri.
Larticolo 1 del Regolamento, unitamente ai Considerando, dispone il
suo raggio di operativit, il quale destinato ad abbracciare tutti gli
aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, cio qualsiasi
modalit di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni, a prescindere dal
fatto che questi siano stati pianificati dal testatoreovvero avvengano per
effetto di successione legittima.
Tuttavia, il Regolamento esclude diverse questioni civilistiche che
potrebbero prima facie essere ritenute attinenti alla materia
successoria.
Sotto questo profilo, innanzitutto, ricadono al di fuori delle norme di
conflitto comunitarie la validit formale delle disposizioni a causa di
morte oralmente effettuate, nonch il diritto di famiglia patrimoniale e
non. In particolare sono esclusi: (i) i rapporti di famiglia e i rapporti che
secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili ai
primi, nonch le questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi,
inclusi le convenzioni matrimoniali e i regimi patrimoniali relativi a
rapporti che abbiano effetti comparabili a quelli prodotti dal matrimonio;
(ii) lo status delle persone fisiche e la loro capacit (fatto salvo quanto
stabilito allarticolo 23, paragrafo 2, lettera c), e allarticolo 26); (iii) le
questioni riguardanti la scomparsa, lassenza o la morte presunta; e (iv)
le obbligazioni alimentari diverse da quelle a causa di morte.
In secondo luogo il Regolamento non dispone regole di conflitto
applicabili in materia di societ, associazioni, persone giuridiche e trust.
Sotto il primo profilo, sono escluse le questioni disciplinate dalla legge
applicabile a societ, associazioni e persone giuridiche, relative ad
aspetti successori, come le clausole degli atti costitutivi e degli statuti
che stabiliscono la destinazione delle quote di partecipazione alla morte
dei loro membri, cos come non ricadono nellambito di applicazione del
Regolamento lo scioglimento, lestinzione e la fusione di societ,
associazioni e persone giuridiche.
In materia di trust, sono escluse le questioni inerenti alla loro
istituzione, al loro funzionamento e allo scioglimento del rapporto, che
saranno evidentemente regolate, perlomeno nel nostro ordinamento e
negli Stati che la hanno ratificata, dalla Convenzione dellAja. Sul punto,
tuttavia, si specifica che in caso di istituzione di trust testamentari o
involontari per effetto di legge e connessi con una successione
legittima, dovrebbe applicarsi la legge indicata dal Regolamento in
relazione alla devoluzione dei beni e alla determinazione dei beneficiari.
Circa questultimo profilo, si pensi ad esempio al caso in cui la classe
dei beneficiari sia enucleata facendo riferimento agli eredi legittimi
ovvero ai legittimari del disponente-testatore.
Inoltre, non ricadono nellambito di applicazione del Regolamento i
diritti di propriet, gli interessi e i beni creati o trasferiti con strumenti
diversi dalla successione, quali le donazioni, la compropriet con
reversibilit a favore del comproprietario superstite, i piani pensione, i
contratti di assicurazione e gli accordi analoghi, con espressa
eccezione di quanto previsto dallarticolo 23, paragrafo 2, lettera i) del
Regolamento stesso. Chiaramente, per, sar la legge designata dalle
regole di conflitto comunitarie a determinare se detti atti
dispositivi inter vivos che comportano lacquisizione precedente alla
morte di un diritto reale debbano essere oggetto di collazione e
riduzione ai fini del calcolo delle quote dei beneficiari.
Del pari, il Regolamento non si occupa della natura dei diritti reali. In tal
senso, le norme comunitarie si curano di non incidere sul numero
chiuso dei diritti reali conosciuti nel diritto nazionale di alcuni Stati
membri. Conseguentemente, uno Stato membro non tenuto a
riconoscere un diritto reale su un bene ivi situato laddove lo stesso
diritto reale non sia contemplato nel catalogo previsto dal suo diritto
civile.
Tuttavia, al fine di consentire ai beneficiari di godere in un altro Stato
membro dei diritti che sono stati creati o trasferiti loro per successione
ai sensi della legge indicata dal Regolamento, questultimo prevede un
meccanismo di adattamento, tale per cui sui beni coinvolti sar
riconosciuto il diritto reale equivalente pi vicino e previsto dal diritto
patrimoniale dello Stato membro che non conosce il modello straniero
da adattare. A tal fine, occorrer tener conto degli obiettivi, degli
interessi perseguiti e degli effetti prodotti dal modello straniero oggetto
di adattamento.
E altres esclusa dalloperativit del Regolamento qualsiasi iscrizione
in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti
legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti delliscrizione o della mancata
iscrizione di tali diritti in un registro, per i quali occorrer far
riferimento alla legge dello Stato in cui il registro tenuto.
Infine, il Regolamento non si applica alle questioni tributarie e doganali
nonch a quelle amministrative di diritto pubblico, in relazione alle quali
si applicher la relativa legislazione nazionale.
Il diritto tributario italiano, pertanto, continuer ad essere applicabile
alleredit, laddove il defunto sia anagraficamente residente in Italia, e
ai beni siti in nel nostro ordinamento, laddove il defunto sia
anagraficamente residente allestero.
Legge applicabile alla successione
La novit pi rilevante per il diritto internazionale privato
rappresentata dal criterio di collegamento previsto di default per la
successione, secondo il quale questa sar regolata non dalla legge
nazionale delde cuius, come disposto dallarticolo 46 della Legge 218
del 1995, bens dalla legge dello Stato in cui il defunto ha la propria
residenza abituale al momento del decesso.
Mentre dunque antecedentemente allapplicabilit del Regolamento, la
successione di una persona fisica con passaporto spagnolo, residente
da tempo in Italia ed ivi deceduta, era disciplinata, in assenza di scelta,
dal diritto spagnolo, oggi disciplinata dal diritto italiano.
Il Regolamento, tuttavia, non prevede una definizione di residenza
abituale ma fornisce allinterprete alcuni parametri in base ai quali
determinarla.
In particolare, si richiede di effettuare una valutazione globale delle
circostanze della vita del defunto negli anni precedenti il suo decesso e
al momento dello stesso, tenendo in considerazione tutti gli elementi
fattuali, tra i quali il Regolamento assegna particolare rilevanza alla
durata, alla regolarit, alle condizioni e alle ragioni del soggiorno in un
determinato Stato membro.
Cos, ad esempio, laddove la permanenza in uno Stato sia duratura e
dovuta a motivi professionali, ma il defunto abbia mantenuto un
collegamento stabile e stretto con il proprio Stato di origine, nel quale
riposto il centro di interessi della sua vita famigliare e sociale, la
successione sar regolata dalla legge di questultimo ordinamento. Del
pari, se il de cuius vissuto in pi Stati essendo cittadino di uno di essi
ovvero mantenendo tutti i propri beni principali nellambito di un unico
ordinamento, tali circostanze dovrebbero essere valutate ai fini della
determinazione del diritto applicabile alla successione, il quale,
pertanto, potrebbe coincidere con la legge nazionale del defunto ovvero
con la legge dello Stato in cui detti principali beni sono localizzati.
In situazioni particolari, poi, in cui dovesse risultare che il de
cuius aveva collegamenti manifestamente pi stretti con uno Stato
diverso da quello della residenza abituale, la legge applicabile alla
successione sar la legge di tale altro Stato. Questo criterio, tuttavia,
non pu essere utilizzato, secondo il Regolamento, alla stregua di un
criterio sussidiario ogniqualvolta non sia di immediata determinazione
la residenza abituale del de cuius, ma in casi eccezionali. Si pensi ad
esempio al caso in cui il de cuius si sia trasferito presso la residenza
abituale ai sensi del Regolamento in un tempo prossimo al decesso,
mantenendo cos pi stretti legami di collegamento con uno Stato
diverso.
La scelta del Legislatore comunitario, fondata sulla continua e
crescente mobilit dei cittadini e finalizzata a garantire un criterio di
collegamento oggettivo tra la successione e lo Stato membro in cui la
competenza esercitata, potrebbe essere oggetto di critica in ragione
della sostituzione di una legge certa, cio quella nazionale del de cuius,
con una legge incerta, che pu risultare di difficile determinazione, cio
quella dello Stato in cui il defunto aveva residenza abituale.
Tuttavia, a fronte dei costi che potrebbero essere imposti allinterprete
per la determinazione della legge applicabile alla successione, il nuovo
criterio di collegamento comporta sicuramente dei benefici in caso di
successione improvvisa e non pianificata, che fanno pendere la bilancia
dellanalisi economica in suo favore e vanno oltre alleffetto positivo
indicato dallo stesso Regolamento in materia di competenza.
Infatti, in fin dei conti, dalle indicazioni fornite dal Legislatore
comunitario, parrebbe potersi evincere che la residenza abituale
coincider, presumibilmente, con il luogo in cui risiedono, stabilmente e
da tempo, anche i beneficiari delleredit. Essi, pertanto, avranno
maggiore facilit di accesso alle informazioni relative ai propri diritti e a
costi nettamente pi contenuti di quelli che dovrebbero sopportare se il
criterio di default indicasse la legge nazionale del defunto e questo
risiedesse stabilmente, con i propri eredi, in uno Stato differente.
In questa prospettiva, regole di conflitto in materia successoria che
possano produrre simili effetti, cio di contenere i costi dei beneficiari,
sono senza dubbio efficienti. Per contro, regole di conflitto che non
prendano in considerazione queste circostanze, curandosi invece dei
costi dellinterprete, sono portatrici di inefficienze o, comunque di
benefici inferiori a quelli generati dalle prime.
Lunica nota negativa dunque rappresentata dallesclusione di sistemi
di common law (Irlanda e quelli inclusi nel Regno Unito con eccezione
della Scozia) dal Regolamento, con la conseguente occasione mancata
di uniformare, tra ordinamenti europei a diversa matrice, le regole di
conflitto in tema di successioni.
Infine va ancora rilevata la permanenza, come ai sensi dellarticolo 46
della Legge 218 del 1995, della facolt di scegliere la legge applicabile
alla propria successione.
Mentre tuttavia nel sistema di diritto internazionale privato contemplato
dalla suddetta legge la professio iuris poteva essere esercitata al fine di
designare la legge dello Stato di residenza, le norme comunitarie
consentono di scegliere, quale legge applicabile, la legge nazionale del
de cuius, al momento della scelta o del suo decesso. Pertanto, il
cittadino spagnolo, che abbia residenza abituale ai sensi del
Regolamento in Italia, potr eleggere il diritto spagnolo quale disciplina
applicabile alla sua successione.
Laddove poi il de cuius sia cittadino di pi Stati, al momento della scelta
o della morte, egli potr scegliere il diritto di uno di essi.
La scelta della legge applicabile alla successione va effettuata in modo
espresso, in una dichiarazione resa nella forma di una disposizione a
causa di morte o deve risultare dalle clausole di tale disposizione,
come ad esempio il testamento ovvero un patto successorio, ove lecito
secondo la legge applicabile. La validit dellatto che contiene la scelta
disciplinata dalla legge eletta e le eventuali revoche e modificazioni
alla scelta stessa devono essere conformi ai requisiti di forma previsti
per la modifica o la revoca di una disposizione a causa di morte
secondo il diritto indicato dal de cuius.
Potrebbero piacerti anche
- Riassunto Diritto Unione Europea Adam Tizzano PDFDocumento58 pagineRiassunto Diritto Unione Europea Adam Tizzano PDFRoccotanosiff100% (3)
- 17 Il Congresso Di Vienna e La RestaurazioneDocumento4 pagine17 Il Congresso Di Vienna e La RestaurazioneAssunta PiccirilloNessuna valutazione finora
- Diritto Dell' Unione EuropeaDocumento34 pagineDiritto Dell' Unione EuropeaWafaaDounaim100% (2)
- Diritto - Privato - Comparato - G.Alpa - Bonell - SAGGI - PARTE - SPECIALE - COMPLETO - PDF Filename UTF-8''Diritto Privato Comparato - G.Alpa - Bonell - SAGGI PARTE SPECIALE COMPLETO-1Documento99 pagineDiritto - Privato - Comparato - G.Alpa - Bonell - SAGGI - PARTE - SPECIALE - COMPLETO - PDF Filename UTF-8''Diritto Privato Comparato - G.Alpa - Bonell - SAGGI PARTE SPECIALE COMPLETO-1merisaNessuna valutazione finora
- Diritto Internazionale PrivatoDocumento11 pagineDiritto Internazionale Privatolupin845Nessuna valutazione finora
- Riassunti Lezioni Di Diritto Processuale Civile Su Il Processo Civile Manuale PicardiDocumento240 pagineRiassunti Lezioni Di Diritto Processuale Civile Su Il Processo Civile Manuale PicardiCarmela Chiariello100% (1)
- Legitimo Affidamento UEDocumento26 pagineLegitimo Affidamento UEsuzanamfmendoncaNessuna valutazione finora
- Diritto Internazionale Privato - Parte PrivataDocumento73 pagineDiritto Internazionale Privato - Parte Privatagaetano.boccia90Nessuna valutazione finora
- I Rapporti Tra L'ordinamento Dell'Unione Europea e L'ordinamento InternoDocumento18 pagineI Rapporti Tra L'ordinamento Dell'Unione Europea e L'ordinamento InternopuzzopuzziNessuna valutazione finora
- Finale UeDocumento67 pagineFinale UeIsmaile SikalNessuna valutazione finora
- 1462 823 1 PBDocumento17 pagine1462 823 1 PBMarco MelliniNessuna valutazione finora
- Diritto Internazionale Privato 6Documento42 pagineDiritto Internazionale Privato 6bluNessuna valutazione finora
- Appunti Sul Consenso Conttrattuale, Volume 47 Di TRATTATO DIR. COMM. GALGANODocumento13 pagineAppunti Sul Consenso Conttrattuale, Volume 47 Di TRATTATO DIR. COMM. GALGANOSara BrancatiNessuna valutazione finora
- 1813 1329 1 PBDocumento135 pagine1813 1329 1 PBterter45Nessuna valutazione finora
- 2020-02-17 Slides Venezia DUE BBDocumento19 pagine2020-02-17 Slides Venezia DUE BBValeNessuna valutazione finora
- Castronovo-El Contrato y La Idea de La CodificaciónDocumento16 pagineCastronovo-El Contrato y La Idea de La CodificaciónJoel Ccencho CondoriNessuna valutazione finora
- 22.adattamento Del Diritto Italiano Al Diritto Internazionale PattizioDocumento3 pagine22.adattamento Del Diritto Italiano Al Diritto Internazionale PattizioProzack ThanatosNessuna valutazione finora
- Adam Tizzano-Lineamenti Di Diritto Dell Unione Europea PDFDocumento49 pagineAdam Tizzano-Lineamenti Di Diritto Dell Unione Europea PDFGiada SollaiNessuna valutazione finora
- Definitivo - Unione EuropeaDocumento133 pagineDefinitivo - Unione EuropeabrunoNessuna valutazione finora
- Diritto Del LavoroDocumento123 pagineDiritto Del LavoroRoberto RotoloNessuna valutazione finora
- Diritto UE Cap. 4Documento10 pagineDiritto UE Cap. 4yszrdss9btNessuna valutazione finora
- RI Cartabia Santiago2014Documento21 pagineRI Cartabia Santiago2014mchiara049Nessuna valutazione finora
- Istituzioni Di Diritto Pubblico Riassunto Diritto Costituzionale ARCIDIACONO CARULLO RIZZADocumento63 pagineIstituzioni Di Diritto Pubblico Riassunto Diritto Costituzionale ARCIDIACONO CARULLO RIZZAGenovese Carla0% (1)
- Diritto Contrattuale EuropeoDocumento7 pagineDiritto Contrattuale EuropeoDimaNessuna valutazione finora
- Il Principio Di Certezza Del DirittoDocumento221 pagineIl Principio Di Certezza Del DirittoNuno Miguel Cunha RoloNessuna valutazione finora
- Astrid Mastroianni Adozione Attilegislativi RassegnaDocumento5 pagineAstrid Mastroianni Adozione Attilegislativi RassegnalabeoneNessuna valutazione finora
- Le Fonti Del Diritto Europeo 4Documento9 pagineLe Fonti Del Diritto Europeo 4giupssNessuna valutazione finora
- Tributario EuropeoDocumento10 pagineTributario EuropeoluNessuna valutazione finora
- Diritto UE e Principio Di LegalitàDocumento3 pagineDiritto UE e Principio Di LegalitàUmbraMarcoNessuna valutazione finora
- Evoluzione Del Rapporto Tra Ordinamento Italiano e Dell UEDocumento43 pagineEvoluzione Del Rapporto Tra Ordinamento Italiano e Dell UEAnna GarbiniNessuna valutazione finora
- dodicesima lezione diritto dell'UEDocumento4 paginedodicesima lezione diritto dell'UEmoncini.francescoNessuna valutazione finora
- FontiDocumento4 pagineFontiCarlotta CeciNessuna valutazione finora
- Lezione 3 Del Corso Di Costituzionale 2Documento12 pagineLezione 3 Del Corso Di Costituzionale 2AlessandroNessuna valutazione finora
- Riassunto Diritto CostituzionaleDocumento75 pagineRiassunto Diritto CostituzionalebrunoNessuna valutazione finora
- Capitolo 9Documento7 pagineCapitolo 9pollohjNessuna valutazione finora
- Diritto Europeo Dei ContrattiDocumento42 pagineDiritto Europeo Dei ContrattiFranco LottolaNessuna valutazione finora
- Riassunto Dispensa Parte II - Tutela Internazionale Dei Migranti A.A. 2021-2022Documento78 pagineRiassunto Dispensa Parte II - Tutela Internazionale Dei Migranti A.A. 2021-2022sofy.nataNessuna valutazione finora
- I+Lezione +Le+FontiDocumento20 pagineI+Lezione +Le+FontiDaniele GalloNessuna valutazione finora
- R Caponi Giudicati Civili Nazionali e SeDocumento22 pagineR Caponi Giudicati Civili Nazionali e SeBruno Silveira de OliveiraNessuna valutazione finora
- Le Fonti Del DirittoDocumento12 pagineLe Fonti Del DirittoMichela MennilloNessuna valutazione finora
- 13.10 .2021Documento4 pagine13.10 .2021Ferdinando SdaoNessuna valutazione finora
- Manuale Diritto AmministrativoDocumento63 pagineManuale Diritto AmministrativoMarica AviNessuna valutazione finora
- Dip in Senso Stretto: FontiDocumento20 pagineDip in Senso Stretto: FontibluNessuna valutazione finora
- Sistemi Giuridici ComparatiDocumento56 pagineSistemi Giuridici ComparatiOsvaldo FalangaNessuna valutazione finora
- Docsity Diritto Internazionale Privato e Pubblico 3Documento63 pagineDocsity Diritto Internazionale Privato e Pubblico 3Matt TorriNessuna valutazione finora
- Diritto Costituzionale Bin PitruzzellaDocumento45 pagineDiritto Costituzionale Bin PitruzzellaannamandaNessuna valutazione finora
- Diritti FondamentaliDocumento10 pagineDiritti FondamentaligiupssNessuna valutazione finora
- Procedura CivileDocumento518 pagineProcedura CivileRiccardo SorrentinoNessuna valutazione finora
- Diritto Dellunione Europea 1Documento50 pagineDiritto Dellunione Europea 1Viola GozzaniNessuna valutazione finora
- La Critica Di Attac Europa Al Trattato Di LisbonaDocumento16 pagineLa Critica Di Attac Europa Al Trattato Di LisbonaDario TamburranoNessuna valutazione finora
- Fonti E Campo Di Applicazione Del Diritto Dell'Unione EuropeaDocumento7 pagineFonti E Campo Di Applicazione Del Diritto Dell'Unione Europealucia-christina.maniutNessuna valutazione finora
- Appunti Marinuncci DolciniDocumento222 pagineAppunti Marinuncci DolciniclaudiaNessuna valutazione finora
- Diritto Del Mercato Europeo e Della ConcorrenzaDocumento53 pagineDiritto Del Mercato Europeo e Della ConcorrenzaMartina MantovanelliNessuna valutazione finora
- Riassunto-Concetti Generali-Draft Common Frame of Reference.Documento4 pagineRiassunto-Concetti Generali-Draft Common Frame of Reference.Enrico Xeddy OrnielliNessuna valutazione finora
- Docsity Diritto Internazionale Ivaldi 1Documento56 pagineDocsity Diritto Internazionale Ivaldi 1Matt TorriNessuna valutazione finora
- Giudici Nazionali Quali Giudici Naturali Del Diritto UEDocumento5 pagineGiudici Nazionali Quali Giudici Naturali Del Diritto UEAnnalisa GianfeliceNessuna valutazione finora
- Appunti PrivatoDocumento50 pagineAppunti Privatochristian varrialeNessuna valutazione finora
- Appunti Diritto Unione Europea - Martines PisaDocumento29 pagineAppunti Diritto Unione Europea - Martines PisaRosellaRussoNessuna valutazione finora
- Delitti Contro La P.A.Documento99 pagineDelitti Contro La P.A.Filippo CastorioNessuna valutazione finora
- PERLINGIERI DocxDocumento143 paginePERLINGIERI DocxMaria Antonia Adesso100% (1)
- Gazzetta Mantova 18 Luglio 2010Documento39 pagineGazzetta Mantova 18 Luglio 2010stefano100% (1)
- Attualita Giugno 2014Documento16 pagineAttualita Giugno 2014Iris HernandezNessuna valutazione finora
- Il Peperoncino Rosso - Maggio 2019Documento16 pagineIl Peperoncino Rosso - Maggio 2019IlPeperoncinoRossoNessuna valutazione finora
- 015 Esercizi Frazioni Espressioni Frazioni DoppieDocumento4 pagine015 Esercizi Frazioni Espressioni Frazioni Doppiegibson les paulNessuna valutazione finora
- Tesi Andrea GangemiDocumento178 pagineTesi Andrea GangemiAnonymous ud43xkjnmNessuna valutazione finora