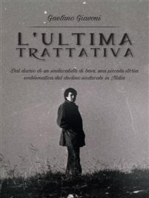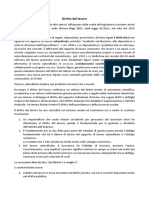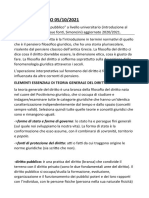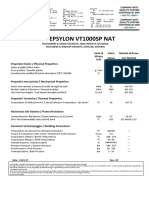Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Riassunto Sindacale
Caricato da
marikasonnessa.577900Titolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Riassunto Sindacale
Caricato da
marikasonnessa.577900Copyright:
Formati disponibili
Diritto sindacale - Giugni
Diritto Del Lavoro
Università del Salento
87 pag.
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
CAPITOLO I
INTRODUZIONE AL DIRITTO SINDACALE
1. Definizione del diritto sindacale
Il diritto sindacale è quella parte del diritto del lavoro che concerne il sistema di norme strumentali –
poste dallo Stato o dalle stesse organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori – che disciplinano la
dinamica del conflitto d’interessi derivante dalla ineguale distribuzione del potere nei processi produttivi.
Il diritto sindacale emerge e si evolve, parallelamente alla storia del movimento operaio, riflettendo la
contrapposizione tra capitale e lavoro, conseguenza della rivoluzione industriale. Per quanto detto, pare
chiaro che il diritto sindacale sia un fenomeno tipicamente moderno, sviluppatosi a partire dalla seconda
metà del sec. XIX come manifestazione e come regolamentazione della autonomia dei gruppi professionali.
Ciò non deve condurre, però, ad una sua assimilazione al diritto autonomo dei gruppi professionali -
caratteristico della vita produttiva del Basso medioevo – in quanto l’economia medievale si strutturava
attorno alle corporazioni (o “arti” o “gilde”), al cui interno non si riscontrava un contrasto d’interessi.
Caratteristica essenziale dell’organizzazione della vita produttiva moderna e della struttura sociale che ne
deriva è, per contro, l’esistenza di un conflitto d’interessi tra i lavoratori e gli imprenditori da cui essi
dipendono.
Con l’espressione conflitto industriale viene generalmente designato il conflitto tra capitale e lavoro, ma:
• tradizionalmente, è inquadrato come elemento della lotta di classe tra chi ha la proprietà dei mezzi di
produzione e chi, non avendola, è obbligato a cedere ai primi la propria forza-lavoro;
• dottrine più recenti, invece, vi ricomprendono tutte le ipotesi di conflitto con l’autorità che viene
esercitata nell’organizzazione del lavoro (così inquadrato, il conflitto si manifesterebbe anche nelle
imprese di proprietà pubblica; per altro verso, è evidente che le S.p.A. siano controllate non tanto
dagli azionisti-proprietari, quanto dai managers; infine, la base materiale del conflitto si manifesta
non solo quando il contratto sia di lavoro subordinato – art. 2094 c.c. – ma anche quando sia di
lavoro autonomo – si pensi agli agenti ed ai rappresentanti di commercio.
In sostanza, il conflitto industriale può avere valenze politico-istituzionali diverse ed il diritto sindacale
può, quindi, essere penetrato da ispirazioni e motivi ideologico-politici diversi.
2. Diritto sindacale e relazioni industriali
Gli studi di diritto sindacale hanno lo stesso oggetto di un’ altra disciplina – con protagonisti sociologi ed
economisti – che ha preso il nome di relazioni industriali. In essa, centrale è la nozione di sistema di
relazioni industriali, una sezione del sistema sociale generale formata dalle interazioni tra imprenditori,
organizzazioni dei lavoratori e pubblici poteri, il cui risultato è un sistema di norme dirette a regolare il
sistema produttivo. Materia degli studi di relazioni industriali è dunque il contesto normativo (web of rules)
dei rapporti tra interessi organizzati.
3. L’effettività nel diritto sindacale
Il diritto sindacale appartiene all’ambito – più circoscritto – della scienza giuridica. In esso, tuttavia, il profilo
della effettività della norma assume una rilevanza primaria e, comunque, ben più cogente che negli altri
rami del diritto. Può addirittura accadere che l’attuazione della norma formalmente valida, anziché essere
oggetto dell’attività delle strutture preposte all’applicazione del diritto, divenga oggetto di mediazione
politica, che può persino svolgersi sull’opportunità o meno di dare ad essa applicazione. In altri termini, non
sempre la disapplicazione di massa di un precetto ha come seguito la sanzione di massa , che può
apparire politicamente inopportuna o essere di attuazione impossibile. È proprio in tali occasioni che si
manifestano forme di elasticità dell’ordinamento (ad es., si pensi alle occupazioni di aziende od ai blocchi
stradali, che in momenti di particolare tensione sociale si preferisce non sanzionare).
A loro volta, nuove leggi – formalmente espressione del potere legislativo – sono sovente frutto di
negoziazione tra i soggetti del sistema di relazioni industriali, e ciò avviene quando si ritiene che solo un
ampio consenso sociale possa garantire alla legge un tasso sufficientemente elevato di osservanza
spontanea.
Il diritto sindacale, in conclusione, poggia la sua effettività sulla costanza del consenso sociale e
dell’opera di mediazione politica, che contribuisce a dare ad esso stabilità e continuità (si rileva, dunque,
una pregnante analogia con il diritto internazionale, ove l’irrogazione di sanzioni passa attraverso una
mediazione politica).
4. Astensione legislativa e ruolo della dottrina
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Dopo l’abrogazione dell’ordinamento corporativo (1926-1944) e l’emanazione della Costituzione del 1948 –
che ha introdotto principi fondamentali, quali quello della libertà sindacale (art. 39) e del diritto di sciopero
(art. 40) – in Italia per un lungo periodo il legislatore ordinario si è astenuto dall’intervenire in materia di
rapporti sindacali, emanando solo:
• la l. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), recante norme sulla tutela della libertà e della dignità
dei lavoratori, nonché della libertà e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro;
• la l. 146/1990, inerente invece lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
L’architettura del sistema è dunque frutto di un’ intensa attività di sistemazione e razionalizzazione,
sostanzialmente creativa, svolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che ha condizionato e continua a
condizionare profondamente anche la successiva produzione legislativa. Pertanto, in questa branca del
diritto il problema interpretativo presenta una centralità indiscutibile e la sua soluzione comporta una
serie di opzioni che l’interprete compie in base a valutazioni di carattere generale (c.d. politica del diritto).
Le costruzioni della dottrina giuridica esprimono infatti posizioni ideologiche, ed il “diritto dei giuristi” non è
teoricamente neutro: in ciascun autore è sempre ravvisabile un filo conduttore che ricollega le
argomentazioni logiche ai sistemi di valori contenuti nella cultura del tempo.
5. L’ordinamento intersindacale
Una delle prospettive da cui può essere osservato il sistema di relazioni industriali è quella giuridico-
normativa: le relazioni industriali – in quanto “istituzione”, nel senso attribuitogli dal Romano – sono
normalmente dotate di una relativa stabilità e di un’ altrettanto relativa autonomia da altri settori della vita
sociale. Tuttavia, ad ogni istituzione corrisponde un ordinamento giuridico (e viceversa): possiamo
dunque affermare che le relazioni industriali sono rette da un ordinamento c.d. intersindacale.
Da ciò, è possibile leggere le costanti di comportamento tipiche di ciascun sistema di relazioni industriali
come effetto dell’applicazione delle norme proprie dell’ordinamento intersindacale, a prescindere
dall’eventuale esistenza e dal significato di norme proprie dell’ordinamento statale aventi il medesimo
oggetto. Ad esempio, l’ammissione o meno di un sindacato alla trattativa sindacale non sono – nel settore
privato – normalmente oggetto di norme valide dell’ordinamento dello Stato, per il quale sono comportamenti
indifferenti; cionondimeno possono essere oggetto di valutazioni nell’ordinamento intersindacale.
Può anche accadere che la medesima materia sia regolata contemporaneamente da nome
dell’ordinamento statale ed intersindacale:
• se le loro valutazioni normative coincidono, il problema non sussiste;
• in caso di valutazioni normative contrastanti, invece, si crea quel conflitto di lealtà che rende
ineffettiva la norma dell’uno o dell’altro.
Si possono infine avere valutazioni differenti ma non confliggenti:
• si pensi, ad es,, al contratto collettivo, che per l’ordinamento statale è un contratto regolato – al
pari degli altri – dal Titolo II del Libro IV del c.c., mentre per l’ordinamento intersindacale è l’atto
fondamentale che regola i rapporti tra imprenditori e sindacati, assolvendo così alla stessa funzione
di normazione astratta e generale che la legge svolge nell’ordinamento statuale;
• o, ancora, ai c.d. accordi triangolari tra parti sociali e governo, nei quali quest’ultimo assume
l’impegno di creare determinate norme, impegno che, sul piano dell’ordinamento statale, non può
vincolare la volontà sovrana del Parlamento ma, cionondimeno, non può dirsi privo di valore
giuridico nell’ordinamento intersindacale, avendo un peso rilevante negli equilibri di quest’ultimo.
La nozione di ordinamento intersindacale assolve, pertanto, ad un’ indispensabile funzione conoscitiva:
senza di essa, la parte più significativa della dinamica delle relazioni sindacali non sarebbe conoscibile dal
punto di vista giuridico. Più in dettaglio, l’ordinamento intersindacale – lungi dall’essere un sistema chiuso
– interagisce con l’ordinamento giuridico statuale, sovente operando come fattore di rinnovamento di
quest’ultimo. Le considerazioni fin qui svolte ci conducono, quindi, ad affermare che lo studio del diritto
sindacale riguarda non solo istituti rilevanti per l’ordinamento statuale, bensì anche quelli che di tale
rilevanza sono privi o che hanno una qualificazione diversa nell’ambito dei due ordinamento.
6. Il ruolo della giurisprudenza
Sebbene negli ordinamenti di civil law la giurisprudenza non costituisce una fonte di diritto obiettivo, nella
materia oggetto di trattazione essa ha espresso indirizzi ermeneutici costituenti componenti essenziali
dell’esperienza giuridica (specie quando hanno colmato lacune lasciate dal legislatore). Ad esempio, anche
prima dello Statuto dei lavoratori, fu la giurisprudenza a costruire il complesso edificio di un diritto sindacale
liberato dall’impostazione pubblicistica tipica del periodo corporativo e saldamente ancorato al diritto privato
(si pensi alla nozione di contratto collettivo di diritto comune, ovvero all’utilizzazione del principio della giusta
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
retribuzione ex art. 36 Cost. per rafforzarne l’efficacia, ovvero ancora all’efficacia soggettiva dei contratti
collettivi, oltre che alla complessa elaborazione di limiti al diritto di sciopero).
7. Il diritto comunitario
I sistemi di relazioni industriali stentano ad avere una dimensione sovranazionale: ciò, per lungo tempo, ha
portato ad una sostanziale indifferenza del diritto comunitario per il diritto sindacale, che trova la sua
espressione formale nell’art. 153, c. 5, TFUE, ove esclude dalla competenza comunitaria alcuni aspetti
fondamentali quali il diritto di associazione, lo sciopero e la serrata, aspetti, questi, riservati alla competenza
degli Stati membri.
L’integrazione economica tra i Paesi dell’Unione si è, però, spinta ad un punto tale che difficilmente può fare
ulteriori progressi senza essere accompagnata da una piena integrazione giuridica. Di qui l’avvio di un
processo verso il riconoscimento, nel diritto comunitario, di un catalogo di diritti fondamentali approdato poi
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (Nizza, 2000), cui è stato attribuito un valore giuridico col
Trattato di Lisbona (2007, entrato in vigore nel 2009).
D’altro canto, nel 2004 all’Unione sono stati ammessi dodici nuovi Paesi, tutti aventi sistemi economici più
deboli e con trattamenti retributivi e normativi deteriori rispetto a quelli dei Paesi che ne facevano parte già in
precedenza. Ciò ha creato una tendenza delle imprese verso una concorrenza al ribasso (c.d. dumping
sociale), ed i tentativi delle organizzazioni sindacali e degli Stati di ostacolare questo processo hanno
trovato un freno nella giurisprudenza della Corte di Giustizia che, pur riconoscendo la natura di diritti
fondamentali al diritto di contrattazione collettiva ed a quello di sciopero, ha dato prevalenza, nel loro
bilanciamento con le libertà economiche, a queste ultime. È presto, però, per affermare che la tendenza
espressa in dette sentenze sia destinata a consolidarsi: se si considerano, da un lato, i progressi che il
Trattato di Lisbona può indurre per l’Europa sociale e, dall’altro, l’esistenza di una contrattazione collettiva
transnazionale, non si può certo escludere che, anche a livello europeo, possano essere le relazioni
industriali a comporre il contrasto tra libertà d’impresa e azione sindacale. Del resto, non solo i lavoratori, ma
anche gli imprenditori dei Paesi più sviluppati hanno interesse ad impedire una concorrenza fondata sul
costo del lavoro: le relazioni industriali potrebbero, così, avvicinare i sistemi di regolazione sociale,
anticipando gli stessi sviluppi legislativi. Ci troviamo, insomma, in un periodo di transizione di cui è
impossibile prefigurare gli esiti.
8. Le regole del conflitto e il problema della loro stabilità
Storicamente, nelle nostre relazioni industriali sono incerte le regole per l’individuazione dei soggetti
legittimati alla trattativa, alla composizione delle controversie, alla proclamazione degli scioperi. L’esigenza
di regole formalizzate non era molto avvertita quando la rappresentanza dei lavoratori era saldamente in
mano alle tre grandi Confederazioni, in quanto il potere di mediazione da esse esercitato era sufficiente a
garantire il rispetto del nucleo essenziale di regole che, anche se non scritte, sono proprie di ogni sistema di
relazioni industriali.
Il problema della formalizzazione di queste regole ha acquistato un grande rilievo durante un lungo lasso
di tempo che va dalla fine degli anni ’70 agli anni ’90 del secolo scorso, nel quale la posizione egemonica
delle grandi Confederazioni è stata insidiata dall’insorgere di sindacati “autonomi” e di gruppi militanti (c.d.
Cobas).
Invero, la scoperta del valore delle regole trova la propria ragione più profonda nell’affievolimento dei
grandi conflitti ideologici: le stesse grandi confederazioni appaiono sempre meno diverse tra loro nella
base sociale rappresentata, ma ciascuna all’interno si presenta sempre meno come comunità d’interessi
omogenei e sempre più quale centro di mediazione tra interessi di gruppi diversi e, talvolta, competitivi.
La necessità di rinnovare le ragioni di compattezza tra i lavoratori ha posto in primo piano due problemi
complementari:
• quello della rappresentanza, e cioè del rapporto tra il sindacato e la totalità del gruppo
professionale di riferimento;
• quello dei rapporti tra base e vertice, tra aderenti e dirigenti.
Tali problemi si intrecciano col dilemma tra democrazia rappresentativa (elezione dei dirigenti) e
democrazia diretta (assemblee, referendum).
In proposito, il sindacalismo italiano presenta due posizioni di principio, che tendono a collidere tra loro:
• nella CGIL è forte la tendenza a privilegiare l’autonomia della base (sindacato-movimento) e ad
interpretare come base non solo quella composta dagli iscritti, ma l’intero gruppo professionale
di riferimento;
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
• da ciò, il problema della democrazia sindacale è, in primo luogo, relativo ai rapporti tra le
organizzazioni ed i lavoratori destinatari della loro azione, a prescindere dall’adesione
formale alle prime. Di qui, la tendenza a privilegiare strutture rappresentative di
democrazia diretta (assemblee e referendum), che coinvolgono anche i lavoratori non
sindacalizzati.
• la CISL, per contro, è più orientata a privilegiare il dato organizzativo (sindacato-istituzione).
• da ciò, democrazia sindacale e democrazia nell’associazione sono sinonimi, per cui la prima
si garantisce attraverso l’effettiva partecipazione degli iscritti alle determinazioni
dell’associazione stessa.
CAPITOLO II
LA LIBERTA’ SINDACALE
1. Il principio costituzionale della libertà sindacale
L’ordinamento corporativo – istituito dal regime fascista nel 1926 – prevedeva il sindacato unico, al
contempo persona giuridica di diritto pubblico (che consentiva così un penetrante controllo dello Stato, dal
momento che ad esso erano riconosciuti poteri anche nei confronti dei non iscritti) e depositario della
rappresentanza legale di tutti i componenti della categoria (da cui discendeva l’efficacia erga omnes del
contratto collettivo). Dopo aver configurato come reato lo sciopero e la serrata, il legislatore fascista istituì
– nel 1934 – le corporazioni che, riunendo al proprio interno le associazioni sindacali contrapposte,
avrebbero dovuto realizzare l’armonica composizione dei conflitti tra i fattori della produzione (per ciò, erano
investite di poteri di regolamentazione con le c.d. ordinanze corporative). L’ordinamento corporativo fu
soppresso nel 1943.
Con l’introduzione della Costituzione, il principio giuridico fondamentale sul quale poggia il nostro sistema di
diritto sindacale è quello contenuto nell’art. 39 Cost., ove si stabilisce che “l'organizzazione sindacale è
libera”. Come si vede, nel nostro ordinamento democratico – contrariamento a quanto avveniva in quello
fascista, che prevedeva un sistema di composizione degli interessi collettivi estraneo ad una libera
partecipazione dei soggetti interessati – la facoltà di agire a tutela e promozione degli interessi viene
attribuita agli stessi soggetti che ne sono portatori, come esplicazione della loro posizione di libertà. In
particolare, il diritto sancito nell’art. 39 Cost. si esplica:
• come diritto soggettivo pubblico di libertà, in quanto inibisce allo Stato di compiere atti che
risultino lesivi di tale libertà (ad es., lo Stato non potrebbe emanare una legge ordinaria che
determini i fini o le forme del sistema sindacale);
• nei rapporti intersoggettivi privati, in quanto ben possono riscontrarsi vistose forme di
manomissione della libertà sindacale nei rapporti tra lavoratori e datore di lavoro.
2. La libertà di organizzazione sindacale
Può essere interessante offrire un parallelo tra gli artt. 39, c.1 e 18 Cost.:
• art. 39, c.1: “L'organizzazione sindacale è libera”;
• art. 18: “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non
sono vietati ai singoli dalla legge penale.”
Come si vede, l’art. 18 non è incondizionato, mentre l’art. 39, tipizzandolo, fa si che il fine sindacale non
possa essere vietato da legge penale ordinaria.
Peraltro, se l’art. 18 utilizza il più “ristretto” lemma di “associazione”, l’art. 39 fa riferimento
all’organizzazione”, implicando così una nozione più ampia del fenomeno sindacale, tale da ricomprendere
anche forme organizzative diverse da quella associativa (si pensi, ad es., ai consigli di fabbrica).
Del predicato “sindacale” possono invece offrirsi due complementari letture:
• sotto il profilo teleologico è sindacale un atto o attività diretti all’autotutela di interessi connessi
a relazioni giuridiche in cui sia dedotta l’attività di lavoro;
• sotto il profilo strutturale, la qualificazione sindacale presuppone un’ aggregazione di soggetti,
almeno potenziale. Sotto tale profilo:
• per taluni, anche un singolo può svolgere attività sindacale;
• per altri, è sempre necessaria una forma solidale (posizione che riteniamo di suffragare, alla
luce del dettato Costituzionale facente riferimento all’”organizzazione”).
Con ciò, non si vuol dire che il titolare della libertà sindacale sia solo il gruppo e non anche
l’individuo: è attività sindacale anche quella svolta da un solo soggetto per promuovere la
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
costituzione di un’ organizzazione sindacale, e dunque oggetto del riconoscimento
costituzionale, prima che l’organizzazione, è l’attività a questa finalizzata.
3. La normativa comunitaria
Come già accennato, se l’ordinamento UE detta una normativa sufficiente in tema di rapporti di lavoro,
trascura quello dei rapporti collettivi di lavoro.
La Carta dei diritti fondamentali (sottoscritta a Nizza), contempla sì, all’art. 12, la libertà sindacale (“ogni
individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in
campo politico, sindacale e civico”), ma come semplice libertà di associazione (la menzione del fine
sindacale ha una funzione meramente esemplificativa). Inoltre, l’art. 153, c.5 TFUE esclude espressamente
la libertà sindacale dalla competenza comunitaria, il che appare una cattiva applicazione del principio di
sussidiarietà: è stato, cioè, ritenuto sufficiente il riconoscimento della libertà sindacale contenuto
negli ordinamenti degli Stati membri. Tuttavia, le norme degli Stati membri, hanno un effetto solo indiretto
nell’ordinamento comunitario attraverso l’art. 6, c.3 TFUE (“ I diritti fondamentali [...] risultanti dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali”). Il
risultato è che, nonostante le organizzazioni sindacali siano chiamate a svolgere un ruolo primario nelle
decisioni comunitarie e nella loro attuazione, tale ruolo viene svolto con un riconoscimento solo indiretto del
principio di libertà sindacale, in stridente contraddizione con la necessità di dare una dimensione
sociale all’Europa.
4. La libertà sindacale nelle convenzioni internazionali
La libertà sindacale è anche oggetto di numerose norme di diritto internazionale, prime fra tutte le convv. 87
(“libertà sindacale”) e 98 (“diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva”) dell’OIL (Organizzazione
internazionale del lavoro, finalizzata a promuovere il miglioramento delle condizioni dei lavoratori attraverso
convenzioni e raccomandazioni).
A queste fondamentali convenzioni se ne aggiungono altre, riguardanti settori particolari:
• nell’ambito dell’ONU è stato stipulato il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
(1966) , il quale prevede l’impegno per gli Stati di garantire, oltre la libertà sindacale, anche il diritto
di sciopero;
• nell’ambito Europeo, invece, vanno menzionate:
• la CEDU, il cui art. 11 garantisce il diritto di associazione sindacale;
• la Carta sociale europea, nella quale viene ribadito il principio di libertà dell’organizzazione
sindacale e riconosciuto il diritto all’autotutela, “compreso il diritto di sciopero”.
Tutte le fonti internazionali sopra citate obbligano gli Stati all’adeguamento del proprio ordinamento
interno e prevedono anche meccanismi di controllo dell’adempimento di tali obblighi.
5. Il divieto di atti discriminatori
La fonte ordinaria di tutela della libertà sindacale più incisiva è costituita dalla l. 300/1970 (c.d. Statuto dei
lavoratori), il cui Titolo II espressamente rubrica “Della libertà sindacale”. Tale legge persegue tre
obiettivi:
• tutelare la libertà e la dignità del lavoratore con riferimento a situazioni repressive che possono
verificarsi nell’impresa (uso della polizia privata nelle fabbriche, uso di strumenti per il controllo a
distanza dell’attività dei lavoratori, esercizio del potere disciplinare, assunzione di informazioni sui
lavoratori, ecc.);
• rafforzare l’effettività del principio di libertà sindacale all’interno dei luoghi di lavoro, vietando
all’imprenditore di utilizzare i poteri del contratto di lavoro per ostacolare i lavoratori nell’esercizio
dell’attivitòà di autotutela dei propri interessi (si pensi al divieto di atti discriminatori di cui agli artt. 15
e 16);
• creare una politica di sostegno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Le norme riferibili ai tre aspetti di cui sopra – pur distinti – realizzano un effetto sinergico per cui ciascun
grippo di norme rafforza gli altri due obiettivi. In questa sede, pare opportuno esaminare le norme del Titolo
II (come detto, specificamente rivolte alla tutela della libertà sindacale):
• art. 14: “Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attivita' sindacale, e'
garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.”
Tale norma, ribadendo un principio già sancito nell’art. 39 Cost., potrebbe apparire superflua ma, a
ben vedere, essa è finalizzata a garantire la libertà sindacale soprattutto nei confronti del
datore di lavoro (e dunque non solo nei rapporti cittadino-Stato, ma anche nella sfera dei rapporti
interprivati);
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
• art. 15: “E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad
una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte.”
Oltre alla nullità dell’atto, l’art. 38 prevede l’applicazione di una sanzione penale.
“b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei
trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio (qui si fa riferimento
alle situazioni più disparate, che il legislatore non sarebbe stato in grado di determinare a priori) a
causa della sua affiliazione o attivita' sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.”
Per tali atti non è disposta una sanzione penale.
• art. 16: “E' vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere
discriminatorio a mente dell'articolo 15 (si pensi ai premi corrisposti ai lavoratori che non abbiano
partecipato ad uno sciopero).
Il [giudice], su domanda dei lavoratori nei cui confronti e' stata attuata la discriminazione di cui al
comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i
fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una
somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel
periodo massimo di un anno (i lavoratori che promuovono l’azione non ne traggono alcun beneficio
patrimoniale).”
Si badi che trattamento economico collettivo discriminatorio può considerarsi:
• sia quello diretto ad ostacolare in genere l’attività sindacale;
• sia quello corrisposto per agevolare l’adesione a particolari organizzazioni sindacali.
Peraltro, trattamento economico è:
• non solo la corresponsione di somme di denaro;
• ma anche qualsiasi concessione valutabile in termini economici (ad es., un periodo di
ferie più lungo).
Si badi che l’art. 15 – e, di conseguenza, anche l’art. 16 che lo richiama – si applica anche ad altre tipologie
di discriminazione, come si evince dal comma 2:
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresi' ai patti o atti diretti a fini di discriminazione
politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di eta' o basata sull'orientamento
sessuale o sulle convinzioni personali.”
Tuttavia, mentre per le discriminazioni sindacali l’apparato sanzionatorio rimane quello già descritto, per le
discriminazioni per altre ragioni è stato elaborato un complesso apparato procedurale e sanzionatorio
specifico. Ad ogni modo, le discriminazioni sindacali possono essere perseguite e sanzionate anche con
l’azione ex art. 28 Stat. lav. (v. cap VI, sez. B).
6. I sindacati di comodo
L’art. 17 dispone che:
“E' fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con
mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.”
L’esistenza di tali sindacati – chiamati “gialli” nel linguaggio corrente – costituisce infatti un modo indiretto di
comprimere la libertà sindacale, limitando lo spazio dell’organizzazione genuina ed effettivamente
rappresentativa. Quello che rileva, poiché ricorra la situazione antigiuridica tipizzata dalla norma, è in
sostanza l’asservimento del sindacato al datore di lavoro. Tuttavia occorre evitare di travisare il senso di
comportamenti che rientrano nella normale dialettica delle relazioni industriali: così, non può parlarsi di
“asservimento” per la semplice propensione da parte del datore di lavoro ad accettare rivendicazioni
proposte dal sindacato senza però offrirgli particolari vantaggi operativi. Va sottolineato che il
comportamento illegittimo è l’atto del datore di lavoro (o della sua associazione) di costituire o sostenere il
sindacato giallo, non l’esistenza di questo: il giudice, pertanto, in caso di violazione dovrò interdire al datore
di lavoro l’azione di sostegno, ma non potrà ordinare lo scioglimento dell’associazione.
7. La libertà sindacale negativa
Posto che per libertà sindacale negativa si intende la libertà del lavoratore di non aderire ad alcuna
organizzazione sindacale, rileviamo che le fonti comunitarie ed internazionali sono ambigue su tal punto:
• nei paesi anglosassini, le tradizioni sindacali sono state caratterizzate, in passato, da clausole
contrattuali c.d. di sicurezza sindacale, cioè dirette a rafforzare la presenza sindacale in azienda,
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
obbligando l’imprenditore ad assumere solo lavoratori iscritti al sindacato (closed shop), ovvero
vincolando il lavoratore neo-assunto ad iscriversi, pena il licenziamento (union shop).
La Corte EDU ha affermato peraltro l’illegittimità di tali prassi contrattuali per violazione della
Convenzione.
• in Italia, tali clausole sono praticamente sconosciute.
Nella legislazione italiana, un riferimento esplicito a questa libertà è contenuto nell’art. 15, lett. a) dello
statuto dei lavoratori (“E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a a) subordinare l'occupazione (sono quindi
illecite tanto le pratiche di closed shop, quanto quelle di union shop) di un lavoratore alla condizione che
[...] non aderisca ad una associazione sindacale”). Di conseguenza – anche se tale garanzia non esplicitata
– è possibile affermare l’inammissibilità non solo di clausole contrattuali che subordinino l’occupazione
all’adesione ad un determinato sindacato, ma anche di discriminazioni economiche e normative
dipendenti dalla non adesione ad esso. Dietro tale scelta si coglie infatti un’ elementare garanzia del
diritto al dissenso, in un sistema di valori costituzionali fondato su una scelta nel senso di un sindacalismo
volontaristico.
Tra le discriminazioni vietate non va però annoverata la pratica dei c.d. benefici riservati, che riserva in
tutto o in parte i vantaggi della contrattazione collettiva ai soli lavoratori iscritti ai sindacati
stipulanti: la concessione di trattamenti più favorevoli è, infatti, illecita solo ove sia frutto di iniziativa
unilaterale dell’imprenditore.
8. L’organizzazione sindacale dei militari e della polizia
Se, riguardo al diritto di sciopero, la controversia è stata aspra (v. cap. XIII), la libertà di organizzazione dei
pubblici dipendenti ha acquistato una sua legittimazione senza momenti traumatici (essa è, infatti, ora
positivamente garantita da una convenzione dell’OIL). I soli limiti vigenti riguardano:
• i militari cui, giusta l’art. 3, l. 382/1978 (in realtà abrogato nel 2010!) “spettano i diritti che la
Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri
delle Forze armate la legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti.”
Su questa falsariga, l’art. 8, con specifico riguardo ai diritti sindacali, sancisce che “I militari non
possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere
sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali.” In parziale compensazione di questo limite,
tuttavia, la legge istituisce organi elettivi di rappresentanza che partecipano al procedimento di
determinazione del trattamento economico e normativo.
• i corpi di polizia non militari (Polizia di Stato, Corpo Forestale e Polizia Penitenziaria) godono di
una differente condizione.
In particolare, l’art. 83, l. 121/1981 dispone che “I sindacati del personale della Polizia di Stato
sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alla Polizia di Stato, in attivita' di servizio o in
quiescenza, e ne tutelano gli interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti
operativi.
Essi non possono aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre
associazioni sindacali.”
La legittimità costituzionale del divieto di cui al secondo comma, in relazione all’art. 39 Cost., è
dubbia, in quanto l’affiliazione costituisce anch’essa espressione di libertà sindacale. Il divieto di
affiliazione alle Confederazioni, in quanto limitativo di un diritto fondamentale e quindi norma
eccezionale, non può essere interpretata estensivamente (dunque, non se ne può dedurre il
divieto di intrattenere rapporti politici con una di esse, né rapporti convenzionali che consentano agli
iscritti al sindacato di polizia di usufruire degli stessi servizi di altri lavoratori: di qui, la legittima prassi
di alcuni sindacati di Polizia di avere rapporti privilegiati con una delle maggiori Confederazioni
sindacali). La legge prevede, inoltre, il divieto di sciopero (art. 84, v. cap. XIII, par. 2) e il
riconoscimento di una serie di diritti sindacali (artt. 82 e 88 ss.).
Per il Corpo Forestale, la l. 36/2004, per quanto riguarda l’argomento oggetto di trattazione, ha fatto
espresso rinvio alla l. 121/1981.
Per la Polizia penitenziaria, invece, l’art. 19, l. 395/1990 dispone che “gli appartenenti al Corpo di
polizia penitenziaria hanno l’esercizio dei diritti politici, civili e sindacali”, senza porre analoghe
limitazioni.
9. La libertà sindacale degli imprenditori
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Un problema particolarmente dibattuto è quello della libertà sindacale degli imprenditori. Il problema sorge
perché, mentre l’attività sindacale dei lavoratori è sempre riferita ad un termine collettivo (e perciò è attività
organizzata), l’imprenditore può agire come singolo (ad es., nella contrattazione aziendale) o con la
serrata, o con qualsivoglia comportamento individuale rilevante per la contrapposta collettività di lavoratori.
D’altra parte, il sindacalismo imprenditoriale è storicamente un sindacalismo “di risposta”, che si forma in
funzione di resistenza nei confronti dell’organizzazione dei lavoratori. In proposito, alcuni autori hanno
osservato:
• in primo luogo, che la Costituzione, nelle sue norme di principio, pone il lavoro come fondamento
della Repubblica e, nell’art. 3, c. 2, dispone che “E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
[...] che, [...] impediscono [...] l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese”.;
• in secondo luogo, che nel Titolo III destina gli artt. Dal 35 al 40 esclusivamente alla tutela del lavoro,
mentre la libertà dell’impresa è trattata nel successivo art. 41.
Su queste basi, si è ritenuto – nonostante la contestazione della dottrina maggioritaria – che
l’associazionismo degli imprenditori non goda della tutela dell’art. 39 e sarebbe, invece, tutelato dal
combinato disposto tra gli artt. 18 e 41 Cost.. Per quanto detto, l’attività di queste organizzazioni
potrebbe essere assoggettata ai limiti attinenti all’iniziativa economica.
Questa soluzione appare in effetti come la più rispondente al dato storico e costituzionale (come visto, il
Titolo II dello Statuto dei lavoratori, intestato alla libertà sindacale, attiene solo a quella dei lavoratori!).
L’interpretazione qui proposta, infatti, non nega che anche gli imprenditori godano della libertà di
organizzarsi a fini sindacali, ma indica come suo fondamento non l’art. 39 Cost., ma gli artt. 18 e 41
Cost., i quali predispongono una tutela meno intensa, ma comunque coerente con la normativa
internazionale e comunitaria.
Insomma:
• la dottrina della libertà sindacale unilaterale valorizza i caratteri specifici dell’esperienza
sindacale dei lavoratori, considerata principalmente come una libertà collettiva, anche quando
l’esercizio sia individuale;
• la libertà “sindacale” dell’imprenditore può anche assumere aspetti collettivi, ma essa è pur
sempre una proiezione dell’iniziativa economica privata e, come tale, è essenzialmente una
libertà individuale.
La concezione unilaterale, pertanto:
• da un lato, inibisce ogni trattamento privilegiato dell’associazionismo dei datori di lavoro;
• dall’altro, fonda l’ammissibilità di condizioni più favorevoli per le organizzazioni dei
lavoratori, giustificate dall’obiettivo di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, c. 2 Cost..
10. La libertà sindacale dei lavoratori autonomi
L’adozione di un criterio guida orientato dalle valutazioni politico-sociali canonizzate nel capoverso dell’art. 3
Cost. offre anche una chiave di soluzione circa la riferibilità del principio di libertà sindacale alle
organizzazioni di lavoratori autonomi:
• vero è che esiste un sindacalismo di lavoratori autonomi riferibile all’autotutela finalizzata alla
promozione di condizioni di uguaglianza effettiva (ad es., quello degli agenti e rappresentanti di
commercio);
• al contrario, quando non emergano indici rivelatori di condizioni di squilibrio economico-sociale (si
pensi, ad es., agli avvocati), si rientrerà nel campo delle comuni garanzie di libertà associativa, non
qualificabile giuridicamente come libertà sindacale.
CAPITOLO III
IL SINDACATO
A. Il fenomeno storico
1. I modelli
Il sindacato è una forma di organizzazione collettiva dei lavoratori nata per contrastare e riequilibrare
la disparità di potere individuale nella quale questi si trovano nei confronti del datore di lavoro da cui
dipendono, sia al momento della stipulazione del contratto, sia nel corso dell’esecuzione del rapporto di
lavoro.
Le FORME DI ORGANIZZAZIONE ipotizzabili per la difesa dei propri interessi professionali sono quanto mai
varie, ma è possibile effettuarne una tipizzazione empirica:
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
• Sindacato di mestiere (craft union)
Emerso nei Paesi a più antico sviluppo industriale (Gran Bretagna e USA) e nei settori produttivi in cui
maggiore è la presenza di operai specializzati, esso assume il mestiere esercitato dai lavoratori come
criterio individuante il gruppo professionale da organizzare.
• Secondo questo modello, in ogni impresa operano tanti sindacati quanti sono i mestieri
necessari al processo produttivo.
• Sindacato per ramo d’industria
Nato dalla diffusione dell’industria altamente meccanizzata e dalla conseguente dequalificazione della
manodopera – che hanno portato alla prevalenza di operai comuni o semi-specializzati – si afferma
soprattutto nell’Europa continentale.
• In base a questo modello, il sindacato organizza i lavoratori in base all’attività produttiva
esercitata dall’impresa da cui dipendono e, dunque, per settore produttivo.
In Italia, inizialmente furono costruiti numerosi sindacati di mestiere, ma ben presto prevalse il sindacato
per ramo d’industria, perché consentiva di creare tra i lavoratori una solidarietà più ampia. Si noti, tuttavia,
come l’evoluzione verso il criterio dell’attività produttiva non ha riguardato né i dirigenti d’azienda, né i
lavoratori con professionalità elevate.
• Sindacato occupazionale
A partire dalla fine degli anni ’70, con l’impiego massiccio delle nuove tecnologie, si sono diffuse nel mercato
del lavoro figure di lavoratori con funzioni professionali più elevate e complesse che, ritenendo che i propri
interessi fossero sacrificati dalle politiche delle Confederazioni (evidentemente centrate sugli interessi dei
lavoratori con professionalità medio-basse), hanno costituito numerose organizzazioni sindacali “autonome”,
cioè non aderenti a nessuna delle tre maggiori Confederazioni sindacali. In tal modo è emerso e si è diffuso
il sindacato occupazionale (si pensi, in Italia, ai sindacati dei quadri dell’industria, ad es. Unionquadri) una
variante del sindacato di mestiere.
Nell’ultimo decennio, poi, si è accelerato anche nel nostro Paese un processo di sperimentazione mi modelli
di rappresentanza diversi dal sindacalismo industriale, sintomo della sempre minore importanza del
criterio del settore produttivo. Le soluzioni adottate sono sostanzialmente due:
• fusione – al fine di razionalizzare l’organizzazione e di diminuire i costi - di organizzazioni di
categoria preesistenti e creazione di sindacati multi-industriali o conglomerati;
creazione di strutture di rappresentanza ad hoc, prima per i pensionati, poi per i lavoratori
occupati con particolari tipologie contrattuali (collaboratori a progetto, lavoratori occasionali, c.d.
lavoratori atipici). In particolare, i secondi, in quanto partecipanti in maniera discontinua al mercato
del lavoro e soggetti a frequenti cambiamenti di azienda e categoria produttiva, non possono infatti
essere efficacemente organizzati dai tradizionali sindacati di categoria.
2. L’organizzazione
La struttura organizzativa della maggiori Confederazioni sindacali dei lavoratori in Italia (Confederazione
generale italiana del lavoro, CGIL; Confederazione italiana sindacati liberi, CISL; Unione italiana del lavoro,
UIL) si articola in due linee organizzative:
• verticale, basata sul criterio della categoria produttiva (e, cioè, dell’attività produttiva svolta
dall’impresa in cui operano i lavoratori iscritti);
• orizzontale, basata sul criterio territoriale (in genere, provinciale e regionale) e, percioè,
intercategoriale.
In dettaglio:
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
• in base alla LINEA VERTICALE (prevalente nell’esperienza storica italiana e degli altri Paesi
industrializzati), l’unità di base di ciascuna organizzazione è costituita dagli iscritti presenti in
ciascuna azienda o unità produttiva. L’organismo aziendale confluisce poi nelle strutture territoriali
(in genere provinciali) e, quindi, in quelle regionali e nazionali di categoria.
• in base alla LINEA ORIZZONTALE, il sindacato si articola in strutture territoriali, provinciali e
regionali, intercategoriali, che rappresentano, cioè, tutti i lavoratori, indipendentemente dal settore
produttivo di appartenenza.
Infine, come si evince dal grafico, le strutture orizzontali regionali e le federazioni nazionali di categoria
concorrono a formare la Confederazione.
3. Sindacalismo unitario e pluralità di sindacati
Distinguiamo situazioni di:
• unità sindacale, caratteristica di Paesi in cui esistono confederazioni che raggruppano tutti, o
quasi, i sindacati esistenti (come avviene in Gran Bretagna, Germania e Svezia);
• pluralità sindacale, data dalla coesistenza di confederazioni con diverse culture sindacali
(presenti in Francia, Paesi Bassi, Italia, Spagna e Portogallo).
In Italia, nel 1944, la DC, il PCI ed il PSI stipularono il c.d. Patto di Roma, atto a creare un’ unica
Confederazione – la CGIL – che avrebbe organizzato tutti i lavoratori, indipendentemente dal proprio credo
politico e confessionale. Tuttavia, nel 1948, col venir meno dell’unità tra le forze politiche antifasciste, dalla
CGIL unitaria uscì la corrente democratico-cristiana e, poco dopo, quelle socialdemocratica e repubblicana
che costituirono la CISL e la UIL.
Ad ogni modo, è possibile affermare che lo stato dei rapporti tra le maggiori confederazioni da sempre
dimostra una forte tensione verso la c.d. unità di azione (accordo sulle politiche e sulle iniziative da
realizzare), dunque, nel dibattito sindacale, è sempre stato presente anche l’obiettivo della riunificazione
organica. Da questo punto di vista, il risultato più avanzato si conseguì sull’onda delle grandi lotte sindacali
unitarie dell’autunno caldo (1969): nel 1972, infatti, le tre grandi organizzazioni stipularono un patto col quale
fu creata la Federazione delle confederazioni, in cui esse si riconoscevano reciprocamente pari peso
nelle decisioni, a prescindere dalla propria effettiva consistenza associativa; in cambio, ciascuna
rinunziava alla possibilità di stipulare accordi separati. Questo equilibrio resse fino al mancato accordo
unitario con il governo del 1984, che portò allo scioglimento della Federazione.
La prassi unitaria successiva – instauratasi per reciproca convenienza – ha continuato ad incontrare ostacoli
determinati sia dalle profonde diversità tra le confederazioni, sia dal quadro politico, in quanto i governi
di centro-destra hanno legittimato gli accordi separati e, comunque, operato “con l’intendo di sfruttare a
proprio favore le divisioni fra le culture sindacali”.
Come già anticipato, oltre alle tre grandi confederazioni esistono altre organizzazioni sindacali
“autonome” concentrate prevalentemente nei servizi e nei trasporti: tra queste, di una certa importanza è
l’UGL (Unione generale del lavoro); altre organizzazioni sono radicate in singoli gruppi professionali, come lo
SNALS degli insegnanti di scuola secondaria. L’elevata frammentazione fa si che simili organizzazioni con
difficoltà riescano ad assurgere al ruolo di parti nel processo negoziale.
4. Le affiliazioni internazionali
Nonostante le difficoltà derivanti dal forte radicamento nelle esperienze nazionali dei sindacati dei Paesi
aderenti all’UE, nel 1973 è stata costituita la Confederazione europea dei sindacati (Ces) - cui aderiscono
le tre maggiori Confederazioni sindacali italiane – che svolge un’ intensa attività politica nei confronti degli
organi della Comunità europea,. Esistono, infine, anche organizzazioni internazionali di categoria (tra cui le
più importanti sono i Segretariati professionali internazionali).
5. L’associazionismo sindacale degli imprenditori
Dal lato degli imprenditori vi è una frammentazione maggiore delle strutture associative che, a differenza di
quelle dei lavoratori, non svolgono esclusivamente funzioni di tipo sindacale, ma anche economiche.
Se in Italia i lavoratori tendono a raggrupparsi in confederazioni di carattere generale, i datori di lavoro si
raggruppano in confederazioni che si distinguono per grandi settori economici. Le maggiori
organizzazioni degli imprenditori sono: Confindustria (per l’industria ed i servizi); Confcommercio (per il
commercio); Confagricoltura (per l’agricoltura). La legge, invece, assegna all’Aran la rappresentanza
negoziale delle Pubbliche Amministrazioni quali datrici di lavoro.
Negli stessi settori operano anche le organizzazioni concorrenti, che rappresentano in particolare le medio/
piccole e piccolissime imprese (Confapi, nell’industria; Confesercenti, nel commercio; Coldiretti,
10
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
nell’agricoltura). Altre associazioni rappresentano aziende bancarie (Abi), e ancora esistono diverse
associazioni che rappresentano le imprese cooperative e quelle artigiane (ad es., Confartigianato). In
passato, le imprese a prevalente partecipazione statale erano organizzate nell’Intersind o nell’ASAP, ma
tale organizzazione separata ha perduto ragion d’essere col processo di dismissione, da parte dello Stato, di
tali partecipazioni.
Quanto alla struttura organizzativa di queste associazioni, va sottolineata la netta prevalenza della
dimensione territoriale. In particolare, la Confindustria – fondata nel 1910 – è un’ associazione di
secondo grado, cioè una federazione di associazioni articolate per territorio e settore produttivo: le
associazioni provinciali – struttura organizzativa di base – riuniscono gli industriali di tutte le categorie
produttive operanti nell’ambito di una stessa provincia. Le associazioni provinciali costituiscono, a loro volta,
18 Confindustrie regionali; vi sono, poi, le Federazioni di settore produttivo (ad es., Federmeccanica,
Federchimica, ecc.). La struttura delle organizzazioni minori appare, compatibilmente con la loro dimensione,
simile (unità di base di carattere territoriale-intercategoriale, strutture nazionali di categoria costituenti la
confederazione).
Naturalmente, anche gli imprenditori sono organizzati a livello europeo (Business Europe, Ceep).
6. L’organizzazione sindacale non associativa
Se la forma organizzativa associativa è, storicamente, quella prevalente nel fenomeno sindacale, essa non
è però esclusiva: la rappresentanza dei lavoratori viene spesso svolta – all’interno ed all’esterno dei luoghi di
lavoro – anche da coalizioni provvisorie idonee ad esprimere una volontà collettiva. Se ciò si riscontrava
soprattutto ai primordi della storia sindacale, occorre rilevare come si sia verificato anche successivamente,
in fasi di particolare risveglio conflittuale (si pensi, in proposito, all’esperienza dei Comitati di base
(Cobas), prima che assumessero una loro stabilità organizzativa).
B. La regolamentazione giuridica
1. Sindacato e categoria professionale e la libertà di scelta tra i diversi modelli organizzativi
Comprendere le ragioni per cui ciascuna organizzazione sceglie di strutturarsi in un certo modo e di
organizzare determinati lavoratori è un’ indagine di grande rilievo, perché consente di capire quali siano gli
obiettivi dell’organizzazione osservata: ad es., un sindacato che organizzi solo i macchinisti delle ferrovie ne
dovrà promuovere gli interessi anche ove confliggenti con quelli degli addetti alle stazioni; al contrario, un
sindacato che organizzi tutti i ferrovieri dovrà rivendicare gli interessi dell’insieme di questi lavoratori.
Dal punto di vista dell’ordinamento statale, la scelta del criterio organizzativo può essere:
• eteronoma, ove sia lo Stato a determinare quali e quante fossero le categorie, nel momento in cui
riconosce un solo sindacato per ciascuna di esse (come avveniva nel sistema corporativo);
• autonoma, ove il principio di libertà sindacale fa si che i gruppi professionali che si costituiscono
in sindacato possano liberamente formarsi, fondersi, separarsi, estinguersi (come avviene oggi).
Questa soluzione comporta la possibile compresenza di più gruppi costruiti secondo criteri che si
intersecano e si sovrappongono, ponendo in essere un conflitto organizzativo (ad es., i macchinisti
delle ferrovie sono organizzati contemporaneamente dai sindacati confederali insieme agli altri
ferrovieri, e dai Cobas isolatamente). Tali conflitti, in passato sostanzialmente sconosciuti nel nostro
Paese, da termo emergono con frequenza e la questione – impossibile da risolvere sul piano
giuridico – viene risolta o dal rapporto di forza, ovvero raggiungendo un compromesso tra le
diverse posizioni.
2. La mancata attuazione dell’art. 39 Cost.
L’art. 39 Cost. dispone:
“L'organizzazione sindacale è libera (il gruppo sindacale può scegliere liberamente il proprio campo di
azione, attraverso la determinazione di quale tipo di lavoratori organizzare, cioè la categoria).
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali,
secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base
democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei
loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle
categorie alle quali il contratto si riferisce.”
11
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Questa formulazione tende evidentemente a mediare tra un orientamento che voleva salvare la struttura del
sistema corporativo e quello opposto di chi, legato all’esperienza liberale, manifestava una netta opposizione
all’intervengo pubblico nella vita sindacale. Il compromesso portò:
• da un lato, ad affermare con forza il principio della libertà sindacale;
• dall’altro, ad attribuire ai sindacati il potere di porre in essere norme generalmente vincolanti.
Tuttavia, contrariamente al principio di cui al primo comma (immediatamente precettivo), il meccanismo dei
commi 2, 3 e 4 necessitava specificazioni da parte della legge ordinaria (ad es., era necessario determinare
gli uffici competenti per la registrazione), ma il legislatore non è mai intervenuto sul punto e, di
conseguenza, queste disposizioni sono rimaste lettera morta.
Le ragioni della mancata attuazione sono di varia natura:
• timore che il procedimento di registrazione diventasse uno strumento di intromissione dello Stato
nella vita interna del sindacato;
• la CISL, in passato sensibilmente minoritaria, in un eventuale procedimento di contrattazione
fondato sulla proporzionalità della rappresentanza negoziale, avrebbe visto consacrata la posizione
di maggior forza della CGIL;
• la dottrina giuslavoristica si è progressivamente depurata dai residui corporativi che ponevano la
personalità giuridica e il contratto collettivo erga omnes come categorie necessarie;
• soprattutto, si è consolidato un sistema sindacale “di fatto” cui il legislatore rispondeva – anziché
in termini di attuazione costituzionale – con la legislazione “di sostegno”, che attuava un indiretto
riconoscimento a detto sistema.
La mancata attuazione non costituisce, dunque, un inadempimento costituzionale: il meccanismo dei
commi citt. è infatti diretto ad attribuire ai sindacati il potere di stipulare contratti collettivi con efficacia erga
omnes, e non a disciplinare in sé il soggetto sindacale. Pertanto, rientra nella discrezionalità politica del
legislatore ordinario ritenere o meno questo risultato opportuno o, quantomeno, valutare se una disciplina
eteronoma del soggetto sindacale sia o meno un prezzo troppo elevato da dover pagare a tal fine.
D’altro canto, la presenza di tali norme esplica un’ efficacia “negativa”, in quanto non consente di
pervenire ai medesimi risultati (personalità ed efficacia erga omnes) con gli strumenti ordinari del
diritto comune.
3. La scelta privatistica
La scelta di non procedere all’emanazione della legge sindacale significa che lo Stato-apparato non deve
interferire con l’attività autonoma dei gruppi. Ciò comporta, in termini giuridici, il rifiuto di soluzioni che
regolamentino l’esperienza sindacale all’interno del diritto pubblico, agganciandola saldamente ai moduli
del diritto privato.
4. L’associazione non riconosciuta
Un primo corollario di questo inquadramento del sindacato nel diritto privato è la sua qualificazione giuridica
come associazione non riconosciuta, ai sensi degli artt. 36 e ss. c.c. (almeno quando assume una
struttura associativa).
Com’è noto, l’associazione non riconosciuta qualifica fenomeni organizzativi eterogenei (circoli ricreativi e
culturali, ma anche organismi complessi e di grandi dimensioni). Si pensi che proprio due tra le formazioni
sociali più importanti – partiti e sindacati – oggi rientranti tra le associazioni non riconosciute, erano
estranei al legislatore del 1942.
La regolamentazione delle associazioni non riconosciute nel c.c. del 1942 costituì un’ innovazione
legislativa notevole: il codice del 1865 – ispirato alla codificazione napoleonica – ignorava del tutto questo
tipo di organizzazione sociale. Una delle idee centrali dei sistemi ispirati dalla Rivoluzione francese è, infatti,
la riduzione del rapporto Stato-individuo ai minimi termini: sotto tali regimi, l’attività associativa era lecita, ma
non di per sé atta ad imputare le relative responsabilità patrimoniali direttamente all’associazione, in
quanto si preferiva imputarle a tutti i singoli associati.
Cionondimeno, il fenomeno associativo acquistava un’ importanza crescente e la nuova dottrina influì sulla
disciplina dettata dal nuovo c.c. in tema di associazione non riconosciuta:
• art. 36 c.c.
“L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone
giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
12
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e
conferita la presidenza o la direzione.”
• art. 37 c.c.
“I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune
dell'associazione. Finche questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo
comune, né pretendere la quota in caso di recesso (il fondo si estingue soltanto con l’atto in cui i soci
deliberano lo scioglimento dell’associazione).”
• art. 38 c.c.
“Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro
diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le
persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.”
Come si vede, il regime di responsabilità patrimoniale occupa una posizione intermedia fra quella propria
della persona giuridica (dotata di autonomia patrimoniale perfetta) e l’imputazione a tutti i singoli soci propria
della visione atomistica della vecchia dottrina.
Da tali elementi è dato concludere che l’associazione non riconosciuta – anche se priva di personalità
giuridica – è soggetto di diritto, in quanto costituente centro autonomo di imputazioni giuridiche.
Notevoli, peraltro, sono le insufficienze della disciplina appena descritta: in seguito alle scissioni del 1948 e
del 1949 dalla CGIL, i gruppi secessionisti rivendicavano una parte del patrimonio dell’associazione, ed a
questi si opponeva che l’atto di scissione costituiva mera somma di dimissioni dei singoli componenti che,
come recedenti, non potevano avanzare alcuna pretesa di ripetizione. La questione, oggetto di transazione
stragiudiziale, non venne decisa, ma neppure in sede teorica ha trovato una soluzione soddisfacente.
5. Disciplina costituzionale e disciplina del codice civile
Lo schema descritto dev’essere integrato tenendo conto di alcuni contributi dottrinali. È stato argomentato,
infatti, che tra associazioni riconosciute e non riconosciute vi sarebbe identità di struttura e, quindi, per le
seconde troverebbero applicazione, oltre agli artt. 36-38 c.c., anche “tutte quelle norme sull’associazione
riconosciuta che non si ricolleghino al riconoscimento della personalità giuridica”. Pertanto gli accordi tra gli
associati, nonostante la lettera dell’art. 36, c.1, non sarebbero fonte esclusiva o primaria dell’ordinamento
interno e l’associazione non riconosciuta verrebbe così ad essere regolata da un complesso di norme legali,
esauriente anche sotto il profilo dell’organizzazione interna. La conseguenza di maggior rilievo sarebbe la
sottoposizione della dinamica interna dell’associazione al controllo giudiziale.
A questa impostazione – evidentemente volta ad ampliare le regole eteronome che l’associazione deve
rispettare, al fine di accentuarne la democraticità – si è obiettato il contrasto con il principio di libertà
associativa di cui all’art. 18 Cost. e, coerentemente, si è sostenuto che l’unica fonte di regolamentazione
dei rapporti interni dovrebbero rimanere gli accordi tra gli associati.
6. La disciplina delle forme organizzatorie non associative
Se, come detto, l’organizzazione sindacale può assumere una veste diversa da quella associativa, anche
in tal caso la sua regolamentazione giuridica dovrà essere reperita nelle forme organizzatorie del diritto
privato, in quanto compatibili con il principio fondamentale della libertà sindacale.
Si pensi, ad esempio, alle delegazioni occasionali di lavoratori (comitati di sciopero, comitati di base, ecc.),
investite di un mandato che si esaurisce al termine del conflitto, col conseguente scioglimento della
coalizione. Se detta coalizione, difettando dell’elemento della stabilità, non può certo rispecchiarsi in un’
associazione, sarà invece probabilmente assimilabile al comitato (artt. 39 e ss. c.c.), mentre il rapporto
con i lavoratori potrebbe ricondursi alla figura del mandato collettivo (art. 1726 c.c.). Certo è che, anche
se è assente la fattispecie associativa sindacale, in tali casi ricorre pur sempre una forma di esercizio
della libertà di organizzazione ex art. 39 Cost..
Forme di questo tipo si riscontrano anche tra i datori di lavoro (si pensi alla delegazione temporanea, ma
anche alla delegazione con mandato permanente).
In definitiva, l’organizzazione sindacale può esprimersi anche fuori dalla forma dell’associazione:
l’organizzazione non coincide con l’associazione, che ne è piuttosto una species.
7. Interessi collettivi, individuali e generali
Il sindacato è l’organizzazione di un gruppo di lavoratori e ne esprime gli interessi: per quanto questo
gruppo sia grande, non coinciderà mai con la società nel suo complesso. Dunque occorre distinguere tra:
• interesse pubblico generale (di cui è portatrice l’intera comunità);
13
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
• interesse individuale dei singoli lavoratori.
• interesse collettivo (di cui è portatore il sindacato) che, secondo Santoro Passarelli, “non è la
somma di interessi individuali, ma la loro combinazione ed è indivisibile, nel senso che viene
soddisfatto non già da più beni atti a soddisfare bisogni individuali, ma da un unico bene atto
a soddisfare il bisogno della collettività”.
Di qui, il problema del rapporto tra sindacato e non iscritti, che può essere osservato da due differenti
prospettive:
• quella del solidarismo classista – cui si ispira gran parte del movimento sindacale europeo – che
induce il sindacato ad agire in favore anche dei non-iscritti;
• quella del sindacato-istituzione che, pur privilegiando il rapporto tra l’organizzazione e gli iscritti,
risente di una spinta all’estensione degli effetti dell’azione sindacale a tutti i lavoratori, in quanto
funzionale alla difesa degli iscritti.
Due esempi potrebbero essere chiarificatori:
• ove gli imprenditori potessero praticare, nei confronti dei non iscritti al sindacato, condizioni
economiche deteriori rispetto a quelle che debbono praticare verso gli aderenti allo stesso,
preferirebbero dare occupazione ai primi anziché ai secondi;
• peraltro, limitando gli effetti della contrattazione collettiva ai soli iscritti il sindacato subirebbe una
deminutio della propria forza contrattuale, in quanto i non iscritti diserterebbero la lotta.
Per quanto detto, possiamo concludere che il sindacato ha un proprio interesse a non limitare agli
iscritti la propria azione di rappresentanza, e ciò ben spiega la sua tendenza ad allargare gli effetti della
sua azione anche ai non iscritti.
Quanto detto pare collidere col diritto privato, che è radicato su basi individualistiche. In particolare, pare
inadeguata la tradizionale costruzione del rapporto tra sindacato e lavoratori in termini di mandato con
rappresentanza, poiché una simile costruzione non è in grado di dar conto della differenza tra interesse
collettivo ed interesse individuale del lavoratore rappresentato (si pensi al sindacato che si accorda con
un imprenditore affinché questi, anziché procedere – come vorrebbe – ad un licenziamento collettivo, riduca
il numero dei lavoratori da licenziare: esso avrà promosso l’interesse collettivo, sacrificando però quello
individuale dei lavoratori che continuano ad essere soggetti al licenziamento).
L’interesse collettivo – come d’altronde quello pubblico – altro non è se non una convenzione linguistica che
designa l’esito di un processo di formazione della volontà di una pluralità di persone: anch’esso dipende da
una scelta volontaristica.
Nel linguaggio giuridico, l’espressione “interesse collettivo” viene spesso utilizzata in modo più o meno
fungibile con quella di “interesse diffuso”, nata in relazione alla tendenza ad introdurre forme di tutela di
interessi dei quali è difficile individuare il titolare (si pensi alla materia ambientale). Se utilizziamo questa
seconda espressione per designare quell’interesse o situazione giuridica che appartiene identicamente
ad una pluralità di soggetti e che ha per oggetto beni non suscettibili di appropriazione e godimento
esclusivi, possiamo vedere come i due concetti, da un lato si distinguono dall’interesse individuale e da
quello pubblico ma, dall’altro, non vanno confusi: per l’interesse collettivo – e solo per questo – è
essenziale l’appartenenza ad una o più organizzazioni che ne siano titolari.
•
CAPITOLO IV
RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE
1. Rappresentanza e rappresentatività
Come visto, al sindacato, in quanto organizzazione di lavoratori portatrice di un proprio interesse
collettivo, dev’essere riconosciuta una sfera di autonomia propria, e non derivata da quella individuale dei
singoli lavoratori. Se poi, ricordiamo che l’interesse collettivo è qualcosa di diverso dalla somma degli
interessi individuali, allora sarà evidente che è impossibile ricondurre il legame tra il sindacato ed i lavoratori
all’istituto del mandato con rappresentanza. In quest’ultimo, infatti, il rappresentante agisce in nome e
nell’interesse del rappresentato, mentre il sindacato agisce in nome proprio, perseguendo l’interesse
collettivo di cui è titolare.
Pur essendo differente dalla rappresentanza volontaria civilistica, il nesso che lega all’organizzazione
sindacale i lavoratori appartenenti al gruppo professionale è pur esso qualificato come rapporto di
rappresentanza.
14
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Diversa è la nozione di rappresentatività, definibile come capacità dell’organizzazione di unificare i
comportamenti di lavoratori, in modo che gli stessi operino non ciascuno secondo scelte proprie, ma come
gruppo. Il legislatore, per regolare alcuni aspetti della concreta dinamica delle relazioni industriali, attribuisce
le posizioni giuridiche che a tal fine vengono create non già a tutte le organizzazioni, bensì ai soli sindacati
che, dotati di un’ effettiva capacità unificatrice, siano soggetti reali di quella dinamica.
Si badi, però, che il riconoscimento della libertà sindacale ex art. 39 Cost. e la regolamentazione del
sindacato come associazione ex artt. 36 ss. c.c. operano invece in favore di tutti i sindacati.
A. La maggiore rappresentatività nello Statuto dei lavoratori
1. La ratio della selezione tra i sindacati
Nel Titolo III dello Statuto dei lavoratori, il legislatore, oltre a ribadire che i lavoratori hanno diritto di
esercitare la propria libertà sindacale anche all’interno dei luoghi di lavoro, riconosce alle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative diritti che favoriscono il rapporto tra l’organizzazione ed i
lavoratori rappresentati, nell’ottica di quella che è stata definita come legislazione di sostegno
dell’attività sindacale. A questi diritti corrispondono precise posizioni debitorie dell’imprenditore che, ad
esempio, deve porre a disposizione dei lavoratori il locale in cui esercitare il loro diritto di assemblea (art.
20). Se dunque lo scopo del legislatore del 1970 è quello di favorire l’attività sindacale all’interno dei luoghi di
lavoro e se, per far ciò, egli deve comprimere alcune posizioni dell’imprenditore, riconoscere pari diritti a
tutte le organizzazioni sarebbe, da un lato, eccessivo rispetto allo scopo (in quanto si favorirebbero
anche organizzazioni non realmente attrici del conflitto sindacale) e, dall’altro, sarebbe privo di
giustificazione il sacrificio imposto all’imprenditore.
2. I criteri di selezione
L’art. 19, nella sua formulazione originaria disponeva che:
“Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita'
produttiva, nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di
contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unita' produttiva (criterio residuale,
introdotto al fine di non escludere alcuni sindacati che, pur non essendo inquadrati nelle confederazioni
maggiormente rappresentative, hanno tuttavia un ruolo rilevante).
Nell'ambito di aziende con piu' unita' produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di
coordinamento.”
Il criterio principale, riassunto nella formula “confederazioni maggiormente rappresentative”, implica un
giudizio di rappresentatività c.d. storica, in quanto basata sul dato storico dell’effettività dell’azione
sindacale svolta dalle grandi confederazioni. Tale criterio, in quanto implicante un giudizio non formulabile
sulla base di indici quantitativi (e, dunque, misurabili), è anche indicato come il criterio della rappresentatività
presunta.
Dunque, la nozione di sindacato maggiormente rappresentativo svolge una duplice funzione:
• selezionare i sindacati effettivamente soggetti del sistema di relazioni industriali;
• favorire le forme di aggregazione sindacale più ampie, al cui interno i diversi “egoismi” di settore
trovino le proprie compensazioni.
Tuttavia, la genericità dell’espressione ha indotto dottrina e giurisprudenza ad enucleare, rispetto al testo
originario dell’art. cit., alcuni indici atti ad individuare le “confederazioni maggiormente
rappresentative”:
• consistenza del numero degli iscritti;
• equilibrata presenza in un ampio arco di settori produttivi e territori (occorre che l’organizzazione
rappresenti i lavoratori di una pluralità di categorie e di ambiti territoriali);
• svolgimento di un’ attività di autotutela effettiva, continua e sistematica.
Questi criteri hanno poi trovato un riscontro legislativo nella legge di riforma del Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro (l. 936/1986), nella quale sono stati utilizzati per individuare i sindacati che hanno
il potere di designare i rappresentanti dei lavoratori subordinati nel Consiglio stesso (“Nel ricorso le
organizzazioni sono tenute a fornire tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di
rappresentatività, con particolare riguardo all’ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative, alla
consistenza numerica, alla loro partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti [...]”).
15
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Ad ogni modo, si è assistito ad un progressivo logoramento della funzione selettiva: nell’applicare questi
criteri, la giurisprudenza ha progressivamente ricompreso anche sindacati che, pur formalmente dotati di una
struttura confederale, erano in realtà presenti solo in uno o in pochi settori del mondo del lavoro.
3. La giurisprudenza costituzionale sull’art. 19 prima del referendum del 1995
Tra le decisioni emesse dalla Corte costituzionale con riferimento alla versione oggi superata della norma,
fondamentale è la sent. 54/1974, ove si afferma con chiarezza che la selezione tra i sindacati:
• non viola l’art. 39 Cost. se non tocca la libertà sindacale, ma è funzionale all’attribuzione di diritti
o poteri aggiuntivi che vanno oltre la stessa. La funzione dell’art. 19, infatti, è quella di identificare
i soggetti titolari dei diritti previsti dal Titolo III, e non quella di limitare la libertà di costituire
rappresentanze sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, che è garantita a tutti i lavoratori e a tutte
le organizzazioni dall’art. 14, l. cit.;
• non viola l’art. 3 (che, come noto, risulta trasgredito non già in presenza di una qualsivoglia
disparità di trattamento, bensì quando la stessa non abbia giustificazione e sia irragionevole), in
quanto la scelta del legislatore di non conferire a tutti i diritti sindacali è “razionale e consapevole,
tenendo presenti gli scopi che si propone la legge n. 300 del 1970 [che] ha infatti voluto evitare che
singoli individui o piccoli gruppi isolati di lavoratori [...] possano pretendere di espletare tale funzione
[di rappresentanza aziendale] [...] e possano così dar vita ad un numero imprevedibile di organismi
[...] i quali, interferendo nella vita dell'azienda a difesa di interessi [...] anche a contrasto fra loro,
abbiano il potere di pretendere l'applicazione di norme che hanno fini assai più vasti.”
4. Il referendum del 1995
L’art. 19 è stato oggetto di due referenda abrogativi che, svoltisi l’11 Giugno 1995, hanno avuto esiti
differenti:
• il primo, che mirava ad eliminare entrambi i criteri selettivi, ha avuto esito negativo;
• il secondo, volto ad abrogare il primo criterio (eliminando l’intera lett. a)), ed a modificare il
secondo (eliminando le parole “nazionali o provinciali”), ha avuto esito positivo.
Il risultato è che il criterio selettivo della rappresentatività è oggi unico: la RSA (rappresentanza
sindacale aziendale) deve essere costituita – sempre ad iniziativa dei lavoratori – nell’ambito di un
sindacato che non deve essere necessariamente a struttura confederale, ma che abbia stipulato un
contratto collettivo applicato nell’unità produttiva, quale che sia il livello di tale contratto, compreso
quello aziendale che, in precedenza, non era sufficiente a tal fine. L’abrogazione referendaria della
qualificazione come “nazionali o provinciali” dei contratti collettivi la cui stipulazione dava tutolo alla
costituzione delle RSA ha, dunque, allargato le maglie selettive, consentendo l’accesso ai diritti del Titolo
III anche ai sindacati in grado di operare solo in un’ azienda, contrariamente al favore che il legislatore
del 1970 voleva attribuire alle forme organizzative più ampie.
Se, da un punto di vista pratico, cambia poco (dato che i sindacati che firmano contratti appartengono,
normalmente, alle confederazioni maggiormente rappresentative, la novità è nel senso che la materia passa
tutta alla competenza della contrattazione: è come dire che lo Statuto dei lavoratori promuove l’attività
contrattuale dei sindacati che hanno già stipulato il contratto; consolida, cioè, una posizione di forza
contrattuale già conseguita, ma non può promuoverla laddove manchi. Ed infatti, un sindacato confederale
che non abbia stipulato un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva interessata ora non può più
accedere ai diritti sindacali attraverso la lett. a) dell’art. 19.
Con riguardo alle conseguenze sistematiche, l’effetto più rilevante del referendum è che, nello Statuto dei
lavoratori, si passa dal criterio della maggiore rappresentatività presunta ad un criterio fondato su di
un elemento di fatto accertabile (il sindacato ha sottoscritto un contratto collettivo applicato nell’unità
produttiva in cui pretende di costituire la propria RSA) e non più su valutazioni che si prestano ad un elevato
soggettivismo.
5. La giurisprudenza costituzionale sull’art. 19 dopo il referendum
Censure di legittimità costituzionale sono state proposte anche nei confronti del testo dell’art. 19 per come
risultante in seguito al referendum. Su di esse, la Corte costituzionale si è pronunciata con sent. 244/1996.
Nelle ordinanze di rimessione, si era affermato che la nuova formulazione della norma, in sostanza, rimette il
riconoscimento della rappresentatività all’arbitrio del datore di lavoro, che è libero di accettare o meno
come controparte contrattuale il sindacato stesso: di qui, la presunta violazione sia del principio di libertà
sindacale, sia di quello di eguaglianza (per l’irragionevolezza del criterio posto).
La corte, nel respingere ambedue le eccezioni, ha affermato che, anche nella nuova formulazione, l’art.
19:
16
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
• non vìola l’art. 39 Cost., perché “le norme di sostegno dell'azione sindacale nelle unità
produttive, in quanto sopravanzano la garanzia costituzionale della libertà sindacale, ben possono
essere riservate a certi sindacati identificati mediante criteri scelti discrezionalmente nei limiti
della razionalità”;
• “non viola l'art. 3 Cost. perché, una volta riconosciuto il potere discrezionale del legislatore di
selezionare i beneficiari di quelle norme, le associazioni sindacali rappresentate nelle aziende
vengono differenziate in base a (ragionevoli) criteri prestabiliti dalla legge”.
Nell’affermare la conformità al sistema costituzionale dell’art. 19, la Corte ha precisato che tale coerenza
sussiste solo se della norma viene data un’ interpretazione rigorosa, che risponda al principio della
“rappresentatività effettiva”. A tal fine, l’interpretazione deve garantire che il meccanismo basato sulla
sottoscrizione di un contratto collettivo, anche solo aziendale, risponda al fine di misurare la consistenza
reale del sindacato e non finisca per condizionare il riconoscimento della rappresentatività alla scelta del
datore di lavoro di sottoscrivere un contratto con quello specifico sindacato. La sottoscrizione del contratto
collettivo deve essere indice della “capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro, direttamente
o attraverso la sua associazione, come controparte contrattuale”.
Da tale premessa, derivano alcuni corollari:
• “non è sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre
una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto”;
• “nemmeno è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto
normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto
importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale, di un contratto nazionale
o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva.”
Di conseguenza, la Corte ha escluso la rilevanza della sottoscrizione di un contratto gestionale (per la
relativa distinzione, v. cap VII, sez. B, par. 10).
B. Ulteriori ipotesi di rilevanza della maggiore rappresentatività
1. Le altre leggi che dispongono una selezione tra i sindacati
Prima, ma soprattutto dopo lo Statuto dei lavoratori, una nutrita serie di altre leggi ha presentato un’
esigenza di selezione tra i sindacati analoga a quella fin qui descritta. Tali leggi possono dividersi in due
categorie:
• la prima, riguarda le disposizioni che attribuiscono ad alcuni sindacati il potere di designare i
rappresentanti dei lavoratori in organi collegiali espressivi degli interessi delle parti sociali.
• L’esempio più rilevante di tale categoria è il CNEL – organo previsto alla Costituzione
repubblicana con funzioni di consulenza del Parlamento e del Governo e di iniziativa
legislativa in materia di lavoro e di economia – di cui fanno parte esperti e “rappresentanti
delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa”. Tali rappresentanti sono designati dalle Confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
• la seconda, invece, riguarda norme che riservano ai sindacati selezionati la legittimazione a
stipulare particolari tipi di contratti collettivi , ovvero contratti collettivi che producono particolari
effetti.
• L’esempio più rilevante della seconda categoria è la regolamentazione della contrattazione
collettiva delle Pubbliche Amministrazioni (artt. 40 e ss., d. lgs. 165/2001), perché risrva
in via esclusiva ai sindacati maggiormente rappresentativi la legittimazione a negoziare
in rappresentanza dei dipendenti pubblici. In questo caso, però, la maggiore
rappresentatività – a differenza di tutte le altre ipotesi trattate in questo par. – viene fatta
discendere da indici misurabili (v. par. succ.).
In definitiva, con la rilevante eccezione della contrattazione collettiva delle Pubbliche Amministrazioni, nelle
altre ipotesi qui considerate i sindacati che possono designare propri rappresentanti in organi collegiali o che
sono legittimati a stipulare contratti collettivi che producono particolari effetti sono indicati con la generica
espressione di sindacati “maggiormente rappresentativi” o, più di recente, con quella sostanzialmente
equivalente di “comparativamente più rappresentativi”. In tali casi, occorre dunque fare ricorso agli indici
presuntivi elaborati dalla giurisprudenza sull’art. 19 dello Statuto dei lavoratori, nel testo previgente al
referendum. Infatti, l’attenuazione del filtro selettivo conseguente al referendum del 1995 fu voluta e
vale per la finalità specifica perseguita dall’art. 19 – e, cioè, per l’individuazione dei titolari, in azienda,
dei diritti sindacali riconosciuti dal Titolo III – e non può estendersi alle altre ipotesi qui considerate.
PARAGRAFO SUCCESSIVO FOTO
2. La rappresentatività ponderata nel settore pubblico
17
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Per i rapporti di lavoro alle dipendenze dello Stato e degli altri enti pubblici, la riforma degli anni Novanta (v.
cap. IX) ha introdotto, come accennato, una disciplina compiuta della rappresentatività sindacale, che
occorre esaminare analiticamente.
Va preliminarmente segnalato che, nella regolamentazione giuridica delle relazioni sindacali nelle Pubbliche
Amministrazioni, la nozione di sindacato maggiormente rappresentativo non assolve solo alla funzione
di selezionare i soggetti titolari dei diritti sindacali (come avviene nello Statuto dei lavoratori), ma quella – ben
più pregnante – di individuare i sindacati abilitati all’attività di contrattazione collettiva nazionale. Nel
settore privato, al contrario, la selezione dei soggetti ammessi al tavolo della trattativa contrattuale non è
giuridicamente regolata, essendo piuttosto affidata ai rapporti di forza.
L’art. 43, d. lgs. 165/2001 dispone che:
“1. L'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, è un'agenzia italiana
che rappresenta legalmente la pubblica amministrazione italiana nella contrattazione collettiva nazionale)
ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o
nell'area una rappresentativita' non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato
associativo e il dato elettorale. Il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il
versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate (a tutti i sindacati) nell'ambito
considerato. Il dato elettorale e' espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle
rappresentanze unitarie del personale (v. cap. V, par. 5), rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito
considerato.
[…]
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che
definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche
amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o
due aree contrattuali; siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.”
Come può facilmente rilevarsi, con questa disciplina la rappresentatività è determinata non più sulla base
di indici discrezionalmente valutati, bensì viene misurata sulla base di dati numerici accertabili e che
devono essere accertati secondo una procedura espressamente regolata dai commi 7 e ss. dello stesso art.
cit..
Alleva osserva giustamente che questa disciplina realizza un’ inversione del flusso di legittimazione:
• se nell’art. 19, lett. a) (oggi abrogata) la rappresentatività era individuata al livello confederale
dell’organizzazione sindacale e si rifletteva sui livelli organizzativi inferiori (procedendo, così,
dall’alto verso il basso);
• l’art. 43 dispone che la rappresentatività di ciascuna organizzazione venga misurata dal consenso
effettivo da questa goduto tra i lavoratori nei luoghi di lavoro, per poi riflettersi nella
legittimazione negoziale a livello nazionale. E ciò vale anche per le confederazioni, la cui
legittimazione deriva – come visto – da quella ottenuta a livello di comparto (e, quindi, dal consenso
espresso dai lavoratori tramite i meccanismi sopra descritti) dai sindacati ad esse affiliati.
Il legislatore del 1997, dunque:
• da un lato, sembra aver fatto propria la proposta di individuare una soglia minima di
rappresentatività, varcata la quale ciascun soggetto sindacale si ritrova in posizione di eguaglianza
con gli altri che abbiano, parimenti, superato quella soglia;
• dall’altro, ha accolto la soluzione opposta, consistente nel proporzionare i diritti al grado di
rappresentatività:
• in primo luogo, l’ARAN (cap. IX, par. 7), non può sottoscrivere i contratti nazionali se non
acquisisce il consenso di organizzazioni sindacali che rappresentino almeno il 51% dei
lavoratori – calcolato come media tra dato associativo e dato elettorale – oppure il 60% -
calcolando il solo dato elettorale (art. 43, c. 3);
• inoltre, le organizzazioni sindacali godono di permessi, aspettative e distacchi sindacali per i
propri dirigenti in proporzione alla propria rappresentatività, sempre misurata attraverso la
media tra dato associativo ed elettorale (art. 47-bis, c. 6).
Insomma, in questo settore si è realizzato il superamento completo del criterio della rappresentatività
presunta, a favore di un sistema legale di misurazione della rappresentatività.
C. La crisi della maggiore rappresentatività presunta
1. Maggiore rappresentatività presunta o ponderata
La complessa vicenda trattata in questo capitolo spazia dunque tra due poli:
18
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
• da un lato, la legge ha l’esigenza di non affidare certi diritti e poteri a tutti i sindacati, ma solo a quelli
che dimostrino la propria capacità di essere effettivamente rappresentativi.
Su questo punto, la Corte cost. fin dalla sent. 54/1974 ha riconosciuto la legittimità costituzionale di
una selezione tra i soggetti sindacali, a patto che:
a. si tratti di diritti e poteri che vadano oltre la libertà sindacale (spettante a tutti i sindacati);
b. la selezione tra i soggetti sindacali sia giustificata e risponda a criteri ragionevoli.
• dall’altro, i criteri di selezione – con l’eccezione dei sindacati dei dipendenti delle PA – rimangono
ancorati ad indici generici di maggiore rappresentatività, che attribuiscono un’ ampia discrezionalità
all’interprete (maggiore rappresentatività presunta).
La crisi di questo metodo di selezione dei soggetti sindacali è stata denunciata almeno dalla seconda metà
degli anni Ottanta, quando le trasformazioni del processo produttivo (v. cap. I, par. 8) e il superamento del
modello tayloristico hanno segmentato la forza lavoro in gruppi d’interesse diversi. Ciò ha reso più difficile la
sintesi organizzativa tradizionalmente operata dalle grandi confederazioni ed ha consentito la nascita di
organizzazioni sindacali autonome, svincolate da legami di solidarietà col resto del mondo del lavoro.
In questo contesto, come ha rilevato la Corte cost. in sent. 30/1990, “è andata progressivamente
attenuandosi l'idoneità del modello disegnato nell'art. 19 a rispecchiare l'effettività della
rappresentatività”. La stessa sentenza ammonisce il legislatore: “l’ apprestamento di nuove regole - ispirate
alla valorizzazione dell'effettivo consenso come metro di democrazia anche nell'ambito dei rapporti tra
lavoratori e sindacato - è ormai necessario per garantire una più piena attuazione, in materia, dei principi
costituzionali.” La Corte, dunque, richiedeva il superamento del criterio della rappresentatività
presunta, che doveva essere, piuttosto, “verificata”.
E tuttavia, nonostante il monito della Corte, il dibattito politico sull’introduzione, anche nel settore privato, di
criteri certi e misurabili non ha dato luogo, sinora, ad una disciplina della materia (salvo, appunto, che
per le amministrazioni pubbliche).
CAPITOLO V
LA RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO
1. L’organizzazione sindacale sui luoghi di lavoro
I lavoratori si organizzano, a fini di autotutela dei propri interessi, sia fuori dei luoghi di lavoro, sia all’interno
di questi. La comparazione tra le diverse esperienze storiche mostra che la RAPPRESENTANZA DEI
LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO può essere:
• a canale doppio, caso in cui, nella stessa azienda coesistono due organismi:
• uno elettivo, di rappresentanza generale (di tutti i lavoratori, indipendentemente
dall’iscrizione al sindacato), avente funzione di consultazione e partecipazione;
• l’altro associativo, che riproduce all’interno dei luoghi di lavoro la struttura di
rappresentanza a base volontaria propria dei sindacati esterni e che, storicamente, ha il
potere negoziale.
• a canale unico, in cui la struttura di rappresentanza è sindacale/associativa sia all’interno, sia
all’esterno dei luoghi di lavoro, e cumula tutte le funzioni.
L’esperienza italiana è caratterizzata da una sintesi dei due modelli, essendo prevalse nel tempo forme di
rappresentanza uniche ed elettive, ma che hanno mantenuto un forte collegamento con le associazioni
sindacali esterne.
2. Le Commissioni interne, le sezioni sindacali aziendali, i delegati ed i Consigli di fabbrica
Fin dai primissimi anni del secolo, la risposta all’esigenza di un’ adeguata organizzazione interna all’azienda
fu la creazione di un canale separato da quello dei sindacati: se questi ultimi si davano la struttura
associativa (e, cioè, di organizzazioni stabili ad adesione volontaria), gli organi che stiamo per analizzare
hanno assunto, il più delle volte, la forma di una struttura elettiva di rappresentanza di tutti i lavoratori
occupati nell’impresa, indipendentemente dalla loro iscrizione ad una delle associazioni sindacali esterne.
L’espressione più antica di questa forma di rappresentanza è costituita dalle COMMISSIONI INTERNE (CI),
che furono per la prima volta regolate (nel 1906) in un accordo sindacale tra la FIOM ( federazione italiana
operai metallurgici) e la fabbrica di automobili Itala. Esse furono:
• soppresse durante il periodo fascista;
• ripristinate dopo la caduta del regime, con un accordo che attribuiva ad esse la funzione di
negoziare i contratti collettivi a livello aziendale;
19
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
• regolate, dopo la Liberazione, da un accordo interconfederale (v. cap VIII, par. 2) del 1947, che
sottrasse a tali strutture ogni potere contrattuale, riconoscendogli mere funzioni di controllo
sull’applicazione di alcune discipline collettive e di composizione delle controversie (aziendali,
individuali e collettive).
La ragione di questa sostanziale riduzione dei poteri delle CI dipese, in larga parte, dalle modalità della loro
composizione (erano elette a suffragio universale e con voto di preferenza, su liste presentate da
qualsiasi gruppo di lavoratori o associazione sindacale; i seggi erano ripartiti proporzionalmente).
Insomma:
• la CI era una struttura di rappresentanza unitaria distinta dai sindacati e, come tale, poco
coordinabile rispetto alle loro politiche;
• la composizione della CI non rispecchiava la differenziazione degli interessi dei lavoratori
(poiché le elezioni si svolgevano a collegio elettorale unico, corrispondente all’intera unità
produttiva).
Per questo duplice ordine di ragioni, le CI sono state poi progressivamente sostituite dalle nuove forme
di rappresentanza costituite spontaneamente dai lavoratori nel ciclo delle lotte sindacali del 1968-69.
Prima che ciò avvenisse, peraltro, numerosi tentativi furono compiuti – soprattutto calla CISL – per costituire
nei luoghi di lavoro SEZIONI SINDACALI AZIENDALI (SAS) che, a differenza delle CI, erano un’
articolazione interna alle aziende del sindacato esterno, del quale riproducevano il pluralismo, la struttura
associativa ed il fondamento volontario della rappresentanza. Ove si fossero diffuse, affiancandosi alle
CI, si sarebbe realizzato in Italia il sistema di rappresentanza a canale doppio; in concreto; in effetti, la sua
diffusione concreta si limitò a poche imprese delle categorie industriali più sindacalizzate.
Nel corso degli anni 1968-69 si verificò un radicale mutamento nella struttura organizzativa del movimento
sindacale italiano, a seguito della nascita e della rapida affermazione di nuove strutture di rappresentanza
dei lavoratori all’interno delle imprese. Il DELEGATO era eletto direttamente da tutti i lavoratori
appartenenti ad uno stesso “gruppo omogeneo” (i lavoratori di uno stesso reparto, di uno stesso ufficio,
ecc.), senza alcun vincolo di designazione da parte dei sindacati esterni (non era neppure prescritto
che il delegato fosse iscritto al sindacato). L’ insieme di tutti i delegati di una certa unità produttiva
costituiva il CONSIGLIO DI FABBRICA. Le tre maggiori confederazioni nel 1972 strinsero un patto
federativo e riconobbero questi organismi come la propria struttura di base all’interno dei luoghi di
lavoro, attribuendo ad essi “poteri di contrattazione sui posti di lavoro”. Tali strutture di rappresentanza
erano, dunque, unitarie come le CI, ma più articolate rispetto ad esse, dalle quali si differenziavano,
peraltro, per l’esistenza di un legame organizzativo politico col sindacato esterno. Si noti poi che questa
forma di rappresentanza – elettiva e, contemporaneamente, associativa (in quanto riconosciuta dai sindacati
come propria struttura di base) – non è riconducibile interamente né al modello del doppio canale, né a
quello del canale unico, costituendo, piuttosto, un compromesso tra i due.
3. Le RSA dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori
Le forme di rappresentanza descritte nel paragrafo precedente si sono formate in assenza di
regolamentazione legislativa. Il primo intervento in materia è stato realizzato nel 1970 con lo Statuto dei
lavoratori, con cui il legislatore, però, non intende regolare la rappresentanza dei lavoratori, bensì sostiene
la presenza nei luoghi di lavoro dell’organizzazione sindacale e la sua attività, lasciando liberi lavoratori e
sindacati di scegliere la forma organizzativa che preferiscono. Ed infatti, l’art. 19 si limita ad identificare le
rappresentanze sindacali aziendali titolari dei diritti sindacali disciplinati dagli artt. 20 ss., ma rinunzia a
prescrivere una forma organizzativa determinata, perché:
• nel 1970 continuavano ad operare le vecchie CI, mentre in altre stavano nascendo Delegati e
Consigli; in un simile contesto, la scelta per l’una o per l’altra struttura sarebbe potuta entrare in
conflitto con la realtà (così depotenziando l’effettività della legge);
• lo Statuto è una legge di sostegno all’azione sindacale, non di regolamentazione di essa.
Ad ogni modo, ex art. 19 i requisiti per la costituzione di RSA sono due:
• che essa avvenga “ad iniziativa dei lavoratori”;
• che operi “nell’ambito” delle associazioni sindacali che soddisfino i criteri di rappresentatività indicati
nella stessa norma. È dunque necessario un collegamento tra RSA e sindacato, ma nulla dice la
norma sulla natura o sulle modalità di tale collegamento: ciò che conta è che ci sia, in sostanza, una
sorta di “riconoscimento” da parte del sindacato esterno.
Si noti come la scelta contenuta nell’art. 19 di non regolare né la struttura della RSA, né il tipo di
collegamento con il sindacato esterno, ha conferito alla norma un’ elasticità tale da consentire di identificare
nelle RSA:
20
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
• sia forme di rappresentanza che, all’interno del luogo di lavoro, erano diretta emanazione del
sindacato esterno;
• sia le strutture elettive ed unitarie (come i Consigli di fabbrica) che erano costituite “ad iniziativa
dei lavoratori” ed operavano, in forza del patto federativo del 1972, “nell’ambito” di CGIL, CISL e
UIS;
• non vi è alcuna difficoltà a riconoscere che le attuali rappresentanze sindacali unitarie (delle quali si
parlerà in seguito) sono rappresentanze sindacali aziendali ex art. 19 e, perciò, titolari dei diritti
sindacali di cui al Titolo III dello Statuto.
Insomma, le RSA dell’art. 19 sono una fattispecie che il legislatore ha voluto lasciare aperta al fine di
applicare il precetto normativo (il godimento dei diritti sindacali del Titolo III), quale che sia la forma
organizzativa attribuita alla rappresentanza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
4. La crisi dei Consigli e le rappresentanze sindacali unitarie nel settore privato
I Consigli di fabbrica sono entrati in crisi nel corso degli anni Ottanta, in primo luogo a causa della rottura del
patto federativo (1984). Intervennero, tuttavia, anche cause strutturali: il superamento del taylorismo:
• spostò progressivamente l’asse del sistema produttivo, da un lato verso settori nei quali i Consigli
erano stati un fenomeno passivo (come nei servizi) e, dall’altro, verso le piccole e piccolissime
imprese, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 19;
• eliminò – con i processi di automazione – anche all’interno dell’azienda medio-grande l’elevata
omogeneità preesistente, creando alcune figure professionali che stentavano a riconoscersi in
questa forma di rappresentanza sindacale.
La formula dei Consigli di fabbrica o dei delegati conteneva in sé un arduo compromesso tra l’idea del
sindacato-organizzazione (rappresentativo degli iscritti) e quella del sindacato-movimento (rappresentativo di
tutti i lavoratori). Quando i Consigli entrarono in crisi, la difficoltà di trovare una soluzione che componesse
queste diverse istanze rallentò la riforma della rappresentanza. Dopo vari tentativi, la mediazione è stata
realizzata con le RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU), previste dal Protocollo tra Governo
e parti sociali (1993) e poi analiticamente regolate da un accordo stipulato tra le maggiori
confederazioni e la Confindustria (fine del 1993).
Tale accordo prevede che le organizzazioni sindacali firmatarie – e quelle che vi abbiano successivamente
aderito – acquistino il diritto, nelle unità produttive che abbiano più di 15 dipendenti, di promuovere la
formazione delle RSU e di partecipare alle relative elezioni, rinunziando a costituire proprie RSA. Di
conseguenza, la RSU subentra alle RSA di tutti i sindacati che hanno stipulato l’accordo, o che vi
abbiano successivamente aderito, “nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali” ex Titolo III
dello Statuto, nonché “nella titolarità dei poteri e dell’esercizio delle funzioni” attribuite dalla legge.
D’altro canto, è un accordo centralizzato (interconfederale) a prevedere questo scambio tra la possibilità di
costituire la RSU e di partecipare alle relative elezioni, da un lato, e, all’altro, di rinunziare a costituire la
propria RSA, e dunque un sindacato firmatario può revocare il proprio riconoscimento della RSU in un
determinato luogo di lavoro e costituire una propria RSA solo dando disdetta dell’intero accordo
interconfederale, così precludendosi la possibilità di partecipare alle elezioni della RSU in tutti gli altri
luoghi di lavoro. In tal modo, non può riprodursi quanto è accaduto per i Consigli dei delegati ai quali, in
caso di conflitto, un sindacato esterno ben poteva revocare il riconoscimento per poi costituire la propria RSA
in uno stabilimento industriale, mantenendo la partecipazione ai Consigli in tutti gli altri.
Per evitare che la formazione della RSU dipenda dalla previsione che ciascuna organizzazione sindacale fa
di un esito favorevole delle elezioni, l’accordo stabilisce che l’iniziativa per la costituzione delle RSU o per
il loro rinnovo possa esser presa, anche disgiuntamente:
• dalla RSU di cui sta per scadere il mandato;
• da ciascuna delle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo del 1993 e dell’accordo
interconfederale;
• dalle associazioni firmatarie del contratto collettivo nazionale applicato nell’unità produttiva;
• dalle altre associazioni sindacali che, formalmente costituite con un proprio statuto ed atto
costitutivo, raccolgano un numero di firme non inferiore al 5% dei lavoratori aventi diritto al voto.
Negli ultimi due casi, i sindacati debbono aderire formalmente all’accordo sulle RSU.
A queste condizioni, dunque, l’accordo è aperto all’adesione successiva di sindacati diversi da quelli
affiliati alle Confederazioni inizialmente sottoscrittrici; rimangono esclusi, invece, i gruppi occasionali di
lavoratori: a presentare le liste devono essere associazioni sindacali formalmente costituite, con un proprio
statuto ed atto costitutivo. Ciò, al fine di evitare che le elezioni per le RSU siano l’occasioni per regolare
eventuali dissidi interni alle organizzazioni stesse (il gruppo dissenziente di un sindacato, infatti, per poter
presentare una propria lista deve formalizzare la propria uscita dallo stesso attraverso la costituzione di una
diversa associazione sindacale, e prestare formale adesione all’accordo interconfederale.
21
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Si badi, tuttavia, che le associazioni sindacali non hanno rinunziato del tutto a strumenti di controllo e
raccordo:
• il primo risiede nella composizione della RSU:
• 2/3 dei seggi sono ripartiti tra tutte le liste regolarmente presentate, in proporzione ai voti
conseguiti;
• sul restante 1/3 concorrono – sempre in proporzione al numero dei voti – le sole liste
presentate dai sindacati firmatari del contratto collettivo nazionale applicato nell’unità
produttiva.
A tal proposito, la giurisprudenza ha affermato che il componente di RSU che, eletto nella lista di un
sindacato, successivamente ne esca, non decade dalla carica (in tal modo, viene indebolito il
controllo che il sindacato può esercitare sugli eletti nella propria lista);
• il secondo è costituito dal riconoscimento del potere di contrattare a livello aziendale
congiuntamente alle RSU ed alle strutture territoriali dei sindacati firmatari del ccnl;
• infine, i sindacati firmatari del ccnl riservano a se stessi una parte dei diritti sindacali, al fine di
poter continuare ad operare in azienda direttamente, e non solo attraverso gli eletti alla RSU nelle
proprie liste.
Dunque, anche le RSU sono un compromesso tra canale doppio ed unico di rappresentanza, ma si
differenziano dai Consigli per la più accentuata presenza delle organizzazioni sindacali.
Nell’accordo interconfederale, infine, vi sono alcune norme dirette a garantire l’effettiva rappresentatività
dell’organismo:
• le elezioni – a suffragio universale – sono valide se si realizza il quorum del 50% degli elettori;
• la durata del mandato è rigidamente determinata in tre anni, senza possibilità di proroghe.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie nelle Pubbliche Amministrazioni
L’impegno a costituire in tutti i luoghi di lavoro le rappresentanze sindacali unitarie, contenuto nel Protocollo
del 1993, si estendeva anche al lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione. In questo settore,
però, la materia è stata successivamente regolata dall’art. 42, d. lgs. 165/2001 (preliminarmente, va
precisato che, nonostante la legge definisca questi organismi come “rappresentanze unitarie del personale”,
la prassi le ha denominate “rappresentanze sindacali unitarie” – RSU – sottolineandone l’affinità con il
parallelo istituto del settore privato).
I primi due commi dell’art. cit. dispongono che:
“1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta' e l'attivita' sindacale sono tutelate nelle forme previste
dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni ed integrazioni (con
l’importante differenza, già segnalata sopra, che alcuni diritti sindacali sono attribuiti ai diversi sindacati in
proporzione al grado di rappresentatività: v. cap. IV, sez. B, par. 2) […].
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa [che abbia almeno 15 dipendenti], le
organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentativita', le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della
medesima legge n.300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dal contratti collettivi.”
Viene così riconosciuto ai sindacati maggiormente rappresentativi del settore pubblico – così qualificati
secondo le precipue regole di tale settore ex art. 43, d. lgs. 165/2001: v., ancora, cap. IV – il diritto a
costituire proprie RSA.
Il comma 3 aggiunge che “In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa [che abbia almeno
15 dipendenti], ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresi'
costituito, con le modalita' di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del
personale mediante elezioni alle quali e' garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.”
La combinazione dei due precetti implica che ciascun sindacato ha facoltà – non l’obbligo – di partecipare
alle elezioni delle RSU (ovvero di rinunciarvi), mantenendo il diritto di costituire la propria RSA e di
godere, così, direttamente dei relativi diritti sindacali. Poiché – come visto, solo i sindacati maggiormente
22
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
rappresentativi (cioè quelli che abbiano almeno il 5% del consenso, misurato come media tra il dato
associativo e quello elettorale) sono ammessi alle trattative per i contratti nazionali, il sindacato che per
sua scelta non partecipi alle elezioni, per esser ammesso a tali trattative dovrà avere una percentuale
di iscritti pari almeno al 10% (ove non realizzi questo indice, ex art. 42, c. 2, non potrà neppure costituire
una propria RSA, né potrà godere dei diritti sindacali).
Le differenze tra le discipline delle RSU vigenti, rispettivamente, nel settore pubblico e in quello privato sono
significative:
• in primo luogo, la fonte delle prime è nella legge e non in un contratto;
• inoltre, la previsione legale del metodo proporzionale (art. 42, c. 4) è incompatibile con la riserva di
1/3 dei seggi alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale (tutti i seggi, dunque,
devono essere ripartiti tra le liste concorrenti in proporzione al numero dei voti ottenuto);
• inoltre:
• se nel settore privato le liste elettorali debbono essere sottoscritte, almeno dal 5% degli
elettori, solo se presentate da sindacati non firmatari del contratto nazionale (ma che
abbiano aderito all’accordo sulle RSU),
• nel settore pubblico la sottoscrizione è richiesta per tutte le liste, senza distinzione tra
sindacati stipulanti e non, ed è fissata in misura notevolmente inferiore (3% o 2%, a
seconda del numero dei dipendenti);
• ancora:
• mentre l’ambito di costituzione delle RSU nel settore privato è limitato alle imprese o alle
unità produttive con più di 15 dipendenti,
• in quello pubblico gli organismi di rappresentanza sono eletti nelle amministrazioni con
più di quindici dipendenti ed, inoltre, in tutte le strutture periferiche che siano sede di
contrattazione integrativa, secondo le previsioni dei contratti nazionali;
Infine, la legge rinvia ai contratti nazionali la determinazione della titolarità per la contrattazione
integrativa: e, sul punto, anche l’Accordo quadro costituzione RSU comparti 7 agosto 1998 ha disposto la
legittimazione congiunta della RSU e dei sindacati firmatari del contratto nazionale di comparto.
Sempre lo stesso Accordo dispone che le decisioni relative all’attività negoziale siano assunte dalla RSU e
dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale, secondo i criteri previsti dal
contratto stesso.
Il risultato è che tanto nel settore pubblico, quanto in quello privato, la reale ampiezza della legittimazione
a contrattare è affidata al contratto nazionale di comparto o di categoria.
6. La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese
L’art. 46 Cost. dispone che “ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei
limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”.
Il riferimento storico che il Costituente aveva presente era l’esperienza dei Consigli di gestione che,
durante la guerra di Liberazione e nel periodo immediatamente successivo, formati da rappresentanti dei
lavoratori, sostituirono o affiancarono gli imprenditori nella gestione delle grandi imprese.
Venuto meno il riferimento ad un’ esperienza concreta, è mancata la legge ordinaria prevista dalla norma
costituzionale (le proposte avanzate non hanno mai avuto l’effettivo appoggio delle forze sociali, non avendo
mai incontrato, da un lato, il consenso degli imprenditori e, dall’altro, neppure quello della CGIL, che temeva
un coinvolgimento dei lavoratori nelle responsabilità gestionali senza reali posizioni di potere).
Il dibattito in materia, pur in assenza di una legge ordinaria che dia esplicita e diretta attuazione alla norma
costituzionale, ha sofferto spesso di pregiudizi ideologici: è frequente, infatti, la contrapposizione tra due
opposte visioni della dialettica tra imprenditori e lavoratori:
• una, conflittuale, troverebbe espressione nell’organizzazione sindacale, nella contrattazione
collettiva, e nello sciopero;
• un’ altra, partecipativa, nella creazione di organismi misti, composti da rappresentanti delle due
parti, che assumerebbero le proprie decisioni alla luce dell’interesse al funzionamento dell’impresa.
In realtà, l’attività d’impresa, coinvolgendo anche l’interesse dei lavoratori, è un fenomeno sociale e non
un mero affare privato dell’imprenditore. L’art. 46 Cost.:
• impone che l’ordinamento attribuisca rilevanza all’interesse dei lavoratori per le decisioni
d’impresa e riconosca loro il diritto di influire su di esse;
23
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
• nulla dice sull’intensità di detta influenza, né sugli strumenti idonei ad esercitare questo diritto
(ciò può infatti avvenire tanto attraverso la creazione di organi di cogestione – sull’esempio tedesco
– quanto attraverso la contrattazione collettiva).
Avendo riguardo alle materie oggetto della partecipazione, possiamo distinguere tra:
• partecipazione “debole”, limitata alle questioni attinenti all’organizzazione del lavoro;
• partecipazione “forte”, che riguarda anche le strategie aziendali (investimenti, trasformazioni,
ecc)
Un significato diverso a questa distinzione arriva dall’esperienza tedesca, giusta la quale:
• la partecipazione debole è quella in cui il dissenso dei rappresentanti dei lavoratori non impedisce al
management di assumere la decisione;
• nella partecipazione forte, invece, avviene il contrario.
Avendo, poi, riguardo agli strumenti attraverso cui la partecipazione si realizza, distinguiamo tra:
• partecipazione “disgiuntiva”, che si realizza attraverso l’attività negoziale dell’organizzazione
sindacale;
• partecipazione “integrativa”, che si realizza con l’inclusione di rappresentanti dei lavoratori in
organi della società.
Il silenzio della norma costituzionale sugli strumenti per realizzare la partecipazione è la lettura più congrua
con il principio di libertà sindacale ex art. 39 Cost.: il fine della partecipazione dei lavoratori alle decisioni
d’impresa può essere realizzato attraverso una pluralità di strumenti, e la scelta di quale di essi sia più
opportuno in ogni momento storicamente dato deve essere affidata ai lavoratori stessi. Né può essere
invocato, per sostenere il contrario, il rinvio alla legge contenuto nello stesso art. 46: con esso, il Costituente
non riserva alla fonte legislativa la disciplina della materia, escludendo gli altri strumenti normativi, bensì fa
obbligo al legislatore ordinario di intervenire, garantendo la presenza della dialettica sindacale anche sui
luoghi di lavoro e, con questa, la possibilità che gli interessi dei lavoratori siano considerati nei processi
decisionali d’impresa.
Insomma, l’art. 46 dev’essere letto non in alternativa, ma in sintonia con il pluralismo conflittuale che emerge
nelle altre norme costituzionali (artt. 39 e 40): la partecipazione dei lavoratori può realizzarsi attraverso
l’azione contrattuale del sindacato. Ciò non esclude che, da un lato, sia proprio quest’ultima a disporre la
costituzione di organismi bilaterali con competenze e poteri contrattualmente definiti sulla materia in
discorso e, dall’altro, che sia la legge a prevedere simili organismi: per non creare una contrapposizione
tra gli artt. 46 e 39 Cost., è sufficiente che simili organismi non costituiscano un limite alla
contrattazione collettiva.
Non possono, invece, essere ricondotte alla norma costituzionale le tecniche manageriali che tendono a
corresponsabilizzare i lavoratori nella realizzazione delle finalità aziendali attraverso la partecipazione
economica (partecipazioni agli utili, elementi della retribuzione legati agli obiettivi aziendali, ecc.): tali forme
di retribuzione non comportano, in se, alcun potere di partecipare alle decisioni relative
all’individuazione degli obiettivi da realizzare e dei relativi strumenti, mentre la norma costituzionale fa
chiaramente riferimento proprio ai processi decisionali.
Alla categoria della partecipazione meramente economica debbono essere ascritti anche i sistemi di
partecipazione azionaria: essi devono essere esclusi dall’art. 46 Cost., poiché vi coesistono due distinti
rapporti – di lavoro e societario – che si mantengono distinti nella regolamentazione giuridica, anche se il
secondo origina dal primo (infatti, i diritti di partecipazione che spettano al lavoratore-azionista sono quelli
che il diritto societario attribuisce ad un qualunque azionista). Del resto, la normativa in materia di
intermediazione finanziaria si caratterizza per un’ accentuata individualizzazione dei diritti di partecipazione
degli azionisti alle decisioni sociali: insomma, è proprio l’ispirazione di fondo di questa normativa a costituire
un grave ostacolo ad un uso dei diritti di partecipazione degli azionisti a tutela degli interessi dei lavoratori,
laddove le due vesti giuridiche vengono a coincidere nelle stesse persone fisiche.
7. I comitati aziendali europei ed i diritti di informazione nella normativa comunitaria
Il concetto che l’impresa non sia un fatto privato dell’imprenditore, ma un fenomeno sociale, è proprio anche
dell’ordinamento comunitario: anche in esso, il concetto è svolto garantendo diritti di informazione e di
consultazione che consentano alle rappresentanze dei lavoratori di influenzare le decisioni d’impresa, ma
senza imporre che tali rappresentanze assumano una forma o l’altra.
24
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Vengono in rilievo, in materia, tre direttive:
• 94/45/CE, oggi rifusa nella 2009/38/CE, avente ad oggetto il diritto di informazione e di
consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese a dimensioni comunitarie
La definizione di impresa e di gruppo d’imprese a dimensione comunitaria è data nell’art. 2 della direttiva,
sulla base di due parametri: il numero complessivo dei lavoratori occupati nei diversi Stati dell’Unione
(almeno 1000), ed una presenza significativa in più di uno Stato membro (almeno 150).
In queste imprese o gruppi di imprese deve essere istituito un comitato aziendale europeo (CAE),
attraverso un accordo scritto tra la direzione ed una delegazione speciale di negoziazione, i cui componenti
possono essere eletti dai lavoratori o designati. Se la soluzione preferita dal legislatore comunitario è quella
della costituzione del CAE, la stessa non è obbligatoria: le parti, infatti, possono prevedere, in via
alternativa, “una o più procedure per l’informazione e la consultazione”.
L’Italia, dando attuazione a tale direttiva con il d. lgs. 74/2002, dispone che i componenti italiani del CAE
(ovvero i titolari della procedura di informazione e consultazione alternativa) siano designati per 1/3 dalle
organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale applicato nell’impresa e, per
2/3, dalle RSU.
• 2001/86/CE, posta a completamento della disciplina di diritto societario contenuta nel Reg.
2157/2001
L’Unione ha infatti ritenuto necessario prevedere la costituzione ed il funzionamento di società di capitale
disciplinate direttamente dal diritto comunitario.
Il “coinvolgimento dei lavoratori” viene definito – dall’art. 2 della direttiva – come “qualsiasi
meccanismo, ivi comprese l’informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i
rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un’ influenza sulle decisioni che devono essere
adottate nell’ambito della società”. Le sue modalità concrete sono affidate ad un accordo da raggiungere
tra gli organi societari e, in rappresentanza dei lavoratori, una delegazione speciale di negoziazione (sulla
falsariga della direttiva sui CAE).
• 2002/14/CE
Se le prime due direttive hanno, come visto, come campo di applicazione particolari tipi di imprese
(rispettivamente, le imprese o i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie e le imprese esercitate dalla
Società Europea), la direttiva in esame ha, invece, una portata generale, e si applica a tutte le imprese o
stabilimenti situati nella Comunità. La direttiva ha esplicitamente l’obiettivo di porre un quadro generale di
prescrizioni minime riguardo il diritto all’informazione ed alla consultazione dei lavoratori occupati in
queste imprese. Il compito di determinare le modalità di esercizio di questo diritto è affidato agli Stati
membri.
Il nostro Paese ha dato attuazione a questa direttiva con il d. lgs. 25/2007, attribuendo la titolarità dei diritti di
informazione e di consultazione alle RSU e rinviando ai contratti collettivi la determinazione delle modalità di
esercizio.
Dall’ampiezza dello spettro delle possibili forme che possono servire a realizzare il c.d. “coinvolgimento dei
lavoratori”, devono ricavarsi due osservazioni:
• la prima, di carattere storico, riguarda la difficoltà di armonizzare legislazioni e prassi nazionali
tra loro differenti: la soluzione è stata quella di dettare una normativa comunitaria aperta a
soluzioni tra loro molto diverse, sostanzialmente corrispondente all’intero arco delle soluzioni che
l’esperienza storico-comparata ha fin qui offerto;
• la seconda, di carattere funzionale, rileva che la normativa comunitaria pone in primo piano la
necessità che i lavoratori siano “coinvolti” nelle decisioni d’impresa: l’intensità e gli strumenti
di tale coinvolgimento sono affidati all’autonomia delle parti (soluzione, questa, coerente con
l’interpretazione dell’art. 46 Cost. fornita nel paragrafo precedente).
8. Il rappresentante per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza – oggi disciplinato dal d. lgs. 81/2008 – a differenza delle altre forme di
rappresentanza descritte in questo capitolo, svolge la sua azione non solo in favore dei lavoratori
subordinati, ma nei confronti di tutti coloro che sono definiti “lavoratori” (tutte le persone che,
indipendentemente dalla forma contrattuale utilizzata, svolgono un’ attività lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, anche senza retribuzione).
La rappresentanza per la sicurezza dev’essere istituita a livello territoriale o di comparto, aziendale, di
sito produttivo. Giusta l’art. 47, d. lgs. cit.:
“2. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
25
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno […]
4. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di
tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.”
La norma determina altresì il numero minimo di rappresentanti in relazione al numero dei lavoratori,
precisando che tale numero può essere incrementato dalla contrattazione collettiva.
Più interessante è la figura del rappresentante per la sicurezza di sito produttivo: è oggi frequente che
operino nello stesso luogo una pluralità d’imprese, ciascuna con i propri lavoratori e, di conseguenza, il
decreto prevede che in tali ipotesi, quando si presentino alcuni requisiti di complessità, i rappresentanti
aziendali individuino uno di loro per coordinare le proprie attività.
Questi rappresentanti devono ricevere un’ adeguata formazione, hanno diritto a permessi retribuiti ed ai
mezzi necessari per l’esercizio delle proprie funzioni, possono accedere liberamente ai luoghi di lavoro,
hanno diritto di accedere ai documenti utili per controllare l’esatta applicazione delle regole di sicurezza e
l’efficienza del sistema di prevenzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi, ecc..
Le modalità per l’esercizio di queste funzioni e prerogative sono determinate dalla contrattazione
collettiva nazionale: l’esclusione di quella aziendale è, evidentemente, dovuta al rischio che, in questa
sede, un rapporto di forza favorevole al datore di lavoro possa pregiudicare la realizzazione di un’efficace
rappresentanza.
CAPITOLO VI
L’ATTIVITA’ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO
A. I diritti sindacali
1. Lo Statuto dei lavoratori come legislazione di sostegno
Se gli artt. 14-17 impongono all’imprenditore un obbligo di rispetto della sfera di libertà di autodeterminarsi,
propria dei lavoratori e del sindacato, quest’obbligo negativo può non essere sufficiente: anche a prescindere
da comportamenti dell’imprenditore volti a impedire o condizionare l’attività sindacale, vi possono essere
molteplici “ostacoli di ordine economico e sociale” che impediscono l’azione sindacale o la sua efficacia. In
considerazione di ciò, il legislatore dello Statuto non si è limitato – con le norme del Titolo II – a vietare
all’imprenditore di interferire nella sfera di libertà sindacale, ma – con le norme del Titolo III – ha
predisposto misure di sostegno all’attività sindacale, ispirandosi al modello dell’auxiliary legislation,
sperimentato per la prima volta negli Stati Uniti e, precisamente, nella legislazione sindacale del New Deal.
Tali misure, non definiscono solo uno spazio di autodeterminazione del soggetto titolare della libertà ed un
divieto per tutti gli altri di interferirvi, ma danno vita, in capo al soggetto tutelato, a pretese configurabili
come diritti nei confronti degli imprenditore , sul quale gravano gli obblighi corrispondenti (ad es.,
esercitando il diritto di assemblea, il sindacato produce l’effetto giuridico di sospendere l’obbligazione di
lavorare che grava sul lavoratore, pur nella permanenza – nel limite di 10 ore annue – dell’obbligazione
retributiva).
In altre parole, con queste norme:
• non solo si riconosce che i soggetti del conflitto industriale debbono essere liberi di
esprimere e perseguire i loro interessi;
• ma, onde porre il soggetto più debole (i lavoratori) in condizioni di essere effettivamente partecipe
del conflitto industriale, vengono apprestate misure di sostegno.
D’altro canto, però, poiché si tratta di tutelare gli interessi coinvolti nella concretezza del conflitto, queste
misure di sostegno non sono garantite a tutti i sindacati, ma solo a quelli effettivamente in grado di
essere parti reali in esso (lo strumento utilizzato è, come visto, quello di attribuire tali diritti a RSA costituite
sì ad iniziativa dei lavoratori, ma nell’ambito dei sindacati selezionati sulla base dei criteri ex art. 19, St. lav.).
2. L’assemblea
26
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
La riunione costituisce uno dei modi di esercizio della libertà di pensiero di cui all’art. 1, St. lav.. Tuttavia
essa, nella forma dell’assemblea, ha ricevuto una disciplina specifica in quanto il suo svolgimento implica
la collaborazione del datore di lavoro (che deve mettere a disposizione quanto è necessario affinché
l’assemblea possa svolgersi: il locale, l’accesso ad esso, l’illuminazione, ecc.). Questi deve, tra l’altro,
consentire l’accesso in azienda ai lavoratori sospesi e collocati in Cassa integrazione o ai lavoratori in
sciopero. Da ciò è derivata l’esigenza di circoscrivere il diritto di assemblea alle riunioni qualificate dalla loro
pertinenza con la condizione di lavoro: una riunione di altra natura (a scopo politico, ricreativo, ecc.)
dovrebbe ritenersi legittima ex art. 1, St. lav. – purché non turbi il normale svolgimento dell’attività produttiva
– ma non godrebbe, però, della copertura e delle agevolazioni previste per le riunioni di cui all’art. 20.
L’art. 20, infatti, dispone:
“I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unita' produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario
di lavoro, nonche' durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verra' corrisposta
la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.”
Come si vede, le assemblee si svolgono, di regola, fuori dall’orario di lavoro; tuttavia, esse possono aver
luogo anche durante lo stesso, per cui ciascun lavoratore ha dieci ore annue retribuite da poter utilizzare in
assemblee (e solo in esse).
Per impedire un uso poco responsabile del diritto di assemblea, la norma prevede che:
“Le riunioni - che possono riguardare la generalita' dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette,
singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unita' produttiva, con
ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle
convocazioni, comunicate al datore di lavoro.”
Il legislatore ha escluso la possibilità di assemblee convocate da organismi diversi dalle RSA
individuate dall’art. 19, però – come già segnalato (v. cap. V, par. 4) – la disciplina delle RSU prevede che
anche le organizzazioni sindacali – e non solo le RSU stesse, che sono la forma assunta dalle RSA dei
sindacati che vi aderiscano – possono convocare assemblee retribuite (nel settore privato, tale diritto è
limitato a tre ore annue; nel settore pubblico non vi è invece una simile precisazione, ma rimane fermo il
limite di dieci ore retribuite annue di assemblea spettanti a ciascun dipendente).
Un altro limite è costituito dal fatto che le riunioni devono essere indette “con ordine del giorno su materie
di interesse sindacale e del lavoro”: gli argomenti da discutere in assemblea, però, non devono
necessariamente inerire ai problemi particolari del sindacato nell’azienda, ben potendo essere tutti quelli che
il sindacato assume come materia propria in rapporto ai propri fini istituzionali; possono inoltre essere
problemi di carattere anche più generale, riconducibili al comune denominatore “del lavoro”.
L’art. 20 aggiunge che:
“Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato
che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.”
Il datore di lavoro non ha, invece, diritto di partecipare all’assemblea (salvo, naturalmente, che vi sia
invitato).
Se deve escludersi che l’esercizio del diritto di assemblea sia condizionato alla salvaguardia del normale
svolgimento dell’attività aziendale, vi è però, nell’ultimo comma dell’art. 20, uno spazio per la considerazione
dell’interesse dell’imprenditore:
“Ulteriori modalita' per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti
collettivi di lavoro, anche aziendali.”
Parallelamente, il periodo finale del primo comma prevede che “Migliori condizioni possono essere
stabilite dalla contrattazione collettiva”.
Dal coordinamento tra queste norme deve concludersi che la contrattazione non può derogare in pejus la
norma legale sui punti della fruibilità concreta del diritto; può, invece, dettare modalità dirette a rendere
meno oneroso per l’imprenditore l’esercizio del diritto da parte dei lavoratori, purché esse non
incidano sul nucleo inderogabile (ad es., introducendo un obbligo di preavviso, o l’impegno a non
convocare assemblee in certi giorni della settimana).
La contrattazione può, altresì, introdurre limitazioni dirette a contemperare l’esercizio del diritto
d’assemblea con i diritti degli utenti costituzionalmente garantiti, e in questo senso ha disposto
l’accordo 7/08/1998 sui diritti sindacali nel settore pubblico, che consente all’amministrazione di differire
l’assemblea quando ricorrano “condizioni eccezionali e motivate”, purché tale differimento sia
comunicato almeno 48 ore prima, e che debba essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili
anche durante l’assemblea.
27
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
3. Il referendum
L’art. 21, St. lav., pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di consentire lo svolgimento di referendum:
“Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro
(nonostante ciò, esso coinvolge la necessaria collaborazione dell’imprenditore per la disponibilità dei locali,
l’accesso ad essi, ecc.), di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attivita'
sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori (il legislatore,
conformemente alla sua ispirazione in favore dell’unità sindacale, ha voluto evitare che potessero sorgere
nelle singole RSA tentazioni di ricorrere isolatamente alla consultazione della base, per servirsene come
strumento di rivalità e di sfida), con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unita'
produttiva e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalita' per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro
anche aziendali.”
4. I permessi sindacali VEDI FOTO
Al fine di agevolare le RSA nello svolgimento dell’attività sindacale, il legislatore ha riconosciuto ai dirigenti di
esse il diritto a permessi – retribuiti e non – per svolgere attività sindacale: il diritto, cioè, di assentarsi dal
lavoro per tale motivo, entro limiti stabiliti dalla legge nella loro misura minima.
Gli artt. 23 e 24, infatti, prevedono che un determinato numero di “dirigenti” delle RSA – variabile in
relazione alla consistenza numerica del gruppo professionale di cui la RSA è espressione nell’unità
produttiva – abbia diritto a permessi, retribuiti e non, per un dato numero di ore per ciascuna RSA
regolarmente costituiva (e non complessivo, da dividere tra le RSA).
Dirigenti delle RSA debbono essere considerati coloro che sono stati nominati secondo le procedure
previste dallo statuto dell’organizzazione, a patto che, per produrre gli effetti voluti dalle norme, tale
nomina sia comunicata al datore di lavoro o altrimenti conosciuta dallo stesso (art. 1334 c.c.: "Gli atti
unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono
destinati"; art. 1335 c.c.: "La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una
determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se
questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia").
La contrattazione collettiva, dal canto suo, ha spesso regolato la materia in modo parzialmente diverso,
prevedendo la fruizione dei permessi anche da parte di altri soggetti: in tali casi, viene fissato un monte
ore di permessi, dal quale possono attingere i componenti di RSA ed RSU, ma anche – ad esempio – i
lavoratori chiamati ad affiancare le rappresentanze nell’esercizio dei loro compiti. Tale disciplina contrattuale
deve, evidentemente, considerarsi legittima, in quanto costituisce un trattamento di miglior favore rispetto a
quello legale.
Distinguiamo:
• diritto a permessi retribuiti (art. 23), riconosciuto ai dirigenti “per l’espletamento del loro
mandato” e, cioè, per lo svolgimento delle attività proprie delle RSA (ad es., partecipazione a
trattative nei confronti della controparte a livello aziendale). Il lavoratore che intenda esercitare tale
diritto deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro – di regola 24 ore prima – tramite la RSA
(al fine di consentire al datore di lavoro di sostituirlo);
• permessi non retribuiti (art. 24), riconosciuto “per la partecipazione a trattative sindacali o a
congressi e convegni di natura sindacale”; in altri termini, per la partecipazione ad ogni attività
sindacale di carattere extra-aziendale. Anche per l’esercizio di tale diritto, la norma prevede che si
dia comunicazione scritta al datore di lavoro – di regola 3 giorni prima – tramite le RSA.
Nella prassi, la scelta tra i due tipi di permessi è operata dalla RSA richiedente (che potrà sempre
affermare, ad es., che la partecipazione del proprio dirigente a trattative sindacali nazionali avviene su
mandato della RSA stessa, così riconducendo all’art. 23 un’ ipotesi che rientrerebbe nell’art. 24). Del resto, la
giurisprudenza ha negato al datore di lavoro la possibilità sia di sindacare l’uso dei permessi, sia di
subordinarne il godimento alle esigenze aziendali.
Inoltre, in forza dell’art. 30, “I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di
cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la
partecipazione alle riunioni degli organi suddetti”. Il rinvio alla contrattazione collettiva ha posto delicati
problemi che hanno trovato equilibrate soluzioni giurisprudenziali: così, la Cassazione ha precisato che
spetta al giudice determinare la quantità di questi permessi ed un congruo preavviso, in forza dei principi di
28
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
correttezza (art. 1175 c.c.) e di equità (art. 1374 c.c.), eventualmente utilizzando come parametri gli usi e, in
analogia, la disciplina degli artt. 23 e 24 St. lav.. E’ stato anche ammesso un controllo per la loro effettiva
utilizzazione ai fini previsti dalla norma. Il diritto ai permessi è potestativo, ed il suo esercizio da parte del
lavoratore determina la sospensione dell’obbligazione di lavoro, fermo restando – se ne è il caso – il diritto
alla controprestazione retributiva, mentre il godimento di esso non può essere subordinato – neanche
dalla contrattazione collettiva – alle esigenze aziendali.
Infine, giusta l’art. 31, i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali nazionali o provinciali possono
essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita, per la durata del mandato (il rapporto di lavoro,
dunque, viene sospeso ed essi possono riprendere il posto quando cessano dalla carica ricoperta). È da
segnalare che, a differenza degli altri diritti a sospensioni precedentemente esaminati, questa norma è di
applicazione generale, e non limitata ai dirigenti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative ex art. 19.
Per connessione, deve ricordarsi che gli artt. 31 e 32 riconoscono rispettivamente il diritto all’aspettativa ed
ai permessi anche ai lavoratori subordinati che ricoprono determinate cariche politiche.
I periodi trascorsi in aspettativa sindacale o per incarichi politici ed i permessi per le medesime cause sono
utili ai fini previdenziali.
5. Le tutele per i dirigenti sindacali
Se la condizione essenziale di libertà nello svolgimento dell’attività sindacale è un’ adeguata tutela per i
soggetti più attivi, maggiormente esposti a ritorsioni, allora è stata prevista per i dirigenti delle RSA
(ricordiamo, coloro che sono stati nominati secondo le regole interne dell’organizzazione e la cui nomina sia
stata comunicata all’imprenditore o, comunque, dallo stesso conosciuta) una protezione specifica avverso:
• licenziamenti, ex art. 18 (cc. 7, 8 e 9), che prevede una particolare procedura cautelare,
esperibile durante il corso del giudizio, per ottenere l’immediata reintegrazione nel posto di
lavoro del dirigente di RSA che sia stato licenziato, senza dover attendere la sentenza definitiva di
merito. Nella pratica, comunque, in tali ipotesi è molto più frequente il ricorso alla tutela ex art. 28 St.
lav. (v. infra, sez. B);
• trasferimenti arbitrari, ex art. 22:
“Il trasferimento dall'unita' produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui
al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna puo' essere disposto
solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.”
Si badi che non sono rilevanti, ai fini della necessità del nulla osta, i trasferimenti interni alla stessa
unità produttiva, poiché l’interesse tutelato non è quello individuale del lavoratore, bensì quello
collettivo della RSA a non vedere allontanato il proprio dirigente dai lavoratori rappresentati (è
comunque illegittimo – e reprimibile ex art. 28 St. lav. – il trasferimento, anche se interno all’unità
produttiva, che abbia carattere discriminatorio, in forza dell’art. 15 St. lav.. La giurisprudenza ha di
recente affermato che la tutela in oggetto spetta ai dirigenti della RSA, e non ad altri dirigenti
sindacali.
La norma prosegue, al c. 2, disponendo che:
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo
dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui e' stata eletta la
commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine
dell'anno successivo a quello in cui e' cessato l'incarico [di dirigente].”
La legge tace sul numero dei lavoratori che possono utilizzare queste tutele, ma l’opinione prevalente è
che sia quello stabilito nell’art. 23 per i permessi retribuiti.
6. Diritto di affissione e diritto all’uso di locali
L’art. 25 dispone che:
“Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro
ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unita' produttiva,
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro (in realtà,
qualsiasi argomento può essere considerato di interesse sindacale se il sindacato lo assume come tale e, di
conseguenza, il datore di lavoro non può esercitare alcun controllo in merito).”
Come visto, la norma non riconosce all’imprenditore alcun potere preventivo di autorizzazione
all’affissione, così come è da escludere che lo stesso abbia il potere di rimuovere testi che siano stati affissi
29
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
dalle RSA. Nel caso limite in cui essi integrino estremi di reato, occorre chiedere la rimozione ai
responsabili delle RSA o ricorrere all’autorità giudiziaria.
La responsabilità per il contenuto delle affissioni grava, infatti, sulle persone che agiscono per conto
delle RSA e ciò, naturalmente, comporta che la provenienza delle affissioni debba essere identificabile.
La politica di sostegno dell’attività sindacale all’interno dell’azienda ha trovato espressione anche nel
riconoscimento alle RSA del diritto all’utilizzazione di un locale, ex art. 27, che detta una disciplina
differente in base a criteri dimensionali:
“Il datore di lavoro nelle unita' produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a
disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale
comune all'interno della unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unita' produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali
hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.”
7. La libertà di proselitismo e i contributi sindacali
Come naturale corollario del diritto di libera manifestazione del pensiero ex art. 1 e di quello di libertà
sindacale ex art. 14, l’art. 26 dispone che:
“I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo (propaganda,
iscrizioni, ecc.) per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del
normale svolgimento dell'attivita' aziendale.”
Può dirsi che l’esercizio del diritto in discorso non sospende l’obbligazione lavorativa (come avviene per il
diritto di assemblea), e che i poteri che il contratto di lavoro attribuisce all’imprenditore non possono essere
utilizzati per impedire od ostacolare l’esercizio dell’attività di proselitismo. Si noti come il diritto al proselitismo
ed alla raccolta di contributi sono riconosciuti a tutti i lavoratori.
Riguardo ai contributi sindacali – obbligazione liberamente assunta con l’iscrizione al sindacato – se essi,
nel primo periodo di vita democratica, venivano riscossi mediante versamento diretto da parte del lavoratore
al sindacato prescelto (attraverso i c.d. collettori d’azienda), vennero poi raccolti per mezzo di una ritenuta
sul salario, operata dall’imprenditore e da questi versata all’organizzazione indicata dal lavoratore in un’
apposita delega. Come visto, il primo comma della norma in esame accomuna all’attività di proselitismo la
raccolta di contributi per le organizzazioni sindacali. Il secondo e il terzo domma, invece, codificavano in
legge le clausole dei contratti collettivi che prevedevano l’obbligo dei datori di lavoro di trattenere, dalla busta
paga dei lavoratori che rilasciassero apposita delega, il contributo sindacale e di versarlo all’organizzazione
scelta dal lavoratore stesso. Queste norme sono state abrogate da un referendum del 1995, la cui portata
pratica è stata in verità scarsa:
• se l’azienda applica un contratto collettivo che regola la materia, allora il suo obbligo troverà
nel contratto stesso la sua fonte;
• nel caso di inesistenza di un contratto collettivo, invece, la delega rilasciata dal lavoratore dovrà
essere ricostruita come:
• delegazione di pagamento
• cessione del credito, e solo qui – a differenza dell’ipotesi di cui sopra – il debitore ceduto (il
datore di lavoro, debitore della retribuzione) non deve prestare il suo consenso.
Le SS.UU. hanno affermato che il lavoratore ben può procedere alla cessione di una parte
del proprio credito retributivo in favore del sindacato, per adempiere al proprio debito nei
confronti di quest’ultimo; il datore di lavoro potrà dunque opporsi alla cessione solo se
dimostri che l’operazione sia per lui eccessivamente gravosa e contraria alla buona fede.
8. Il campo di applicazione del Titolo III dello Statuto
Come già visto, sussiste una profonda differenza tra le norme appartenenti:
• al Titolo II, che si risolvono nel divieto per l’imprenditore di interferire nell’esercizio della libertà
sindacale;
• in quanto tali, godono dell’ambito di applicazione generale proprio dell’art. 39 Cost.;
• al Titolo III, che impongono allo stesso comportamenti positivi per rendere effettiva l’attività
sindacale;
• in quanto tali, la sfera di applicazione è determinata da valutazioni di opportunità
compiute dal legislatore.
Coerentemente con quanto detto, l’art. 35 dispone che:
30
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
“Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma
dell'articolo 27 (e dell’art 26, che è di applicazione generale), della presente legge si applicano a ciascuna
sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa piu' di quindici dipendenti. Le stesse
disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano piu' di cinque dipendenti (per queste ultime,
il limite è riferito all’intera impresa, e non all’unità produttiva).
Le norme suddette si applicano, altresi', alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso
comune occupano piu' di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale
occupano piu' di cinque dipendenti anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non
raggiunge tali limiti.”
Come si vede, il legislatore ha individuato il campo di applicazione delle norme del Titolo III facendo
riferimento non già all’impresa, bensì alla nozione di unità produttiva, identificata dalla giurisprudenza con
l’articolazione dell’impresa dotata di autonomia organizzativa e funzionale. Fondandosi su questo
elemento e su una critica al concetto di autonomia utilizzato dalla giurisprudenza, in dottrina è stato proposto
di interpretare la norma nel senso che i diritti sindacali non esercitabili nell’unità produttiva con meno di 16
dipendenti possano essere esercitati aggregandola con altre articolazioni organizzative dell’impresa, fino al
raggiungimento del limite.
Il riferimento alle dimensioni dell’unità produttiva, anziché a quelle dell’impresa unitariamente considerata, è
stato ritenuto dalla Corte Cost. il frutto di una scelta politica ragionevole e, come tale, non sindacabile
(l’esistenza in una data unità produttiva di un certo numero di dipendenti – come condizione perché in essa
possano esercitarsi i diritti del Titolo III – sarebbe giustificata dalla necessità che il gruppo di lavoratori sia
dotato di un minimo di consistenza; ancora, i diritti del Titolo III presuppongono una distinzione tra
rappresentanti e rappresentati che non può aversi in unità organizzative minime). Ad ogni modo, nel comma
2, accanto al criterio sopra riportato, l’art. 35 fa riferimento anche ad un dato territoriale.
Se l’art. 35 fa riferimento alle unità produttive delle imprese, si è ritenuto che esso implicitamente escluda
che le disposizioni del Titolo III trovino applicazione ai datori di lavoro non imprenditori, e tale
esclusione è stata considerata legittima dalla Corte Cost., che ha ravvisato la giustificazione della disparità di
trattamento nella minore consistenza organizzativa delle organizzazioni non imprenditoriali, e nel fatto che
molte di esse, dirette a perseguire fini ideologici, sarebbero inidonee a subire antagonismi conflittuali interni.
9. I diritti sindacali nel pubblico impiego
Per i dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici, l’art. 2, c. 2, d. lgs. 165/2001 ha affermato che “i
rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati [...] dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa” e tra esse, pertanto, dallo Statuto dei lavoratori.
Coerentemente a ciò, gli artt. 42, c. 1 e 51, c. 2 esplicitamente dispongono che, anche nelle Pubbliche
Amministrazioni, la libertà e l’attività sindacale siano regolate secondo le disposizioni della l. 300/1970. Anzi,
l’art. 51 dispone che l’applicazione di questa legge non è soggetta alle limitazioni derivanti dal numero
dei dipendenti esaminate nel paragrafo precedente.
Ciò, però, non toglie che anche in questa materia vi siano importanti differenze rispetto al settore privato:
• se nel settore privato i diritti sindacali spettano alle diverse RSA in misura paritaria;
• nel settore pubblico i diritti ai permessi previsti dagli artt. 23, 24 e 30 dello Statuto sono determinati
nella loro misura complessiva e ripartiti in proporzione al grado di rappresentatività di ciascuno
dei diversi sindacati (si tratta di una conseguenza del passaggio dalla maggiore rappresentatività
presunta a quella ponderata che, come visto, è stata compiutamente realizzata solo nelle
amministrazioni pubbliche);
Altrettanto avviene per i distacchi sindacali, un istituto tipico dell’impiego pubblico: il lavoratore dipendente
della Pubblica Amministrazione, che ricopra una carica sindacale, può essere collocato in aspettativa
retribuita per la durata del mandato (la differenza con le aspettative ex art. 31, St. lav. è, appunto, nella
permanenza o meno dell’obbligazione retributiva (ne consegue che i primi sono quantitativamente limitati).
Inoltre, si noti che nelle Pubbliche Amministrazioni – oltre alle RSU ed alle RSA dei sindacati che non
abbiano aderito ad esse – operano anche dei “terminali di tipo associativo” delle associazioni sindacali
che partecipano alle RSU, la cui forma organizzativa è, ovviamente, determinata liberamente dallo Statuto di
ciascuna associazione.
B. La repressione della condotta antisindacale
1. L’art. 28 dello Statuto
31
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
L’art. 28 dello Statuto, intitolato alla repressione della condotta antisindacale, è atto a rendere effettivi il
principio di libertà sindacale e tutte le posizioni giuridiche attive dei prestatori di lavoro esaminate in
precedenza. Difatti, se la mera esistenza di una norma non è elemento sufficiente affinché il dato reali si
adegui ad essa, il mutevole equilibrio dei rapporti di forza condiziona la stessa effettività delle norme di
condotta ove le stesse non sia assistite da un adeguato apparato di norme secondarie, sanzionatorie e
processuali. I lavoratori ben possono far ricorso all’autotutela per realizzare l’effettività della norme, ma si
tratta pur sempre di una forma di difesa dall’esito incerto e dai costi elevati. Di conseguenza, il legislatore
dello Statuto ha predisposto un particolare strumento giudiziario ed una particolare strumentazione
sanzionatoria.
2. Le regole processuali
Stando ai primi tre commi dell’art. cit., il procedimento si svolge in due fasi, la seconda delle quali è
meramente eventuale:
“Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della
liberta' e della attivita' sindacale nonche' del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle
associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, [il giudice del lavoro del Tribunale] del luogo ove e'
posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte
sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore
di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento
illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere revocata fino alla sentenza con cui il [giudice del lavoro]
definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso e' ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle
parti, opposizione davanti [allo stesso giudice] che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si
osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.”
Con l’opposizione, si apre la seconda fase, nella quale il procedimento si trasforma in un giudizio ordinario –
regolato, come qualsiasi altro processo del lavoro, ex artt. 409 ss. c.p.c. – che si concluderà con una
sentenza, contro la quale potrà essere proposto appello e ricorso per Cassazione.
3. La condotta antisindacale
La condotta antisindacale può esser posta in essere direttamente dal datore di lavoro ovvero dai
soggetti che svolgono attività a lui imputabile (ad es., il direttore generale, i dirigenti, ecc.): ciò che conta
è che il soggetto agente eserciti i poteri del datore di lavoro.
Come visto, la norma fornisce una definizione teleologica della condotta antisindacale (“comportamenti
diretti ad impedire o limitare l'esercizio della liberta' e della attivita' sindacale nonche' del diritto di
sciopero), che individua il comportamento illegittimo non già in base a sue caratteristiche strutturali, bensì
alla sua idoneità a ledere i beni protetti. Non ebbe dunque seguito l’interpretazione restrittiva giusta la quale
la norma sarebbe utilizzabile solo ove la lesione colpisca un interesse esclusivo del sindacato, prevalendo,
piuttosto, l’idea per cui il ricorso all’art. 28 non sia impedito dalla circostanza che il comportamento del datore
di lavoro leda un interesse individuale, che già abbia una propria tutela giudiziaria. Insomma, la facoltà dei
singoli lavoratori di agire in giudizio per le vie ordinarie a tutela del proprio interesse non esclude
che, contro lo stesso comportamento, agisca il sindacato ex art. 28. Si è parlato, a proposito, di
plurioffensività del comportamento, nel senso che questo è idoneo ad incidete, nello stesso momento,
sull’interesse individuale e su quello collettivo, ambedue protetti (seppur da norme differenti); nulla
esclude, dunque, che il sindacato agisca autonomamente per la difesa di quest’ultimo.
La qualificazione di antisindacalità dev’esser riferita all’attività di autotutela organizzata dei lavoratori: è
essa ad esser tutelata, e non ogni e qualsiasi interesse di questo polo del conflitto. È dunque illecito il
comportamento dell’imprenditore teso ad opporsi al conflitto (licenziare o trasferire i militanti sindacali,
negare l’assemblea, ecc.), non già ogni opposizione ai lavoratori che si muova nel conflitto (respingere
le richieste di aumenti salariali, rifiutare la trattativa, ecc.). Ad esser tutelato non è, infatti, l’interesse dei
lavoratori a maggiori salari ed a migliori condizioni di lavoro, ma l’interesse ad organizzarsi e ad agire
collettivamente per perseguirlo.
Una delle questioni più dibattute è quella inerente l’elemento costitutivo della fattispecie della condotta
antisindacale:
• un risalente orientamento lo rinveniva nello specifico intento lesivo dei beni protetti del datore di
lavoro;
• altra giurisprudenza, speculare a quella di cui sopra, non riteneva necessario tale intento;
32
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
• altra ancora, intermedia tra le due, lo ritiene necessario solo quando la condotta sia atipica, ma
non quando sia in violazione di un diritto sindacale riconosciuto dall’ordinamento.
Le Sezioni Unite hanno risolto il conflitto in senso negativo, ritenendo che elemento costitutivo della
fattispecie della condotta antisindacale non sia uno specifico intendo lesivo dei beni protetti del datore di
lavoro.
Si noti che, in alcuni casi, l’antisindacalità di specifici comportamenti è espressamente prevista da norme di
legge (ad es., nel disciplinare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, il legislatore ha esplicitamente
affermato che costituisce condotta antisindacale ex art. 28 la violazione delle clausole concernenti diritti ed
attività sindacali contenute negli accordi e nei contratti collettivi che disciplinano il rapporto di lavoro nei
servizi essenziali).
4. La legittimazione attiva
Se la giurisprudenza aveva, in precedenza, negato al sindacato il diritto di azione a tutela degli interessi
collettivi, argomentando che dopo la caduta dell’ordinamento corporativo il sindacato non aveva più la
rappresentanza legale della categoria, oggi legittimato alla proposizione dell’azione è il sindacato. Il
legislatore precisa che tale legittimazione spetta agli “organismi locali delle associazioni sindacali
nazionali”, ossia quelli cui lo statuto dell’organizzazione attribuisca la cura degli interessi locali. Ne sono
esclusi, pertanto, da un lato i singoli lavoratori e, dall’altro, le forme di organizzazione dell’autotutela dei
lavoratori che non abbiano una “rappresentatività” nazionale.
Come si vede, il criterio di selezione è notevolmente diverso da quello ex art. 19: ai fino dell’art. 28 è
sufficiente che si tratti di un’ “associazione sindacale nazionale”: non vi è alcuna necessità che essa abbia
stipulato un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva. Non è stata accolta la tesi che riconduceva –
sia pure parzialmente – i criteri di selezione dell’art. 28 a quelli dell’art. 19, escludendo dalla legittimazione
attiva le organizzazioni rappresentative degli interessi di un’ unica categoria di lavoratori.
Il limite alla legittimazione attiva ha posto delicati problemi di legittimità costituzionale:
• il primo attiene all’esclusione dei singoli lavoratori dalla legittimazione attiva che, stando alle
ordinanze di remissione, violerebbe il diritto, spettante a tutti, di agire in giudizio a tutela delle proprie
posizioni giuridiche attive (art. 24 Cost.).
• la Corte ha rilevato come l’art. 28 dello Statuto non si sostituisce, ma si aggiunge agli
ordinari strumenti processuali: pertanto, ogni singolo lavoratore, se anche la sua posizione
individuale sia lesa dal comportamento antisindacale dell’imprenditore, può ricorrere ad essi.
• Il secondo attiene all’esclusione dei gruppi non aventi una struttura associativa nazionale, al
cui proposito la Corte ha rilevato che:
• rispetto all’art. 24 Cost., il sindacato non legittimato ex art. 28 può avvalersi degli ordinari
strumenti di tutela giudiziaria, con ciò riconoscendo la legittimazione generale del sindacato
a promuovere la tutela giurisdizionale dell’interesse collettivo di cui sia portatore; l’art. 28,
pertanto, offre ai sindacati uno strumento di tutela ulteriore, senza nulla sottrarre alle altre
organizzazioni;
• la Corte ha anche escluso ogni contrasto con l’art. 39 Cost.: la limitazione della
legittimazione attiva non incide sulla libertà di organizzazione sindacale se, come visto,
rimane ferma la possibilità per tutti i sindacati di ricorrere all’ordinaria tutela giurisdizionale di
questa libertà (e, comunque, il requisito della struttura associativa nazionale è aperto, nel
senso che è realizzabile da tutte le organizzazioni;
• rispetto all’art. 3 Cost., effettivamente, la norma realizza una disparità di trattamento tra i
diversi soggetti collettivi. Per valutarne la legittimità la Corte ha rilevato che l’art. 28 sarebbe
uno strumento pericoloso in mano a sindacati che, per vivere ed operare solo in una certa
zona geografica o, peggio, in un’ impresa, non diano affidamento di un suo uso
responsabile: è perciò ragionevole privilegiare organizzazioni individuate in base ad un
criterio di effettività della capacità rappresentativa.
5. L’interesse ad agire
A prima vista, con la locuzione “associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse”, l’art. 28 sembra
far riferimento ad un interesse qualificato. Questa tesi, però, è stata respinta, poiché non è da escludere che
un sindacato abbia interesse a far rimuovere un comportamento antisindacale che riguardi lavoratori non
aderenti o, anche, aderenti ad un altro sindacato. In altri termini, l’interesse tutelato ex art. 28 non è solo
quello alla propria libertà sindacale, bensì quello alla libertà di tutti i lavoratori e di tutti i sindacati.
La carenza di interesse risulterà, pertanto, di rara ricorrenza (si pensi all’ipotesi di azione contro
comportamenti lesivi della libertà o attività sindacale nei confronti di soggetti estranei al gruppo professionale
proprio del sindacato ricorrente).
33
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
6. L’apparato sanzionatorio
Il giudice che ritenga fondata l’azione promossa dal sindacato “ordina al datore di lavoro […] la cessazione
del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti”. In questa fase, insomma, il legislatore mira solo al
ripristino dello status quo ante, senza ulteriori conseguenze afflittivo-sanzionatorie per il datore di lavoro.
Sennonché il legislatore ha introdotto un sistema di coazione indiretta e, cioè, un meccanismo idoneo a
costringere il condannato ad adeguarsi all’ordine del giudice: “Il datore di lavoro che non ottempera al
decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione e' punito ai sensi
dell'articolo 650 del codice penale”. Peraltro, “l'autorita' giudiziaria ordina la pubblicazione della
sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale”. Si badi che reato è la
mancata ottemperanza all’ordine del giudice di cessazione del comportamento antisindacale e di rimozione
dei suoi effetti, non già il comportamento in sé.
Più di recente è stata aggiunta un’ ulteriore sanzione: l’art. 7, c.7, l. 388/2000 dispone la revoca delle
agevolazioni fiscali di incentivazione di nuova occupazione a danno del datore di lavoro condannato, con
provvedimento definitivo, per condotta antisindacale.
7. La condotta antisindacale delle Pubbliche Amministrazioni
L’art. 63, c.3, d. lgs. 165/2001 ha espressamente devoluto al giudice ordinario del lavoro le controversie
attinenti possibili condotte antisindacali delle Pubbliche Amministrazioni ai danni dei propri dipendenti.
CAPITOLO VII
IL CONTRATTO COLLETTIVO
A. Il contratto collettivo
1. La determinazione delle condizioni di lavoro
Il movimento sindacale ha avuto tra i propri fini primari quello di ottenere minimi di tutela, economica e
normativa, delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori. Queste finalità furono perseguite dalle
associazioni sindacali sia mediante la contrattazione con la controparte imprenditoriale, sia per mezzo di
un’ azione politica tesa a condizionare gli orientamenti legislativi.
In origine, una funzione protettiva fu assunta anche da forme di determinazione unilaterale delle
condizioni di lavoro, che ebbero peraltro una qualche importanza solo nell’esperienza francese ed in quella
anglosassone. Esse consistevano, semplicemente, nel rifiuto da parte di un gruppo di lavoratori di accettare
lavoro, se non a determinate condizioni.
Consolidata è, invece, la determinazione delle condizioni di lavoro mediante un’ attività di contrattazione
con il singolo datore di lavoro o con le associazioni imprenditoriali. Questo metodo si è venuto evolvendo
dalle sue forme originarie – in cui venivano concordati essenzialmente i livelli retributivi a livello aziendale –
sino agli odierni sistemi che costituiscono l’intelaiatura delle relazioni industriali moderne. Come si vedrà (v.
cap. VIII, sez. A), la contrattazione collettiva ha acquisito progressivamente nuovi contenuti e funzioni, e lo
stesso contratto collettivo presenta oggi una morfologia giuridica notevolmente articolata, sebbene la parte
dominante del sistema continua ad essere costituita dal c.d. contratto collettivo di diritto comune (v. infra,
sez. B).
2. Le prime riflessioni giuridiche sul contratto collettivo
Il problema dell’attuazione delle norme poste attraverso la contrattazione collettiva era affidato:
• nel sistema anglosassone, non già al valore giuridico del contratto, bensì al sistema di reciproci
rapporti tra sindacati e datori di lavoro;
• in Francia e nella Germania pre-weimariana, invece, all’individuazione di una loro efficacia giuridica,
derivante dall’inquadramento del nuovo fenomeno nella consolidata categoria del contratto ed alla
conseguente possibilità di invocarne il rispetto in sede giudiziaria.
Rispetto al problema dell’efficacia del contratto collettivo, distinguiamo due profili:
• soggettivo, concernente l’individuazione dei soggetti vincolati e veniva risolto nel senso che essi
coincidevano con gli aderenti alle associazioni sindacali firmatarie;
• oggettivo, consistente nell’individuare i meccanismi attraverso cui il contratto collettivo avrebbe
vincolato i contratti individuali di lavoro stipulati tra l’imprenditore ed i singoli lavoratori (la c.d.
inderogabilità).
34
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Il secondo tema si presentò subito come un nodo centrale, poiché si trattava di pervenire ad un risultato non
facilmente conseguibile all’interno della tradizione giuridica liberale: quello di impedire l’accettazione, da
parte dei singoli lavoratori, di condizioni di lavoro peggiorative rispetto a quelle poste collettivamente.
In Germania e Francia questo problema trovò un’ esplicita definizione legislativa; in Italia, dove si
pervenne ad una soluzione legislativa solo con la legge che pose le fondamenta del sistema corporativo nel
1926, si delinearono una pluralità di teorie e soluzioni contrastanti.
Il punto più alto della dottrina pre-corporativa fu senza dubbio raggiunto da Giuseppe Messina – civilista –
che importò la concezione del Lotmar – giurista svizzero – che affermava l’inderogabilità del contratto
collettivo inquadrando il rapporto tra aderente e soggetto collettivo stipulante come rappresentanza,
così esponendosi alla critica per cui, se le associazioni sindacali e datoriali agissero in nome e per conto dei
soci, ciascuna coppia di costoro – nello stipulare il singolo contratto di lavoro – potrebbe modificare quanto
pattuito tra le parti collettive. Messina, conscio di questo limite, ritenne che in base al diritto comune delle
obbligazioni non si potesse affermare la prevalenza automatica delle clausole del contratto collettivo su
quelle difformi del contratto individuale (c.d. efficacia reale, v. sez. B, par. 3), ma era tuttavia possibile
assicurare al contratto collettivo una sanzione di natura obbligatoria, perché la sua deroga costituiva
violazione di un obbligo al quale sarebbe stato possibile reagire con un’ azione risarcitoria. Per
questa via, senza abbandonare la teoria della rappresentanza, l’autore riuscì ad identificare una sanzione
giuridica del contratto collettivo – alternativa alla sostituzione automatica – meno efficace ma, tuttavia, la sola
consentita dall’ordinamento del tempo.
3. Il contratto collettivo corporativo
La graduale acquisizione di identità da parte del nuovo istituto fu interrotta a seguito della legislazione del
1926 istitutiva dell’ordinamento corporativo, la quale prevedeva che, per ciascuna categoria di datori di
lavoro, lavoratori, artisti o professionisti, potesse essere riconosciuta legalmente una sola associazione
che, in seguito al riconoscimento a mezzo di decreto, diveniva persona giuridica di diritto pubblico, ente
ausiliario dello Stato.
Poiché il sindacato era dotato del potere di rappresentanza legale di tutti i soggetti – iscritti o meno –
appartenenti alla categoria per cui era costituito, il contratto collettivo da esso stipulato era vincolante per
tutti gli appartenenti alla categoria ed inderogabile in pejus dal contratto individuale. Se le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori non raggiungevano l’accordo, ciascuna poteva ricorrere alla Magistratura del lavoro, la
cui sentenza faceva le veci del mancato contratto collettivo.
Con l’emanazione del codice civile del 1942, il contratto collettivo venne inserito nella categoria delle
norme corporative ed inquadrato tra le fonti del diritto.
Nel 1944, con la soppressione dell’ordinamento corporativo, venne meno anche il contratto collettivo
corporativo. Tuttavia, il d. lgs. Luogotenenziale 369/1944m che abrogò l’ordinamento corporativo, mantenne
in vigore tutti i contratti stipulati dalle organizzazioni disciolte, perché non si vollero privare ad un tratto i
lavoratori della tutela costituita dalle norme ivi contenute.
4. Il contratto collettivo e l’art. 39 Cost.
Venuto meno l’ordinamento corporativo e ripristinata la libertà sindacale, il contratto collettivo ritornò nell’area
dell’autonomia privata e, di conseguenza, si riproposero i problemi propri dell’esperienza pre-corporativa.
Giusta l’art. 39, c. 4 Cost., “I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”.
La mancata attuazione di questa norma costituzionale (v. cap. III, sez. B, par. 2) non impedì, naturalmente,
che i sindacati liberi stipulassero contratti collettivi e sviluppassero un complesso sistema di contrattazione.
In assenza di una normativa legale ad hoc, il compito di attribuire un significato giuridico a questa attività
contrattuale è stato, dunque, assunto da giurisprudenza e dottrina.
5. La l. 741/1959 (c.d. Legge Vigorelli)
L’esigenza di estendere l’applicazione dei contratti collettivi oltre lo stretto ambito degli iscritti alle
associazioni stipulanti, attribuendo loro un’ efficacia generale – cioè nei confronti di tutti i lavoratori e le
imprese per le quali vengono stipulati – ha trovato nelle legislazioni straniere varie soluzioni: in Franci e
Germania, ad esempio, si ricorre ad un intervento della pubblica autorità, che generalizzi gli effetti di un
contratto collettivo già stipulato ed originariamente efficace solo nei confronti degli iscritti delle associazioni
stipulanti.
35
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Tale soluzione non era praticabile in Italia, poiché l’art. 39 Cost. attribuisce efficacia erga omnes al contratto
collettivo stipulato dai soggetti sindacali e secondo le procedure determinate dalla norma stessa, escludendo
un intervento eteronomo dell’autorità pubblica. Il legislatore italiano, nel 1959, escogitò così una soluzione
alquanto sottile, tesa a conseguire il medesimo effetto entro una cornice formalmente diversa. Una legge
delega – l. 741/1959 – attribuì al governo il potere di emanare, entro un anno dall’entrata in vigore della
legge stessa, decreti legislativi aventi come contenuto la determinazione di trattamenti minimi di lavoro per
ciascuna categoria, uniformandosi alle clausole dei contratti collettivi esistenti alla data di entrata in vigore
della legge. Formalmente, il governo non dichiarava l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi, ma
dettava direttamente una disciplina sui minimi di trattamento economico e normativo; tuttavia, per
raggiungere tale obiettivo, era vincolato ai contenuti dei contratti collettivi.
A seguito dell’entrata in vigore di questa legge furono emanati circa mille decreti, dato che essa prevedeva la
recezione non solo dei contratti applicati su tutto il territorio nazionale, ma anche di quelli provinciali muniti di
determinate caratteristiche.
6. Alcuni principi costituzionali sul contratto collettivo
Alla scadenza, la delega conferita nel 1959 venne prorogata di quindici mesi ed estesa ai contratti collettivi
stipulati entro i dieci mesi successivi all’entrata in vigore della legge prorogata: in tal modo, una disciplina
nata sotto l’insegna dell’eccezionalità manifestava la tendenza, attraverso periodici rinnovi, a divenire
permanente, sovrapponendosi di fatto al procedimento previsto dalla Costituzione.
La tendenziale stabilizzazione del meccanismo venne, però, arginata dalla sent. 106/1962 con cui la Corte
cost. respinse le eccezioni di incostituzionalità mosse avverso la c.d. legge Vigorelli, ma accolse quella
relativa all’art. 1 della legge di proroga (che, come detto, estendeva la delega anche ai contratti stipulati dopo
l’entrata in vigore della legge del 1959). Di conseguenza, l’estensione della delega ai successivi contratti
fu dichiarata illegittima dalla Corte.
Con tale sentenza, la Corte ha fissato alcuni importanti principi che hanno condizionato l’evoluzione della
materia:
• in primo luogo, ha affermato che l’art. 39 Cost. non pone una riserva in favore della
contrattazione collettiva per la regolazione dei rapporti di lavoro: questa tesi, infatti, contrasterebbe
coi principi costituzionali (ad es., art. 3, c. 2; art. 35, cc. 1, 2 e 3; art. 36; art. 37 Cost.) che postulano
un intervento del legislatore “al fine di tutelare la dignità personale del lavoratore ed il lavoro in
qualsiasi forma e da chiunque prestato”;
• inoltre, l’art. 39 Cost. conferisce automaticamente efficacia erga omnes ai contratti collettivi
stipulati dai soggetti forniti dei requisiti ivi specificati ed in base alla procedura prevista: ogni
legge che cercasse di conseguire il medesimo risultato in maniera diversa sarebbe illegittima.
Un problema di notevole gravità fu quello della determinazione dell’ ambito di applicazione dei decreti,
dato che l’art. 1, l. 741/1959 individuava il fine di “ assicurare minimi inderogabili […] nei confronti di tutti gli
appartenenti ad una medesima categoria”, senza precisare cosa dovesse intendersi con quest’ultimo
termine. La corte ritenne che, non esistendo un concetto univoco di categoria, debba essere il contratto
stesso a definire il proprio ambito di applicazione.
B. Il contratto collettivo di diritto comune
1. Rilevanza e natura giuridica
Se, in seguito alla caduta dell’ordinamento corporativo, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
hanno perso i connotati pubblicistici e sono ritornate nell’area del diritto privato, i contratti collettivi non
potevano essere qualificati – giusta la mancata attuazione dell’art. 39 Cost. – che come espressione del
potere di autoregolamentazione di soggetti di diritto privato: l’autonomia collettiva riassumeva anch’essa
natura di autonomia privata, riconosciuta dall’ordinamento ex art. 1322 c.c...
Il contratto collettivo c.d. “di diritto comune” caratterizza in modo incontrastato l’esperienza giuridico-
sindacale italiana: pur non esaurendo la tipologia del contratto collettivo – perché l’ordinamento ne prevede
anche altri tipi – attualmente, a parte il settore delle amministrazioni pubbliche (v. cap IX), è quasi
esclusivamente il contratto collettivo di diritto comune a regolare i rapporti individuali di lavoro e le
relazioni sindacali (dato che quello ex art. 39 Cost. è rimasto inattuato; i contratti collettivi corporativi hanno
un ambito d’applicazione limitatissimo e, infine, i d. lgs. emanati ex l. 741/1959 sono ormai obsoleti).
L’inquadramento dogmatico tra i negozi giuridici e, in particolare, tra i contratti, implica che l’unica
regolamentazione del contratto collettivo rinvenibile nell’ordinamento è quella dettata dal codice civile per i
contratti in generale. Al contrario, non sono applicabili gli artt. 2067 ss. c.c. dettati per i contratti corporativi
e tutt’ora vigenti solo per questi ultimi. Il contratto collettivo di diritto comune è, dunque, espressione di
36
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
autonomia privata e non può essere annoverato – a differenza del contratto corporativo – tra le fonti del
diritto obiettivo dell’ordinamento dello Stato: queste ultime sono, infatti, espressione di un potere normativo
che si impone eteronomamente ai destinatari delle norme; invece, i contratti collettivi di diritto comune
realizzano la composizione d’interessi confliggenti attraverso l’accordo delle parti.
Invero, la dottrina accosta il contratto collettivo alle fonti, soprattutto in virtù di una considerazione funzionale
– giusta la quale i contratti collettivi nazionali pongono norme astratte e generali dirette a regolare una serie
indeterminata di casi concreti, al pari di leggi e regolamenti – che però non può prevalere sull’aspetto
strutturale: il contratto collettivo trae fondamento dal potere dei soggetti privati di regolamentare
autonomamente i propri rapporti, non già dal potere eteronomo di soggetti pubblici.
Il d. lgs. 40/2006, introducendo, tra i motivi di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., la violazione o falsa
applicazione “dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”, aggiungendolo alla violazione e falsa
applicazione di norme di diritto, sembra aver avvalorato la qualificazione del contratto collettivo di diritto
comune come fonte. In realtà, la novità in discorso ha un intendimento eminentemente pratico: i problemi
interpretativi posti dalle norme dei contratti collettivi nazionali possono dar luogo a contenziosi di massa
affrontati da un numero elevato di giudici, a scapito della certezza del diritto. Per risolvere questo problema,
il legislatore ha ritenuto opportuno l’intervento della Cassazione nella sua funzione nomofilattica. Invero,
l’esigenza di assicurare un’ omogeneità di indirizzi interpretativi deriva dal carattere generale e astratto della
norma, non già da una sua natura eteronoma.
2. La funzione normativa
All’interno della categoria dei contratti, il contratto collettivo si distingue per una sua incontrovertibile tipicità
sociale, che lo rendo giuridicamente rilevante ancorché non sia oggetto di una specifica disciplina legale. Alle
origini, il suo contenuto era costituito solo da clausole sui minimi di trattamento economico e normativo
che, ancora oggi numericamente dominanti, sono riconducibili alla c.d. funzione normativa.
Per quanto detto, il contratto collettivo è stato inquadrato, alternativamente, nella categoria del:
• contratto normativo, ossia di quel contratto che, invece di porre in essere direttamente uno
scambio o altro atto economico, determina i contenuti di una futura produzione contrattuale.
Alle origini, infatti, il suo contenuto era costituito da sole clausole sui minimi di trattamento
economico e normativo, ed ancora oggi queste sono numericamente dominanti.
All’interno di questo schema, però, il contratto collettivo si caratterizza sotto un duplice profilo,
costituendo così una species di quel genus:
• almeno una delle parti è necessariamente un soggetto collettivo , cosicché,
quantomeno per la parte riguardante i lavoratori, sono sempre diversi il soggetto
(l’associazione) che stipula il contratto e quelli che stipulano i contratti individuali (i singoli
lavoratori);
• il contratto collettivo predetermina le clausole dei contratti individuali e non solo di
quelli futuri, bensì anche di quelli in corso al momento della sua stipulazione.
• contratto tipo, che non predetermina in forma generica gli elementi cui si dovranno attenere i
futuri contratti, ma “li detta nella veste stessa che dovranno assumere nel rapporto cui si
riferisce, predisponendo una serie di clausole ordinatamente raccolte in uno schema”.
Deve però ricordarsi che tali contratti sono differenziati sotto il profilo della diversa vincolatività della
predeterminazione di contenuti che entrambi pongono in essere:
• nel contratto tipo, la predeterminazione proviene da una delle parti e non è vincolante poiché
costituisce un mero schema contrattuale che si perfeziona in contratto solo con la stipulazione;
• il contratto normativo, invece, realizza un vincolo contrattuale tra le parti, e comporta tra esse
un rapporto obbligatorio (il cui contenuto consiste nell’obbligo di attenersi, nell’attività contrattuale, a
quanto concordato).
3. L’inderogabilità in pejus
Se la parte normativa del contratto collettivo è volta a stabilire minimi di trattamento economico e normativo
per i singoli contratti di lavoro, il problema giuridico centrale da essa posto è quello della sua efficacia sia
sotto il profilo soggettivo (individuazione dell’ambito di applicazione), sia sotto quello oggettivo (rapporto tra
contratto collettivo ed individuale). Per quanto riguarda questo secondo profilo, il rapporto tra l’autonomia
collettiva e quella individuale è regolato dal meccanismo della inderogabilità in pejus di natura reale: il
contratto individuale non può disporre trattamenti economici e normativi deteriori per il lavoratore rispetto a
quelli previsti dal contratto collettivo. Qualora ciò si verifichi, la conseguenza non è una mera obbligazione
37
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
risarcitoria, bensì l’automatica sostituzione delle clausole (c.d. natura reale – cioè automatica –
dell’inderogabilità). Se un tale risultato era stato conseguito senza problemi quando l’autonomia collettiva
aveva assunto caratteri pubblicistici, per il contratto collettivo di diritto comune, al contrario, nell’assenza di
un’ esplicita previsione legislativa, l’affermazione del principio dell’inderogabilità ha costituito per anni un
tema di acceso dibattito. A tal proposito, è possibile distinguere la dottrina in due orientamenti, tendenti a
risolvere il problema:
• con soluzioni interne al sistema del diritto civile, delle quali si fa portatore F. Santoro Passarelli
(1950) secondo cui il contratto collettivo sarebbe espressione di un “fenomeno di
autoregolamentazione di privati interessi fra gruppi contrapposti”. Questa particolare forma di
autonomia privata – sintetizzabile nella formula di autonomia collettiva – ha natura collettiva perché i
soggetti che la esprimono (le associazioni, dei lavoratori e degli imprenditori) sono portatori
dell’interesse di una pluralità di persone. Pur trattandosi, in entrambi i casi, di interessi privati,
l’interesse collettivo prevale su quello individuale e, conseguentemente, il contratto collettivo
prevale su quello individuale.
In mancanza di una norma specifica, Santoro Passarelli riteneva che detto rapporti di prevalenza
trovi espressione, sul piano del diritto generali dei contratti, negli artt.:
• 1723, c. 2: “Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si
estingue per revoca da parte del mandante [...]"
• 1726: “Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare
d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia stata fatta da tutti i mandanti
[...]".
in quanto “in entrambe le norme l’interesse collettivo servito sottrae il mandato all’influenza
della mutevole volontà o delle vicende personali del mandante o di uno dei mandanti”.
Così, il singolo datore ed il singolo lavoratore, come non possono utilmente revocare il mandato
prima della sua esecuzione fino a che non escano dalle associazioni, così, dopo che il contratto
collettivo è stato concluso in esecuzione del mandato, non possono sottrarsi alla sua osservanza o
derogare ad esso, neppure consensualmente.
Altri autori ritengono che il meccanismo di prevalenza del contratto collettivo debba essere
individuato, invece, nell’atto di adesione del singolo al sindacato, che implica necessariamente
l’assoggettamento del singolo al potere dell’associazione.
Si badi che entrambe le spiegazioni non hanno permesso di motivare il carattere “reale” e non
meramente obbligatorio dell’inderogabilità in pejus e, cioè, l’obbligo del giudice di applicare la
clausola collettiva in luogo di quella individuale peggiorativa.
• con soluzioni eteronome ai principi civilistici classici:
• insoddisfacente appare il richiamo all’art. 39 Cost., in quanto implicherebbe una supremazia
gerarchica dell’autonomia collettiva su quella individuale cui un generico rinvio alla norma
costituzionale non è in grado di dare fondamento;
• parimenti criticabile è apparso il ricorso all’art. 2077 c.c. (“I contratti individuali di lavoro tra
gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi
alle disposizioni di questo. | Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o
successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo,
salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”), poiché tale
norma attiene specificamente ai contratti collettivi corporativi, e sarebbe rimasta in vigore
solo in funzione di tali contratti;
• l’orientamento giurisprudenziale fondato sull’art. 2077 ha costituito per l’interprete l’unico
punto fermo sino al momento in cui il problema dell’inderogabilità in pejus ha trovato una più
puntuale definizione legislativa con la formulazione del nuovo testo dell’art. 2113, introdotto
dalla l. 533/1973, secondo la quale: “Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto
diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei
contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di
procedura civile, non sono valide”.
4. La derogabilità in melius
L’inderogabilità del contratto collettivo concerne solo i trattamenti peggiorativi per i lavoratori; al contrario, è
possibile che il contratto individuale si discosti da quello collettivo derogandolo in melius. Se il
principio è esplicato dall’art. 2077, c. 2, complessa e contrastata è, invece, la soluzione del problema della
comparazione dei trattamenti derivanti dalle due diverse fonti: non sempre, infatti, è agevole stabilire se il
trattamento previsto dal contratto individuale sia più favorevole o meno per i lavoratori rispetto a quello
38
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
previsto dal contratto collettivo. Invero, la questione è di semplice soluzione quando varia solo un elemento
ma a volte, però, possono variarne due o più ed in senso non convergente (ad es., quando il contratto
individuale prevede contestualmente una retribuzione maggiore ed un più breve periodo di ferie). Sul punto
si sono delineati due orientamenti di fondo:
• la tesi del c.d. conglobamento ritiene che debba operarsi una comparazione tra i trattamenti
complessivi previsti da ciascuna fonte, applicando esclusivamente la regolamentazione che,
globalmente valutata, risulti più favorevole per il lavoratore;
• la teoria del cumulo, per contro, propende per confrontare le singole clausole di ciascuna delle
regolamentazioni, estraendo dai due contratti quelle più favorevoli e cumulandole tra loro.
D’altra parte, però, in presenza di clausole d’inscindibilità – che stabiliscono che le disposizioni contrattuali
sono correlative ed inscindibili tra loro, e non sono cumulabili con alcun trattamento derivante da altra fonte –
non saranno utilizzabili le soluzioni generali sopra esposte.
5. Efficacia soggettiva e categoria contrattuale
L’altro problema posto dalla parte normativa del contratto collettivo di diritto comune è quello della efficacia
soggettiva, che si estende ai soli iscritti alle associazioni stipulanti: la natura privatistica di tale contratto
– conseguente, ribadiamo, alla mancata attuazione dell’art. 39, c. 2 ss., Cost. – lo rende efficace solo nei
confronti di quei soggetti che abbiano conferito all’associazione il potere di rappresentanza per la
stipulazione dei contratti collettivi. Il conferimento del mandato rappresentativo è, di norma, collegato
all’adesione all’associazione: nel momento in cui si iscrivono ad essa, il lavoratore o l’imprenditore
conferiscono il mandato a stipulare contratti collettivi. La ricostruzione dell’efficacia del contratto sulla base
delle norme civilistiche in tema di rappresentanza comporta anche l’inutilizzabilità, per il contratto collettivo
di diritto comune, dell’art. 2070 (che individuava l’ambito di applicazione del contratto collettivo corporativo
in relazione alla natura dell’attività svolta): esso applica un criterio oggettivo incompatibile con la natura
privatistica dei contratti collettivi di diritto comune, il cui ambito di applicazione non può che essere
determinato dalla volontà delle parti stipulanti (e, dunque, nel contratto stesso).
6. L’efficacia soggettiva nella giurisprudenza
Se il principio generale in materia di efficacia soggettiva è quello della vincolatività solo nei confronti degli
aderenti alle associazioni stipulanti, tuttavia, nel corso degli anni, si sono delineati una serie di meccanismi
di estensione dell’ambito di applicazione del contratto collettivo, al di là della sua portata naturale:
• la giurisprudenza della Cassazione ha fatto propria una tesi secondo la quale il datore di lavoro
aderente all’associazione firmataria di un contratto collettivo deve applicare le disposizioni ivi
contenute nei confronti di tutti i propri dipendenti (anche di quelli non iscritti alle contrapposte
organizzazioni sindacali stipulanti che ne richiedano l’applicazione).
La soluzione – condivisibile alla luce del divieto di discriminazioni a causa dell’affiliazione sindacale
(art. 15, St. lav.) – presenta peraltro un interesse più teorico che pratico, perché è assai improbabile
che l’imprenditore operi trattamenti differenziati a favore dei lavoratori iscritti (onde non incentivare i
non iscritti ad aderire al sindacato).
Più complessi sono, invece, i problemi relativi all’estensione dell’efficacia del contratto collettivo nei
confronti dei datori di lavoro non iscritti ad alcuna associazione sindacale;
• l’applicabilità del contratto collettivo è pacifica quando le parti nel contratto individuale
abbiano formulato un richiamo ad un particolare accordo o, più genericamente, alla contrattazione
collettiva vigente;
• il contratto collettivo è vincolante anche nei confronti del datore di lavoro che, pur non
essendovi tenuto, ne abbia spontaneamente applicato il contenuto (la fonte dell’obbligo risiede
nel comportamento concludente del datore di lavoro, che si evince dalla determinazione del
contenuto dei contratti individuali sulla base di quanto previsto da quello collettivo).
• l’operazione giurisprudenziale più influente è però, senza dubbio, quella che estende le
determinazioni del contratto collettivo in ordine alle retribuzioni minime: se l’art. 36 Cost.
sancisce che “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa ” e
tale norma è immediatamente precettiva, allora sarà nulla la clausola retributiva dei contratti
individuali con essa contrastante. Il venir meno della clausola retributiva determina, a sua volta, la
mancanza di un accordo tra le parti sul punto, sicché troverà applicazione l’art. 2099 c.c. “In
mancanza di [norme corporative o di] accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice ”.
Nell’operare tale valutazione equitativa, il criterio senza dubbio più corretto è quello del riferimenti ai
minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva del settore.
39
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
7. L’estensione dell’efficacia soggettiva nella legislazione
Anche il legislatore ordinario si è più volte preoccupato di estendere l’efficacia soggettiva del contratto
collettivo, per assicurarne la funzione di regolazione sul mercato del lavoro. Preclusa dalla Corte
costituzionale la via di procedere direttamente a tale estensione con un intervento governativo sul modello
della l. 741/1959, il legislatore, nel riconoscere agli imprenditori agevolazioni o benefici, ne ha più
volte subordinato il godimento all’applicazione dei contratti collettivi ovvero di trattamenti economici e
normativi non inferiori a quanto ivi stabilito. Questi ultimi, dunque, non sono resi obbligatori per sé, ma
l’erogazione dei trattamenti previsti dal contratto collettivo è condizione per fruire di certe situazioni di
vantaggio. Il prototipo di questi interventi legislativi è l’art. 36, St. lav., che impone alle amministrazioni
pubbliche di inserire, nei provvedimenti di concessione di agevolazioni finanziarie e creditizie a favore
di imprenditori e nei capitolati d’appalto di opere pubbliche, una clausola determinante l’obbligo, per
il beneficiario o appaltatore, di applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni di trattamento non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. La clausola che
impone l’obbligo di rispettare i contratti collettivi è stata ricondotta dalla giurisprudenza alla fattispecie della
stipulazione a favore di terzi (art. 1411 c.c.), il che comporta che ai lavoratori venga riconosciuta la titolarità
di un diritto soggettivo nei confronti del proprio datore di lavoro che l’abbia sottoscritta.
Più di recente, l’art. 118, c. 6, d. lgs. 163/2006, ha disposto non già un obbligo per la Pubblica
Amministrazione di inserire nel contratto con l’imprenditore privato una clausola del tenore indicato, ma di un
vincolo giuridico direttamente scaturente dalla legge.
Simili interventi legislativi trovano un fondamento nel diritto internazionale: la Convenzione OIL 94/1949
prevede, infatti, che i contratti con le Pubbliche Amministrazioni debbano contenere apposite clausole c.d.
sociali, che garantiscano ai lavoratori salari e condizioni di lavoro non inferiori a quanto previsto dai contratti
collettivi dello stesso settore e dello stesso territorio.
Questa tendenza ha trovato invece ostacolo nella Corte di Giustizia UE che, con sent. Ruffert del 2008, ha
censurato la normativa di un Land tedesco che prescriveva come condizione per l’aggiudicazione di
un appalto pubblico il rispetto delle tariffe salariali previste da contratti collettivi privi di efficacia
generale. Secondo la Corte, una norma nazionale che così disponga, se applicata ad un’ impresa di altro
Stato comunitario costituisce violazione dell’art. 49, TCE, perché ostacola la libera circolazione dei
servizi. La Corte ritiene che il vincolo che lo Stato ospitante può imporre agli imprenditore degli altri Stati
membri sia unicamente quello derivante da norme di legge o regolamentari, ovvero da contratti collettivi
dichiarati di applicazione generale. La sentenza ha meritato vivaci critiche, perché porta ad un paradosso: la
normativa che vincola al rispetto del contratto collettivo non sarebbe applicabile alle imprese straniere – che
si avvalgono dell’art. 49 TCE – mentre lo sarebbe a quelle nazionali: queste ultime, dunque, avrebbero un
trattamento deteriore, mentre alle prime sarebbe riconosciuta una sorta di immunità.
8. Le altre funzioni
Anche se – come detto – nella maggior parte delle sue clausole il contratto collettivo si atteggia come
contratto a causa normativa, un’ analisi esauriente dei suoi contenuti permette di individuarne una variegata
serie non riconducibile a tale funzione. Pertanto, la dottrina ha teorizzato una distinzione all’interno del
contratto collettivo, secondo la quale, accanto ad una parte normativa, è individuabile un’ altra parte definita
obbligatoria. La caratteristica comune delle clausole obbligatorie è individuata nel fatto che instaurano
rapporti obbligatori non facenti capo alle parti del rapporto individuale, bensì a soggetti collettivi (ad es.,
il contratto collettivo stipulato tra il sindacato nazionale dei metalmeccanici e la contrapposta organizzazione
imprenditoriale crea rapporti obbligatori anche tra il sindacato provinciale e l’associazione provinciale degli
industriali). A seconda che la singola disposizione contrattuale collettiva abbia una o l’altra funzione saranno
diversi gli effetti giuridici:
• i problemi concernenti le clausole normative si risolvono fondamentalmente in quelli inerenti al
rapporto tra autonomia collettiva e negoziale dei singoli (v., supra, parr. 3-4);
• i problemi posti dalle clausole obbligatorie attengono, invece, ai vari doveri, obblighi e
responsabilità che da esse discendono per i soggetti collettivi: l’inadempimento di tali clausole
comporta una responsabilità del soggetto collettivo nei confronti della propria associazione
(per esempio, quando il contratto decentrato sia stipulato in violazione della clausola di rinvio
contenuta in quello nazionale).
Alcune clausole obbligatorie, poi, costituiscono enti bilaterali per la gestione di alcuni istituti
contrattuali (ad es., le Casse edili) e, in questo senso, può parlarsi di una funzione istituzionale.
Ancora, l’accordo sindacale talvolta affronta e risolve un singolo problema di gestione aziendale: in tal
caso, può parlarsi di funzione gestionale.
40
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Vi sono, infine, clausole difficilmente collocabili all’interno sia dell’uno che dell’altro gruppo: si tratta
dell’ipotesi in cui le parti dispongono di situazioni giuridiche già formatesi, in genere in forma transattiva
o accertativa, nell’esercizio di una funzione compositiva dei conflitti giuridici.
In conclusione, quindi, si trae la convinzione dell’impossibilità di ridurre la causa del contratto collettivo
alla funzione normativa; al contrario, quanto più il sindacato tende ad intervenire sui temi
dell’organizzazione del lavoro, dell’occupazione, delle strategie dell’impresa, ecc., tanto più, nell’equilibrio
complessivo dei contratti, cresce l’importanza della parte obbligatoria.
Allo stato, nell’intento di fornire una costruzione dell’istituto secondo una visione unitaria, può dirsi che la
posizione più aderente al dato reale è quella che ravvisa nel contratto collettivo la funzione economico-
sociale di composizione dei conflitti di interessi tra gruppi professionali: tale funzione, poi, si articola in
una pluralità di funzioni più specifiche.
9. Il dovere di pace sindacale e il dovere di influenza
L’Accordo interconfederale del 15/04/2009 e l’analoga Intesa per il settore pubblico del 30/04 successivo
prevedono che, durante i sei mesi precedenti la scadenza del contratto nazionale ed il mese successivo, “le
parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette”. Dal canto suo, la l. 83/2000
ha reso obbligatoria l’inclusione, nei contratti collettivi dei servizi pubblici essenziali, di clausole che
prevedano simili “procedure di raffreddamento”.
Come si vede, è quindi sempre d’attualità il dibattito sull’obbligazione di tregua (o pace) sindacale. Un più
antico orientamento sosteneva che un tale obbligo sia implicito, essendo coessenziale al concetto di
contratto la sua funzione di comporre il conflitto tra le parti per un certo periodo di tempo: l’associazione
sindacale non sarebbe legittimata a ricorrere alla azione diretta per la modificazione del contratto collettivo
fino alla sua scadenza.
È stato giustamente obiettato che, non potendo l’interprete sovrapporre alla volontà delle parti la propria
valutazione del contenuto del contratto, l’obbligo di tregua andrebbe assunto esplicitamente: in
mancanza, la stipulazione del contratto ha naturalmente come contropartita la cessazione del conflitto in
atto, senza però addurre alcuna garanzia per gli eventuali conflitti futuri (sarebbe ben strano che dalla
stipulazione di un contratto nazionale che introduce nuovi minimi salariali si debba dedurre l’obbligo di non
scioperare contro una ristrutturazione aziendale decisa unilateralmente da un singolo imprenditore).
Insomma, l’obbligo di tregua, ove una clausola contrattuale lo preveda senza ulteriori specificazioni, deve
intendersi come relativo alle sole materie sulle quali si è formato l’accordo, escludendo quelle ad esso
estranee (c.d. dovere “relativo” di pace sindacale); un’ estensione del suo contenuto a materie non
regolate espressamente dal contratto potrebbe ammettersi solo ove fosse statuito in maniera esplicita in tal
senso (c.d. dovere “assoluto” di pace sindacale) ed in limiti tali, comunque, da non vanificare totalmente il
diritto di sciopero.
Diverso è il problema degli effetti delle clausole di tregua sui singoli lavoratori. Se parte della dottrina ha
affermato che in esse sia implicita una rinunzia al diritto di sciopero – per cui la clausola vincolerebbe non
solo il sindacato che l’ha sottoscritta, ma anche i singoli lavoratori ad esso iscritti – in verità non può
affermarsi aprioristicamente che tali clausole mirino a realizzare un simile effetto normativo. Piuttosto, dalla
struttura che, di solito, tali clausole presentano, si può desumere che esse impegnano solo i sindacati
stipulanti e che, proprio per questo, sono inquadrabili nella parte obbligatoria. La clausola di tregua,
pertanto, implica l’assunzione di un obbligo relativo a comportamenti propri dell’associazione, ma non pone
in essere un atto di disposizione del diritto di sciopero, del quale sono titolari i lavoratori e non le
organizzazioni sindacali.
Va menzionato il DOVERE DI INFLUENZA che impegna le organizzazioni che stipulano il contratto collettivo
a influire sulle proprie articolazioni organizzative e sui propri associati perché applichino il contratto stesso.
10. La c.d. procedimentalizzazione dei poteri dell’imprenditore
Il contratto aziendale gestionale è quel contratto collettivo che non detta regole sui rapporti di lavoro, ma
affronta un problema di gestione aziendale (ad es., se una situazione di crisi debba essere affrontata con
licenziamenti ovvero con una diversa misura di riorganizzazione).
Simili contratti sono di frequente il risultato (non vincolante, ma auspicato) di clausole contrattuali – di natura
obbligatoria, in quanto creano diritti in capo alle organizzazioni – che obbligano l’imprenditore a dare alle
rappresentanze dei lavoratori informazione preventiva su alcune decisioni che intende assumere in modo
che esse, a seguito dell’informazione, possano chiedere un incontro per esaminare il problema, posto che il
potere decisorio dell’imprenditore rimane sospeso per la durata del procedimento. Si tratta della c.d.
procedimentalizzazione del potere dell’imprenditore, “la quale consiste in una complicazione del
processo decisionale, volta a garantire che nel formarsi di certe decisioni si tenga conto degli
interessi antagonistici sui quali va ad incidere l’esercizio del potere”.
41
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Il favore verso soluzioni concordate dei problemi aziendali e l’imposizione di vincoli procedurali a decisioni
imprenditoriali non è presente solo nei contratti collettivi, ma anche nella legislazione: con tali norme non si
obbliga l’imprenditore a pervenire ad un accordo se vuol porre in essere l’atto di gestione (infatti, trascorso il
termine fissato senza che l’accordo sia realizzato, il potere dell’imprenditore ritorna integro) ma, piuttosto, si
vuol dare al sindacato la possibilità di intervenire prima che la decisione sia presa. L’obiettivo di questa
tecnica normativa è, insomma, certamente quello di favorire soluzioni concordate, ma l’esito positivo
della procedura rimane nella disponibilità e nella responsabilità delle parti.
Quanto detto ci consente di individuare una doppia funzione del contratto collettivo aziendale:
• da un lato, quella di dettar norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori e sulle
relazioni sindacali (funzione normativa e funzione obbligatoria);
• dall’altro, quella di vincolare l’imprenditore ad assumere le determinazioni organizzative
concordate.
11. L’efficacia soggettiva del contratto gestionale VEDI FOTO
Come abbiamo visto, il contratto aziendale può assumere anche una funzione gestionale, ossia quella di
concordare un provvedimento di gestione del personale (ad es., evitare l’esuberanza del personale
attraverso una riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione – c.d. contratto di solidarietà) e,
generalmente, si ricorre a simili contratti quando si tratta di gestire situazioni di crisi aziendale ed occorre
dunque distribuire sacrifici, talvolta anche in deroga agli standard stabiliti dalla legge o da altri contratti
collettivi. In tali ipotesi, il problema dell’efficacia soggettiva del contratto aziendale si presenta in modo
peculiare, perché non è l’imprenditore, ma sono i lavoratori che possono avere interesse a sottrarsi
all’applicazione del contratto.
A tal proposito, occorre distinguere due ipotesi:
• quella in cui il contratto collettivo operi direttamente sul rapporto individuale di lavoro (ad es.,
quando l’accordo consenta l’assegnazione di lavoratori a mansioni diverse), caso in cui, secondo la
giurisprudenza, rimane fermo anche a questo proposito il principio che il sindacato trae
legittimazione alla stipula del contratto dal mandato che riceve dai lavoratori con la loro iscrizione e,
dunque, il contratto non può spiegare efficacia nei confronti dei lavoratori non iscritti;
• quella in cui l’accordo non spiega alcun effetto diretto sui rapporti individuali, ma è solo un
momento – eventuale – del procedimento che l’imprenditore deve seguire per esercitare un proprio
potere. In tal caso, in altri termini, ciò che spiegherà effetto sul rapporto individuale di lavoro non è
l’accordo, bensì l’atto col quale il datore di lavoro esercita il suo potere (ad es., il potere
dell’imprenditore di procedere al licenziamento collettivo è sottoposto al vincolo dell’informazione
preventiva alle RSA): non avendo, tali contratti, alcun effetto normativo sui rapporti individuali di
lavoro, non si pone il problema dell’estensione soggettiva della loro efficacia.
12. I contratti collettivi espressamente previsti da norme di legge
La più stretta integrazione tra legge e contratto collettivo ha creato anche ipotesi in cui la disciplina di
quest’ultimo non è riconducibile a quella elaborata da dottrina e giurisprudenza sul contratto collettivo di
diritto comune. Innanzitutto, la sua rilevanza giuridica non è più affidata all’art. 1322 c.c., ma alle norme di
legge che espressamente lo prevedono; peraltro, differisce sotto il profilo funzionale: il contratto non è
più una mera autoregolamentazione di interessi privati, ancorché collettivi, ma tale autoregolamentazione –
ferma restando la natura privata di soggetti e degli interessi regolati – è abilitata a derogare, sostituire o
integrare il precetto legale, altrimenti inderogabile dall’autonomia privata, ovvero ad autorizzare la parte
datoriale ad usufruire di certi istituti solo alla condizione di trovare un’ intesa con le contrapposte
organizzazioni sindacali (è questa la funzione c.d. autorizzatoria della contrattazione collettiva).
La ratio di simili interventi normativi risiede nella considerazione giusta la quale alcuni aspetti delle relazioni
di lavoro possano esser meglio regolati dal contratto collettivo, in quanto strumento normativo più
flessibile, più vicino alle situazioni concrete e più idoneo a porre regole sulle quali si realizzi il consenso
dei destinatari.
Occorre ora interrogarsi su quali parti della disciplina generale del contratto collettivo siano applicabili anche
a questi contratti e, al contrario, in quali punti la disciplina sia differente.
Il fatto che il fondamento giuridico di questi contratti non derivi dal generale riconoscimento dell’autonomia
privata ex art. 1322 c.c., bensì dalla specifica norma di legge che li prevede, non ha riflessi sull’efficacia
soggettiva: la norma legale ha sì un efficacia generale, ma ciò non è sufficiente a farne scaturire
l’efficacia soggettiva generale anche del contratto stipulato in forza di essa.
42
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Un’ attenta dottrina ha proposto di distinguere tra rinvii:
• propri, in cui la norma di legge prima dispone una regola e poi autorizza il contratto a derogarvi;
• impropri, in cui la legge rinvia al contratto collettivo perché regoli direttamente la materia (ad es., è
affidato alla contrattazione collettiva il compito di individuare i requisiti dei lavoratori esclusi
dall’obbligo del lavoro notturno). Simili norme di legge paiono prive di un reale contenuto
precettivo: già in forza del generale principio di libertà di contrattazione collettiva ex art. 39 Cost., i
sindacati e l’imprenditore potrebbero accordarsi sul punto, anche in mancanza di un’ apposita
autorizzazione del legislatore. Per quanto detto, i rinvii c.d. impropri avrebbero un valore meramente
simbolico-politico, di “invito” alle parti collettive a regolare una data materia.
Un problema sorge quando le norme che operano i rinvii impropri riservano ai sindacati più
rappresentativi la legittimazione a stipulare i contratti collettivi cui fanno rinvio. In tali casi, deve ravvisarsi
l’illegittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 39 Cost.: infatti, essa non attribuirebbe ai
sindacati più rappresentativi un diritto o un potere che va oltre la libertà sindacale (il che, stando alla sent.
della Corte cost. 54/1974, è ben possibile ed è quanto avviene quando, con rinvii propri, si da facoltà ad
alcune organizzazioni di derogare, sostituire ovvero integrare la norma legale, facoltà, queste, che esulano
dalla mera libertà sindacale), ma si negherebbe ad altri sindacati un segmento di essa, cioè la libertà di
contrattare su quell’argomento.
Insomma, delle due l’una:
• o lo Stato regola direttamente una data materia con norme inderogabili e, in questo caso, può
legittimamente riservare soltanto ad alcune organizzazioni sindacali il potere di modificare, sostituire,
integrare la disciplina legislativa (rinvio proprio);
• ovvero lascia che quella materia sia disponibile per l’autonomia privata, pur rinviando al
contratto collettivo (rinvio improprio) e, in tal caso, non può però comprimere la libertà contrattuale
ed il potere sociale di normazione delle organizzazioni sindacali minoritarie.
CAPITOLO VIII
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
A. Evoluzione storica: soggetti, livelli, procedure
1. Premessa
Il contratto collettivo costituisce l’esito della contrattazione collettiva, cioè di quel processo – che
costituisce il metodo principale di composizione del conflitto industriale – attraverso cui i sindacati dei
lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro (o i singoli datori direttamente), ricorrendo ai mezzi di
pressione di cui dispongono definiscono congiuntamente la regolamentazione dei rapporti, individuali e
collettivi, di lavoro.
Il processo contrattuale può svolgersi:
• a scadenze regolari ed esaurirsi con la stipulazione del contratto;
• permanente, cioè continuare anche nelle fasi di applicazione e di amministrazione della disciplina
negoziale, per favorirne il progressivo adattamento all’evoluzione delle condizioni in cui vengono
rese le prestazioni di lavoro.
Nel momento in cui la contrattazione collettiva si articola verticalmente su vari livelli si parla di struttura
contrattuale, con ciò intendendo proprio l’insieme dei livelli ai quali si svolge la contrattazione
collettiva, le competenze di ciascuno di essi e i reciproci rapporti. Tale struttura è regolata per accordo
tra le parti collettive nel settore privato e prevalentemente dalla legge in quello pubblico.
In Italia, i livelli negoziali più stabilmente praticati sono tre:
• contratto collettivo nazionale di categoria (ccnl), perno del sistema contrattuale stipulato con
periodicità fissa – ogni 3 o 4 anni, a seconda delle regole vigenti nei diversi periodi (v. infra parr.
5-6) – dalle federazioni nazionali di categoria delle parti. Esso disciplina, per ciascuna categoria
(alimentare, metalmeccanico, chimico, ecc.) sia i minimi di trattamento economico-normativo
applicabili ai rapporti individuali di lavoro, sia le relazioni tra i soggetti sindacali stipulanti e le loro
articolazioni organizzative.
• contratto decentrato, ossia quello che viene stipulato, nell’arco della vigenza del contratto
nazionale di categoria, a livello territoriale (generalmente provinciale o regionale) ovvero a livello
aziendale. Esso ha, in generale, la funzione di integrare e completare la disciplina dettata dal
contratto nazionale e, di conseguenza, determina gli “standard” di trattamento, cioè i trattamenti
43
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
applicabili ai rapporti individuali e collettivi di lavoro rientranti nel suo ambito di applicazione; in altri
casi, invece, esso interviene su singoli problemi gestionali.
• accordo interconfederali, occupanti il livello negoziale più elevato. Essi, privi di periodicità e
scadenza predeterminate, sono stipulati a livello nazionale dalle confederazioni sindacali e
datoriali al fine di disciplinare singoli istituti, quando le parti ritengono utile una regolamentazione
uniforme degli stessi per una pluralità di categorie.
Una struttura contrattuale può esser definita:
• centralizzata, laddove in essa sia tendenzialmente dominante il livello ad ambito di applicazione più
esteso (interconfederale o nazionale di categoria);
• decentrata, laddove in essa sia tendenzialmente dominante il livello ad ambito di applicazione più
ristretto (aziendale e territoriale),
• bipolare, quando entrambi i livelli negoziali hanno competenze e funzioni ampie e rilevanti.
Dal punto di vista dell’evoluzione storica della contrattazione collettiva – che in qualche modo può essere
descritta come un’ oscillazione tra centralizzazione e decentramento – schematicamente può affermarsi che
la prevalenza di imprese piccole e piccolissime, l’arretratezza tecnologica, un’ elevata disoccupazione
e la recessione economica favoriscono la centralizzazione perché, da un lato indeboliscono il potere
rivendicativo del sindacato (limitandone il numero di iscritti, la diffusione settoriale, la capacità organizzativa)
e, dall’altro, fanno emergere esigenze di governo complessivo delle politiche salariali e del mercato del
lavoro. Evidentemente, condizioni opposte sostengono, invece, il decentramento.
2. L’evoluzione della contrattazione collettiva. Dal dopoguerra ai primi anni ‘60
Nel decennio successivo alla caduta del regime corporativo, il sistema contrattuale era fortemente
centralizzato, essendo dominante il livello interconfederale.
Innanzitutto, le organizzazioni sindacali avevano potuto ricostituire per prime le proprie strutture di vertice –
quelle confederali, appunto – cui fu pertanto affidata l’attività contrattuale. Peraltro, le stesse organizzazioni
erano particolarmente deboli a causa della sfavorevole situazione economico-politica, e ciò le induceva
a concentrare i propri sforzi sulla tutela di interessi comuni a tutti i lavoratori, come la stabilità
dell’occupazione. Parallelamente, un sistema contrattuale centralizzato soddisfaceva pienamente l’interesse
degli imprenditori di evitare qualsiasi attività sindacale in azienda.
La centralizzazione fu massima fino alla metà degli anni ’50, ma rimase elevata anche quando la funzione di
negoziare i minimi retributivi fu riconosciuta alle ricostituite federazioni di categoria. La contrattazione di
categoria fu, tuttavia, inizialmente debole e, di conseguenza, i contratti nazionali erano rinnovati con
diversi anni di ritardo rispetto alle scadenza previste. La contrattazione aziendale, d’altra parte, non era
formalmente riconosciuta, anche se informalmente praticata dalle commissioni interne.
Alla fine degli anni ’50, lo sviluppo economico ed il consistente aumento dell’occupazione modificarono i
rapporti di forza a favore dei sindacati, che cominciarono anche ad operare unitariamente. Così, la
contrattazione interconfederale perse rilievo, pur senza scomparire del tutto, ed i contratti nazionali di
categoria divennero il fulcro della struttura contrattuale e la fonte principale della disciplina dei rapporti di
lavoro. Dal canto suo, la contrattazione aziendale continuò ad essere svolta dalle commissioni interne,
anche se con l’intervento crescente del sindacato provinciale di categoria.
Nel 1962 venne formalmente riconosciuto il livello di contrattazione aziendale e le federazioni dei
metalmeccanici firmarono con l’Intersind e l’Asap – le associazioni che allora rappresentavano le aziende a
partecipazione statale – un Protocollo che fissava i principi generali di un nuovo sistema contrattuale, c.d. di
contrattazione articolata, che fu poi recepito nei contratti di categoria dell’intero settore industriale.
Il Protocollo Intersind-Asap introdusse una struttura contrattuale composta di tre livelli – nazionale di
categoria (nel caso di specie, le aziende metalmeccaniche), di settore (siderurgia, auto, navalmeccanica,
ecc.) e aziendale – collegati sulla base di un criterio gerarchico: il contratto nazionale determinava,
attraverso apposite clausole di rinvio, materie e/o istituti di competenza dei livelli inferiori e l’agente
contrattuale a livello aziendale era il sindacato provinciale di categoria, e non più l’organismo di
rappresentanza dei lavoratori interno all’azienda.
In cambio del riconoscimento della contrattazione aziendale, i sindacati si impegnavano, con le c.d. clausole
di tregua (o di pace sindacale) a non promuovere azioni di lotta per modificare, integrare o innovare i
contratti collettivi in vigore fino alla loro scadenza.
In tale sistema, dunque:
44
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
• il contratto nazionale di categoria si confermava dominante, non solo perché ad esso spettava
determinare le competenze ed i soggetti della contrattazione aziendale ma, soprattutto, perché
il decentramento era ancora molto parziale;
• al livello aziendale, infatti, erano riconosciute competenze molto limitate al punto che esso, in
sostanza, aveva una funzione meramente integrativa ed applicativa del contratto di categoria;
• il livello di settore non sarebbe stato mai praticato.
3. Il ciclo 1968-1973 e la contrattazione non vincolata
Nel 1967, all’inizio di una fase di ripresa economica si avviò a livello aziendale un nuovo ciclo contrattuale,
che fu caratterizzato da un altissimo livello di conflittualità e, per la prima volta, da una diffusione capillare
della contrattazione nei luoghi di lavoro.
Gli elementi fondamentali che influenzarono tale ciclo furono, in particolare, due: la rigidità del mercato del
lavoro, caratterizzato da una tendenziale piena occupazione, e le forti esigenze di recupero salariale e di
miglioramento delle condizioni di lavoro degli operai comuni (cioè quelli poco o per nulla qualificati), che,
ormai divenuti componente centrale della classe operaia, furono i protagonisti delle lotte del periodo, insieme
alle nuove strutture di rappresentanza – delegati e consigli di fabbrica (v. cap. V, par. 2) – alle quali dettero
vita.
Anche le rivendicazioni contrattuali furono nuove e riguardarono materie che, nel sistema di contrattazione
articolata ancora formalmente in vigore, erano escluse dalla sfera di competenza della contrattazione
aziendale. L’emersione del nuovo sistema contrattuale venne sancita, sia pure informalmente, dal contratto
nazionale dei metalmeccanici del dicembre 1969 – che concluse il c.d. “autunno caldo” – in cui, infatti, non
si raggiunse alcuna intesa in materia di competenze della contrattazione aziendale ed il mancato accordo
fece venir meno il sistema della contrattazione articolata (e, quindi, sia il coordinamento fondato sulle
clausole di rinvio, sia la vincolatività della clausola di pace sindacale).
Emerse così un sistema nuovo e alternativo, c.d. di contrattazione non vincolata, in cui ciascuno dei due
livelli (nazionale di categoria ed aziendale) era formalmente autonomo e la contrattazione aziendale, in
particolare, poteva esser aperta in qualsiasi sede e per qualsiasi materia, pur in vigenza del contratto
nazionale.
La struttura contrattuale raggiunse così il massimo decentramento: i contratti aziendali, infatti, svolgevano
un ruolo non più soltanto integrativo ed applicativo, ma prevalentemente modificativo e sostitutivo e,
addirittura, trainante rispetto ai contratti nazionali, tanto da rendere questi ultimi prevalentemente strumento
di generalizzazione all’intera categoria dei risultati innovativi ottenuti dalla contrattazione in alcune grandi
aziende.
In realtà, il modello di sistema contrattuale che scaturì da queste profonde trasformazioni può esser definito
bipolare:
• il livello interconfederale scomparve per alcuni anni;
• la contrattazione aziendale crebbe ed ampliò le proprie competenze;
• il livello nazionale di categoria, pur non essendo più la sede dominante della regolamentazione e
del coordinamento negoziale, conservò funzioni di grande rilievo, come quella, appena citata, di
estendere alle aziende medio-piccole importanti innovazioni contrattuali.
Va sottolineato, però, che la contrattazione aziendale si sviluppò soprattutto su temi che non potevano
essere oggetto di una regolamentazione di categoria generale ed omogenea (ad es., ambiente e ritmi di
lavoro). Tale aspetto prefigura una tendenza essenziale della contrattazione decentrata: quella ad
assumere una funzione specializzata rispetto al contratto di categoria, consistente nell’integrare ed
adeguare la disciplina in esso dettata alle specifiche caratteristiche dei luoghi nei quali viene resa la
prestazione di lavoro.
4. Gli anni dal 1975 al 1990: ricentralizzazione e nuovo decentramento
Nel corso degli anni ’70 il sistema di contrattazione collettiva, pur rimanendo formalmente ancorato al
principio della reciproca autonomia tra i diversi livelli, cominciò a subite progressive modificazioni sotto la
spinta dei profondi mutamenti tecnologici e dell’evoluzione del mercato del lavoro. La crisi economica
e lo sfavorevole andamento del mercato del lavoro indussero un processo di ricentralizzazione della
struttura contrattuale. Questo processo si attuò inizialmente attraverso un forte recupero del ruolo del livello
interconfederale: nel ’75 fu stipulato, infatti, l’accordo interconfederale sull’indicizzazione dei salari al costo
della vita (il meccanismo della c.d. scala mobile) e nel 1977 quello sul costo del lavoro e la produttività. A ciò,
corrispose una riduzione dell’intervento dei livelli contrattuali di categoria ed aziendale.
La centralizzazione della contrattazione raggiunse il culmine nella prima metà degli anni Ottanta, con le
prime esperienze di contrattazione triangolare e, in particolare, con il Protocollo del 22/01/1983 (v. cap.
45
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
X, sez. A, par. 4) che dettò anche regole in materia di struttura contrattuale, tra cui il c.d. principio di non
ripetibilità della contrattazione aziendale su materie già definite ad altri livelli che, reintroducendo una
distinzione delle competenze dei due livelli negoziali, mirava ad evitare la sovrapposizione di discipline
contrattuali nazionali e decentrate sulle medesime materie (e la connessa duplicazione di costi).
Nella seconda metà degli anni ’80, la necessità di reggere la concorrenza internazionale (e, quindi, di
incrementare la produttività) indusse le imprese italiane a perseguire l’obiettivo di una forte flessibilità
organizzativa, da realizzare anche attraverso la diversificazione dei trattamenti di lavoro e la riduzione delle
rigidità nella regolazione dei rapporti: questa politica favorì nuovamente il decentramento contrattuale.
5. Il Protocollo 23 Luglio 1993 e la riforma della struttura contrattuale
All’inizio degli Anni ’90, la necessità di impostare politiche economiche finalizzate a contrastare il graduale
peggioramento della congiuntura economica indusse i pubblici poteri ad avviare con le parti sociali un
negoziato triangolare che portò alla stipulazione di due accordi:
• quello del 31/07/1992, che abolì la “scala mobile”;
• il Protocollo del 23/07/1993, la c.d. “carta costituzionale” delle relazioni industriali italiane.
Quest’ultimo confermò i due livelli di contrattazione, nazionale di categoria e “alternativamente aziendale o
territoriale”, e prolungò la durata dei contratti da tre a quattro anni, salvo che per la parte retributiva del
contratto nazionale, la cui durata divenne biennale: abolito il meccanismo automatico di adeguamento
all’inflazione precedentemente vigente, ciascun rinnovo biennale del contratto di categoria aveva la
funzione di adeguare i minimi retributivi ai tassi di inflazione programmati per il biennio successivo e, in
più, di riallineare le retribuzioni all’inflazione “effettiva intervenuta nel biennio precedente”, ove questa fosse
stata superiore a quella programmata.
Al contratto decentrato, invece, il Protocollo riservava un ruolo specializzato nella disciplina delle
retribuzioni, sia escludendo che a questo livello potessero essere ricontrattata materie e istituti “retributivi
propri del ccnl” (c.d. clausola di non ripetibilità), sia riconoscendogli, in via esclusiva, la funzione di
definire i c.d. premi di risultato (erogazioni correlate a miglioramenti della produttività, della qualità, ecc.
conseguiti nelle singole aziende o ambiti territoriali.
Il coordinamento tra i due livelli negoziali delle competenze era affidata, su tutte le altre materie, al
contratto nazionale di categoria, che vi doveva provvedere per mezzo di clausole di rinvio.
Insomma, il rapporto tra livelli era, per un verso, di tipo gerarchico, in quanto era il ccnl a determinare per
rinvio le materie di competenza della contrattazione decentrata e, per altro verso, di tipo funzionale, in
quanto il livello decentrato, oltre ad una funzione integrativa ed applicativa del contratto di categoria, aveva
competenze distinte e specializzate (ad es., quelle in materia retributiva).
La disciplina sul sistema contrattuale contenuta nel Protocollo era completata da alcune previsioni sul
raffreddamento dei conflitti, mirate a favorire lo svolgimento e la conclusione dei negoziati; se,
comunque, vi era un ritardo nella stipulazione del nuovo contratto, a copertura del periodo di carenza
contrattuale era prevista a favore dei lavoratori un’ indennità di vacanza contrattuale.
L’esperienza applicativa ha mostrato, però, che la contrattazione di secondo livello è stata
insoddisfacente, avendo essa coinvolto, nel settore industriale, solo le imprese di medio-grandi dimensioni,
lasciando scoperte quelle piccole e piccolissime che, a ben vedere, costituiscono gran parte della nostra
struttura produttiva. La mancanza di contrattazione di secondo livello si spiega con la debolezza sindacale
nelle imprese di minori dimensioni, derivante anche dal fatto che, in esse, non trova applicazione né il
Titolo III dello Statuto (v. cap. VI, par. 8), né l’accordo interconfederale sulle RSU (v. cap. V, par. 4). La
limitata estensione della contrattazione aziendale non è stata compensata, peraltro, dalla diffusione del
livello negoziale territoriale, idoneo a garantire copertura contrattuale a tutte le imprese, indipendentemente
dalle dimensioni. L’assenza della contrattazione decentrata in larga parte delle strutture produttive – dove, di
conseguenza, si applicava solo la disciplina del contratto nazionale – ha determinato la centralizzazione di
fatto del sistema contrattuale e, soprattutto, una crescita delle retribuzioni inferiore a quella della
produttività (evidentemente, a causa della mancata contrattazione dei premi per obiettivi).
6. L’Accordo quadro del 22 Gennaio 2009 VEDI FOTO
I punti di maggiore sofferenza degli assetti contrattuali disegnati nel ’93 si sono rivelati l’oggetto di un nuovo
negoziato sulle regole della contrattazione collettiva, che ha portato alla stipulazione dell’Accordo quadro
sulla riforma degli assetti contrattuali del 22/01/2009, che non è stato firmato dalla CGIL (e, dunque, le sue
clausole non vincolano questa organizzazione).
46
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Questo accordo è stato definito “quadro” perché detta, in via sperimentale per la durata di quattro anni, i
“principi” basilari del nuovo modello contrattuale comune al settori privato ed a quello pubblico, e rinvia
la definizione delle specifiche regole a successivi accordi.
Innanzitutto, la durata dei contratti è riportata a tre anni, mentre i livelli di contrattazione sono confermati
essere due, nazionale di categoria e decentrato e la scelta dell’ambito – territoriale e/o aziendale – di
quest’ultimo è rinviata ai successivi accordi.
In relazione alle competenze in materia di retribuzione, l’accordo, in sostituzione del tasso d’inflazione
programmata, assume come indicatore della crescita dei pressi al consumo un nuovo indice previsionale,
costruito sulla base dell’IPCA (l’indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), e
affida l’elaborazione della previsione ad un soggetto “terzo”, cioè estraneo alle parti sociali.
In questo quadro, il contratto nazionale di categoria ha la funzione di adeguare le retribuzioni
all’andamento dell’inflazione sulla base del nuovo indice previsionale e di recuperare gli eventuali
scostamenti “significativi” tra inflazione prevista e reale.
Per le pubbliche amministrazioni, il sistema deve operare “nel rispetto e nei limiti della necessaria
programmazione prevista dalla legge finanziaria”; l’indice IPCA viene assunto quale mero “parametro di
riferimento per l’individuazione dell’indice previsionale”; la verifica degli scostamenti è prevista alla
scadenza del triennio contrattuale ed il loro eventuale recupero è spostato al triennio contrattuale
successivo.
Se il contratto nazionale non ha più la funzione di aumentare le retribuzioni reali – come prevedeva il
Protocollo del ’93, utilizzando una quota della produttività media di settore – esso può definire il c.d.
elemento economico di garanzia, cioè una somma che le aziende dove non sia stato contrattato il
premio di risultato devono erogare, in sostituzione di quest’ultimo, ai propri dipendenti. Questo nuovo
istituto è stato introdotto evidentemente per incentivare le imprese a negoziare il premio stesso, poiché – in
assenza di questo – esse sono comunque obbligate ad erogare una voce retributiva aggiuntiva ai minimi
che, per di più, è slegata da qualunque parametro riconducibile all’andamento economico produttivo.
Quanto alle competenze del contratto decentrato, l’accordo conferma quella relativa ai premi di risultato
o per obiettivi, già previsti dal Protocollo del ’93.
Inoltre, relativamente al coordinamento tra i due livelli, l’intesa conferma la funzione del contratto
nazionale di determinare le competenze di quello decentrato, prevedendo che quest’ultimo regoli le
materie delegate dal contratto nazionale o dalla legge e, comunque, solo le materie e gli istituti che non
siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione: la clausola di non ripetibilità, dunque, è stata
estesa dai soli istituti retributivi – com’era nel Protocollo del ’93 – alla totalità degli stessi.
Queste previsioni sembrano configurare il rapporto tra i livelli contrattuali in senso più nettamente gerarchico
rispetto al sistema previgente; tuttavia, i contratti decentrati possono derogare, anche in pejus, la
disciplina dei singoli istituti economici o normativi dettata dal contratto nazionale di categoria, ove ciò
sia funzionale a governare situazioni di crisi o a favorire lo sviluppo economico ed occupazionale di un
territorio (c.d. clausole di uscita o di apertura, che possono ora essere inserite nel ccnl).
Per garantire la corretta applicazione delle regole sulla ripartizione delle competenze, l’intesa prevede che
eventuali controversie in materia siano disciplinate con strumenti di conciliazione ed arbitrato (v. sez. B,
par. 4).
L’accordo, infine, promuove un rafforzamento delle procedure negoziali per favorire il regolare
svolgimento delle trattative contrattuali (ad es., prevede che le Confederazioni possano intervenire nei
casi di crisi di un negoziato, al fine di favorirne la positiva conclusione).
6.1.Le intese successive all’AQ del 2009 e la vertenza FIAT VEDI FOTO
Dopo l’Accordi quadro, una serie di intese interconfederali sugli assetti contrattuali sono state sottoscritte
nel settore privato. Dalle relative discipline, emerge che al modello contrattuale disegnato dall’AQ
corrispondono – come già avvenne con l’applicazione del Protocollo del ’93 – una pluralità di sistemi
contrattuali, che presentano gradi differenti di centralizzazione e decentramento (in agricoltura, ad es., si
può parlare di un modello sostanzialmente bipolare; nell’artigianato, invece, il modello appare addirittura
tripolare perché anche al livello confederale sono affidate competenze negoziali, ecc.).
47
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Un primo elemento dei nuovi Accordi interconfederali da sottolineare è che – salvo quelli dell’agricoltura
e del settore bancario – sono tutti separati, perché non firmati dalla CGIL, elemento, questo, che innestava
conflitti soprattutto sotto il profilo dell’efficacia soggettiva di tali accordi, limitata ai soggetti collettivi
firmatari ed ai loro iscritti. D’altra parte, l’efficacia dei nuovi assetti contrattuali appariva condizionata
negativamente anche dal contesto economico-produttivo, segnato dalla caduta della domanda, dal connesso
aumento della disoccupazione, ma anche dall’esposizione alla concorrenza globale, che sembra dare
alle imprese maggior potere di pressione sui sindacati, per indurli a scambiare concessioni in tema di
flessibilità del lavoro con la tutela dei livelli occupazionali (piuttosto che aprire spazi alla negoziazione di
aumenti salariali).
Emblematica è, a proposito, la vicenda FIAT, che ha messo in evidenza profili critici delle relazioni industriali
italiane: la derogabilità in pejus del ccnl; la misurazione della rappresentatività sindacale ai fini della
legittimazione a negoziare; l’efficacia soggettiva dei contratti collettivi, e la garanzia del loro rispetto da
parte di tutti i soggetti coinvolti nello scambio contrattuale, ecc..
La vertenza, che ha avuto origine dalla situazione di crisi produttiva degli stabilimenti e dalla decisione di
passare a nuovi sistemi produttivi, ha portato alla stipulazione, il 15/16/2010, dell’Accordo per lo
stabilimento di Pomigliano (poi replicato a Mirafiori ed alle officine di Grugliasco) che, in vista
dell’attuazione di un consistente piano di investimenti annunciato dall’Azienda, ha introdotto deroghe
peggiorative al contratto nazionale di categoria in materia.
È stato un caso da manuale di contrattazione “concessiva”, compatibile col nuovo modello contrattuale
definito nell’AQ del 2009, nonché con l’accordo modificativo del ccnl dei metalmeccanici sottoscritto nel 2010
da CISL e UIL per dare applicazione alle nuove regole in materia di clausole d’uscita. Il problema, però, è
che la FIOM-CGIL non ha firmato quest’ultimo accordo, né il contratto nazionale di categoria del 2009, né il
contratto FIAT, e per questo ha proposto numerosi ricorsi giudiziari, sostenendo che ai propri iscritti
poteva essere applicato solo il ccnl unitario del 2008 (ancora basato sulle regole del Protocollo del
1993), che non prevedeva le clausole d’uscita. La conseguenza è che i lavoratori non iscritti al sindacato,
o iscritti alla FIOM, avrebbero potuto sottrarsi all’applicazione di contratti aziendali in deroga peggiorativa,
come quello FIAT.
La contromossa della FIAT è stata quella di sostituire con propri contratti collettivi quelli stipulati da
Federmeccanica e da Confindustria e, per questo, di uscire da tali associazioni. Il 29/12/2010, infatti, FIAT,
CISL, UIL, Fismic e Associazione Quadri e Capi Fiat hanno stipulato un nuovo accordo, definito specifico di
primo livello perché sostitutivo del ccnl sottoscritto da Federmeccanica; ad esso, ha fatto seguito – il
7/02/2011 – la stipulazione di un accordo di secondo livello tra organizzazioni sindacali e Fabbrica Italia
Pomigliano S.p.A..
Dal punto di vista del sistema della contrattazione collettiva, quello della FIAT costituisce un caso di
contrattazione (non in deroga, ma) di uscita dal ccnl – messo in discussione dall’Azienda come strumento
di tutela dei suoi specifici interessi di impresa multinazionale – il che implicherebbe, secondo alcuni
commentatori, la rottura del modello contrattuale fondato sul doppio livello e sul ruolo del ccnl. Più
specificamente, il modello di derogabilità controllata a livello decentrato, introdotto dall’AQ del 2009,
sarebbe così sostituito da un modello di decentramento non controllato o disorganizzato. In realtà, la
vera motivazione dell’iniziativa FIAT non è stata l’esigenza di sottrarsi alle rigidità del contratto nazionale
(dato che quest’ultimo – modificato nel 2009 coerentemente con l’AQ dello stesso anno – risulta ampiamente
derogabile a livello aziendale), quanto piuttosto un interesse gius-lavoristico: quello di sottrarsi
all’applicazione dei contratto e degli accordi collettivi stipulati da Federmeccanica e da Confindustria in
materia di rappresentanza e di diritti sindacali in azienda, in modo da escludere la presenza della FIOM –
non firmataria del contratto collettivo applicato e, dunque, non legittimata ai sensi dell’art. 19, St. lav. (v. cap.
IV, sez. A, parr. 4 e 5) – dai propri stabilimenti.
Altro problema posto dall’accordo di Pomigliano del 2010 concerne la governabilità dell’impianto in relazione
al rispetto degli accordi sottoscritti. Su questo profilo, l’intesa prevede sia che le sue disposizioni siano
inserite nei contratti individuali di lavoro, sia una clausola di responsabilità (con la quale “le parti si danno
atto che comportamento individuali e/o collettivi dei lavoratori idonei a violare […] le clausole del contratto
collettivo […] producono per l’Azienda effetti liberatori”), la cui formulazione lasciava intendere una
responsabilità disciplinare dei lavoratori in caso di sciopero; successivamente si è convenuto, però, di
interpretarla come una clausola di pace sindacale, che vincola le sole organizzazioni sindacali.
6.2.L’Accordo Interconfederale del 28 Giugno 2011 VEDI FOTO
L’anomalia di un sistema contrattuale regolato da un accordo separato è stata rimossa, nell’area delle
imprese aderenti a Confindustria, dall’AI stipulato il 28/06/2011 tra questa e CGIL, CISL e UIL che integra, e
in parte modifica, le regole definite nelle precedenti intese del 2009, che CGIL non aveva sottoscritto. Il
recupero dell’unità sindacale e la condivisione delle nuove regole rappresentano, dunque, i valori
fondamentali dell’Accordo del 2011. Già nella Premessa ad esso, infatti, le parti hanno riconosciuto che “un
sistema di relazioni sindacali e contrattuali in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai
tempi ed ai contenuti della contrattazione collettiva, ma anche sull’affidabilità ed il rispetto delle regole
48
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
stabilite” è essenziale perché le relazioni industriali possano svolgere il proprio ruolo nel sistema economico
e sociale.
In materia di struttura della contrattazione collettiva, anche il nuovo accordo mira ad incentivare il
decentramento, tuttavia confermando il doppio livello contrattuale coordinato (il che non era scontato
dopo la vertenza FIAT):
• il contratto di categoria, dunque, conserva la funzione di definire trattamenti minimi omogenei
per tutti i lavoratori rientranti nel suo ambito di applicazione;
• resta il principio – già presente negli accordi del 2009 – che le competenze del contratto aziendale
sono delegate sia dal contratto nazionale, sia dalla legge.
Quest’ultimo riferimento implica la possibilità di un decentramento più disorganizzato, per il contrasto che
può emergere tra le competenze rinviate dall’una e dall’altra fonte.
Nell’Accordo del 2011 non è stata riproposta la clausola di non ripetibilità, che ha sostanzialmente la
funzione di blindare il principio per cui la contrattazione decentrata deve svolgersi nei limiti delle materie e
degli istituti delegati. Se il suo mancato inserimento è parso ad alcuni irrilevante, tuttavia, poiché è altrettanto
verosimile che essa possa avere anche la funzione di limitare i rinvii della legge al secondo livello, almeno
per le materie già disciplinate dal ccnl, la sua eliminazione potrebbe essere stata motivata dalla volontà
delle parti di “aprire” ai rinvii legislativi, onde favorire un decentramento più ampio, anche se più
sregolato.
Funzionale ad incentivare il decentramento è, poi, la nuova disciplina delle clausole di uscita, definite
dall’AI 2011 “strumenti di articolazione contrattuale” e mirate “ad assicurare la capacità [dei contratti] di
aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi”. Rispetto al già citato AI sottoscritto tra Confindustria,
CISL e UIL nell’Aprile 2009, vi sono differenze formali e sostanziali:
• in primo luogo, le intese possono ora essere aziendali, e non più territoriali, con quanto ciò
implica in termini di crescente diversificazione delle discipline nelle singole imprese;
• alle due condizioni previste nell’AI del 2009 per la stipulazione di contratti in deroga peggiorativa –
l’individuazione nei contratti di categoria dei parametri oggettivi cui ancorare la deroga, e la
preventiva approvazione di tali contratti da parte dei soggetti negoziali nazionali – l’AI del 2011
sostituisce una formulazione più vaga, in quanto rinvia ai contratti di categoria la determinazione
dei limiti e delle procedure da osservare per la stipulazione di accordi aziendali in deroga
peggiorativa.
Transitoriamente – cioè fin quando i contratti di categoria non provvederanno a dettare una disciplina in
materia – l’AI unitario del 2011 prevede che gli accordi aziendali “al fine di gestire situazioni di crisi o in
presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa”
possano modificare in pejus “gli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la
prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro”, a condizione che i contratti aziendali siano
conclusi dalle rappresentanze sindacali (rsa o rsu) “d’intesa con le organizzazioni sindacali territoriali
firmatarie” del nuovo AI. Tale condizione presuppone, per la validità del contratto, un consenso unanime di
queste ultime e, dunque, esclude la possibilità di accordi in deroga separati: almeno ai fini
dell’ordinamento intersindacale, anche se non di quello giuridico-statuale. Infatti, la mancata stipulazione da
parte di un sindacato territoriale aderente ad una delle confederazioni firmatarie dell’AI difficilmente può
condurre ad un giudizio di invalidità del contratto aziendale, poiché – secondo un orientamento diffuso in
giurisprudenza e dottrina – sono da ritenere validi i contratti aziendali, anche separati, che prevedono
deroghe ulteriori e più ampie di quelle consentite dal contratto nazionale. Semmai, il problema attiene
all’efficacia soggettiva degli accordi derogatori che non rispettino le regole dettate a livello superiore; non
a caso, l’AI prevede che le intese modificative esplicano “efficacia generale come disciplinata nel
presente accordo”.
In ogni caso, la condizione relativa alla “intesa con le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie” introduce
una modalità di controllo e di validazione dell’accordo in deroga da parte del sindacato esterno (firmatario del
contratto di categoria derogato), che poi è anche uno strumento di raccordo soggettivo tra i livelli.
Va notato, da ultimo, che l’accordo del 2011 non prevede che l’assenza, nelle piccole imprese, della
contrattazione aziendale possa essere compensata da quella territoriale. Dunque, anche con il nuovo
accordo interconfederale, il contratto di categoria resta l’unico applicabile ai lavoratori dipendenti dalle
imprese di piccole dimensioni.
L’AI del 2011, come si è accennato, introduce altre importanti novità, in quanto regola la rappresentatività
delle organizzazioni sindacali al fine:
• della legittimazione a negoziare i contratti nazionali di categoria (ma non quelli decentrati), al
cui fine adotta il criterio di misurazione – già presente nelle PA (v. cap. V, sez. B, par. 2) – delle
49
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
deleghe associative, da ponderare coi voti ottenuti nelle elezioni delle RSU. Si badi che la
rappresentatività così misurata serve esclusivamente al fine della ammissione alle trattative, mentre
nulla vien detto sul livello di rappresentatività minima necessario per la stipulazione del contratto, e
ciò potrebbe continuare a permettere la sottoscrizione di contratti nazionali separati ed anche con
sindacati complessivamente minoritari;
• di definire le condizioni per attribuire efficacia generale ai contratti aziendali, per cui l’AI
attribuisce efficacia generale al contratto aziendale (ed anche quindi, come accennato, alle
“specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei ccnl”) approvato:
• se nell’impresa son presenti RSU, dalla “maggioranza dei componenti” delle stesse;
• se nell’impresa son presenti RSA, da quelle “maggioritarie”, in base al numero di lavoratori
iscritti ai sindacati di riferimento.
In caso di sottoscrizione da parte delle RSA, però, per sottolineare la preferenza accordata alle RSU
è prevista la possibilità di ricorrere ad un referendum confermativo, con la conseguenza che, se
l’intesa è respinta, essa non potrà spiegare efficacia erga omnes;
• di definire le condizioni per attribuire efficacia generale alle clausole di tregua sindacale, che
“hanno effetto vincolante esclusivamente per tutte le rappresentanze sindacali firmatarie del
presente accordo interconfederale operanti all’interno dell’azienda e non per i singoli lavoratori”.
Quest’ultima precisazione risulta conforme all’interpretazione storicamente consolidata dell’art. 40
Cost., poiché esclude qualsiasi effetto limitativo dell’adesione individuale allo sciopero (v. cap VII,
sez. A, par. 9). Essa implica, peraltro, che il sindacato che appartiene ad una confederazione
firmataria dell’AI del 28 Giugno, ma non sottoscrive il contratto aziendale, non può contrapporsi ad
esso con il conflitto. Insomma, la novità di fondo di queste clausole è l’imposizione dell’obbligo di
tregua anche ai sindacati che non stipulano il contratto aziendale.
6.3.La contrattazione di prossimità: l’art. 8, d.l. 138/2011 VEDI FOTO
Poco dopo la sottoscrizione dell’Accordo del 2011, però, anche il legislatore è intervenuto su alcune delle
materie in esso previste con l’art. 8, d.l. 138/2011 – convertito dalla l. 148/2011 – rubricato “sostegno alla
contrattazione collettiva di prossimità”. Tale disposizione si segnala per due fondamentali innovazioni:
• in primo luogo, con una previsione inedita, riconosce efficacia erga omnes ai contratti collettivi
di secondo livello;
• e, in secondo luogo, attribuisce ad essi la facoltà di derogare in pejus alle discipline legislative
ed alle previsioni dei contratti nazionali.
La ratio è, evidentemente, quella di consentire la flessibilizzazione e la diversificazione della disciplina dei
rapporti individuali di lavoro ad opera dei contratti decentrati e di garantire la loro applicazione generale,
neutralizzando il dissenso di singoli lavoratori e gruppi organizzati.
Esaminando più in dettaglio la norma, va rilevato che essa sancisce, anzitutto, l’efficacia nei confronti di
tutti i lavoratori interessati di “specifiche intese”, realizzate nel contesto dei “contratti collettivi di lavoro
sottoscritti a livello aziendale o territoriale”. Tali intese – che possono riguardare la regolazione delle materie
inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a numerosi ambiti elencati al comma
2 del medesimo art. 8 – possono operare “anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le
materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi
nazionali di lavoro”.
Va, peraltro, considerato che tali effetti possono essere prodotti solo dalle intese sottoscritte nel rispetto dei
presupposti e dei limiti dettati dall’art. 8. Al riguardo, in merito ai livelli ed ai soggetti competenti a
sottoscrivere l’intesa, dev’essere in particolare evidenziato che i contratti collettivi idonei a produrre gli effetti
contemplati dalla previsione:
• possono essere “sottoscritti a livello territoriale o aziendale”;
• se territoriali, devono essere sottoscritti “da associazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o territoriale”;
• se aziendali, possono essere sottoscritti, indifferentemente, dai citati soggetti esterni (territoriali, ma
anche nazionali) ovvero dalle “loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della
normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti”.
Per quanto attiene alla sede aziendale di contrattazione, dunque, la legittimazione negoziale è attribuita
separatamente a ciascuno dei soggetti menzionati dalla legge e, pertanto, non è necessaria la sottoscrizione
congiunta, né alcuna assistenza del sindacato territoriale rispetto all’azione negoziale delle rappresentanze
50
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
aziendali. Tra i soggetti richiamati dall’art. 8, inoltre, vanno certamente ricomprese anche le (sole) RSA,
purché operino ai sensi della normativa di legge (e cioè dell’art. 19 St. lav.). Ciò significa, tra l’altro, che al
tavolo negoziale possono sedere solo soggetti che posseggano già il requisito di cui all’art. 19. Inoltre, nel
riferirsi alle “loro rappresentanze sindacali operanti in azienda”, la lettera della legge esclude anche le RSA
che non siano costituite nell’ambito di “associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale o territoriale”. Questa interpretazione, al contempo, contribuisce a ridimensionare il rischio
che si creino in azienda RSA “di comodo”, al precipuo scopo di favorire la sottoscrizione di intese aziendali in
deroga: quantomeno, tali RSA non potrebbero essere costituite al di fuori delle associazioni
comparativamente più rappresentative.
Non può poi trascurarsi il fatto che le intese debbono essere “sottoscritte sulla base di un criterio
maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali”, il che rappresenta un’ assoluta novità nella
formulazione delle norme di rinvio.
Per quanto attiene, poi, agli obiettivi considerati nel comma 1 dell’articolo, se è pur vero che la loro
ampiezza renderà più agevole dimostrarne la sussistenza (si pensi alla “ qualità dei contratti di lavoro”,
all’”adozione di forme di partecipazione dei lavoratori”, ecc.), non v’è dubbio che dall’accordo debba,
quantomeno, potersi desumere che le regole adottate siano effettivamente strumentali al
raggiungimento di uno o più tra gli obiettivi indicati.
Per quanto concerne, invece, le materie sulle quali le intese possono incidere, va sottolineato che l’elenco
contenuto nel comma 2 dev’esser interpretato – secondo la dottrina e la Corte costituzionale – in senso
restrittivo.
Infine, può esser ricordato che l’art. 8, al comma 3 stabilisce che “le disposizioni contenute in contratti
collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 Giugno
2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto
stesso si riferisce, a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori”. Con
riferimento a questa previsione, ci si limita ad osservare che essa pare rispondere all’esigenza di garantire al
gruppo FIAT la tenuta degli accordi pregressi (cui si è già fatto cenno), evitando di sottoporli alle nuove
procedure dell’AI 2011.
Più in generale, merita di essere sottolineato che sull’art. 8 si è sviluppato un ampio dibattito che, come
intuibile, ha avuto tra i punti di maggior interesse quelli relativi:
• in primo luogo, alle sue interferenze con il travagliato processo di riforma del sistema contrattuale e
con le coeve vicende che hanno interessato il gruppo FIAT;
• in secondo luogo, alla sua esegesi, in considerazione delle numerose incertezze interpretative;
• infine, alle conseguenze, anche sociali, che potrebbero derivare dall’ampio rinvio derogatorio in essa
contenuto, che mette in discussione le fondamenta stesse del diritto del lavoro.
Ai suddetti profili è necessario però aggiungere quelli relativi ai problemi di costituzionalità della
previsione. Particolarmente rilevanti sono le questioni relative al contrasto con:
• art. 39, c.1, che garantisce la libertà sindacale
La disposizione individua, infatti, attori e funzioni dei contratti collettivi e disciplina i rapporti tra i contratti di
diverso livello, sovrapponendosi all’autonomia delle parti. Infatti, il legislatore si riferisce ripetutamente all’AI
del 2011, ma va ben oltre le previsioni di quest’ultimo. Ed invero, mentre l’AI, confermando il ruolo di
“governo” del decentramento dei contratti di categoria, rinvia ad essi la determinazione delle materie e delle
procedure da osservare per la stipulazione degli accordi decentrati in deroga, la legge amplia a dismisura gli
spazi per le possibili deroghe al ccnl. In tal modo, la legge finisce per favorire la destrutturazione degli assetti
contrattuali fondati sui contratti nazionali di categoria, aprendo la strada ad un decentramento contrattuale
disorganizzato, ed altera gli equilibri raggiunti al tavolo negoziale che ha condotto alla sottoscrizione dell’AI.
• art. 39, cc. 2-4, che apprestano uno specifico meccanismo di estensione del contratto collettivo
Per quanto concerne, poi, la previsione di efficacia generalizzata delle intese disciplinate dall’art. 8, alcuni
autori ne hanno evidenziato il contrasto con la seconda parte dell’art. 39 Cost., poiché la Costituzione
conferisce efficacia erga omnes ai contratti collettivi (art. 39, c. 4) quando siano stipulati dai soggetti forniti
dei requisiti ivi specificati e in base alla procedura prevista (cc. 2, ss.); di conseguenza, ogni legge che
cercasse di conseguire il medesimo risultato in maniera diversa sarebbe illegittima (v. cap. VII, sez. A, parr.
4-6). Circa la riferibilità o meno della disposizione costituzionale in questione anche ai contratti aziendali, va
precisato che la stessa Corte ha riconosciuto che l’art. 39 Cost. contempla non solo i contratti collettivi
destinati a regolare i rapporti individuali di lavoro di una o più categorie professionali, ma anche quelli relativi
ad una o più imprese.
51
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
• art. 3 , che garantisce l’uniformità su tutto il territorio nazionale della disciplina dei rapporti tra
privati, e consente normative differenziate solo nei limiti dettati dal principio di ragionevolezza
La previsione, si è sostenuto, consentirebbe una diversificazione delle tutele non paragonabile a quella
sinora ammessa dagli interventi legislativi che attribuiscono competenze derogatorie alla contrattazione
collettiva. Sotto questo aspetto, non può negarsi che il nuovo modello di rapporti tra legge e contrattazione
collettiva emergente dall’art. 8 non ha pari nel quadro dei precedenti modelli. In questo caso, la quantità dei
rinvii derogatori al contratto e la qualità delle materie interessate rende l’intervento tutt’altro che sintonico con
le tecniche di flessibilità contrattata e controllata, già da tempo sperimentate.
• art. 117, che pone le regole relative all’esercizio della potestà legislativa, ed al riparto di
competenze tra Stato e Regioni
Al momento, la Corte costituzionale si è espressa, in sent. 221/2012, con la quale è stato respinto il ricorso
della Regione Toscana per la dichiarazione d’incostituzionalità dell’art. 8. In tale pronuncia, la Corte ha
osservato che le materie indicate dall’art. 8, c. 2 “concernono aspetti della disciplina sindacale ed
intersoggettiva del rapporto di lavoro, riconducibili tutti alla materia dell’ordinamento civile, rientrante nella
competenza legislativa esclusiva dello Stato” e che, pertanto, le intese previste dal comma 2-bis non sono
idonee ad “incidere sulla legislazione regionale emanata in materia di tutela del lavoro, demandata alla
legislazione concorrente tra Stato e Regioni”.
Restano, dunque, impregiudicati gli altri profili di costituzionalità cui si è fatto riferimento, ivi compreso quello
relativo all’ipotizzata violazione dell’art. 39, c. 4 Cost., poiché nella sent. cit. la Corte ha evitato di
pronunciarsi sulla questione.
6.4.L’accordo programmatico interconfederale sulla produttività del 21 Novembre 2012 VEDI
FOTO
A distanza di più di un anno dall’intervento legislativo descritto, il 21/11/2012 è stato firmato un accordo sulle
“Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia”, una nuova
intesa che ha elementi di continuità con l’evoluzione delle relazioni industriali italiane esaminata nei
paragrafo precedenti: rafforza la contrattazione decentrata, confermando il sistema di decentramento
controllato dal livello nazionale.
Sul piano politico-sindacale, l’accordo si segnala per due aspetti:
• al pari degli accordi interconfederali del 2009, non è stato sottoscritto dalla CGIL;
• al pari dell’AQ del 2009 – e a differenza dell’AI del 2011 – è stato sottoscritto da quasi tutte le
associazioni d’impresa.
L’accordo conferma il sistema a doppio livello contrattuale e:
• con una formula identica a quella dell’AI 2011, conferma la tradizionale funzione del contratto
nazionale di categoria “di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni
per tutti i lavoratori, ovunque impiegati nel territorio nazionale”;
• esso, peraltro, finalizza più esplicitamente il ruolo della contrattazione di secondo livello
all’aumento della produttività, “attraverso un migliore impiego dei fattori di produzione e
dell’organizzazione del lavoro”.
Circa il rapporto tra i due livelli contrattuali, è pure confermato il ruolo del contratto nazionale di
categoria nella definizione delle competenze della contrattazione decentrata ma, ferma restando la sua
funzione di “governo” del sistema contrattuale, si pongono le condizioni perché un ruolo decisivo possa
essere svolto dalla contrattazione di secondo livello. Coerentemente, l’autonomia contrattuale di
categoria viene quasi “precettata” attraverso l’indicazione sia delle materie e/o degli istituti nella cui
regolazione va privilegiata la contrattazione decentrata, sia degli strumenti da utilizzare. Si tratta di un’
indicazione molto più stringente rispetto agli accordi precedenti – come si evince dal frequente ricorso al
verbo dovere – forse connessa alla consapevolezza che tutti gli inviti rivolti nei precedenti accordi ai soggetti
della contrattazione di categoria ai fini dell’ampiamento delle competenze del secondo livello sono rimasti
sostanzialmente disattesi.
Cominciando dalla funzione dei due livelli in materia di RETRIBUZIONE, si conferma che il contratto
nazionale di categoria “deve rendere la dinamica degli effetti economici […] coerente con le tendenze
generali dell’economia, del mercato del lavoro, del raffronto competitivo internazionale”, come a dire che il
recupero del potere d’acquisto – se dette condizioni sono negative – può non essere totale.
I contratti di categoria, inoltre, possono prevedere “che una quota degli aumenti economici derivanti dai
rinnovi contrattuali sia destinata alla pattuizione di elementi retributivi da ricollegarsi ad incrementi di
52
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
produttività e redditività definiti dalla contrattazione di secondo livello, così da beneficiare anche di
congrue e strutturali misure di detassazione e decontribuzione per il salario di produttività definito dallo
stesso livello di contrattazione. Tale quota resterà parte integrante dei trattamenti economici comuni
per tutti i lavoratori rientranti nel settore di applicazione dei contratti nazionali laddove non vi fosse o
venisse meno la contrattazione di secondo livello”.
Si tratta proprio di uno dei profili ambigui dell’Accordo del 2012: secondo la CGIL, ad esempio, questa
previsione riconoscerebbe alla contrattazione decentrata la facoltà di derogare in pejus anche i minimi
retributivi nazionali, ed è stato questo uno dei motivi per i quali non ha firmato l’accordo (si pensi, in
concreto, all’ipotesi che in un’ impresa si registri un andamento negativo della produttività: ove si svolgesse
la contrattazione aziendale, i lavoratori perderebbero il diritto alla “quota” retributiva definita dal ccnl e il
salario di produttività negoziato in tale sede potrebbe anche essere inferiore a questa o, addirittura, nullo). A
ben vedere, però, non sembra che la nuova previsione modifichi sostanzialmente l’AQ del 2009 (accettato
implicitamente dalla CGIL con la firma dell’Accordo del 2011) in materia di elemento di garanzia retributiva,
considerato che anche l’erogazione di tale elemento era assoggettata alla condizione che i lavoratori non
fossero coperti da un contratto di secondo livello.
Certo, il fatto che nel nuovo accordo si faccia riferimento ad una “ quota degli aumenti economici” e non ad
una “voce” particolare della retribuzione (come l’elemento di garanzia retributiva), può fare la differenza in
termini di rapporto tra i livelli:
• nel Protocollo del ’93, ad es., per la determinazione a livello decentrato del premio di risultato o per
obiettivi si prevedeva di impiegare la quota di produttività “eccedente quella eventualmente già
utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL”;
• nell’Accordo del 2012, invece, si consente alla contrattazione decentrata di assorbire in parte
l’aumento retributivo previsto da quella di categoria e, quindi, si indebolisce ulteriormente il ruolo di
questo livello contrattuale in materia di retribuzione.
Si possono così promuovere le realtà produttive più dinamiche, concentrando su queste le scarse
risorse disponibili per il finanziamento delle misure legislative di defiscalizzazione e di
decontribuzione.
In definitiva, la funzione del secondo livello resta quella di correlare la crescita delle retribuzioni dei
lavoratori “al raggiungimento di obiettivi”.
L’accordo detta poi i principi ed individua gli strumenti – le clausole di delega e di uscita – destinati a
distribuire tra i livelli tutte le altre competenze. In particolare:
• il ccnl “deve perseguire la semplificazione normativa, il miglioramento organizzativo e gestionale,
prevedere una chiara delega al secondo livello di contrattazione delle materie e delle modalità
che possono incidere positivamente sulla crescita della produttività […]”.
• correlativamente, “la contrattazione di secondo livello deve disciplinare, valorizzando i demandi
specifici della legge o della contrattazione collettiva, gli istituti che hanno come obiettivo quello di
favorire la crescita della produttività aziendale […] attraverso un migliore impiego dei fattori di
produzione e dell’organizzazione del lavoro”.
Risulta evidente che il nuovo accordo è diretto a restringere la funzione normativa del contratto di
categoria e, correlativamente, ad ampliare ed approfondire in misura significativa le competenze della
contrattazione decentrata, perché possa “specializzare” la disciplina dei rapporti individuali di lavoro a
seconda degli interessi aziendali o territoriali delle parti negoziali.
Coerenti con questo tendenziale rovesciamento del rapporto tra livello nazionale e decentrato, sono altri
due degli obiettivi perseguiti:
• la semplificazione normativa del ccnl, in modo da valorizzare la delega di competenze al secondo
livello;
• quello di “agevolare la definizione di intese modificative delle norme contrattuali, più mirate alle
esigenze degli specifici contesti produttivi”.
È da notare che qui viene ripresa la formulazione “soft” usata nell’AI 2011 in luogo di quella – più
esplicita – di clausole di uscita. Da questo punto di vista, la modifica più rilevante riguarda
l’ampliamento delle finalità perseguibili attraverso la derogabilità in pejus del contratto nazionale da
parte di quello decentrato (che è, poi, un’ altra motivazione della mancata firma dell’Accordo da
parte della CGIL).
In definitiva, dunque, la contrattazione di secondo livello può:
• sia disciplinare direttamente talune materie e/o istituti sulla base delle clausole di delega;
• sia derogare il contratto di categoria.
Dalla descrizione che precede, poi, emergono alcuni profili di continuità tra taluni contenuti dell’Accordo e la
scelta legislativa consacrata nell’art. 8, l. 148/2011. Infatti, per depotenziare la carica dirompente del sistema
53
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
contrattuale rappresentata da tale previsione (v. par. 6.3) – salvaguardandone, però, le capacità di
flessibilizzazione – le parti hanno rivendicato una riforma legislativa che consenta che “la contrattazione
collettiva fra le organizzazioni comparativamente più rappresentative, nei singoli settori, su base nazionale,
si eserciti, con piena autonomia, su materie oggi regolate in maniera prevalente o esclusiva dalla legge che
incidono sul tema della produttività del lavoro” (c.d. contrattazione collettiva per la produttività).
Infine, le Parti “per dare effettività a un sistema ordinato di relazioni industriali, definiscono un altrettanto
ordinato sistema di regole sulla rappresentanza”, prevedendo che entro il 31/12/2012 la materia venga
“disciplinata, con accordo e regolamento integrativo, per consentire il rapido avvio della procedura per la
misurazione della rappresentanza nei settori di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro”, in
attuazione dei principi contenuti nell’Accordo 2011. Entro la stessa data, “saranno definite, per i settori
interessati, le modifiche da introdurre alla disciplina delle RSU contenuta nell’AI 20/12/1993, per
armonizzarle con le finalità fissate il 28/06/2011 (esplicitare il superamento del terzo)”.
Su queste previsioni c’è solo da sottolineare, da un lato, che vincolano solo le parti che hanno stipulato
anche l’Accordo del 2011 (e non tutte quelle firmatarie dell’intesa del 2012); dall’altro, che nessuno dei due
accordi previsti in quest’ultima è stato concluso entro la data indicata.
In conclusione, nella prospettiva del “sistema” contrattuale va sottolineato che, se il caso FIAT ha messo
direttamente in discussione il sistema tradizionale di contrattazione a doppio livello, gli accordi
interconfederali del 2011 e del 2012 lo hanno salvaguardato. La derogabilità del contratto nazionale di
categoria, infatti, può costituire un argine alle tendenze centrifughe nella regolazione dei rapporti di lavoro,
poiché le deroghe possono consentire di conciliare le spinte alla diversificazione delle condizioni di lavoro
con il mantenimento di una cornice generale di tutele definita dal centro e, quindi, di conservare il
sistema di decentramento controllato.
Di certo, gli ultimi accordi, definendo un sistema contrattuale più marcatamente decentrato confermano la
cesura tra due epoche contrattuali:
• quella precedente alla globalizzazione, in cui decentramento e centralizzazione si alternavano
nettamente in relazione all’andamento positivo o negativo del ciclo economico e del mercato del
lavoro,
• e quella successiva, in cui la tendenza al decentramento diviene stabile, e mira a consentire
l’adeguamento flessibile delle condizioni di lavoro nelle singole imprese o nelle diverse aree
territoriali all’andamento del contesto economico-produttivo.
Sul futuro del sistema contrattuale e delle relazioni industriali pesano diverse variabili: la divisione dei
sindacati, una crisi economico-finanziaria su cui lo Stato ha una ridotta capacità di governo ed un quadro
politico incerto. Se queste non dovessero influire negativamente, resterà da vedere se le regole sulla
struttura contrattuale e, in particolare, le clausole di uscita saranno effettivamente in grado di salvaguardare
la centralità del contratto collettivo nazionale e la sua funzione storica.
La sfida per il futuro è, in sostanza, quella tra un più deciso potenziamento della contrattazione
decentrata, ma controllato dal centro, ed una definitiva erosione della contrattazione collettiva come
“sistema”.
7. Il processo di stipulazione e di rinnovo del contratto collettivo
Come visto, il Protocollo del 1993 e l’Accordo del 2009 hanno formalizzato e rafforzato le procedure di
stipulazione dei contratti collettivi, nazionali e decentrati. Il processo negoziale, peraltro, segue prassi ormai
notevolmente consolidate:
• prima della fase di trattativa, si ha la presentazione – normalmente al datore di lavoro o alle
organizzazioni datoriali – della c.d. piattaforma rivendicativa, ossia il documento contenente
l’elenco delle richieste di modifica del contratto in scadenza (o già scaduto);
• qualche mese prima della scadenza del contratto, le parti si incontrano per avviare le trattative di
rinnovo del contratto, ove per “rinnovo” s’intende la stipulazione di un nuovo contratto che
sostituisca il precedente. In concreto, la contrattazione non modifica la disciplina precedente nella
sua globalità, bensì la aggiorna nei contenuti che hanno formato oggetto del conflitto.
Le trattative possono prolungarsi nel tempo e, una volta scaduto il periodo di tregua sindacale,
essere intramezzate da scioperi;
• quando il conflitto è particolarmente aspro, può aversi la c.d. mediazione politica, ossia
l’intervento di un soggetto pubblico in veste di compositore;
54
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
• le trattative terminano con la stipulazione dell’accordo di rinnovo del contratto collettivo, di solito
sottoposto alla ratifica dei lavoratori tramite assemblee ovvero, più di recente, referendum (c.d.
democrazia di ratifica). Tale prassi viene negata in caso di accordo separato, a conferma del fatto
che la democrazia sindacale può essere realmente praticata solo in caso di azione unitaria tra le
tre grandi confederazioni.
L’ultimo aspetto da considerare riguarda la legittimazione rappresentativa e negoziale delle
organizzazioni, in quanto la pluralità di sindacati può dar luogo ad un conflitto di rappresentanza tra gli stessi,
che in genere ricorre ove più sindacati si dichiarino rappresentativi di una stessa categoria, ovvero quando
ha luogo il c.d. conflitto di giurisdizione, ossia un dissenso sulla definizione dell’ambito del contratto
(v. cap. III, sez. B, par. 1). Tale conflitto:
• non può sorgere nel settore pubblico, poiché in esso vige un sistema legale di misurazione della
rappresentatività ed è la legge che fa derivare la legittimazione a negoziare dalla qualificazione
del sindacato come rappresentativo (v. cap. IX, par. 6);
• nel settore privato:
• è raro ove i sindacati realmente rappresentativi siano confederali (cioè aderenti a CGIL,
CISL e UIL);
• è diffuso nei settori ove operano i sindacati autonomi (cioè non affiliati alle
confederazioni).
Simili conflitti non hanno criteri di soluzione giuridica: o prevale il sindacato che, attraverso la propria
capacità di mobilitare i lavoratori, riesce ad imporre agli imprenditori di riconoscerlo come controparte,
ovvero i sindacati coinvolti trovano un accordo tra loro.
Infine, va ricordato che, ove dalla stipulazione di un contratto collettivo siano rimaste estranee una o più
organizzazioni sindacali, queste sono spesso ammesse a sottoscriverlo a parte, senza peraltro potervi
apportare alcuna modifica, in modo da estenderne gli effetti ai propri iscritti (c.d. contratto per
adesione, formalmente distinto dal primo, pur avendo il medesimo contenuto).
B. I rapporti tra contratti collettivi
1. Premessa
Per quanto detto, ogni singolo rapporto di lavoro risulta essere regolato, oltre che dal contratto individuale
e dalle norme di legge, da una pluralità di contratti collettivi, di natura e di livello diversi. Si pongono, di
conseguenza, problemi di individuazione della regolamentazione del rapporto che nasce
dall’integrazione di disciplina differenziate, tra le quali spesso si determinano anche situazioni di concorso-
conflitto. Inoltre, con una certa periodicità – in genere costante, ma in alcuni casi imprecisata – i contratti
collettivi si rinnovano e succedono nel tempo, e tutto ciò pone ulteriori problemi di individuazione della
disciplina contrattuale applicabile.
2. La successione di contratti collettivi nel tempo
Per tracciare un quadro adeguato della materia conviene partire dall’ipotesi più semplice, ossia quella dei
rapporti tra contratti collettivi di medesimo livello. A tal proposito:
• per le modifiche migliorative non si determinano problemi di sorta;
• per le modifiche peggiorative complessa è la questione della loro ammissibilità, che peraltro la
giurisprudenza risolve in senso positivo muovendo dalla considerazione che il principio
dell’immodificabilità in pejus ex art. 2077, c. 2 non può trovare applicazione ai rapporti tra contratti
collettivi.
Questa linea argomentativa pare però insufficiente ad inquadrare il problema, la cui soluzione è
condizionata dalle opzioni in tema di rapporti tra contratto collettivo ed individuale:
• se esso è spiegato in termini di incorporazione delle clausole del contratto collettivo in
quello individuale, deve escludersi la possibilità che il contratto collettivo successivo possa
apportare modifiche in pejus a quello collettivo precedente: la clausola di quest’ultimo, a
seguito dell’incorporazione, sarà entrata a far parte del contratto individuale, e troverà
applicazione l’art. 2077, c. 2 (“Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o
successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo,
salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”). La
disposizione peggiorativa introdotta dal contratto collettivo successivo, dunque, troverà
applicazione solo ai contratti individuali sottoscritti dopo la sua entrata in vigore;
• la tesi dell’incorporazione non è però appagante: una corretta analisi porta a riconoscere
che il rapporto di lavoro è oggetto di una concorrenza tra varie fonti di regolamentazione
55
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
(legge, contratto collettivo, contratto individuale) e che, in particolare, il contratto collettivo
non si incorpora in quello individuale, ma trova applicazione al posto della clausola
individuale difforme. Dunque, un contratto collettivo successivo può modificare anche
in pejus la disciplina di istituti che trovino la loro fonte solo in precedenti contratti
collettivi; prevarrà, viceversa, la disciplina precedente ove ne siano fonte disposizioni
inderogabili di legge ovvero il contratto individuale.
L’unico limite in materia è costituito dall’intangibilità dei c.d. diritti quesiti (o acquisiti),
ossia quelli già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una
prestazione già resa e nell’ambito, quindi, di un rapporto o di una sua fase già esaurita (in
concreto, certamente il sindacato non potrà disporre della maggiorazione per il lavoro
straordinario già prestato dal lavoratore, che è determinata dal contratto vigente al momento
della prestazione; ciò, tuttavia, non legittima il lavoratore a pretendere che nei suoi confronti
quella maggiorazione rimanga, per il futuro, nella misura determinata dal precedente
contratto, nonostante una sua successiva riduzione).
3. L’efficacia nel tempo del contratto collettivo
E’ frequente che la trattativa, per quanto avviata prima della scadenza, non riesca ad esaurirsi entro quel
termine. Si determina, in questi casi, una vacanza contrattuale – cioè un vuoto normativo, dal momento
che ha perso efficacia il contratto scaduto e non è stato ancora stipulato quello nuovo – ed il datore di
lavoro, non più tenuto al rispetto del contratto collettivo scaduto, può convenire pattuizioni individuali
peggiorative dei trattamenti minimi da quest’ultimo previsti (fatti salvi, naturalmente, i diritti quesiti).
Non manca, però, giurisprudenza che afferma il contrario: è propria della funzione del contratto collettivo la
sua ultrattività, cioè la conservazione dell’efficacia fino alla sostituzione da parte del successivo
contratto.
Il problema non può essere risolto con il richiamo all’art. 2074 c.c. (“il contratto collettivo, anche quando è
stato denunziato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo
regolamento collettivo”), perché tale norma concerne il contratto collettivo corporativo.
In concreto, peraltro, i contratti di diritto comune contengono spesso clausole che esplicitamente ne
sanciscono la ultrattività, tuttavia non sempre rinvenibili nel testo contrattuale.
Un altro tipo di problema si pone quando il nuovo contratto collettivo contiene clausole che prevedono la
retroattività del nuovo regolamento contrattuale. Posto che la norma preclusiva dettata per i contratti
collettivi corporativi (art. 11, c. 2 disp. prel. “I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia
una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione”) è certamente
inapplicabile a quelli di diritto comune, oggi i contratti possono legittimamente contenere clausole che
ne facciano decorrere gli effetti da date anteriori a quella di stipulazione.
Particolare è l’ipotesi in cui la nuova regolamentazione collettiva, dotata di clausola di retroattività, sia meno
favorevole per il lavoratore. Si ripropone qui la questione dei diritti quesiti: la modifica in pejus viene
ammessa dalla giurisprudenza anche con portata retroattiva, purché il diritto scaturente dalla
regolamentazione precedente non sia già entrato nel patrimonio del lavoratore.
4. Il concorso-conflitto tra contratti di diverso livello
Il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello può generare conflitti di regolazione: può accadere, infatti,
che – a seguito della violazione delle clausole di rinvio, ovvero per la mancanza di criteri di riparto delle
competenze tra i livelli – che contratti collettivi di diverso livello regolino la stessa materia o istituto,
dettando discipline contrastanti.
Prima di affrontare il problema, occorre rilevare l’impossibilità di un simile conflitto:
• ove esplicitamente la legge attribuisca un ruolo ordinante al contratto nazionale e sanzioni con la
nullità il contratto decentrato che lo violi;
• ove il contratto nazionale contenga una clausola di uscita, consentendo così che il contratto
aziendale o territoriale possa derogarlo.
Ciò premesso, rileviamo che quando i conflitti tra clausole contrattuali di diverso livello hanno cominciato ad
emergere nella prassi delle relazioni industriali, la giurisprudenza ha affermato il principio dell’ inderogabilità
in pejus del contratto nazionale di categoria da parte di quello di livello inferiore, fondando tale tesi
sull’applicazione dell’art. 2077 c.c. (“I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali
si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. | Le clausole difformi dei
contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del
contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”) anche al
56
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
rapporto tra contratti collettivi, ovvero sull’art. 19, l. 300/1970, dal quale si faceva derivare l’esistenza di un
rapporto di gerarchia tra atti negoziali di diverso livello.
A partire dagli anni Ottanta, in numerose pronunce della Cassazione è stata, invece, affermato il criterio
della successione temporale, che conduce alla prevalenza della regolamentazione dettata dal contratto
posteriore nel tempo, indipendentemente che fosse di livello superiore o inferiore, così applicando al
rapporto tra contratti collettivi di diverso livello il principio affermato in tema di successione tra contratti
collettivi del medesimo livello.
Un altro criterio utilizzato, questa volta su suggerimento della dottrina, è stato quello della specialità, alla cui
stregua il contratto prevalente è quello più vicino alla situazione da regolare, cioè quello di livello
inferiore. Affinché l’utilizzazione di questo criterio sia corretta, è però necessario che i diversi contratti siano
anche stipulati dalle medesime organizzazioni. In altri termini, di specialità può parlarsi solo laddove i
soggetti stipulanti un contratto collettivo che deroga/specifica il contenuto di un contratto di livello superiore
hanno un legame organizzativo con le parti stipulanti di quest’ultimo contratto.
Sulla riflessione giuridica si è innestato il criterio sistematico, ossia la regolamentazione negoziale del
rapporto tra livelli contrattuali, che ha dato un assetto sufficientemente preciso al sistema contrattuale,
generalizzando il metodo delle c.d. clausole di rinvio e di non ripetibilità per determinare le competenze
del contratto decentrato. Sennonché, il problema non può dirsi automaticamente risolto, in quanto è tuttora
controversa la natura giuridica e l’efficacia di tali clausole. In particolare, solo una parte minoritaria della
dottrina riconosce ad esse un’ efficacia reale, tale da determinare l’invalidità giuridica della norma
contrattuale di livello inferiore; altra parte ritiene, viceversa, che esse non abbiano una simile efficacia, con la
conseguenza della piena validità della norma del contratto decentrato lesiva della clausola di rinvio del ccnl.
A tal proposito, la giurisprudenza più recente è, comunque, oscillante. VEDI LIBRO PAG 201 E SEGUENTI
C. La contrattazione e la legge
1. L’inderogabilità unilaterale della legge VEDI LIBRO PAG 204 E SS
Se – come detto – la regolamentazione del rapporto di lavoro è il risultato della combinazione delle regole
dettate dal contratto individuale, dai contratti collettivi e dalla legge, non resta che da analizzare il rapporto
tra l’autonomia collettiva e la legge. Lo schema classico è nel senso che l’autonomia privata è subordinata
alla legge e, più specificamente, che le norme di legge predispongono un livello di tutela minima per i
lavoratori mediante norme unilateralmente inderogabili e che il contratto collettivo, al pari di quello individuale
di lavoro, può apportare deroghe migliorative al trattamento dei lavoratori, ma non può dettare disposizioni
peggiorative della tutela predisposta dalla legge. Questo schema non è però privo di eccezioni, date da:
• rinvii legali alla contrattazione collettiva, che “autorizzano” il contratto collettivo ad integrare,
sostituire o derogare in pejus quanto da essi stabilito.
Questa più stretta integrazione funzionale tra legge e contratto collettivo può essere realizzata
mediante il ricorso a tecniche diverse, che possono essere così tipizzate:
• la norma legale pone una regola e, contemporaneamente, consente al contratto
collettivo di derogarla (è il caso dell’art. 2120 c.c. il quale prevede che, ai fini del calcolo
del TFR, siano considerate tutte le voci non occasionali della retribuzione annua, ma
autorizza i contratti collettivi a disporre diversamente);
• la norma legale pone una regola suppletiva, da applicare laddove la materia non sia
disciplinata da un contratto collettivo;
• la norma legale pone una regola di massima e:
■ attribuisce al contratto collettivo il compito di integrarla;
■ attribuisce al contratto collettivo la possibilità di derogarla, aggiungendo che, se le
parti non raggiungono l’accordo, l’integrazione viene disposta dal Ministro del lavoro;
• la norma legale affida al contratto collettivo la regolamentazione di una materia ma,
contemporaneamente, affida ad un’ autorità amministrativa indipendente sia il
controllo del rispetto dei vincoli da essa stessa posti, sia un potere sostitutivo nel caso
le parti non realizzino l’accordo (questa è la tecnica utilizzata per la determinazione, nei
servizi pubblici essenziali, delle prestazioni indispensabili che devono essere garantite in
occasione di scioperi).
• limiti legali alla contrattazione collettiva, che impongono al contratto collettivo di non disporre
trattamenti migliorativi di quelli da essi indicati (i c.d. “tetti”).
Si tratta di un’ ipotesi non frequente, realizzatasi la prima volta con il d.l. 12/1977 che sabilì che i
contratti collettivi non potessero disporre sistemi di indicizzazione dei salari più favorevoli di quello
allora in atto nel settore industriale.
57
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Questa radicale innovazione nel rapporto tra legge e contratto collettivo sollevò consistenti problemi
di costituzionalità, specie in relazione ad una possibile violazione dell’art. 39 Cost.: il porre limiti
alla contrattazione collettiva implica, infatti, una restrizione della libertà sindacale, comprendente
anche la libera determinazione dei contenuti della contrattazione. La Corte Cost., con sentt.
141-142/1980, respinse le eccezioni di incostituzionalità, limitandosi però a sottolineare che “sino a
quando l’art. 39 non sarà attuato, non si può, né si deve ipotizzare conflitto tra attività normativa dei
sindacati ed attività legislativa del Parlamento”.
Il problema si è riproposto con il d.l. 70/1984, che limitò la dinamica del meccanismo contrattuale di
indicizzazione dei salari, destando aspre polemiche. Mentre, infatti, l’intervento legislativo più sopra
citato aveva alla base il consenso di tutte le maggiori organizzazioni sindacali, il decreto in questione
aveva incontrato la netta opposizione di CGIL, sul versante sindacale, e del PCI, su quello politico.
La Corte costituzionale, con sent. 34/1985, respinse nuovamente le eccezioni di costituzionalità,
negando che il mancato accordo del 1984 fosse espressione di contrattazione collettiva e
qualificandolo, invece, come accordo di concertazione (v. cap. X, sez. A, par. 8).
Dato che, in entrambe le occasioni, la Corte non ha dato una soluzione definitiva al problema, la
questione rimane aperta, ma almeno due punti possono dirsi acquisiti:
• non esiste una riserva normativa in favore della contrattazione, che escluda la
legittimità di interventi legislativi su materie regolate dai contratti;
• la contrattazione collettiva trova una tutela costituzionale nell’art. 39, c. 1 Cost, a
prescindere dall’utilizzazione o meno del meccanismo previsto dalla parte inattuata della
norma.
Infine, la norma legale ha talvolta disposto che la contrattazione collettiva non possa regolare alcune
materie: in virtù del principio di libertà contrattuale, da ricavarsi da quello di libertà sindacale, è lecito
dubitare della legittimità costituzionale di simili normative.
CAPITOLO IX
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL LAVORO PUBBLICO
1. Diritto pubblico e rapporto di pubblico impiego
La regolamentazione giuridica dei rapporti di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni ha trovato un punto di
svolta negli anni Novanta del secolo scorso. In precedenza, una tradizione giuridica risalente alla fine del
XIX secolo aveva inteso disciplinare con regole di diritto pubblico non solo il rapporto tra la PA ed i
cittadini, ma anche l’organizzazione interna della sua attività. In quest’ottica, il rapporto di lavoro era visto
non in termini contrattuali, bensì in termini di supremazia speciale della PA nei confronti dei suoi
dipendenti, una supremazia addirittura più intensa di quella esercitata sulla generalità dei cittadini. Il
consolidamento di questa tradizione si deve all’attribuzione delle controversie in materia di pubblico
impiego alla giurisdizione esclusiva (cioè non solo sugli interessi legittimi, ma anche sui diritti soggettivi) del
Giudice Amministrativo.
In realtà, questa costruzione dogmatica entrava in contraddizione con la presenza del conflitto all’interno
delle organizzazioni pubbliche in misura non inferiore a quella delle organizzazioni private. Nonostante tale
conflittualità avesse già ottenuto un riconoscimento con l’attribuzione del diritto di sciopero anche ai pubblici
dipendenti (v. cap. XI, par. 2), quella tradizione aveva continuato a qualificare il rapporto di pubblico impiego
come autoritativo. Eppure un autorevole dottrina amministrativistica (Giannini) aveva già da tempo acquisito
due risultati importanti:
• gli atti di gestione dei rapporti d’impiego e gli atti organizzativi non presuppongono, in realtà,
l’esistenza di una supremazia speciale dell’amministrazione;
• occorre distinguere tra:
• rapporto organico, quello di preposizione all’ufficio, che dev’esser retto da norme
pubblicistiche;
• rapporto di servizio, quello di scambio tra l’attività lavorativa e una retribuzione, che
nessuna necessità giuridica impone che sia retto da norme pubblicistiche.
Sbagliò, dunque, il Consiglio di Stato ad affermare – nel parere fornito sul primo disegno di legge di riforma
(l. delega 421/1992 – che l’art. 97 Cost. comporterebbe la necessità che l’intera attività organizzatoria della
PA, in quanto funzionalizzata alla realizzazione del principio di buon andamento, non potesse esser posta su
un piano paritario con l’attività dei privati e dovesse esser necessariamente retta da norme di diritto pubblico.
In realtà, se il legislatore ordinario può scegliere di assoggettare a tali vincoli funzionali anche i singoli atti,
attribuendogli la natura di atti amministrativi, non gli è costituzionalmente preclusa la scelta contraria di
58
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
attribuire loro natura giuridica privatistica: secondo questa differente lettura, l’art. 97 Cost. non è di
ostacolo a che siano le norme del diritto privato a regolare i singoli atti organizzativi e, di conseguenza, alla
c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, cioè al suo assoggettamento alle regole del diritto
del lavoro privato.
2. Accordi sindacali e disciplina del rapporto attraverso il loro recepimento in atti regolamentari
Stando alla tradizione giuspubblicistica richiamata nel paragrafo precedente, le regole del rapporto di
impiego pubblico non potevano essere dettate da una fonte, insieme contrattuale e privatistica (e, quindi,
formalmente paritaria) come il contratto collettivo.
A partire dal 1968, su pressione dei lavoratori pubblici, il legislatore riconosceva l’attività di contrattazione
collettiva nel settore pubblico: tuttavia, agli “accordi sindacali” – significativamente differenziati anche nel
nome dai contratti collettivi del settore privato – non veniva attribuita alcuna efficacia giuridica diretta sui
rapporti di lavoro, ma erano solo il presupposto per l’emanazione di successivi atti unilaterali di
recezione da parte della P.A., aventi natura regolamentare, ed erano questi ultimi a regolare i rapporti di
impiego.
Nel 1983, la legge-quadro sul pubblico impiego mantenne lo schema secondo cui l’accordo sindacale era
solo un momento di un procedimento amministrativo che sfociava in un atto regolamentare di recezione.
Così si consolidava una soluzione compromissoria che voleva innestare il riconoscimento della
contrattazione collettiva, per definizione consensuale, sul tradizionale modello autoritativo del pubblico
impiego.
Questo eccesso di rigidità entrò in una profonda crisi che portò, negli anni ’90, ad un’ apertura al pieno
riconoscimento della contrattazione collettiva.
3. La contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego
Il sovvertimento della tradizione giuspubblicistica passa per diversi atti:
• la l. delega 421/1992 avvia il processo riformatore. Essa, in una prima fase della riforma, aveva
conferito mandato al legislatore delegato di disporre che i rapporti di impiego con le PA fossero
“ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e […] regolati mediante contratti individuali e
collettivi”. In forza di ciò, l’art. 2, d. lgs. 29/1993 faceva propria la distinzione tra rapporto organico e
rapporto di servizio, distinguendo tra organizzazione pubblicistica degli uffici e organizzazione
privatistica del lavoro;
• in una seconda fase della riforma, il Governo ha allargato l’area privatistica ad una parte dell’attività
organizzativa. Restano così sottoposti al diritto pubblico i soli atti di c.d. macro-organizzazione
(le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l’individuazione ed i modi di conferimento degli
uffici di maggiore rilevanza, le dotazioni organiche complessive); per contro, quando le
amministrazioni pongono in essere atti di c.d. micro-organizzazione (ossia tutti gli atti organizzativi
non ricompresi tra i precedenti) e, tra essi, quelli di gestione dei rapporti di lavoro, agiscono “con la
capacità e i poteri del privato datore di lavoro”.
Quel che ci riguarda è, naturalmente, la materia dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, regolati
mediante contratti individuali e collettivi, mentre l’applicazione delle norme generali sul lavoro privato
è limitata solo dalle “diverse disposizioni contenute nel presente decreto”.
In conclusione, oggi il rapporto di pubblico impiego è un rapporto di lavoro fondato su un
contratto di diritto privato, che è speciale solo per l’esistenza, nel diritto positivo, di deroghe legali
alla disciplina generale.
• L’assoggettamento, in linea di principio, dei rapporti di lavoro pubblico alle regole del diritto privato è
rimasto fermo anche nel d. lgs. 150/2009.
La riforma in discorso ha più volte ottenuto l’avallo della Corte costituzionale che, in particolare con la sent.
309/1997, ha affermato che il legislatore ha realizzato un “equilibrato dosaggio” di fonti regolatrici che, senza
ledere il principio dell’imparzialità delle amministrazioni, ne promuove l’efficienza e dunque il buon
andamento, conformemente alle previsioni dell’art. 97 Cost..
Più di recente, la Corte ha affrontato anche un’ altra delicata questione, sorta a seguito della riforma
costituzionale del 2001. Il nuovo testo dell’art. 117 Cost., infatti, al comma 2, lett. g) dispone che “Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...] g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato
e degli enti pubblici nazionali”; di conseguenza, l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa delle
Regioni, degli enti pubblici regionali e degli enti locali rientra nella competenza legislativa esclusiva delle
Regioni. A tal proposito, la Corte ha specificato che, essendo i rapporti di pubblico impiego – ivi compresi
quelli con le Regioni e gli enti locali – soggetti al diritto privato del lavoro , la competenza legislativa spetta
59
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
in via esclusiva allo Stato ex art. 117, c. 2, lett. l), Cost.: “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie: [...] l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa”.
4. Contrattazione collettiva e lavoro pubblico
Se elemento cardine della riforma è che i rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici hanno perso il loro
carattere formalmente autoritativo, per essere “disciplinati dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro V
c.c.”, in questo nuovo quadro istituzionale gli accordi sindacali sono, come i contratti collettivi privati, atti di
autonomia privata, la cui legittimazione deriva dall’art. 39, c. 1 Cost.: sono sì soggetti ad una disciplina
giuridica peculiare, ma sono pur sempre espressione dell’autonomia privata collettiva. Perciò, il contratto
collettivo regola direttamente ed immediatamente il rapporto di lavoro pubblico, senza bisogno di
alcun atto di recezione da parte della PA. Un’ altra conseguenza è che se l’accordo non viene raggiunto, in
linea di principio le PA possono procedere unilateralmente nei limiti in cui può farlo il privato datore di lavoro,
utilizzando i poteri che derivano dal contratto individuale, con un’ unica eccezione: le amministrazioni, per
ragioni di trasparenza della spesa pubblica e a differenza dei datori di lavoro privati, non possono
corrispondere ai dipendenti trattamenti economici superiori a quanto previsto dai contratti collettivi.
La centralità del ruolo attribuito alla contrattazione collettiva come fonte di regolazione dei rapporti di lavoro
con le PA è stata ridimensionata dalla l. 15/2009 e dal suo decreto attuativo, ma – si badi - non in favore di
un allargamento dell’area pubblicistica, bensì in favore dei poteri unilaterali dei dirigenti, pur sempre di
natura privatistica. Ed infatti, il legislatore del 2009 si limita a stabilire che la contrattazione collettiva può
intervenire sulla “determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro”:
ciò che si vuole rafforzare è, dunque, quell’area “intermedia” nella quale la PA – e, per essa, i suoi
dirigenti – opera con i poteri del privato datore di lavoro e che non è coperta dalla contrattazione
collettiva. A ben guardare, già dai testi legislativi originali la competenza della contrattazione collettiva era
limitata ai rapporti di lavoro ed alle relazioni sindacali e, quindi, la novità si risolve in un mero criterio
interpretativo: un maggior rigore nell’individuazione di questa competenza, suggerita dall’avverbio
“direttamente”.
Invero, un rilevante ridimensionamento della contrattazione collettiva si coglie sotto un altro profilo: il d.
lgs. 150/2009 se, da un lato, detta regole sulla struttura della contrattazione (v. dopo), dall’altro, disciplina
numerosi aspetti importanti della disciplina dei rapporti d’impiego, sottraendo così spazio alla
contrattazione. Ed, infatti, la legge regola temi che attengono direttamente alla disciplina dei rapporti di
lavoro (meccanismi di valutazione dei dipendenti e di incentivazione della produttività, responsabilità
disciplinare del dipendente, ecc.) e che dunque, in astratto, rientrano nella competenza della
contrattazione collettiva, cui vengono però sottratti perché regolati direttamente dalla legge.
È stato così interrotto il processo di delegificazione in favore della contrattazione collettiva che era iniziato
con la l. delega 421/1992; si ritorna ad utilizzare lo strumento legislativo non già per dettar norme di principio,
ma regole da applicare immediatamente (c.d. rilegificazione). Manifestazione di questo processo è anche
la modifica all’art. 2, c. 2 introdotta dalla l. 15/2009:
• il testo originario disponeva che le norme di legge che introducessero previsioni speciali sui
rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici, salvo diversa ed espressa disposizione, potessero essere
derogate dal successivo contratto collettivo;
• ora, la norma dispone il contrario, ossia che il contratto collettivo può regolare diversamente la
materia solo su espressa autorizzazione della legge.
Non è stato invece modificato il successivo comma 3 che, dopo aver attribuito ai contratti collettivi il
compito di determinare il trattamento economico dei dipendenti delle PA, dispone che le norme di legge o
regolamentari che attribuiscano trattamenti economici più favorevoli cessino di avere efficacia con l’entrata in
vigore del successivo contratto collettivo.
5. La struttura del sistema contrattuale
Nelle PA, insomma, la contrattazione collettiva non trae la sua legittimazione dal generico riconoscimento
dell’autonomia privata ex art. 1322 c.c., ma dall’art. 40, c.3, d. lgs. 165/2001: “La contrattazione collettiva
disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata
dei contratti collettivi nazionali e integrativi”.
Il perno del sistema contrattuale è il contratto nazionale di comparto – così come, per i lavoratori privati, lo
è il contratto collettivo nazionale di categoria – ove i comparti sono settori omogenei o affini di
amministrazioni pubbliche, individuati da appositi accordi tra l’Aran (v. par. 7) e le confederazioni sindacali
rappresentative (v. cap. IV, sez. B, par. 2).
60
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Inoltre, in analogia con gli accordi interconfederali del settore privato, è possibile stipulare accordi quadro,
applicabili all’insieme dei comparti ovvero ad alcuni di essi, quando le parti decidono, nella loro autonomia,
che sia opportuno che una certa materia sia disciplinata in modo uniforme.
Le PA possono attivare “autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa”, anche per sedi e strutture
periferiche, col vincolo che tale livello debba essere destinato ad incentivare “l’impegno e la qualità della
performance”: a tal fine, le Regioni e gli Enti locali possono impegnare risorse proprie. Se, dunque, sotto
il profilo economico il contratto integrativo non è subordinato a quella nazionale, sotto altri profili tale
subordinazione vi è: tale contrattazione, infatti, deve svolgersi “sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti
dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziale che questi ultimi prevedono”. La
legge, dunque, attribuisce al contratto nazionale una funzione ordinatrice, garantita dalla sanzione di
nullità che colpisce i contratti integrativi che non rispettino le regole di competenza così poste. Nel settore
privato, per contro, non è prevista una simile sanzione (cfr. cap. VIII, sez. B, par. 4).
6. I soggetti della contrattazione: la rappresentanza dei lavoratori
Per quanto riguarda i soggetti della contrattazione negoziale, una caratteristica della contrattazione dei
dipendenti pubblici che la differenzia fortemente da quella dei lavoratori privati consiste nella previsione che
la legittimazione a negoziare collettivamente deriva, in via esclusiva, dalla qualificazione del sindacato
come rappresentativo, secondo i criteri già esaminati (v. cap. IV, sez. B, par. 2). Inoltre, il contratto collettivo
può essere concluso solo quando sia sottoscritto da sindacati che, nel loro complesso, realizzino un indice di
rappresentatività pari al 51% (come media tra dato associativo ed elettorale), ovvero al 60% (se si assume il
solo dato elettorale). Nel settore privato, invece, la legittimazione contrattuale non è subordinata al
soddisfacimento di alcun requisito specifico.
Per quanto attiene alla contrattazione integrativa o di secondo livello, la legge individua nelle RSU i
soggetti necessari (v. cap. V, par. 5), prevedendo anche che i contratti nazionali possano prevederne
l’integrazione con rappresentanze dei sindacati firmatari del contratto nazionale di comparto. Il risultato –
avuto riguardo anche all’Accordo quadro del 1998 sulle RSU – è che, per quanto riguarda poteri e compiti
contrattuali, le RSU dei settori pubblico e privato sono sullo steso piano: in ambedue, è il contratto nazionale
di categoria a definire, ai fini della contrattazione di secondo livello, i poteri della RSU e dei sindacati firmatari
del contratto nazionale.
7. I soggetti della contrattazione: la rappresentanza delle amministrazioni
Dato che l’esperienza compiuta quando era in vigore la legge quadro del 1983, nella quale le delegazioni
erano formate da responsabili politici di governo, è stata valutata insoddisfacente, perché incapace di
assicurare la necessaria competenza tecnica e, soprattutto, l’impermeabilità a pressioni elettorali. Di qui, la
scelta del legislatore delegante di affidare la rappresentanza negoziale della parte pubblica ad un apposti
organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, l’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
Pubbliche Amministrazioni). Esso rappresenta ex lege tutte le PA per la stipulazione dei contratti nazionali e
può assistere, se richiesto, le singole amministrazioni nella contrattazione integrativa (sulla quale, dunque,
non ha una competenza propria). La rappresentanza da parte dell’Agenzia assolve ad una duplice funzione:
• fa si che il contratto produca i suoi effetti nei confronti di tutte le PA interessate senza necessità
di alcun atto di recezione da parte degli organi di governo di ciascuna di esse;
• favorisce la creazione di un quadro unitario delle politiche contrattuali seguite nei diversi
comparti.
L’azione di rappresentanza dell’Aran si svolge si svolge all’interno di “atti di indirizzo” espressi dai comitati
di settore; l’Agenzia, per sottoscrivere definitivamente un contratto collettivo, deve ottenere preventivamente
dal comitato di settore il parere favorevole sull’ipotesi di accordo.
8. Il procedimento contrattuale
La legge regola le procedure contrattuali distintamente per:
• contrattazione nazionale che, a sua volta, si articola in varie fasi:
• fase preliminare (quantificazione degli oneri di spesa a carico del bilancio; il Presidente del
Consiglio o il comitato di settore impartiscono gli indirizzi all’Agenzia; si procede alla
selezione dei soggetti sindacali abilitati alla trattativa ex art. 43);
• trattativa tra i soggetti abilitati;
• perfezionamento dell’accordo (è previsto che l’Aran possa sottoscrivere il contratto solo
dietro parere favorevole – vincolante – del comitato di settore competente).
61
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Il procedimento, dunque, dal lato delle Amministrazioni pare equilibrato: spetta al comitato di settore
formulare gli indirizzi dell’attività contrattuale, determinando gli obiettivi da realizzare; all’Aran la
gestione della trattativa; nuovamente al comitato di settore esprimere un parere nel merito del
contratto, perché lo stesso possa essere sottoscritto.
Il controllo della Corte dei conti è limitato alla “certificazione di compatibilità [dell’accordo] con gli
strumenti di programmazione e di bilancio ”; essa, dunque, controlla solo l’esistenza di una copertura
effettiva delle spese connesse al contratto: l’Aran, nel caso di negazione della certificazione,
procede alla riapertura della trattativa con le organizzazioni sindacali per diminuire i costi attraverso
una modifica dell’accordo.
• contrattazione decentrata, rispetto cui la legge rimette interamente ai contratti nazionali la
disciplina delle materie, dei soggetti e della procedura, salva la previsione legale del controllo sui
costi, affidato qui al collegio dei revisori dei conti, o ai nuclei di valutazione, ovvero ai servizi di
controllo interni di ciascuna amministrazione.
9. L’efficacia soggettiva del contratto collettivo
Anche il contratto collettivo per i dipendenti delle PA – ancorché non tragga la propria legittimazione ex art.
1322 c.c., bensì dalla disciplina legale sin qui descritta – ha natura di atto di autonomia privata e, pertanto, si
pone anche per esso il problema della sua efficacia soggettiva. Per risolverlo, il legislatore ha predisposto
un duplice meccanismo:
• conferendo all’Aran la rappresentanza legale di tutte le PA interessate, gli effetti giuridici del
contratto collettivo si producono immediatamente in capo ai soggetti rappresentati;
• dispone che il trattamento economico è stabilito dai contratti collettivi, e prescrive che le
amministrazioni non possano corrispondere trattamenti inferiori a quanto da essi stabilito.
Con tali accorgimenti è ritolto il problema dal lato datoriale, non già dal lato dei lavoratori dissenzienti,
rispetto ai quali esso si pone nei termini già esaminati a proposito della contrattazione collettiva in generale
(v. cap. VII, sez. B, par. 5). Su questo tema è intervenuta la Corte cost. con sent. 309/1997 che, nel
respingere la questione di legittimità propostale, ha affermato che le norme del d. lgs. 29/1993 non
contrastano con l’art. 39 Cost., nella parte in cui prescrive un particolare meccanismo (v. cap. VII, sez. A,
par. 6) per il conferimento di efficacia generale al contratto collettivo. In particolare, secondo la Corte, sono le
amministrazioni le esclusive destinatarie del dovere di osservanza degli impegni assunti con i contratti
collettivi, onde il contratto collettivo del lavoro pubblico non ha un’ efficacia generale diretta. Tale
efficacia discende, piuttosto:
• da un lato, dal vincolo di conformazione che grava sulle amministrazioni;
• e, dall’altro, dal rinvio che i contratti individuali di lavoro dei dipendenti pubblici necessariamente
operano alla disciplina collettiva (ex art. 2, c. 3), che il lavoratore ha accettato alla stipulazione del
proprio contratto individuale.
10. Ulteriori garanzie di controllo della spesa
Altre norme di questa disciplina sono destinate a garantire il rispetto delle previsioni di spesa nell’attività di
contrattazione collettiva:
• una prima, dispone che “in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa”, il contratto collettivo
debba prevedere la possibilità di prorogarne l’efficacia nel tempo o di sospenderne gli effetti;
Si badi che l’effetto di sospensione o di proroga non sarà frutto di un provvedimento autoritativo
dell’organo pubblico, ma della realizzazione della condizione nei termini oggettivi indicati dal
contratto;
• una seconda norma è quella che dispone la nullità dei contratti integrativi che non rispettino i
vincoli di bilancio gravanti sulle amministrazioni.
• analoga finalità è rintracciabile nella norma sulla c.d. interpretazione autentica dei contratti
collettivi, che dispone: “1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi,
le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle
clausole controverse. | 2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le
procedure di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza
del contratto. […]”.
Posto che, più che di un’ interpretazione autentica, si tratta di una transazione collettiva, si pone il
problema se le parti del rapporto individuale di lavoro siano vincolate, per il passato, a questo
accordo e, dunque, se la norma attribuisca al sindacato il potere di disporre di diritti già entrati nel
patrimonio dei lavoratori; problema cui la Corte costituzionale ha dato risposta positiva.
62
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Alla stessa funzione deflattiva del contenzioso giudiziario è diretto l’art. 64, giusta il quale il giudice
chiamato a decidere una controversia sulla validità e sull’efficacia di un contratto collettivo nazionale,
ovvero sull’interpretazione di una sua clausola, deve sospendere il giudizio per consentire alle parti
collettive di pervenire all’accordo interpretativo ex art. 49.
Infine, lo stesso art. rafforza la funzione unificatrice della Cassazione, anticipando il ricorso ad essa
rispetto alla normale procedura e, soprattutto, estendendola alle norme dei contratti collettivi (per il
settore privato, v. cap. VII, sez. B, par. 1).
CAPITOLO X
SINDACATI E SISTEMA POLITICO
A. La concertazione
1. L’azione “politica” del sindacato e il ruolo dei pubblici poteri nelle relazioni industriali
Se l’attività fondamentale attraverso cui il sindacato assolve alla sua funzione di tutela è quella contrattuale,
il sindacato raramente si è limitato alla mera difesa delle condizioni salariali: all’azione più direttamente
economica il sindacato ha, infatti, affiancato un’ azione politica.
Lo studio delle diverse esperienze sindacali ha consentito di costruire due modelli tendenziali:
• quello del sindacalismo economico (o, meglio, negoziale): esso, tipico dell’esperienza nord-
americana, privilegia gli obiettivi economici ed agisce prevalentemente attraverso la contrattazione
collettiva; è, in via di principio, autonomo dai partiti;
• quello del sindacalismo competitivo: esso, riconducibile all’esperienza britannica ed italiana ha,
rispetto al primo, obiettivi più ampi che includono riforme di carattere economico-sociale e che
vengono perseguiti sia attraverso la contrattazione collettiva, sia attraverso l’azione politica; ha,
infatti, intensi legami con i partiti.
D’altra parte, all’azione politica del sindacato fa riscontro l’intervento dei pubblici poteri nelle relazioni
industriali, nella veste di compositori dei conflitti collettivi, ma anche di datori di lavoro nelle PA. Se, dunque,
è sempre esistita un’ ampia area di sovrapposizione tra sistema politico e relazioni industriali, a partire dalla
metà degli anni Settanta il rapporto tra questi due sistemi ha assunto caratteri nuovi, di coinvolgimento
esplicito delle parti sociali nella definizione delle scelte di politica economico-sociale. Questo
mutamento cominciò a manifestarsi a seguito delle profonde trasformazioni del sistema produttivo e del
mercato del lavoro, con particolare riferimento all’aumento della disoccupazione. Di fronte alla necessità di
definire politiche che imponevano “sacrifici”, i pubblici poteri ebbero l’esigenza di coinvolgere le parti
sociali in un negoziato sui relativi provvedimenti, attraverso cui si mirava ad acquisire il consenso preventivo
delle parti sociali sugli obiettivi e sulle politiche progettate, e la loro collaborazione all’attuazione delle stesse.
Per conseguire tali obiettivi, dunque, lo Stato assunse – prima informalmente e, poi, formalmente – la veste
di terza parte negoziale, immettendo nella contrattazione – tradizionalmente svolta tra le organizzazioni
datoriali e dei lavoratori – risorse proprie, ed assumendo impegni politici a vantaggio delle parti sociali, in
cambio della condivisione di obiettivi di politica economica e sociale.
2. La concertazione delle politiche economico-sociali
Con riferimento a questo nuovo metodo di contrattazione triangolare, si parla di concertazione sociale,
della quale sono stati elaborati, in letteratura, due concetti piuttosto diversi:
• concertazione come scambio politico, alla cui stregua essa è considerata un modo di formazione
delle politiche pubbliche, fondato su un rapporto di scambio di risorse materiali (finanziarie e
normative) e simboliche (consenso e legittimazione), tra lo Stato e le grandi organizzazioni
rappresentative degli interessi delle parti sociali (il c.d. scambio politico).
In tal caso, si fa riferimento ad accordi triangolari basati sulla rigida predeterminazione
centralizzata delle politiche da realizzare e dei loro contenuti, e sullo scambio tra vincoli
all’azione contrattuale delle parti sociali e benefici compensativi in termini di risorse economiche
e normative, trasferite a queste dai pubblici poteri. È evidente che la distribuzione di benefici e
sacrifici è disuguale nel tempo: i benefici offerti dalle parti sociali al soggetto pubblico (legittimazione
ed impegno alla moderazione) si fanno sentire subito; per i sindacati ed i loro aderenti, invece,
immediati sono i sacrifici (ad es., in termini di mancato miglioramento delle condizioni di lavoro),
mentre le compensazioni sono proiettate nel futuro ed incerte. L’insieme di tali elementi rende
instabile questo tipo di concertazione, e l’assetto delle relazioni che ne deriva. Nell’esperienza
italiana, questo concetto di concertazione può essere applicato agli accordi conclusi negli anni
Ottanta (v. par. 3).
63
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
• concertazione come determinazione degli obiettivi comuni, alla cui stregua essa è considerata
come un metodo decisionale in cui il Governo determina con le parti sociali gli obiettivi
economico-sociali fondamentali, e delega ad esse una quota di autorità e di responsabilità per la
loro concreta realizzazione.
Questo concetto di concertazione fa riferimento ad un modo di regolazione che postula la
disponibilità dei Governi a definire con le parti sociali gli obiettivi fondamentali delle politiche
economico-sociali, e la disponibilità dei tre soggetti ad adoperarsi per la loro realizzazione.
Questo tipo di concertazione, in particolare, lascia alle parti sociali la responsabilità di definire
autonomamente – nell’ambito delle proprie competenze – contenuti e misure di attuazione delle
politiche da realizzare, salvo il vincolo della coerenza con gli obiettivi concordati. Questo secondo
concetto di concertazione – che può godere di maggiore stabilità – qualifica gli accordi triangolari
stipulati in Italia negli anni Novanta (v. parr. 4 e 5).
Va ancora sottolineato che un ruolo essenziale nella determinazione e nell’attuazione delle politiche
regolative oggetto degli accordi triangolari è stato svolto da procedure che combinano fonte legislativa e
contrattuale: è il caso della prassi di consultare le parti sociali da parte dei pubblici poteri prima
dell’approvazione di un provvedimento (c.d. negoziazione legislativa), oppure della legge che autorizza il
contratto collettivo a derogare, integrare ovvero a specificare la regola da essa stessa posta (c.d.
contrattazione delegata, v. cap. VIII, sez. C, par. 2).
Più di recente, nella XIV a legislatura (2001-2006), il Governo ha praticato un metodo di confronto con le parti
sociali alternativo alla concertazione, il “modello del dialogo sociale”, con cui il Governo non determina più
consensualmente con le parti sociali gli obiettivi, ma si limita ad assumere nei loro confronti obblighi
politici di informazione e consultazione. Ciò ha suscitato contrasti e conflitti, che hanno riproposto
l’attualità della concertazione, ripresa nella legislatura successiva, per poi essere nuovamente abbandonata
nella XVIa (v. par. 7).
3. L’evoluzione storica della concertazione: gli anni ’70 ed ‘80
L’avvio informale di prassi triangolari nel nostro Paese risiede, come detto, alla seconda metà degli anni
Settanta: in un quadro di recessione, l’attore politico intervenne nel negoziato che portò all’accordo
interconfederale del 1977, rimanendo però formalmente estraneo al negoziato, pur risultando essenziale per
la sua conclusione l’impegno assunto di emanare determinati provvedimenti legislativi.
Negli anni Ottanta, le difficoltà che i sindacati e le organizzazioni datoriali incontravano nel definire un
accordo che modificasse il sistema allora vigente di indicizzazione dei salari al costo della vita (c.d. scala
mobile), indusse il Governo ad intervenire attivamente nella vertenza, non già come soggetto esterno al
negoziato, ma come parte dello stesso. Il Governo, infatti, si impegnò ad emanare misure legislative
favorevoli a lavoratori ed imprese “in cambio” dell’assunzione dell’impegno – da parte di sindacati ed
organizzazioni imprenditoriali – a modificare il sistema di indicizzazione dei salari: nel 1983 si realizzava,
così, il primo accordo triangolare, chiamato Protocollo Scotti (dal nome dell’allora Ministro del Lavoro). Il
Governo, insomma, in cambio del consenso alle proprie linee di politica economica, compensò con
benefici a carico della finanza pubblica i costi sostenuti dalle parti sociali per aderire all’accordo.
L’anno successivo il Governo si mosse nella stessa logica, ma il c.d. Accordo di San Valentino (1984) non
ebbe il consenso della CGIL (che riteneva insufficienti le risorse messe a disposizione dall’esecutivo come
contropartita alla riduzione della copertura delle retribuzioni all’inflazione). Il Governo decise, nonostante ciò,
di recepire ugualmente le previsioni dell’Accordo in un d.l., così rompendo la prassi di astenersi
dall’intervenire per via legislativa su una materia di competenza della contrattazione collettiva (come,
appunto, l’indicizzazione delle retribuzioni al costo della vita) in mancanza di accordo tra tutte le parti. Tale
intervento produsse un intenso dibattito giuridico che precedette e seguì la pronuncia della Corte cost. sulla
legittimità del decreto sulla scala mobile (v. par. 8) e violente polemiche politiche, che indusseso ad
interrompere per lungo tempo le prassi concertative.
4. Il Protocollo del 23 Luglio 1993 e la politica dei redditi
All’inizio degli anni Novanta, la necessità di contrastare la crisi economico-occupazionale indusse Governi
e parti sociali di molti Paesi europei a recuperare il metodo concertativo. Il confronto che seguì –
centralizzato sulla riforma del meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni e della struttura contrattuale –
portò alla firma di due accordi triangolari: il Protocollo Amato (1992), che abolì il meccanismo della scala
mobile, ed il Protocollo Ciampi (1993), nel quale le parti predisposero per la prima volta un quadro di
principi e di regole per rendere coerenti le politiche contrattuali con quelle economiche e dei redditi (ossia
64
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
quella parte della politica economica che riguarda i redditi e le retribuzioni). Gli strumenti fondamentali su cui
questo accordo poggiava erano l’associazione delle parti sociali alla realizzazione della politica dei redditi ed
una serie articolata di misure strutturali in materia di politiche del lavoro e di sostegno al sistema produttivo.
In particolare, nel primo capitolo dell’intesa erano individuati, innanzitutto, gli obiettivi della politica dei
redditi, orientata a “conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito” ed a “favorire lo
sviluppo economico e la crescita occupazionale”. A tal fine, si adottava la determinazione consensuale del
tasso entro cui contenere l’inflazione (c.d. tasso d’inflazione programmato). Si definivano, poi, le
procedure del confronto sulla politica economica, in modo che l’adempimento dei reciproci impegni restasse
affidato alla volontà politica dell’Esecutivo e delle parti sociali e che, comunque, gli stessi non vincolassero il
Parlamento.
Insomma, con l’accordo di concertazione il Governo e le parti sociali si assumono la responsabilità di
definire – autonomamente e ciascuno nel proprio ambito – i contenuti e le misure di attuazione delle
politiche da realizzare, salvo il vincolo della coerenza con gli obiettivi concertati.
In conclusione, il Protocollo del ’93 non è stato basato sullo scambio immediato tra vincoli (all’azione
contrattuale) e benefici (in termini di trasferimento di risorse dai pubblici poteri alle parti): pur implicando uno
scambio di consenso e legittimazione tra i soggetti stipulanti, esso ha realizzato un mero coinvolgimento
delle parti sociali nel processo di assunzione delle decisioni di politica economica, sulla base di obiettivi
condivisi. D’altro canto, nella consapevolezza che l’informalità favorisce l’instabilità della concertazione, il
Protocollo ha predeterminato le regole per i confronti futuri tra le parti, al fine di creare i presupposti e gli
strumenti per la stabilizzazione di questo metodo.
5. Il Patto del ’98: istituzionalizzazione e decentramento della concertazione
Negli anni successivi, la concertazione è stata praticata per realizzare importanti obiettivi di riforma (Accordo
sulle pensioni del 1995, e Patto per il lavoro del 1996). Sulla base di tali risultati si svolse la prevista verifica
sul Protocollo, che portò alla stipulazione del Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione (1998, c.d.
Patto di Natale). Un rilevante elemento di novità era il coinvolgimento nelle procedure di concertazione
delle Regioni e delle autonomie locali, in coerenza con il contemporaneo processo di decentramento
amministrativo.
Con le nuove regole del Patto del ’98, la concertazione assumeva, in secondo luogo, un ruolo prioritario di
strumento di coordinamento tra legislazione ed autonomia collettiva anche nelle procedure di
adeguamento dell’ordinamento italiano a quello comunitario. L’Accordo prevedeva, infatti, una duplice
procedura concertativa, che privilegiava il ricorso alla legge o all’autonomia collettiva a seconda che le
tematiche oggetto di trattativa rientrassero nelle competenze dell’una o dell’altra. In particolare, per le
materie di competenza delle parti sociali che non comportassero un impegno di spesa a carico del bilancio
dello Stato erano previsti, prima, un confronto tra Governo e parti sociali sugli obiettivi generali da realizzare
e, successivamente, un’ iniziativa legislativa del governo o, in alternativa, un negoziato bilaterale. Il ricorso
a quest’ultimo strumento risultava privilegiato: le parti sociali, potevano chiedere all’Esecutivo di procedere
per via negoziale, e quest’ultimo, ove l’accordo fosse stato concluso coerentemente, era impegnato a
recepirne i contenuti ed a portarlo avanti come iniziativa propria, promuovendo, “nel rispetto delle prerogative
del Parlamento, la convergenza tra i risultati della concertazione e la produzione legislativa”.
In definitiva, la nuova disciplina introdotta dal Patto del '98 confermava che la concertazione era “un
metodo di condivisione degli obiettivi” di politica economico-sociale, che assicurava alle parti
“autonomia e responsabilità” e si fondava sul “rispetto delle prerogative e dei diritti costituzionalmente
garantiti”. Con la concertazione, insomma, tutti i sottoscrittori si impegnavano ad adottare gli strumenti idonei
a perseguire gli obiettivi congiuntamente definiti e, più specificamente, che ai soggetti negoziali veniva
delegata la funzione di definire e coordinare autonomamente, nell’ambito delle proprie competenze
negoziali, le misure di attuazione delle politiche concertate e che al Governo restava affidata la
definizione e l’attuazione degli interventi di sua spettanza.
6. Il c.d. dialogo sociale e il Patto per l’Italia del 2002
Come già accennato, nel 2001 il Governo di centro-destra propose il metodo del dialogo sociale che – ben
diverso dalla concertazione – consisteva in una procedura di consultazione preventiva delle parti sociali,
finalizzata a valutare l’opportunità ed i contenuti dell’intervento legislativo che il Governo o la Regione
volevano realizzare su materie – di politica sociale e dell’occupazione – che non comportassero impegni
di spesa pubblica. Vi era, inoltre, un eventuale successivo negoziato tra le parti sociali da concludere, se si
raggiungeva l’intesa, nella “traduzione legislativa” di questa ovvero, in caso contrario, nella ripresa
dell’iniziativa legislativa degli stessi soggetti.
65
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Quanto alle procedure, il dialogo sociale, in sostanza, riconosceva alla legge un ruolo privilegiato e
tendenzialmente sostitutivo della contrattazione collettiva, garantendo al Governo il potere d’iniziativa e
un’ ampia discrezionalità nell’impostazione e nelle conduzione del confronto e, quindi, un altrettanto ampio
potere di determinarne sostanzialmente gli esiti.
Questo anche perché il Libro Bianco prevedeva che, nell’eventualità di disaccordo tra le parti sociali, il
Governo potesse procedere sulla base di un consenso maggioritario (c.d. regola della maggioranza).
Tuttavia, nella concreta applicazione del metodo in oggetto – che nel 2002 ha portato alla sottoscrizione del
Patto per l’Italia tra Governo, CISL e UIL – il criterio della maggioranza è stato inteso come maggioranza
delle organizzazioni, a prescindere da ogni verifica sulla loro effettiva consistenza rappresentativa (e,
dunque, sull’esistenza di un consenso realmente maggioritario tra i lavoratori).
Dopo la sottoscrizione del Patto, gli stessi sindacati che avevano sottoscritto il Patto manifestarono
ripetutamente il proprio dissenso sulle iniziative ed i provvedimenti assunti dal Governo, fino a denunciare la
sostanziale inattuazione del Patto ed a far ricorso al conflitto. Queste vicende, dimostrano che il dialogo
sociale non è stato utile ad acquisire il consenso preventivo delle parti sociali e ad evitare reazioni
conflittuali. Ed, infatti, numerosi richiami alla opportunità di riavviare la concertazione cominciarono presto
a provenire da tutte le parti sociali, compresa la Confindustria.
7. Il Protocollo del 23 Luglio 2007 VEDI FOTO P 246
Nella XV a legislatura, il ritorno al Governo di una coalizione di centro-sinistra determinò il rilancio della
concertazione, al fine di affrontare alcuni dei grandi problemi economico-sociali del Paese. Il confronto che
si aprì tra Governo e parti sociali portò, nel 2007, alla stipulazione del c.d. Protocollo sul Welfare e alla
successiva attuazione legislativa delle previsioni dell’intesa. Si tratta di un accordo di notevole portata perché
ha toccato una molteplicità di temi rilevanti (rilancio dello sviluppo economico, sistema previdenziale,
mercato del lavoro) che, date le loro strategicità e delicatezza, hanno condotto all’emersione di problemi e
divergenze all’interno della stessa maggioranza parlamentare e di Governo, che hanno messo in crisi prima
l’esito della concertazione e, poi, la stessa stabilità del Governo. L’intesa fu comunque raggiunta e, per
rafforzare la propria adesione al Protocollo i sindacati indissero una consultazione dei lavoratori di grandi
dimensioni, che raccolse l’80% dei consensi e fornì, così, una forte legittimazione all’accordo. Come si è
accennato, però, i dissidi interni alla maggioranza sono proseguiti anche nella fase successiva all’intesa e
soprattutto in sede parlamentare: la legge che recepiva il testo sottoscritto dal Governo con le parti sociali e
la legge finanziaria per il 2008 furono approvate, ma il Governo entrò in crisi ponendo così fine alla
legislatura.
Queste vicende confermano due elementi:
• il ruolo centrale, nella concertazione, dell’attore pubblico, anche nel condizionare gli sbocchi e la
stabilità delle intese raggiunte;
• la delicatezza del rapporto fra concertazione e ruolo del Parlamento: la concertazione non
espropria il Parlamento, ma attribuisce al Governo la responsabilità di tradurre in legge i
contenuti dell’accordo attraverso la sua maggioranza parlamentare.
8. Natura giuridica dei protocolli triangolari e problemi di legittimità costituzionale
Il significato giuridico degli accordi triangolari tra Governo, organizzazioni imprenditoriali e sindacati
costituisce un problema di grande rilevanza, anche perché presenta delicati profili di legittimità costituzionale
– affrontati dalla Corte con sent. 34/1985 – attinenti:
• da un lato, alla forma di Governo, al cui proposito la Corte – rivolgendo l’attenzione all’Accordo del
1983 – qualificò il Governo “quale soggetto che assume una serie di impegni politici, spesso assai
precisi e rilevanti”, rilevando comunque come ciò non contrasta con la Costituzione a patto che
rimanga inalterata la forma di Governo da questa disposta.
L’affermazione che la prassi della concertazione non violi la Costituzione è pienamente condivisibile:
la concertazione sociale, a ben vedere, formalizza e rende pubblica l’influenza degli interessi
particolari di cui sono portatrici le c.d. parti sociali. La forma di Governo disciplinata dalla
Costituzione non è alterata dalla considerazione di questi interessi, a condizione che la
rappresentanza politica resti livera di valutare le proposte presentate, e la sola abilitata ad
interpretare la volontà popolare e, dunque, che l’accordo concertato non sia altro che un mero
documento programmatico degli impegni assunti, senza che da essi discendano vincoli giuridici,
né tantomeno limitazioni della sovranità parlamentare, quale titolare del potere legislativo ex art.
70 Cost..
66
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Che questo sia l’assetto voluto dalle parti risulta esplicitamente dall’accordo del 1998, che fa
esplicito riferimento al principio del rispetto delle prerogative e delle funzioni costituzionalmente
garantite.
• dall’altro, alla possibilità di ricomprendere questa attività sindacale nell’art. 39 Cost..
A tal proposito, innanzitutto la Corte affermò che l’intervento legislativo non viola l’art. cit.,
perché intendeva perseguire “finalità di carattere pubblico, trascendenti l’ambito nel quale si colloca
[…] la libertà di organizzazione sindacale e la corrispondente autonomia negoziale”.
Ambigua è l’altra affermazione della sent., stando alla quale gli accordi triangolari non sono
regolati dall’art. 39 Cost., in quanto “le organizzazioni sindacali non sono in tal campo separate
dagli organi statali, bensì cooperanti con essi”. Se è certamente vero che tali accordi sono diversi
dai contratti collettivi, non lo è l’affermazione per cui le organizzazioni imprenditoriali ed i sindacati
coopererebbero con il Governo alla promozione dell’interesse generale: le parti sociali sono portatrici
dell’interesse collettivo dei gruppi rappresentati che, per quanto ampio, non coinciderà mai con
quello generale.
Peraltro, se l’accordo di concertazione non è regolato dal quarto comma dell’art. 39 Cost. in quanto
non è un contratto collettivo, l’attività di autotutela svolta dai sindacati nell’ambito della
concertazione certamente è oggetto della libertà sindacale tutelata dal primo comma dello stesso
articolo. Concertazione (e accordi triangolari), contrattazione collettiva (e contratti collettivi) sono,
cioè, due diverse species dello stesso genus dell’autonomia sindacale collettiva.
B. Il dialogo sociale nell’ordinamento dell’Unione europea
1. Unione europea e attività negoziale delle organizzazioni sindacali
L’interesse dei pubblici poteri ad ottenere il consenso alla propria azione politica da parte delle
organizzazioni rappresentative degli interessi ha indotto anche il legislatore comunitario a riconoscere a
queste organizzazioni un ruolo attivo nella formazione delle politiche dell’Unione in alcune, fondamentali,
materie sociali.
Si deve preliminarmente segnalare che:
• nelle esperienze nazionali, è stata la forza espressa dalle coalizioni dei lavoratori che prima ha
prodotto il fenomeno sociale della contrattazione collettiva e, poi, ha indotto l’ordinamento a
conferirgli uno statuto giuridico;
• a livello comunitario, invece, la ritrosia delle organizzazioni sindacali nazionali a cedere quote del
proprio potere a soggetti sindacali europei ha ostacolato fortemente l’affermazione di organizzazioni
sindacali forti e rappresentative, che andassero al di là della somma delle organizzazioni nazionali e,
pertanto, fossero in grado di condurre trattative e di stipulare contratti collettivi a livello europeo.
Peraltro, considerato anche che un riconoscimento giuridico dei diritti sociali fondamentali è mancato,
nell’ordinamento comunitario, fino all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2009), è intuitivo capire come
le parti sociali, almeno in una prima e lunga fase dell’integrazione comunitaria, interloquissero con i pubblici
poteri più per l’interesse degli organi di governo dell’unione ad ottenere il consenso, che come naturale
sbocco dell’autonomia collettiva. In altri termini, il dialogo sociale europeo è nato e si è sviluppato
dall’alto verso il basso, e non viceversa.
Solo con i Trattati degli anni Novanta e, infine, con il Trattato di Lisbona, il dialogo sociale europeo muta
l’originario carattere octroyee per assumere, gradualmente, una propria e peculiare fisionomia.
2. Il dialogo sociale e gli accordi sindacali europei
Di particolare importanza ai nostri fini è l’art. 153, TFUE che, delimitando il campo d’azione del legislatore
comunitario, sottrae alla sua competenza materie come le retribuzioni, il diritto di associazione, il
diritto di sciopero e la serrata.
L’art. 151, TFUE, dal canto suo, indica nel dialogo sociale uno degli obiettivi della politica sociale
dell’Unione e degli Stati membri. A sua volta, l’art. 152.1, TFUE impegna l’Unione europea a riconoscere e
promuovere il ruolo delle parti sociali al suo livello , e a facilitare il dialogo tra tali parti, nel rispetto
della loro autonomia. La sua collocazione non già tra le disposizioni generali, ma tra quelle dedicate alla
Politica sociale, collega strettamente il ruolo delle parti sociali all’azione dell’Unione (e degli Stati membri)
volta a realizzare gli obiettivi descritti dall’art. 151, Insomma, devono essere oggetto di dialogo sociale –
che si svolge tra le parti stesse, o tra queste e l’Unione – tutte le azioni comunitarie miranti a perseguire
gli obiettivi ex art. 151, TFUE.
67
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
L’interpretazione di cui sopra trova conferma nel riconoscimento di un valore istituzionale al Vertice sociale
trilaterale per la crescita e l’occupazione – composto da rappresentati dei sindacati, degli imprenditori e
del Consiglio – e nella sua qualifica come mezzo che “contribuisce al dialogo sociale”, senza alcuna
ulteriore specificazione.
Di ambito più puntuale è, invece, il Dialogo sociale di competenza della Commissione: l’art. 154, TFUE,
attribuisce alla Commissione “il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello
dell’Unione” e specifica che essa “prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo, provvedendo ad un
sostegno equilibrato delle parti”. A tal fine, la Commissione, prima di presentare proposte nell’abito del
“settore della Politica sociale”, deve consultare le Organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro sulla
opportunità e sugli obiettivi di massima di un’ azione dell’Unione; se poi intende proseguire nell’iter
legislativo, deve consultarle nuovamente sui contenuti della proposta. A sua volta, l’art. 155, TFUE,
prevede che, nell’ambito di queste consultazioni, le parti sociali possono anche comunicare alla
Commissione la loro intenzione di provvedere esse stesse a disciplinare contrattualmente la materia che
forma oggetto della proposta della Commissione. Questa stessa norma prevede anche che agli accordi
raggiunti nell’ambito di questa procedura possa esser data attuazione:
• secondo una modalità c.d. debole, giusta la quale l’accordo è attuato in base alla prassi ed alla
normativa proprie di ciascuno Stato membro (per questo, l’accordo che ne scaturisce è detto
“libero”);
• la debolezza di questa prima modalità di attuazione dell’accordo risiede nella contraddizione
tra la stipulazione dell’accordo, che avviene a livello comunitario, ed il rinvio agli ordinamenti
nazionali per l’efficacia dello stesso: il medesimo accordo avrà tante valutazioni giuridiche
differenti quanti sono gli Stati che compongono l’Unione;
• secondo una modalità c.d. forte – ove l’accordo riguarda le materie comprese nella competenza
concorrente dell’Unione (ex art. 153, TFUE) – giusta la quale l’accordo trova attuazione tramite
un apposito atto normativo che, nella prassi, è una direttiva (l’accordo che ne scaturisce è detto
“vincolato” in quanto la sua efficacia dipende dall’adozione di un apposito atto legislativo
comunitario);
• tale forma di attuazione è “vincolata” ratione materiae, dal momento che l’accordo stipulato
tra le parti può avere ad oggetto solo le materie elencate nell’art. 153, TFUE.
3. L’attuazione delle direttive attraverso la contrattazione collettiva
Un altro profilo di rilevanza dell’autonomia collettiva nell’ordinamento comunitario emerge dall’art. 153.3,
TFUE, il quale dispone che “uno Stato membro può (e non “deve”) affidare alle parti sociali, a loro
richiesta congiunta, il compito di mettere in atto”, mediante contratti collettivi (di ambito nazionale), le
direttive adottate dal Consiglio, sia quelle emanate secondo le normali procedure legislative, sia quelle che
danno efficacia agli accordi collettivi (c.d., appunto, “vincolati”). Resta fermo che lo Stato membro ha
l’obbligo di assumere tutte le misure necessarie perché i risultati imposti dalla direttiva stessa siano realizzati
e, quindi, di assicurare l’efficacia soggettiva generalizzata e la stabilità temporale degli effetti dei contratti
collettivi.
Pare ovvio che:
• nei sistemi in cui il contratto collettivo può conseguire efficacia erga omnes (ad es., Belgio, Francia
e Germania), il ricorso a questa modalità di attuazione non presenta problemi;
• nei sistemi, come il nostro, in cui il contratto collettivo di diritto comune non è dotato di una simile
efficacia, sono più che legittimi i dubbi sull’utilizzabilità di tale strumento per la recezione delle
direttive.
Proprio per superare questa impasse, nel Patto sociale del 1998 (v. sez. A, par. 5) Governo e parti
sociali hanno concordato di sottoporre a concertazione “anche la trasposizione delle direttive
comunitarie […], soprattutto in riferimento a quelle che siano state emanate a seguito del dialogo
sociale [comunitario]”.
In dottrina, secondo un’ opinione autorevole (D’Antona), sarebbe legittima una legge che
introducesse un meccanismo ad hoc – cioè diverso da quello previsto dalla seconda parte dell’art.
39 Cost. (v. cap. III, sez. B, par. 8) – di estensione dell’efficacia soggettiva degli accordi sindacali
attuativi di direttive comunitarie (infatti, la regola posta dalla norma costituzionale dovrebbe cedere di
fronte all’art. 153.3 TFUE, ex art. 117, c. 1 Cost.). A questa tesi si è, tuttavia, obiettato che tale
prevalenza potrebbe essere invocata ove il legislatore nazionale fosse obbligato a ricorrere allo
strumento negoziale, sennonché tale obbligo non sussiste.
68
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
4. Gli sviluppi più recenti del dialogo sociale
Accanto al metodo dell’armonizzazione normativa, che si esplica attraverso le direttive, il “modello sociale
europeo” include anche altri metodi d’intervento, tra cui va menzionato il dialogo sociale settoriale, che
affonda le sue radici nella sostituzione dei vecchi comitati paritetici in Comitati di dialogo sociale settoriale,
aventi funzioni consultive sui “processi a livello comunitario che abbiano implicazioni sociali” ed il compito di
promuovere il dialogo sociale a livello settoriale.
Vi è, poi, il principale strumento finanziario dell’Unione, il Fondo sociale europeo, al cui intervento sono
rimesse specifiche finalità di politica dell’occupazione, incluse quelle di “rafforzare la coesione economica e
sociale dell’Unione europea allargata”.
Infine, vanno considerate le interessanti prospettive di sviluppo di una dimensione transnazionale delle
relazioni industriali. In tale direzione sembra orientato il Trattato di Lisbona che, come detto, con l’art.
152.1, TFUE, riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali a livello europeo e ne facilita il dialogo. Del
resto, l’art. 155.1 non sembra limitato a disciplinare l’attuazione dei contratti collettivi conclusi ex art. 154, ma
sembra includere anche contratti collettivi “liberi”, cioè promossi, negoziati e stipulati esclusivamente dalle
organizzazioni datoriali e sindacali. Con questa interpretazione ampia è ben possibile attribuire una base
giuridica alla contrattazione collettiva transnazionale.
In definitiva, il modello sociale europeo fin qui è stato frutto, per lo più, della paziente opera praticata dalla
Corte di Giustizia, attraverso un processo interpretativo volto al graduale bilanciamento degli originari valori
economici con i valori sociali progressivamente entrati a far parte del tessuto connettivo dell’Unione. Ciò non
è più sufficiente ed è necessario, piuttosto, che entrino in campo gli attori sociali.
CAPITOLO XI
L’AUTOTUTELA E IL DIRITTO DI SCIOPERO
1. L’autotutela degli interessi collettivi
L’autotutela degli interessi collettivi, una delle manifestazioni essenziali della coalizione sindacale, può
esprimersi i una varietà di comportamenti, il cui denominatore comune è l’ esercizio di una pressione, a
difesa di interessi collettivi, generalmente indirizzata nei confronti della controparte del conflitto sindacale
(ma anche nei confronti di altri, come nel caso degli scioperi aventi finalità politiche).
L’ordinamento non valuta allo stesso modo tutte le manifestazioni di autotutela: vi sono forme che
costituiscono un diritto (qual è oggi lo sciopero in Italia), mentre altre sono mera espressione di libertà
(come la serrata dei datori di lavoro); altre ancora, poi, sono vietate dalla legge e, se praticate, possono
portare conseguenze sul piano civile, disciplinare o, addirittura, penale.
2. Sciopero e diritto: lineamenti storici
Nel nostro ordinamento, fino al 1889 lo sciopero era considerato un reato dal codice penale sardo (esteso
dopo l’unificazione a tutto il territorio del Regno d’Italia), in conseguenza dell’ostilità dell’ordinamento
giuridico – ispirato ai principi individualistici della Rivoluzione francese e del liberalismo – verso coalizioni che
potessero, in qualche modo, riesumare le antiche corporazioni.
Nel 1889, con l’emanazione del c.d. Codice Zanardelli, venne abrogato il divieto di coalizione: lo sciopero
non fu più considerato un fatto perseguibile penalmente, purché posto in essere senza “violenza o minaccia”.
Sebbene non più reato, la sospensione della prestazione da parte del lavoratore integrava, sul piano
civilistico, gli estremi dell’inadempimento contrattuale, anche nell’ipotesi di sciopero.
Con l’ordinamento corporativo (1926), si ritornò alla repressione penale, e furono create alcune figure di
reato che, poi, passarono nel c.d. Codice Rocco (1930). Questo, infatti, agli artt. 502-508 sanzionava come
delitti “contro l’economia pubblica” tutti i mezzi di lotta sindacale (sciopero e serrata, boicottaggio, ecc.)
mentre, con gli artt. 330 e 333, considerava reati contro la Pubblica Amministrazione l’interruzione di un
servizio pubblico o di pubblica necessità, e l’abbandono individuale di un pubblico servizio, ufficio o lavoro.
La ratio di queste norme incriminatrici era, evidentemente, diversa da quella sottesa alle precedenti:
• nei codici penali liberali prefascisti era, come visto, la volontà di negare e reprimere le
organizzazioni sindacali;
• nel corporativismo fascista, invece, era quella di garantire l’effettività del meccanismo di
definizione delle controversie attraverso la Magistratura del lavoro.
69
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Se per l’esplicita abrogazione di alcune di queste norme si è dovuto attendere la legge – del 1990 – che oggi
regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, fu invece la giurisprudenza – evidentemente della Corte
costituzionale – a dichiararle incostituzionali.
3. Lo sciopero nella Costituzione
Nella Carta costituzionale, la norma fondamentale in materia di conflitto di lavoro è l’ art. 40, giusta il quale “Il
diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano”.
Il riconoscimento di tale diritto conferisce al principio di libertà di organizzazione sindacale (ex art. 39 Cost.)
un potente strumento di effettività: è proprio la garanzia dello sciopero che consente all’organizzazione
sindacale di esistere ed operare. In altri termini, l’art. 40 Cost. svolge un ruolo di garanzia della libertà
sindacale. Questa norma:
• non si limita a restaurare una libertà previgente nell’ordinamento prefascista;
• ma, superando la concezione liberista della parità tra le parti del conflitto industriale, configura lo
sciopero come diritto sulla base dell’ineguale rapporto di forza esistente tra le stesse parti.
Nella Costituzione italiana, dunque:
• mentre lo sciopero costituisce esercizio di un diritto;
• la serrata non trova una qualificazione giuridica specifica.
L’art. 40 Cost. si pone, dunque, come una delle norme costituzionali in cui più acutamente si rileva il
contrasto tra:
• Stato liberale, fondato sull’asserzione del principio di uguaglianza formale del cittadino di fronte
alla legge;
• Stato sociale, che tende alla realizzazione di un’ uguaglianza sostanziale. In quest’ottica, il diritto
di sciopero costituisce uno degli strumenti giuridici atti a rimuovere la disuguaglianza sociale, che
caratterizza la posizione del lavoratore nei rapporto con il datore di lavoro.
Fino alla l. 146/1990 sono mancate leggi regolatrici dello sciopero, e dunque il compito di inquadrare la
norma costituzionale nell’ordinamento giuridico è stato, di fatto, attribuito alla giurisprudenza. Punto di
partenza di essa fu la sent. 29/1960, con cui la Corte costituzionale dichiarò illegittimo l’art. 502 c.p., che
qualificava come delitto sia lo sciopero, sia la serrata per fini contrattuali. La Corte, che era stata investita
specificamente della questione di legittimità costituzionale della sanzione penale della serrata, dichiarò
incostituzionale l’intera norma, affermando che il divieto penale dello sciopero “a più forte ragione” non
era compatibile con gli artt. 39 e 40 Cost.. Si affermarono, così, alcuni fondamentali principi:
• in primo luogo, la Corte riconobbe l’immediata precettività dell’art. 40 Cost., così sconfessando la
tesi di chi riteneva quella norma meramente programmatica;
• si affermò l’incompatibilità del divieto penale di sciopero e serrata col nuovo ordinamento
democratico;
• si evidenziò la stretta connessione tra l’art. 40 e l’art. 39 Cost., affermando che “sebbene
enunciati in due distinte norme, il principio della libertà di sciopero e il principio della libertà sindacale
non possono non considerarsi logicamente congiunti”.
Il sindacato nasce dal conflitto industriale; dunque, il diritto di sciopero, inteso come diritto al conflitto,
può riguardarsi come il sostrato della stessa libertà organizzativa sindacale.
4. Lo sciopero nel diritto dell’Unione europea
Il riconoscimento dello sciopero come diritto fondamentale viene operato anche nell’ordinamento dell’Unione
europea. La Carta di Nizza – che ha acquisito valore giuridicamente vincolante col Trattato di Lisbona - , nel
riconoscere una pluralità di diritti fondamentali, enuncia, fra questi, il diritto di negoziazione collettiva e di
sciopero (art. 28: “I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al
diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi,
ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro
interessi, compreso lo sciopero”).
L’Unione riconosce, quindi, il diritto di azione collettiva come diritto fondamentale, senza fornirne una
regolamentazione, che preferisce rimettere alla competenza dei legislatori degli Stati membri. Difatti, stando
all’art. 153, TFUE, le materie che esulano dalla competenza comunitaria sono retribuzioni, diritto di
associazione, diritto di sciopero e di serrata, temi, questi, sui quali l’Unione riconosce la competenza
esclusiva dei legislatori nazionali.
5. Lo sciopero come diritto: conseguenze
70
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
La qualificazione dello sciopero come “diritto costituzionalmente garantito” determina implicazioni in varie
direzioni. Fin dall’inizio, la dottrina sottolineò come lo sciopero dovesse essere inteso come diritto pubblico
di libertà: questa qualificazione sta ad indicare che la norma opera nel rapporto tra Stato e cittadino, nel
senso che non può esser emanato alcun provvedimento legislativo, amministrativo ovvero
giurisdizionale, che contrasti con il diritto di sciopero.
A ben vedere, il diritto di sciopero esplica, però, i suoi effetti anche nei rapporti intersoggettivi privati,
inibendo al datore di lavoro la possibilità di compiere atti diretti a mortificare l’esercizio del diritto. La
rilevanza di tali effetti, negata in un primo momento, fu riconosciuta sotto l’impulso della dottrina e trovò
esplicita conferma nella legislazione, quando l’art. 4, l. 604/1966 dichiarò nullo il licenziamento “determinato
dalla partecipazione ad attività sindacali” e, quindi, anche dalla partecipazione ad uno sciopero. Questa
tutela venne ulteriormente estesa dallo Statuto dei lavoratori, nei confronti di ogni discriminazione operata ai
danni del lavoratore a causa della sua partecipazione ad uno sciopero (artt. 15 e 16), nonché nei confronti di
ogni comportamento del datore diretto ad impedire o a limitare l’esercizio di tale diritto (art. 28, v. cap. VI,
sez. B).
La partecipazione ad uno sciopero, in quanto esercizio di un diritto, costituisce un fatto giuridicamente
lecito e non un inadempimento contrattuale, anche se, naturalisticamente, consiste in una mancata
esecuzione della prestazione lavorativa: emerge, qui, il principio per cui “qui iure suo utitur, neminem
laedit”.
È a questo proposito che, soprattutto, si manifesta il superamento dei principi propri dello Stato liberale:
• dalla libertà di sciopero, concetto che implica unicamente l’esclusione di ogni responsabilità
penale,
• si passa al diritto di sciopero e, quindi, all’esclusione anche di ogni responsabilità contrattuale,
poiché prevale l’interesse all’autotutela del lavoratore sul diritto dell’imprenditore ad ottenere la prestazione
lavorativa.
La giurisprudenza ha dato coerente applicazione a questi principi, riconoscendo che l’esercizio del diritto
di sciopero sospende le due obbligazioni del rapporto di lavoro: il lavoratore ha la facoltà di non
prestare il lavoro e, di conseguenza, in virtù del principio sinallagmatico viene meno l’obbligo del datore di
corrispondere la retribuzione. Per contro, se lo sciopero non fosse riconosciuto come diritto, alla
sospensione della prestazione conseguirebbe non solo la non corresponsione della retribuzione, ma anche
una responsabilità contrattuale (tale da esporre il lavoratore a sanzioni disciplinari ed, eventualmente, al
licenziamento per inadempimento).
6. La titolarità del diritto di sciopero
Dallo stretto nesso funzionale individuato tra il diritto di sciopero e gli artt. 3, c. 2 e 39 Cost., debbono trarsi
alcune importanti conseguenze in ordine alla titolarità del diritto stesso. Innanzitutto, deve escludersi che
essa spetti alle organizzazioni sindacali: lo sciopero può essere praticato anche da gruppi di lavoratori
non organizzati, e sarebbe del tutto arbitrario escludere tale ipotesi dalla tutela ex art. 40 Cost.. Del resto, se
titolari del diritto di sciopero fossero i sindacati e non i lavoratori, non si comprenderebbe perché il suo
esercizio dovrebbe avere l’effetto di sospendere l’obbligazione di lavoro anche dei lavoratori non iscritti; al
contrario, nessuno ha mai dubitato del diritto di questi di partecipare allo sciopero stesso.
In realtà, il diritto in questione può essere definito come diritto individuale ad esercizio collettivo: la sua
titolarità spetta, cioè, ad ogni singolo lavoratore, anche se – essendo esso riconosciuto per la tutela
comune di un interesse collettivo – il suo esercizio si esplica collettivamente. Insomma, per determinare se
la sospensione operata da pochi dipendenti – al limite, uno solo – sia o meno qualificabile come sciopero, è
decisiva solo la natura collettiva, e non individuale, dell’interesse perseguito. Al contrario, una pluralità,
anche numerosa, di lavoratori, uniti in astensione da ragioni individuali e sconnesse tra loro, non fa sciopero.
7. Gli scioperi dei lavoratori parasubordinati e le astensioni degli autonomi
Problema distinto è se titolari del diritto di sciopero siano solo i lavoratori subordinati, ovvero anche i
lavoratori che abbiano stipulato un diverso contratto. Se, come visto, il diritto di sciopero è riconosciuto dalla
Costituzione come strumento atto a realizzare l’obiettivo di cui all’art. 3, c. 2, Cost., ciò che conta non è il
dato formale della possibilità di inquadrare o meno nell’art. 2094 c.c. (Prestatore di lavoro subordinato) il
rapporto giuridico in forza del quale il lavoro viene erogato, ma la reale situazione di sottoprotezione
sociale.
La Corte costituzionale, in sent. 222/1975 dichiarò l’illegittimità della norma incriminatrice della serrata
posta in essere da esercenti di piccole industrie e commerci privi di lavoratori alle proprie dipendenze,
per contrasto con l’art. 40 Cost.: ad avviso della Corte è infatti errato qualificare come “serrata” la protesta di
71
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
tali imprenditori, perché si tratta di un comportamento ininfluente su alcun rapporto di lavoro; in altri termini,
svolgendo la loro attività d’impresa solo col proprio lavoro, essi non sono qualificabili come datori di
lavoro.
Successivamente, la Cassazione, in sent. 3278/1978 riconobbe la titolarità del diritto di sciopero ai
lavoratori autonomi in condizione di parasubordinazione.
Tale orientamento estensivo, tuttavia, non va portato oltre il segno. Lo sciopero è, storicamente, strumento di
lotta di gruppi sociali subalterni: se tale disuguaglianza non sussiste, l’astensione dal lavoro non può
essere configurata come sciopero e, del pari, non potrà trovare applicazione l’art. 40. Difatti, la Corte
costituzionale, con sent. 53/1986, ha respinto il tentativo di estendere la portata della sent. 222/1975 ai
piccoli imprenditori con uno o due lavoratori.
Secondo la Corte, piuttosto, queste forme di lotta – pur non essendo qualificabili come sciopero e non
rientrando, dunque, nella tutela dell’art. 40 Cost. – godono comunque della tutela costituzionale – meno
pregnante – ex art. 18 Cost., in quanto manifestazione di libertà associativa.
8. Natura giuridica del diritto di sciopero
Alcuni autori – nell’ottica della c.d. “disponibilità della pretesa” – hanno definito il diritto di sciopero come
diritto potestativo del lavoratore, il cui esercizio costituirebbe un negozio giuridico che fa venir meno il
diritto del datore alla prestazione lavorativa. Stando a questa premessa, tale diritto non potrebbe però
esercitarsi se non in funzione di una pretesa diretta contro il datore di lavoro.
In quest’ottica, insomma, lo sciopero, per essere legittimo, dev’esser praticato solo a sostegno di
rivendicazioni che possano essere soddisfatte dal datore di lavoro; è, invece, posizione molto diffusa in
dottrina e in giurisprudenza che il concetto di sciopero vada definito con riguardo agli interessi economico-
professionali, intesi nel senso più ampio (v. cap. XII, sez. A, par. 2).
Se poi si guarda al diritto di sciopero come diritto assoluto della persona – condizionato all’esistenza di un
contratto di lavoro, ma non necessariamente attinente al rapporto giuridico col datore – si perviene ad una
definizione più coerente alla sua valutazione sociale del fenomeno. Per questa via è dato ammettere la
legittimità delle ipotesi di sciopero di solidarietà e di sciopero diretto ad esercitare una pressione
sulla pubblica autorità.
Né è più convincente la qualificazione dell’esercizio del diritto come negozio giuridico: nel comportamento
del lavoratore che attua lo sciopero, infatti, non si ravvisa alcun intento negoziale.
Il problema della definizione della natura giuridica dello sciopero si semplifica notevolmente trattandolo come
un comportamento rilevante quale mero fatto giuridico: qualsiasi astensione dal lavoro, in quanto
concertata da un gruppo di lavoratori ed avente per obiettivo la soddisfazione di un interesse collettivo,
rileva non per la dichiarazione di volontà che essa possa implicitamente esprimere, ma come semplice
comportamento, cui l’ordinamento ricollega l’effetto giuridico della sospensione del rapporto di lavoro. Alla
stregua di tale costruzione, pare chiaro che non è necessaria la proclamazione dello sciopero da parte
dell’associazione sindacale. Del resto – e coerentemente – la giurisprudenza ha di recente affermato che,
al di fuori dei servizi pubblici essenziali (v. cap. XIII, par. 5), non vi è alcun obbligo di preavviso.
9. Sciopero e retribuzione
In forza del principio sinallagmatico, l’effettuazione di uno sciopero sospende, per il lavoratore che vi
abbia partecipato, il diritto alla retribuzione, con una serie di precisazioni:
• in primo luogo, la sospensione non si estende a diritti diversi da quelli relativi alla retribuzione
(non incide, ad es., sulla sfera dei diritti sindacali e, in particolare, sul diritto di assemblea);
• peraltro, la sospensione della retribuzione deve essere riferita a tutti i suoi elementi e, quindi,
anche a quelli accessori che abbiano carattere retributivo (ad es., la tredicesima mensilità); in tali
casi, sarà legittima la trattenuta operata in misura proporzionale alla durata dello sciopero;
• si ritiene, poi, che anche il periodo di ferie vada ridotto proporzionalmente alla durata dello sciopero,
sulla scorta della considerazione per cui il diritto alle ferie retribuite risponda all’esigenza di
reintegrare le energie del lavoratore spese durante un anno di lavoro. Se questi, dunque, non ha,
speso alcuna energia, durante il periodo di sciopero, ricollegabile alla prestazione di lavoro, ne
consegue che il periodo di ferie vada congruamente ridotto.
Tale orientamento non è però univoco, perché vi è chi sottolinea che le ferie, come il trattamento di
fine rapporto, siano indipendenti ed intangibili dalle cause che sospendono le sole prestazioni di
lavoro (qual è lo sciopero), senza interrompere o sospendere il rapporto di lavoro complessivamente
inteso.
In realtà, tali problemi vanno risolti sulla base delle norme contenute nei contratti collettivi.
72
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Un aspetto molto controverso riguarda i c.d. scioperi brevi, cioè quelli di durata inferiore alla giornata
lavorativa. Si è sostenuto che, in tali casi, la trattenuta sulla retribuzione debba essere operata in
proporzione non già alla durata dello sciopero, ma alla diminuita utilità della prestazione, come se il
prestatore di lavoro dovesse effettuare non una prestazione utile in sé, bensì una che realizzi l’utilità
economica finale cui è preposta l’organizzazione produttiva. È apparso dunque più corretto riconoscere che
al lavoratore nulla spetti non già quando il creditore della prestazione abbia trovato “poco utile”
l’effettuazione di quest’ultima, bensì quando la prestazione, in conseguenza dello sciopero breve, sia
scesa al di sotto di quel livello di “normalità tecnica”, mandando la quale essa viene a perdere la sua
stessa identità originaria. È, infatti, possibile parlare di un’ unità tecnico-temporale infrazionabile, al di sotto
della quale l’attività lavorativa non ha, di per sé, alcun significato. In sostanza, l’utilità del risultato – indice
dell’esatto adempimento – andrebbe misurata non in relazione al risultato finale cui l’imprenditore tende,
bensì in relazione alla natura della singola prestazione. Al di sotto di essa, comunque, non essendovi
prestazione (utile), non nascerà il diritto alla controprestazione retributiva.
10. Le attività strumentali all’esercizio del diritto di sciopero
Il riconoscimento del diritto di sciopero implica necessariamente il riconoscimento del diritto a porre in essere
comportamenti strumentali rispetto alla stessa astensione dal lavoro: l’ordinamento, nel momento in cui
riconosce il diritto di sciopero, non può, a pena di smentire se stesso, negare la propria tutela ai
comportamenti strettamente collegati con l’effettiva possibilità di esercizio di quel diritto.
Si pensi, ad es., all’attività di propaganda, ovvero alle pubbliche manifestazioni o, infine, ai cortei interni.
Quanto al picchettaggio – e, cioè, all’organizzazione, da parte dei sindacati o dei lavoratori in sciopero, di
una vigilanza all’ingresso dei luoghi di lavoro – esso è considerato lecito, a condizione che non si traduca
in comportamenti autonomamente rilevanti sul piano penale (come costantemente affermato dalla
giurisprudenza, la condotta diretta ad impedire, con violenza o minaccia, l’esecuzione della prestazione da
parte dei lavoratori non scioperanti non rientra nel diritto di sciopero ed è illegittima).
CAPITOLO XII
I LIMITI AL DIRITTO DI SCIOPERO
1. La tecnica definitoria
Il Calamandrei, nel 1952, osservava che “dal momento in cui lo sciopero ha accettato di diventare un diritto,
esso si è adattato necessariamente a sentirsi prefiggere condizioni e restrizioni di esercizio che, se non
venissero stabilite per legge, dovrebbero immancabilmente essere tracciate, prima o poi, sulla base dell’art.
40 Cost. dalla giurisprudenza”.
Questa previsione si è puntualmente verificata: come ricordato, fino al 1990 è mancata quasi del tutto un’
attività del legislatore ordinario, ma una serie di limiti penetranti è stata individuata dalla giurisprudenza.
In una prima fase, fino al 1980, la dottrina aveva definito lo sciopero come “astensione concertata dal
lavoro per la tutela di un interesse professionale collettivo ”. Altri elementi, poi, erano stati aggiunti in
funzione restrittiva: l’attinenza ad un rapporto di lavoro subordinato; la “completezza” dell’astensione, sia
nella dimensione temporale (cfr., invece, lo sciopero “a singhiozzo”), sia in quella del coinvolgimento dei
lavoratori (cfr., invece, lo sciopero “a scacchiera”); la funzionalizzazione dello sciopero alla contrattazione
collettiva (cfr., invece, lo sciopero politico e quello di solidarietà): le forme di lotta cui mancasse uno o più
degli elementi individuanti erano considerate estranee alla nozione di “sciopero”. Da qui, la negazione
dell’applicabilità della tutela costituzionale in tutta un’ ampia serie di ipotesi.
Tali operazioni interpretative furono oggetto di critiche da parte della dottrina, in quanto si fingeva di dire ciò
che lo sciopero “è”, ma in effetti si diceva ciò che esso “deve essere”; si scambiava il piano descrittivo con
quello, giuridico, dell’individuazione dei requisiti che lo sciopero deve avere per essere legittimo.
Fino al 1980, peraltro, i limiti dello sciopero dovevano essere distinti in:
• esterni, derivanti dalla necessità di coordinare il riconoscimento del diritto di sciopero con gli
altri valori costituzionali, realizzando in via interpretativa un contemperamento di contrapposti
interessi;
• interni, che la giurisprudenza argomentava sulla base della suddetta tecnica definitoria.
Si vedrà come i problemi che in origine erano affrontati utilizzando gli strumenti concettuali di
quest’ultima tecnica per pervenire all’individuazione di limiti interni, sono stati successivamente – e
più correttamente – affrontati e risolti utilizzando le norme costituzionali ed i loro reciproci rapporti.
73
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
La distinzione tra limiti interni ed esterni deve, dunque, considerarsi del tutto superata.
Un’ esplicita rinunzia alla tecnica definitoria di cui ad inizio paragrafo arriva, da parte della Cassazione, con
sent. 711/1980, ove si legge che l’art. 40 Cost., così come gli artt. 15 e 28 St. lav., “non definiscono
direttamente lo sciopero, il cui significato, anche agli effetti giuridici, è quindi quello che la parola, ed il
concetto da essa sotteso, hanno nel comune linguaggio adottato nell’ambiente sociale (e che, dal
significato così individuato, esuli qualsiasi delimitazione attinente all’ampiezza temporale o all’estensione
dello sciopero stesso)”. Il rinvio alla prassi delle relazioni industriali non significa, però, che possa esser
definita “sciopero” ogni manifestazione di lotta che i soggetti agenti designino come tale: per molte di esse –
ad es., l’occupazione di fabbrica o l’ostruzionismo – deve escludersi un’ applicazione diretta dell’art. 40
Cost..
A. Gli interventi della Corte costituzionale sulle norme penali precostituzionali VEDI FOTO
1. Sciopero-diritto e sciopero-reato
Come si è visto nel cap. precedente, delle norme del codice penale repressive dello sciopero solo gli artt.
330 e 333 sono stati espressamente abrogati dalla l. 146/1990; gli artt. 502-508 c.p., invece, non sono
stati mai abrogati o riformulati dal legislatore. A ben vedere, solo l’art. 502 c.p. – che puniva la serrata e lo
sciopero per fini contrattuali – fu integralmente eliminato dalla Corte (v. cap. XI, par. 3); per contro, la
Corte scelse di non dichiarare integralmente incostituzionali tutte le altre norme penali sullo sciopero, ma di
manipolarle attraverso dichiarazioni di incostituzionalità parziale.
2. Lo sciopero politico
In un primo tempo, l’astensione dal lavoro per fini politici venne considerata illegittima:
• da un lato, per l’impossibilità di qualificare come economico-professionale l’interesse degli
scioperanti,
• e, dall’altro, perché la rivendicazione da loro avanzata non è nella disponibilità del datore di
lavoro.
La conseguenza era la compatibilità con l’art. 40 Cost., così restrittivamente interpretato, degli artt. 503
(sciopero per fine politico) e 504 c.p. (sciopero con lo scopo di costringere l’autorità a dare o ad omettere un
provvedimento).
Altra dottrina affermò la necessità di distinguere tra sciopero:
• politico in senso stretto, attinente al prevalere di questa o quella scelta intorno a specifici problemi
politici;
• economico-politico, diretto ad ottenere interventi della pubblica autorità che riguardino le
condizioni socio-economiche dei lavoratori.
Questo orientamento è stato seguito dalla Corte costituzionale che, in una serie di importanti decisioni, ha
via via più chiaramente precisato che nel diritto sancito dall’art. 40 Cost. rientrano gli scioperi proclamati
“in funzione di tutte le rivendicazioni riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori che trovano
disciplina nelle norme racchiuse sotto il Titolo III della Parte I della Costituzione”. Si tratta di scioperi
caratterizzati dal fine di tutelare interessi di natura economica e che, pertanto, sono pur sempre scioperi
politici, ma, ciononostante, sono legittimi ex art. 40 Cost., perché con essi gli scioperanti perseguono
comunque un interesse economico. Insomma, la Corte costituzionale soltanto ai fini economici dello
sciopero riconosce la natura di diritto soggettivo.
Anche lo sciopero politico puro non costituisce più, di per se, reato: la Corte cost., con sent. 290/1974
abrogò quasi integralmente l’art. 503 c.p., osservando che, nel regime costituzionale, lo sciopero trova il
suo titolo di legittimità – prima ancora che nell’art. 40 Cost. – nei fondamentali principi di libertà che
caratterizzano il nuovo ordinamento. Insomma, anche se lo sciopero politico in senso stretto non è
tutelato dall’art. 40 Cost. e, dunque, non è oggetto di un “puntuale, specifico diritto”, purtuttavia, come
specifico strumento di tutela degli interessi dei lavoratori, è di rilievo costituzionale come mezzo di
partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3, c. 2 Cost.). Di
conseguenza, è illegittima la norma penale che lo configuri come reato. Si badi che, non essendo né
oggetto di un diritto, né di una fattispecie penale, dev’esser considerato come oggetto di libertà.
Lo sciopero politico, in definitiva, “non può essere penalmente compresso se non a tutela di interessi che
abbiano rilievo costituzionale”, e dunque sono ipotesi residue di sciopero politico configurabile come
reato i soli casi in cui esso sia diretto a “sovvertire l’ordinamento costituzionale”, ovvero quando
“oltrepassando i limiti di una legittima forma di pressione, si converta in uno strumento atto ad impedire od
ostacolare il libero esercizio di quei diritti/poteri nei quali si esprime la sovranità popolare”.
74
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Non può sfuggire la notevole incertezza cui dà luogo la genericità della seconda ipotesi: è certo, ad es., che
uno sciopero nei pubblici trasporti possa avere l’effetto di impedire una riunione del Parlamento, ma non è
detto che esso miri a tale obiettivo sovversivo. Vi è, inoltre, da chiedersi in quali ipotesi possano ritenersi
oltrepassati “i limiti di una legittima forma di pressione”: si è affermato che ciò avverrebbe quando lo sciopero
sia in grado di turbare il processo di formazione della volontà pubblica, ma non si comprenderebbe allora
come la Corte abbia potuto ammettere la legittimità degli scioperi economico-politici, che sono definiti proprio
dallo scopo di influire sulle deliberazioni della pubblica autorità.
Successivamente, in simmetria con la sent. del 1974, la Corte, riproponendo il medesimo ragionamento e la
medesima soluzione con riferimento all’art. 504 c.p., ritenne che non può costituire reato neppure lo
sciopero di coazione sulla pubblica autorità, che non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale
ovvero ad impedire od ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità.
3. Lo sciopero di solidarietà
Sempre in base alla considerazione che non è condizione di legittimità dello sciopero il fatto che lo stesso sia
attuato per fini contrattuali (cioè, per sostenere pretese nei confronti del datore di lavoro), la Corte cost., in
sent. 123/1962, ha riconosciuto la legittimità anche del c.d. sciopero di solidarietà. Questa ipotesi, prevista
come reato dall’art. 505 c.p., ricorre quando alcuni lavoratori si pongono in sciopero senza avanzare una
pretesa che influisca sul loro rapporto di lavoro, ma per “solidarizzare” con le rivendicazioni di altri
gruppi, oppure contro la lesione degli interessi di un singolo lavoratore. Tale forma di sciopero, per la
Corte cost., deve trovare giustificazione “ove sia accertata l’affinità delle esigenze che motivano
l’agitazione”. Ne consegue, conclude la Corte, che, pur restando in vigore l’art. 505 c.p., esso non sarà
applicabile nell’ipotesi descritta, in quanto ricorre l’esimente dell’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.).
A ben vedere, il rinvio, da parte della Corte, della valutazione della sussistenza di una “ comunanza
d’interessi” al giudice di merito appare in netto contrasto col principio di autodeterminazione dell’interesse
collettivo, il quale comporta che il gruppo sindacale sia libero di valutare l’esistenza di un interesse tale da
giustificare lo sciopero e, nel caso di specie, l’intensità del collegamento d’interessi. D’altra parte, la
decisione qui commentata è stata pronunziata in un periodo in cui la Corte non aveva ancora elaborato le
sentenze interpretative di accoglimento: ciò spiega la permanenza in vigore, nel suo testo integrale, dell’art.
505 c.p., sia pure con la riserva di applicare, nel caso concreto, l’esimente dell’esercizio del diritto.
B. Sciopero e libertà d’iniziativa economica
1. Le c.d. forme anomale di sciopero
Un’ altra vicenda giurisprudenziale è relativa al problema dei danni che lo sciopero produce all’attività
produttiva dell’imprenditore.
Per tutto un primo e lungo periodo, che va dal dopoguerra fino al 1980 (anno della sent. 711 cit.), la
giurisprudenza ha affermato l’illegittimità dello sciopero praticato secondo “modalità anomale”, ossia
dei c.d.:
• scioperi a singhiozzo, ossia astensioni dal lavoro frazionate nel tempo in periodi brevi;
• scioperi a scacchiera, tali quando l’astensione è effettuata in tempi diversi da differenti gruppi di
lavoratori.
Nella prassi sindacale, queste due forme di sciopero – che prendono anche il nome di sciopero articolato
– sono volte a produrre il massimo danno per la controparte con la minima perdita di retribuzione per gli
scioperanti.
2. Sciopero articolato e danno ingiusto
Sullo sciopero articolato, la giurisprudenza elaborò la c.d. teoria del danno ingiusto o della corrispettività
dei sacrifici, con la quale tracciava un limite al diritto di sciopero che poneva fuori dall’area della legittimità
queste modalità di esercizio. Ove ricorra l’elemento della “totalità” (intesa sia come contemporaneità
dell’astensione da parte di tutti gli scioperanti, sia come continuità temporale della stessa), al danno subito
dall’imprenditore “corrisponde” la perdita della retribuzione da parte dei lavoratori; per contro, il rapporto di
corrispettività viene meno in uno sciopero articolato, in cui il danno subito dal datore di lavoro è ingiusto
poiché “diverso e più grave di quello necessariamente inerente ai mancati utili dovuti alla momentanea
sospensione dell’attività lavorativa dei suoi dipendenti, perdita – questa – compensata o limitata dal mancato
pagamento della retribuzione agli scioperanti”.
In realtà, il punto di discrimen tra le due coppie di concetti sciopero anomalo – danno ingiusto e sciopero
normale e danno normale è meramente quantitativo ed indeterminato, sicché risulta affidato all’arbitrarietà
dell’interprete. Peraltro, all’applicazione dei principi di correttezza e buona fede (ex artt. 1175 e 1375 c.c.),
più volte richiamati, è stato opposto che essi operano nel momento dell’esecuzione del contratto, e non
possono essere estesi allo sciopero (costituente, invece, un momento di non esecuzione della prestazione).
75
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
In realtà, l’attuazione dello sciopero, in quanto manifestazione del conflitto collettivo, costituisce un
comportamento inidoneo ad esser vatutato alla luce delle regole che presiedono all’attuazione del rapporto.
In altri termini, lo sciopero presuppone una volontà di infliggere un danno, e non si può rimproverare
chi adopera tale mezzo se tenta di rendere l’azione la più efficace possibile, sempreché – come
vedremo – non ne scaturisca la lesione di un valore altrimenti protetto.
3. Sciopero e responsabilità aquiliana
Un importante passo avanti fu compiuto da una parte della dottrina (Ghera, 1970) che pervenne aduna più
adeguata impostazione sulla base dei principi che governano la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c..
Secondo tale dottrina, sui partecipanti allo sciopero grava l’obbligo di rispetto della sfera giuridica altrui,
nel quale deve essere ricompreso anche l’interesse del datore di lavoro alla conservazione
dell’organizzazione aziendale in vista della ripresa dell’attività produttiva. Si badi che tale interesse
dev’esser tenuto distinto da quello attinente allo svolgimento dell’attività produttiva stessa, che soccombe
all’esercizio del diritto di sciopero. Danno ingiusto, in sostanza, sarebbe quello che lede l’interesse del
datore di lavoro alla conservazione dell’organizzazione aziendale. Questa impostazione sembra esser
fatta propria dalla Cassazione, che ha affermato che l’entità del danno non è elemento di qualificazione dello
sciopero come legittimo o meno, ed ha negato che l’interprete possa ricavare in via sistematica tale
qualificazione dalle regole civilistiche in tema di adempimento delle obbligazioni, in quanto lo sciopero
consiste nella non esecuzione dell’obbligazione scaturente dal contratto di lavoro.
4. Il danno alla produttività
La Cassazione, dunque, abbandona la tradizionale prospettiva dei limiti interni al diritto di sciopero,
senza peraltro rinunziare a dettar regole all’esercizio di esso sotto il profilo della sua relazione con
l’organizzazione del lavoro. In tal modo, il problema viene collocato all’interno della tecnica dei c.d. limiti
esterni, desunti dal raffronto tra l’interesse tutelato dall’art. 40 Cost. e gli altri interessi costituzionalmente
protetti.
Tra i beni che lo sciopero non deve ledere – secondo la sent 711/1980 – viene posta anche la libertà
d’iniziativa economica ex art. 41 Cost. la quale, peraltro, non dev’essere intesa nel senso di “libertà di
realizzare profitto” (altrimenti, l’unico sciopero ammissibile sarebbe quello che non produce alcun danno
all’imprenditore), dovendo invece intendersi in senso dinamico, come attività imprenditoriale garantita non
solo dall’art. 41 Cost., ma anche dall’art. 4, c. 1 Cost. (“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”).
In base a tali principi, secondo la Cassazione lo sciopero:
• non deve causare danno alla produttività, ossia dev’essere esercitato con modalità tali da non
“pregiudicare irreparabilmente [non la produzione, ma] la produttività [rectius: la “capacità
produttiva”] dell’azienda, cioè la possibilità per l’imprenditore di [continuare a] svolgere la sua
iniziativa economica;
• viceversa, è ammesso (in quanto coperto dal legittimo esercizio del diritto di sciopero) il danno alla
produzione.
Insomma, la legittimità dello sciopero non dipende più da una valutazione meramente quantitativa del
danno subito dall’imprenditore, ma da una distinzione tra due differenti qualità del danno.
5. La distinzione tra danno alla produzione e danno alla produttività
Questa impostazione giurisprudenziale non consente, tuttavia, di considerare interamente risolto il problema.
È, infatti, difficile distinguere il danno alla produttività da quello alla produzione, né vale identificare
quest’ultimo nel danno derivante dai mancati utili (infatti, in determinate situazioni, può ben darsi che il
mancato profitto per un periodo anche breve impedisca all’imprenditore di far fronte ai propri impegni e lo
escluda dal mercato, impedendogli così di continuare a svolgere la sua iniziativa economica).
Una risposta a questi dubbi può esser trovata precisando che il dovere di rispetto concerne la capacità
dell’organizzazione produttiva di riprendere a funzionare, e non le capacità competitive dell’impresa sul
mercato.
Un caso ancor più particolare è quello degli impianti che non possono esser fermati (si pensi a quelli
siderurgici). Il problema, in via empirica, è risolto con le c.d. comandate, ossia attraverso accordi tra
imprenditore e sindacati in forza dei quali una certa quantità di lavoratori continua a prestare, in tutto o
in parte, la propria opera, per evitare che lo sciopero produca gli effetti indicati. In mancanza di simili
accordi, cautele analoghe dovranno comunque esser prese unilatelarmente dai lavoratori, per evitare di
incorrere nella responsabilità aquiliana per i danni eventualmente inflitti alla produttività.
6. I limiti al diritto di sciopero nella giurisprudenza della Corte di giustizia europea
76
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Il tema del rapporto tra sciopero e libertà economiche si è arricchito di un capitolo importante a seguito di
alcune sentenze della Corte di Giustizia europea. In particolare, ne rilevano due di cui occorre dar sommaria
esposizione dei fatti:
• la Viking, società finlandese di trasporti marittimi, cambia la bandiera di una delle sue navi
registrandola in Estonia, così da poter applicare la contrattazione collettiva di quel paese e
corrispondere retribuzioni inferiori. Il sindacato finlandese cui sono iscritti i componenti
dell’equipaggio della nave promuove un’ azione sindacale, coinvolgendo la ITF (una federazione
internazionale), che invita i propri affiliati a non avviare trattative con la Viking. L’impresa, allora,
instaura una controversia giudiziaria dinnanzi ad una Corte britannica, che rimette alla Corte di
giustizia la questione pregiudiziale volta a stabilire “se il Trattato intenda vietare un’ azione
sindacale nel caso in cui la stessa abbia lo scopo di impedire ad un datore di lavoro di
avvalersi della libertà di stabilimento”;
• l’altra sentenza nasce da un ricorso della Laval, società lettone, che distaccò in Svezia un certo
numero di dipendenti. I sindacati svedesi degli edili intrapresero un’ azione per ottenere
l’applicazione a questi lavoratori del contratto collettivo dell’edilizia svedese; la trattativa non ebbe
successo, e i sindacati posero in essere un’ azione di autotutela consistente nel blocco dell’accesso
delle merci in cantiere e nell’impedire l’ingresso al cantiere dei lavoratori lettoni. La controversia
sorta innanzi al giudice svedese venne sospesa, sottoponendo alla Corte di giustizia europea la
questione pregiudiziale di stabilire se sia compatibile con le norme del Trattato sulla libera
prestazione dei servizi l’azione con cui i sindacati tentino di indurre un’ impresa straniera, che
distacca lavoratori in Svezia, ad applicare un contratto collettivo svedese.
Le sentenze, con una serie di affermazioni convergenti, limitano fortemente il diritto di azione sindacale
quando entri in conflitto con la liberta di stabilimento (caso Viking) ovvero con il diritto alla libera
prestazione di servizi (Laval).
Forti sono state le critiche mosse dalla dottrina e in sede politica, perché:
• nel caso Viking, è discutibile che il cambio di bandiera di una nave rientri nella libertà di
stabilimento e non costituisca, invece, un uso distorto o fraudolento della stessa;
• problema, di natura sistematica, è quello della competenza della Corte di giustizia a fissare limiti
al diritto di sciopero, dato che – come visto – il legislatore comunitario non ha tale competenza;
• è discutibile che le norme del Trattato prevedenti i due diritti di cui sopra, oltre a vincolare gli Stati
(effetto verticale diretto), vincolino anche l’autonomia regolativa di soggetti privati e siano opponibili
da un privato ad un altro privato (effetto orizzontale diretto).
I limiti al diritto di azione sindacale vengono dalla Corte costruiti nel raffronto con le libertà sul mercato con le
quali – nelle due diverse situazioni – lo sciopero entra in conflitto. La Corte afferma che “ la Comunità non ha
solo finalità economica, ma anche una finalità sociale” e che l’azione sindacale volta a tutelare le condizioni
di lavoro rientra in queste finalità e costituisce un diritto fondamentale, ma poi, nell’effettuare l’operazione
di bilanciamento, finisce per privilegiare le libertà di ordine economico. La Corte, insomma, non solo
non riconosce ai diritti fondamentali sociali un rango più elevato rispetto alle libertà economiche, ma
addirittura statuisce che le libertà economiche possono essere intaccate dall’azione collettiva solo
entro i limiti già presenti nella disciplina che le riconosce: l’azione collettiva non può introdurre ulteriori
limitazioni.
Nell’applicare le “restrizioni della libertà di mercato consentite” ai casi in discussione, la Corte detta all’azione
sindacale alcune regole fortemente invasive:
• nella sentenza Viking, afferma che una restrizione alle libertà economiche è possibile qualora si
persegua un obiettivo compatibile col Trattato ed essa sia giustificata da ragioni imperative di
interesse generale, ammettendo che il diritto di intraprendere un’azione collettiva rientra tra le ragioni
imperative di interesse generale già riconosciute dalla Corte, per poi precisare però che, anche
quando le condizioni per la restrizione vi siano, comunque l’azione intrapresa dai sindacati deve
essere adeguata e non deve andare al di là di ciò che è necessario per perseguirlo. Il giudizio
finale viene rimesso al giudice di rinvio, che dovrà valutare nel merito se il ricorso allo sciopero fosse
o meno giustificato; tuttavia, un simile controllo di merito nell’ordinamento italiano sarebbe
inammissibile;
• nella sentenza Laval, invece, si afferma che anche la libera prestazione di servizi è principio
fondamentale della Comunità e che “una restrizione a tale libertà può essere ammessa soltanto se
essa persegue un obiettivo legittimo compatibile con il trattato ed è giustificata da ragioni imperative
77
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
di interesse generale, purché sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo e non vada al di là
di ciò che è necessario per raggiungerlo”.
Si aggiunge che l’azione collettiva contro una pratica di dumping sociale (competizione al ribasso tra
le condizioni di tutela dei lavoratori) può essere ragione idonea, ma che nel caso in esame l’obiettivo
non giustifica l’azione, perché il datore di lavoro è tenuto a rispettare un nucleo di norme imperative
di protezione minima nello stato ospitante, mentre l’azione sindacale era diretta a costringere
l’imprenditore a praticare le condizioni retributive normalmente praticate dagli altri imprenditori in
quel settore produttivo e in quella località, e non solo quelle minime.
È evidente, insomma, come il bilanciamento sia tutto a favore delle libertà economiche: l’azione collettiva
viene ammessa come eccezione, se ed in quanto inquadrabile nelle restrizioni in generale consentite dalle
due norme che regolano dette libertà.
CAPITOLO XIII
SCIOPERO E SERVIZI ESSENZIALI
1. Premessa
L’importanza del ruolo del diritto di sciopero non può far trascurare che molti servizi sono erogati da
amministrazioni pubbliche ovvero da imprese il cui bilancio viene riassestato dalla finanza pubblica; di
conseguenza, l’accoglimento delle rivendicazioni degli scioperanti si riverbera sulla generalità dei cittadini,
ma ancor più rilevante è il fatto che danneggiato dalla sospensione dell’attività produttiva non è (solo) il
datore di lavoro, ma anche l’utenza del servizio, estranea al conflitto.
Per queste particolarità, nel 1990 il legislatore scelse di regolare organicamente la materia con la l.
146/1990, “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”.
Dieci anni dopo, il legislatore è intervenuto nuovamente sui punti deboli evidenziati dall’esperienza
applicativa, con la l. 83/2000.
2. La giurisprudenza costituzionale sugli artt. 330 e 333 c.p.
Sino al 1990, la disciplina generale della materia era affidata agli artt. 330 (Abbandono collettivo di
pubblici uffici, impieghi, servizi o lavoro) e 333 (Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o
lavoro) c.p. ed alla giurisprudenza costituzionale sugli stessi formatasi.
Peraltro, una disciplina speciale limitativa del diritto di sciopero era stata introdotta per particolari
categorie di lavoratori, operanti in settori di eccezionale delicatezza (ad es., gli addetti ad impianti nucleari
ed i controllori di volo).
Un divieto di scioperare, infine, era previsto per i militari e per il personale della Polizia di Stato.
Il legislatore del 1990 ha:
• lasciato inalterati tali divieti e discipline particolari,
• mentre ha abrogato le due previsioni penali.
Nel fare ciò ha mutuato i principi fondamentali dalle sentenze della Corte costituzionale intervenute su quelle
norme, così sintetizzabili:
• i servizi pubblici qualificati come essenziali, nei quali l’esercizio del diritto di sciopero può
incontrare limitazioni, sono solo quelli funzionali all’esercizio di diritti costituzionalmente protetti
di rango superiore o paritario;
• in essi, il diritto di sciopero dev’essere esercitato con modalità tali da evitare che sia leso
l’effettivo godimento di questi diritti nel loro nucleo essenziale;
• il diritto di sciopero e quello contrapposto devono trovare un contemperamento in concreto,
individuando i servizi minimi che devono comunque essere erogati.
3. I servizi essenziali
In continuità con tale linea giurisprudenziale, la legge del 1990 ha introdotto limiti al diritto di sciopero nei
servizi essenziali “allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della
persona, costituzionalmente tutelati” (art. 1, c. 2). La legge, per definire i servizi essenziali, utilizza un
criterio teleologico, nel senso che qualifica come tali quelli “volti a garantire il godimento dei diritti della
persona, costituzionalmente tutelati” (art. 1, c. 1). L’uso dell’espressione “diritti della persona” non è casuale,
e consente di escludere che possano costituire limite al diritto di sciopero diritti di natura economico-
patrimoniale, ancorché costituzionalmente garantiti (ad es., l’iniziativa economica privata ex art. 41 Cost.).
78
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Il legislatore, volendo dare un contributo alla certezza dei rapporti giuridici:
• nel primo comma dell’art. 1, enumera tassativamente i diritti della persona che qualificano come
essenziale il servizio volto a garantirne il godimento (alla vita, alla salute, alla liberta' ed alla
sicurezza, alla liberta' di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla
liberta' di comunicazione);
• nel secondo comma, invece, elenca in maniera meramente esemplificativa ("in particolare nei
seguenti servizi...") i servizi essenziali, raggruppati secondo il diritto della persona cui sono
funzionali.
È da registrare, rispetto alla giurisprudenza costituzionale, un allargamento dei diritti costituzionali suscettibili
di costituire un limite al diritto di sciopero, differenza, questa, che ben si giustifica in quanto la Corte
ridisegnava una fattispecie di reato, mentre il legislatore, abrogando le norme del codice penale, garantisce
le norme sostanziali con sanzioni disciplinari ed amministrative.
Coerentemente con il criterio teleologico di identificazione dei servizi pubblici essenziali, il legislatore
sottolinea che è irrilevante, ai fini della essenzialità del servizio:
• “la natura giuridica del rapporto di lavoro”, sia essa pubblica o privata, così anticipando
l’unificazione normativa del rapporto di lavoro pubblico e privato che sarebbe stata poi introdotta
dalle riforme del pubblico impiego degli anni Novanta (v. cap. IX);
• la distinzione tra lavoro subordinato ed autonomo, ma sul punto la legge del ’90 non fu
adeguatamente esplicita, sicché questo tema è stato uno di quelli su cui è intervenuta la nuova
normativa del 2000.
4. L’astensione dal lavoro dei lavoratori autonomi
In realtà, nella legge del ’90 non mancavano elementi indicanti la volontà del legislatore di estendere la
normativa anche al di là dei confini del lavoro subordinato. D’altro canto, diverse categorie di lavoratori
autonomi avevano fatto ricorso a forme di agitazione aspre e, soprattutto, incisive sulla continuità di alcuni
servizi essenziali.
Del problema era stata investita la Corte costituzionale, la quale colse l’occasione per auspicare che “tale
situazione patologica” (la mancanza di regole sull’astensione dei lavoratori non subordinati) venisse rimossa,
sottolineando che “se il legislatore ha avvertito la necessità di dettare norme sul diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali non v’è ragione per cui debbano restare esenti da specifiche previsioni forme di
tutela collettiva che, al pari dello sciopero, sono in grado di impedire il pieno esercizio di funzioni che
assumono un risalto primario nell’ordinamento dello Stato”.
Da tali affermazione, emergeva, implicitamente, che la Corte non qualificava come sciopero le astensioni
dei lavoratori autonomi e, quindi, che le considerava estranee all’art. 40 Cost. e, dall’altro, alla l.
146/1990.
Due anni dopo, la Corte ritornò sul problema e rilevò che la normativa del 1990 non apprestava una
razionale e coerente disciplina che includesse tutte le manifestazioni collettive di lotta capaci di comprimere
valori primari. In altri ermini, era irragionevole che nei servizi pubblici essenziali fossero posti limiti
all’esercizio dello sciopero – che costituisce oggetto di un diritto costituzionalmente garantito – e non ad
altre forme di lotta collettive – che non godono di pari tutela. Dopo tali premesse, la Corte dichiarò
incostituzionale l’art. 2, l. cit., nella parte in cui non prevedeva anche per queste astensioni l’obbligo di
un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale, gli strumenti idonei per individuare ed assicurare
le prestazioni indispensabili, nonché le procedure avverso eventuali inosservanze.
La l. 83/2000 ha colmato questa grave lacuna, prevedendo l’estensione dei limiti posti al diritto di
sciopero anche alla “astensione collettiva dalle prestazioni da parte di lavoratori autonomi, professionisti o
piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici essenziali” (art. 2-bis del testo novellato).
Pertanto, oggi, l’ambito di applicazione della l. 146/1990 è esteso a tutte le forme di astensione dal
lavoro, a prescindere dalla loro qualificazione come sciopero o meno e dalla natura subordinata o autonoma
del lavoro. Ciò, peraltro, non significa che la disciplina sia identica.
5. Il preavviso e l’obbligo di indicare la durata
In caso di sciopero o di astensione dal lavoro nei servizi essenziali, la l. 146, nel suo assetto originario,
indicava tre ordini di limiti: l’obbligo di preavviso, la necessaria indicazione preventiva della durata delle
singole astensioni dal lavoro, il rispetto di “misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni
indispensabili”.
79
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
La nuova legge ha integrato tali previsioni con alcune aggiunte: l’art. 2, c. 2, l. 146/1990 ora prescrive che,
nei settori disciplinati dalla legge, i contratti collettivi devono predisporre procedure di raffreddamento e di
conciliazione delle controversie, “da esperire prima della proclamazione dello sciopero”, al fine di prevenirlo
favorendo una soluzione consensuale del conflitto. Nelle more di queste procedure, né i sindacati possono
proclamare lo sciopero, né le amministrazioni o gli imprenditori possono dare attuazione alla misura
controversa. La procedura di raffreddamento, però, proprio perché prevista da contratto collettivo, vincola
solo le organizzazioni stipulanti; per evitare che lo scopo della norma rimanga frustrato in relazione ai
sindacati non firmatari, la norma disciplina essa stessa una procedura di conciliazione, da rispettare
quando non sia applicabile quella contrattuale.
Il primo limite direttamente attinente allo sciopero è costituito dall’OBBLIGO DI PREAVVISO. A tal proposito,
l’art. 2, c. 5 dispone che: “Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di
predisporre le misure [necessarie per l’erogazione delle prestazioni indispensabili] ed allo scopo, atresi', di
favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di
usufruire di servizi alternativi, il preavviso non puo' essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi,
negli accordi [collettivi], nonche' nei regolamenti di servizio […] possono essere determinati termini
superiori”.
Il preavviso di sciopero deve essere contenuto in una comunicazione scritta, indicante, altresì, le modalità
di attuazione e la durata dello sciopero; non sembra condivisibile la tesi della compatibilità dello sciopero ad
oltranza con l’obbligo di comunicarne la durata, perché esso frustra ontologicamente la certezza della
estensione temporale, che il legislatore ha inteso invece garantire.
La comunicazione ha un duplice destinatario: le imprese o le amministrazioni eroganti e l’autorità
competente alla precettazione che, a sua volta, deve trasmettere la comunicazione alla Commissione di
garanzia. Le amministrazioni e le imprese hanno l’obbligo di comunicare agli utenti, almeno cinque giorni
prima dell’inizio dello sciopero, i modi e i tempi dei servizi erogati, nonché di riattivare prontamente il servizio
quando l’astensione è terminata.
In alcuni settori, gli effetti negativi dello sciopero sugli utenti si determinano a prescindere
dall’effettiva attuazione dell’astensione, grazie al c.d. effetto annuncio (ad es., il mero preavviso di uno
sciopero aereo induce gli utenti a non viaggiare quel giorno). In questi casi, chi proclama lo sciopero può
esercitare una forte pressione senza necessità di astenersi realmente, eliminando in tal modo il costo della
perdita delle retribuzione. La riforma del 2000 ha affrontato questo problema, prevedendo che la revoca
dello sciopero costituisce una forma sleale di azione sindacale, e viene valutata dalla Commissione di
garanzia ai fini dell’applicazione delle sanzioni, quando non sia giustificata o da un’ evoluzione dello stato
della vertenza, ovvero da una richiesta in tal senso della Commissione o dell’autorità competente per la
precettazione.
Sono esclusi dall’obbligo di preavviso i casi di sciopero in difesa dell’ordine costituzionale o di
protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità o della sicurezza dei lavoratori. In ambedue le ipotesi,
comunque, resta l’obbligo di garantire i servizi minimi.
6. Le prestazioni indispensabili
All’interno dei servizi pubblici essenziali indicati nell’art. 1, l’astensione dal lavoro non è preclusa, ma
l’esercizio di essa dovrà garantire alcune prestazioni indispensabili.
Il difficile compito di individuarle ed organizzarle è affidato, in prima istanza, ai contratti collettivi; uno
strumento diverso è previsto per i lavoratori autonomi, i professionisti ed i piccoli imprenditori – categorie che
non hanno una contrattazione collettiva – per i quali tale compito è, sempre in prima istanza, attribuito ai
codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni o dagli organismi di rappresentanza delle
categorie.
Tali accordi (e, per i lavoratori autonomi, i codici) devono individuare le prestazioni indispensabili, le
modalità e le procedure di erogazione ed altre eventuali misure dirette a salvaguardare i diritti
costituzionalmente tutelati (ad es., l’astensione dallo sciopero di quote di lavoratori, forme di erogazione
periodica dei servizi, ecc.).
La nuova legge ha aggiunto anche il c.d. obbligo di rarefazione, in virtù del quale gli accordi devono anche
indicare intervalli minimi da rispettare tra uno sciopero e l’altro, quando ciò sia necessario ad evitare che,
per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi ed incidenti sul medesimo
bacino d’utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici.
Le previsioni contrattuali circa le prestazioni indispensabili hanno efficacia generale: vincolano, cioè, anche
i lavoratori non iscritti alle organizzazioni stipulanti e gli stessi sindacati non stipulanti. In favore di questa
soluzione depongono:
80
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
• un argomento funzionale, alla cui stregua se così non fosse, gli accordi sarebbero inutili, in
quanto la funzionalità (ancorché parziale) della organizzazione d’impresa non potrebbe più essere
garantita se i sindacati dissenzienti o i singoli lavoratori non fossero obbligati ad osservare le regole
poste dall’accordo;
• argomenti letterali:
• l’art. 2, c. 3, imponendo il “rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione delle
prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui al comma 2”, non condiziona tale obbligo
all’esser parte dell’accordo;
• l’art. 4, prevedendo sanzioni a carico dei soggetti che non rispettino quanto previsto dagli
accordi, ugualmente non fa distinzione tra lavoratori iscritti e non iscritti alle organizzazioni
stipulanti, né tra queste ultime e le altre.
In proposito, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, prospettando la violazione degli artt.
39 e 40 Cost.:
• in relazione all’art. 39, la Corte ha respinto l’eccezione affermando che l’obbligo dei singoli
lavoratori di prestare la propria opera nonostante lo sciopero non è un effetto derivante
direttamente dall’accordo, ma dal “regolamento di servizio in quanto atto d’esercizio del potere
direttivo del datore di lavoro” che, a sua volta, deve essere esercitato in conformità o all’accordo
valutato idoneo dalla Commissione di garanzia o, in mancanza, alla regolamentazione provvisoria
deliberata da quest’ultima (v. par. 7).
• in relazione al profilo della riserva di legge contenuta nell’art. 40, la Corte ha respinto l’eccezione
affermando che, data la natura relativa della stessa, ben può il legislatore ordinario, fissati i criteri
fondamentali, delegare alla contrattazione collettiva la determinazione dei limiti e delle modalità di
esercizio del diritto di sciopero.
Se la seconda affermazione è convincente, lo è molto meno la prima:
• innanzitutto, i regolamenti di servizio sono espressamente richiamati solo per le amministrazioni
pubbliche regolate dal d.lgs. 165/2001 (v. par. 5) e non per le imprese private;
• i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero sono destinatari diretti degli obblighi della l. 146 anche
prima che intervenga l’esercizio del potere del datore di lavoro ed a prescindere dallo stesso;
• obbligate al rispetto degli accordi sono anche le organizzazioni sindacali dissenzienti, nei cui
confronti certamente il datore di lavoro non ha alcun potere direttivo.
A ben guardare, l’argomento fondamentale a favore della soluzione interpretativa indicata è che l’obbligo
deriva non dall’accordo, ma direttamente dalla legge stessa e, prima di questa, dal sistema costituzionale. In
questo quadro, l’accordo ha la limitata funzione di specificare il precetto legale e di precisare gli
obblighi gravanti su ciascuno dei soggetti in relazione alla situazione concreta.
Un’ acuta dottrina precedente alla novella del 2000 (D’Antona e Pascucci) ha valorizzato il fatto che l’accordo
debba esser valutato idonei dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge; se così è, la sua
efficacia generale si giustifica, sul piano costituzionale, perché è solo un momento di un procedimento
più complesso.
Insomma, l’accordo esula dalla disciplina dell’art. 39 perché non è diretto a comporre un conflitto tra
datore di lavoro e lavoratori, ma è solo lo strumento – sostituibile, in mancanza di accordo tra le parti
ovvero in presenza di un accordo valutato negativamente, con la regolamentazione dettata dalla
Commissione di garanzia – di individuazione delle misure concrete da adottare per risolvere il conflitto tra il
diritto di sciopero ed i diritti degli utenti, in attuazione del principio del contemperamento posto dalla legge.
7. La regolamentazione provvisoria disposta dalla Commissione di garanzia
Se gli accordi costituiscono una specificazione di limiti già direttamente operativi in forza della legge, si pone
un problema di controllo dell’idoneità dell’atto a realizzare i fini della legge. Difatti, “ al fine di valutare
l’idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il
godimento dei diritti della persona, costituzionalmente garantiti”, l’art. 12, l. 146/1990 ha istituito la
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge. Si tratta di un’ autorità amministrativa
indipendente di derivazione parlamentare, composta da nove membri nominati dal Presidente della
Repubblica su designazione dei Presidenti delle Camere, che non risponde del suo operato al Governo né
ad altra autorità politica, essendo i suoi membri inamovibili in costanza di mandato.
Compito principale della Commissione è quello di valutare l’idoneità degli accordi previsti dall’art. 2, c. 2,
“a garantire il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della
persona costituzionalmente tutelati”. In caso di valutazione negativa, la Commissione formula una
proposta sulla quale le parti debbono pronunciarsi; se la proposta non viene accettata, la Commissione
dispone, con propria deliberazione, le regole di esercizio dello sciopero idonee a realizzare detto
81
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
contemperamento. Analogo potere-dovere la Commissione ha in relazione ai codici di autoregolamentazione
previsti per le astensioni dal lavoro dei lavoratori autonomi.
La regolamentazione disposta dalla Commissione è provvisoria: le parti, infatti, possono in ogni momento
farne cessare l’efficacia realizzando un accordo, che deve, a sua volta, essere valutato idoneo dalla
stessa Commissione. Attribuendogli questo potere, il legislatore ha spostato il baricentro della legge
dall’autonomia collettiva alla Commissione stessa.
8. Le sanzioni
La centralità del ruolo della Commissione è confermato dalla disciplina delle sanzioni e delle procedure per
irrogarle, su cui la l. 83/2000 è intervenuta profondamente.
Gli artt. 4, c. 4-bis e 13, lett. i), oggi dispongono che la Commissione abbia il potere di valutare il
comportamento delle parti di un conflitto sindacale. Al termine di una procedura vincolata, la Commissione
formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento, delibera le SANZIONI:
• per i lavoratori
Nei confronti dei lavoratori che partecipano ad uno sciopero illegittimo, possono essere erogate sanzioni
disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione, con esclusione del licenziamento. La qualificazione
di queste sanzioni come “disciplinari” non può esser presa in senso letterale: il potere disciplinare
dell’imprenditore (art. 2106 c.c.) tutela l’interesse dello stesso, mentre le sanzioni in discorso costituiscono la
reazione dell’ordinamento alla violazione di norme poste nell’interesse pubblico (tant’è vero che è la
Commissione a deliberare la sanzione, e il datore di lavoro non può rinunziare ad infliggerla). In conclusione,
detta qualificazione deve essere intesa come richiamo della normativa legale e contrattuale in materia di
potere disciplinare, in quanto compatibile.
• per le organizzazioni dei lavoratori
Le organizzazioni dei lavoratori che proclamino o aderiscano ad uno sciopero in violazione delle
disposizioni di cui all’art. 2 (preavviso; comunicazione scritta; garanzia delle prestazioni indispensabili)
potranno andare incontro a tre tipi di sanzioni: sospensione dei permessi sindacali retribuiti; mancata
percezione dei contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione (che verranno versati all’INPS); esclusione
dalle trattative. Nel caso in cui queste sanzioni – la cui applicazione è un obbligo per i dirigenti responsabili
delle amministrazioni pubbliche e per i legali rappresentanti degli altri datori di lavoro – non risultino
applicabili, perché l’associazione non partecipa alle trattative ovvero non fruisce di benefici patrimoniali, è
prevista in via sostitutiva l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che
rispondono legalmente per l’organizzazione.
• per i dirigenti ed i legali rappresentanti delle amministrazioni
I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti di imprese ed enti che
erogano i servizi pubblici essenziali sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie quando non
garantiscono le prestazioni indispensabili o, comunque, gli obblighi derivanti loro dagli accordi o dalla
regolamentazione provvisoria dettata dalla Commissione, o quando non prestino correttamente le
informazioni che sono tenuti a fornire agli utenti.
Queste medesime sanzioni si applicano anche alle associazioni dei lavoratori autonomi, professionisti o
piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori. Per loro
la sanzione diviene applicabile in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione o della
regolamentazione provvisoria dettata dalla Commissione. Si noti come:
• mentre per i lavoratori subordinati le sanzioni contro i singoli dipendenti e quelle contro le
organizzazioni sono distinte, e trovano applicazione congiuntamente,
• la sanzione contro i lavoratori autonomi – incongruamente e ingiustificabilmente – è unica e
ne rispondono solidalmente il lavoratore astenuto e l’organizzazione stessa, per cui
l’adempimento dell’organizzazione rende indenni i singoli lavoratori.
Giusta l’art. 20-bis, “contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni e'
ammesso ricorso al giudice del lavoro”.
9. Le associazioni degli utenti
La l. 281/1998 riconosce una serie di facoltà e diritti alle associazioni che abbiano per scopo statutario la
tutela dei diritti e degli interessi di consumatori ed utenti e, rispondendo a determinati requisiti di
rappresentatività a livello nazionale, siano iscritte in apposito elenco. Queste associazioni possono
esprimere pareri alla Commissione in sede di valutazione dell’idoneità delle prestazioni indispensabili, e
possono richiedere l’apertura del procedimento di applicazione delle sanzioni dinnanzi alla
Commissione stessa.
82
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Inoltre, l’art. 7-bis prevede che le stesse siano legittimate ad agire in giudizio, in relazione a specifiche
situazioni concernenti le astensioni dal lavoro nei servizi essenziali, nei confronti:
• delle organizzazioni sindacali, quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione
all’utenza e quando venga effettuato nonostante la delibera della Commissione a differirlo e da ciò
consegua un pregiudizio per il “diritto degli utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici”;
• delle amministrazioni e delle imprese, qualora non vengano fornite adeguate informazioni e da ciò
consegua un pregiudizio al “diritto degli utenti di usufruire dei servizi pubblici secondo standard di
qualità ed efficienza”.
10. La precettazione: aspetti sostanziali
La regolamentazione delle astensioni dal lavoro nei servizi essenziali si avvale anche della c.d.
precettazione che, se oggi è disciplinata dalla l. 146/1990, in precedenza trovava la sua fonte di
regolamentazione nell’art. 20, r.d. 383/1934 (Testo unico della legge comunale provinciale), che attribuisce al
Prefetto il potere di adottare le ordinanze (la cui violazione costituisce reato) “di carattere contingibile ed
urgente in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità o di sicurezza pubblica”. Quella
adottata sino all’entrata in vigore della l. 146/1990 era, pertanto, un’ applicazione particolare di un istituto di
portata generale.
La precettazione è oggi disciplinata, come detto, dalla l. 146/1990 (come modificata dalla novella del 2000).
Essa consiste in un’ ordinanza, adottata da un organo del potere esecutivo (Presidente del Consiglio o
Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale; Prefetto, negli altri casi).
Questo potere trova il suo presupposto sostanziale nel fatto che lo sciopero – o l’astensione collettiva degli
autonomi – provochi l’interruzione, o almeno un’ alterazione del funzionamento di uno dei servizi pubblici
essenziali dell’art. 1 e ciò, a sua volta, produca il “fondato pericolo di un pregiudizio grave ed
imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’art. 1, c.1”. Si tratta, dunque, di un
potere vincolato a limiti rigorosi:
• in primo luogo, i servizi pubblici bloccati o alterati devono esser quelli indicati dall’art. 1 della legge;
• inoltre, il pregiudizio deve essere “grave e imminente”;
• infine, deve ricorrere la fondatezza del pericolo che quel pregiudizio si realizzi, in modo da imporre
un giudizio di forte probabilità in ordine alla realizzazione del danno.
11. La precettazione: aspetti procedurali
Altrettanto rigorosi sono i vincoli procedurali cui è subordinato l’esercizio del potere in discorso. In primo
luogo, la legge individua i soggetti che possono attivare il meccanismo:
• la medesima autorità che ha il potere di precettare, che può procedere direttamente nei casi di
necessità ed urgenza, fermo restando che deve informare la Commissione prima di adottare il
provvedimento;
• la Commissione di garanzia, che ha il potere di segnalare all’autorità gli scioperi o le astensioni
collettive che determinano un imminente pericolo (in tal caso, la Commissione formula anche sue
“proposte” in ordine alle misure da adottare e l’autorità competente ne dovrà tener conto.
L’autorità non può emanare immediatamente il provvedimento, ma deve invitare le parti a desistere e deve
esperire un tentativo di conciliazione.
A fronte dell’esito negativo del tentativo, l’autorità adotta con ordinanza le misure necessarie a prevenire il
pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati. Il principio ispiratore dell’intera legge impone
però che il contenuto dell’ordinanza possa sacrificare il diritto di sciopero solo nei limiti in cui ciò sia
necessario “per assicurare l’effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti” dell’utenza; mai,
dunque, il divieto puro e semplice di scioperare.
L’ordinanza – che dev’essere emessa almeno quarantotto ore prima dell’inizio dell’astensione – può essere
impugnata, da tutti i suoi destinatari che ne abbiano interesse, innanzi al TAR entro sette giorni dalla
comunicazione, o dal giorno successivo all’affissione. La proposizione del ricorso non sospende l’immediata
esecutività della precettazione, che peraltro il giudice può sospendere, anche solo in parte, alla prima
udienza utile.
L’inadempimento a quanto prescritto nell’ordinanza è punito con sanzioni amministrative pecuniarie
irrogate dall’Autorità precettante ed applicate dall’ispettorato del lavoro.
CAPITOLO XIV
83
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
LE ALTRE FORME DI LOTTA SINDACALE E LA SERRATA
A. Le altre forme di lotta sindacale
1. Premessa
L’esperienza dei conflitti di lavoro ci rivela l’esistenza di altre forme di lotta che non sono riconducibili allo
sciopero, o perché non consistono in un’ astensione concertata dal lavoro, o perché non si limitano ad essa.
2. Sciopero bianco ed occupazione d’azienda
Nonostante la loro permanenza sul posto di lavoro, i lavoratori possono porre in essere:
• uno sciopero bianco, che si verifica, nella prassi, durante taluni scioperi intermittenti o di breve
durata, attuato in modo tale che non venga intralciata l’attività di gestione dell’imprenditore.
• un’ occupazione d’azienda, al fine di intralciare l’attività dell’imprenditore. Essa può aversi a
sostegno di uno sciopero in atto, oppure anche con la prosecuzione, contro la volontà
dell’imprenditore, dell’attività produttiva (c.d. sciopero alla rovescia).
In proposito, è costante in giurisprudenza il riconoscimento dell’esperibilità dei mezzi di tutela del
possesso (azione di spoglio ed azione di manutenzione).
Sotto il profilo penale, invece, viene in considerazione il reato di arbitraria invasione e
occupazione di aziende agricole o industriali (art. 508 c.p.).
La Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittimo l’art. 508 c.p., affermando, quanto
all’art. 40 Cost., che altro è lo sciopero, altro l’occupazione di fabbrica, che costituirebbe un attentato
alla libertà del lavoro, garantita dall’art. 4 Cost..
Spesso, peraltro, i giudici di merito hanno rilevato, nei casi concreti, l’inesistenza del dolo specifico
richiesto dalla norma (“col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro”). La
stessa Corte costituzionale, del resto, aveva affermato che si è fuori dall’art. 508 c.p. se, al momento
dell’occupazione, lo svolgimento del lavoro sia già sospeso per effetto di una causa antecedente
rispetto all’occupazione stessa, così escludendo, tra l’altro, la punibilità dello sciopero “bianco”, con
permanenza sul posto di lavoro.
Sono state talvolta applicate, a proposito, anche altre norme penali:
• l’art. 633 c.p. (Invasione di terreni o edifici), rispetto cui, però, appare carente l’elemento
soggettivo (“al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto), dato che nell’occupazione di
azienda è presente unicamente l’animus di esercitare un’azione di pressione sulla
controparte;
• l’art. 614 c.p. (Violazione di domicilio), rispetto cui appare fortemente dubbio che i locali
dell’impresa possano costituire “luogo di privata dimora” dell’imprenditore.
3. Il blocco delle merci
Col blocco delle merci, i lavoratori mirano ad impedire che le merci esistenti in magazzino siano portate
fuori dallo stesso. Per una corretta valutazione giuridica, occorre distinguere tra due ipotesi:
• quella in cui i lavoratori non impediscono materialmente ai trasportatori di accedere alla fabbrica,
limitandosi a tentare di convincerli a sospendere la loro attività, in solidarietà con gli scioperanti. Un
simile comportamento è certamente lecito;
• quella di impedimento materiale all’attività dei trasportatori, in cui l’illiceità del comportamento è
indubbia. Il provvedimento appropriato per inibire tale attività pare essere quello che consegue
all’azione di manutenzione ex art. 1170 c.c., in quanto il comportamento dei lavoratori costituisce
una turbativa del possesso dei locali in cui le merci sono custodite. Evidentemente, se il blocco è
attuato con violenze o minacce, ricorrerà il reato di violenza privata (art. 610 c.p.).
4. Le forme di lotta sindacale con offerta della prestazione
Premesso che nessuna delle fattispecie seguenti può, sul piano civilistico, godere dell’immunità dal diritto
comune delle obbligazioni disposta dall’art. 40 Cost., poiché, non dando luogo ad un’ astensione dal lavoro,
non sono qualificabili come sciopero, tra le forme di lotta sindacale non riconducibili al tipo dello sciopero,
possiamo ricomprendere:
• il RALLENTAMENTO CONCERTATO, consistente nell’imprimere all’attività lavorativa un ritmo più
lento del normale. In tal caso, prestando i lavoratori una diligenza inferiore a quella normale, si ha
inadempimento che, come tale, è esposto alle sanzioni disciplinari ed al risarcimento dei danni, o
anche al licenziamento per “notevole inadempimento”, ove ne ricorrano gli estremi.
84
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
La giurisprudenza ha affermato la legittimità, in tale ipotesi, di una decurtazione della retribuzione
proporzionale alla riduzione de rendimento, ma tale conclusione è discutibile: la quantità della
prestazione dovuta, infatti, è misurata dalla sua durata e non dal suo rendimento, la cui diminuzione,
pertanto, non giustifica una proporzionale riduzione della controprestazione retributiva. Piuttosto, il
datore di lavoro potrebbe rifiutare di corrispondere la retribuzione qualora ciò consegua al previo
rifiuto di ricevere una prestazione lavorativa a contenuto anomalo (in tal caso, il problema coincide
con quello della c.d. serrata di ritorsione, per cui v. sez. B, par. 3).
• la NON COLLABORAZIONE, consistente nella limitazione dell’attività lavorativa a ciò che è di
stretto obbligo contrattuale. Per essa, si fa richiamo alle nozioni di esecuzione secondo buona
fede (art. 1375 c.c.) e di integrazione del contratto (art. 1374 c.c.), pertanto, se le prestazioni
omesse erano usualmente eseguite dai prestatori, devono ritenersi comprese nel contratto e, quindi,
la loro omissione costituisce inadempimento. Tuttavia, non è detto che lo svolgimento abituale di
determinate prestazioni renda le stesse vincolanti, poiché il comportamento del lavoratore può
dipendere da semplice acquiescenza, come tale ininfluente sul contenuto del rapporto.
• lo SCIOPERO DELLE MANSIONI, nel quale i lavoratori rifiutano di svolgere solo alcuni tra i
compiti che sono loro affidati dall’imprenditore. In tal caso, se le mansioni rifiutate erano dovute, il
rifiuto è illegittimo.
• l’OSTRUZIONISMO, consistente nell’applicazione pedantesca dei regolamenti. Qui pare ovvio
che non si possa far nascere una responsabilità giuridica dall’applicazione dei regolamenti, ancorché
cavillosa. A conclusione opposta, tuttavia, si deve arrivare se l’ostruzionismo si risolve in un’
intenzionale forma di abuso di un potere discrezionale (ad es., la perquisizione di tutti i bagagli in
dogana, laddove la legge attribuisce una larga discrezionalità in proposito).
5. Il boicottaggio
Un cenno va, infine, dedicato al boicottaggio – mezzo di lotta notissimo nella pratica sindacale nord-
americana, ma pressoché sconosciuto in Italia – che si realizza quando “chiunque, mediante propaganda o
valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare
patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non
acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali”.
La Corte costituzionale rigettò l’eccezione di incostituzionalità della norma, argomentando che la stessa
tutela beni protetti anche dalla Carta costituzionale (la libertà di stipulare patti di lavoro, la libertà di iniziativa
economica, ecc.).
B. La serrata e le altre forme di autotutela del datore di lavoro
1. Il silenzio della Costituzione
Come detto, anche i datori di lavoro hanno loro forme di autotutela, volte ad esercitare pressione sulla
controparte del conflitto sindacale. Il mezzo di lotta sindacale più radicale utilizzato dagli imprenditori è la
serrata, consistente nella chiusura totale o parziale dell’impresa e, cioè, nel rifiuto di accettare la
prestazione lavorativa e, conseguentemente, di pagare le retribuzioni.
Il dato normativo fondamentale da cui occorre muovere è il silenzio della Costituzione: l’art. 40 Cost.
riconosce lo sciopero come diritto, mentre la serrata non è menzionata. Questa scelta del costituente,
deliberatamente voluta come risulta dai lavori preparatori, rivela l’intenzione di non porre la serrata sullo
stesso piano dello sciopero, poiché vuole respingere il principio liberistico del parallelismo tra sciopero
e serrata come mezzi simmetrici. Il legislatore costituzionale ha dunque conferito rilevanza giuridica alla
disuguaglianza tra lavoratori e datori, attribuendo ai primi – e non ai secondi – il potere di sospendere il
rapporto di lavoro e le obbligazioni che ne discendono.
Primo corollario di questa scelta è che un’ ipotetica legge ordinaria che sancisca un diritto di serrata
sarebbe illegittima, perché in contrasto con questa valutazione del Costituente.
2. Serrata e mora del creditore
La scelta del Costituente si riverbera poi sulle conseguenze civilistiche della serrata: essa soggiace ai
principi del diritto comune delle obbligazioni, in base ai quali il rifiuto di accettare la prestazione
lavorativa altro non è che una forma di mora del creditore, di cui agli artt. 1206 ss. c.c.. Si ha mora del
creditore (o mora accipiendi) quando il creditore, senza un motivo legittimo (ad esempio, l’irregolarità
dell’adempimento), rifiuta di ricevere la prestazione o di compiere quanto è necessario affinché il debitore
possa adempiere. Dalla mora derivano una serie di conseguenze sfavorevoli al creditore: egli deve risarcire
i danni da essa causati, sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta, sopportare
85
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
il rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore; inoltre, non
gli sono più dovuti gli interessi o i frutti della cosa non percepiti dal debitore.
Il creditore è costituito in mora a seguito dell’offerta da parte del debitore (in particolare, se la prestazione
consiste in un fare il creditore è costituito in mora mediante intimazione di ricevere la prestazione o di
compiere gli atti necessari affinché questa possa svolgersi); gli effetti della mora si verificano dal giorno
dell’offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è rifiutata
dal creditore.
Se il creditore rifiuta l’offerta, il debitore può liberarsi dalla sua obbligazione eseguendo il deposito di ciò che
è dovuto: se il deposito è accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il
debitore è liberato.
Più problematico è individuare gli effetti, ai nostri fini, di questa qualificazione giuridica. L’art. 1207, c. 2 c.c.,
infatti, grava il creditore in mora dell’obbligo di risarcire i danni derivati al suo debitore; ne è stata tratta la
conseguenza che il datore di lavoro che ponga in essere una serrata sia tenuto a risarcire il danno
subito dal lavoratore a cause delle mancate retribuzioni ma che, giusta il principio della compensatio
lucri cum damno, sia detraibile dal risarcimento quanto il prestatore di lavoro abbia guadagnato impiegando
altrove la propria attività lavorativa. In contrario, è stato affermato che l’art. 6 della legge sull’impiego privato
(r.d. 1825/1924) prevede che il risarcimento del danno, in ogni caso, non possa essere inferiore alle mancate
retribuzioni.
Una diversa impostazione – che pure perviene sostanzialmente allo stesso risultato pratico – è quella per cui
l’obbligazione retributiva permane nonostante la situazione di mora credendi in cui versa il datore di lavoro e,
di conseguenza, ben può il lavoratore esigerne l’adempimento.
3. Serrata di ritorsione
Lo stesso art. 1206 c.c. specifica che il creditore non è in mora se rifiuta di ricevere la prestazione
dovutagli per un motivo legittimo. Da questa prescrizione ha tratto spunto l’orientamento – prevalente in
giurisprudenza – di considerare legittima la c.d. serrata di ritorsione, ossia il rifiuto del datore di lavoro di
ricevere le prestazioni quando i lavoratori pongono in essere uno sciopero articolato (v. cap. XII, sez.
B, par. 1). Con questa particolare forma di serrata – posta in essere come risposta alle forme di lotta
richiamate – la sospensione provocata dallo sciopero articolato diventa continuata e totale, e l’imprenditore
evita il maggior danno prodotto dall’articolazione dello sciopero.
Un primo orientamento giurisprudenziale derivava la legittimità della serrata dall’illegittimità dello
sciopero. Questa impostazione, a ben vedere, confonde due piani tra loro distinti: la valutazione della
legittimità dello sciopero, infatti, opera sul piano dei rapporti collettivi, mentre l’individuazione del motivo
legittimo che autorizza il creditore a rifiutare la prestazione opera sul piano di ciascun rapporto individuale.
Del resto, per definizione un rifiuto può aver luogo solo nei tempi e negli spazi lasciati vuoti dall’azione
di sciopero e, quindi, l’eventuale illegittimità di quest’ultima non influenza il diverso problema della
legittimità del rifiuto stesso; questo, infatti, può aversi solo per lavoratori che offrono la prestazione e che,
dunque, nel momento del rifiuto, non sono in sciopero.
Secondo un altro, e più prudente, orientamento giurisprudenziale, la legittimità del rifiuto delle prestazioni
deve essere valutata non in relazione al momento dello sciopero, bensì a quello dell’offerta della
prestazione lavorativa, per cui l’imprenditore legittimamente può rifiutare la prestazione che “non sia più
utilizzabile in relazione alla preesistente struttura ed organizzazione dell’impresa, ovvero che possa essere
utilizzata solo attraverso l’assunzione di maggiori oneri e spese”. In altre parole, può essere rifiutata la
prestazione che non sia proficua nella stessa misura di quella normale, né l’imprenditore è tenuto a
variare l’organizzazione del lavoro o i piani di produzione per rendere utilizzabili le prestazioni offerte. Ma,a
ben vedere:
• da un lato, l’affermazione che la prestazione lavorativa, per costituire esatto adempimento
dell’obbligazione, debba essere normalmente proficua, finisce per trasferire sul lavoratore il rischio
della produttività del lavoro, che la dottrina ha sempre ritenuto gravante sul datore di lavoro;
• dall’altro, la necessità di variare l’organizzazione o i piani di produzione costituiscono ipotesi di mera
difficoltà – e non di impossibilità – a ricevere la prestazione.
Peraltro, la reazione del datore di lavoro non è volta contro l’inesatto adempimento già verificatosi, ma si
proietta sulle prestazioni future, per le quali non è dato sapere né se i lavoratori aderiranno allo sciopero
articolato, né quali lavoratori lo praticheranno. La chiusura dell’impresa colpisce indiscriminatamente
sia i lavoratori che avevano intenzione di aderire all’agitazione, sia quelli ad essa estranei , sulla base
di una sorta di responsabilità collettiva sconosciuta al nostro ordinamento.
L’unica conclusione giuridicamente corretta sembra, dunque, essere nel senso che la sospensione
dell’attività produttiva sia legittima solo:
86
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
• quando, nell’intervallo di uno sciopero a singhiozzo, la prestazione offerta sia tanto breve da non
consentire alla prestazione di lavoro di realizzare la sua minima unità tecnico-temporale (v. cap.
XI, par. 8).
• in tal caso, il rifiuto è legittimo perché l’offerta ha ad oggetto una prestazione parziale (art.
1181 c.c.) o, meglio, diversa da quella pattuita (art. 1197 c.c.).
• ovvero quando, in uno sciopero a scacchiera, l’astensione di un gruppo di lavoratori impedisca ad
altri di effettuare la propria prestazione, nonché quelle esigibili ex art. 2103 c.c..
• in tal caso, l’offerta della prestazione non è reale, perché ha ad oggetto una prestazione
impossibile.
Nei casi in cui, al contrario, lo sciopero articolato abbia solo diminuito la convenienza per il datore di lavoro
o reso più difficile l’utilizzazione, allora il rifiuto della prestazione non potrà trovare giustificazione, e
l’imprenditore dovrà essere considerato in mora.
4. Il reato di serrata e la giurisprudenza costituzionale
Esaminati i profili civilistici della serrata, devono ora essere considerati i risvolti penalistici. Anche per la
serrata, la Corte costituzionale è stata chiamata a svolgere un’ opera di adeguamento del codice penale. La
sent. 29/1960 – già esaminata a proposito dell’abolizione del reato di sciopero per fini contrattuali (v. cap. XI,
par. 3) – dichiarò incostituzionale l’art. 502 anche nella parte in cui prevedeva il reato di serrata per fini
contrattuali (attuata “col solo scopo di imporre […] ai dipendenti modificazioni ai patti stabiliti o di opporsi
alla modificazione di tali patti”). Come già evidenziato, questa sentenza derivò dall’art. 39 Cost. il principio
della libertà di azione sindacale e, per tale via, stabilì che, pur non essendo riconosciuta come diritto dall’art.
40 Cost., la serrata costituiva espressione del principio di libertà sindacale garantito dall’art. 39 Cost.
e, pertanto, non poteva essere perseguita penalmente.
Successivamente, la Corte costituzionale (sent. 141/1967) affrontò il problema della legittimità del reato di
serrata di solidarietà o per protesta, di cui all’art. 505 c.p.. La Corte qui puntualizzò che la libertà di serrata
opera “nel quadro dei rapporti fra datori di lavoro e lavoratori”, rimanendo estranei a questa sfera di libertà
“tutti quei comportamenti che non si collochino nell’ambito di quei rapporti”. Né, secondo i giudici, potevano
estendersi alla serrata i principi enunciati nella sentenza sullo sciopero politico (per i quali il diritto di sciopero
opera al di là dell’azione a fini contrattuali, v. cap. XII, sez. A, par. 2), perché gli interessi economici derivanti
dallo svolgimento di un’ attività imprenditoriale trovano, nell’art. 41 Cost., una tutela più attenuata di quella
che gli interessi dei lavoratori trovano nell’art. 40. Di qui, la legittimità costituzionale dell’incriminazione
della serrata di solidarietà o per protesta (e, riteniamo, di quella a fine politico – art. 503 c.p. – e di
coazione della pubblica autorità – art. 504 c.p.).
Diversa conclusione vale per la serrata di esercenti di piccole industrie o commerci che non abbiano
lavoratori alle loro dipendenze (art. 506 c.p.): di essa, parificata allo sciopero, è stata data nozione in
precedenza (v. cap. XI, par. 6).
5. La sostituzione dei lavoratori in sciopero
A fronte di uno sciopero, il datore di lavoro spesso si organizza in modo tale da annullare o limitare gli effetti
dell’astensione dal lavoro, sostituendo i lavoratori in sciopero con:
• lavoratori a termine, caso espressamente previsto da alcune norme di legge. In particolare, il d.
lgs. che disciplina il contratto a tempo determinato ne vieta l’utilizzazione per la sostituzione di
lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. Se ne può forse dedurre l’esistenza di un principio
generale per cui il contratto di lavoro che contenga un termine non può essere utilizzato per la
sostituzione di lavoratori in sciopero;
• altri dipendenti dell’azienda che abbiano deciso di non scioperare o siano impegnati in altri settori
non interessati dall’astensione,
la sostituzione è considerata legittima a patto che si rispetti l’art. 2103 c.c. (“Il prestatore di
lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla
categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte”). Pertanto, si è ritenuto legittimo l’impiego di altri lavoratori dell’impresa se ciò
è stato fatto nel rispetto del principio di equivalenza delle mansioni; del pari, si è ritenuto legittimo
l’impiego del lavoratore non scioperante in mansioni superiori, se ciò è avvenuto con le garanzie
previste dall’art. 2103 c.c..
87
Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: mari0017 (sonnessa2002@gmail.com)
Potrebbero piacerti anche
- Diritto Costituzionale Comparato: Approccio metodologicoDa EverandDiritto Costituzionale Comparato: Approccio metodologicoNessuna valutazione finora
- Diritto Sindacale Giugni 2010Documento74 pagineDiritto Sindacale Giugni 2010Francesco Villafrate100% (1)
- Giugni - Riassunto Diritto SindacaleDocumento157 pagineGiugni - Riassunto Diritto SindacaleLorenzoNessuna valutazione finora
- Diritto Sindacale GiugniDocumento135 pagineDiritto Sindacale GiugniAda IessiNessuna valutazione finora
- Carinci Il Diritto SindacaleDocumento113 pagineCarinci Il Diritto SindacaleMike MurdacaNessuna valutazione finora
- Riassunto Diritto Del Lavoro Subordinato Ghera Garilli GarofaloDocumento122 pagineRiassunto Diritto Del Lavoro Subordinato Ghera Garilli GarofaloAlessandra Giada MigliettaNessuna valutazione finora
- Diritto Del Lavoro, Riassunti Carinci, Treu, Tosi, de Luca e TamajoDocumento120 pagineDiritto Del Lavoro, Riassunti Carinci, Treu, Tosi, de Luca e Tamajoflorentinaivona100% (1)
- Diritto Lavoro - Dal PuntaDocumento121 pagineDiritto Lavoro - Dal PuntaGianni Bi Petrucci100% (1)
- Riassunti Manuale Di Diritto Sindacale Carinci - Tamajo - Tosi - TreuDocumento58 pagineRiassunti Manuale Di Diritto Sindacale Carinci - Tamajo - Tosi - TreuTiziana Letizia100% (3)
- Diritto Del LavoroDocumento123 pagineDiritto Del LavoroSara CastellaniNessuna valutazione finora
- Diritto Del Lavoro GheraDocumento58 pagineDiritto Del Lavoro GheraLayla_cre100% (3)
- Riassunto Ghera Diritto Del LavoroDocumento127 pagineRiassunto Ghera Diritto Del LavoroCarmen LacuocaNessuna valutazione finora
- Diritto Del Lavoro Ghera Edizione 2020Documento147 pagineDiritto Del Lavoro Ghera Edizione 2020Biagio Biandolino100% (1)
- Diritto Sindacale II ParteDocumento63 pagineDiritto Sindacale II Partechiaralonardo2015Nessuna valutazione finora
- Diritto Delleconomia e Dinamiche IstituzionaliDocumento91 pagineDiritto Delleconomia e Dinamiche IstituzionaliFrancesco FerraroNessuna valutazione finora
- Riassunto Diritto Del Lavoro E. Ghera 2010Documento162 pagineRiassunto Diritto Del Lavoro E. Ghera 2010Francesco BenedettoNessuna valutazione finora
- SindacaleDocumento167 pagineSindacaleFrancesca VertaldiNessuna valutazione finora
- Rappresentanza e o Rappresentatività Sindacale Quali Regole Per Quale Gioco (2007)Documento95 pagineRappresentanza e o Rappresentatività Sindacale Quali Regole Per Quale Gioco (2007)ichbinggNessuna valutazione finora
- Diritto Del LavoroDocumento8 pagineDiritto Del Lavoroarianna.gazzaneo23Nessuna valutazione finora
- Diritto CivileDocumento17 pagineDiritto Civileappuntigratis_unicamNessuna valutazione finora
- Manuale Diritto Del Lavoro Ghera Aggiornato Al 2009Documento121 pagineManuale Diritto Del Lavoro Ghera Aggiornato Al 2009Mariagrazia Vittoria NappaNessuna valutazione finora
- 3OrgSindLiber MercatorumDocumento10 pagine3OrgSindLiber MercatorumGabrieleNessuna valutazione finora
- Diritto Privato 13.03Documento8 pagineDiritto Privato 13.03Luca CovielloNessuna valutazione finora
- Ghera Diritto Del Lavoro RiDocumento110 pagineGhera Diritto Del Lavoro RiFrancesco BenedettoNessuna valutazione finora
- Perulli - Nuove Frontiere Del Diritto Del LavoroDocumento26 paginePerulli - Nuove Frontiere Del Diritto Del LavoroTauredon100% (1)
- 31 Dispensa Diritto Del LavoroDocumento39 pagine31 Dispensa Diritto Del LavoroDaniel MarcianoNessuna valutazione finora
- Autonomia ContrattualeDocumento33 pagineAutonomia ContrattualeAnnamaria SurianoNessuna valutazione finora
- Il Diritto Di Sciopero Ad OggiDocumento6 pagineIl Diritto Di Sciopero Ad OggiDaniela SansoneNessuna valutazione finora
- Riassunti Diritto SindacaleDocumento2 pagineRiassunti Diritto SindacaleRoberto BonoNessuna valutazione finora
- Diritto Del Lavoro Mazzotta RiassuntoDocumento66 pagineDiritto Del Lavoro Mazzotta RiassuntoAna PestanaNessuna valutazione finora
- Riassunto Diritto PrivatoDocumento86 pagineRiassunto Diritto PrivatoMas20Nessuna valutazione finora
- As Distintas Correntes Sobre A Natureza Jurídica...Documento15 pagineAs Distintas Correntes Sobre A Natureza Jurídica...daniellerodriguesdszNessuna valutazione finora
- Diritto Del Lavoro - Sindacale RiassuntoDocumento8 pagineDiritto Del Lavoro - Sindacale RiassuntoEnrico ArzilliNessuna valutazione finora
- Diritto Privato Riassunti OttimiDocumento307 pagineDiritto Privato Riassunti OttimiLicia (Felici.a)Nessuna valutazione finora
- Cap 1 Diritto Del LavoroDocumento18 pagineCap 1 Diritto Del LavoroAndreea Mihaela TofanNessuna valutazione finora
- Scognamiglio Gruppi Di SocietDocumento34 pagineScognamiglio Gruppi Di SocietSabino FortunatoNessuna valutazione finora
- Il Pluralismo SindacaleDocumento4 pagineIl Pluralismo SindacaleAlessandro PicaNessuna valutazione finora
- Riassunto Manuale Mazzotta Diritto Del LavoroDocumento175 pagineRiassunto Manuale Mazzotta Diritto Del LavoroalfaomegaNessuna valutazione finora
- EstrattoDocumento13 pagineEstrattoMurilo César NetoNessuna valutazione finora
- Il SindacatoDocumento7 pagineIl SindacatoFrancesco MuranteNessuna valutazione finora
- Iniziativa Economica e Mercato OlivieriDocumento30 pagineIniziativa Economica e Mercato OlivieriSabino FortunatoNessuna valutazione finora
- Diritto Del Lavoro Esame 1Documento65 pagineDiritto Del Lavoro Esame 1Anthony BarberioNessuna valutazione finora
- Diritto PrivatoDocumento51 pagineDiritto Privatolucacpll98Nessuna valutazione finora
- Lezioni Diritto Privato 2020Documento145 pagineLezioni Diritto Privato 2020lucacpll98Nessuna valutazione finora
- CorporazioniDocumento180 pagineCorporazioniPadre LeyNessuna valutazione finora
- Dispensa Diritto CostituzionaleDocumento39 pagineDispensa Diritto CostituzionaleSirNessuna valutazione finora
- Modulo Lavoro Nello SpettacoloDocumento18 pagineModulo Lavoro Nello SpettacoloFrancesco DimizianiNessuna valutazione finora
- Il Negozio GiuridicoDocumento7 pagineIl Negozio GiuridicoMariaCristinaZuppelliNessuna valutazione finora
- Appunti Sulle Relazioni Industriali e Contrattazione Collettiva Cella e TreuDocumento25 pagineAppunti Sulle Relazioni Industriali e Contrattazione Collettiva Cella e TreuGiovanni StefanucciNessuna valutazione finora
- Riassunto Diritto Amministrativo ClarichDocumento232 pagineRiassunto Diritto Amministrativo ClarichImmortalis100% (1)
- Diritto Pubblico Appunti LezioniDocumento92 pagineDiritto Pubblico Appunti LezioniMiko ArzoNessuna valutazione finora
- Profili civilistici delle associazioni e fondazioni del Terzo SettoreDa EverandProfili civilistici delle associazioni e fondazioni del Terzo SettoreNessuna valutazione finora
- I principi generali dell'attività amministrativa ed il legittimo affidamento del cittadinoDa EverandI principi generali dell'attività amministrativa ed il legittimo affidamento del cittadinoNessuna valutazione finora
- Autorità amministrative indipendenti e profili problematici comuni: Le soluzioni prospettate da dottrina e giurisprudenzaDa EverandAutorità amministrative indipendenti e profili problematici comuni: Le soluzioni prospettate da dottrina e giurisprudenzaNessuna valutazione finora
- La contrattazione collettiva e la qualificazione dei rapporti di lavoroDa EverandLa contrattazione collettiva e la qualificazione dei rapporti di lavoroNessuna valutazione finora
- Fondata sul lavoro: Utopia e realtà della Costituzione italianaDa EverandFondata sul lavoro: Utopia e realtà della Costituzione italianaNessuna valutazione finora
- Assistente Parlamentare: dalla storia del diritto alle moderne strutture di lobbyDa EverandAssistente Parlamentare: dalla storia del diritto alle moderne strutture di lobbyNessuna valutazione finora
- Elogio Del PregiudizioDocumento3 pagineElogio Del PregiudizioEsonet.orgNessuna valutazione finora
- DS3010Ed10 PDFDocumento5 pagineDS3010Ed10 PDF26110Nessuna valutazione finora
- WF PDFDocumento1 paginaWF PDFElvira00Nessuna valutazione finora
- Manon Je Marche Sur Tous Les Chemins Traduzione ItalianoDocumento1 paginaManon Je Marche Sur Tous Les Chemins Traduzione ItalianoFederica RajaNessuna valutazione finora
- EPSYLON VT1000SP NAT Rev.05Documento1 paginaEPSYLON VT1000SP NAT Rev.05Ivan TimarevNessuna valutazione finora
- Plan TematicoDocumento5 paginePlan TematicoEdisson Barbosa100% (1)
- Le Fonti Del Diritto Processuale CivileDocumento3 pagineLe Fonti Del Diritto Processuale CivileleleNessuna valutazione finora
- Cesia InstallazioneCertificatoAlmaWifiNokiaSymbianDocumento4 pagineCesia InstallazioneCertificatoAlmaWifiNokiaSymbiangiacomondiaNessuna valutazione finora
- B2-2018 Aprile - Parlare - CandidatoDocumento14 pagineB2-2018 Aprile - Parlare - Candidato76lunalu100% (3)
- 4 Castelli MayaDocumento16 pagine4 Castelli Mayarobert100% (1)