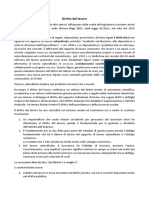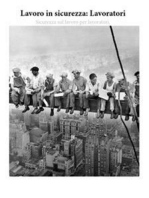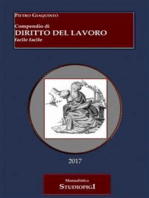Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Riassunto Manuale Mazzotta Diritto Del Lavoro
Caricato da
alfaomegaTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Riassunto Manuale Mazzotta Diritto Del Lavoro
Caricato da
alfaomegaCopyright:
Formati disponibili
lOMoARcPSD|10832702
Riassunto manuale Mazzotta Diritto DEL Lavoro
Diritto del Lavoro (Università degli Studi di Padova)
StuDocu non è sponsorizzato o supportato da nessuna università o ateneo.
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
DIRITTO DEL LAVORO: Manuale di Diritto del lavoro, Oronzo Mazzotta
IL DIRITTO DEL LAVORO
1. Il diritto del lavoro nasce con la civiltà industriale. Allo schema giuridico si giunge passando
attraverso una fase di transizione fra l’organizzazione produttiva di tipo artigianale e quella
strutturata sulla vera e propria impresa capitalistica. La bottega artigiana era l’epicentro del sistema
economico pre-industriale. L’artigiano era circondato da collaboratori (laborantes) che prestavano la
loro opera con lo scopo di apprendere il “mestiere”. Il risultato produttivo era a soddisfare le
esigenze dell’economia cittadina o della corte, dal momento che l’artigiano produceva su
commissione. Tale direttiva era codificata negli statuti delle corporazioni artigiane, che stabilivano
dei massimali alla produzione da parte delle singole botteghe. Un salto di qualità si produce con il
fenomeno dell’accumulazione dei capitali che si realizza con l’avvento delle banche. È in questa
fase che, secondo alcuni studiosi, nasce l’archetipo del contratto di lavoro subordinato alla
confluenza fra il rapporto di servitù ed il rapporto di Verlag. Quest’ultimo è uno schema contrattuale
con cui l’artigiano ottiene un mutuo da un mercante, impegnandosi a restituire il capitale tramite
cessione di una partecipazione agli utili della bottega. Il ruolo del mercante è perciò limitato
all’acquisizione e allo smercio del manufatto artigianale. Successivamente taluni mercati
affideranno a più imprese artigiane la realizzazione delle diverse fasi produttive di un determinato
prodotto. Non sempre la realizzazione era affidata a botteghe artigiane, ma talvolta fu commessa a
singoli lavoranti a domicilio. È su questa realtà che si innesta l’avvento del sistema di fabbrica, nel
quale tutte le fasi del processo produttivo sono accentrate in un unico luogo, alle dipendenze di un
imprenditore, con lo scopo di produrre in serie i manufatti. Ad un certo punto dell’evoluzione si
ritroverà l’artigiano, deprofessionalizzato, che offre la sua forza lavoro al capitalista che è
proprietario dei mezzi per produrre. È questo il prototipo della figura del lavoratore subordinato.
Condizioni necessarie per questo passaggio sono: a) la rivoluzione tecnologica, con l’avvento delle
macchine che sostituiscono il lavoro manuale e consentono di produrre in serie, b) una
modificazione dei rapporti socio-economici, tale da superare le libertà economiche
corporativistiche, che si realizza con le rivoluzioni borghesi del fine settecento, c) la traduzione di
tali istanze sul piano degli istituti giuridici, tramite le grandi codificazioni. È naturale che il codice
civile italiano del 1865 trascuri la materia lavoristica, limitandosi a sole due brevi indicazioni
normative. La situazione di astensionismo legislativo non poteva però perdurare in eterno dal
momento che, la presenza di un’enorme massa di manodopera disponibile, non mancò di produrre
forti contrasti che sfociarono nel porsi della “questione sociale”. Mentre i lavoratori si
organizzavano in leghe di resistenza, il legislatore cominciò a por mano ad una prima serie di
interventi normativi. Questi ultimi costituirono il primo nucleo della legislazione sociale, diretta a
proteggere tutti i lavoratori con una tutela minimale ovvero fasce di questi molto svantaggiate. Si
segnalano le l. 11/02/1886 n. 3657 e 19/06/1902 n. 242, la l. 17/03/1898 n. 80, la l. 07/07/1907 n.
489 ed ulteriori discipline che costituirono un primo nucleo di interventi assistenziali e
previdenziali. La descritta legislazione ha come soggetto protetto non il contraente di uno specifico
rapporto obbligatorio, ma l’operaio degli opifici industriali, mostrando di identificare il proprio
referente in una peculiare categoria sociale. Ovviamente la legislazione sociale appariva
insufficiente a governare l’amministrazione del rapporto di lavoro ed i conflitti giuridici che
potevano insorgere tra le parti. La soluzione di tali conflitti era affidata agli usi industriali o ai primi
embrioni di contrattazione collettiva. Il legislatore fu costretto ad intervenire con un’originale
soluzione: l’istituzione di una speciale magistratura arbitrale: i Collegi dei probiviri, che avevano
l’incarico di dirimere sul campo le controversie individuali fra datori di lavoro e lavoratori. I
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
probiviri decidevano le controversie secondo equità, ma con un’equità creativa di diritto, data
l’assenza di regole legali. In tutto ciò è facile intravedere il nucleo minimo dello statuto del lavoro
dipendente. L’esperienza dei probiviri è il primo segno dell’originale vocazione del diritto del
lavoro a formare le proprie regole al di fuori del processo creativo di origine statuale (formazione
extra-legislativa).
2. L’avvento dello stato totalitario segna un crescente interventismo in materia lavoristica. Risaltano
infatti la prima regolamentazione legislativa dell’orario di lavoro con il r.d.l. 15/03/1923 n. 692 e
l’intervento con il quale veniva regolato il rapporto di lavoro degli impiegati. Bisogna considerare
che la legge del 1923 non è un frammento di archeologia giuridica, ma contiene principi in gran
parte ancora oggi vigenti. L’importanza invece della legge sull’impego privato nella storia della
legislazione lavoristica è constatabile se si osserva che essa contiene la prima regolamentazione dei
vari istituti del rapporto di lavoro e che costituirà un modello per il codice civile del 1942. Vengono
inoltre a compimento altre tappe evolutive della legislazione lavoristica: r.d. 06/07/1933 n. 1033 che
istituisce l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
legge 22/02/1934 n. 370 sul riposo domenicale e settimanale; legge 10/01/1935 n. 112 di istituzione
del libretto di lavoro; r.d.l. 04/10/1935 n. 1827 sul perfezionamento e coordinamento legislativo
della previdenza. Significativa anche la predisposizione di una Carta del lavoro: una summa di
principi in materia lavoristica. Il tratto distintivo del regime si espresse nell’ambito dei rapporti
collettivi di lavoro. Il regime volle risolvere la questione sociale attraverso una forma di
corporativismo autoritario. Con la l. 03/04/1926 n. 563 venne bandita la libertà sindacale ed il
pluralismo sindacale fu sostituito con un unico sindacato fascista. Questo sindacato stipulava con la
controparte datoriale un contratto collettivo con validità nei confronti di tutti i lavoratori
appartenenti ad una determinata categoria professionale. Il contratto collettivo era dunque fonte di
diritto obiettivo.
3. Allo spirare del ventennio il regime fascista produsse il massimo sforzo sul piano della
produzione di norme con l’emanazione del codice civile del 1942. Con esso la disciplina lavoristica
entra nel diritto dei privati. Il codice costituisce il punto di approdo nella sistemazione della materia,
ma anche il punto di partenza di un latente conflitto fra disciplina codificata e disciplina contenuta
nella legislazione speciale. È opportuno ricordare la singolare struttura nella quale è immersa la
regolamentazione della materia lavoristica nel codice civile: il contratto di lavoro trova
regolamentazione nel libro V (Del lavoro) che contiene le regole giuridiche del diritto commerciale
e del diritto del lavoro; il legislatore definisce i soggetti, cosicché la definizione del contratto deve
essere dedotta da quella di prestatore di lavoro; per la regolamentazione del rapporto il codice civile
dà importanza al datore di lavoro, approntando la disciplina del lavoro nell’impresa e dispone che ai
“rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all’esercizio di un’impresa” si applichino
quelle dettate per il lavoro nell’impresa “in quanto compatibili con la specialità del rapporto”.
Queste apparenti stranezze sono spiegate come sovrastrutture, espressione dell’ideologia autoritaria
e centralistica. L’idea di fondo muoveva dalla funzionalizzazione dell’autonomia privata ad un fine
esterno, definito “interesse superiore della produzione nazionale”. L’impresa era la cellula
elementare dell’economia corporativa e l’imprenditore doveva essere considerato gerarchicamente
responsabile nei confronti dello stato del perseguimento di quello scopo. L’art. 2088 c.c. prevedeva
l’obbligo per l’imprenditore di “uniformarsi nell’esercizio dell’impresa ai principi dell’ordinamento
corporativo e agli obblighi che ne deriva(va)no”, ritenendolo responsabile “verso lo Stato
dell’indirizzo della produzione e degli scambi, in conformità della legge e delle norme corporative”.
Alla violazione degli obblighi era collegato uno specifico meccanismo sanzionatorio. Alla posizione
di subordinazione dell’imprenditore verso lo stato corrispondeva la gerarchica subordinazione del
2
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
prestatore di lavoro all’imprenditore (art. 2086 c.c.: “l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui
dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori”). Tutto ciò contribuì a disegnare un assetto
autoritario della gestione dei rapporti di lavoro nell’impresa.
4. La Costituzione repubblicana costituisce una svolta anche per il diritto del lavoro. Il Titolo III,
dedicato ai Rapporti economici, si inserisce a pieno titolo nella materia lavoristica. I padri
costituenti attribuirono al “lavoro” un’importanza così preminente da farne fondamento della
Repubblica (art. 1) e indicarono nel lavoratore “subordinato” un protagonista del nuovo assetto
sociale. L’art. 3 afferma la norma che contiene il principio di eguaglianza, scandito su due piani
distinti: da una parte viene riaffermato il principio di eguaglianza formale, dall’altra viene sancito il
principio di eguaglianza sostanziale. È il capoverso dell’art. 3 che assegna ai lavoratori dipendenti il
ruolo e la funzione di propulsori della partecipazione effettiva al progresso morale e materiale della
società. La considerazione del lavoro subordinato nella Costituzione è poi ribadita nell’art. 4 che lo
assume come oggetto di un vero e proprio diritto: diritto, sociale e non di libertà, verso il quale la
Repubblica si impegna a renderlo effettivo; pone l’accento sull’impegno dello Stato a garantire la
piena occupazione attraverso adeguati strumenti di politica economica. L’art. 35 riconferma
l’impegno della Repubblica a tutelare “il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”,
ricomprendendo anche il lavoro autonomo, ma non quello di lavoro imprenditoriale, in quanto tale,
garantito in termini di libertà, dall’art. 41. Seguono le norme che statuiscono i minimi inalienabili di
protezione (art. 36-37-38) e pongono i presupposti strumentali per a realizzazione dell’autotutela da
parte dei lavoratori stessi (art. 39-40). Si colloca infine l’art. 41 che pone le basi della libertà
d’impresa e dei suoi contrappesi. L’intervento del legislatore in materia lavoristica rappresenta la
materializzazione degli interessi che si contrappongono all’iniziativa economica privata. È la norma
lavoristica che indica la possibile via di mediazione del conflitto di interessi. In tal modo l’impresa
vede compromessa la propria libertà di adoperare il fattore lavoro in modo illimitatamente
flessibile, nella stessa misura in cui il lavoratore vede penalizzato il proprio interesse
all’inamovibilità.
5. La produzione normativa post-costituzionale è distinguibile in tre grandi periodi:
a. Passaggio da una società basata sull’agricoltura ad una società industriale moderna. Nel
primo quindicennio l’intervento normativo presenta una marcata attenzione verso la
protezione di fasce marginali e/o particolarmente deboli della forza lavoro o per
l’approntamento di uno standard minimo ed invalicabile di protezione o in senso
antifraudolento.
Nel primo gruppo ritroviamo le leggi sull’apprendistato, sulla tutela delle lavoratrici
madri, sul divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio, nonché i
d.p.r. 27/04/1955 n. 547 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e 19/03/1956 n. 303
contenente le norme per l’igiene del lavoro.
Al secondo gruppo appartengono la regolamentazione giuridica del collocamento della
manodopera e la l. 14/07/1959 n. 741. Quest’ultima fu significativa, in quanto è un
tentativo di realizzare l’obiettivo dell’estensione erga omnes dei contratti collettivi di
lavoro.
Nel terzo gruppo si ritrovano invece le discipline con le quali il legislatore intese
reprimere o forme illecite e fraudolente di impiego dei lavoratori o tecniche elusive di
diritti inderogabili.
b. Decennio a cavallo fra gli anni sessanta e settanta (1965/1975): anni della grande
espansione del garantismo normativo. Si apre con un intervento della Corte
costituzionale che dichiara l’illegittimità dell’art. 2948 n.4 c.c. nella parte in cui consente
3
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro. La Corte, in ragione
della libertà di licenziamento, sposta la decorrenza dei termini di prescrizione al
momento in cui il rapporto è ormai cessato ed il lavoratore è tornato nella piena libertà
dispositiva. Fa seguito la legge 15/07/1966 n. 604 con la quale si avvia il processo di
superamento del principio di libera recedibilità dal contratto di lavoro, ribadito dall’art.
2118 c.c. del ’42. Si stabilisce, per la prima volta, il principio secondo cui il
licenziamento deve essere giustificato. L’epicentro del sistema di garanzie è costituito
dallo statuto dei diritti lavoratori (l. 20/05/1970 n. 300). Lo statuto è una disciplina
calibrata sul segno dell’effettività e sotto vari profili. In primo luogo ha l’obiettivo di
rendere effettivi i diritti sanciti in astratto nella carta costituzionale: la Costituzione ha
varcato i “cancelli della fabbrica”, potendo il lavoratore mantenere i propri diritti di
cittadino anche nell’ambito del rapporto di lavoro e prospettandosi l’incidenza dei diritti
fondamentali anche nei rapporti privatistici. Una prima strategia di tutela si attua
rafforzando i diritti individuali del lavoratore. Una seconda strategia si ha attraverso
l’istituzionalizzazione della presenza del sindacato nei luoghi di lavoro, mediante la
costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali. A ciò sono collegati tutta una serie
di divieti diretti a tutelare sia il singolo che il militante sindacale, nonché la
configurazione di un procedimento volto alla repressione dell’attività antisindacale del
datore di lavoro. Un ulteriore fondamentale passaggio del sistema di garanzie è la legge
11/08/1973 n. 533 che introduce una nuova disciplina per le controversie individuali di
lavoro. Il modello di processo proposto è un processo rapido, concentrato e
tendenzialmente orale, in cui il tempo non corre ai danni della parte economicamente più
debole: si prevede che il giudice, quando liquida i crediti di lavoro, debba condannare il
datore al pagamento degli interessi e del maggior danno di svalutazione monetaria sulle
somme riconosciute al lavoratore.
c. Le difficoltà del sistema economico dei primi anni settanta segnano un’inversione di
tendenza nel diritto del lavoro. Quella che prende corpo a partire dal 1975 è stata definita
legislazione della crisi o dell’emergenza, diretta ad attutire le conseguenze delle avverse
fortune economiche.
i)Un primo gruppo di interventi si occupa del salario e dei meccanismi automatici di
rivalutazione della retribuzione: si imputava a tali meccanismi infatti di alimentare
fenomeni inflattivi. Gli interventi si occupano di disboscare le scale mobili anomale,
unificando i sistemi di indicizzazione del salario.
ii)Un secondo gruppo di leggi cerca di dare risposta ai problemi posti dalle grandi
ristrutturazioni industriali, rivitalizzando gli ammortizzatori sociali.
iii)Un terzo gruppo di interventi aveva il fine di incentivare e sostenere l’occupazione
giovanile.
L’insieme di tali interventi è accumunato, non solo dalla necessità di fronteggiare le
conseguenze della crisi economica, ma anche: a) da un mutamento nel metodo della
formazione della legge, b) da una diversificazione dei luoghi di mediazione del conflitto,
c) dall’inversione di taluni tratti strutturali della norma lavoristica. Si segnala il ricorso al
metodo della concentrazione sociale. Il governo concorda con le parti sociali i contenuti
dei provvedimenti legislativi da emanare ed il raggiungimento del consenso fra le parti è
convalidato in protocolli d’intesa. Altra caratteristica è il decisivo ruolo affidato
all’intervento della pubblica amministrazione. L’amplificazione del ruolo dei pubblici
poteri si giustifica per il fatto che la protezione del lavoratore tende a collocarsi
direttamente sul mercato. Degna di rilievo è la considerazione secondo cui viene meno il
4
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
principio di assoluta inderogabilità in pejus della legge, che costituisce un dato
strutturale nel rapporto tra le fonti del diritto del lavoro. La legge invece comincia a
presentarsi come tetto massimo, invalicabile in melius anche ad opera dell’autonomia
privata. In sostanza il legislatore vieta all’autonomia collettiva di stabilire trattamenti più
favorevoli.
6. Si può tentare di fornire un quadro delle prospettive del diritto del lavoro a partire dagli anni
ottanta. Gli anni che stiamo vivendo si caratterizzano per quella che è stata definita la “quarta
rivoluzione industriale”, conseguente all’avvento delle “tecnologie informatiche” ed altresì per la
“globalizzazione”, ossia la formazione di un unico mercato economico a livello planetario. Il diritto
del lavoro deve confrontarsi con una nuova modificazione dell’assetto dell’impresa che sta
producendo mutamenti che non riusciamo ancora a intravvedere in maniera chiara. Ha dato luogo
alla cosiddetta “terziarizzazione” dell’economia, cioè la crescita esponenziale delle imprese, a
discapito del settore industriale che costituisce l’originario e tradizionale referente della nostra
disciplina. Inoltre l’avvento dell’automazione ha prodotto una riduzione dei posti di lavoro. La
risposta dei governi si è orientata anzitutto nella direzione di un’accentuazione del coinvolgimento
delle parti sociali nelle scelte di politica economica. Sul piano normativo il diritto del lavoro si è
sviluppato alla luce della flessibilità, con l’intento di stimolare il decollo delle imprese e garantire
nuova occupazione. La flessibilità è stata richiesta inoltre per far fronte alla concorrenza
internazionale e alla mutevolezza dell’andamento dei mercati. Ciò ha comportato un
ridimensionamento nel sistema delle garanzie approntato nei decenni precedenti. Sono state
introdotte forme flessibili di impiego della manodopera grazie la creazione di “sottotipi”, rispetto al
tipo contrattuale del rapporto di lavoro ovvero riducendo gli ostacoli all’utilizzo temporaneo o
parziale dei lavoratori. Rientrano in questa categoria il contratto di formazione-lavoro, il contratto a
tempo parziale, il contratto di lavoro temporaneo, il contratto di lavoro a termine. Con il d.lgs.
10/09/2003 n. 276 i sottotipi flessibili sono stati ulteriormente ampliati con l‘introduzione del lavoro
intermittente, del lavoro ripartito, del lavoro accessorio, nonché la previsione del contratto di
somministrazione di lavoro anche a tempo indeterminato. Una seconda variante della
flessibilizzazione riguarda interventi di deregolazione pura nei confronti di obblighi incombenti
sulle imprese. Una terza variante di flessibilizzazione si avvale invece della tecnica della
deregolazione contrattata. Nel caso la legge, anziché procedere ad eliminare il vincolo o la
limitazione alla libertà d’impresa, rinvia tale compito alla contrattazione collettiva. In questo ambito
si collocava il “Pacchetto Treu” (legge n. 196 del 1997), che conteneva un insieme di misure dirette
ad introdurre maggiore flessibilità, attraverso la riforma della disciplina dell’orario di lavoro,
dell’apprendistato, del lavoro a termine e l’introduzione nel nostro ordinamento del lavoro
temporaneo. A tale metodologia si contrappone quella accolta dal d.lgs. n. 276/2003 che ha allargato
ulteriormente gli orizzonti della flessibilità ed ha attenuato il ruolo della contrattazione collettiva.
Con la legge n. 247/2007 si è parzialmente ridato fiato all’autonomia collettiva, in taluni istituti
della flessibilità. La grave crisi finanziaria che ha investito l’Europa nella seconda metà del 2011
non ha mancato di proiettare le sue ombre anche sul diritto del lavoro. Il governo “tecnico” Monti
ha varato una riforma del lavoro che ha cercato di dare al mercato del lavoro un’ulteriore sterzata
nella direzione della flessibilità, sia in entrata che in uscita. Ancor più radicale la svolta dei
provvedimenti del governo Renzi. Con esso ha avuto corso la vasta riforma denominata “jobs act”.
Il governo ha ottenuto, con la legge n. 183/2014, un’ampia delega diretta a riscrivere buona parte
del diritto del lavoro. Alla delega è stato dato corso con i seguenti decreti legislativi:
1. n. 22/2015: nuova disciplina degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione
involontaria (NASPI)
5
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
2. n. 23/2015: introduzione il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti
3. n. 80/2015: conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
4. n. 81/2015: rivisitazione delle tipologie contrattuali
5. n. 151/2015: su “semplificazioni”
6. n. 148/2015: riguardo agli ammortizzatori sociali
7. n. 150/2015: sui servizi per l’impiego
8. n. 149/2015: sulle ispezioni del lavoro
I provvedimenti puntano su un incremento delle assunzioni a tempo indeterminato, incentivate da
un significativo sgravio contributivo e dal notevole abbassamento delle garanzie all’interno del
rapporto di lavoro e di quelle nei confronti dei licenziamenti illegittimi. Un costante stimolo alla
produzione normativa viene dall’adempimento degli obblighi dello stato italiano nei confronti della
comunità europea. L’influenza del diritto comunitario sulla formazione del diritto del lavoro è
testimoniata dal mutamento di prospettiva assunto dalle fonti comunitarie. Nell’originario Trattato
di Roma del 25/03/1957 l’ottica era quella di consentire la libera circolazione dei lavoratori fra un
Paese e l’altro ed evitare che regolamentazioni diversificate creassero situazioni di squilibrio nella
concorrenza fra le imprese. Nei decenni successivi la comunità europea si è dotata di strumenti più
diretti a promuovere l’occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro: è nato
così un vero e proprio diritto sociale europeo. La svolta ha fatto capo specialmente alla
sottoscrizione del Trattato di Lisbona del dicembre 2007. Inoltre gli stati membri hanno delineato
un’azione centrata su un metodo di “coordinamento aperto”, basato sull’indicazione di criteri-guida
per i rispettivi governi nazionali, vincolati nei fini. Le aree di intervento riguardano: l’occupabilità,
l’adattabilità, le pari opportunità e la promozione dell’imprenditorialità.
7. La storia del diritto del lavoro ci dà un’immagine del lavoratore come di un soggetto sociale
sottoprotetto, la cui debolezza contrattuale deve essere riequilibrata da una forte integrazione di
origine legale. È possibile individuare delle componenti basiche o strutturali. Un primo dato
strutturale è dato dall’inderogabilità della norma lavoristica cui è collegata un’indisponibilità dei
diritti. L’inderogabilità è sancita dall’art. 17 della legge del 1924 sull’impiego privato e poi
riaffermata dall’art. 2077 c.c. e dall’art. 40 dello statuto dei lavoratori. L’indisponibilità è invece
scaturita dall’art. 2113 c.c. Le due categorie concettuali non sono necessariamente connesse sul
piano logico, ma lo sono in qualche modo nel diritto positivo. Una seconda componente è la rigidità
del tipo contrattuale: le parti del contratto di lavoro non sono libere di dare ad esso un contenuto in
contrasto con la disciplina inderogabile. Un ruolo essenziale gioca il meccanismo di surrogazione
alla volontà delle parti e della volontà legislativa e di quanto previsto in sede contrattuale collettiva.
Caratteristica essenziale è la peculiarità delle tecniche di tutela, allo scopo di tener dietro alla
direttiva di politica del diritto di proteggere la “persona” del lavoratore nel processo produttivo. Il
diritto del lavoro si è reso conto dell’ineffettività delle tradizionali strumentazioni del diritto dei
contratti che ruotano intorno alla disciplina della nullità negoziale e ciò ha fatto non solo
predisponendo una disciplina ad hoc per la nullità del contratto di lavoro, ma elaborando originali
tecniche repressive. Occorre notare che la formazione progressiva del corpus della materia e la
compresenza di spezzoni normativi concepiti in epoche tanto diverse, non hanno impedito una
coesione interna. Il problema è però comprendere in quale direzione vada il mutamento. È quasi un
luogo comune la constatazione che i nostri tempi sono segnati da una ripresa dell’”individualismo”.
Il che, applicato alla nostra materia, può significare:
a. che esistono sempre più lavoratori dotati di un certo potere di negoziale
b. che un numero sempre crescente di lavoratori guarda al proprio itinerario lavorativo come
una strada variamente frazionata da impegni a tempo pieno e/o a tempo parziale
6
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
c. che un numero sempre crescente di lavoratori risulti difficilmente collocabile entro la
dicotomica e rigida alternativa fra autonomia e subordinazione ed aspiri ad una collocazione
intermedia fra le due
Come risposte il diritto del lavoro? Il diritto del lavoro risponde in modo rigido, in conseguenza
delle componenti basiche che si sono già ricordate. Se dobbiamo giudicare dalla riforma del diritto
del lavoro attuata dal governo Renzi, dobbiamo assumere che è stata del tutto superata l’idea che si
possa agire su una revisione della fattispecie di riferimento, per ripiegarsi su un sostanziale
svuotamento dall’interno degli effetti della subordinazione, con abbassamento drastico del livello di
protezione assicurato dal diritto del lavoro. Si tratta di una risposta ineludibile alla grave crisi
finanziaria che ha colpito l’occidente, per uscire dalla quale uno dei principali strumenti si ritiene
debba essere quello di offrire alle imprese un contratto di lavoro meno costoso e garantito, allo
scopo di incentivare le assunzioni.
8.Il problema dei rapporti fra il diritto del lavoro e il diritto civile costituisce un topos. La questione
sta nel chiedersi se il diritto del lavoro, nato dal diritto civile, si sia dotato di autonomi strumenti di
comprensione e classificazione. Tradizionalmente si risponde segnalando i profili di specialità della
disciplina, la peculiarità del suo oggetto, l’implicazione della persona nel rapporto e costruendo il
quadro dei condizionamenti reciproci o delle reciproche differenze fra le strutture del diritto del
lavoro e del diritto civile. È forse maggiormente produttivo individuare i “punti caldi” dell’attrito
fra le due discipline. Essi sono: a) contrapposizione fra contrattualismo ed anticontrattualismo
nell’individuazione della fonte del rapporto e nella complessiva sistemazione della materia; b) la
tensione fra subordinazione e organizzazione; c) la diseguale distribuzione dei “poteri” fra datore e
lavoratore. I tre punti si riducono ad uno solo nel chiedersi se il contratto può contenere il forte
squilibrio di potere fra le parti, nel quale consiste la subordinazione del lavoro ed altresì i profili
dell’organizzazione dell’impresa. Il confronto fra le parti vai “storicizzato”, ossia proposto fra entità
omogenee e sincroniche. Ne possono derivare delle incomprensioni che accompagnano il confronto
nel corso del tempo. La prima riguarda quelle contrapposizioni così radicali da apparire di comodo.
Alla revisione della tradizionale concezione del contratto come terreno d’elezione della libertà dei
privati ha contribuito proprio la normativa lavoristica e le riflessioni della sua dottrina. La
circostanza che la fattispecie fondamentale del diritto del lavoro abbia natura contrattuale non è
certo sufficiente a giustificare una sorta di anacronistico “primato” del diritto privato sul diritto del
lavoro. È evidente che lo stesso diritto del lavoro abbia avuto bisogno di una trama di concetti, tali
da costituirne lo scheletro portante. Per l’uso di questo vocabolario però sia il diritto del lavoro che
il diritto privato sono tributari della teoria generale: il diritto privato fornisce al discorso lavoristico
le “infrastrutture e gli snodi” indispensabili per consentirgli di dialogare. È innegabile la centralità
del libro IV del codice civile, che mantiene la propria attualità, perché si tratta di
concettualizzazioni piegabili ad un impiego “neutro”. Assai spesso gli schemi del diritto delle
obbligazioni sono stati utilizzati dalla giurisprudenza allo scopo di rafforzare le garanzie per il
lavoratore. È dunque questa la miglior riprova del significativo contributo del diritto del lavoro ad
un profondo rinnovamento del diritto dei contratti. Si manifesta anche l’originalità del diritto del
lavoro: mentre la disciplina di alcuni contratti tipici viene completamente scarnificata dalla
normativa speciale, il rapporto fra strutture codicistiche e leggi lavoristiche si presenta in modo
pressoché ribaltato. Nel diritto del lavoro infatti lo sviluppo della disciplina speciale può dirsi
avvenuto non contro ma dentro la struttura del codice. È la fattispecie fondamentale, riassunta
dall’art. 2094, che garantisce la mediazione fra interno ed esterno. La normativa speciale ha
contribuito ad una rilettura e sistemazione della fattispecie fondamentale che è e rimane all’interno
del tessuto del codice. La centralità della definizione codicistica è stata garantita in questo ambito
7
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
dalla rigidità del tipo contrattuale, che ha altresì impedito il processo di frantumazione delle tutele.
Gli sviluppi della legislazione potrebbero produrre un revival delle tecniche civilistiche di
protezione, sia con un recupero delle categorie generali della nullità, annullabilità, etc., sia sul piano
della valorizzazione di più ampie prospettive risarcitorio/sanzionatorie.
IL CONTRATTO DI LAVORO
Capitolo primo: IL LAVORATORE SUBORDINATO
Sezione I: IL TIPO CONTRATTUALE
1. “Subordinazione”: questione con un significato culturale e pratico. Sotto il primo profilo bisogna
interrogarsi intorno all’”essere” di una disciplina giuridica che fa del lavoro dipendente l’epicentro
del proprio interesse. Non meno rilevante è il profilo pratico, sotto il quale si tratta di circoscrivere i
tratti caratteristici di un contratto tipico e di individuare a quali rapporti della vita di relazione siano
applicabili le norme giuridiche che si riferiscono a quel contratto. E tali norme non sono poche né di
scarso rilievo. Basti pensare che se si parla di rapporto subordinato scattano per il datore di lavoro
degli obblighi: costituzione del rapporto giuridico obbligatorio di previdenza sociale e poi
l’osservanza da parte del datore di tutta la legislazione di garanzia per il lavoratore, cioè
l’estensione del diritto del lavoro. Viceversa se si assume che il rapporto è di lavoro autonomo
l’unica conseguenza è quella dell’applicabilità degli artt. Da 2222 a 2228 c.c. che regolano i diritti
delle parti sulla materia prima ed i problemi relativi all’esecuzione e sulla difformità o i vizi
dell’opera. Il referente originario del diritto del lavoro è l’operaio dell’impresa industriale, cioè quel
soggetto che è costretto a vendere la propria forza lavoro ad un imprenditore che ha i mezzi per
produrre e che detiene il potere di organizzare l’attività di una gran massa di soggetti a lui
“subordinati”. Un carattere essenziale è l’estraneazione del lavoratore dal risultato finale della sua
prestazione: il lavoratore fornisce all’imprenditore delle generiche energie, che quest’ultimo utilizza
nel processo produttivo, assumendosi il rischio del risultato finale dell’attività economica; il
prestatore è invece responsabile della corretta esecuzione della propria prestazione. È facile cogliere
la differenza con il lavoro autonomo: in questo il lavoratore auto-organizza i mezzi ed i modi della
prestazione e si impegna a fornire al committente un prodotto finito, che può essere un bene
materiale o un servizio.
2. Il codice civile colloca la definizione del contratto di lavoro (art. 2094 c.c.) nell’ambito del libro
V. Prestatore di lavoro subordinato: “chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare con
l’impresa, prestando il proprio lavoro […] alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
Gli elementi essenziali sono: a) la collaborazione nell’impresa, b) la dipendenza dall’imprenditore,
c) l’eterodirezione. Sono elementi che appaiono già del tutto insufficienti se non tautologici.
Sembrano rinviare alla realtà sociale l’individuazione di più precisi referenti, secondo la
caratteristica del processo d tipizzazione che muove dal piano dei rapporti economici per poi
assumere i dati nell’orbita dell’ordinamento giuridico. Per quanto concerne la collaborazione, si
tratta di un dato generico: si può collaborare con altri soggetti quale che sia la veste giuridica che si
assume. L’ordinamento lavoristico fornisce indicazioni contradditorie al riguardo, se è vero che la
collaborazione connota un modo di essere dell’attività lavorativa dell’impiegato, secondo la legge
del 1924. Se l’impiegato è qualificato come collaboratore dell’imprenditore, come può assumersi
che la collaborazione costituisca un elemento essenziale di caratterizzazione di tutti i prestatori di
lavoro? Non dissimili rilievi vi sono per l’elemento dell’etero-direzione. Si tratta del profilo che
fotografa il potere del datore di dirigere la prestazione verso un risultato a sé utile. Anche
l’utilizzabilità di tale requisito si presta ad un’obiezione a suo modo classica, secondo cui il potere
8
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
del creditore di indirizzare la prestazione del debitore verso la soddisfazione del proprio interesse è
comune ad altre specie contrattuali. Residua l’elemento della dipendenza. Di esso vi è una lettura
che tende a valorizzare lo stato di subordinazione socio-economica del lavoratore, il quale non
avendo i mezzi per produrre è costretto a mettere a disposizione del datore le proprie energie
lavorative. Anche rispetto ad essa è facile contrapporre che il concetto di dipendenza si presta a dar
conto della ratio dell’intervento del legislatore a protezione del lavoratore dipendente, ma non
costituisce un elemento valorizzabile a fini interpretativi e soprattutto selettivi. Dunque nessuno
degli elementi individuati dall’art. 2094 c.c. appare dotato di qualità definitoria della
subordinazione.
3. Bisogna dunque individuare una nozione di subordinazione che possa essere utile nel processo di
qualificazione del rapporto. Tale operazione è stata condotta valorizzando il dato della
collaborazione, in collegamento con quello dell’etero-direzione. Escluso che nel sistema nato dalla
Costituzione potesse ancora fornirsi un’immagine della collaborazione nei termini di una
comunione di scopo fra datore e lavoratore, se è ritenuto che potesse essere identificata nella
nozione di subordinazione in senso tecnico-funzionale. Si è ritenuto che il lavoratore si obbliga ad
un facere specifico, in attuazione di un contratto di scambio. Poiché tale dato essenziale è comune
ad altre relazioni che hanno ad oggetto il lavoro, la specificità del rapporto descritto dall’art. 2094
c.c. si individuerebbe alla stregua del requisito della subordinazione. Attraverso essa il datore di
lavoro vedrebbe garantito il proprio interesse ad organizzare l’attività produttiva per il
raggiungimento delle proprie finalità. Alla soddisfazione di tale interesse sarebbe ordinato il potere
di dirigere la prestazione dedotta nel contratto impartendo disposizioni sul come e sul quando di
essa nonché il potere di infliggere sanzioni disciplinari in caso di violazione delle disposizioni
impartite.
4. “In tema di distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, l’esistenza del vincolo di
subordinazione va valutata dal giudice di merito […] avuto riguardo alla specificità dell’incarica
conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che […] occorre fare
riferimento a criteri complementari e sussidiari […] che […] possono essere valutati globalmente
come indizi probatori della subordinazione.” (Cass. 9252/2010). “In relazione alla configurabilità,
da un lato, di una nozione giuridica di subordinazione nella prestazione del lavoro […] e, dall’altro,
di elementi sintomatici della situazione di subordinazione […], il giudizio relativo alla
qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo ha carattere sintetico […] e
integra un giudizio di fatto censurabile […] solo per ciò che riguarda sia l’individualizzazione dei
caratteri identificativi del lavoro subordinato […] sia la riconduzione o meno degli stessi allo
schema contrattuale del lavoro subordinato.” (Cass. 7260/2009). La giurisprudenza utilizza degli
indici empirici di riconoscimento esteriore della subordinazione. Gli indici più ricorrenti sono:
l’inserimento nell’impresa del datore, la continuità della prestazione, la sottoposizione ai poteri del
datore, il carattere personale della prestazione, la cessione di energie lavorative, l’estraneazione dal
risultato produttivo. Sono indici dedotti dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro
subordinato e che quindi dovrebbero costituire gli effetti della fattispecie. Si può dire che la
giurisprudenza ribalta il procedimento logico di qualificazione: anziché valutare prima la fattispecie
per poi collegarne i relativi effetti, muove da questi ultimi, riconoscendo in essi qualità evocativa
della fattispecie. C’è inoltre una evidente sfasatura fra la posizione della dottrina e la posizione della
giurisprudenza che polverizza la definizione in una serie di indici empirici. La questione è se
l’operazione condotta dalla giurisprudenza sia conforme alla definizione di cui all’art. 2094 c.c. o se
sia eversiva e si avvalga di dati dedotti direttamente dalla realtà sociale. Il discorso critico è centrato
sulla congruità degli “indici” elaborati dalla giurisprudenza al fine di qualificare correttamente la
9
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
prestazione di lavoro in posizione “subordinata”, in contrappunto con la definizione del concetto di
“dipendenza” contenuta nel codice civile. La conclusione dell’analisi è diretta a rimarcare
l’estraneità all’indicazione normativa dei risultati cui fa capo la giurisprudenza. Dunque la
giurisprudenza confronterebbe la specie da decidere con la figura sociale maggiormente
riconoscibile di lavoratore dipendente. Così facendo i nostri giudici si troverebbero al di fuori del
dato normativo, operando una contaminazione tra la funzione complessiva sottesa all’intervento
protettivo dello stato a favore di talune “classi” sociali e il più restrittivo punto di riferimento
assunto dall’ordinamento. In sintesi: 1) la giurisprudenza dice di mantenersi fedele al presupposto
dell’esistenza di un’unica fattispecie negoziale tipica, intesa come sottoposizione al potere direttivo
e decisionale del datore; 2) nella soluzione del caso concreto, abbandona il criterio della
subordinazione e richiama quali indici tipizzanti altri elementi; 3) tali elementi vengono desunti dal
contesto socio-economico. Ciò che resta da verificare è il presupposto interpretativo da cui muove
tutto il discorso critico: l’inconsistenza degli elementi di giudizio forniti dal sistema normativo
lavoristico ai fini dell’individuazione della fattispecie tipica del lavoro subordinato. Ciò vale a
chiedersi se gli elementi utilizzati dalla giurisprudenza siano eversivi rispetto al sistema normativo
o in esso in qualche modo codificati.
5. Per attenuare la contrapposizione fra il dato sociale e la fattispecie legale tipica bisogna verificare
se l’ordinamento stesso non ha assunto positivamente nella sua orbita il riferimento alla situazione
di inferiorità economica del lavoratore, caratterizzata dall’alienità del lavoro e del suo risultato,
derivante dalla mancanza di disponibilità dei mezzi di produzione.
a) Un primo passo lo si fa ricordando quanto esposto in relazione alle origini del diritto del
lavoro: non c’è dubbio che il protagonista della legislazione fosse un soggetto espropriato
dei mezzi per produrre e costretto a vendere la propria forza-lavoro. La situazione di
subordinazione non è mutuata in gran misura, cosicché non solo è ancora da dimostrare che
la legislazione abbia abbandonato la direttiva di porre al centro del proprio interesse una
determinata categoria di soggetti, ma che tale atteggiamento non sia proprio dell’art. 2094
c.c. Si procede perciò ad una rilettura dell’art. 2094 alla luce della Carta costituzionale e
della normativa speciale cresciuta dopo la codificazione. Abbiamo già visto come la
Costituzione evochi la figura del lavoratore dipendente e ne faccia oggetto di una tutela
privilegiata, cosicché l’originaria ratio ispiratrice della normazione protettiva è stata fatta
propria dal sistema costituzionale; per quanto ognuno persegua obiettivi diversi, è sempre
distinguibile la strategia di tutela a favore di chi dal lavoro trae i mezzi di sostentamento,
sprovvisto della possibilità di intraprendere un’attività economica indipendente, da quella
connessa con la protezione di chi ha i mezzi per produrre.
b) Univoche e concordanti indicazioni provengono dalla disciplina speciale lavoristica.
Occorre distinguere quella parte che presuppone già risolto il problema della qualificazione
del rapporto cui debba essere applicata da quell’altra che delimita sul piano definitorio lo
schema giuridico di riferimento. Una prima serie di indicazioni ce le fornisce il fenomeno
giuridico della interposizione nei rapporti di lavoro, che caratterizza quelle situazioni in cui
il datore frappone tra sé ed i lavoratori lo “schermo” costituito da un soggetto interposto allo
scopo di eludere la disciplina protettiva. Rilevare che l’art. 1 della l. 23/10/1960 n. 1369
inibiva all’imprenditore di “affidare in appalto, subappalto o in qualsiasi altra forma” ad un
soggetto interposto “l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro”, realizzate da lavoratori
assunti e retribuiti dall’interposto medesimo. Oggetto del divieto normativo era il
conferimento al di fuori dello schema tipico di cui all’art. 2094 di “mere prestazioni di
lavoro” a favore di un soggetto che non poteva essere considerato datore di lavoro, perché
10
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
sprovvisto dei mezzi di produzione. La legge vietava la cessione di “lavoro subordinato
altrui”, stabilendo il principio che il datore di lavoro dovesse essere riconosciuto nel
soggetto che “effettivamente utilizzava” le prestazioni di lavoro. La legge non sanzionava
dall’esterno ma agiva riconoscendo che già nei fatti l’effettiva utilizzazione dei lavoratori da
parte dell’interponente integrasse gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato. In pratica
proponeva la necessaria sovrapposizione fra interposizione e subordinazione, consentendo di
valorizzarne le indicazioni normative al fine di meglio chiarire le espressioni adoperate
dall’art. 2094 scandendone i momenti essenziali. La legge del ’60 è stata formalmente
abrogata, ma il divieto è rimasto ugualmente. Il legislatore è intervenuto allo scopo di
consentire la somministrazione di lavoratori a favore di imprese, ad opera di soggetti
autorizzati: ha cioè costruito un’ipotesi di lecita interposizione. Si ripropone così il
fenomeno della scissione fra titolarità formale del rapporto ed effettiva destinazione delle
prestazioni. Questa scissione continua però a costituire un’eccezione rispetto alla regola
generale secondo cui chi utilizza le prestazioni di lavoro altrui, in condizioni date ne è il
datore di lavoro. La formula della “collaborazione nell’impresa” e del “prestare lavoro” alle
altrui “dipendenze” diviene impegno alla “somministrazione di lavoro”, cioè alla cessione di
energie lavorative. La legge non può prescindere da una distinzione tra appalto ed
interposizione. Mentre nell’appalto l’oggetto della vendita a favore del committente è lavoro
oggettivato, nella fattispecie interpositoria l’oggetto correlativo è la somministrazione di
lavoro. Connotato di tale “cessione di energie” è poi il dato della loro effettività: non
basterebbe ad integrare la fattispecie interpositoria la sola messa a disposizione delle energie
in assenza dell’effettiva utilizzazione di queste. L’esame della fattispecie interpositoria
consente di ridisegnare il requisito della subordinazione: quest’ultimo infatti va individuato
nell’ esautorazione ed alienazione del risultato del lavoro. Il datore di lavoro è l’“effettivo
utilizzatore delle prestazioni di lavoro altrui”, è inoltre colui il quale ha i mezzi economici
necessari per produrre.
c) Un ulteriore dato valorizzato è quello della continuità della prestazione. L’art. 409 n. 3 cod.
proc. civ. ha esteso la speciale tutela processuale assicurata dal nuovo rito del lavoro anche
ai rapporti di collaborazione che si concretino “in una prestazione d’opera continuativa e
coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”
(parasubordinazione). Viene posto perciò un nesso di corrispondenza fra l’esistenza della
fattispecie negoziale tipica ed il dato della continuità della prestazione. Di recente poi il
legislatore è intervenuto per chiarire il confine fra subordinazione e parasubordinazione.
Secondo l’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, a decorrere dall’ 01/01/2016, “si applica la disciplina
del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in
prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione
sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. La
disposizione si preoccupa di perseguire forme elusive del contratto di lavoro subordinato che
si celino dietro rapporti di lavoro parasubordinato. Si ha rapporto di lavoro subordinato
quando il prestatore è obbligato a rispettare le coordinate spazio-temporali della prestazione
imposte dal datore.
d) Analoghe indicazioni si traggono dalla definizione di lavoratore subordinato sportivo,
prevista dall’art. 2 della legge n. 91/1981, che fa leva proprio sui tratti della continuità, della
sottoposizione ai poteri di coordinamento da parte della società datrice e di un’apprezzabile
durata espressiva della dipendenza.
Il dato che viene dalla storia e che riconosce nella subordinazione l’esautorazione del lavoratore e
l’alienità del lavoro è assunto dal nostro ordinamento come ratio dell’intervento normativo a favore
11
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
di una particolare categoria di soggetti. La rilevazione di siffatti caratteri nella subordinazione ha
precisi punti di emersione normativa valorizzati all’interno della stessa norma definitoria del codice
civile (art. 2094). Se questa viene letta in correlazione con la Carta costituzionale e con la normativa
speciale, il requisito del lavoratore alle altrui “dipendenze” acquista un preciso significato
valutativo e selettivo delle singole prestazioni di lavoro.
6. Resta il problema del metodo più corretto per collegare gli elementi desunti dall’analisi di fatto ai
parametri normativi assunti dall’ordinamento. Il problema si pone in ragione della mancanza di
compattezza della fattispecie. La questione è ineludibile, data la necessità di mediare il dato
normativo ed il dato sociologico dalla cui dialettica non è possibile prescindere ai fini del
procedimento valutativo. L’analisi del modus procedendi della giurisprudenza dimostra come si
avvalga di un criterio che valorizza l’insieme della disciplina del rapporto per risalire alla
fattispecie. Un contributo alla razionalizzazione dell’impiego di tale tecnica viene da quella parte
della dottrina che la ritiene conforme al metodo tipologico di ricognizione della realtà giuridica, in
contrapposizione al metodo sussuntivo. Il metodo tipologico fa valorizzare il complesso della
disciplina, fa utilizzare le comparazioni sul piano della disciplina normativa nei confronti di
contratti affini, fa raffrontare la disciplina legale con quella di origine pattizia, fa acquisire una serie
di elementi “indiziari” dal cui insieme dedurre la caratteristica dell’articolarsi concreto della
specifica prestazione. Attraverso questo metodo è possibile fornire criteri dotati di maggiore
elasticità per la soluzione dei singoli casi concreti rispetto ai connotati di rigidità e astrattezza del
ragionamento per concetti. Resta però la questione della compatibilità del metodo tipologico con il
nostro sistema che fissa i tipi contrattuali in concetti definitori che richiedono l’impiego del metodo
sussuntivo, attraverso il quale la fattispecie concreta viene ricondotta a quella astratta. La
contrapposizione fra le due metodologie può perdere significato se si considera che resta
indispensabile uno strumento che garantisca il costante adeguamento della “norma giuridica” alla
“realtà sociale”. Una proposta risolutiva può essere quella di coordinare i due punti di vista,
scindendo la metodologia qualificatoria in due fasi distinte:
1. L’articolazione “tipologica” di una serie di fattispecie specifiche di subordinazione
2. Il raffronto fra tali fattispecie astratte e le fattispecie concrete, condotto secondo il
tipico metro del metodo sussuntivo.
6.1. Altra questione è quella del ruolo della volontà nel procedimento di qualificazione. Qui incide il
principio di rigidità del tipo contrattuale, che sottrae alle parti individuali il potere di determinare il
contenuto del contratto e quindi di disporre del tipo. Quindi per la qualificazione del contratto di
lavoro subordinato è necessario far capo al comportamento complessivo delle parti. Da qualche
anno circolano massime della giurisprudenza che intenderebbero valorizzare la volontà delle parti
nel procedimento di qualificazione. A tale filone ha fatto anche eco un orientamento di origine
dottrinaria che intende fondare ed asseverare l’inconsistenza logica prima che giuridica della tesi
dell’irrilevanza della volontà negoziale ai fini della qualificazione del contratto di lavoro. Si tratta
però di una costruzione che non riesce a scalfire la fondatezza dell’orientamento tradizionale. A
completare il discorso valga altresì ricordare che i descritti limiti nel procedimento valutativo
dell’attività privata valgono anche per il legislatore. La norma dell’art. 13 2° e 3° co. della l.
23/12/1992 n. 498 ha stabilito che i comuni, le province, le comunità montane ed altri enti non sono
“soggetti, relativamente ai contratti d’opera o per le prestazioni professionali a carattere individuale
da essi stipulati, all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti da leggi in materia di previdenza e di
assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione”. È una previsione
suscettibile di doppia lettura: o si ritiene che il legislatore abbia inteso ribadire che gli enti pubblici
menzionati non sono esposti all’adempimento di oneri previdenziali o si ritiene che il legislatore
12
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
abbia inteso qualificare a priori come di lavoro autonomo i rapporti posti in essere dagli enti. Ove
prevalga la prima ipotesi si potrà al limite lamentare una riaffermazione dell’ovvio, ove prevalga la
seconda si sospetterà l’esistenza di una sorta di attentato alla libertà del giudice di qualificare in
concreto la fattispecie sottopostagli. La questione venne rimessa alla Corte costituzionale, la quale
precisò che mai sarebbe consentito al legislatore di autorizzare le parti ad escludere l’applicabilità
della tutela inderogabile prevista a tutela dei lavoratori a rapporti che siano inquadrabili nell’ambito
della subordinazione.
6.2. Ci si chiede se sia opportuno mantenere un sistema basato sull’inderogabilità della disciplina da
parte dell’autonomia individuale o se sia il caso di aprire ulteriori spazi alla disponibilità delle
obbligazioni che fanno capo al contratto di lavoro. In tal contesto si trova la riflessione di chi
segnala che sarebbe l’irrigidimento del rapporto di lavoro a produrre effetti sperequativi nel mercato
del lavoro. Fra le proposte al fine di risolvere tutto ciò vi è quella che consentirebbe al lavoratore di
ridisegnare il contenuto del contratto, con l’inserimento di clausole derogative e/o abdicative
rispetto alle previsioni di norme inderogabili. Il sistema proposto è quello della volontà assistita,
tramite il quale un organo imparziale ed autorevole possa sorreggere la volontà del lavoratore
all’atto della formazione del contenuto del contratto. Un progetto di tale portata era contenuto nel
Libro Bianco sul mercato del lavoro presentato dal governo di centro-destra nell’ottobre 2001. Con
la legge di delegazione 14/02/2003 n. 30 l’idea era già edulcorata, prevedendosi solo un
meccanismo sperimentale di certificazione dei contratti di lavoro con lo scopo di ridurre il
contenzioso sulla qualificazione del medesimo. Questo meccanismo è stato regolato dal d.lgs. n.
276/2003, le cui norme sono state modificate con il “Collegato lavoro” (l. n. 183/2010), con
l’intento di ampliarne la rilevanza e rafforzare il ruolo dei certificatori. L’art. 75 del d.lgs. del 2003
ribadisce la finalità deflattiva del contenzioso in materia di lavoro, prefigurando una procedura
volontaria, tramite la quale le parti possono ottenere la “certificazione”. Essa riguarda tutti i
contratti in cui sia dedotta una prestazione di lavoro e non. La medesima procedura è estesa: a) ai
regolamenti delle cooperative, b) alla certificazione delle rinunce e transazioni “a conferma della
volontà abdicativa” del lavoratore, c) alle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo di
licenziamento, d) alla determinazione di “elementi e parametri” per definire le conseguenze del
licenziamento illegittimo, e) all’introduzione nel contratto di lavoro di un “clausola
compromissoria”. La certificazione è un atto con cui l’autorità pubblica esprime un parere
valutativo motivato intorno alla qualificazione di un regolamento contrattuale posto in essere dalle
parti, con natura di atto amministrativo. L’autorità accertatrice non ha il potere di sorreggere la
volontà abdicativa del lavoratore, ma di verificare la corrispondenza dello schema negoziale
realizzato rispetto ai tipi contrattuali previsti dall’ordinamento. Il “Collegato lavoro” attribuisce alla
certificazione: l’interpretazione delle sue clausole, la tipizzazione della giustificazione del
licenziamento, i parametri per la quantificazione del risarcimento o l’apposizione della clausola
compromissoria. Resta comunque il fatto che l’atto di certificazione è un parere non vincolante
rispetto al quale il giudice si potrà muovere con la medesima libertà valutativa. Le parti che
intendono ottenere la certificazione devono inoltrare la relativa istanza scritta alle Commissioni di
certificazione. La procedura è volontaria ed è scandita da una serie di adempimenti che prevedono
la comunicazione dell’istanza alle autorità pubbliche interessate. I contratti di lavoro certificati
devono essere conservati per cinque anni presso la sede di certificazione. L’atto di certificazione
deve contenere la menzione degli effetti civili, amministrativi, fiscali e previdenziali, per i quali le
parti richiedono la certificazione, nonché “il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”. Il cuore
della disciplina ed il suo significato sta nella sua efficacia giuridica. Gli effetti dell’accertamento
hanno stabilità sia nei confronti delle parti che dei terzi interessati. La certificazione resta vincolante
per le parti del rapporto di lavoro nonché per gli istituti previdenziali ed eventualmente
13
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
l’amministrazione finanziaria, fino a che sulla vicenda non si pronunci il giudice del lavoro, il quale
non è espropriato del potere di procedere ad un’autonoma qualificazione del contratto certificato
dalla Commissione. Avverso l’atto di certificazione le parti e i terzi interessati possono esperire
molteplici rimedi sia davanti al giudice ordinario sia a quello amministrativo. Quanto ai rimedi
davanti al giudice ordinario, gli interessati possono contestare l’erroneità della qualificazione
giuridica del contratto. Può essere altresì impugnata “per vizi del consenso” e per difformità “tra il
programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione”. Il presupposto da cui muove
quest’ultima è che le parti, dopo avere conclamato per iscritto l’esistenza di un contratto di lavoro
para-subordinato a progetto ed ottenuto la relativa certificazione, prescindano dall’attuare tale
programma e realizzino in concreto un diverso schema negoziale. Nei primi due casi l’accertamento
giurisdizionale ha effetto ex tunc, cioè la qualificazione del contratto opera fin dalla manifestazione
della volontà. Nel terzo caso invece l’effetto si produce solo dal momento in cui la sentenza accerta
che ha avuto inizio la difformità. Di diversa natura è il rimedio tramite la giurisdizione
amministrativa: quest’ultima sarà competente in relazione allo scrutinio dei vizi del procedimento o
in caso di eccesso del potere dell’atto di certificazione. Tutto ciò comunque non esclude il potere
del giudice ordinario. Una funzione ulteriore svolta dalle commissioni di certificazione è quella di
espletare attività di “consulenza ed assistenza” a favore delle parti contrattuali sia in ordine della
stipulazione del contratto di lavoro che in relazione alle modifiche del programma negoziale. La
previsione sembra costituire un ponte verso un sistema di derogabilità assistita, in cui alla
commissione sia dato il potere di assistere il lavoratore nella prospettiva di una vera e propria
dismissione di diritti previsti dall’ordinamento per quello specifico modello negoziale.
Sezione II: I RAPPORTI DI LAVORO
1.Lavoro autonomo: non vi è un disegno preciso, forse per il fatto che i giudici hanno sempre posto
l’attenzione sulla distinzione generica fra autonomia e subordinazione, in cui il lavoro autonomo
emerge a contrario dell’esclusione del requisito della subordinazione. Non esiste una definizione
normativa del lavoro autonomo, ma solo del contratto d’opera (art. 2222 c.c.). A sua volta la
definizione di contratto d’opera è lacunosa, stretta com’è fra il rovescio della medaglia del lavoro
dipendente e la qualificazione alla stregua di altri contratti tipici. Si ha contratto d’opera (art. 2222
c.c.) “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con
lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione” e si applicano le norme del
Capo I del Titolo III, “salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”. L’unico
dato in positivo nella definizione di contratto d’opera è quello del “lavoro prevalentemente
personale”, il quale evoca un confronto con la nozione di “piccolo imprenditore”, definito dall’art.
2083 c.c. Quest’ultimo è un produttore che svolge “un’attività professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”. Dunque la nozione di
lavoratore autonomo vive schiacciata nell’interstizio fra imprenditorialità e subordinazione. Occorre
esaminare due questioni fondamentali:
1. La regolamentazione di confini fra le nozioni di lavoratore autonomo e (piccolo)
imprenditore;
2. La verifica dei dati strutturali della fattispecie nel gioco fra le regole prefigurate per il
contratto d’opera e quelle descritte nelle singole figure contrattuali del libro IV.
La dottrina giuscommercialistica presenta due scenari contrapposti. C’è chi muove da una
svalutazione del ruolo dell’organizzazione del lavoro altrui e dei mezzi ed ammette che il requisito
dell’imprenditorialità vada riconosciuto anche nell’auto-organizzazione. Ne discende che nella
nozione di impresa ci sarebbero anche figure minime e residuali di operatori economici. Diversa è
14
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
la considerazione della nozione di impresa in cui elemento centrale è l’organizzazione di lavoro
altrui. In tal modo il lavoro autonomo diviene una figura a sé stante di produttore, caratterizzato
proprio dal ruolo svolto dal carattere “prevalentemente personale” del lavoro. Per il momento
dobbiamo verificare il secondo profilo, cioè quello del rapporto fra le regole dettate per il contratto
d’opera e l’applicabilità delle norme del libro delle obbligazioni. La disciplina sul contratto d’opera
manifesta residualità a fronte di quella dei contratti tipici. In tal modo il lavoro autonomo esce dal
riferimento del contratto d’opera per rinvenire una serie di regolamentazioni differenziate nelle
varie fattispecie del libro delle obbligazioni. Non c’è perciò una nozione unica di lavoro autonomo
ma una serie di nozioni a seconda della specifica funzione che il contratto intende perseguire e dei
modi della sua realizzazione. Nel libro delle obbligazioni si rinvengono diverse figure rapportabili
al lavoro autonomo, ma distinguibili dal contratto d’opera. Un classico esempio è quello del
mandato, della commissione e della spedizione: mentre il primo ha per oggetto atti giuridici e il
secondo e il terzo attività di acquisto e vendita di beni e di trasporto, l’oggetto del contratto d’opera
sono atti materiali. Ciò non toglie che tali specie rappresentino forme di lavoro autonomo. Una
difformità strutturale rispetto al contratto d’opera si ha in relazione all’appalto: con quest’ultimo il
contratto d’opera condivide identità di oggetto, ma se ne allontana per la diversa qualità dei soggetti
e l’incidenza nei due casi dei profili dell’organizzazione dei mezzi necessari per il perseguimento
dello specifico risultato richiesto dal committente. Una forma di lavoro autonomo più prossima al
lavoro subordinato è il lavoro parasubordinato. Il principale esempio è costituito dal contratto di
agenzia, che è l’ennesima forma di lavoro autonomo in cui l’agente “assume stabilmente l’incarico
di promuovere . . . verso retribuzione, la conclusione di contratti in una determinata zona”. Il
legislatore peraltro si è fatto carico di far emergere un prototipo normativo di carattere generale, che
funziona quale genus (anche) della species cui accede il contratto di agenzia. Il più risalente
riferimento a tale figura è nell’art. 2 della l. n. 741/1959 che estendeva il proprio ambito di
applicazione anche ai “rapporti di collaborazione che si concretino in prestazione d’opera
continuativa e coordinata”. La consacrazione legale del lavoro parasubordinato si ha con l’art. 409
n. 3 del cod. proc. civ. che riferisce l’applicabilità del rito lavoristico altresì ai rapporti che si
concretano “in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche
se non a carattere subordinato”. La figura del lavoratore parasubordinato è sotto l’ala protettiva del
diritto del lavoro in ragione della sussistenza di una situazione di sottoprotezione sociale analoga a
quella del lavoro dipendente, con il quale condivide alcuni requisiti tipici: continuità, personalità e
coordinazione rispetto all’organizzazione dell’impresa. Al lavoratore parasubordinato si estende una
parte delle tutele previste per il lavoro subordinato: tutela processuale e tutela previdenziale
obbligatoria. Con l’art. 5 del d.lgs. 23/02/2000 n. 38, inoltre, è stata estesa ai “lavoratori
parasubordinati indicati nell’art. 49 2° co. lett. a) del d.p.r. 22/12/1986 n. 917” l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni. Le legge finanziaria per il 2007 ha previsto il sostegno finanziario
a “programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale” per i
collaboratori a progetto che abbiano prestato la loro opera presso aziende in crisi. Con l’art. 15 de
d.lgs. n. 22/2015 è stata estesa ai lavoratori para-subordinati l’indennità di disoccupazione (DIS-
COLL). La prefigurazione di una fattispecie generale ha creato un contenitore ampio, al cui interno
si sono fatte rientrare le specie più diverse, fungendo da catalizzatore per le situazioni in cui la
prestazione è posta fra autonomia e subordinazione. La propensione ad utilizzare il lavoro
parasubordinato in funzione elusiva della disciplina sul lavoro subordinato ha indotto forti
limitazioni al suo impiego. La materia è stata regolata con il d.lgs. n. 276/2003 ed è stata rivisitata
con la riforma Monti. La logica dell’innovazione sta nel fatto che non si poteva più convenire
liberamente un contratto di prestazione d’opera continuativa e coordinata, ma doveva essere
riconducibile “a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente
15
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
dal collaboratore”. Con la riforma Monti del 2012 la fattispecie del lavoro a progetto era stata
ulteriormente ristretta fino al punto di concepirlo come un episodio irripetibile nella vita
dell’impresa. L’art. 52 del d.lgs. n. 81 del 15/06/2015 ha abrogato le disposizioni che regolavano il
lavoro a progetto, lasciando in piedi solo il prototipo della para-subordinazione di cui all’art. 409
n.3 cod. proc. civ.. La precedente regolamentazione continuerà però ad applicarsi esclusivamente
per le regolamentazioni dei contratti già in essere alla data di entrata in vigore del decreto del
giugno 2015. Quindi dal giugno 2015 i tipi contrattuali in cui può essere convenuta un’attività
lavorativa sono tre: il lavoro subordinato (art. 2094 c.c.), il lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) e il
lavoro para-subordinato (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.). Oltre ad eliminare il lavoro a progetto, il
d.lgs. n. 81/2015 ha introdotto una disposizione con l’art. 2, la cui rubrica allude alle
“collaborazioni organizzate dal committente”. È una norma che prevede che “a far data dal 1°
gennaio 2016 (?) si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di
collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le
cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al
luogo di lavoro”. Seguono forme di collaborazione cui non si applica la presunzione indicata. La
tecnica adoperata suscita perplessità, a dar credito si dovrebbe ritenere che esista un sottotipo del
rapporto di lavoro parasubordinato caratterizzato da prestazioni di lavoro esclusivamente personali
e continuative, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. A tale sottotipo dovrebbe applicarsi “la disciplina del
rapporto di lavoro subordinato”, ma solo “a far data dal 1° gennaio 2016”. A ciò si aggiunga che un
rapporto di lavoro parasubordinato stipulato a decorrere dal giugno 2015 e che presentasse le
caratteristiche indicate, sarebbe riconducibile al prototipo di cui all’art. 409 cod. proc. civ. fino al
31/12/2015, mentre solo a decorrere dall’01/01/2016 dovrebbe poter essere disciplinato dalle norme
sul rapporto di lavoro subordinato. Più convincente è però assumere che la legge non intende
introdurre un nuovo tipo contrattuale del lavoro parasubordinato, bensì fornire elementi di
qualificazione della fattispecie. In sostanza la norma intenderebbe dare migliore specificazione ai
criteri di qualificazione della para-subordinazione a fronte della definizione di cui all’art. 2094 c.c.
Il d.lgs. n. 81/2015 prevede, all’art. 54, una sorta di sanatoria per i rapporti di lavoro
parasubordinato anche a progetto, nonché per i rapporti di lavoro autonomo stipulati con soggetti
titolari di partita IVA. I datori di lavoro che procedano ad assumere con contratto di lavoro
subordinato, a tempo indeterminato i lavoratori sopra indicati, possono usufruire dell’estinzione
degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di
lavoro. Le condizioni per aver diritto alla sanatoria sono le seguenti:
a) Che i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano atti di conciliazione in una delle
sedi di cui all’art. 2113, quarto comma, c.c. o davanti alle commissioni di certificazione
b) Che nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto
di lavoro.
Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni bisogna notare che erano esonerate
dall’applicazione della disciplina sul lavoro parasubordinato a progetto, derivandone la possibilità
di far ricorso al lavoro parasubordinato. Però a decorrere dal 1° gennaio 2017 è fatto divieto alle
pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione con le caratteristiche indicate.
Infine occorre ricordare un nuovo tipo contrattuale: il lavoro accessorio. La sua regolamentazione
risale al d.lgs. n. 276/2003, ritoccato dalla l. n. 92/2012. Tali disposizioni sono state poi abrogate
dall’art. 55 del d.lgs. n. 81/2015 che attualmente regola la materia agli articoli da 48 a 50. È uno
schema che ha subito modificazione dell’ambito dei destinatari. Alle origini era caratterizzato sul
piano soggettivo dall’essere destinato a lavoratori “a rischio di esclusione sociale o comunque non
16
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne”. Con la più recente riforma ne può
essere titolare qualsiasi lavoratore. Resta invece la sua connotazione oggettiva per lo svolgimento di
attività lavorative di natura occasionale: si intendono le attività “che non danno luogo a compensi
superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile”. Nei confronti dei committenti le attività
lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non
superiori a 2.000 euro. Il lavoro accessorio può essere anche svolto in tutti i settori produttivi, nel
limite di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito. Per il settore agricolo, il lavoro accessorio può aver corso con
riferimento: a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole
stagionali effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni; b) alle attività agricole svolte a
favore di piccoli produttori agricoli. Gli aspiranti allo svolgimento di prestazioni di lavoro
accessorio sono compensati attraverso dei buoni. I committenti possono acquistare i buoni solo “con
modalità telematiche” e sono onerati di comunicare alla DTL i dati anagrafici del lavoratore ed il
luogo della prestazione. Il compenso viene erogato presso l’ente o la società concessionaria che
provvede al pagamento dei buoni. La propensione legislativa ad estendere a forme di lavoro
autonomo porzioni di trattamento normativo tipiche del lavoro subordinato è definita tendenza
espansiva del diritto del lavoro. È posto all’attenzione dei giuristi il problema dell’alternativa fra
subordinazione e autonomia. Ci si è perciò interrogati sulla possibilità di distinguere fra problemi di
qualificazione del rapporto e problemi di applicazione delle relative discipline. L’obiettivo di
pervenire al superamento del modello del lavoro subordinato non può essere perseguito con puri
aggiustamenti interpretativi, al di fuori di un disegno legislativo di riscrittura di una parte della
disciplina lavoristica. È solo il legislatore che così come può procedere alla tipizzazione di nuove
specie contrattuali di lavoro, può decidere di collegare ad esse solo una parte delle discipline
protettive. Un tentativo in questa direzione è stato fatto con il disegno di legge n. 2049 approvato
dal Senato il 13/02/1999 su uno “Statuto dei lavoratori”, ma non è giunto a compimento per la fine
della legislatura. Ulteriori idee erano contenute nel Libro bianco sul lavoro, presentato dal Ministro
del lavoro del governo di centro-destra nell’ottobre 2001. I successivi sviluppi normativi si sono
invece mossi in direzione diversa: hanno voluto introdurre nuovi sottotipi contrattuali del lavoro
autonomo o del lavoro subordinato, lasciando impregiudicato il collegamento fra qualificazione del
contratto ed applicazione della disciplina protettiva. L’idea di uno statuto dei lavoratori è riapparsa
nei programmi del governo di centro-destra nella primavera del 2004. L’opposizione di centro-
sinistra ha invece ripresentato un progetto che riprende i contenuti del disegno di legge non giunto a
compimento nella precedente legislatura. A riforma Renzi del 2015 si muove invece nella direzione
opposta: semplifica i contratti tipici, riducendoli a tre e cerca di incrementare il rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, stabilendo un ponte fra autonomia e para-subordinazione con
l’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015.
2.I rapporti di lavoro autonomo e subordinato non esauriscono i contesti giuridici al cui interno può
essere spesa attività lavorativa. Mentre essi sono caratterizzati dallo scambio fra lavoro e
retribuzione sussistono situazioni nelle quali la causa del contratto ha natura associativa. Il lavoro
cioè può essere oggetto di conferimento in società: l’art. 2247 c.c. dice che oggetto del
conferimento possono essere beni o servizi, alludendosi alla prestazione di attività lavorativa da
parte del socio. L’ipotesi è confermata dall’art. 2263 2° co. c.c. che regola le tecniche di ripartizione
dei guadagni a favore del socio d’opera. La prestazione di lavoro in tale circostanza viene resa come
adempimento del contratto sociale. Un genere particolare di conferimento di lavoro in società è
quello nell’ambito delle cooperative di produzione e lavoro. Lo scopo della società cooperativa è
quello di assicurare un’occupazione e migliori condizioni di vita ai soci cooperatori, laddove il
profitto rappresenta una condizione di efficienza della cooperativa. Via via che si è evoluto il
17
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
fenomeno cooperativistico non ha mancato di presentare forme di appiattimento del conferimento di
lavoro sugli stilemi del lavoro dipendente, così come ha spesso “mascherato” il lavoro subordinato
sotto le spoglie del rapporto societario. Secondo l’interpretazione prevalente l’attività lavorativa del
socio cooperatore costituiva adempimento del contratto sociale, senza che potesse in alcun modo
integrare gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato. Secondo un’altra prospettazione l’attività
lavorativa del socio avrebbe dovuto essere inquadrata nell’ambito delle prestazioni accessorie di cui
all’art. 2345 c.c., secondo cui al socio spetta un compenso erogato in osservanza delle “norme
corporative applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni”. Secondo una tesi più
radicale sarebbe stato ben ammissibile il cumulo fra il rapporto societario e quello di lavoro
dipendente. Quest’ultima opinione muoveva dalla constatazione secondo cui il ruolo del socio
cooperatore si caratterizzava nei termini di una collaborazione subordinata ed appariva meritevole
della medesima tutela accordata ai lavoratori dipendenti. Maggiormente equilibrata appariva la
prospettazione di chi riteneva di collocare il lavoro del socio fra le prestazioni accessorie solo nel
caso in cui l’obbligo di prestare lavoro fosse previsto nello statuto della società. Per converso le
cooperative sono state oggetto da tempo di interventi legislativi: quelli più tradizionali erano diretti
ad estendere forme di tutela previdenziale; quelli più recenti hanno invece privilegiato il sostegno
della cooperazione nella prospettiva della creazione di nuove forme di imprenditorialità con il
mantenimento delle occasioni di lavoro. Quanto al secondo filone vanno segnalate la legge che
promuove la costituzione di cooperative di produzione e lavoro da parte di lavoratori licenziati per
cessazione dell’attività dell’impresa o per riduzione del personale o quella che vuole che vengano
attivati oneri di informazione a favore delle rappresentanze sindacali. Al socio di cooperativa è stata
estesa la disciplina della cassa integrazione guadagni e quella dei licenziamenti collettivi. Il
descritto atteggiamento di sostegno al fenomeno della cooperazione è stato abbandonato dal
legislatore con la legge 3 aprile 2001 n. 142. La legge ha rivisitato su nuove basi la posizione del
socio cooperatore ed ha riordinato i profili del trattamento. La pre-condizione per l’applicazione
della disciplina è che ci si trovi in presenza di cooperative “nelle quali il rapporto mutualistico abbia
ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio”. In tale contesto viene meglio
definito il rapporto associativo, ponendosi indicazioni ai regolamenti che dovranno regolare le
modalità di partecipazione del socio alla vita sociale. Accanto al rapporto associativo vive anche un
ulteriore rapporto di scambio che può assumere molteplici vesti: subordinata, autonoma, para-
subordinata o “qualsiasi altra forma”. È solo dall’instaurazione di tali rapporti che discendono i
relativi effetti di natura fiscale, previdenziale e gli altri effetti giuridici previsti dall’ordinamento.
Alle fonti interne delle cooperative è demandata l’organizzazione dell’impresa e dei rapporti dei
soci e la determinazione delle “modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei
soci”. Il contenuto del regolamento delle cooperative va sottoposto alla procedura di certificazione.
L’interrogativo più pressante sta nel chiedersi se il legislatore abbia autorizzato una sorta di
detipizzazione del rapporto di lavoro: a) nel senso che alla ricostruzione di un tipo contrattuale la
legge collega effetti diversi da quelli voluti dall’ordinamento; b) nel senso che alle parti sia dato in
sede negoziale un potere di derogare a tutti o ad alcuni di questi effetti. La risposta deve essere
negativa. Quanto alla prima opzione la legge ricollega “i relativi effetti” e dunque non consente che
vengano riconnessi effetti diversi. Quanto alla seconda, sembra evidente che il riferimento ad altre
possibili tipologie costituisca solo un ponte verso la prefigurazione di nuove forme di rapporti di
lavoro da parte del legislatore. Rimane quindi il potere del giudice di procedere alla qualificazione
effettiva del rapporto. La legge poi risolve in modo originale la contrapposizione fra mutualità e
scambio, coordinando i due profili: infatti la mutualità si realizza attraverso un contratto di scambio.
Tale risultato è garantito dal collegamento genetico e funzionale fra i due rapporti e fra le rispettive
cause, valutate nell’ambito di una più ampia operazione economica. Quanto al trattamento spettante
18
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
al socio si prevede che, se il rapporto è di lavoro subordinato, si applichi lo statuto dei lavoratori.
Agli altri soci lavoratori si applicano in ogni caso le norme dello statuto ed altresì la disciplina in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ai soci lavoratori deve essere riconosciuto un trattamento
economico proporzionato alla qualità e alla quantità del loro apporto e non inferiore ai minimi
previsti della contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine o ai compensi
medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. Trattamenti economici
ulteriori possono essere deliberati in assemblea. Quanto alla tutela dei diritti la legge prevede
l’estensione al trattamento economico del socio lavoratore del privilegio di cui all’art. 2751-bis c.c.
Le controversie relative al rapporto di lavoro subordinato sono di competenza del giudice del
lavoro, mentre quelle che riguardano il rapporto mutualistico rientrano nella competenza del giudice
civile ordinario. L’attività di lavoro poteva inoltre rientrare nello schema contrattuale
dell’associazione in partecipazione. Con essa l’associante attribuisce all’associato una
partecipazione agli utili della propria impresa verso il corrispettivo di un determinato apporto, che
poteva essere una prestazione di lavoro. La distinzione rispetto al lavoro dipendente in
un’attenuazione dei poteri tipicamente datoriali e nella sottoposizione dell’associato al rischio
d’impresa. Ciò conferma come lo schema dell’associazione in partecipazione potesse costituire
espressione di forme di elusione della disciplina di tutela del lavoro dipendente. Allo scopo di
evitare tali forme elusive è intervenuto il legislatore con la riforma Monti che aveva previsto che il
numero degli associati impegnati in una medesima attività non poteva essere superiore tre, con
l’unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all’associante da rapporto coniugale, di
parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione il rapporto con tutti
gli associati si considerava di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Era dunque una
presunzione assoluta che prescindeva dalla reale sussistenza del requisito della subordinazione. Con
la riforma Monti si escludeva la riconducibilità del contratto al prototipo di cui all’art. 2549 c.c. sia
in mancanza di una partecipazione reale agli utili dell’impresa, sia quando l’apporto di lavoro fosse
relativo a mansioni di scarso contenuto professionale. La riforma Renzi ha del tutto escluso che
l’apporto dell’associato possa consistere in una prestazione di lavoro, stabilendo che “nel caso in
cui un associato sia una persona fisica l’apporto . . . non può consistere, nemmeno in parte, in una
prestazione di lavoro”. Oggi dunque non è più possibile utilizzare l’associazione in partecipazione
per fini elusivi della disciplina del lavoro subordinato. Un problema diverso si ha a riguardo alla
possibilità di cumulo fra la posizione di amministratore-socio e quella di lavoratore subordinato. È
ovvio che le società hanno bisogno di fruire dell’attività di soggetti che si incarichino di svolgere
l’attività di amministrazione. Può in tali situazioni configurarsi l’esistenza del rapporto di lavoro
subordinato, purché sia individuabile una qualche entità alla quale il lavoratore debba rendere conto
della propria attività e dalla quale riceva le necessarie direttive. Significative sono le forme
associative in agricoltura. È in questo che sono state sperimentate le tecniche giuridiche attraverso
cui le parti possono mettere in comune l’attività economica. Con la legge 15/09/1964 n. 756 il
legislatore è intervenuto per disboscare la selva dei contratti associativi agrari, riducendoli allo
schema dell’affitto. Il processo è stato ampliato e perfezionato con la l. 03/05/1982 n. 203.
3. Il lavoratore si impegna a svolgere la prestazione “mediante retribuzione”: il contratto è
caratterizzato dall’onerosità, rafforzata dalla garanzia costituzionale che riceve il diritto alla
retribuzione nell’art. 36. Non esclude che possa esservi spendita di attività lavorativa in assenza di
controprestazione retributiva. Classico terreno della gratuità del rapporto è tradizionalmente il
lavoro che si svolge entro le mura domestiche tra familiari: presunzione di gratuità dell’attività
prestata sul presupposto che la prestazione verrebbe resa in ragione dell’affectio parentale. Tale
atteggiamento non si è modificato in conseguenza della riforma del diritto di famiglia del 1975. In
tal contesto l’art. 230 bis c.c. ha introdotto la figura dell’impresa di famiglia e ha regolato i rapporti
19
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
patrimoniali fra i partecipanti ad essa o fra i soggetti che prestano lavoro. Si è così stabilito che il
familiare che presta attività continuativa di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto:
a) al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e b) a partecipare agli utili e
ai beni acquistati con essi in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Con riferimento
alle attività agricole il legislatore ha previsto che non costituiscono rapporti di lavoro subordinato o
autonomo le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente
occasionale o ricorrente di breve periodo. Un altro ambito nel quale ha rilievo la mancanza di
onerosità del rapporto è il fenomeno del volontariato. Esistono associazioni che si dedicano ad
opere di carità o assistenzialistiche e che adempiono alla loro funzione avvalendosi del lavoro
prestato volontariamente dagli associati. Così come può menzionarsi l’attività lavorativa svolta dal
militante di un partito o di un sindacato o da un religioso nell’ambito dell’ordine cui appartiene. Si
ha una deviazione causale rispetto al tipico rapporto di lavoro subordinato, dal momento che la
funzione sociale del rapporto accede al perseguimento delle finalità etiche, politiche o religiose che
l’ente si propone. Il fenomeno quindi si differenzia sia dalle prestazioni di cortesia, sia dal
praticantato ed altresì dal lavoro familiare. Sul piano della qualificazione del volontariato non si può
che ripiegare sulla ricostruzione in termini di contratto atipico di lavoro. È necessaria una
valutazione del caso concreto allo scopo di distinguere genuine prestazioni volontarie di lavoro da
semplici elusioni della disciplina lavoristica. Un ruolo importante ha il criterio dello “stato di
bisogno” del lavoratore: costituisce un indizio della genuinità del volontariato una prestazione
svolta da un soggetto che sia già titolare di un rapporto di lavoro, che garantisca un reddito per sé e
per la propria famiglia. Accanto a tale verifica vi è l’indagine intorno all’effettività del carattere “di
tendenza” dell’organizzazione, sull’assenza di fini di lucro di quest’ultima e sull’effettività e
genuinità del coinvolgimento motivazionale del lavoratore. Oggi il legislatore ha fornito una
cornice legislativa al fenomeno con la legge-quadro sul volontariato dell’11/08/1991 n. 266.
L’importanza sta nel riconoscimento e nel sostegno al fenomeno del volontariato, “come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”. Di rilievo poi è la definizione normativa i
cui elementi vengono individuati nella personalità, spontaneità e gratuità della prestazione, nel
contesto di organizzazioni senza fine di lucro e per fini di solidarietà. Tale attività è incompatibile
con altri rapporti onerosi con l’organizzazione. Vi è quindi la possibilità che l’organizzazione si
avvalga di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato nei limiti necessari al regolare
funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. A tutela dei volontari
le legge prevede a carico delle organizzazioni l’obbligo assicurativo contro gli infortuni e le
malattie. Un sostegno indiretto viene poi dalla possibile attivazione di forme flessibili di orario o di
turni nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui siano titolari i volontari. La legge 08/11/1991 n. 381
sulle cooperative sociali ammette la possibile presenza di soci volontari, che prestino la loro attività
gratuitamente e al di fuori dello schema di subordinazione.
4. Il rapporto di “pubblico impiego” è stato recuperato alla sponda lavoristica. Alle origini il
rapporto il pubblico impiego tendeva a confondersi con il rapporto di immedesimazione “organica”.
Il pubblico dipendente rappresentava quindi una sorta di “strumento” della pubblica
amministrazione, attraverso il quale quest’ultima manifestava all’esterno la propria volontà. Il
distacco dal rapporto organico maturò con l’allargamento delle funzioni statali, quando cioè le
funzioni e le istituzioni amministrative si moltiplicarono, facendo proliferare anche il numero dei
dipendenti pubblici. Si prese atto che accanto e oltre al rapporto “organico”, si costituiva un
“rapporto di servizio”, attraverso il quale la pubblica amministrazione acquisiva la disponibilità di
energie lavorative, al pari di qualsiasi altro datore di lavoro. Il rapporto di pubblico impiego subì
l’influsso della visione amministrativistica, la quale enfatizzava il ruolo e l’importanza delle finalità
pubblicistiche perseguite dal datore di lavoro. Vennero così fissate le caratteristiche fondamentali:
20
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
1. Regolamentazione per legge delle condizioni di lavoro
2. Riconduzione della fonte del rapporto ad un atto amministrativo e non ad un contratto
3. Soggezione del dipendente ai poteri datoriali di supremazia speciale
4. Formalizzazione del rapporto del tutto impermeabile all’articolazione in fatto della
prestazione
5. Negazione della struttura di “scambio” propria del rapporto privatistico
A mantenimento del sistema stava la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che
valutava le vicende del rapporto attraverso il filtro dell’atto amministrativo. A partire dagli anni
settanta cominciò a maturare la consapevolezza della necessità di riformare la materia del pubblico
impiego nella direzione di convergenza verso le regole privatistiche. La propensione al mutamento
si basa su una molteplicità di ragioni. Inoltre l’accresciuta sindacalizzazione dei pubblici impiegati e
l’espandersi della contrattazione collettiva costituivano i motivi di convergenza nello statuto
giuridico dei dipendenti pubblici e privati. Ma non erano solo esigenze di maggior tutela a far
orientare verso il riavvicinamento. C’era la fondamentale esigenza di garantire una miglior
amministrazione della cosa pubblica attraverso una maggiore efficienza organizzativa e gestionale.
Un significativo momento di transizione va fatto risalire alla l. 29/03/1983 n. 93, legge-quadro sul
pubblico impiego, che ha dettato regole generali circa le fonti di determinazione della disciplina. Ha
regolato poi le procedure per la stipulazione dei contratti collettivi. Il limite della legge del 1983 è
però costituito da una omogeneizzazione solo parziale dei contenuti dei due rapporti, ma soprattutto
dalla riconferma della giurisdizione del giudice amministrativo sulle relative controversie. La vera
svolta si ha negli anni novanta ed è riconducibile alle ll. di delegazione n. 421/1992, n. 59/1997 e n.
127/1997. In attuazione di tali deleghe la normativa-base è ora costituita dal d.lgs. 03/02/1993 n. 29.
Con il d.lgs. 30/03/2001 n. 165 la materia, infine, è stata raccolta in una sorta di testo unico. La più
recente iniziativa è costituita dalla legge 02/08/2015 n. 124 che contiene una serie di deleghe al
governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Si prevede che vengano
predisposti nuovi testi unici per il “lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e
connessi profili di organizzazione amministrativa”. Inoltre all’art. 17 vengono indicati i principi
direttivi cui devono ispirarsi i decreti legislativi. Secondo il d.lgs. n. 165/2001 le finalità della
riforma rispondono alle esigenze di accrescere l’efficienza delle pubbliche amministrazioni,
razionalizzare il costo del lavoro pubblico e realizzare l’uniformità di trattamento fra dipendenti
pubblici e privati. Fondamentale è il principio secondo cui i rapporti di lavoro dei dipendenti
pubblici “sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, del Titolo II, del Libro V del codice civile e
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e sono “regolati contrattualmente”.
Significa che lo statuto giuridico del pubblico dipendente è di regola il medesimo di quello del
lavoratore privato e le eccezioni hanno carattere di tassatività. Significativo è che il legislatore abbia
modificato il precedente testo che poneva come limite all’estensione della disciplina privatistica il
fine del perseguimento degli interessi generali dell’organizzazione amministrativa, così aprendo lo
spazio ad un controllo del giudice amministrativo sugli scopi degli atti di gestione del rapporto.
Viceversa si deve oggi ritenere che questi non vanno riguardati come atti amministrativi, ma
secondo lo schema generale dei poteri negoziali che si incardinano nel contratto di lavoro. Il che
significa che l’attività amministrativa resta esterna rispetto alla dinamica del rapporto di lavoro. La
preminenza della regolamentazione tramite contratto collettivo è edulcorata con la riforma
“Brunetta” del 2009. Secondo il nuovo testo dell’art. 2, 2° co., del d.lgs. n. 151/2001 le eventuali
disposizioni di legge che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata
ai dipendenti della pubblica amministrazione possono essere derogate da successivi contratti
collettivi “solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge”. Viene così ribaltato il rapporto
fra legge e contratto collettivo: la regola è l’inderogabilità della legge. Le clausole del contratto
21
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
collettivo difformi dalla legge sono sostituite di diritto. Sono esclusi dalla contrattualizzazione del
rapporto solo quei dipendenti rispetto ai quali appare maggiormente riconoscibile il nesso di
immedesimazione organica. La tendenziale universalità della riforma è segnata dall’art. 1, 2° co.,
del d.lgs. 29/93, nella parte in cui definisce il proprio ambito di applicazione con riferimento a tutte
le amministrazioni dello Stato. La riforma inoltre estende i propri effetti anche nei confronti
dell’ordinamento regionale, posto che le sue disposizioni costituiscono principi fondamentali ai
sensi dell’art. 117 Cost. Le regioni a statuto ordinario devono attenersi ad esse, per quelle a statuto
speciale si prevede invece che i principi relativi alla ripartizione delle materie fra legge e
contrattazione collettiva costituiscano un punto di riferimento per l’attività legislativa. Un ruolo
essenziale per l’attuazione dei principi di efficienza della pubblica amministrazione è affidato ai
dirigenti pubblici. Le controversie relative ai rapporti di lavoro contrattualizzati sono devolute alla
cognizione del giudice del lavoro ordinario, del giudice cioè che ha competenza sulle controversie
per i rapporti di lavoro privatistici; questa devoluzione ha avuto effettivo corso con decorrenza dal
01/07/1998, con riferimento alle controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di
lavoro successivo al 30/06/1998. Si è voluto così garantire un subingresso graduale del giudice
ordinario, che altrimenti sarebbe stato “travolto” dal contenzioso dei dipendenti pubblici.
Ricordiamo inoltre la previsione secondo cui nella materia devoluta al giudice ordinario,
quest’ultimo conosce anche degli atti amministrativi implicati nel rapporto, e, qualora illegittimi, li
disapplica. All’esito della riforma il rapporto di pubblico impiego si presenta come un rapporto di
lavoro speciale, nel senso che ha in sé elementi di deviazione rispetto lo schema generale. Si può
quindi riaffermare che la materia del pubblico impiego è ormai ascritta al diritto del lavoro.
Sezione III: I LAVORATORI SUBORDINATI
1. Il lavoratore subordinato è colui che vive dei frutti del proprio lavoro, svolto in condizione di
dipendenza. L’ordinamento lavoristico si è impegnato a riequilibrare la forza contrattuale del datore,
attribuendo al lavoratore posizioni giuridiche soggettive di vantaggio, che si traducevano nella
creazione di un vero e proprio diritto diseguale già all’interno del contratto. Il diritto diseguale si
proietta anche al di fuori del contratto, se è vero che al lavoratore viene assicurata una tutela
“differenziata”, rispetto agli altri soggetti di diritto in particolari materie. Il lavoratore dipendente
costituisce il prototipo della folta schiera dei “contraenti deboli”. La propensione a fare del
lavoratore subordinato un cittadino “a statuto speciale” muove da un presupposto che attinge la
propria giustificazione a livello costituzionale e sul piano del principio di eguaglianza. Il ruolo del
lavoro dipendente nell’ordinamento è espresso nella Carta costituzionale che vi si riferisce
costruendo una specifica protezione, a cominciare proprio dal principio di eguaglianza sostanziale
che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che impediscono proprio ai lavoratori
dipendenti la partecipazione alla vita politica e sociale del Paese. È il gioco dei rapporti fra
eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale che costituisce l’essenza del diritto del lavoro. I
rapporti fra eguaglianza e diritto del lavoro non si riducono nella costruzione di un diritto diseguale
all’interno del rapporto e nel confronto con altri soggetti di diritto, ma si prolungano anche
all’interno della disciplina, istituendo relazioni di diseguaglianza anche fra le categorie o classi di
lavoratori subordinati. Il diritto del lavoro ha individuato sottoclassi di soggetti a cui favore
approntare una tutela ulteriormente “differenziata” rispetto agli altri lavoratori dipendenti. Ci sono
però altre classi che anche le norme costituzionali assumono come svantaggiate, per particolari
condizioni personali o sociali: è il caso, ad esempio, degli invalidi, delle donne e dei minori. Quanto
a queste ultime due classi, l’atteggiamento del legislatore è coerente con l’unicità delle classi di
soggetti: per il minore e per la donna un numero maggiore di ostacoli si frappongono alla
realizzazione dell’eguaglianza sostanziale. Di questo si occupano le norme lavoristiche. In effetti le
22
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
tecniche legislative di intervento nei confronti di queste due classi hanno seguito una strada
comune. Vi era innanzitutto una questione sociale, riguardante un problema di tutela: occorreva
proteggere con norme limitative l’impiego delle donne e dei minori in ragione della loro maggiore
fragilità fisio-psichica o in relazione alla condizione della donna in quanto madre. C’era poi il
problema di far sì che la particolare condizione personale dei minori e delle donne lavoratrici non
comportasse conseguenze sul piano del trattamento. Si spiega la normativa antidiscriminatoria, di
cui è espressione l’art. 37 Cost. La posizione della donna si è viceversa differenziata quando il
sostanziale fallimento delle politiche antidiscriminatorie ha indotto ad adottare misure che
favorissero l’accesso delle donne ai posti di lavoro. È stata così introdotta una normativa di
promozione delle pari opportunità d’impiego delle donne. Il segno dell’intervento legislativo muta
radicalmente e muta il rapporto tra le due facce dell’eguaglianza a seconda che l’intervento
legislativo si attesti su di una tutela antidiscriminatoria o si avvalga di tecniche promozionali.
2. La difficile coesistenza fra tutela e parità nel lavoro femminile è già iscritta nel suo DNA. La
Carta fondamentale al 1° co. dell’art. 37 delinea i termini dell’alternativa. Da una parte statuisce il
principio paritario, secondo cui “la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e le stesse retribuzioni che
spettano al lavoratore”, mentre dall’altra ribadisce la necessità dell’intervento protettivo, assumendo
che “le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione
familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione”. La norma
costituzionale è il frutto di un difficile compromesso fra la posizione cattolica, che sottolineava
l’essenzialità della funzione familiare della donna, e quella della sinistra, che premeva per una
concezione più emancipata del lavoro femminile e della famiglia. La verità è che la questione
dell’emancipazione del lavoro femminile e della sua parificazione a quella dell’uomo lavoratore
non si risolve a colpi di proposte interpretative dell’art. 37 Cost., ma costituisce una variabile
dipendente dell’assetto dei rapporti sociali. Sotto tale profilo non c’è dubbio che l’accentuazione
degli interventi protettivi a favore della donna si presti oggettivamente ad allontanare gli obiettivi
paritari. Non è un caso che il legislatore ha dapprima accentuato la tutela antidiscriminatoria e si è
volto poi ad ipotizzare discipline ancor più avanzate per la promozione del lavoro e
dell’occupazione femminile. Nel quadro dei progetti di politica legislativa diretti a ridisegnare i
difficili equilibri fra “tutela” e “parità” si inserisce la disciplina dei “congedi familiari” di cui alla
legge 08/03/2000 n. 53 nonché la risistemazione della materia nel d.lgs. 26/03/2001 n. 151,
modificato ed integrato con il d.lgs. 23/04/2003 n. 115, ed ulteriori interventi. La nuova disciplina
non si propone solo di fornire un sostegno all’istituzione familiare, ma anche di ridistribuire gli
oneri relativi anche sul padre-lavoratore. Essa dà attuazione alle indicazioni provenienti dall’
Unione europea che pone al centro della propria attenzione la cura del figlio nei primi anni di vita.
La direttiva fa proprio il principio codificato nell’art. 16 della Carta dei diritti sociali fondamentali
dei lavoratori che richiama gli stati alla necessità di precostituire “misure che consentano agli
uomini e alle donne di conciliare meglio i loro obblighi professionali e familiari”. Una delega al
governo diretta all’emanazione di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa
in materi di occupazione femminile è contenuta nell’art. 1, 81° co., della legge n. 247/2007.
3. Il più risalente nucleo protettivo per le lavoratrici ha riguardo alla tutela della persona.
Nell’ambito degli interventi del regime fascista è opportuno ricordare la legge 26/04/1934 n. 653,
che è restata in vigore anche dopo l’emanazione della Costituzione repubblicana. Fra l’altro:
a) Ammetteva i lavori pericolosi o insalubri;
b) Vietava il trasporto ed il sollevamento;
c) Vietava il lavoro notturno;
d) Stabiliva i limiti massimi per l’orario di lavoro e l’obbligo di riposi intermedi.
23
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
Sull’onda della constatazione secondo cui l’eccessiva accentuazione del profilo protettivo tendeva a
rendere meno appetibile per le imprese l’occupazione delle donne, il legislatore ha disposto, con la
legge 09/12/1977 n. 903, una revisione di taluni dei principi e l’abrogazione delle disposizioni “in
contrasto”. La materia è stata poi rivisitata con il d.lgs. n. 151/2001. Ne è derivato il sostanziale
superamento delle norme di cui alla l. 653/1934 ed una nuova e diversa regolamentazione della
materia. In particolare è stato eliminato il divieto di lavoro notturno, che però è restato in vigore per
le sole lavoratrici-madri, o, a determinate circostanze, per i lavoratori-padri.
4.L’ordinamento prevede un’accentuazione della tutela della donna lavoratrice nelle situazioni in
cui può essere esposta: in occasione del matrimonio e della maternità. Si tratta di interventi che
hanno riguardo alla prefigurazione:
1. Di un periodo di irrecedibilità assoluta per il datore di lavoro;
2. Della limitazione all’impiego della lavoratrice in stato di gravidanza in attività insalubri o
pericolose;
3. Del diritto alla sospensione del rapporto in caso di gravidanza e puerperio;
4. Del diritto per la lavoratrice di assentarsi dal lavoro in relazione alle cure del bambino.
Con la legge sui congedi parentali una buona parte delle precedenti provvidenze è stata estesa anche
al padre-lavoratore. Il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio è stato
regolato originariamente dalla legge 09/01/1963 n. 7. Attualmente la disciplina è contenuta nell’art.
35 del d.lgs. 11/04/2006 n. 198. La legge vuole reagire nei confronti della possibilità che il datore
proceda a licenziare la lavoratrice che contragga matrimonio o predisponga delle clausole negoziali
(clausole di nubilato) secondo cui il rapporto si estingue in automatico all’atto della celebrazione
del matrimonio. È un intervento incisivo perché emanato in un periodo in cui l’assetto legale
concedeva ancora al datore il potere di recedere ad nutum dal rapporto, cosicché il medesimo ben
avrebbe potuto esercitare il diritto di recesso senza alcuna motivazione. Il licenziamento è
considerato connesso al matrimonio della lavoratrice quando sia posto in essere nel periodo
intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni ed un anno dopo la celebrazione stessa.
In tale periodo il licenziamento si presume a causa di matrimonio e tale presunzione può essere
vinta solo dalla prova che il licenziamento sia avvenuto per una delle seguenti ragioni:
1) Per colpa grave da parte della lavoratrice;
2) Per cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta;
3) Per ultimazione della prestazione per la quale è stata assunta o per la risoluzione del
rapporto per scadenza del termine.
Sono considerate nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel medesimo periodo, salvo che
siano confermate, entro un mese, davanti all’Ufficio del lavoro. La disciplina sulle dimissioni della
donna lavoratrice sopravvive rispetto a quella generale introdotta dalla riforma Monti sulle
“semplificazioni”. La lavoratrice che dichiari di recedere dal contratto ha diritto al trattamento
previsto per le dimissioni per giusta causa. La lavoratrice deve esercitare il recesso entro dieci
giorni dal ricevimento dell’invito. La descritta disciplina si applica alle lavoratrici dipendenti da
imprese private di qualsiasi genere e da enti pubblici. Con la riforma Monti la nullità del
licenziamento è sanzionata con la tutela reale in senso forte, di cui all’art. 18, 1° co., nuovo testo
dello statuto dei lavoratori.
5.L’intervento normativo a favore delle lavoratrici madri è fra le provvidenze più risalenti a favore
della donna nel rapporto di lavoro: risale ai primi anni del secolo. Successivamente nel periodo
fascista la legislazione fu ampliata. Dopo l’entrata in vigore della Costituzione fu emanata una
24
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
disciplina unitaria contenuta nella legge 26/08/1950 n. 860, rivisitata con la legge 30/12/1971 n.
1204, a sua volta modificata e integrata dalla legge n. 903/1977. La materia è stata riformata
secondo l’orientamento diretto ad una valorizzazione delle istanze di protezione della famiglia e
della cura del bambino.
a) Rispetto alla lavoratrice madre opera anzitutto il divieto di licenziamento. Il periodo in cui
opera va dall’inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione
obbligatoria dal lavoro nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto
opera con riferimento allo stato oggettivo di gravidanza. Dunque, ove la lavoratrice, ignara
della propria situazione, sia stata licenziata, la medesima ha il diritto al ripristino del
rapporto, mediante presentazione della certificazione da cui risulti l’esistenza delle
condizioni che lo vietavano. L’art. 54 del d.lgs. 151/2001 ha eliminato il termine di 90 giorni
entro cui andava presentato il certificato. Il licenziamento della lavoratrice madre è nullo per
il periodo in cui perdura il divieto. Con la riforma Monti tale ipotesi di nullità è sanzionata
con la tutela reale forte. Rispetto al licenziamento valgono le tre eccezioni al divieto di
licenziamento a causa di matrimonio, cui si aggiunge il mancato superamento della prova.
Durante il periodo la lavoratrice non può nemmeno essere sospesa dal lavoro, salvo che sia
sospesa l’attività dell’intera impresa o del reparto cui la lavoratrice è addetta. Inoltre non
può essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo. Sia la risoluzione
consensuale del rapporto che le dimissioni presentate dalla lavoratrice devono essere
convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
competenti per territorio. In caso di dimissioni volontarie durante il periodo di irrecedibilità
ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di
licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono in tale periodo non sono tenuti
al preavviso. Il d.lgs. n. 151/2001 considera nullo il licenziamento causato dalla domanda o
dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino. La nuova legge ha
sancito il diritto al rientro nella medesima unità produttiva presso cui operavano in
precedenza o in altra ubicata nello stesso comune ed alla permanenza fino al compimento di
un anno di età del bambino. È ribadito il diritto all’adibizione alle mansioni da ultimo svolte
o equivalenti ed altresì di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro
che sarebbero spettati loro durante l’assenza. La più significativa novità è quella di aver
esteso tutte le tutele appena citate anche al lavoratore che fruisca del congedo per paternità.
Le medesime provvidenze si applicano anche in caso di adozione o di affidamento. Si
prevede che la violazione del divieto di licenziamento comporti l’applicazione di una
sanzione amministrativa.
b) Un ulteriore intervento riguarda le condizioni fisico-biologiche. Si prevede il divieto di
adibizione della lavoratrice al trasporto ed al sollevamento di pesi, nonché a lavori
pericolosi, faticosi e insalubri. L’elenco di tali lavori è contenuto nell’art. 5 del d.p.r. n.
1026/1976, regolamento attuativo della l. n. 1204/1971, mantenuto in vita dal d.lgs. n.
151/2001 e nell’ all. B a quest’ultimo. Le lavoratrici adibite ai lavori vietati devono essere
trasferite ad altre mansioni ma con il mantenimento del trattamento acquisito in precedenza.
La tutela si applica anche alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o
affidamento. La violazione di tali disposizioni è punita con sanzione penale. Quanto al
lavoro notturno c’è il divieto per il periodo che va dall’accertamento dello stato di
gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
c) Il periodo di astensione obbligatoria opera durante i due mesi antecedenti alla data presunta
del parto e fino al terzo mese successivo. Ove il parto avvenga oltre tale data per il periodo
intercorrente fra la data presunta e quella effettiva nonché durante gli ulteriori giorni non
25
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata. Si è aggiunto poi che tali
giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche nel caso in cui
la somma dei periodi di cui sopra superi il limite di cinque mesi. Nel caso di interruzione
spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al centottantesimo giorno dall’inizio
della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo la lavoratrice ha
diritto di riprendere l’attività lavorativa con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro.
Inoltre la lavoratrice può ottenere il rinvio e la sospensione del congedo di maternità, in caso
di ricovero del neonato, per il periodo successivo al parto e di godere del congedo dalla data
di dimissione del bambino. È però un diritto che può essere esercitato una sola volta per
ogni figlio, previo comunque la produzione di un attestato medico che dichiari la
compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa. Può
essere peraltro disposta l’anticipazione dell’interdizione dal lavoro:
1) in caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si
presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
2) quando le condizioni di lavoro o ambientali sono ritenute pregiudizievoli alla salute
della donna o del bambino;
3) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
La lavoratrice ha peraltro facoltà di rendere flessibile il periodo di astensione obbligatoria,
spostandone il godimento a partire dal primo mese antecedente la data presunta del parto e
fino a quattro mesi successivi. Le ferie e le altre assenze non possono essere godute
contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria dal lavoro. Il periodo di
astensione obbligatoria è computato ad ogni effetto nell’anzianità di servizio. Il medesimo
periodo è equiparato all’attività lavorativa anche ai fini della progressione in carriera. Infine
il diritto di astensione obbligatoria è stato esteso anche al padre lavoratore, per tutto il
periodo o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre, in caso di morte o di grave
infermità di quest’ultima o di abbandono nonché di affidamento esclusivo del bambino al
padre (congedo per paternità). In tali situazioni si applicano al padre le norme che regolano
il trattamento economico e normativo della lavoratrice-madre. Nel caso in cui la madre
fruisca del congedo ordinario di maternità con la riforma Monti è stato introdotto un
congedo di un giorno per il padre-lavoratore, da utilizzare improrogabilmente entro i primi
cinque mesi dalla nascita del figlio. Entro il medesimo periodo il padre lavoratore può
astenersi per ulteriori due giorni, in sostituzione della madre lavoratrice dipendente e con il
suo consenso. Al datore va fornita una comunicazione scritta con 15 giorni di preavviso. È
inoltre prevista la possibilità di un ulteriore periodo di astensione facoltativa, rivisitato dal
d.lgs. n. 151/2001. È stato introdotto il principio secondo cui l’astensione facoltativa spetta
comunque ad uno dei due genitori, anche se l’altro non ne ha diritto. Può aver corso entro un
arco di tempo: i primi dodici anni di vita del bambino. Complessivamente i congedi
parentali non possono eccedere il limite di dieci mesi. Trascorso il periodo di astensione
obbligatoria: a) la lavoratrice ha diritto di assentarsi per un periodo non superiore a sei mesi,
b) il padre-lavoratore può assentarsi per un periodo non superiore a sei mesi, c) il genitore
che sia solo per un periodo non superiore a dieci mesi. Il congedo può anche essere su base
oraria, secondo le previsioni della contrattazione collettiva che ne regolamenta la fruizione
ed i criteri di computo. In caso di mancata regolamentazione ciascun genitore può scegliere
tra la fruizione giornaliera o quella oraria. Quest’ultima è consentita in misura pari alla metà
dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrimestrale o mensile immediatamente
precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Si esclude la
cumulabilità della fruizione oraria con altri permessi o riposi relativi ai congedi parentali.
26
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
Per tali diritti vi è l’onere di preavviso del datore nel termine decretato dal contratto
collettivo e non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo.
Il termine di preavviso è di due giorni nel caso di congedo parentale su base oraria. Un
prolungamento del congedo è previsto per i genitori di minori portatori di handicap gravi. In
tali casi entro il compimento del dodicesimo anno di età del bambino, la lavoratrice o il
padre lavoratore hanno diritto ad un prolungamento del congedo per un periodo non
superiore a tre anni. Il periodo di astensione facoltativa è computato nell’anzianità di
servizio. La riforma Monti ha previsto che per gli undici mesi successivi al congedo di
maternità, possano essere concessi dei voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per
pagare gli asili nido. I periodi di assenza obbligatoria e quelli di assenza facoltativa sono
coperti da un trattamento economico di carattere sociale, gestito dall’ INPS. I genitori che
usufruiscono dall’astensione obbligatoria, percepiscono un’indennità pari all’80% della
retribuzione per il periodo di astensione. Tale indennità è corrisposta anche in caso di
cessazione del rapporto di lavoro. Durate l’astensione facoltativa si ha invece un’indennità
giornaliera pari al 30% della retribuzione, ma solo fino al sesto anno di vita del bambino.
Oltre tali termini l’indennità spetta solo nel caso in cui il reddito individuale dell’interessato
sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria. Per venire incontro alle necessità economiche dei
genitori nella prima fase di crescita del bambino è stato previsto che l’astensione facoltativa
costituisce una nuova ipotesi di diritto all’anticipazione del trattamento di fine rapporto. Il
diritto all’astensione facoltativa spetta anche per le adozioni e per gli affidamenti.
d) Ulteriori provvidenze si hanno con riferimento alle cure per l’allevamento del bambino. Il
datore deve consentire, durante il primo anno di vita di vita del bambino, alle lavoratrici
madri, due periodi di riposo. Tali periodi hanno la durata di un’ora ciascuno e sono
considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. In caso di
parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati. La retribuzione dei periodi di riposo è a
carico dell’ente previdenziale. Il medesimo diritto spetta al padre lavoratore: a) nel caso in
cui i figli gli siano affidati in via esclusiva, b) in alternativa alla madre che non se ne
avvalga, c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, d) in caso di morte o
grave infermità della madre. Anche questo diritto è esteso ai casi di adozione e di
affidamento. Entrambi i genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Inoltre ciascun
genitore può astenersi entro il limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di
ciascun figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. Si tratta di congedi non retribuiti. Vi è
poi la previsione del diritto a rifiutare la prestazione di lavoro notturno. La legge prevede
che non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età
inferiore a tre anni o il padre-lavoratore convivente, b) la lavoratrice o il lavoratore che sia
l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età non inferiore a dodici anni.
6. L’art. 37 Cost. stabilisce che la donna ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, la stessa
retribuzione che spetta al lavoratore. Con il principio di eguaglianza si esclude che il sesso possa
costituire elemento di discriminazione fra personale maschile e femminile nell’ambito del rapporto
di lavoro. Ciò risponde alla direttiva generale secondo cui il principio di eguaglianza “si frantuma”
in una serie di diritti sociali, riassunti nell’art. 3. È una previsione conforme alla Convenzione n.
100 dell’OIL, che parla di “lavoro di valore eguale” ed all’art. 157 del TFUE, che si riferisce al
“lavoro eguale”. Anche per tale norma si impose la tesi della percettività, nel senso dell’immediata
spendibilità del principio come diritto soggettivo perfetto davanti all’autorità giurisdizionale. Un
po’ più a lungo si è invece protratta la discussione intorno all’interpretazione della nozione di
27
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
“parità di lavoro”. Da una parte infatti si assumeva che si intendesse parificare le posizioni
lavorative della donna e dell’uomo, purché sussistesse parità di rendimento, dall’altra invece si
riteneva che l’inciso alludesse alla parità di inquadramento contrattuale. La prima interpretazione
poneva però più problemi di quanti non ne risolvesse, posto che risultava difficile stabilire il livello
di rilevanza di tale rendimento e la sua verificabilità in concreto. La prospettiva interpretativa
esprimeva un intento di politica del diritto palesemente ripudiato dalla Costituzione, che alludeva
invece alla perfetta parificazione economica e normativa fra uomini e donne a parità di qualifica e
durata del rapporto. È bene ricordare che il principio della parità retributiva e di trattamento fra i
sessi ha stentato ad affermarsi anche sul piano sindacale. La contrattazione collettiva aveva infatti
prefigurato tabelle salariali distinte fra uomini e donne per lungo tempo, tanto che solo nel 1960
venne raggiunta un’intesa fra le parti sociali, ratificata con l’Accordo Interconfederale del
16/07/1960, con cui si prevedeva il graduale superamento dei differenziali basati sul sesso. Con ciò
si introduceva un inquadramento basato sulle categorie professionali. Di recente la Corte di giustizia
dell’Ue ha qualificato come discriminazione per sesso in materia retributiva anche la differenza di
età per l’accesso alla pensione, prevista nell’ordinamento dell’INPDAP, ora confluito nell’INPS.
7. La difficoltà nel rendere effettivi i principi costituzionali è resa manifesta dall’emanazione di una
specifica normativa antidiscriminatoria, che faceva capo alla legge 09/12/1977 n. 903. È invece
oggi contenuta nel “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” emanato con il d.lgs. n.
198/2006. Si ispira al duplice criterio di ridurre i profili della tutela che irrigidiscono l’impiego del
personale femminile ed ampliare le prospettive della parità di trattamento fra uomini e donne.
Rileva anzitutto il divieto di discriminazione diretta. Vieta qualsiasi discriminazione basata sul
sesso, per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata o autonoma. Il divieto
comprende ogni fora di discriminazione anche se attuata attraverso il riferimento allo stato
matrimoniale o di famiglia o di gravidanza o in modo indiretto. Il divieto si applica anche alle
iniziative in materia di orientamento, formazione ed aggiornamento professionale per quanto
riguarda sia l’accesso che i contenuti nonché all’affiliazione ed all’attività di un’organizzazione di
lavoratori o datori di lavoro. Va altresì iscritto il comportamento ritorsivo dal datore a fronte di un
reclamo a un’azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità fra uomini e donne. Le
uniche eccezioni riguardano i lavori particolarmente pesanti e le assunzioni nei settori della moda,
dell’arte e dello spettacolo, quando ciò sia coessenziale alla natura dell’attività. Negli artt. da 27 a
34 del codice delle pari opportunità vengono elencati una serie tipizzata di divieti di
discriminazione. L’art. 28, 2° co., ribadisce che i sistemi di classificazione del personale ai fini della
determinazione delle retribuzioni devono adottare criteri comuni per uomini e donne ed essere
elaborati in modo da eliminare le discriminazioni. Il divieto di discriminazione colpisce sia atti
negoziali che comportamenti della vita di relazione ed ha carattere oggettivo. Non è nemmeno in
astratto necessario un effetto pregiudizievole, dovendosi ritenere ricompreso anche l’ordine di
discriminare impartito dal datore ai sottoposti. Vi è altresì il divieto di discriminazione collettiva,
dedotto indirettamente dalla norma processuale che attribuisce al consigliere di parità uno speciale
diritto di azione, diretto a reagire nei confronti di situazioni lesive le cui vittime non siano
identificabili a priori, nel caso in cui il datore abbia precostituito delle regole potenzialmente
applicabili ad una serie aperta e indeterminata di possibili destinatari. L’ambito di estensione dei
divieti ricomprende anche i rapporti di lavoro autonomo o “qualsiasi altra forma” di lavoro. Più
ampia è la nozione di “lavoratore” accolta in sede comunitaria, nel cui ambito la giurisprudenza
della Corte di giustizia tende a far capo allo status di dipendenza socio-economica della lavoratrice
autonoma. I divieti si estendono anche ai lavoratori in cerca di occupazione. Inoltre con il d.lgs. n.
145/2005 sono state introdotte le nozioni di molestia e molestia sessuale, equiparandole alle
discriminazioni. La prima avviene attraverso quei comportamenti indesiderati, aventi lo scopo o
28
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
l’effetto di violare la dignità di una persona e creare un clima intimidatorio, ostile, degradante,
umiliante e offensivo. La seconda è caratterizzata, oltre che dalla connotazione sessuale, anche dal
realizzarsi “in forma fisica, verbale o non verbale”. La sanzione è quella della nullità. Delicato è il
giudizio in ordine alla indesideratezza della molestia. Si dovrà evitare di valorizzare esclusivamente
il punto di vista soggettivo della vittima. La disciplina antidiscriminatoria si amplia con il divieto di
discriminazioni indirette. Tale nozione è stata introdotta con la legge 10/04/1991 n. 125. Secondo
l’art. 25, 2° co., del codice delle pari opportunità si ha discriminazione indiretta quando una
disposizione, un criterio, ecc., mettono i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di
particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso. Costituisce inoltre discriminazione
anche ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza nonché di maternità o
paternità ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti. Qui l’accento cade su
elementi che attengono a criteri di pre-selezione dei possibili destinatari. È utile richiamare una
vicenda di cui si è interessata anche la Corte costituzionale con una sentenza del 1993. La questione
riguardava l’applicazione di una legge della provincia autonoma di Trento che richiedeva fra i
requisiti di ammissione una statura minima non inferiore a metri 1,65, identica sia per gli uomini
che per le donne. Il requisito era da considerare essenziale, posto che il personale, anche se
destinato a carriere direttive o di concetto, avrebbe potuto essere adibito a compiti operativi. La
Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma. La previsione legislativa del requisito
minimo di statura si basa su di un erroneo presupposto di fatto, cioè “l’insussistenza di una statura
fisica mediamente differenziata tra uomo e donna” ovvero è fondata su una valutazione erronea
“concernente la supposta irrilevanza, ai fini del trattamento giuridico previsto. La disposizione
“comporta la produzione di effetti concreti più svantaggiosi per i candidati di sesso femminile.
Ipotesi che pone in luce una discriminazione indiretta a sfavore delle donne. L’art. 31, 2° co., del
codice delle pari opportunità rinvia ad un decreto della presidenza del consiglio l’individuazione
delle “mansioni e qualifiche speciali” per le quali è necessario definire un limite d’altezza per
l’accesso a cariche, professioni e impieghi pubblici. Si prevede altresì una speciale articolazione
dell’onere della prova. La prova della discriminazione incombe su chi ne invoca la sussistenza. La
legge assume che quando la lavoratrice discriminata fornisce elementi di fatto idonei a fondare la
presunzione dell’esistenza di atti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al
convenuto l’onere della prova dell’insussistenza della discriminazione. Più che inversione
dell’onere probatorio, è più corretto parlare di una sorta di attenuazione del rigore probatorio che
incombe sull’attore. È utilizzato il meccanismo delle presunzioni, di cui all’art. 2729 c.c., se pure
depurato dell’elemento della gravità, sebbene solo per imporre al convenuto l’onere di dimostrare
l’insussistenza del comportamento discriminatorio. Vi è dunque un alleggerimento della posizione
del soggetto agente, che resta comunque onerato della prova. Poi corrisponde l’onere del convenuto
di allegazione di fatti contrari alla presunzione di discriminazione. Di notevole delicatezza è il
ventaglio dei fatti suscettibili di consentire la costruzione delle presunzioni, al cui interno un ruolo
essenziale è dato alle risultanze di analisi statistiche, che appaiono inespressive di un accettabile
contenuto di credibilità, condizionate dalla situazione sociale ed economica. Il che può prestarsi ad
amplificare per il datore di lavoro le difficoltà di una prova contraria rispetto all’apparente
espressività del metodo statistico. È da chiedersi se per il datore di lavoro si ponga un problema di
giustificazione sostanziale delle scelte organizzative, ben al di là di quanto è imposto da
un’allegazione della pura economicità della scelta imprenditoriale. Sembrerebbe evocato un
controllo sull’opportunità della scelta aziendale, con la conseguente indicazione della sostanziale
insussistenza di scelte alternative.
8. Nonostante l’ampiezza della protezione garantita dalla l. n. 903/1977, i cui principi sono oggi
recepiti nel codice delle pari opportunità, anch’essa rimase largamente ineffettiva. Di qui la spinta
29
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
verso un intervento ancor più innovativo che si proponesse una strategia di promozione del lavoro
femminile. Questo obiettivo fu affidato alla legge 10/04/1991 n. 125. Il contenuto è poi confluito
nel codice delle pari opportunità. Il “programma” dell’intervento è esplicitato nell’art. 42 del
“codice”: favorire l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e
donne nel lavoro, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari
opportunità. Le prospettive più innovative sono affidate dalla legge alle “azioni positive”. Sono
iniziative a cui corrispondono le seguenti finalità: a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne
sono soggetto; b) favorire la diversificazione delle scelte professionali; c) favorire una diversa
organizzazione del lavoro, allo scopo di eliminare la diversa incidenza dell’assetto organizzativo
esistente rispetto ai due sessi; d) promuovere l’inserimento delle donne in attività nelle quali sono
sottorappresentate; e) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza
femminile. È una disciplina calibrata mediante la tecnica teleologica, che indica cioè i fini delle
condotte e non descrive il comportamento concreto. È impossibile indicare a priori in che cosa le
azioni positive possano consistere. Qualche indicazione indiretta si può dedurre dall’individuazione
dei soggetti promotori. Essi vengono indicati: a) nel Comitato Nazionale di parità e/o nei consiglieri
di parità; b) nei centri per la parità e le parità di opportunità; c) nei centri per l’impiego; d) nei datori
di lavoro privati e pubblici; e) nei centri di formazione professionale; f) nelle organizzazioni
sindacali nazionali e territoriali. Ulteriori dati ricostruttivi si traggono dall’art. 44 del “codice”, che
prevede i finanziamenti delle azioni positive. Si prevede che hanno la precedenza nell’accesso al
beneficio dei finanziamenti i progetti di azioni positive concordati dai datori di lavoro con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Merita inoltre
segnalazione il principio secondo cui per le amministrazioni pubbliche i progetti di azioni positive
costituiscono l’oggetto di un vero e proprio obbligo. Si può dedurre che le azioni positive si
realizzano mediante interventi: a) su base volontaria, b) unilaterali o c) consensuali, d) di carattere
temporaneo. È pacifico che le azioni positive costituiscano strumenti di attuazione di un diritto
diseguale. È naturale porsi l’interrogativo circa la legittimità costituzionale dell’impianto della
legge e segnatamente delle azioni positive, nelle sue connotazioni di divieto di discriminazioni
ingiustificate e di eguaglianza sostanziale. È infatti una disciplina rispetto alla quale il diritto ha una
funzione di promozione non tanto della protezione degli interessi che intende valorizzare, quanto
dello stesso comportamento degli interessati. La legittimità di una strategia di azioni positive deve
necessariamente passare attraverso il loro carattere temporaneo e perciò reversibile, volontario e
sufficientemente elastico. Peraltro una cosa è ammettere che sia legittimo costituzionalmente
prefigurare degli strumenti per l’attuazione degli obiettivi di pari opportunità, altra cosa è passare al
vaglio il singolo progetto di azione positiva. La tecnica di redazione della legge è tale che ogni
giudizio di legittimità non può che essere rinviato ad una valutazione delle forme concrete nelle
quali le azioni positive potranno essere calate. Il discorso è più comprensibile sottoponendo al
vaglio di legittimità due delle tecniche più sperimentate per la realizzazione dell’obiettivo delle pari
opportunità. Una prima tecnica consiste nello stabilire una sorta di imponibile di manodopera
femminile, imponendo l’assunzione di una certa quota di personale femminile. Una seconda tecnica
si risolve nell’introdurre un criterio di privilegio, di un individuo in quanto appartenente ad un
determinato sesso, soverchiando il giudizio di valore per merito. Su ambedue le tecniche esistono
prese di posizione che ne stigmatizzano sia l’illegittimità che la legittimità. Le varie opinioni danno
la misura di una discussione ancora aperta ad ulteriori sviluppi. Toccano infatti lo snodo cruciale
dell’opzione fra eguaglianza delle opportunità ed eguaglianza dei risultati. Un più marcato supporto
istituzionale alla promozione dell’eguaglianza in materia elettorale viene ora dalla modifica dell’art.
51, 1° co., Cost., operata con l. costituzionale n. 1/2003, alla cui stregua la repubblica è impegnata a
promuovere “con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne”. Ulteriore
30
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
argomento costituirà la previsione secondo cui, in caso di assunzioni o promozioni “a fronte di
analoga qualificazione e preparazione professionale tra canditati di sesso diverso, l’eventuale scelta
del candidato di sesso maschile” dovrà essere “accompagnata da una esplicita e adeguata
motivazione”.
9. La legge affida la propria effettività anche a tutta una serie di istituzioni della parità. In evidenza
è messo il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza di
opportunità tra lavoratori e lavoratrici. La legge del ’91 definiva meglio la funzione dei Consiglieri
di parità, già istituiti con l. 19/12/1984 n. 863. La materia è stata rivista per effetto del d.lgs. n.
196/2000 ed è ora contenuta nel codice delle pari opportunità. I Consiglieri di parità operano a
livello nazionale, regionale e provinciale e svolgono funzioni di promozione e controllo
dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini.
Interessanti e nuove sono le funzioni giurisdizionali di tale organo. Il Consigliere può non solo
prestare assistenza tecnica nella promozione delle conciliazioni, ma anche proporre ricorsi, sia su
delega delle lavoratrici interessate che per via diretta. L’azione diretta risulta come una vera e
propria azione pubblica, cui è legittimato il Consigliere territorialmente competente. La legge
prevede il possibile accesso a forme conciliative ex art. 410 cod. proc. civ., anche tramite il
Consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente. Per garantire l’apparato
dei divieti opera uno speciale strumento processuale che consente alla donna lavoratrice una
soddisfazione rapida dei propri diritti. Tale procedimento d’urgenza è stato generalizzato con l’art.
38 del “codice”. È un procedimento con cui la lavoratrice discriminata o le organizzazioni sindacali
possono adire al giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato. Il
giudice, nei due successivi giorni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina
all’autore del comportamento denunciato la cessazione del comportamento illegittimo e la
rimozione degli effetti. Si tratta di un procedimento cautelare con cui il giudice anticipa gli effetti
del provvedimento che verrà emanato nel giudizio di merito, per l’immediata soddisfazione delle
aspettative della lavoratrice discriminata. L’effettività è garantita dal riferimento ad ogni
comportamento della vita di relazione. Anche in questo caso il provvedimento del giudice può
essere oggetto, entro quindici giorni, di opposizione da parte del soccombente, davanti allo stesso
giudice, che decide con sentenza esecutiva. L’ambito di applicabilità della tutela giurisdizionale è
esteso anche contro ogni comportamento pregiudizievole posto in essere. È esteso in sostanza ai
comportamenti ritorsivi, definiti “vittimizzazione”. L’art. 37 del “codice” completa poi la
strumentazione processuale, prevedendo la possibilità di ricorsi avverso comportamenti
discriminatori di carattere collettivo. La legittimazione a ricorrere è affidata al Consigliere
regionale. Si prevede che i consiglieri di parità possano chiedere all’autore della discriminazione di
predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, entro un certo termine non
superiore a centoventi giorni. Se il piano è considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni
il relativo verbale di conciliazione acquista valore di titolo esecutivo, con decreto del giudice del
lavoro. Di rilievo è la constatazione secondo cui il giudice ordina al datore di lavoro di definire un
piano di rimozione delle discriminazioni accertate, fissandone un termine per la definizione. Il
consigliere può anche proporre la medesima azione in via d’urgenza, davanti al giudice del lavoro o
al giudice amministrativo. Con un procedimento il giudice, ove ritenga sussistente la violazione,
ordina all’autore della discriminazione la cessazione della medesima e la rimozione degli effetti, ivi
compreso un piano di rimozione delle medesime. Il decreto è opponibile con ricorso, da proporre
entro quindici giorni dalla sua comunicazione, davanti alla medesima autorità giurisdizionale, che
decide con sentenza esecutiva. L’inottemperanza alla sentenza comporta l’applicazione di
un’ammenda o dell’arresto. La violazione del divieto di discriminazione è punita anche con
sanzioni penali. Nonostante l’impotenza dell’impianto processuale restano dubbi sulla sua
31
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
effettività ed anche sulla sua giustizia sostanziale. Per il datore va constatata l’assoluta
indeterminatezza del contenuto dell’ordine giudiziale che appare in contrasto con la circostanza che
alla mancata ottemperanza dell’ordine è collegata la sanzione penale. Più producente sembra la
precostituzione di deterrenti indiretti, che tendono a dissuadere il datore di lavoro da comportamenti
discriminatori.
10. La tutela a favore dei minori ha costituito il primo nucleo della legislazione sociale fin dalla fine
del secolo scorso. Per quanto riguarda il diritto vigente occorre muovere dalla Carta costituzionale
che prevede: a) una riserva di legge per la determinazione del “limite minimo di età per il lavoro
salariato”; b) l’impegno della Repubblica alla tutela del lavoro dei minori; c) l’impegno della
Repubblica per la garanzia ai medesimi, a parità di lavoro, del diritto alla parità di retribuzione. Sul
piano delle fonti sovranazionali va ricordata la Direttiva n. 94/33 del 22/06/1994 dell’Unione
europea. A quest’ultima è stata data attuazione nel nostro ordinamento con il d.lgs. 04/08/1999 n.
345 che ha modificato la regolamentazione contenuta nella l. 17/10/1967 n. 977. Dopo aver distinto
tra bambini (minori fino a 15 anni) e adolescenti (15-18 anni), la legge fissa l’età minima di accesso
al lavoro con riferimento al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione
obbligatoria. Con la legge finanziaria per il 2007 si è previsto che la durata dell’istruzione
obbligatoria deve essere di almeno dieci anni: ne è conseguita l’elevazione a sedici anni dell’età
minima per l’accesso al lavoro. A divieto di adibizione al lavoro dei bambini fa eccezione solo il
caso dell’impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o
pubblicitario e nel settore dello spettacolo. Lo svolgimento di siffatta attività va comunque
autorizzato dalla direzione territoriale del lavoro. Molta attenzione è dedicata dalla legge alla tutela
della salute del minore nel rapporto di lavoro. È necessario che il minore sia riconosciuto idoneo
all’attività lavorativa, a seguito di esame medico, il cui esito deve essere comprovato da un apposito
certificato. L’idoneità inoltre deve permanere nel tempo. C’è poi il divieto dell’adibizione degli
adolescenti ad alcune lavorazioni particolarmente pesanti o pericolose tassativamente previste.
L’unica deroga è costituita dallo svolgimento del lavoro per indispensabili motivi didattici o di
formazione professionale e solo per il tempo strettamente necessario alla formazione. Vi è poi il
divieto di lavoro notturno, fatte salve le prestazioni artistiche, rispetto alle quali comunque il lavoro
non può protrarsi oltre le ore 24:00, con il diritto del minore a godere di un periodo di riposo di
almeno 14 ore consecutive. L’orario di lavoro per i bambini liberi da obblighi scolastici non può
superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali e per gli adolescenti le 8 ore giornaliere e le 40
settimanali. C’è altresì l’obbligo di riposi intermedi, con l’interruzione dell’attività lavorativa dopo
4 ore e mezza. Infine ai minori è assicurato un periodo di ferie non inferiore a 30 giorni annuali per
coloro che non hanno compiuto sedici anni e 20 giorni per gli ultrasedicenni.
11. Anche per i minori è sancito il diritto alla parità retributiva, “a parità di lavoro”. La differente
formulazione legislativa non è idonea a scalfire la precettività della disposizione. L’inciso “a parità
di lavoro” deve essere inteso come parità di inquadramento professionale e non di rendimento. Si
deve ora aggiungere che il diritto alla parità di retribuzione per il giovane lavoratore discende
dall’evidente collegamento fra le previsioni costituzionali dell’art. 37 e dell’art. 3, 1° co., del quale
la prima costituisce una specifica applicazione. Non è fuori luogo il richiamo al principio di non
discriminazione per giustificare l’impossibilità di attribuire ai minori una retribuzione inferiore agli
adulti: l’età infatti costituisce una delle “condizioni personali” che non devono essere fonti di
discriminazione. Ciononostante il principio di parità retributiva ha stentato ad affermarsi nella
realtà, tanto che la contrattazione collettiva, fino alla fine degli anni settanta, ha conservato tabelle
salariali differenziate per età ed età diversa per la decorrenza degli “scatti di anzianità”. Su ambedue
si è peraltro pronunciata la giurisprudenza sancendone la nullità.
32
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
Capitolo secondo: IL DATORE DI LAVORO
Sezione I: CONCETTI GENERALI
1.La figura del datore di lavoro emerge al termine di un articolato processo evolutivo. Dal punto di
vista formale la nozione coincide con quella del creditore di lavoro, che è il soggetto che trae dalla
prestazione di lavoro una utilitas. Il che corrisponde alla nozione di prestazione, la quale deve
essere suscettibile di “valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse del creditore”.
Alla stregua di quest’ultima si usa sostenere che il concetto di datore è unico e immutabile e
prescinde dalle condizioni soggettive o dalla qualificazione della persona o dall’ente che occupa
tale posizione. Si tratta di un’affermazione che anzitutto non corrisponde al diritto positivo. Inoltre
l’individuazione della nozione formale di datore di lavoro costituisce un angolo visuale troppo
ristretto e non restituisce un’immagine attenta ai profili di effettività della disciplina. Una prima
serie di distinzioni accede alla qualità del soggetto datore: un ruolo essenziale ha la distinzione fra
datori imprenditori e datori non prenditori. Può anche essere rilevante la natura dell’attività
espletata. Un esempio recente di diversificazione qualitativa del datore è costituito dalle start-up
innovative, che sono una particolare categoria di imprese, la cui definizione è rinvenibile nell’art.
25 del d.l. 18/10/2012 n. 179. Tali imprese sono caratterizzate dall’avere come oggetto sociale
esclusivo lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad
alto valore tecnologico. Rispetto ad esse il legislatore prevede, per il periodo di 4 anni dalla loro
costituzione, notevoli agevolazioni nell’assunzione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo
determinato o con somministrazione di lavoro a termine. Inoltre la legge fissa le linee essenziali del
trattamento economico, indicando anche che la retribuzione deve essere costituita da una parte fissa
e una variabile. La legge delega la contrattazione collettiva a definire “disposizioni finalizzate
all’adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up
innovative. In sostanza vi è una delega a riscrivere il diritto del lavoro adattandolo alla specificità di
tali imprese, che dovrebbero costituire una sorta di laboratorio per l’elaborazione del lavoro più
adatto alla gestione delle imprese tecnologicamente avanzate. Ci sono poi significative differenze in
ordine quantitativo fra datori che mettono in luce la rilevanza della dimensione dell’impresa nel
diritto del lavoro: essa comporta l’applicazione di discipline differenziate. Rilevante è anche il dato
della frammentazione dell’impresa. Il datore può presentarsi come un’entità unitaria o essere
inserito nell’ambito di una struttura societaria complessa, così da formare un gruppo di imprese o di
società. Sul trattamento del rapporto di lavoro influiscono le scelte organizzative dell’impresa. Il
datore può cioè organizzare la propria attività produttiva decidendo di far tutto da sé o
programmando di far fare qualcosa da altri, cioè di decentrare parte della produzione all’esterno. In
quest’ultimo caso l’ordinamento appronta una serie di garanzie per i lavoratori occupati nell’attività
decentrata. Così come predispone una disciplina speciale per l’ipotesi in cui il decentramento si
attui nella forma del lavoro a domicilio. Un limite al decentramento è costituito da un impiego
elusivo dello schermo costituito dall’impresa decentrata, allo scopo di deresponsabilizzare il datore
di lavoro committente.
2. Una prima grande distinzione passa fra datori di lavoro che svolgono un’attività imprenditoriale e
datori che non esercitano un’impresa. La distinzione ha fondamento negli artt. 2238, 2239, 2240 c.c.
e 98 disp. att. cod.civ. Quanto al rapporto di lavoro domestico l’art. 2240 c.c. ne dispone la
regolamentazione attraverso le norme del capo relativo e dalla convenzione o dagli usi. La
disciplina codicistica individua una categoria generale di datori definita per quello che non è: datori
non imprenditori; ne individua poi due categorie specifiche: il titolare dei rapporti di lavoro
domestico ed il professionista intellettuale. Torna in evidenza la scelta del codice civile di proporre
33
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
come modello preminente quello del lavoro nell’impresa. Si tratta di una scelta storica legata
all’ideologia corporativa che faceva perno sulla figura del produttore. L’unico profilo sistematico
enucleabile dalla scelta a favore della regolamentazione del lavoro nell’impresa attiene alla
valorizzazione dell’aspetto organizzativo, tipico dell’attività imprenditoriale, la quale si trasferisce
alla stessa funzione del contratto di lavoro. L’art. 2239 identifica la figura del datore non
imprenditore come qualunque soggetto che procuri ad altrui un’occasione di lavoro. La fattispecie è
caratterizzata a contrario della circostanza che il datore non sia titolare di un’attività economica
organizzata con lo scopo di trarne profitto. È la discriminante dello scopo di lucro che richiama una
delle più importanti categorie di datori non imprenditori: le organizzazioni di tendenza. Si tratta dei
“datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica,
sindacale, culturale, di istruzione o di religione/culto. Un’ulteriore definizione sta nell’art. 20 della
legge 05/08/1981 n. 416 che accomuna alle organizzazioni di tendenza i giornali e i periodici che
risultino organi di partiti, di sindacati o di enti o comunità religiose. La questione della natura del
datore di lavoro non va confusa con la diversa questione della natura del rapporto in sé e per sé. Può
accadere che il singolo svolga un’attività non in attuazione di un rapporto obbligatorio di lavoro
subordinato, ma volontariamente in adesione all’ideologia dell’organizzazione. Bisogna ricordare
che le leggi speciali prevedono regimi differenziali di trattamento per i datori di lavoro non
imprenditori. Fra questi è sufficiente ricordare l’inestensibilità dello statuto dei lavoratori a chi non
eserciti un’attività in impresa, nonché il trattamento di particolare favore ricevuto dalle
organizzazioni di tendenza in relazione alla materia dei licenziamenti.
3. Nel diritto del lavoro hanno altresì rilievo profili quantitativi dell’impresa. La legislazione
costruisce regimi differenziati a seconda della dimensione aziendale. Si può dunque assumere che il
parametro quantitativo si traduce in una diversa qualità del trattamento normativo delle varie
fattispecie. Non può peraltro assumersi che i tratti giuridici che caratterizzano la nozione di piccola
impresa presentino diversità sostanziali rispetto a quelli che caratterizzano la nozione di grande
impresa. Non può assumersi che la prima si caratterizzi per l’assenza del requisito
dell’organizzazione, elemento caratterizzante la seconda. Più corretto è ritenere che
l’organizzazione adempia a funzioni diverse nei due modelli di attività imprenditoriale. Il parametro
che il diritto usa per delimitare la dimensione aziendale è quello del numero di dipendenti. È noto
però che possono sussistere imprese che, a parità di personale occupato, hanno una ben diversa
potenzialità economica. È infatti da tempo in discussione la necessità di modificare e differenziare i
parametri di riferimento. Di rilievo è poi constatare che il dato numerico è a volte riferito all’intera
impresa, altre volte ad articolazioni minori dell’impresa: si pensi alla nozione di unità produttiva,
che allude ad articolazioni territoriali dell’impresa, dotate di autonomia organizzativa. Quest’ultimo
riferimento è maggiormente attento ai profili di effettività della disciplina. Come esempi di
disciplina differenziata in relazione alla dimensione dell’impresa è sufficiente ricordare: la
disciplina relativa all’obbligo di assunzione di soggetti appartenenti a categorie protette, quella sui
licenziamenti individuali e collettivi, quelle sulla mobilità, la cassa integrazione o sulla tutela
dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro. In tutte queste situazioni si pone il problema delle
modalità di computo dei lavoratori ai fini dell’accesso alla soglia, sia quanto alla qualità dei rapporti
di lavoro, sia quanto al periodo di tempo da prendere a base per la determinazione dell’organico
dell’impresa. Anche la contrattazione collettiva propone fonti di regolamentazione diversificate in
relazione alla dimensione ed alla qualità dell’impresa. La disparità di trattamento è sempre stata
giustificata avendo riguardo alla direttiva di contenere i costi per le imprese minori. Un’attenzione
legislativa ha sempre ricevuto l’impresa artigiana, sulla base della direttiva costituzionale di tutela e
sviluppo dell’artigianato. Allo scopo di delimitarne la nozione il legislatore post-costituzionale è
intervenuto dapprima con la legge n. 860/1956 e poi con la legge 08/08/1985 n. 443. La disciplina
34
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
ha lo scopo sia di meglio definire la potestà delle regioni in materia, sia di individuare i tratti
caratterizzanti dell’impresa artigiana.
Sezione II: LA FRAMMENTAZIONE DELL’IMPRESA
1.L’impresa non costituisce una realtà statica e spesso neanche unitaria. È una realtà soggetta a
trasformazioni. Il contratto di lavoro è attrezzato per tener dietro a tali trasformazioni riducendo i
rischi che si traducano in limitazioni e/o elusioni dei diritti dei lavoratori. Un primo ordine di
problematiche consegue alla circostanza che il datore di lavoro si organizzi in modo da realizzare il
prodotto finale completando con i propri mezzi ed al proprio interno l’intero ciclo produttivo o
decentri all’esterno una parte di esso. In quest’ultimo caso il datore stipulerà contratti di appalto o di
sub-committenza con altre parti terze o potrà ricorrere al lavoro a domicilio. Intorno alle grandi
fabbriche ruota l’”indotto” che è costituito dalle piccole e medie imprese che operano su
committenza della grande impresa. Perciò il decentramento assolve alla funzione fisiologica di
consentire un razionale impiego delle risorse ed il ricorso ad operatori specializzati per la
realizzazione di determinati prodotti. Decentrare può peraltro essere un modo per sfuggire ai
controlli ed ottenere un’illecita forma di flessibilità con il ricorso al lavoro nero. La legge fornisce
supporti diretti sia a reprimere il decentramento patologico, sia a regolare quello fisiologico,
attraverso garanzie a favore dei lavoratori impegnati in attività a favore del terzo-committente. La
complessità dell’organizzazione produttiva può poi far capo a rapporti stabili di collegamento
societario fra le imprese. La prestazione lavorativa può così svolgersi alle dipendenze di un’impresa
che opera all’interno di un più ampio gruppo ed essere destinata a favore di più soggetti. In queste
situazioni i problemi riguardano sia l’individuazione dell’effettivo datore di lavoro nell’ambito della
struttura complessa, sia la tutela del lavoratore rispetto a trasferimenti che possano celare intenti
fraudolenti. Le modificazioni strutturali possono far capo al mutamento della titolarità dell’impresa.
Sono fenomeni di sub-ingresso di un soggetto giuridico ad un altro nella gestione dell’impresa. In
tale ambito i problemi lavoristici nascono dalla necessità di tutelare l’occasione di lavoro
nell’impresa.
2. Si ha interposizione nel rapporto di lavoro quando il datore di lavoro si serve di un soggetto
interposto, il quale assume la manodopera, retribuendola direttamente e lucrando sulla differenza fra
il compenso corrispostogli dall’imprenditore per la complessiva opera pattuita e quello corrisposto
ai lavoratori. Il ricorso all’appalto di manodopera o alle “somministrazione di lavoro” altrui è una
forma distorta (ed illecita) di utilizzazione della forza-lavoro e quindi di organizzazione della
produzione. Tale forma consente all’imprenditore di utilizzare i lavoratori come “dipendenti” senza
assumere la veste di datore di lavoro. La circostanza che tali lavoratori operino come “dipendenti”
dell’utilizzatore conferma i nessi fra il tema dell’inter-posizione e quello della subordinazione. Il
primo ed unico intervento normativo in materia di repressione delle interposizioni nei rapporti di
lavoro è stato la legge 23/10/1960 n. 1369. Esso perseguiva due obiettivi: uno repressivo nei
confronti delle forme illecite di interposizione nei rapporti di lavoro; un altro regolatore nei
confronti di forme contrattuali lecite, ma caratterizzate dalla particolarità dell’opera convenuta,
destinata ad integrare il “ciclo produttivo” del committente. All’attivazione dei meccanismi di
illecita interposizione, corrispondeva la costituzione, sul piano civilistico, di un rapporto di lavoro
diretto fra i lavoratori assunti dall’interposto ed il datore di lavoro che ne avesse “effettivamente
utilizzato” le prestazioni. Nel caso invece del contratto di appalto di opere e servizi da svolgersi
all’interno dell’azienda del committente si aveva un arricchimento delle garanzie a favore dei
lavoratori dipendenti dall’appaltatore, prevedendosi l’estensione dell’obbligo retributivo anche nei
confronti del datore di lavoro committente ed altresì la garanzia di un trattamento economico e
35
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
normativo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti dal committente. Il fulcro della disciplina
era costituito dalla nozione di appalto di manodopera. L’art. 1 vietava all’imprenditore: a) di
affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, l’esecuzione di mere prestazioni di
lavoro mediante l’impiego di manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore; b) di affidare ad
intermediari lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori assunti e retribuiti da tali intermediari. Si
considerava “appalto di mere prestazioni di lavoro” ogni forma di appalto o subappalto in cui
l’appaltatore impiegasse capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante, quand’anche per
il loro impiego venisse corrisposto un compenso all’interponente. La legge confermava la
confluenza del tema dell’interposizione con quello della subordinazione, consolidando il principio
secondo cui il soggetto che trae giovamento dalla prestazione di lavoro ne è nei fatti il datore di
lavoro. La questione dell’abrogazione o della modificazione della legge n. 1369/1960 è stata
oggetto di dibattito già poco più di dieci anni dopo la sua emanazione e si sono susseguite varie
proposte di legge, ispirate a linee di politica del diritto non sempre coincidenti. Negli anni settanta
prevalevano proposte di modifica dirette ad inasprire più che ad allentare i divieti legali. Negli anni
ottanta il perno dell’interesse si sposta e la possibilità di derogare al divieto di rapporti interpositori
si inserisce in un più ampio disegno di flessibilizzazione dell’impiego del lavoro. È lo stesso
governo che fa proprio tale disegno, con la finalità di ottenere uno scambio fra lavoro flessibile e
maggiore occupazione o di garantire un recupero di fasce di lavoratori marginali o sommersi. Fra le
iniziative governative si ricorda il Progetto De Michelis del 1986 che ebbe anche un breve periodo
di vigenza legislativa. La discussione trovò una prima realizzazione legislativa nell’ambito della l.
n. 196/1997 (Pacchetto Treu). La legge introdusse la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro
temporaneo (interinale). I lavoratori erano assunti da speciali Agenzie ed inviati a svolgere la loro
prestazione di lavoro presso le imprese che ne avessero fatto richiesta. Per la durata del rapporto,
necessariamente a termine, i lavoratori rimanevano formalmente dipendenti dell’agenzia, anche se
di fatto si inserivano a tutto tondo entro l’organizzazione dell’impresa utilizzatrice. La legge del
1997 mimava in positivo, quanto la legge del ’60 descriveva in negativo come disvalore. Si trattava
cioè di una interposizione lecita, la cui regolamentazione era scindibile negli stessi tre elementi che
costituivano il tessuto della legge 1369/60: a) contratto fra soggetto interposto e lavoratori; b)
contratto fra soggetto interposto e utilizzatore; c) prestazione di lavoro resa a favore
dell’utilizzatore. Il fulcro della finalità di favorire l’occupazione era la temporaneità della
somministrazione che impediva che l’impresa potesse avvalersi stabilmente di lavoratori che non
fossero dipendenti diretti. La legge sanciva il ritorno all’applicazione della legge del ’60 tutte le
volte in cui vi fosse una mancata corrispondenza alle legittime ipotesi di costituzione di un rapporto
di lavoro temporaneo. In tali situazioni i lavoratori venivano considerati alle dirette dipendenze del
datore di lavoro “effettivo utilizzatore”. È con il d.lgs. n. 276/2003 che giunge al tramonto la legge
del 1960, la quale viene sottoposta ad abrogazione. L’abrogazione si inserisce in un disegno di
consolidamento delle ipotesi di ricorso alla somministrazione di lavoro da parte delle agenzie
autorizzate. Attualmente la somministrazione è regolata dagli artt. da 30 a 40 del d.lgs. n. 81/2015.
Se è vero che il legislatore ha introdotto una nuova ipotesi di somministrazione lecita della
manodopera, la deviazione da tale schema non potrà che condurre alla caducazione dello “schermo”
costituito dall’interposto per ricollegare i rapporti di lavoro direttamente in capo all’interponente.
La regolazione normativa della somministrazione lecita comporta logicamente il suo rovescio:
l’interposizione illecita, posta in essere al di fuori del circuito autorizzato e controllato dalla legge.
In tal caso si ripropone la necessaria confluenza delle problematiche innescate dai fenomeni
interpositori con la fattispecie della subordinazione, che comporta che il soggetto che utilizza le
prestazioni di lavoro altrui, ne è inequivocabilmente il datore di lavoro. Ad onta dell’abrogazione
della legge del ’60 quindi è ancora vigente nell’ordinamento la direttiva generale secondo cui sono
36
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
vietate forme di organizzazione del lavoro in cui l’effettivo utilizzatore della prestazione non
coincida con il titolare del rapporto di lavoro. Gli argomenti logico-sistematici sono poi confermati
dal lato testuale del d.lgs. n. 81/2015 che prefigura la somministrazione irregolare, ricollegando ad
essa il diritto del lavoratore di pretendere la costituzione di un rapporto di lavoro diretto alle
dipendenze dell’utilizzatore. La medesima conclusione è prefigurata dal d.lgs. n. 276/2003 per
l’appalto dall’art. 29 co. 3-bis e per il distacco dall’art. 30 co. 4-bis, quando essi siano stipulati “in
violazione” delle previsioni che ne circoscrivono l’ambito definitorio. All’interno dell’ordinamento
è ancora codificato il principio della illiceità dei rapporti interpositori, che non siano attuati secondo
la tecnica dell’interposizione autorizzata. Resta solo da verificare quale sia la definizione
interposizione illecita. Nel precedente assetto tale definizione risultava dall’art. 1 della l. n.
1369/1960 che assumeva l’interposizione vietata nei casi in cui l’imprenditore committente avesse
affidato “in appalto, subappalto o in qualsiasi altra forma” ad un soggetto interposto l’“esecuzione
di mere prestazioni di lavoro”. Il legislatore intendeva alludere all’assenza, in capo all’interposto,
dei mezzi di produzione, quale indizio dell’insussistenza della capacità imprenditoriale necessaria
per il compimento dell’opera o servizio convenuti. Si aveva appalto di manodopera nel caso in cui il
soggetto incaricato dell’opera o del servizio non avesse avuto la capacità imprenditoriale necessaria
per eseguirlo: non fosse stato cioè un imprenditore. Per l’identificazione della qualità
imprenditoriale era rilevante l’accertamento dell’insussistenza del rischio d’impresa. Tale assunto
era stato oggetto di un progressivo affinamento ed aggiornamento. In una prima direzione erano
stati rivisitati i criteri di identificazione della nozione di capitali, macchine ed attrezzature e quindi
dei tratti identificativi del concetto di impresa. In una seconda direzione era stata riconosciuta la
qualità imprenditoriale a quei soggetti il cui apporto si limitava alla semplice organizzazione del
lavoro altrui. La giurisprudenza escludeva la sussistenza di un’interposizione vietata nei casi in cui
il soggetto interposto esercitasse anche solo i caratteristici poteri datoriali diretti ad organizzarne
l’attività. L’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 ha codificato i criteri distintivi fra interposizione (illecita)
ed appalto (lecito). Il discrimine continua ad essere costituito: a) dall’“organizzazione dei mezzi
necessari da parte dell’appaltatore” e b) dall’“assunzione da parte del medesimo del rischio
d’impresa”. L’idea secondo cui può esservi impresa genuina anche in assenza di complessi elementi
materiali e sulla base della sola “organizzazione del lavoro altrui” si è trasferita sul piano
normativo. Il legislatore nel 2011 ha introdotto una nuova norma incriminatrice penale che punisce
l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro.
3. La legge n. 1369/1960 conteneva all’art. 3 una disciplina con cui venivano regolate legittime
ipotesi di contratti d’appalto. La peculiarità di questi contratti stava nel fatto che oggetto ne era
l’esecuzione di opere o servizi, da svolgersi “all’interno dell’azienda” del committente. Secondo la
lettura accreditata, con “all’interno dell’azienda”, la legge intendeva riferirsi al concetto di ciclo
produttivo dell’impresa committente. Rientravano quindi tutte le forme di appalto in cui
l’imprenditore decentrava a terzi la realizzazione di una fase, anche sussidiaria o accessoria, del
ciclo normale della produzione. Ne consegue che la disciplina era applicabile anche quando si
trattava di attività che si svolgevano in luoghi fisicamente lontani dallo stabilimento della
committente. Si prevedeva, a tal fine, l’obbligo di garantire solidalmente con l’appaltatore ai
lavoratori dipendenti da quest’ultimo un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare
un trattamento normativo non inferiore a quelli applicati ai lavoratori da loro dipendenti. Era
dunque sancita una sorta di parità di trattamento fra dipendenti del committente e dipendenti
dell’appaltatore. I committenti erano inoltre tenuti in solido con l’appaltatore all’adempimento di
tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza. Il d.lgs. n. 276/2003 ha abrogato
la l. n. 1369/1960, ed ha sostituito la disciplina con una nuova regolamentazione, riduttiva rispetto
al passato. La norma di riferimento è l’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, che è stato più volte ritoccato.
37
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
L’attuale testo dell’art. 29 è il risultato di ulteriori modifiche introdotte dalla riforma Monti.
Secondo la nuova disciplina appaltante ed appaltatore sono solidalmente obbligati nei confronti dei
dipendenti dell’appaltatore per il trattamento dovuto a questi ultimi. Resta escluso per il
committente qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile
dell’inadempimento. È un allargamento della tutela generale prevista dall’art. 1676 c.c. Tale norma,
applicabile ad ogni specie di appalto, dà diritto ai dipendenti dell’appaltatore di proporre azione
diretta nei confronti del committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del
debito che il committente ha verso l’appaltatore. La tutela è estesa al trattamento retributivo e
contributivo effettivamente dovuto. È quindi superato l’assetto precedente che estendeva ai
dipendenti dell’appaltatore il trattamento dei dipendenti dell’appaltante ed il ruolo di quest’ultimo è
limitato ad una garanzia esterna del debito contratto dall’appaltatore. L’obbligazione solidale si
estende anche agli eventuali subappaltatori. Il committente risponde quindi solidalmente delle
obbligazioni assunte da tutta la filiera organizzativa. La pretesa è esigibile entro il termine di
decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto. L’unica eccezione è prefigurata con riferimento
al committente che sia “persona fisica che non esercita attività d’impresa o professionale”.
L’eccezione si spiega con lo scopo di non aggravare di costi sproporzionati i committenti-persone
fisiche, che solo occasionalmente si avvalgono dell’opera di appaltatori. La disciplina è derogabile,
posto che i contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori e dei lavoratori
possono disporre “diversamente” ed altresì “individuare metodi e procedure di controllo e di
verifica della regolarità complessiva degli appalti”. Sul piano processuale, con la riforma Monti, è
stato introdotto un temperamento al rigore dell’obbligazione solidale prevedendosi che il lavoratore
deve convenire in giudizio sia il committente che il proprio datore di lavoro-appaltatore, con una
sorta di litisconsorzio necessario ex lege, e in tale sede il committente può eccepire il beneficio
della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. A tali
innovazioni vanno poi sommate quelle nell’art. 35, 28° co., del d.l. 04/07/2006 n. 223 che ha esteso
il regime di responsabilità solidale anche al versamento delle ritenute fiscali e del versamento
dell’IVA sui redditi dei dipendenti di appaltatori e subappaltatori, se pure “nei limiti dell’ammontare
del corrispettivo dovuto”. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino
all’esibizione della documentazione da parte dell’appaltatore. L’ordinamento prefigura poi una
disciplina specifica a favore dei dipendenti di taluni appaltatori: cioè dipendenti da appaltatori di
opere pubbliche. L’art. 36 dello statuto dei lavoratori prevede che nei capitolati di appalto attinenti
all’esecuzione di opere pubbliche deve essere inserita la “clausola a favore dei lavoratori”,
determinante l’obbligo per l’appaltatore di applicare o far applicare nei confronti dei dipendenti
condizioni non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della
zona. La medesima disciplina si estende inoltre ai provvedimenti di concessione di benefici
accordati dalla legge a favore di imprenditori che esercitino un’attività economica organizzata.
L’omessa osservanza della disposizione è sanzionata con la risoluzione per inadempimento del
contratto di appalto, nel caso di appaltatori di opere pubbliche, e con la revoca dei benefici, nel caso
degli imprenditori. L’ordinamento appronta anche una forma di protezione anche alla piccola
impresa in sé. Il presupposto da cui muove è quello di considerare che se la piccola impresa opera
prevalentemente per un unico committente, si trova più facilmente esposta al rischio della perdita
delle occasioni di lavoro. Con la legge n. 192/1998 è stata introdotta una forma di tutela a favore
delle piccole imprese subfornitrici che forniscono prodotti o servizi “destinati ad essere incorporati
o ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un
bene complesso”, così dando rilievo ad una situazione di sostanziale dipendenza economica della
piccola impresa.
38
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
4. Il lavoro a domicilio ha costituito una delle prime forme di utilizzazione dei lavoratori
nell’ambito del processo produttivo industriale. Un accenno ne venne fatto nell’ambito della Carta
del lavoro del 1927 che stabilì il principio secondo cui speciali norme sarebbero state emanate per
assicurare la pulizia e l’igiene del lavoro a domicilio. Il codice civile, riguardo ciò, contiene una
sola norma, l’art. 2128, che estende ai prestatori di lavoro a domicilio le disposizioni della Sezione
III del Titolo II del Libro V, a condizioni di compatibilità con la specialità del rapporto. La prima
regolamentazione completa deve farsi risalire alla legge 13/03/1958 n. 264. Con essa venne
prefigurato l’impianto di tutela del lavoratore a domicilio, consistente nel controllo pubblico
dell’offerta e della domanda, nella costituzione di entità adibite alla vigilanza, nella determinazione
del trattamento spettante al lavoratore. Solo nel regolamento attuativo, approvato con d.p.r.
16/12/1959 n. 1289, si prevedeva che la subordinazione potesse anche avere carattere “tecnico” e
non inteso nel senso stretto di cui all’art. 2094 c.c. La giurisprudenza fu indotta ad escludere la
natura subordinata del rapporto in assenza dei requisiti della subordinazione in senso “forte”.
L’ultimo co. dell’art. 1 della legge escludeva la configurabilità del lavoro a domicilio nel caso in cui
il lavoratore fosse iscritto all’albo delle imprese artigiane. Si giunge così alla vigente
regolamentazione contenuta nella legge 18/12/1973 n. 877. Se ne deduce che è lavoratore a
domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue, nel proprio domicilio o in locale di cui
si abbia a disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a
carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di
uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso
imprenditore. La legge prende in considerazione il fenomeno del lavoro a domicilio industriale. È
quindi lavorante a domicilio colui che opera a favore di uno o più imprenditori e non direttamente
per il mercato. Spicca inoltre il tratto “sociale” del lavoro a domicilio che evoca la collaborazione
anche dell’attività dei familiari. Si tratta di un’eccezione al principio della personalità della
prestazione lavorativa. L’art. 1 della legge del 1973 prevede, inoltre, quanto all’impiego di materiali
ed attrezzature, che essi possano essere indifferentemente di proprietà del lavorante, di proprietà
dell’imprenditore committente o in comproprietà. Il problema cruciale è quello della qualificazione
giuridica della posizione del lavoratore, alla luce del dato della subordinazione. È evidente che
manca il controllo sulla persona del lavorante e subiscono modificazioni ed adattamenti l’esercizio
del potere direttivo, la determinazione del sistema retributivo, etc. Un contributo per la questione
viene dal testo dell’art. 1, 2° co., della legge del 1973, secondo cui “la subordinazione, agli effetti
della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall’art. 2094 c.c., ricorre quando il lavoratore a
domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione”. La
previsione ha carattere definitorio, nel senso che delimita l’ambito soggettivo entro il quale la
disciplina risulta applicabile. Il legislatore mostra di considerare il lavoro a domicilio come un
rapporto di lavoro subordinato, se pure speciale, seguendo le direttive generali segnate dall’art.
2128 c.c. La specialità e la deroga all’art. 2094 c.c. discendono dal particolare contesto in cui si
svolge la prestazione ed influenzano decisivamente il trattamento del lavorante. Strutturalmente il
lavoro a domicilio è una species del genus lavoro subordinato. La direttiva segnata dalla deroga
all’art. 2094 c.c. si iscrive in un contesto di ulteriore rafforzamento di garanzie a favore del lavoro a
domicilio. È una sorta di norma di chiusura, da cui dedurre che la prestazione non può essere
qualificata di lavoro autonomo, ma va considerata subordinata, anche se non si svolge all’interno
dell’impresa. La deroga ha poi carattere elastico, nel senso che ogni deviazione rispetto alla
definizione normativa, comporta il ritorno alla qualificazione della fattispecie come rapporto di
lavoro “interno”. Il 3° co. dell’art. 1 conferma tale direttiva dal momento che stabilisce che “non è
lavoratore a domicilio chiunque esegue lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore”.
Nella medesima chiave la legge predispone una serie di divieti diretti nei confronti del lavoro a
39
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
domicilio patologico o fraudolento. Vieta alle imprese interessate da programmi di ristrutturazione e
di conversione di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno dall’ultimo provvedimento di
licenziamento o dalla cessazione delle sospensioni. È evidente l’intenzione di prevenire e reprimere
le situazioni di smantellamento di reparti dell’impresa, finalizzate a proseguire all’esterno l’attività.
C’è inoltre divieto ai committenti di lavoro a domicilio di avvalersi dell’opera di intermediari, che
vengono considerati alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell’interesse del quale hanno
svolto la loro attività. Infine di rilievo è il divieto di lavoro a domicilio per attività le quali
comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l’incolumità del
lavoratore e dei suoi familiari. La violazione della norma comporta la nullità del rapporto di lavoro
a domicilio e, in applicazione dei principi di cui all’art. 2126 c.c., l’eliminazione dei tratti di
“specialità” con la costituzione di un rapporto di lavoro interno con il committente. Il sistema dei
controlli pubblicistici sul lavoro a domicilio contempla la cura dell’incontro tra domanda e offerta
di lavoro. A tale scopo sono istituiti i “registri dei committenti” ed i “registri dei lavoratori a
domicilio”, cui i datori ed i lavoranti devono essere obbligatoriamente iscritti. Inoltre sono istituite
commissioni, a vari livelli, per il controllo del lavoro a domicilio. Il lavorante a domicilio deve
essere retribuito secondo il sistema del cottimo pieno e le tariffe sono determinate da una
commissione a livello regionale composta di otto membri, nominati dal direttore della direzione
regionale del lavoro su indicazione delle rispettive associazioni sindacali maggiormente
rappresentative. Presiede la commissione il capo dell’Ispettorato regionale del lavoro, senza diritto
di voto. Il lavoratore a domicilio deve rispettare l’obbligo di diligenza ed attenersi alle istruzioni del
committente. Deve custodire il segreto sui modelli di lavoro e non può svolgere attività in
concorrenza con il datore, quando quest’ultimo gli affidi una quantità di lavoro tale da procurargli
una prestazione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro del settore. Deve inoltre
essere munito di uno speciale “libretto di controllo”, in cui devono essere annotate le coordinate
delle varie commesse ricevute. Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme in materia di
assicurazioni sociali, eccezion fatta per quelle in materia di integrazione salariale. L’applicazione
della disciplina limitativa dei licenziamenti è disturbata dalle peculiari modalità di esecuzione del
rapporto. Nel lavoro a domicilio, in materia di licenziamento, al datore è sufficiente un
comportamento meramente passivo, consistente nell’interruzione delle commesse di lavoro. La
versione post-moderna dell’arcaico lavoro a domicilio è il telelavoro. Il fenomeno nasconde peraltro
una realtà assai più complessa. Su di esso sono riposte molte aspettative, fra le quali: la
flessibilizzazione del lavoro, la costruzione di percorsi individuali nei confronti dell’attività di
lavoro e la sdrammatizzazione dei problemi del traffico nei grandi centri urbani. Una definizione di
telelavoro fa riferimento all’attività lavorativa svolta al di fuori dello spazio fisico dell’impresa con
l’impiego di strumenti telematici. Può essere qualificato fra le specie del lavoro autonomo, del
lavoro para-subordinato, del lavoro a domicilio o del lavoro subordinato tout court. Peraltro
l’applicazione degli schemi più propriamente lavoristici richiede notevoli sforzi di adattamento
della disciplina. È anche per questa ragione che sono stati presentati progetti di legge diretti alla
regolamentazione del fenomeno, mentre la contrattazione collettiva ne ha proposto varie tipologie.
L’importanza crescente del fenomeno ha determinato le parti sociali a livello europeo a stipulare un
accordo quadro sul telelavoro (16/07/2002) cui è stata data attuazione in Italia con l’accordo
interconfederale del 09/06/2004. Un riferimento indiretto è contenuto nell’art. 115, 1° co., del d.lgs.
196/2003, laddove si impone al datore di lavoro il rispetto della “personalità e della libertà morale”
del telelavoratore. Un incentivo al ricorso al telelavoro, allo scopo di agevolare la conciliazione dei
tempi di vita e lavoro, è contenuto nell’art. 23 del d.lgs. n. 80/2015, secondo cui i datori privati che
ricorrano al telelavoro possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti
numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti.
40
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
I problemi appena accennati sono poi amplificati in relazione all’estensione del telelavoro al
pubblico impiego. La necessità di una regolamentazione ad hoc è imposta dalla circostanza che il
telelavoro comporta una revisione ed omogeneizzazione delle procedure amministrative. Per tali
ragioni esiste un’apposita disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni.
5. L’economia contemporanea propone l’esistenza di nessi di collegamento fra imprese. Si parla di
“imprese di gruppo” o “gruppi d’imprese”, che gestiscono un’attività economica organizzata. I tratti
di connessione si presentano in varie forme: il controllo di un’impresa su un’altra, che può dare
luogo ad un rapporto di affiliazione; il collegamento fra società attuato nella forma della “catena” o
del “sistema stellare”. Assai spesso le società capo-gruppo sono delle holding, che sono imprese il
cui oggetto sociale è costituito dalla partecipazione ad altre società. Le descritte forme organizzative
assolvono la funzione classica di realizzare la scissione fra potere e rischio, ma anche di rendere più
agile l’apparato funzionale dell’impresa. L’impiego del lavoratore nel contesto dei gruppi societari
può dar luogo a vari fenomeni, riconducibili a due schemi-base: a) il lavoratore può operare
alternativamente per varie imprese del gruppo; b) il lavoratore può svolgere la propria attività
cumulativamente a favore di più società del gruppo. La prima ipotesi a sua volta può contemplare
due sotto-insiemi: a1) il lavoratore può essere inviato temporaneamente a svolgere la propria a
favore della collegata (ipotesi del comando o distacco) o a2) il lavoratore può essere destinato
stabilmente a prestare attività a favore di un’altra impresa del gruppo, la quale subentra a pieno
titolo nella titolarità del rapporto di lavoro. Il problema di fondo è quello di evitare che il lavoratore,
attraverso gli spostamenti, possa perdere le tutele approntate dal diritto del lavoro. Prima di
verificare attraverso quali parametri giuridici il diritto del lavoro può governare i descritti fenomeni,
occorre scartare la soluzione più facile e suggestiva: quella di considerare che datore di lavoro possa
essere il gruppo societario. Nessuna disposizione ci autorizza a ritenere che sia costruibile una sorta
di soggettività unitaria dell’ambito di più imprese fra loro collegate e ciò anche se il legislatore ha
dimostrato un certo attivismo nella regolazione dei profili “giuscommercialistici” del fenomeno. La
medesima finalità hanno anche le norme giuslavoristiche che hanno evocato i gruppi di impresa e/o
i fenomeni di collegamento o controllo fra le società. È dunque corretto il punto di vista secondo cui
le varie società conservano la propria autonomia giuridica, rimanendo titolari dei rapporti giuridici
che alle medesime fanno capo. Tale acquisizione è confermata indirettamente dall’art. 31 del d.lgs.
n. 276/2003, che consente ai “gruppi di impresa individuati ai sensi dell’art. 2359 c.c. e del d.lgs.
02/04/2002 n. 74” di delegare lo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro e previdenza
alla società capogruppo per tutte le società controllate. Siffatta delega di funzioni non rileva ai fini
dell’“individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle
singole società datrici di lavoro”: cioè la delega di funzioni non trasferisce al “gruppo” la titolarità
dei rapporti di lavoro delle singole società. A fronte della giurisprudenza di legittimità, quella di
merito è invece ispirata a maggiore empirismo ricorrendo ad indici vari, quali l’interscambiabilità
del personale, l’utilizzazione del medesimo immobile, la coincidenza degli
amministratori/proprietari, etc. Si tratta però di un atteggiamento pericoloso perché rischia di
criminalizzare il fenomeno del collegamento societario. In realtà l’ordinamento lavoristico fornisce
già gli elementi per discernere un impiego patologico dell’impresa di un gruppo da un impiego
fisiologico. Un ruolo essenziale svolge il divieto di rapporti interpositori, che esprime la direttiva
secondo cui il datore di lavoro è “l’effettivo utilizzatore” della prestazione e dunque costituisce un
utile punto di riferimento normativo per selezionare l’organismo imprenditoriale cui ricondurre la
titolarità del rapporto. Un impiego fisiologico della prestazione lavorativa all’interno del gruppo
può porre vari problemi in relazione alle due ipotesi-tipo che abbiamo ricordato. Nel caso di
prestazione alternativa viene in evidenza la figura del “comando” o “distacco”. È un istituto con cui
il lavoratore viene trasferito a prestare attività a favore di un’impresa terza, permanendo inoltre la
41
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
titolarità del rapporto in capo al datore distaccante. L’istituto del comando è materia di discussione,
con riferimento ai suoi snodi di fondo: la sua configurazione giuridica, nella prospettiva della
verifica dell’esistenza di un potere del creditore di lavoro di destinare la prestazione del debitore a
favore di un terzo, la compatibilità con il divieto di interposizione nei rapporti di lavoro nonché con
la disciplina del trasferimento. La giurisprudenza ne ha ammesso sì la compatibilità con
l’ordinamento, ma ne ha condizionato la legittimità ad alcuni presupposti che consentivano di
escludere la realizzazione di un’illecita interposizione. Ha ritenuto necessaria la temporaneità dello
spostamento, in quanto tale idonea ad escludere una forma di affitto della forza-lavoro. Ha altresì
evocato la necessità di un “interesse” del distaccante all’effettuazione del comando. L’adempimento
della prestazione a favore del terzo deve sempre e comunque soddisfare un interesse del creditore di
lavoro. È solo con l’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 che viene introdotta una disciplina di portata
generale che fissa i presupposti di legittimità del distacco. Viene configurato con riferimento
all’ipotesi in cui “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente
uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività
lavorativa”. La disciplina dettata dal d.lgs. n. 276/2003 codifica gli elementi già valorizzati dalla
giurisprudenza. L’istituto del distacco è legittimato anche al di fuori di un’organizzazione
imprenditoriale. Ulteriori limitazioni sono richiamate con riferimento a particolari specie di
distacco. In primo luogo il distacco che comporti mutamento di mansioni è soggetto al consenso del
lavoratore interessato. Il che consente di acquisire che il distacco, in tutte le altre situazioni,
costituisce una legittima forma di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro che non richiede
il consenso del distaccato. Quando il distacco implica un trasferimento ad un’unità produttiva
situata ad oltre 50km dall’originaria sede di lavoro, il medesimo può avvenire solo in presenza di
una giustificazione obiettiva. Rilevante è l’innovazione introdotta con il decreto correttivo del d.lgs.
n. 276/2003 che ha aggiunto un co. 4-bis all’art. 30 del decreto originario. Il legislatore rende ora
esplicita la sanzione del distacco illegittimo, quando il distacco avvenga “in violazione del disposto
di cui al primo comma” dell’art. 30 il lavoratore ha titolo per pretendere la costituzione di un
rapporto di lavoro diretto in capo al soggetto “che ne ha utilizzato la prestazione”. Anche il distacco
illegittimo entra nel novero degli schemi elusivi del divieto di interposizione e ad esso sono
riconnesse le medesime conseguenze della somministrazione irregolare. In una prospettiva più
ampia il fenomeno del distacco “nel quadro di una prestazione di servizi transnazionale” è stato
preso in considerazione a livello europeo, con la Direttiva 16/12/1996 n. 71, che ha lo scopo di
rafforzare la protezione del lavoratore. Ne è stata data attuazione nel nostro ordinamento con il
d.lgs. 25/02/2000 n. 72, il quale trova applicazione nel caso di distacco di un lavoratore presso
un’unità produttiva di un’impresa “transnazionale” che opera in Italia o presso un’impresa
appartenente al medesimo gruppo della distaccante. La disciplina garantisce la parità di trattamento
fra il lavoratore distaccato ed i dipendenti dell’impresa presso cui opera. La formulazione di tali
principi è in tutto identica alle previsioni degli ormai abrogati artt. 3 e 4 della l. n. 1369/1960. Il che
dà la misura di come la disciplina si muova sulla lunghezza d’onda anti-elusiva. Infine la legge
prevede che il lavoratore distaccato in Italia possa far valere i propri diritti anche davanti all’autorità
giudiziaria di altro Stato con cui l’Italia abbia stipulato una convenzione internazionale in tema di
giurisdizione di rapporti di lavoro. Nel caso in cui invece opti per la giurisdizione italiana era
previsto l’esonero dal previo tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. Il lavoratore può poi
svolgere la propria attività cumulativamente a favore di più società del gruppo. Di recente viene
spesso evocata l’espressione “codatorialità”: è un’espressione polisenso che può essere o
semplicemente descrittiva di un concorso fra datori di lavoro di determinate obbligazioni, o avere
un significato prescrittivo. Per tale, ultima, prospettiva, è però necessario rivisitare ab imis l’idea
stessa di subordinazione nonché i criteri di imputazione del rapporto di lavoro non più ad un datore
42
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
ma ad un’entità unica che li dovrebbe accumunare. Recentemente però la codatorialità ha ricevuto
una sponda legislativa per effetto della legge n. 99/2013 che ha introdotto un nuovo comma 4-ter
all’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, relativo all’istituto del distacco: se quest’ultimo ha luogo fra
imprese che abbiano sottoscritto un “contratto di rete” non solo l’interesse della parte distaccante
sorge automaticamente, ma per le medesime imprese “è ammessa la codatorialità dei dipendenti
ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete”.
Sezione III: LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TRAMITE AGENZIA
1.La possibilità per le imprese di ricorrere a prestazioni di lavoro da parte di dipendenti di speciali
agenzie è stata introdotta nel nostro ordinamento nell’ambito di quelle misure di intervento sul
mercato del lavoro definite “Pacchetto Treu”. Successivamente la materia è stata rivisitata con gli
artt. da 20 a 28 del d.lgs. 10/09/2003 n. 276, che ricalcava la precedente disciplina, con un’unica
innovazione: l’introduzione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, nota con
l’espressione di staff leasing. Attraverso tale tecnica diveniva possibile accreditare una permanente
scissione fra titolarità del rapporto ed utilizzazione della prestazione. Attualmente la materia è
regolata dal d.lgs. n. 81/2015 agli artt. da 30 a 40, essendo state abrogate le omologhe disposizioni
del d.lgs. n. 276/2003. L’articolazione strutturale del meccanismo di operatività del sistema è
rimasta immutata. Si può continuare a descriverlo prendendo in considerazione: a) la struttura ed il
ruolo delle agenzie; b) il contratto fra agenzia ed utilizzatore; c) il contratto di lavoro fra agenzia e
lavoratore; d) l’utilizzazione del lavoratore da parte dell’impresa; e) l’apparato sanzionatorio.
2. Per quanto riguarda le agenzie per la fornitura di lavoro temporaneo, l’idea di fondo è quella di
consentire la formazione di una imprenditorialità sana, filtrata dal controllo della pubblica
amministrazione. Si stabilisce che l’attività di somministrazione di lavoro può essere esercitata
soltanto da agenzie iscritte in un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro. L’art. 4 del
d.lgs. n. 276/2003 articola in cinque sezioni l’albo delle agenzie a seconda delle funzioni che esse
devono esercitare: 1) agenzie per promiscue o generaliste; 2) agenzie per la somministrazione a
tempo indeterminato; 3) agenzie di intermediazione; 4) agenzie di ricerca e selezione del personale;
5) agenzie di supporto alla ricollocazione del personale. La legge poi prevede una serie di requisiti
per l’esercizio dell’attività di somministrazione di lavoro. Inoltre specifici requisiti di affidabilità
devono possedere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i
soci accomandatari. Il potere di accertamento e vigilanza sulla sussistenza dei requisiti è affidato al
Ministero del lavoro. Ad esso è collegato l’obbligo strumentale delle società di comunicare
all’autorità concedente gli spostamenti di sede, l’apertura delle filiali, la cessazione dell’attività e di
fornire tutte le informazioni richieste. Per semplificare l’attività di controllo, si prevede che le
agenzie “polifunzionali” debbano organizzarsi con “distinte divisioni operative”. La legge esclude
che l’autorizzazione possa essere oggetto di “transazione commerciale”. Il divieto intende impedire
che l’autorizzazione circoli e sia trasmissibile fra varie società. Poiché esclude la circolazione
dell’autorizzazione non può che vietare altresì l’affidamento a terzi dell’attività autorizzata.
L’insieme dei requisiti e delle condizioni richieste sono mutuati dalla precedente disciplina del
lavoro temporaneo. L’innovazione più significativa è costituita dalla previsione secondo cui le
agenzie non sono obbligate ad avere come oggetto sociale esclusivo l’attività di somministrazione.
3. La chiave di volta è costituita dal contratto per la somministrazione di lavoro, che si costituisce
fra l’agenzia e l’utilizzatore del lavoro. Esso è definito dall’art. 30 del d.lgs. n. 81/2015 come il
contratto con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata “mette a disposizione di un
utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali svolgono la propria attività nell’interesse e
sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore”. È un contratto tipico, di cui la disciplina legale ci
43
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
fornisce le coordinate, autorizzando una scissione fra titolarità del rapporto e destinazione della
prestazione di lavoro che è diretta a favore dell’utilizzatore. Non è sovrapponibile ad alcuno schema
negoziale già conosciuto. La causa del contratto di fornitura è diretta a favorire la soddisfazione di
esigenze di flessibilizzazione dell’utilizzatore, attraverso l’acquisizione delle energie lavorative,
senza l’assunzione formale della veste di datore del lavoro. Sia la somministrazione a termine che
quella a tempo indeterminato sono a-causali, nel senso che non devono essere stipulate in presenza
di specifiche ragioni giustificative. Ambedue incontrano però limiti quantitativi. Il numero dei
lavoratori somministrati a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al primo gennaio dell’anno di stipulazione del
contratto. La legge prevede inoltre che ad un contratto di somministrazione a tempo indeterminato
deve corrispondere un’assunzione a tempo indeterminato da parte dell’agenzia. Per la
somministrazione a tempo determinato vi è un rinvio ai limiti quantitativi individuati dai contratti
collettivi applicati dall’utilizzatore. È esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo
determinato dei lavoratori in mobilità, di disoccupati che godono di trattamenti di disoccupazione
non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati”,
individuati con decreto del Ministero del lavoro. L’ampliamento della somministrazione di lavoro è
poi confermata dalla sua estensione a tutti i settori produttivi. A rendere ristretta la chiave d’accesso
alla somministrazione di lavoro vale ora solo la serie di divieti normativi, previsti dall’art. 32, che
caratterizzavano l’accesso a tutte le forme di lavoro flessibile. Il contratto è poi sottoposto a rigorosi
oneri di forma, da osservarsi ad substantiam, in quanto alla violazione di buona parte di essi è
ricollegato il diritto del lavoratore di richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro diretto con
l’utilizzatore. Devono risultare espressamente i seguenti elementi: gli estremi dell’autorizzazione; il
numero dei lavoratori richiesti; l’indicazione di eventuali rischi per la salute e le misure di
prevenzione adottate; la data di inizio e la durata della somministrazione; le mansioni alle quali
saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento; il luogo, l’orario e il trattamento economico e
normativo dei lavoratori. Con il contratto l’utilizzatore ha l’obbligo di comunicare all’agenzia il
trattamento economico e normativo applicabile ai dipendenti diretti che svolgono le medesime
mansioni dei somministrati ed a rimborsare gli oneri retributivi e contributivi effettivamente
sostenuti dall’agenzia. È prevista la nullità della clausola negoziale diretta a limitare la facoltà
dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione, salvo che al
lavoratore sia corrisposta una “adeguata indennità”, secondo le previsioni della contrattazione
collettiva applicabile all’agenzia. La mancanza di forma scritta del contratto è sanzionata con la
riconduzione diretta in capo all’utilizzatore del rapporto di lavoro con i dipendenti. Non essendovi
indicazioni contrarie il ruolo di utilizzatore può essere rivestito sia da imprese che da altri soggetti.
Più complicata è la questione circa l’applicabilità della somministrazione di lavoro nei confronti
della pubblica amministrazione. La legge esclude tassativamente l’utilizzabilità della
somministrazione a tempo indeterminato. Quanto a quella a termine rinvia alla disciplina di cui
all’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001. Si tratta della disposizione che regola l’impiego da parte della
pubblica amministrazione dei contatti flessibili. La disposizione affida alla contrattazione collettiva
il potere di disciplinare “la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e
lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio”, in
applicazione delle rispettive leggi. Le conseguenze della violazione di norme imperative riguardanti
la somministrazione a termine mai potranno comportare la costituzione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato con la pubblica amministrazione. Al lavoratore spetterà solo il risarcimento dei
danni per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, mentre alle amministrazioni pubbliche è
imposto l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
44
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
responsabili. In ogni caso non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l’esercizio di
funzioni direttive o dirigenziali.
4. IL contratto fra il lavoratore e l’agenzia fornitrice è un contratto tipico di lavoro subordinato, che
presenta significativi profili di specialità. Innanzitutto può essere a tempo determinato o a tempo
indeterminato. Come causa di tale contratto vi è l’obbligazione assunta dal lavoratore verso
l’agenzia a “lasciarsi destinare” a favore di terzi. Tale impegno ha caratteri diversi, a seconda che si
tratti di lavoro a termine o a tempo indeterminato. La differenza non manca poi di ripercuotersi sul
problema del corretto adempimento da parte del lavoratore all’obbligazione assunta con l’agenzia.
È infatti solo nel contratto a tempo indeterminato che può emergere come autonomo
inadempimento il rifiuto di accettare la destinazione nei confronti del terzo. Al contratto di lavoro
con l’agenzia è applicabile ovviamente la disciplina generale dei rapporti di lavoro. Non vi è
previsione della forma scritta del contratto agenzia/lavoratore. Ne deriva che l’agenzia-datore di
lavoro avrà gli oneri di informazione previsti dal d.lgs. n. 152/1997, ma il contratto resterà
sostanzialmente libero nella forma. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto a
tempo indeterminato, il medesimo contratto deve prevedere la misura dell’indennità mensile di
disponibilità, divisibile in quote orarie corrisposta dall’agenzia al lavoratore per i periodi nei quali il
lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. Tale indennità ha natura sostanziale di salario
minimo garantito. Le cause di cessazione del rapporto di lavoro fra lavoratore ed agenzia dipendono
ovviamente dalla natura del relativo rapporto. Se il lavoro è a tempo determinato, il rapporto cesserà
per la scadenza del termine. In caso di rapporto a tempo indeterminato si applicheranno invece le
norme sui licenziamenti individuali. Altra questione riguarda la sorte dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato con l’agenzia, nel caso di recesso ad nutum da parte dell’utilizzatore del contratto di
somministrazione a tempo indeterminato. La riforma del 2015 esclude che la cessazione della
somministrazione a tempo indeterminato sia riconducibile alla disciplina dei licenziamenti
collettivi, rientrando piuttosto fra le ipotesi di giustificato motivo oggettivo. L’agenzia datrice di
lavoro sarà onerata di dimostrare la concreta inutilizzabilità del lavoratore nell’ambito della propria
organizzazione. Quanto all’assunzione a tempo determinato le agenzie di somministrazione hanno
un trattamento di particolare favore rispetto alla disciplina generale. A tali assunzioni non risulta
infatti applicabile né il limite massimo dei trentasei mesi né tutta la disciplina delle proroghe e dei
rinnovi né quella relativa ai limiti quantitativi né quella relativa ai diritti di precedenza.
5. Per effetto del contratto di somministrazione il lavoratore si impegna a prestare attività lavorativa
nei confronti del terzo. La fase di svolgimento della prestazione a beneficio dell’impresa utilizzante,
mette in luce le peculiarità deducibili dalla scissione fra titolarità del rapporto e destinazione della
prestazione a favore del terzo. Bisogna rilevare che la relazione che si instaura fra lavoratore ed
utilizzatore non è di mero fatto, ma è una relazione giuridica, fonte cioè di diritti ed obblighi per
ambedue le parti. La fonte costitutiva va rinvenuta nel doppio ordine di impegni, contenuti nei
contratti che vi sono a monte. Nella somministrazione di lavoro, l’obbligazione di eseguire la
prestazione a favore del terzo si perfeziona con il contemporaneo concorso di ambedue gli schemi
negoziali. Di qui la necessità di costruire uno stretto collegamento funzionale fra contratto di
somministrazione e contratto di lavoro con l’agenzia, ciascuno dei quali non è autosufficiente al
fine di determinare l’effetto obbligatorio. Va poi risolta la questione della ripartizione fra i due
soggetti dei diritti ed obblighi che accedono alla posizione del titolare del rapporto e
dell’utilizzatore della prestazione e di adattare alla specificità della situazione il quadro delle tutele
a favore del lavoratore. Il punto di partenza è: risponde alla ratio della legge che il lavoratore
somministrato sia inserito nell’organizzazione produttiva dell’utilizzatore. Significa che
quest’ultimo è destinato a divenire il datore di lavoro sostanziale. Ne deve conseguire che la
45
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
titolarità solo formale del rapporto in capo all’agenzia è segnata dalle previsioni normative relative
ai due soli obblighi del pagamento della retribuzione, con gli oneri contributivi connessi e
dell’attivazione del potere disciplinare, il cui impulso però resta nelle mani del datore utilizzatore. I
problemi di trattamento riferibili a profili variabili vanno risolti secondo le previsioni della
contrattazione collettiva dell’utilizzatore. Ciò vale anche per le situazioni in cui la legge assegna un
residuo ruolo al datore di lavoro “formale”. La concreta misura dell’inadempimento dovrà essere
valutata alla stregua del codice disciplinare vigente presso l’utilizzatore. L’agenzia non ha nemmeno
il potere di contestazione della decisione dell’utilizzatore di irrogare l’una o l’altra sanzione. Ha
solo il potere di procedere agli adempimenti formali ed all’irrogazione della sanzione indicata dal
committente. Si prospetta quindi una situazione di scissione fra titolarità del medesimo che resta in
capo all’agenzia e potere di impulso per la segnalazione degli elementi per la contestazione degli
addebiti che non può che ricadere sull’utilizzatore. Un discorso non diverso vale per l’ipotesi di
esercizio di mansioni superiori da parte del lavoratore. La legge prevede anzitutto un obbligo di
immediata informazione scritta nei confronti dell’agenzia, al cui inadempimento è collegata la
responsabilità esclusiva dell’utilizzatore per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato
in mansioni superiori nonché per l’eventuale risarcimento del danno. I lavoratori poi devono essere
informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso quest’ultimo, per poter aspirare a ricoprire posti
di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni sono fornite mediante un avviso generale, affisso
all’interno dei locali dell’utilizzatore presso il quale operano. Tutto ciò che attiene ai profili
esecutivi della prestazione vede come protagonisti esclusivi il lavoratore “in affitto” e il terzo
utilizzatore. È ovvio che il potere direttivo e il suo rovescio in termini di obblighi a carico del
lavoratore rientrino nella titolarità dell’utilizzatore. Il prestatore deve svolgere l’attività secondo le
istruzioni impartite dall’utilizzatore per l’esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro. Nella
sfera di influenza dell’utilizzatore ricadono tutti gli obblighi connessi con la situazione ambientale
in cui si svolge la prestazione. Ciò è da dire anzitutto per l’obbligo di sicurezza. Vi è un obbligo
preventivo dell’agenzia che deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute
connessi alle attività produttive e deve formarli ed addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro
necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi sono assunti. L’utilizzatore deve
osservare infatti tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è
responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti
collettivi. Analogamente ci sono i diritti del lavoratore, rispetto ai quali deve assumersi l’esistenza
una sostanziale parità di trattamento nei confronti dei dipendenti dell’utilizzatore. L’adempimento
dell’obbligazione retributiva è rafforzato dall’obbligo solidale fra le due imprese. L’utilizzatore
infatti resta obbligato in solido con l’agenzia per l’adempimento della relativa obbligazione
retributiva. C’è poi la previsione secondo cui il prestatore di lavoro ha diritto a fruire di tutti i
servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità
produttiva. È ovvio che la responsabilità civile per i danni causati dal lavoratore in affitto ricada
sull’utilizzatore. I diritti sindacali del lavoratore in affitto sono esigibili nei confronti
dell’utilizzatore. Si prevede infatti che il prestatore di lavoro ha diritto ad esercitare presso
l’utilizzatore i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del
personale dipendente da quest’ultima. Sul piano previdenziale si prevede l’inquadramento delle
agenzie nel settore terziario. I premi per l’assicurazione infortuni sono determinati in relazione alle
attività dell’utilizzatore.
6. L’art. 38 del d.lgs. n. 81/2015 è dedicato alla somministrazione irregolare. Non viene prevista
l’ipotesi della stipulazione di un contratto di somministrazione di lavoro fra un utilizzatore ed
un’agenzia non iscritta nell’albo speciale: nonostante l’omissione, sappiamo comunque che un
contratto di questo tipo sarebbe nullo per violazione di una norma imperativa. La nullità è poi
46
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
prefigurata in caso di mancanza di forma scritta del contratto di somministrazione. In ambedue tali
ipotesi le conseguenze della nullità consistono nel fatto che i lavoratori si considerano a tutti gli
effetti alle dipendenze dell’utilizzatore. La somministrazione inoltre è irregolare:
Quando è stipulata in violazione dei limiti quantitativi previsti dall’art. 31
Nel caso di violazione dei divieti di cui all’art. 32
Nel caso di omessa indicazione, nel contratto, degli estremi dell’autorizzazione, del numero
di lavoratori da somministrare, dell’indicazione dei rischi per la salute dei lavoratori e della
durata del contratto.
Il connotato di irregolarità sorge solo a seguito di effettiva occupazione del lavoratore presso il
terzo. Per la somministrazione irregolare l’art. 38, 2° co., prefigura, a vantaggio del lavoratore, la
“costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze” dell’utilizzatore. La diversità di
formulazione fra il 1° co. dell’art. 38, in caso di mancanza di forma scritta, e del 2° comma
dovrebbe orientare l’interprete, nel primo caso, verso la sanzione di nullità, e, nel secondo caso,
verso quella dell’annullabilità. Tale diversità è confermata dal 2° co. dell’art. 39 che esclude la
ricostruzione integrale del rapporto di lavoro, in caso di somministrazione irregolare, dal momento
che il giudice condanna il datore ad un risarcimento dei danni, stabilendo un’indennità
onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità
dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. La questione, per gli enti
previdenziali, è sdrammatizzabile a misura che si ritenga che questi ultimi restano certamente
titolari del potere di far accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro diretto con l’effettivo
lavoratore della prestazione. Le imprecisioni tecniche sono risistemabili intorno all’interpretazione
del 5° co. dell’art. 1 della legge 1369/60 ed alla valutazione complessiva del sistema. L’imputazione
all’utilizzatore dei rapporti di lavoro altro non è se non dichiarazione giudiziale dell’esistenza di un
rapporto, che già nei fatti si configura come subordinato. La legge si preoccupa poi di precisare che
l’agenzia non è litisconsorte necessario della lite instaurata dal lavoratore, che può essere proposta
anche solo nei confronti dell’utilizzatore. I pagamenti effettuati dal somministratore valgono a
liberare il soggetto utilizzatore. Tutti gli atti per la costituzione ed amministrazione del rapporto
sono imputabili all’utilizzatore. Alla somministrazione irregolare sono collegate anche sanzioni
amministrative pecuniarie. Sia l’agenzia che l’utilizzatore sono sanzionati in caso di omissione
degli elementi costitutivi del contratto di somministrazione nonché in caso di violazione della parità
di trattamento tra lavoratori somministrati e dipendenti diretti dell’utilizzatore. Il solo utilizzatore è
sanzionato in caso di violazione dei limiti quantitativi di impiego del lavoro somministrato, dei
divieti previsti dall’art. 32, per l’omessa fruizione dei servizi sociali a favore dei lavoratori nonché
per l’omissione delle informative sindacali. La sola agenzia è sanzionata per l’omessa informazione
circa la durata del contratto di somministrazione. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione
di un rapporto di lavoro con l’utilizzatore, il medesimo è onerato di impugnare stragiudizialmente la
somministrazione irregolare entro sessanta giorni, con termine decorrente dalla data in cui il
lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore.
Sezione IV: LE VICENDE DELL’IMPRESA
1. L’impresa è soggetta a vicende “circolatorie”, cioè alla possibilità di essere oggetto di
trasferimento. Il mutamento pone il problema della sorte dei rapporti di lavoro. Il nucleo della tutela
era contenuto nell’art. 2112 c.c. Tale norma fissò un duplice principio di tutela: a) da una parte il
diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto con il datore acquirente, con la conservazione
dei diritti e dell’anzianità acquisita; b) dall’altra, l’estensione anche all’acquirente della
responsabilità per i crediti che il prestatore di lavoro aveva al momento del trasferimento. La
47
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
materia è stata oggetto di attenzione da parte della Comunità Europea, che ha emanato tre
importanti direttive: la Dir. 77/187/CE del 14/02/1977, integrata e modificata con la Dir. 98/50/CE
del 29/06/1998 ed infine la Dir. 12/03/2001 n. 2001/23 che ha risistemato la disciplina. L’Italia vi si
è adeguata con l’art. 47 della legge 29/12/1990 n. 428, introducendo inoltre una procedura di
informazione sindacale in caso di trasferimento d’azienda e norme più specifiche in relazione a
situazioni di crisi aziendale. Una consolidata giurisprudenza di legittimità riteneva indispensabile
l’esistenza di un trasferimento degli elementi patrimoniali dell’impresa, nella permanenza
sostanziale dell’attività economica di quest’ultima. Il legislatore italiano è quindi intervenuto con il
d.lgs. 02/02/2001 n. 18 che ha riscritto l’art. 2112 c.c. e modificato i primi quattro commi dell’art.
47 della l. n. 428/1990. Poi con la legge n. 30/2003 il governo è stato delegato ad emanare una
disciplina che provvedesse ad un “completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa
comunitaria”. A tanto ha provveduto l’art. 32 del d.lgs. n. 276/2003 che ha modificato il 5° co.
dell’art. 2112 c.c. ed aggiunto un 6° co. Questo ultimo intervento è più che altro diretto ad
introdurre marcati elementi di flessibilità nell’amministrazione del rapporto. Il nucleo degli
interventi degli anni 2001/2003 è la nuova nozione di trasferimento d’azienda. Alla stregua del
rinovellato 5° co. dell’art. 2112 c.c. si intende per trasferimento d’azienda “qualsiasi operazione che
comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia
negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato. Quanto alla nozione di
“azienda” la disciplina si estende al trasferimento “di parte dell’azienda, intesa come articolazione
funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
dal cessionario al momento del suo trasferimento”. Rientrano qui tutte le fattispecie “circolatorie”
rispetto alle quali ferveva il dibattito nel precedente assetto. Si riteneva rinvenibile la fattispecie
quando si fosse verificata la sostituzione del titolare, quale che fosse il mezzo tecnico-giuridico
adoperato. La giurisprudenza ammetteva la sussistenza del trasferimento anche nelle situazioni in
cui non vi fosse un rapporto contrattuale diretto fra alienante ed acquirente. Oggetto di maggiore
discussione erano i fenomeni di trasformazione delle strutture delle società. La giurisprudenza era
incline ad estendere l’applicabilità della normativa di tutela alle fusioni societarie ed analoga presa
di posizione valeva per i fenomeni di scissione societaria. C’era unanimità di vedute sulla
prospettiva secondo cui non integrava un trasferimento d’azienda la semplice cessione del pacchetto
di maggioranza delle quote di una società. Il nuovo tenore della norma codicistica sembra ora
ricomprendere entro lo specchio protettivo anche queste situazioni. Si escludeva inoltre
l’applicabilità della disciplina all’ipotesi di subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di
una concessione amministrativa. Pur dopo la riforma resta discutibile l’estensibilità dell’art. 2112
c.c. all’ipotesi di successione mortis causa. Dalla nozione di trasferimento è esclusa dall’art. 29, 3°
co., del d.lgs. n. 276/2003 l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di
subingresso di un nuovo appaltatore. Quanto alla nozione di “azienda”, si riteneva applicabile la
relativa disciplina anche quando oggetto del trasferimento fosse stato solo un ramo dell’azienda. La
riforma del 2001 richiedeva che la porzione di azienda trasferita avesse una propria individualità
“preesistente” al trasferimento e che tale individualità si “conservasse” all’esito del medesimo. La
nuova disciplina di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 276/2003 consente che cedente e cessionario
identifichino in concreto l’articolazione funzionale da trasferire. Un problema diverso si pone a
seguito dei processi definiti di “esternalizzazione” o di outsourcing e che consistono nella cessione
ad altri di un ramo o reparto dell’impresa, cui fa seguito una riacquisizione del risultato produttivo.
Si tratta di una combinazione fra il decentramento produttivo ed il trasferimento di una parte
autonoma dell’azienda. In tali situazioni il problema centrale è quello dell’identificazione del grado
di autonomia del ramo o reparto ceduti e quindi del concetto stesso di azienda, potendo in taluni
48
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
casi tale concetto essere integrato anche soltanto dall’unità economica costituita dal gruppo di
lavoratori. Dal grado di contaminazione fra trasferimento d’azienda ed appalto dipenderà la verifica
della legittimità dell’operazione economica realizzata, che è ancora enucleabile dall’ordinamento.
Tali fattispecie trovano collocazione entro la disciplina di cui al novellato art. 2112 c.c. in
considerazione dell’ampiezza del riferimento alle articolazioni indipendenti “di un’attività
autonoma organizzata”. Il 6° co. dell’art. 2112 c.c. estende ad appaltante ed appaltatore il regime di
solidarietà previsto dal nuovo testo dell’art. 29, 2° co., del d.lgs. n. 276/2003. Ne deriva che i
dipendenti dell’appaltatore possono agire direttamente anche nei confronti del committente per
conseguire quanto è loro dovuto, essendo l’oggetto della pretesa limitato al trattamento convenuto
con l’appaltatore. Passando ad esaminare le garanzie per i lavoratori anche l’attuale assetto
normativo conferma il principio generale secondo cui i mutamenti della titolarità dell’impresa non
interferiscono con i rapporti di lavoro, che continuano con il soggetto subentrante. L’art. 2112
sancisce l’obbligo per il cessionario di continuare ad applicare i trattamenti economici e normativi
vigenti al momento del trasferimento, fino alla loro scadenza. Il termine “contratti vigenti” sta per
“contratti concretamente applicati”. L’art. 2112 c.c. conferma il principio secondo cui il
trasferimento d’azienda non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento. L’eventuale
diritto di recesso va esercitato nel rispetto della normativa in materia di licenziamenti. Il lavoratore,
le cui condizioni di lavoro subiscano una netta modifica nei tre mesi successivi, può rassegnare le
dimissioni per giusta causa. Resta ferma la possibilità per il lavoratore di liberare il cedente dagli
obblighi solidali, per il tramite di una procedura conciliativa in sede sindacale o in sede
amministrativa. La posizione di coobbligati solidali del cedente e del cessionario non interferisce,
nei rapporti interni fra costoro, sulla diversa ripartizione del rischio che essi abbiano operato all’atto
del trasferimento. La più importante innovazione è quella concernente il coinvolgimento delle
associazioni sindacali nelle vicende circolatorie delle aziende. Si prevede, nelle imprese con oltre
quindici dipendenti, che il cedente e il cessionario diano comunicazione scritta, almeno venticinque
giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento e che sia raggiunta un’intesa
vincolante tra le parti, alle rispettive rappresentanze sindacali aziendali, dell’intenzione di effettuare
un trasferimento d’azienda. Oggetto dell’informazione sono: a) la data o la data proposta per il
trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento; c) le sue conseguenze giuridiche,
economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
Su richiesta scritta deve essere avviato un esame congiunto con i soggetti sindacali. La
consultazione si intende esaurita ove non sia stato raggiunto un accordo. La nuova legge sembra
chiarire un problema in relazione al dies ad quem di venticinque giorni per l’informativa. La più
recente disciplina pretende che gli obblighi di informazione ed esame congiunto debbano essere
assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa
controllante. È importante notare che è la stessa legge a prevedere che la violazione degli obblighi
di informativa ed esame congiunto costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello
statuto dei lavoratori. Più discussa è la questione delle conseguenze dell’eventuale declaratoria di
antisindacalità del comportamento delle due imprese. Una disciplina speciale per le ipotesi di
trasferimento delle aziende in crisi è regolata dall’art. 47, co. 4-bis, 5 e 6, della l. n. 428/1990. Il
regime si applica alle imprese delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, a quelle per
cui sia stata disposta l’amministrazione straordinaria etc. Rispetto a tali imprese è l’accordo
collettivo che è sovrano nel regolare le condizioni di applicazione dell’art. 2112 c.c. e le sue
eventuali deroghe. Nel caso in cui il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia
stata dichiarazione di fallimento, ai lavoratori il cui rapporto continua con l’acquirente non si
applica l’apparato di garanzie previste dall’art. 2112. I lavoratori che non transitino presso l’impresa
acquirente hanno diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni, entro un anno dalla data del
49
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
trasferimento. Anche ai lavoratori assunti successivamente si estende la deroga alle garanzie
previste dall’art. 2112 c.c. Rispetto a tale disciplina si è posto il problema della compatibilità con la
Direttiva n. 77/187. Tale opinione ha trovato un riscontro in una decisione della Corte di giustizia
che ha confermato l’estensione della direttiva anche alle situazioni descritte. Va fatta salva la
dismissione dei diritti dei lavoratori nel contesto di una vera e propria procedura fallimentare.
Occorre infine ricordare quale sia l’aspetto della disciplina nel pubblico impiego: la materia si
avvale di una norma generale che codifica il principio secondo cui, nel caso di trasferimento di
attività svolte nel pubblico impiego, ai lavoratori che passano le dipendenze di tali soggetti trovano
diretta applicazione gli artt. 2112 c.c. e 47 della l. n. 428/1990. Dato che le modifiche dal d.lgs.
276/2003 non si applicano, deve ritenersi che per i pubblici dipendenti la tutela resti quella
assicurata dal d.lgs. 18/2001.
2. Le vicende dell’impresa che la portano al fallimento/instaurazione di procedure concorsuali
intersecano il diritto del lavoro. Per quanto riguarda la sorte dei rapporti di lavoro ed il potere di
recesso del datore, l’art. 2119, 2° co., c.c. esclude che il fallimento costituisca giusta causa di
licenziamento. La cessazione del rapporto non costituisce affatto una conseguenza necessaria degli
avvenimenti indicati. La norma ha lo scopo di consentire che il lavoratore conservi il diritto
all’indennità di mancato preavviso. È sempre l’art. 2119, 2° co., che fa ritenere che l’eventuale
risoluzione ante tempus del contratto a termine, per effetto del fallimento, comporti il diritto dei
lavoratori al pagamento delle retribuzioni fino alla scadenza. È coerente l’idea che il licenziamento
possa avvenire solo in presenza di un giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale.
Un ulteriore profilo di intersezione tra procedure concorsuali e diritto del lavoro è quello che
riguarda le garanzie dei crediti del lavoratore e la loro collocazione nella procedura fallimentare.
Capitolo terzo: LA DINAMICA DEL CONTRATTO DI LAVORO
Sezione I: AUTONOMIA PRIVATA E RAPPORTO DI LAVORO
1. Nella disciplina del rapporto di lavoro, vi è una forte eterointegrazione ad opera di fonti esterne.
In sostanza l’ordinamento considera l’autonomia individuale insufficiente a regolare le obbligazioni
che nascono dal rapporto di lavoro. L’assetto regolativo del rapporto è solo in parte dettato dai
contraenti, risultando dall’agire altresì dell’intervento della legge e della contrattazione collettiva.
La legge e la contrattazione collettiva stabiliscono dei minimi di trattamento, cui le parti non
possono in alcun modo derogare. Si tratta quindi di un’inderogabilità unidirezionale, che è
compatibile con trattamenti più favorevoli per il prestatore di lavoro previsti nel contratto
individuale. Il meccanismo attraverso il quale le norme inderogabili agiscono sulla pattuizione
privatistica è quello classico della nullità parziale, regolata dall’art. 1419 c.c., con il corollario della
sostituzione di diritto delle clausole nulle con le norme imperative.
2. È radicata l’idea dell’origine contrattuale del rapporto di lavoro. Il contratto è il contenitore che
meglio si presta a fornire la misura delle reciproche obbligazioni ed a riflettere l’immagine di
uomini liberi che trovano il punto di equilibrio per il loro conflitto di interessi sostanziali. L’etero-
integrazione dei contenuti del contratto di lavori ad opera di fonti esterne ha sempre costituito un
elemento perturbatore della limpidezza del presupposto contrattuale. Ma non vi è incompatibilità fra
la rilevazione della sussistenza della fonte contrattuale e l’assegnazione di un ruolo ridotto o
marginale all’autonomia individuale nella determinazione del contenuto del contratto. La
contrapposizione fra i due momenti è resa dagli artt. 1321 e 1322 c.c. Al potere dell’autonomia
privata di costituire un rapporto giuridico si contrappone quello di “liberamente determinare il
contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge”. Il problema è quello di verificare quale sia la
50
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
rilevanza e la dimensione del contratto assunta nell’ambito di uno specifico ordinamento. Il
contratto si è da tempo piegato ad una pluralità di impieghi ed il suo contenuto si trova alla
confluenza di varie fonti. Questa come altre discussioni deve muovere dal e ricondursi al diritto
positivo. È infatti lo stesso diritto positivo a fare esplicito riferimento al contratto di lavoro in
molteplici circostanze. Un’ulteriore insidia viene dall’idea che alle origini della nostra relazione
giuridica possa esservi direttamente il fatto dell’occupazione. La dottrina civilistica ha provveduto a
ricondurre alla sfera contrattuale tutte quelle situazioni all’apparenza situabili fra i rapporti “di
fatto”, sulla base di una migliore puntualizzazione della nozione di contratto, avendo riguardo al
profilo della formazione delle intese. Scarso credito hanno avuto in Italia le teoriche che
riconducono il rapporto di lavoro alla prospettiva istituzionalista, considerando l’impresa come
istituzione al cui interno opera la comunità dei lavoratori e che postulano che il titolo d’ingresso
nella comunità possa essere, secondo alcune un contratto, mentre secondo altre direttamente il fatto
dell’occupazione. Si tratta di una prospettiva che appare del tutto estranea alla nostra cultura
giuridica e che ha ricevuto solo qualche sostegno normativo nelle norme che danno rilievo alla
subordinazione gerarchica del lavoratore. Le teorie istituzionaliste sono quelle che meglio si
prestano a fornire una giustificazione sistematica dell’esistenza dei robusti poteri unilaterali del
datore, ed in particolare di quelli che non trovano riscontro in altri rapporti negoziali: il che vale
soprattutto per il potere disciplinare.
3. Il contratto di lavoro è un contratto oneroso e di scambio; si caratterizza per la correspettività
delle reciproche obbligazioni. I termini dello scambio sono costituiti dalla prestazione di lavoro
contro il pagamento della retribuzione. L’obbligazione tipicamente corrispettiva costituisce solo una
frazione del salario, parte del quale è viceversa destinato a soddisfare bisogni addirittura estranei
alla funzione del contratto di lavoro. Gli effetti giuridici della corrispettività subiscono deviazioni
più marcate avendo riguardo alle obbligazioni del lavoratore. Ciò in particolare per lo speciale
regime delle varie ipotesi di sospensione del rapporto, rispetto alle quali il diritto ha costruito delle
regole speciali. Il rapporto di lavoro ha una struttura complessa, risultante dalla contrapposizione
delle reciproche situazioni attive e passive che fanno capo alle due parti. Accanto alle due
obbligazioni fondamentali o primarie ruotano una serie di posizioni attive e passive. L’obbligazione
principale del datore di lavoro è costruibile come un’obbligazione di dare. Il che comporta che ad
essa si applichino le norme civilistiche relative alle obbligazioni pecuniarie. Più complicata è
l’obbligazione fondamentale del lavoratore, consistente nella prestazione di lavoro. Ne è stata
proposta la ricostruzione come obbligazione di dare: il lavoratore si impegnerebbe cioè ad erogare
e/o a mettere a disposizione le proprie energie lavorative. Quest’ultima ricostruzione non è fine a se
stessa, in quanto è stata prospettata allo scopo di giustificare il diritto del lavoratore alla permanenza
del diritto alla retribuzione nel caso di scioperi articolati o per affermare il diritto al permanere della
retribuzione a seguito di declaratoria di illegittimità del licenziamento. Tale concezione è in
contrasto con la stessa causa del contratto di lavoro che viene a coincidere con l’interesse del datore
all’effettiva esecuzione proficua della prestazione. L’obbligazione del lavoratore è dunque
un’obbligazione di facere o di attività. È misurabile secondo i parametri dell’oggetto
dell’obbligazione (possibilità, liceità, determinatezza). Il dato della possibilità allude alla
circostanza che il lavoratore si trovi nelle condizioni soggettive di esserne parte e non vi siano
situazioni impeditive temporanee o permanenti. Il carattere di determinatezza è soddisfatto dal
riferimento alle mansioni, cui deve essere adibito il lavoratore, che sono a loro volta riconducibili
alle qualifiche, che designano la specifica professionalità del lavoratore e costituiscono
suddistinzioni interne alle categorie. La prestazione deve essere infine lecita. L’illiceità dell’oggetto
del contratto di lavoro dà luogo alla peculiare disciplina della sua nullità.
51
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
4. L’oggetto del contratto di lavoro implica il carattere della personalità della prestazione.
Dobbiamo ora ritenere che la prestazione debba essere adempiuta personalmente dal lavoratore. il
fondamento della personalità della prestazione è da ritenersi implicito nella stessa nozione di
subordinazione. La circostanza è resa manifesta dalla qualificazione come “proprio” del lavoro
dedotto nell’obbligazione descritta dall’art. 2094 c.c. Si deve altresì ritenere che la prestazione di
lavoro sia soggettivamente infungibile, nel senso che il suo adempimento è collegato con la persona
del debitore di lavoro. Non sempre la prestazione è invece oggettivamente infungibile, essendo tale
carattere collegato a situazioni in cui sussiste un vincolo inestricabile fra il risultato atteso dal
creditore ed il comportamento del debitore. Il carattere personale della prestazione implica che non
sia configurabile una successione nel rapporto dal lato del lavoratore sia mortis causa che per atto
tra vivi. Ulteriore conseguenza è che il lavoratore non può avvalersi di sostituti o ausiliari
nell’adempimento dell’obbligazione. Nell’ordinamento lavoristico costituiscono eccezioni a questa
regola solo le ipotesi di sostituzione del lavorante a domicilio e del portiere. Non è idonea ad
intaccare la vigenza del principio di personalità della prestazione la tecnica di impiego del lavoro
definita lavoro ripartito o “lavoro a coppia” o job sharing, che consiste nell’obbligazione assunta da
due lavoratori che si impegnano a prestare la medesima attività, con la possibilità di sostituirsi
vicendevolmente. Potrebbe parlarsi di un contratto trilatero in cui l’impegno è assunto da due
soggetti distinti che promettono unitariamente l’adempimento dell’obbligo. Tale strumento
negoziale era compatibile con il nostro ordinamento, ma, per scrupolo, il Ministero del lavoro, con
una circolare del 1998, ne aveva ribadito la legittimità con l’intento di promuoverne la diffusione.
Successivamente era stato introdotto e regolamentato agli artt. 41-45 del d.lgs. n. 276/2003. Ma con
la riforma Renzi di cui al d.lgs. n. 81/2015, con l’art. 55, 1° co. lett. d), ha provveduto
all’abrogazione delle disposizioni appena indicate del d.lgs. n. 276/2003. Perciò il lavoro ripartito è
stato formalmente espunto dall’ordinamento. La legittimità e meritevolezza di tutela di tale tipo
contrattuale dovrebbe peraltro rimanere, anche in ragione del fatto che molti contratti collettivi
continuano a richiamarlo, dettandone le regole attuative.
5. L’art. 2126 c.c. introduce una disciplina peculiare per la nullità del contratto di lavoro. La nullità
del contratto di lavoro non produce effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione,
salvo che derivi da illiceità dell’oggetto o della causa. La norma adatta alla specificità del contratto
di lavoro il regime generale della nullità dei contratti. L’applicazione della sanzione della nullità al
contratto di lavoro comporterebbe le “azioni restitutorie”, potendo ogni contraente ripristinare la
situazione di fatto esistente anteriormente alla stipulazione del contratto. Ma non potrebbe ottenere
in restituzione le energie lavorative spese: in questo modo vi sarebbe una sorta di arricchimento del
datore ai danni del prestatore. Si spiega così la ratio della disciplina speciale che non consente che
la nullità produca effetti per tutto il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Durante tale
periodo il lavoratore mantiene integra la titolarità dei propri diritti. Il lavoratore avrà diritto, per il
periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione, all’applicazione di tutti gli effetti tipici scaturenti
dalla prestazione di lavoro. L’art. 2126 c.c. fa salva l’ipotesi che la nullità derivi da illiceità
dell’oggetto o della causa. La lettera della legge potrebbe far pensare che si alluda all’illiceità del
contratto in sé. Ne deriverebbe che il trattamento giuridico dell’illiceità del contratto di lavoro
sarebbe uguale al trattamento degli altri contratti. Nell’art. 2126 c.c. si sarebbe inteso stabilire il
principio secondo cui “se il lavoro è illecito di per sé non è concepibile la sua protezione nemmeno
per l’attuazione che se n’è avuta”. Il legislatore intendeva riferire al lavoro in sé il tratto
dell’illiceità. La circostanza è confermata dal riferimento all’illiceità dell’oggetto, intesa come
illiceità della prestazione, cioè del lavoro. L’allusione all’illiceità della causa può spiegarsi avendo
riguardo allo scopo che viene perseguito con la prestazione lavorativa. Il ritorno alla disciplina
generale della nullità è quindi postulato solo in caso di prestazione oggettivamente o causalmente
52
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
illecita. La giurisprudenza tende a distinguere il contratto nullo per illiceità dal contratto meramente
illegale, collegando solo al primo l’effetto previsto dall’art. 2126, seconda parte del 1° co. Una
cospicua casistica riguarda inoltre la questione dell’attività lavorativa espletata in assenza di
abilitazioni amministrative o iscrizioni ad albi. I giudici tendono ad escludere che ricorra l’ipotesi di
illiceità dell’oggetto o della causa, valutando i presupposti come requisiti estrinsechi e facendo
quindi salve le prestazioni effettuate. Una particolar ipotesi di nullità contrattuale è quella che
consegue alla violazione di norme a tutela del lavoratore; in tale situazione il prestatore
conserverebbe solo il diritto alla retribuzione. L’art.2126 c.c. garantisce comunque, anche in caso di
nullità del contratto, il mantenimento dei diritti derivanti all’esecuzione della prestazione. Il
richiamo al diritto alla retribuzione allude quindi ad uno degli effetti tipici della prestazione di fatto
del lavoro. La reazione dell’ordinamento nei confronti della violazione di norme a tutela del
prestatore si commisura alla funzione che le norme violate intendevano perseguire. Un cenno a
parte merita l’estensione dell’art. 2126, 2° co., c.c. ai contratti di lavoro speciali. All’apparenza la
violazione di norme imperative a tutela del prestatore sembrerebbe produrre la conservazione degli
effetti della prestazione speciale. Ad un’analisi più attenta si può però sostenere che la violazione
della norma debba comportare la nullità del rapporto di lavoro “speciale”. Il che corrisponde alla
realizzazione dell’effetto che il datore intendeva evitare attraverso il meccanismo fraudolento o in
violazione di legge.
Sezione II: LA FASE NORMATIVA.
PROFILI STRUTTURALI
1. Di una specifica capacità in materia lavoristica si può parlare avendo riguardo alla persona del
lavoratore. L’art. 2 c.c. specifica che sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in
materia di capacità a prestare il proprio lavoro. Il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle
azioni che dipendono dal contratto di lavoro. La disposizione ha inteso sancire la coincidenza fra la
capacità di esser parte di un contratto di lavoro e quella di far valere le situazioni soggettive che si
radicano nel contratto. Fra le leggi speciali occorre ricordare la legge n. 977/1967, che, all’art. 3,
modificato dal d.lgs. n. 345/1999 fissa l’età minima per l’accesso al lavoro riferendosi “al momento
in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria”, che non può essere inferiore a
quindici anni compiuti. È ragionevole ritenere che ormai il minore abbia acquisito, oltre alla
capacità d’agire secondaria, anche la capacità d’agire primaria, che allude alla possibilità che sia lo
stesso minore a stipulare il contratto di lavoro. La riforma del 1975 non ha inciso su quelle
discipline che regolano l’età di ammissione al lavoro per alcuni contratti speciali di lavoro. Ciò vale
in particolare per quelli regolati dal codice della navigazione, per i quali si prevede che il minore di
diciotto anni può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le
azioni che ne derivano. Il limite minimo d’età è qui di quattordici anni ed è desumibile dalla norma
che regola la necessaria iscrizione del marittimo nelle matricole e nei registri.
2. La fase formativa del contratto di lavoro non differisce da quella degli altri contratti, se non per il
fatto che la manifestazione del consenso coincide con l’esecuzione stessa del contratto. Scarso
rilievo ha la problematica dei vizi della volontà, cioè di quei fenomeni patologici che impediscono
una valida formazione del consenso. Il comportamento esecutivo dovrebbe essere interpretato come
una sostanziale convalida del contratto. Fra le rare situazioni in cui si ha avuto occasione di fare
applicazione delle norme civilistiche in materia di vizi della volontà nel rapporto di lavoro,
ricordiamo il caso del datore che aveva fatto erroneo affidamento sulla legittimità
dell’autorizzazione concessa dall’Ispettorato del lavoro ai fini dell’apposizione del termine al
contratto di lavoro. In tale situazione è stata riconosciuta l’annullabilità del contratto per errore di
53
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
diritto del datore. L’errore sulle qualità della persona dell’altro contraente tende a rifluire nel
giudizio tipico del patto di prova, il cui oggetto è proprio quello di consentire alle parti di saggiare
l’appetibilità della stipulazione di un contratto di lavoro. Nel rapporto di lavoro è assai raro il caso
della simulazione assoluta, cioè la specie in cui le parti dichiarino l’esistenza di un rapporto che in
realtà non esiste. In tali situazioni il contratto non produce effetti fra le parti. Più diffusa è la
situazione in cui le parti celino il contratto di lavoro dietro l’apparenza di un diverso contratto,
ponendo in essere una simulazione relativa, all’evidente scopo di eludere l’applicazione della
normativa lavoristica. le precedenti considerazioni presuppongono che il contratto sia di forma
tipicamente libera. Tale presupposto non è stato intaccato dalla legislazione, che ha imposto al
datore una serie di obblighi di informazione, accessori rispetto alla costituzione del rapporto.
All’atto di istaurazione del rapporto i datori privati sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia
della comunicazione di instaurazione del rapporto inviata al centro per l’impiego. L’obbligo si
intende assolto nel caso in cui il datore consegni al lavoratore, prima dell’inizio dell’attività
lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro, che contenga anche tutte le informazioni
previste dal d.lgs. n. 152/1997. L’omessa consegna delle dichiarazioni o l’inesatta indicazione dei
dati sono punite con una sanzione amministrativa. Alla necessaria trasparenza nella gestione de
rapporto accede anche il “libro unico del lavoro”, che il datore è tenuto ad istituire e nel quale sono
iscritti non solo i lavoratori subordinati, ma anche i collaboratori coordinati e continuativi e gli
associati in partecipazione, anche se quest’ultima indicazione è assai superflua. Al suo interno
devono essere annotate le retribuzioni corrisposte, nonché le presenze, le ore di lavoro ordinario e
straordinario, etc. Anche la violazione nella tenuta del libro unico comporterà sanzioni
amministrative. Con l’art. 15 del d.lgs. n. 151/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il libro unico
del lavoro è tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del lavoro. Con l’art. 16 del
medesimo decreto legislativo è stato previsto che tutte le comunicazioni in materia di rapporto di
lavoro etc. devono effettuarsi solo in via telematica. La regola della libertà di forma subisce peraltro
una serie di eccezioni: il contratto di arruolamento del personale marittimo, che deve essere
stipulato per atto pubblico, e il contratto di lavoro sportivo, per il quale è prevista la forma scritta.
Vanno inoltre stipulati per iscritto vari contratti di lavoro flessibile. La ratio di tali previsioni deve
rinvenire nella necessità di acquisire certezza circa la consapevolezza del lavoratore dell’esistenza
di tali deviazioni.
3. Le parti del rapporto possono fare precedere la stipulazione definitiva da un patto di prova. Si
discute circa la natura giuridica del patto, oscillando fra la ricostruzione in termini di condizione,
sospensiva per taluni, risolutiva per altri e quella che ne evoca un carattere misto riconducibile in
parte alla condizione in parte al rapporto a termine e quella che assume che il patto costituisce un
effetto preliminare funzionale alla costituzione di un rapporto definitivo. Si tratta di discussioni
delle quali si può fare a meno, posto che le medesime non prospettano ricadute interpretative idonee
a modificare l’assetto normativo. Conta acquisire che vi è convergenza sull’opinione che riconosce
il carattere unitario del rapporto di lavoro, nonostante l’apposizione della clausola di prova. In
sostanza non è destinata a costruire un contratto autonomo, ma solo a prefigurare talune clausole
specifiche, funzionali alla realizzazione del contenuto del patto. Quest’ultimo è ricostruibile alla
stregua delle indicazioni fornite dall’art. 2096, 2° co. c.c., secondo cui “l’imprenditore ed il
prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e fare l’esperimento che forma oggetto
del patto di prova”. Secondo l’art. 2096, 1° co. c.c., l’assunzione in prova “deve risultare da atto
scritto”. La giurisprudenza ha escluso che la clausola di prova possa essere configurata come
clausola vessatoria, deducendone che non è necessaria una doppia sottoscrizione. La norma
codicistica fa salva una diversa regolamentazione della forma del patto di prova. Il patto ha un
termine finale, esaurito il quale “l’assunzione diviene definitiva ed il servizio prestato si computa
54
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
nell’anzianità del prestatore di lavoro”. Il termine è fissato dalla contrattazione collettiva. Il periodo
di prova dovrà essere ragionevolmente più lungo di quanto più sia elevata la posizione del
lavoratore. Un limite massimo è deducibile dall’art. 10 della l. n. 604/1966 che assume che, decorsi
sei mesi dalla stipulazione del patto, il rapporto di lavoro è suscettibile alla disciplina limitativa dei
licenziamenti. Il computo della durata va effettuato tenendo conto dei giorni di lavoro effettivo. Gli
obblighi fondamentali del patto di prova sono quelli di consentire e fare l’esperimento. Ne deriva
che quest’ultimo deve dar modo al lavoratore di fornire la dimostrazione delle proprie capacità
professionali. Il che implica il rilievo del rispetto dei principi di buona fede e correttezza
nell’esecuzione del contratto. Per quanto riguarda i contratti formativi, il relativo patto di prova
potrà avere ad oggetto solo l’idoneità del lavoratore ad acquisire una qualificazione professionale,
che è inesistente in soggetti in fase di formazione. Il patto è illegittimo nel caso in cui il lavoratore
in prova abbia svolto le medesime mansioni di un precedente rapporto intercorso per un congruo
tempo tra le parti. Lo statuto giuridico del lavoratore in prova è identico a quello del lavoratore
“definitivo”. È stata la Corte costituzionale che ha rimosso le ultime disparità di trattamento, in
relazione alla titolarità del diritto all’indennità di anzianità, in caso di licenziamento nel corso del
periodo di prova. Tale diritto è stato poi confermato dalla legge del 1982 sul TFR. Al lavoratore in
prova spetterà anche il diritto alla conservazione del posto in caso di malattia. Secondo l’art. 2096,
3° co. c.c., durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo
di preavviso o di indennità. Nel vigore della precedente disciplina di cui alla l. n. 482/1968 si
discuteva circa l’apponibilità del patto di prova al rapporto di lavoro con i soggetti beneficiari delle
assunzioni obbligatorie. La giurisprudenza si era assestata sull’adesione alla prospettiva della
compatibilità del patto con il sistema delle assunzioni obbligatorie. La nuova disciplina di cui alla
legge n. 68/1999 si colloca nella medesima logica.
4. Al rapporto di lavoro può essere apposta la clausola del termine, che fa sì che venga stipulato un
contratto a termine, la cui estinzione sarà automatica ad una data certa o ad un determinato evento.
Alle origini l’art. 1628 c.c. del 1865 sanciva la regola secondo cui la locazione di opere potesse
essere solo “a tempo o per una determinata impresa”, codificando l’assoluta prevalenza
dell’impiego a termine. Una volta acquisito il principio della libera recedibilità dal contratto di
lavoro emerge il netto sfavore legislativo nei confronti del lavoro a termine che si esprime nella
legge sull’impiego privato del 1924, che introduce la regola secondo cui, in mancanza di
stipulazione per iscritto della clausola, il rapporto si presume a tempo indeterminato e quindi nella
disciplina di cui all’art. 2097 c.c. del 1942. Le maglie lasciate aperte da quest’ultima norma portò
all’abuso di utilizzare il lavoro a termine, allo scopo di eludere la corresponsione dell’indennità di
anzianità e per garantire ai lavoratori a termine condizioni di minor favore. Ha inizio così una lunga
storia normativa che ha subito una serie di modifiche nella direzione di una sempre maggiore
attenuazione delle rigidità fino all’approdo di cui al d.lgs. n. 81/2005, che costituisce una svolta
verso una sostanziale liberalizzazione delle assunzioni a tempo determinato. Ripercorriamo
l’itinerario.
A. La disciplina capostipite è costituita dalla legge 18/06/1962 n. 230, che ha regolato la
materia fino all’entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 368/2001. La legge
confermava la presunzione secondo cui il rapporto si doveva considerare a tempo
indeterminato. Inoltre l’innovazione più significativa consisteva nell’assumere che
l’assunzione a termine potesse aver luogo esclusivamente rispetto alle attività o ai lavori
tassativamente elencati dalla legge. Tale disciplina venne interpretata in modo ancora più
restrittivo dalla giurisprudenza.
55
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
B. La rigidità interpretativa comportò un mutamento di rotta sul piano della regolamentazione
del fenomeno: si introdusse un controllo ex ante circa la legittimità dell’apposizione del
termine al contratto e si allargarono le ipotesi ammesse. Il lavoro a termine venne riguardato
non più come una tecnica fraudolenta ma come un’opportunità di flessibilizzazione del
lavoro da offrire all’impresa. Le scansioni di tale passaggio sono scandite dalla legge n.
18/1978 con cui, prima nei settori del commercio e del turismo e poi in tutti i settori
economici, venne prevista la possibilità di assunzione a termine per “punte stagionali di
attività”. Il secondo passaggio è costituito dal processo di delegificazione delle ipotesi di
legittima apposizione del termine al contratto. L’art. 23 della l. 28/02/1987 n. 56 previde che
l’apposizione del termine era consentita “nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di
lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale”. Ai medesimi contratti era demandato il potere di
stabilire il numero in percentuale dei lavoratori che potevano essere assunti con contratto a
termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato.
C. La materia del lavoro a tempo determinato ha avuto regolamentazione nell’ambito
dell’Unione europea con la Direttiva 28/06/1999 n. 99/70. Gli obiettivi sono quelli di
migliorare la qualità del lavoro a termine, nel rispetto del principio di non discriminazione e
di creare un quadro normativo diretto alla prevenzione degli abusi derivanti dall’impiego
successivo di più contratti. Tali principi peraltro erano in gran parte già fatti propri dal
nostro ordinamento. Qualche elemento di novità era semmai rinvenibile nella previsione di
un obbligo di informazione nei confronti dei lavoratori a termine circa l’esistenza di posti
vacanti nell’impresa nonché nell’attenzione posta ai profili formativi.
D. Alla Direttiva è stata data attuazione nel nostro ordinamento con il d.lgs. 06/09/2001 n. 368.
Tale disciplina è stata più volte modificata e integrata, a seconda dei governi al potere, o con
misure restrittive o con misure di allargamento nell’impiego del lavoro a termine. Ulteriori
modifiche vi furono con la legge n. 99/2013, di conversione del d.l. n. 76/2013. Poi una
decisiva sterzata verso la liberalizzazione è venuta con la l. n. 78/2014, emanata dal governo
Renzi. L’intenzione originaria del d.lgs. n. 368/2001 era quella di fare del contratto di lavoro
a termine uno strumento di flessibilità e di incentivo all’occupazione. La legge del 2001
consentiva l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro “a fronte di ragioni
di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Veniva così sostituita alla
previsione tassativa di specifiche situazioni o attività il rinvio ad una norma generale, che si
sperava potesse offrire maggiore duttilità d’impiego. Ma si ritenne che un’assunzione a
termine corrispondesse ad un’occasione di lavoro precaria. Al giudice restava il potere-
dovere di operare un controllo causale sulla giustificazione invocata dal datore di lavoro per
l’apposizione del termine al rapporto.
E. Una prima eccezione alla regola della necessaria causalità del lavoro a tempo determinato è
stata introdotta solo nel 2012 con la riforma Monti che, con il co. 1 del d.lgs. 368/2001, ha
escluso la necessità del requisito causale “nell’ipotesi del primo rapporto a tempo
determinato, di durata non superiore a dodici mesi”.
F. Di una effettiva liberalizzazione può parlarsi solo oggi all’esito della riforma voluta dal
Governo Renzi, prevista negli artt. da 19 a 29 del d.lgs. n. 81/2015, che ha del tutto
eliminato il requisito causale, ponendo solo un limite temporale all’impiego del lavoro a
tempo determinato e che costituisce l’attuale fonte di regolamentazione dell’istituto. In
primo luogo occorre notare che secondo l’art. 1 del d.lgs. n. 81/2015 “il contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”. La
regola attualmente vigente è che “al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un
56
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
termine di durata non superiore a trentasei mesi”. Quanto alla forma la legge prevede che
l’apposizione del termine “è priva di effetto” se non risulta direttamente o indirettamente da
atto scritto. In assenza di un’esplicita menzione del termine si parla di una vera e propria
inesistenza della clausola e dunque si ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si
esclude la necessità della forma scritta quando la durata del rapporto non sia superiore a
dodici giorni. Quanto ai limiti sostanziali la riforma ha innovato l’assetto preesistente
ponendo solo un limite di durata massima del rapporto a prescindere dalla ragione che lo
abbia giustificato. L’unica limitazione consiste nella circostanza che la durata dei rapporti di
lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore non superi i
trentasei mesi. È importante rilevare che si tiene conto anche dei periodi di missione avanti
ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti nell’ambito di somministrazioni
di lavoro a tempo determinato. Sono esclude da tale limitazione solo le attività stagionali,
individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché le attività
stagionali individuate dai contratti collettivi. Fino all’adozione del decreto ministeriale si
potrà far capo al d.p.r. 07/10/1963 n. 1525. Si tratta di attività legate alla vera stagionalità
naturale non solo propriamente agricole, ma anche industriali. Il limite dei trentasei mesi è
derogabile ad opera della contrattazione collettiva. Un ulteriore limite è dato dalla necessaria
proporzione fra il personale a tempo indeterminato e quello a tempo determinato. Il numero
complessivo di contratti a tempo determinato non può eccedere il limite del 20% del numero
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al primo gennaio dell’anno di assunzione.
Anche questa è derogabile, perché viene fatto salvo il potere di disporre diversamente. La
violazione del limite quantitativo non implica però la conversione a tempo indeterminato dei
rapporti eccedentari, ma solo una sanzione amministrativa. Sono escluse da limitazioni
quantitative le assunzioni a termine, che siano concluse: a) nella fase di avvio di nuove
attività per i periodi definiti dai contratti collettivi; b) da imprese start-up; c) per lo
svolgimento delle attività stagionali; d) per specifici spettacoli o specifici programmi
radiofonici o televisivi; e) per la sostituzione di lavoratori assenti; f) con lavoratori di età
superiore a 50 anni. Per i lavori propriamente stagionali non ci sono limitazioni né di durata
del rapporto né di carattere percentuale rispetto al normale organico dell’impresa. Il limite
percentuale non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti
pubblici di ricerca o enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva
attività di ricerca scientifica o tecnologica. Una regolamentazione diversa riguarda la
posizione soggettiva di taluni datori di lavoro. È prevista una totale liberalizzazione per i
datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Si assume che per tali datori è
“sempre possibile” la stipulazione di contratti a termine. Non è chiaro se la liberalizzazione
ha a che fare con il solo limite temporale o anche con il limite quantitativo. Un trattamento
speciale era riservato dall’art. 2 del d.lgs. n. 368/2001 alle imprese del settore del trasporto
aereo e dei servizi aeroportuali, posto che l’apposizione del termine è usualmente collegata a
esigenze standardizzate rispetto a determinati periodi dell’anno. Tali imprese potevano
ricorrere al lavoro a termine quando l’assunzione avesse “luogo per lo svolgimento dei
servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo
massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile e ottobre di ogni anno e di quattro
mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15%
dell’organico aziendale che risulti completamente adibito ai servizi” indicati. Un’analoga
previsione valeva per le imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste, anche se
per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile e ottobre di ogni anno,
e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al
57
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
15% dell’organico. Era previsto inoltre un onere di informazione circa le richieste di
assunzione nei confronti delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria. Tali
previsioni non sono state definitivamente travolte dalla nuova disciplina del 2015.
L’abrogazione della relativa disposizione è stata prevista con effetto dal 1° gennaio 2017. La
legge fa salve talune ipotesi di assunzione a termine, autorizzate da norme specifiche. In
questo ambito c’è la previsione di cui all’art. 8, 2° co., della l. n. 223/1991, secondo cui “i
lavoratori posti in mobilità possono essere assunti con contratto a termine di durata non
superiore a dodici mesi”. Anche nei confronti di tali lavoratori resta ferma l’applicazione del
principio di non discriminazione. Valgono per essi i medesimi criteri di computo che
valgono per i lavoratori a termine “ordinari”. Sono inoltre esclusi i rapporti tra i datori
agricoli e gli operai a tempo determinato, rimanendo regolati dalla disciplina speciale,
nonché i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Un’esenzione specifica è prevista, nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, in
relazione all’assunzione diretta di manodopera per l’esecuzione di speciali servizi di durata
non superiore a tre giorni. È liberamente apponibile il termine al rapporto di lavoro con i
dirigenti, purché di durata non superiore a cinque anni e con diritto di recesso da parte del
dirigente trascorso un triennio. La legge introduce una serie di divieti di assunzione a
termine di lavoratori, a tutela di specifici interessi che hanno la funzione di escludere
all’accesso ai contratti flessibili quelle imprese che non manifestino un adeguato livello di
responsabilità sociale. Si vieta l’assunzione a termine di lavoratori in sostituzione di
scioperanti, mentre a garanzia del rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro si vieta l’assunzione a termine nei confronti delle imprese che non abbiano effettuato
la valutazione dei rischi. Ulteriori situazioni di divieto sono dirette a tutelare la posizione
degli occupati presso l’impresa. In tale logica c’è la previsione che vieta l’assunzione a
termine presso unità produttive nelle quali si sia proceduto a licenziamenti collettivi, che
abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni dei lavoratori assunti a termine. È
fatto poi divieto di assumere a termine presso unità produttive nelle quali sia operante una
sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario. La violazione di tali divieti comporta la
trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro stipulato. Per quanto riguarda
l’apparato sanzionatorio: in primo luogo la clausola del termine va considerata inesistente e
dunque il rapporto si considera a tempo indeterminato, in assenza di pattuizione scritta. Più
complesso è quanto concerne le proroghe, nonché l’ipotesi di continuazione del rapporto
oltre la scadenza o di successive assunzioni a termine. Per “proroga” si intende il
prolungamento del termine di scadenza del rapporto originariamente fissato nel contratto
d’assunzione. Tale termine può essere prorogato solo quando la durata iniziale sia inferiore a
trentasei mesi. In questi casi sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell’arco
dei complessivi trentasei mesi. Ove il numero sia superiore si ha la trasformazione del
contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. Quanto alle
assunzioni a termine successive, ove il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro
dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi o venti giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si
trasforma in contratto a tempo indeterminato. Restano escluse sia le attività stagionali, sia le
imprese start-up innovative. Per quanto riguarda le conseguenze della continuazione del
rapporto oltre la scadenza si ha una sorta di moratoria in caso di continuazione del rapporto
oltre la scadenza per trenta giorni. In tale periodo non scatta la sanzione della conversione
del contratto, ma il datore è tenuto a maggiorare la retribuzione del 20% per i primi dieci
giorni e del 40% per ciascun giorno ulteriore. La continuazione oltre il trentesimo giorno
58
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
dalla scadenza, per i rapporti di durata inferiore a sei mesi, o oltre il cinquantesimo, per i
rapporti di durata superiore, comporta la conversione a tempo indeterminato. Resta il
problema di verificare in quale misura il lavoratore abbia diritto ad una ricostruzione
integrale del rapporto al momento in cui sopraggiunga la declaratoria giudiziale di
costituzione di un rapporto a tempo indeterminato. In passato al lavoratore era attribuito il
diritto al risarcimento integrale per il periodo intermedio. Successivamente era più volte
intervenuto il legislatore anche con discipline di dubbia costituzionalità. L’attuale assetto
prevede che il giudice condanna il datore al risarcimento del danno a favore del lavoratore
stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un
massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. È
un’indennità onnicomprensiva che risarcisce per intero il danno subito dal lavoratore. Se poi
la conversione del contratto consegue all’applicazione di contratti collettivi che prevedevano
l’assunzione di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche
graduatorie, il limite massimo dell’indennità è ridotto alla metà. Va notato che l’assetto
complessivo rappresenta un’eccezione rispetto alle regole generali di cui agli artt. 1218 e
seguenti c.c., con lo scopo di contemplare l’interesse del lavoratore alla conservazione del
posto con quello del datore a non subire le conseguenze della durata del processo. Il sospetto
di incostituzionalità, per l’ingiustificata disparità di trattamento fra il lavoratore subordinato
e gli altri contraenti, è però già stato considerato infondato dalla Corte costituzionale che ha
argomentato in funzione della razionalità della disposizione in quanto diretta a superare le
precedenti incertezze interpretative e della discrezionalità del legislatore nella scelta dei
modi di attuazione delle garanzie a favore del lavoratore. Un’importante novità è contenuta
nell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015 e riguarda la violazione da parte dell’impresa del
limite percentuale nell’assunzione di lavoratori a termine rispetto ai lavoratori a tempo
indeterminato. Tale forma di illegittimità è sanzionata attraverso una sanzione
amministrativa. Tale sanzione è pari al 20% della retribuzione, se il numero dei lavoratori
assunti in violazione del limite non sia superiore a uno, mentre è pari al 50% della
retribuzione, se il numero di lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia
superiore a uno. Al lavoratore a termine è garantita parità di trattamento rispetto al
lavoratore a tempo indeterminato, spettandogli il trattamento economico e normativo in atto
nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili. La
giurisprudenza aveva talora valutato legittime clausole contrattuali collettive che
escludevano da specifici trattamenti i lavoratori assunti per lavori di carattere transitorio o
eccezionale. La violazione del principio di non discriminazione rispetto al lavoratore a
tempo indeterminato è anche punita da sanzione amministrativa. I contratti collettivi
possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo
determinato ad “opportunità di formazione adeguata”. In tal modo si cerca di utilizzare lo
strumento del lavoro a tempo determinato come tecnica di promozione dell’occupazione. I
contratti collettivi possono inoltre definire le modalità per rendere ai lavoratori a tempo
determinato le informazioni relative ai posti di lavoro vacanti che si rendessero disponibili
nell’impresa. I medesimi contratti possono definire modalità e contenuti delle informazioni
da rendere alle rappresentanze sindacali dei lavoratori in ordine all’utilizzo del lavoro a
tempo determinato nell’impresa. Si prevede che, in relazione all’applicazione di qualsiasi
disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti
del datore, il computo dei lavoratori si basa sul numero medio mensile di lavoratori a
termine, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata
dei loro rapporti di lavoro. Ai lavoratori a termine spetta poi un diritto di precedenza in caso
59
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
di nuove assunzioni a tempo indeterminato. Si prevede che il lavoratore che abbia prestato
attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle
assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore entro i successivi dodici mesi. Si
assume poi che per le lavoratrici il congedo di maternità concorre a determinare il periodo di
attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza. A tali lavoratrici è inoltre
riconosciuto il diritto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato
effettuate dal datore entro i successivi dodici mesi. Condizione per l’esercizio del diritto di
precedenza è che il lavoratore manifesti la propria volontà entro sei mesi dalla data di
cessazione del rapporto. Il diritto di precedenza è soggetto a termine di decadenza di un
anno dalla cessazione del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda la problematica del recesso
bisogna ricordare che anche al rapporto a tempo determinato trova applicazione l’art. 2119
c.c., che prefigura la clausola generale della giusta causa. In caso di illegittimo esercizio del
potere di recesso il datore sarà obbligato a risarcire il danno, corrispondente alle retribuzioni
perdute. In passato è stata oggetto di discussione la questione dell’estensibilità al lavoro a
termine dell’onere di impugnazione del licenziamento illegittimo entro sessanta giorni. Alla
prima opinione si era obiettato non solo che la norma invocata si inseriva nel sistema di
tutela contro i licenziamenti nel rapporto a tempo indeterminato, ma che l’azione con cui il
lavoratore contestava la legittimità del proprio allontanamento alla scadenza del termine non
poteva qualificarsi come un’azione di impugnazione di un licenziamento. Ne deriva che il
lavoratore fa piuttosto valere un’azione di nullità negoziale. L’inestensibilità dell’onere di
impugnazione entro il breve termine di decadenza di sessanta giorni comportava per il
datore un’amplificazione di responsabilità. La giurisprudenza attenuava tale conseguenza
radicale, assumendo che il lavoratore avesse tacitamente rinunciato al diritto ad impugnare o
presumendosi l’intervento di una risoluzione consensuale. La materia è stata
successivamente rivisitata con l’art. 32 del “Collegato lavoro” che ha esteso anche all’azione
di nullità del termine apposto al contratto il regime delle impugnazioni avverso il
licenziamento; la disposizione è poi stata ritoccata dalla riforma Monti del 2012. Sul tema
dell’impugnazione ora dispone l’art. 28, 1° co., del d.lgs. n. 81/2015 che applica né più né
meno le medesime modalità previste dall’art. 6 della legge n. 604/1966 per il licenziamento
nel contratto a tempo indeterminato. Oggi il lavoratore è onerato di impugnare entro 120
giorni dalla scadenza del contratto e di proporre l’azione in giudizio entro i 180 giorni
successivi. L’impugnazione può aver corso con qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la
volontà del lavoratore. Per quanto concerne il lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni nel testo originario del d.lgs. n. 29/1993 era previsto un radicale divieto di
ricorrere ad assunzioni a tempo determinato di durata superiore a tre mesi. Attualmente l’art.
36, 2° co., del d.lgs. n. 165/2001 apre al ricorso a “forme contrattuali flessibili di assunzione
e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell’impresa”. Si tratta di una delegificazione che affida alla contrattazione
collettiva il potere di disciplinare “la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti
di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il
lavoro accessorio”. Resta fermo che le conseguenze della violazione di norme imperative
riguardanti il lavoro a termine mai potranno comportare la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione. Al lavoratore spetterà solo il
risarcimento dei danni. Di recente il principio è stato sottoposto al vaglio della Corte di
giustizia per verificarne la conformità all’accordo quadro sul lavoro temporaneo, attuato con
la direttiva del Consiglio n. 1999/70/CE. I giudici europei hanno ritenuto che la disparità fra
datori pubblici e privati non può dirsi in contrasto con la direttiva, in quanto la normativa
60
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
nazionale contenga un’altra misura diretta ad evitare e sanzionare una successione indebita
di contratti a tempo indeterminato nel settore pubblico. L’art. 29 del d.lgs. n. 81/2015
conferma l’esclusione del campo di applicazione della disciplina sul lavoro a termine dei
contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale
docente ed ATA. Un’ulteriore eccezione è stata operata con riferimento al comparto
sanitario, escludendosi l’applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 81/2015 ai contratti a
tempo determinato del personale sanitario del servizio sanitario nazionale.
L’INTERVENTO ETERONOMO DI ORDINE PUBBLICO
5. Vi è la necessità che l’intervento dello Stato realizzi il diritto del lavoro, attraverso la
predisposizione dei mezzi necessari a rendere effettivo tale diritto. Si allude agli strumenti di
politica attiva del lavoro, diretti ad intervenire sul mercato per promuovere l’occupazione. Ora ci
occuperemo di una serie di interventi che si collocano nella fase di costituzione del rapporto di
lavoro e che tendono a dare regolamentazione all’incontro tra offerta e domanda di lavoro.
L’intervento statale assolve ad una serie di funzioni: a) escludere attività speculative di mediazione
privata; b) garantire una equa distribuzione delle occasioni di lavoro; c) consentire al datore una
congrua selezione del personale. Fin dalla fine dell’Ottocento e fino all’avvento del sistema
corporativo quella del collocamento della manodopera costituiva una tipica attività sindacale. Ma il
limite intrinseco del collocamento amministrato dal sindacato deriva naturaliter dal diverso peso e
dalla diversa forza che le varie associazioni possono avere nei vari settori produttivi, con la
conseguenza che finiscono per essere privilegiate nell’accesso al lavoro solo le aristocrazie dei
lavoratori. Fu il legislatore corporativo a concepire il collocamento come funzione pubblica, con il
correlativo divieto di mediazione privata, anche se l’amministrazione concreta del collocamento
veniva esercitata dal sindacato. Anche l’ordinamento repubblicano conservò il monopolio pubblico
del collocamento. La legge fondamentale in materia prevedeva inoltre la regola della richiesta
numerica da parte dei datori. Questi ultimi dovevano inoltrare agli uffici di collocamento una
richiesta generica di lavoratori, senza identificarli nominativamente. Nell’assetto della legge del ’49
il ruolo del sindacato transitava a quello di un soggetto che aveva un diritto di partecipazione
nell’ambito degli organi burocratici. Il sistema del collocamento pubblico post-costituzionale non
ha peraltro mai soddisfatto le esigenze per cui era nato. La mediazione tra offerta e domanda si
riduceva ad una convalida di carattere burocratico a posteriori di intese già raggiunte in via di fatto
tra le parti. Il legislatore si è così volto a modifiche più radicali del sistema, semplificando anzitutto
la procedura di allocazione dei lavoratori. Il legislatore ha infine messo mano ad una riforma ancor
più radicale diretta all’eliminazione del divieto di mediazione privata e ad un più ampio
decentramento organizzativo a livello regionale con l’abrogazione di gran parte della normativa
previgente.
6. Una spinta decisiva nella direzione del rinnovamento del sistema venne dalla comunità europea.
Nel 1997 infatti la Corte di giustizia delle comunità ha dichiarato il monopolio pubblico italiano del
collocamento italiano in contrasto con i principi di libera concorrenza e con il divieto di abuso di
posizione dominante. Attenzione però che la sentenza non ha dichiarato illegittimo l’affidamento
della funzione di mediazione fra domanda e offerta di lavoro ad un organo pubblico, ma ha
dichiarato che i principi comunitari sono violati se gli uffici pubblici non sono oggettivamente in
grado di adempiere a tale specifica funzione. Il legislatore italiano è intervenuto con il d.lgs. n.
469/1997, abrogando il divieto di mediazione privata. Con il d.lgs. n. 276/2003 è poi stata ampliata
la platea dei soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività e rivisitati i requisiti per il suo
svolgimento. Sono state fissate cinque funzioni, che possono essere svolte dalle agenzie: la
61
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
somministrazione di lavoro a tempo determinato e la somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato, l’intermediazione, la ricerca e selezione del personale ed il supporto alla
ricollocazione professionale. Tali attività possono essere svolte solo da soggetti autorizzati
dall’autorità centrale, denominati appunto agenzie per il lavoro. i requisiti che devono possedere le
agenzie e le modalità di iscrizione nell’albo sono comuni a tutte le agenzie. La riforma del 2003 ha
poi allargato il novero dei soggetti abilitati all’attività di intermediazione. La medesima attività può
essere svolta delle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più significative sul
piano nazionale, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale nazionale e che hanno
come oggetto sociale la tutela e l’assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro e delle
disabilità, etc. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di intermediazione, ricerca e selezione del
personale e supporto alla ricollocazione professionale può essere concessa anche dalle regioni e
dalle province autonome. Il decreto correttivo del d.lgs. n. 276/2003 ha cercato di eliminare una
possibile fonte di contenzioso fra stato e regioni, stabilendo che sono le regioni stesse a disciplinare
le procedure di autorizzazione. Il Collegato lavoro ha introdotto una sorta di autorizzazione
“provvisoria” da parte del ministero del lavoro “in attesa delle normative regionali”. Nel sistema
possono operare: a) su tutto il territorio nazionale, soggetti muniti di autorizzazione statale; b) in
ambito regionale, soggetti muniti di sola autorizzazione regionale; c) in ambito regionale, soggetti
muniti di autorizzazione statale. Tale assetto priva di significato l’autorizzazione regionale. A tutti i
soggetti abilitati all’esercizio delle funzioni di collocamento è imposto il rispetto di una serie di
garanzie per i lavoratori che accedano al servizio. È confermato il principio della gratuità del
servizio per i lavoratori. Ai medesimi soggetti è fatto divieto di svolgere indagini o trattare i dati o
preselezionare i lavoratori in base ad una lunga serie di indici di potenziale discriminazione. La
liberalizzazione dell’intermediazione privata non ha comportato l’eliminazione della relativa
funzione pubblica. Allo scopo di garantire una qualche forma di coordinamento fra le due sfere il
d.lgs. n. 469/1997 ha istituito il Sistema informativo lavoro (SIL) che è “l’insieme delle strutture
organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti” del
collocamento. Il d.lgs. n. 276/2003 ha introdotto l’istituto della Borsa continua nazionale del lavoro,
che ha funzione di creare una rete di collegamenti informatici fra gli operatori ed i destinatari dei
servizi. Il Collegato lavoro ha previsto che l’interconnessione con la borsa del lavoro e l’invio
all’autorità concedente di ogni informazione richiesta costituisce condizione per l’iscrizione e la
permanenza nell’albo delle agenzie sia di intermediazione che di somministrazione. Il secondo
pilastro è stato il decentramento amministrativo, attuato con il d.lgs. n. 469/1997. Con esso sono
stati conferiti alle regioni i compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro. Una
sterzata nella direzione di un parziale riaccentramento amministrativo è stata realizzata con il d.lgs.
n. 150/2015, emanato a seguito della legge di delegazione n. 183/2014. Il decreto del 2015 ha
abrogato i decreti legislativi nn. 468 e 469/1997. È stata istituita la Rete nazionale dei servizi per le
politiche del lavoro. Lo scopo è quello di promuovere l’effettività dei diritti al lavoro, alla
formazione ed all’elevazione professionale previsti dalla Costituzione ed il diritto di ogni individuo
ad accedere a servizi di collocamento gratuito. Il coordinamento dell’attività della Rete è affidato
all’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro). I compiti e le funzioni sono
descritti nell’art. 9 del d.lgs. n. 150/2015. Per garantire i livelli essenziali di prestazioni attraverso
meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il ministero del lavoro stipula una convenzione
finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro
e delle politiche attive del lavoro. Fra gli strumenti messi in campo per garantire un efficiente
coordinamento si istituisce il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, per
condividere inoltre il fascicolo elettronico del lavoratore. Venendo alle procedure che ora regolano
il procedimento di collocamento dei lavoratori, occorre ricordare che vige per tutti i datori, e per
62
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
qualunque tipo di rapporto, il principio dell’assunzione diretta. Il datore è onerato di inviare
all’ANPAL una comunicazione contenente i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la
tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.
Tale obbligo va adempiuto entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto. Un
regime derogatorio è previsto per le agenzie di lavoro autorizzate, che possono procedere alla
comunicazione entro il ventesimo giorno del mese successivo all’assunzione dei lavoratori
temporanei e anche nel settore turistico. L’omessa comunicazione è punita con una sanzione
amministrativa. Nel decreto “semplificazioni” si è prevista una sorta di sanatoria in caso di omessa
denuncia preventiva di assunzione. A tale situazione si applica la procedura di diffida di cui all’art.
13 del decreto legislativo 23/04/2004 n. 124. Nel sistema attuale non ha rilievo l’iscrizione nelle
liste di collocamento che aveva la funzione di garantire un’equa distribuzione delle occasioni di
lavoro. Per l’assunzione presso i datori di lavoro pubblici vige la regola del concorso, fatte salve le
qualifiche ed i profili per i quali si richiede il solo requisito dell’istruzione obbligatoria, rispetto ai
quali si prevede il sistema dell’avviamento numerico a procedure selettive. Il forte impulso dato dal
d.lgs. n. 276/2003 all’ampliamento della platea dei soggetti autorizzati alla mediazione fra domanda
e offerta di lavoro rischia di ingessare il mercato di lavoro se non sono messi in grado di funzionare
i sistemi di collegamento fra i vari operatori. Quanto ai rapporti stato/regioni la riforma accentua i
momenti di conflittualità con riferimento alle rispettive competenze. La riforma del collocamento
ha interessato anche i settori per i quali in passato era stata prevista una regolamentazione
diversificata per l’accesso al lavoro. Con normativa speciale è regolata la situazione dei lavoratori
stranieri extra-comunitari che prestano attività lavorativa in Italia. La materia è disciplinata dal
d.lgs. 25/07/1998 n. 286, con le modificazioni introdotte dalla legge 30/07/2002 n. 189. È una
regolamentazione che costituisce la risposta italiana al ben noto fenomeno dell’immigrazione di
massa e che cerca di fare emergere dall’illegalità il maggior numero possibile di immigrati. Si basa
su un sistema di quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato. Ai fini del
collocamento al lavoro sono previste speciali procedure. Il datore che intenda instaurare un rapporto
di lavoro con un extra-comunitario deve rivolgere una richiesta nominativa di nulla osta al lavoro
allo sportello unico per l’immigrazione. Resta ferma la possibilità per il datore di formulare una
richiesta numerica di lavoratori iscritti nelle liste previste in accordi bilaterali fra gli stati. All’esito
della verifica della posizione dello straniero, viene rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di
lavoro. Di recente è stata prevista la possibilità, per lo straniero in possesso da almeno 5 anni del
permesso di soggiorno, di ottenere dal questore il rilascio di un permesso U.E. per i soggiorni di
lungo periodo a tempo indeterminato. Ai lavoratori stranieri viene garantita parità di trattamento e
piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
7. L’ordinamento si occupa inoltre di fornire una tutela supplementare a soggetti come disabili,
imponendo ai datori di lavoro obblighi di assunzione. Queste tecniche d’intervento normativo
ebbero origine nel primo dopoguerra per agevolare la collocazione al lavoro dei tanti reduci
invalidi. Successivamente la platea dei beneficiari si è estesa ad altre categorie di invalidi ed a
soggetti perfettamente validi ma ugualmente svantaggiati. Il sistema è stato ritenuto
costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale. La materia era stata riordinata con la l. n.
482/168. Anche nel caso del collocamento dei lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate però
la strategia normativa non è riuscita a raggiungere gli obiettivi prefigurati. Da una parte le imprese
hanno vissuto l’obbligo come una limitazione della propria autonomia. Per altro verso la pubblica
amministrazione non è mai riuscita a gestirne l’applicazione con equilibrio ed efficienza. Tutto ciò
ha indotto il legislatore a rivisitare la disciplina con la legge 12/03/1999 n. 68, puntando su una
riduzione del numero di lavoratori da assumere obbligatoriamente e su una strategia di
incentivazioni all’assunzione. Le legge del 1999 è stata poi modificata e integrata dal d.lgs. n.
63
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
151/2015, restando la fonte di regolamentazione della materia. La legge si propone di promuovere
l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso
servizi di sostegno e di collocamento mirato. Quest’ultimo allude agli “strumenti tecnici e di
supporto” che consentono una valutazione adeguata dei disabili e della loro capacità lavorativa.
L’art. 1 del d.lgs. n. 151/2015 delinea le linee guida del collocamento mirato, le quali si devono
attenere a vari principi fissati dalla legge. I soggetti protetti sono: a) gli invalidi fisici, psichici o
sensoriali ed i portatori di handicap intellettivo, con una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 45%; b) gli invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%; c) i non
vedenti e sordomuti; d) gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio con minorazioni ascritte
dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra; e) i titolari dell’assegno ordinario di invalidità. L’obbligo di assunzione è
imposto ai datori di lavoro pubblici e privati nelle seguenti misure: a) 7% dei lavoratori occupati, se
occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un
lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni
l’obbligo va soddisfatto con riferimento a qualifiche per le quali è richiesto solo il requisito della
scuola dell’obbligo. Per le altre qualifiche c’è il pubblico concorso, nel cui ambito va riservato un
numero di posti pari alla quota d’obbligo e comunque non superiore al 50% dei posti messi a
concorso. I bandi di concorso prevedono modalità di svolgimento delle prove di esame per
consentire ai suddetti soggetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri. In caso di
violazione degli obblighi di assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni si applicano altresì
le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste per i responsabili del procedimento
amministrativo. Una disciplina di favore è prevista per le organizzazioni di tendenza, statuendosi
che la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e
svolgente funzioni amministrative e l’obbligo insorge solo in caso di nuova assunzione. Per la
polizia, la protezione civile e la difesa nazionale, l’obbligo ha solo riferimento ai servizi
amministrativi. Gli obblighi di assunzione sono sospesi nei confronti delle imprese interessate
dall’intervento della cassa integrazione e per la durata dei programmi contenuti nella relativa
richiesta di intervento. Sono inoltre sospesi per la durata della procedura di mobilità e per il periodo
in cui permane il diritto di precedenza dell’assunzione di cui all’art. 8, 1° co., della l. 223/91. La
legge regola con maggiore realismo rispetto al passato le situazioni di esonero parziale o totale. Una
fattispecie generale di esonero riguarda le mansioni, che, in relazione all’attività delle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici non economici, non consentono l’occupazione di lavoratori
disabili. Tali mansioni sono individuate con decreto del Ministero del lavoro. Inoltre sono esonerati
dall’obbligo i datori pubblici e privati che operano nel settore del trasporto per il personale
viaggiante e navigante e gli altri datori che non possono occupare l’intera percentuale di disabili
prevista dalla legge. L’esonero parziale è condizionato al versamento al Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili di un contributo esonerativo. È comunque ammessa la “compensazione
territoriale”, cioè la possibilità che il datore sia autorizzato ad assumere un numero i disabili
superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di disabili
assunti in altre unità produttive. La legge poi chiarisce i criteri di computo della quota di riserva,
considerando che vadano presi in considerazione i lavoratori assunti con contratto di lavoro
subordinato ed escludendone però certe categorie. Si fanno salve le ulteriori esclusioni previste
dalle discipline di settore. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro,
sono computati nella quota di riserva nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al
testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra o con disabilità intellettiva e psichica, con
riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. I soggetti divenuti invalidi in costanza di
64
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
rapporto di lavoro sono computabili nella quota d’obbligo solo se la riduzione della loro capacità
lavorativa è non inferiore al 60%. Per tali lavoratori l’infortunio o la malattia non sono motivo di
licenziamento nel caso in cui possano essere adibiti a mansioni equivalenti o inferiori. Ove non
siano assegnabili a mansioni equivalenti o inferiori, hanno diritto ad essere avviati presso altra
impresa, senza un nuovo inserimento nella graduatoria. Per il computo dei lavoratori a tempo
parziale valgono i medesimi criteri previsti dall’art. 18 dello statuto dei lavoratori. Sono inoltre
computabili i lavoratori a domicilio o che svolgano telelavoro. Anche il collocamento obbligatorio è
amministrato dai medesimi soggetti pubblici, cui è demandato il collocamento ordinario. Tali
soggetti si occupano della tenuta delle liste, delle convenzioni e di quant’altro previsto dalla legge
altresì della programmazione, attuazione e verifica degli interventi per l’inserimento dei disabili al
lavoro. I lavoratori disabili devono iscriversi in appositi elenchi tenuti dai servizi per il
collocamento mirato territorialmente competenti. Quanto al procedimento di collocamento si
ricorda che, nel precedente assetto, il datore era onerato di auto-denunciare la dimensione del
proprio organico e fare richiesta dell’assunzione dei soggetti protetti. L’omessa richiesta non
autorizzava l’avviamento d’ufficio degli invalidi, che era considerato illegittimo, residuando in capo
al datore solo la sanzione amministrativa. La nuova legge, pur riconfermando l’obbligo di inviare
un prospetto dal quale risultino il numero complessivo di lavoratori occupati, il numero e i
nominativi dei lavoratori computabili nella quota ed i posti e le mansioni disponibili per
l’assunzione obbligatoria, pone l’avviamento d’ufficio in secondo piano. Secondo l’art. 7 della
legge del 1999 i datori e gli enti pubblici economici possono assumere i lavoratori mediante
richiesta nominativa o mediante la stipula di convenzioni. È così generalizzata la richiesta
nominativa dei lavoratori che era prevista solo in particolari condizioni. La richiesta nominativa può
essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare una preselezione delle persone
con disabilità iscritte negli elenchi. È solo nel caso in cui l’impresa non si avvalga della richiesta
nominativa che scatta l’avviamento d’ufficio. Anche nell’attuale sistema si conferma che la fonte
del contratto di lavoro è riconducibile ad un moto di volontà del datore. Il lavoratore avviato ha
l’onere di presentarsi al datore entro termini brevi e la direzione territoriale del lavoro può disporre
la decadenza dall’indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle liste di collocamento per un
periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive non risponda alla convocazione o
rifiuti il posto di lavoro offerto. Il sistema di assunzione mediante convenzione consiste nella
stipulazione di una convenzione fra datore ed ufficio competente, che ha ad oggetto la
determinazione di un programma per l’attuazione degli scopi della legge. Inoltre vi sono stabiliti i
tempi e le modalità delle assunzioni che il datore si impegna ad effettuare. Su proposta della
Commissione provinciale per le politiche del lavoro, possono essere concesse deroghe ai limiti d’età
e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato. La legge fa inoltre leva
sull’istituzione di particolari incentivazioni economiche. Gli uffici competenti possono inoltre
promuovere ogni iniziativa utile a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso
convenzioni con le cooperative sociali nonché con le organizzazioni di volontariato o con altri
soggetti pubblici e privati. Una forma inedita di incentivazione all’assunzione degli invalidi è
prevista dall’art. 12 della legge. Si ipotizza la stipulazione di speciali convenzioni fra gli uffici
competenti e i datori, mediante le quali si conviene che il disabile venga assunto dal datore, ma
venga utilizzato dalla cooperativa sociale o dal libero professionista, in contropartita dell’obbligo
assunto dal datore di garantire determinate commesse di lavoro che consentano al terzo utilizzatore
di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il rapporto di
lavoro è a tempo indeterminato con il datore destinatario degli obblighi assuntivi, anche se il
lavoratore viene inviato a tempo determinato. Una disciplina più specifica è prevista per le
convenzioni relative all’inserimento lavorativo di persone disabili che presentino particolari
65
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
caratteristiche e difficoltà di collocazione. Il rapporto di lavoro con i disabili deve essere a tempo
pieno e indeterminato. La legge conferma l’apponibilità del patto di prova al contratto, tranne che la
prova non riguardi mansioni incompatibili con l’invalidità. All’invalido si applica il normale
trattamento previsto dalla legge e dai contratti collettivi. Il datore non può chiedere al disabile una
prestazione non compatibile con le sue minorazioni. Nel caso di aggravamento delle condizioni di
salute, il disabile o il datore possono chiedere ad un’apposita commissione che venga accertata la
compatibilità delle mansioni affidate con lo stato di salute. Qualora si riscontri una condizione di
aggravamento, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che
l’incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio
informativo. La semplice richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento
non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. La nozione di “possibili adattamenti
dell’organizzazione del lavoro” va commisurata alla concreta struttura produttiva, dovendo tener
conto della libertà di iniziativa economica. Anche la materia del licenziamento rientra nella garanzia
di parità di trattamento. Una disciplina speciale si prevede solo per il licenziamento per riduzione
del personale o per il giustificato motivo oggettivo. Tali forme sono annullabili qualora il numero
dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva. In tutti i casi
di risoluzione del rapporto, il datore è tenuto a darne comunicazione agli uffici competenti, al fine
della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all’avviamento obbligatorio. La legge del
’99 ridisegna il quadro delle sanzioni. In caso di mancato invio del prospetto periodico è prevista
una sanzione per ritardato invio del prospetto, maggiorata per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti appartenenti alle
categorie protette, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la quota
dell’obbligo, il datore è tenuto al versamento di una somma giornaliera per ciascun lavoratore
disabile che risulta non occupato. Una tecnica indiretta di promozione dell’osservanza della legge
consiste nel prevedere l’obbligo per le imprese di presentare una dichiarazione che attesti
l’adempimento degli obblighi di assunzione, pena l’esclusione. Secondo l’assetto nel precedente
sistema l’obbligo di assunzione inadempiuto dava diritto all’invalido a pretendere la condanna del
datore al risarcimento dei danni, mentre si escludeva che il lavoratore potesse ottenere la
costituzione coattiva del contratto di lavoro. Siffatta conclusione era per solito giustificata in
ragione dell’indeterminatezza degli elementi del contratto da stipulare. La nuova legge sembra
togliere fondamento a quest’ultimo argomento con il connesso diritto anche di scelta della qualifica.
Sezione III: LA FASE ESECUTIVA
LA PRESTAZIONE DI LAVORO. A) L’OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
1. La prestazione di lavoro è l’oggetto della principale obbligazione del lavoratore nell’ambito del
contratto di lavoro. È dedotta nel contratto facendo riferimento a dei nomina, i quali alludono a tre
grandi distinzioni fra i lavoratori: la categoria, la qualifica e la mansione. Le distinzioni esprimono
il diverso “valore” di ciascuna prestazione di lavoro. Le differenziazioni indicate fra i vari modi di
rendere il lavoro corrispondono d’altra parte anche ai dati di riconoscibilità sociale. Dietro le
classificazioni può intravvedersi ciò che resta dell’antico e nobile mestiere, frantumato dall’avvento
del sistema di fabbrica e dalla divisione del lavoro. Il mestiere è non solo suddiviso fra una pluralità
di lavoratori, ma è oggetto di parcellizzazione e scomposizione (organizzazione scientifica del
lavoro). Le tre nozioni sono graficamente rappresentabili come cerchi concentrici o insiemi.
Muovendo dal basso rileviamo anzitutto che la mansione identifica i compiti e corrisponde
all’oggetto dell’obbligazione di lavoro. il sotto-insieme costituito dalla mansione si colloca poi nel
grande insieme costituito dalla qualifica. Quest’ultima si può definire come la sintesi di un
66
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
complesso di mansioni. Infine la categoria identifica il criterio più ampio di classificazione. Oltre
alle quattro categorie di origine legale, ossia operai, impiegati, quadri e dirigenti, vi sono anche
categorie create dalla contrattazione collettiva. È da menzionare la categoria degli intermedi, che,
nel settore industriale, si colloca tra la categoria di operai e di impiegati. La categoria in questione
ha avuto un fugace riconoscimento legislativo dapprima con il decreto Spinelli, emanato dalla
Repubblica di Salò, e successivamente con la recezione in decreto legislativo del “concordato”
23/05/1946 per il settore industriale. Nei settori del credito e delle assicurazioni è diffusa invece la
figura del funzionario. Il nuovo testo dell’art. 2103 c.c., come modificato dal d.lgs. n. 81/2015,
rivitalizza le categorie legali di cui all’art. 2095 c.c., che costituiscono ora il limite esterno nei
confronti della mobilità del lavoratore.
2. L’art. 2095 c.c., dopo aver individuato le quattro categorie legali in cui si distinguono i prestatori
di lavoro, opera un rinvio alle leggi speciali e/o alla contrattazione collettiva per la determinazione
“in relazione a ciascun ramo di produzione e della particolare struttura dell’impresa” dei requisiti di
appartenenza alle medesime. Premesso che le uniche leggi speciali che identificano le categorie
sotto l’aspetto definitorio riguardano gli impiegati e i quadri, il rinvio alla contrattazione collettiva
ha una singolare latitudine. Esso implica sia la libertà dell’autonomia collettiva di introdurre nuove
categorie sia quello di procedere a raggruppare e/o unificare i trattamenti economico-normativi di
soggetti appartenenti a categorie legali diverse. In primo piano vi è la questione della distinzione fra
le nozioni di operaio ed impiegato. Il punto di riferimento è costituito dall’art. 1 del r.d.l. n.
1825/1924 che contiene il primo embrione di regolamentazione normativa del rapporto di lavoro.
Gli elementi di identificazioni dell’impiegato consistono: a) nella normale continuità del relativo
rapporto; b) nel carattere “professionale” dell’attività dedotta; c) nella collaborazione “tanto di
concetto che di ordine”. Il riferimento all’operaio è ricostruibile in ragione dell’esclusione delle
prestazioni puramente manuali, con l’idea secondo cui la prestazione dell’operaio dovrebbe
caratterizzarsi per la prevalente manualità. Sennonché quest’ultima indicazione appariva priva di
contenuto discretivo. È per questa ragione che la giurisprudenza tendeva a far prevalentemente leva
sull’elemento della collaborazione. Normalmente l’impiegato collaborava direttamente alla gestione
dell’impresa, era cioè un collaboratore diretto del datore, laddove l’operaio era impegnato nella
produzione, collaborava cioè nell’impresa. Ma anche il descritto escamotage linguistico è apparso
inidoneo allo scopo per cui era stato proposto. Il superamento della distinzione è da ricollegarsi
anzitutto alle modificazioni dei processi produttivi. È corrisposto un parallelo riavvicinamento dei
trattamenti normativi. Questo riavvicinamento è culminato in una riscrittura e risistemazione delle
categorie legali per effetto dell’inquadramento unico. Le disparità di trattamento di origine
legislativa fra le due categorie venivano sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale. La Corte
riteneva incostituzionali le disparità relative: a) ai requisiti di accesso alla pensione di invalidità, b)
all’obbligo assicurativo nei confronti della disoccupazione involontaria, c) al trattamento per il
richiamo alle armi, d) alla durata del periodo di comporto per malattia. Ulteriori disparità sono poi
progressivamente rimosse per effetto degli interventi legislativi. Attualmente fra le due categorie
residuano differenze in ordine alla durata dei periodi di prova e di preavviso.
3. Alle tre categorie legali, previste dall’art. 2095 c.c., è stata affiancata per effetto della legge
13/05/1985 n. 190 la nuova categoria dei quadri. Il legislatore ha così accolto le rivendicazioni
dell’élite della classe impiegatizia che si riteneva ingiustamente penalizzata dalle politiche
egualitaristiche che comportavano disaffezione verso il lavoro e la compressione delle
professionalità, e che si stava organizzando con la costituzione di sindacati monocategoriali.
Secondo l’art. 2, 2° co., della legge del 1985 la categoria “è costituita dai prestatori di lavoro
subordinato che, pur non appartenendo alla classe dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere
67
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi
dell’impresa”. I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri devono essere stabiliti dalla
contrattazione collettiva in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura
dell’impresa. Ai quadri si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati. L’autonomia
collettiva ha provveduto a collocare nella nuova categoria gli impiegati più alti in grado, con
l’attribuzione di benefici, non particolarmente rilevanti. La contrattazione collettiva successiva alla
legge del 1985 ha optato per una più modesta collocazione dei quadri, all’apice della carriera
impiegatizia, ma al di sotto del livello dei funzionari, che hanno mantenuto la loro autonomia. La l.
n. 190/1985 introduce alcune specifiche forme di tutela. Esse hanno riguardo: a) alla previsione di
un obbligo assicurativo a carico del datore nei conforti dei rischi di responsabilità civile verso terzi;
b) al rinvio alla contrattazione collettiva della delega ad individuare modalità tecniche di
valutazione e determinazione del corrispettivo in relazione all’utilizzazione da parte dell’impresa di
innovazioni di rilevante importanza nei processi produttivi, introdotte dai quadri.
4. La figura del dirigente si confonde a lungo con quelle di soggetti non legati all’imprenditore da
un rapporto di lavoro subordinato, ma da relazioni giuridiche di diversa natura. L’inserimento dei
dirigenti nel novero dei lavoratori dipendenti è resa possibile dalla ricostruzione del procedimento
di qualificazione della subordinazione in termini di “oggetto” della prestazione dedotta e non con
riferimento ai profili soggettivi. Nei confronti del dirigente trova applicazione lo statuto giuridico
del lavoratore subordinato, tranne alcune eccezioni. Il dirigente è escluso dall’applicazione della
disciplina sull’orario di lavoro e da quella sui riposi settimanali. La sua assunzione a termine
incontra meno vincoli per il datore. Inoltre il medesimo è escluso dall’ambito di applicabilità della
tutela legale contro i licenziamenti. La prima definizione di dirigente è quella prevista dall’art. 6
della l. sull’impiego privato del 1924 che richiama “i direttori tecnici ed amministrativi e gli altri
capi d’ufficio, di servizi con funzioni analoghe, gli institori in generale e gli impiegati muniti di
procura”. La rappresentanza sindacale autonoma è rimasta, a conferma della posizione giuridica del
dirigente, che è sì un lavoratore subordinato, ma, nei confronti degli altri dipendenti, appare come
un datore di lavoro. È proprio in ragione di tale origine storica che la giurisprudenza ha a lungo
identificato il dirigente esclusivamente con l’alter ego del datore di lavoro, che esercita le proprie
funzioni su tutta l’impresa ed essendo sottoposto soltanto alle direttive generali del datore di lavoro.
Il carattere “chiuso” della categoria era avallato dall’atteggiamento della contrattazione collettiva
che ha a lungo perpetuato le clausole di riconoscimento formale. In base ad esse si escludeva il
potere giudiziale di attribuzione della categoria dirigenziale ad un determinato lavoratore, essendo
necessario il riconoscimento formale dal datore di lavoro. Dalla metà degli anni settanta la
giurisprudenza ha dichiarato l’illegittimità di tali clausole. È anche tale mutato atteggiamento che ha
consentito di prendere atto dell’intervenuta evoluzione della categoria dirigenziale. Si è trattato
comunque di un avvallo di scelte proposte dalla contrattazione collettiva e non dedotte dalla realtà
sociale. L’operazione giurisprudenziale ha agito nella direzione di individuare vari gradi della stessa
unitaria categoria. Un ruolo essenziale è dato alla figura del dirigente nell’ambito del processo di
contrattualizzazione del pubblico impiego: la figura del dirigente coincide con quella del datore
“sostanziale” dei pubblici dipendenti e quindi, in sostanza, riformare la categoria della dirigenza
pubblica significa riformare la stessa pubblica amministrazione. Il processo relativo è stato attuato a
tappe successive ed è consacrato nel d.lgs. n. 29/1993, emendato ad opera del d.lgs. n. 80/1998. Il
quadro al cui interno si inserisce la regolamentazione della dirigenza pubblica è quello della
separazione fra responsabilità politica e responsabilità amministrativa. La regolamentazione di
confini è segnata dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/2001 che attribuisce agli organi di governo le funzioni
di indirizzo politico-amministrativo con la definizione degli obiettivi e dei programmi ed alla
dirigenza l’adozione degli atti amministrativi nonché la gestione finanziaria, tecnica ed
68
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
amministrativa, con specifica assunzione di responsabilità della gestione di tale attività e dei relativi
risultati. La svolta decisiva è costituita dall’eliminazione del potere di avocazione del Ministro nei
confronti degli atti dirigenziali, che era originariamente previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 29/1993. Il
testo della norma è stato modificato per effetto del d.lgs. n. 80/1998, statuendosi che il ministro non
può revocare, riformare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei
dirigenti. Nei casi di inerzia del dirigente o di grave inosservanza delle direttive generali, il ministro
può nominare un commissario che si sostituisca al dirigente inadempiente. Il quadro è stato
edulcorato per effetto della legge 15/07/2002 n. 145, emanata dal governo di centro-destra e che ha
novellato il Titolo I, Capo II del d.lgs. n. 165/2001. La materia è stata poi rivisitata dall’art. 34, 25°
co., della l. n. 289/2002 e dall’art. 14 della l. 229/2003. Infine con d.p.r. 272/2004 è stato approvato
il regolamento per l’accesso alla dirigenza. Particolare attenzione è posta ai profili della
responsabilità dei dirigenti. Ambedue le fasce dirigenziali sono responsabili del risultato dell’attività
svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati. Il
controllo è affidato a dei “nuclei di valutazione”, che sono organi indipendenti dall’amministrazione
e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi o l’inosservanza delle direttive comportano l’esclusione al rinnovo del medesimo incarico
dirigenziale. L’amministrazione può inoltre revocare l’incarico. Si prevede inoltre che il dirigente
possa essere assegnato ad altri incarichi, prima della scadenza, con conservazione del trattamento
economico, per motivate ragioni organizzative. Con la legge 07/08/2015 n. 124 il governo è stato
delegato ad emanare una serie di decreti legislativi in materia di riforma della dirigenza pubblica. I
decreti dovranno avere ad oggetto: a) l’istituzione del sistema della dirigenza pubblica; b) la
revisione dell’inquadramento; c) la ridefinizione delle regole per l’accesso alla dirigenza; d) le
regole relative alla formazione dei pubblici dipendenti e dei dirigenti; e) la semplificazione della
mobilità della dirigenza; f) il conferimento e la durata degli incarichi dirigenziali; g) la valutazione
dei risultati; h) la responsabilità dirigenziale; i) il trattamento economico.
5. Occorre ora dar conto delle tecniche utilizzate ai fini dell’inquadramento dei lavoratori all’interno
delle categorie. La tradizionale suddistinzione dei lavoratori nelle qualifiche ha avuto corso fino agli
anni sessanta. Una decisiva spinta verso la modifica ci fu sull’onda delle politiche egualitarie della
fine degli anni sessanta e produsse il sistema dell’inquadramento unico, che è ancora in atto per tutti
i settori produttivi, se pure con qualche aggiustamento. Tale sistema ha comportato una riscrittura
dei rapporti fra le categorie legali con la sostituzione ad esse dei livelli, che costituiscono
contenitori, al cui interno sono collocate insieme posizioni di lavoro sia operaie che impiegatizie. I
lavoratori sono inquadrati in un’unica “scala classificatoria” composta da un certo numero di
categorie, al cui interno ci sono una serie di figure professionali che svolgono mansioni considerate
“equivalenti”. L’inquadramento dei lavoratori nelle categorie viene effettuato sulla base delle
declaratorie e dei profili. La declaratoria “determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i
requisiti indispensabili per l’inquadramento nella categoria stessa”. Essa fa riferimento ad una serie
di fattori quali: a) la misura della conoscenza ed esperienza necessarie per lo svolgimento
dell’attività; b) il grado di autonomia nello svolgimento dei compiti affidati; c) la circostanza che al
lavoratore venga affidata la guida ed il controllo di altri dipendenti; d) la misura e l’importanza
della responsabilità posta in capo al lavoratore. I profili invece “descrivono il contenuto
professionale delle mansioni in essi individuate”. È attraverso la descrizione dei profili professionali
che possiamo cogliere la specificità dell’inquadramento unico. L’inquadramento unico ha
sostanzialmente resistito all’onda d’urto revisionista degli anni ottanta. Le più recenti tendenze
degli anni novanta segnalano l’esigenza di tener conto del dato dell’instabilità degli assetti
organizzativi, cercando di spostare a livello aziendale l’asse della pianificazione delle posizioni di
lavoro. Il ruolo dell’autonomia collettiva in materia di inquadramento si esprime nell’affermazione
69
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
dell’insindacabilità dei criteri di individuazione delle qualifiche e di collegamento ad esse dei
compiti espletati dai lavoratori. Il procedimento di verifica delle mansioni svolte dal lavoratore e
collegamento ad esse di un determinato inquadramento ha carattere sussuntivo. Tale procedimento
ha ad oggetto la ricognizione delle mansioni effettivamente svolte, dovendosi escludere che possa
rilevare la circostanza che ad altri lavoratori sia riconosciuto l’inquadramento superiore. Ben può
infatti il datore riconoscere ad un determinato lavoratore un inquadramento superiore, a titolo
convenzionale, al solo scopo di assicurargli un trattamento economico-normativo più favorevole.
Dei problemi si pongono nel caso in cui il lavoratore svolga un complesso di attività polivalenti, le
cui singole parti sono astrattamente collocabili in livelli di inquadramento diversi. La
giurisprudenza tende a risolvere queste questioni attraverso il criterio della prevalenza della
mansione quantitativamente più significativa. Non mancano tuttavia decisioni che pongono invece
l’accento sulla natura dell’attività idonea a qualificare ed esprimere il livello di professionalità del
lavoro stesso.
6. Le mansioni costituiscono l’oggetto immediato della prestazione dedotta nel contratto di lavoro.
Intorno alle mansioni ruota una contrapposizione di interessi fra le due parti del rapporto. Da una
parte c’è l’interesse del creditore di lavoro a un impiego duttile ed elastico della prestazione,
dall’altra l’interesse del lavoratore alle conformità della prestazione alle mansioni convenute al
momento dell’assunzione o a mansioni compatibili con la qualifica e la categoria di appartenenza.
Alla soddisfazione dell’interesse del datore sono preordinati i poteri unilaterali che l’ordinamento
assicura al creditore di lavoro. È all’interno del potere direttivo che si colloca lo jus variandi che è il
potere del datore di modificare il contenuto della prestazione del lavoratore. La regolamentazione di
tale potere si trova nell’art. 2103 c.c., poi riscritto nel 1970, ad opera dell’art. 13 dello statuto dei
lavoratori, e successivamente a seguito dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015. La versione originaria della
disposizione codicistica affidava al datore il potere “di adibire il prestatore ad una mansione diversa,
purché essa non importasse una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della
posizione di lui”. Però i limiti indicati non furono interpretati in modo rigoroso dalla
giurisprudenza. Il conetto di “mutamento sostanziale della posizione” fu inteso nei termini di una
sorta di deminutio sociale, con la conseguenza di considerare legittime e giustificate tutte le
modifiche delle mansioni di assunzione che non mortificassero la dignità del lavoratore. La
giurisprudenza ritenne che la norma avrebbe dovuto trovare applicazione solo nei confronti delle
modifiche delle mansioni conseguenti all’esercizio del potere datoriale e non alle modificazioni a
carattere consensuale. Da ciò si faceva discendere il corollario secondo cui l’adibizione del
lavoratore a mansioni inferiori avrebbe comportato la novazione del rapporto di lavoro, data la
tacita acquiescenza del lavoratore alla modifica contrattuale.
7. L’assetto è stato oggetto di un’incisiva riforma, in chiave garantistica, per effetto dell’art. 13 dello
statuto dei lavoratori. La disposizione apportava regole nei confronti di tutte le possibili modifiche
dell’oggetto del contratto e quindi sia di quelle peggiorative sia di quelle migliorative sia di quelle
dirette a mansioni equivalenti. In primo luogo vietava l’adibizione a mansioni inferiori. Consentiva
invece l’adibizione a mansioni equivalenti. Sulla nozione di equivalenza ci fu un dibattito, all’esito
del quale, scartato il riferimento a omogeneità nel trattamento economico, si è ritenuto di far capo
alla nozione di equivalenza professionale. In sostanza, secondo l’art. 2103, al datore era consentito
di modificare le mansioni purché tale modifica rispettasse il bagaglio di perizia ed esperienza che
costituiva il nucleo del patrimonio professionale del lavoratore. La giurisprudenza aveva a lungo
perpetuato una lettura statica del concetto di equivalenza professionale. Secondo un orientamento
giurisprudenziale la modifica doveva avere ad oggetto mansioni che potessero consentire l’impiego
dell’insieme di esperienza e perizia già acquisito all’interno del rapporto. Tale lettura impediva
70
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
l’adibizione del lavoratore a mansioni che richiedessero la spendita di conoscenze diverse rispetto a
quelle possedute dal prestatore. Il che rendeva impossibile la riconversione dello stesso lavoratore e
l’acquisizione di un nuovo bagaglio professionale. La norma dello statuto è stata accusata di indurre
elementi di rigidità nell’amministrazione del rapporto. Si auspicava una lettura evolutiva del
concetto di professionalità, tale da ridurre l’incidenza del riferimento ad essa come ad un elemento
acquisito una volta per tutte e che facesse piuttosto perno su una capacità professionale potenziale
del lavoratore. Quanto al trattamento economico dovuto al lavoratore in caso di adibizione a
mansioni equivalenti l’art 2103 prevedeva che tale adibizione dovesse avvenire “senza alcuna
diminuzione della retribuzione”. Quanto all’adibizione a mansioni appartenenti ad una categoria
superiore l’art. 2103, oltre ad assicurare il trattamento economico più favorevole, garantiva diritto
alla promozione alla categoria superiore, in caso di adibizione protratta per un periodo fissato dai
contratti collettivi, non superiore a tre mesi. Il diritto alla promozione non maturava nel caso in cui
l’assegnazione del lavoratore abbia luogo “per sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla
conservazione”.
8. Il disegno riformatore nei confronti del testo originario della norma codicistica si completava con
il tratto dell’inderogabilità della disciplina, con previsione di nullità di “ogni patto contrario”. La
questione era quella di coordinare la rigidità con eventuali esigenze che ne assecondassero la
volontà o corrispondano all’interesse alla conservazione del rapporto. In effetti vi sono state
significative aperture giurisprudenziali ad esigenze di una lettura più elastica del divieto dei patti
contrari. Hanno valorizzato il potere delle parti del rapporto di concordare una modificazione delle
mansioni in presenza di una sopravvenuta inidoneità del lavoratore allo svolgimento delle
precedenti mansioni. In talune situazioni ci si è spinti fino al punto di dedurre l’esistenza del
consenso del lavoratore dal suo comportamento concludente. Erano però interpretazioni
sostanzialmente correttive della norma, alla luce di una sorta di gerarchia di valori, cui avrebbe
dovuto cedere il tratto dell’inderogabilità. A conferma del carattere creativo di tale orientamento
può valere il conforto di una serie di interventi che introducevano esplicitamente varie deroghe alla
disciplina dell’art. 2103 c.c., sancendo la legittimità dell’adibizione del lavoratore a mansioni
inferiori.
9. Il nuovo testo dell’art. 2103 c.c., risultante dall’art. 3 del d.lgs. n. 81/2015, dà voce a molte delle
critiche con riferimento al precedente assetto. Introduce un più ampio margine di flessibilità per le
imprese nel governo del fattore lavoro, autorizzando profonde dequalificazioni del lavoratore ed
allargando lo spettro della mobilità orizzontale. L’art. 2103 ribadisce che sono considerate
equivalenti tutte le mansioni collocate nel medesimo livello contrattuale, con il solo limite della
riconducibilità alla categoria legale di inquadramento. Da notare la rivitalizzazione che qui si fa
delle categorie legali di cui all’art. 2095 c.c.: l’impresa avrà la più ampia possibilità di spostamento
del lavoratore all’interno delle mansioni allineate nel livello contrattuale di inquadramento, purché
non risultino collocabili in una categoria legale inferiore. Quanto illustrato costituisce l’oggetto di
un potere unilaterale e insindacabile del datore. L’unico limite è che il mutamento di mansioni possa
essere accompagnato dall’assolvimento di un obbligo formativo. Il lavoratore ben può essere
adibito a mansioni che appartengono al livello di inquadramento inferiore, con il solo limite
dell’appartenenza alla medesima categoria legale. Tale potere va però esercitato “in caso di
modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore”. Ulteriore
ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono
essere previste dai contratti collettivi, di qualsiasi livello, anche aziendale: tutto ciò si può ricavare
dall’art. 51 del d.lgs. n. 81/2015. In tali situazioni il mutamento di mansioni deve essere comunicato
per iscritto, a pena di nullità ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di
71
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
inquadramento e del trattamento retributivo in godimento. Il 5° comma dell’art. 2103 prevede che,
nelle sedi di cui all’art. 2113 c.c. o comunque avanti alle commissioni di certificazione, possono
essere stipulati “accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di
inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione
dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle
condizioni di vita”. In tali sedi il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante
dell’associazione sindacale, da un avvocato o da un consulente del lavoro. Anche la mobilità
ascendente è regolata in modo diverso rispetto alla norma precedente. In caso di assegnazione a
mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta ed il diritto
alla promozione, salvo diversa volontà del lavoratore, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi
o dopo sei mesi continuativi. La disposizione risolve il problema circa la necessità del consenso del
lavoratore alla promozione. L’inderogabilità della disciplina è ridotta entro margini davvero risicati.
Si fa salvo infatti il potere unilaterale di modifica peggiorativa delle mansioni in relazione alle
modifiche degli assetti organizzativi evocate dal datore o previste dai contratti collettivi e dal punto
di vista procedurale il contenuto degli accordi raggiunti presso le sedi di cui all’art. 2113 c.c. Lo
spazio residuo coperto dalla previsione secondo cui “ogni patto contrario è nullo” riguarda patti con
cui si convenga che il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori e/o equivalenti al di fuori
del limite costituito dall’apparenza delle mansioni alla medesima categoria legale o che prevedano
che l’adibizione a mansioni inferiori possa prescindere dal patto scritto.
10. L’assetto regolativo della prestazione di lavoro nell’ambito del pubblico impiego è sempre stato
differenziato rispetto al lavoro privato. Le progressioni di carriera devono essere legate all’esistenza
dei specifici “posti” nella pianta organica e devono essere inoltre ispirate a criteri selettivi che
garantiscano l’accesso dei più meritevoli in attuazione del principio di buona amministrazione. È
per queste ragioni che la giurisprudenza ha quasi sempre negato ogni ingresso al diritto alla
promozione conseguente all’esercizio di mansioni superiori. Con la riforma degli anni novanta la
materia è stata rivisitata, ma ha mantenuto marcati profili di specialità. La riforma ha avuto corso
attraverso aggiustamenti progressivi, che hanno più volte riscritto gli artt. 56 e 57 del d.lgs. n.
29/1993. L’attuale assetto è contenuto nel d.lgs. n. 165/2001, in parte modificato ed integrato con la
riforma “Brunetta” del 2009. Il lavoratore pubblico deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto o a quelle considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale
prevista dai contratti collettivi o a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia
successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o
selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica non ha effetto ai fini
dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione. Questa parte della
norma comporta omogeneizzazione con il lavoro privato. Tale omogeneizzazione si è accentuata
dopo la riforma dell’art. 2103 c.c. ad opera del d.lgs. n. 81/2015. La disciplina si allontana dalla
regolamentazione privatistica, nella parte in cui nega che il mero esercizio di fatto delle mansioni
possa avere effetto sull’inquadramento del lavoratore. più articolata è la regolamentazione
dell’adibizione del lavoratore a mansioni superiori. Viene considerato svolgimento di mansioni
superiori “soltanto l’attribuzione in modo prevalente dei compiti propri di dette mansioni”. Può aver
corso solo per obiettive esigenze di servizio, avendo riguardo alla qualifica superiore ed in talune
ipotesi tassative: a) nel caso di vacanza di posto in organico; b) nel caso di sostituzione di lavoratore
assente con diritto alla conservazione del posto per la durata dell’assenza. Nelle situazioni appena
descritte il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Il cerchio si chiude
con la prefigurazione della nullità delle fattispecie di assegnazione del lavoratore a mansioni
superiori, al di fuori delle ipotesi indicate. Al fine di scoraggiare il ricorso a tali tecniche si prevede
la responsabilità personale del dirigente che abbia disposto l’assegnazione, agendo con dolo o colpa
72
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
grave. L’efficacia della regolamentazione è differita al momento dell’attuazione della nuova
disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da
questi stabilita. Fino all’esercizio di tale delega in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori
rispetto alla qualifica di appartenenza può dar diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento
professionale.
LA PRESTAZIONE DI LAVORO. B) IL LUOGO E IL TEMPO DELLA PRESTAZIONE
11. Il luogo costituisce un elemento discretivo della subordinazione: la giurisprudenza annovera fra
gli indici esponenziali del lavorare la circostanza che la prestazione si svolga in locali nella
disponibilità del datore di lavoro. Il luogo delimita inoltre lo spazio fisico nel cui ambito deve
svolgersi la prestazione. È quasi inutile avvertire che il luogo della prestazione non è affatto
indifferente per il lavoratore, dal momento che coincide con il luogo nel quale egli ha stabilito il
proprio domicilio e quindi svolge la propria vita familiare e sociale. Intorno alla questione della
modificazione del luogo della prestazione si contrappongono gli interessi delle due parti e come
spetta al diritto del lavoro rinvenire un punto di equilibrio. Prima dell’entrata in vigore del testo
dell’art. 2103 c.c., come modificato dall’art. 13 dello statuto dei lavoratori, era oggetto di
discussione sia l’esistenza, in capo al datore, di un potere di modifica del luogo della prestazione,
sia il suo stesso fondamento. Il punto di partenza era costituito dall’art. 1182, 1° co., c.c. Tale norma
elabora la regola secondo cui occorre far capo alle previsioni del contratto, agli usi o agli elementi
desumibili dalla specifica natura della prestazione. Chi sposava la prospettiva di una tutela forte
dell’interesse del lavoratore all’inamovibilità faceva leva sulla prima parte dell’art. 1182, ponendo
l’accento sulla circostanza che solo il contratto potesse determinare il luogo della prestazione. In
assenza di regolamentazione pattizia non sussisteva il potere di modificarlo. Chi intendeva fondare
l’esistenza di un potere unilaterale di trasferire, poneva l’accento sulla specificità del contratto di
lavoro e dunque alla peculiare “natura della prestazione” di lavoro. il potere di modificare il luogo
veniva così ricondotto al potere direttivo, al potere organizzativo o allo jus variandi del datore. Si
riteneva che il potere non fosse assoluto, ma che incontrasse i limiti generali derivanti dal principio
di equità, dalla possibile incompatibilità con la qualifica del lavoratore o dall’esistenza di esigenze
tecniche ed organizzative dell’impresa. È ovvio che l’affermazione dell’esistenza del potere
unilaterale di trasferire fosse oggettivamente rafforzata dal regime di libertà di recesso all’epoca
vigente. La situazione muta con l’entrata in vigore dello statuto dei lavoratori. La materia,
attualmente, è regolata infatti: a) nell’art. 2103 c.c., 8° co., che limita il potere di modificazione del
luogo; b) nell’art. 15, 1° co. lett. b), dello statuto dei lavoratori, secondo cui è nullo ogni patto o atto
diretto a discriminare il lavoratore nei trasferimenti; c) nell’art. 22 dello statuto dei lavoratori che
sottopone a nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza il trasferimento del sindacalista
“interno”; d) nell’art. 7, 4° co., dello statuto dei lavoratori, che sembra escludere il trasferimento dal
novero dei provvedimenti ammissibili. La norma-base è costituita dall’art. 2103, 8° co., c.c.,
secondo cui il lavoratore “non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”. L’accento sembra cadere più sul profilo
del diritto all’inamovibilità che su quello alla limitazione di un potere unilaterale esistente. La
giurisprudenza ha escluso che il potere di trasferire possa essere ancorato all’esistenza del consenso
del lavoratore. La norma valorizza l’interesse del lavoratore ad una relativa inamovibilità, allo
scopo di dare rilievo alle i lui esigenze personali e familiari. Sembra conseguenziale assumere che
la nozione di trasferimento, sottoposta al limite della giustificazione obiettiva, alluda a quegli
spostamenti che comportino effettivi disagi per il lavoratore e dunque a significativi mutamenti
geografici del luogo di esecuzione della prestazione. Un discorso diverso deve farsi per i
trasferimenti discriminatori e per quelli dei sindacalisti interni. Sia nell’uno che nell’altro può
73
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
giustificarsi una più pregnante protezione dell’inamovibilità del lavoratore, nella prima situazione in
ragione del carattere illecito della scelta datoriale, nell’altra per il ruolo del sindacalista interno, che
implica necessari contratti con la “base” dei lavoratori da cui riceve la legittimazione all’azione
sindacale. La tendenza giurisprudenziale più recente si muove nella direzione di unificare le nozioni
di trasferimento rilevanti nelle varie situazioni, facendo prevalere quella più strettamente aderente
alla ratio dell’art. 2103. L’art. 2103 nulla prevede in relazione ad oneri formali di comunicazione
del trasferimento, laddove è spesso la contrattazione collettiva che fa carico al datore di comunicare
per iscritto il provvedimento. Un impegno ad una preventiva comunicazione è stato dedotto
dall’impiego dell’aggettivo “comprovate” anteposto alle esigenze tecniche, organizzative e
produttive. La giurisprudenza di legittimità si è spinta ben oltre: ha esteso in via analogica al
provvedimento di trasferimento, con opera sostanzialmente creativa, gli oneri di comunicazione
previsti per il licenziamento dall’art. 2 della l. n. 604/1966. La clausola generale lega il
trasferimento all’esistenza di un giustificato motivo oggettivo. Il giudice non può sindacare nel
merito le ragioni della scelta, ma solo verificare la sussistenza di un nesso di causalità fra la scelta
tecnico-produttiva ed il trasferimento, restando insindacabile l’opzione fra varie soluzioni
organizzative. Fra le ragioni giustificative del trasferimento la giurisprudenza colloca inoltre
situazioni riconducibili al comportamento del lavoratore, come l’incompatibilità ambientale. Tale
orientamento sembra difficilmente coordinabile con l’esclusione del trasferimento dal novero dei
provvedimenti disciplinari. In effetti la giurisprudenza più recente appare molto cauta nel ricorrere a
tale figura. Un fenomeno a parte è quello del trasferimento collettivo, che implica lo spostamento di
una pluralità di lavoratori da una sede all’altra dell’impresa. La gestione di una vicenda che conduce
ad un trasferimento collettivo investe problematiche legate alla sopravvivenza stessa dell’impresa e
che sono sovente oggetto di consultazione e/o trattativa con il sindacato. Ove il trasferimento non
comporti la chiusura del reparto o dell’unità produttiva, il medesimo deve essere assoggettato alle
regole codificate dall’art. 2103 c.c. e dalla disciplina prevista dai contratti collettivi. Il trasferimento
si distingue dalla trasferta che è invece uno spostamento temporaneo del luogo di adempimento
della prestazione. Un’ipotesi particolare di trasferta è quella che comporta l’esecuzione della
prestazione lavorativa all’estero per un periodo determinato. La materia è regolata con disciplina
speciale. Ora non è più necessaria l’autorizzazione preventiva del ministero del lavoro né è
necessario per i lavoratori iscriversi in particolari elenchi. La legge statuisce che il contratto di
lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all’estero prevede: a) un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro; b)
la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile
delle retribuzioni corrisposte all’estero; c) un’assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di
destinazione e di rientro dal luogo stesso; d) il tipo di sistemazione logica; e) idonee misure in
materia di sicurezza. Vi sono inoltre altri problemi riguardo all’indennità di cui il lavoratore gode
durante la prestazione oltreconfine. Ci si chiede se ha natura retributiva, se è computabile nel TFR e
se il lavoratore ha diritto a conservarla al suo rientro. È oggetto di contrastanti vedute anche il
problema dell’applicabilità del contratto collettivo al di fuori del territorio nazionale. L’art. 22 dello
statuto dei lavoratori prevede una tutela rafforzata rispetto al trasferimento del sindacalista interno.
La ratio della norma è da individuare nella tutela della libertà e dell’attività sindacale. Il sindacalista
gode del diritto di inamovibilità, che può essere rimosso solamente tramite il nulla-osta
dell’associazione sindacale di appartenenza, la cui negazione è insindacabile da parte del giudice.
Per quanto riguarda il pubblico impiego va segnalato il principio contenuto nell’art. 2, 2° co., del
d.lgs. n. 165/2001 secondo cui ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
sono applicabili le norme del codice civile sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa. Il
trasferimento dei pubblici dipendenti può aver luogo nel contesto delle procedure dirette ad un più
74
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
razionale impiego del personale nelle varie amministrazioni. In materia di mobilità obbligatoria e
volontaria è intervenuto l’art. 4 del d.l. 24/06/2014 n. 90, convertito nella legge 11/08/2014 n. 114.
Una delle misure messe in campo è quella di allargare la nozione di unità produttiva.
12. Il tempo svolge un ruolo essenziale nella dinamica del contratto di lavoro, costituendone un dato
strutturale. La continuità della prestazione è un dato di riconoscibilità esterna dell’esistenza della
subordinazione. L’obbligazione del lavoratore è modulata sull’impegno a prestare attività per un
certo numero di ore. Il tempo costituisce la misura dell’impegno del lavoratore ed altresì della
controprestazione retributiva. Il tempo rileva poi anche come variabile interna alla prestazione,
avendo riguardo ai ritmi dell’attività produttiva. Il tempo infine scandisce l’alternanza lavoro e non
lavoro. Viene in evidenza il regime giuridico delle pause che cadenzano il rapporto di lavoro, le più
rilevanti delle quali sono considerate quella giornaliera, quella settimanale e quella annuale.
L’esistenza delle pause non esclude la permanente vigenza del rapporto. L’opinione più accreditata
alle origini era che la determinazione della dimensione quantitativa della prestazione costituisce un
elemento negoziale, la cui determinazione è rimessa all’autonomia delle parti. Sennonché si
comprende come il problema dei limiti alla durata della prestazione sia entrato a pieno titolo
nell’ambito degli interventi dello stato sociale. Con ritardo rispetto agli altri paesi il dibattito sulla
limitazione dell’orario di lavoro venne avviato in Italia solo nella seconda metà dell’ottocento, ma
fu necessario attendere la fine del secolo perché si determinassero con legge limiti alla durata
dell’orario. I maschi adulti ottennero solo con la l. n. 489/1907 il diritto ad un periodo di riposo di
ventiquattro ore consecutive per ogni settimana di lavoro. Fu solo con il r.d.l. 15/03/1923 n. 692 che
la questione fu avviata a soluzione con la fissazione dell’orario massimo giornaliero di otto ore e
settimanale di quarantotto e con una completa regolamentazione della materia. Il codice civile non
ha apportato novità sostanziali. L’art. 2107 rinvia alle leggi speciali la determinazione della durata
massima della prestazione giornaliera e settimanale e l’art. 2108 detta in materia di lavoro
straordinario e notturno, regole già interne al sistema. La riserva di legge sia in materia di fissazione
dell’orario massimo giornaliero e settimanale che di lavoro straordinario e notturno è stata
confermata dall’art. 36, 2° co., Cost. Si tratta di una riserva relativa, che lascia aperta la possibilità
che la contrattazione collettiva proceda a regolamentare autonomamente la materia. La questione
della limitazione o ridefinizione del tempo di lavoro si pone in una duplice e contradditoria
prospettiva. Da una parte c’è la spinta ad una riduzione o rimodulazione dell’orario per lasciare
spazio al tempo liberato, cioè alla cura degli interessi extra lavorativi. Non si chiede tanto di
lavorare per un numero inferiore di ore, quanto di distribuire in modo diverso il tempo di lavoro.
Dall’altra vi è la richiesta di una riduzione dell’orario di lavoro allo scopo di favorire la creazione di
nuovi posti di lavoro, per combattere cioè la disoccupazione. Vi è infine l’esigenza delle imprese di
maggiore flessibilizzazione dell’orario di lavoro allo scopo di attenuare le discontinuità produttive.
Tali tendenze stentano a trovare collocazione sul piano normativo. È unanime la constatazione della
scarsa pregnanza della Direttiva CEE 23/11/1993, 93/104, che si limita a prefigurare un minimo di
prescrizioni in materia di orario di lavoro. Fra i pochi elementi di novità: il principio
dell’adeguamento del ritmo di lavoro alle esigenze dell’uomo, che recepisce le istanze di un
controllo sulla qualità del tempo di lavoro ed il riferimento ad un limite orario medio. Alle
prospettive di riduzione dell’orario di lavoro nonché di modulazione e flessibilizzazione rispondeva
l’art. 13 della l. n. 196/1997, che avrebbe dovuto costituire il primo passo nella direzione di una
revisione globale della regolamentazione, attraverso l’incentivazione di forme flessibili di
distribuzione dell’orario. Le esigenze di flessibilizzazione dell’orario sono state rilanciate con
l’Accordo Interconfederale 12/11/1997, definito Avviso comune sull’orario di lavoro “europeo”, che
ha costituito un messaggio dalle parti sociali alla classe politica, allo scopo di segnalare l’esigenza
che la materia dell’orario resti nella disponibilità dell’autonomia collettiva. Con il d.lgs. 08/04/2003
75
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
n. 66 è stata data attuazione alla direttiva. La nuova disciplina si applica “a tutti i settori di attività
pubblici e privati”, con l’eccezione della gente di mare, del personale di volo nell’aviazione civile e
dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla dir. 2002/15/CE, nonché al personale
della scuola. Nei confronti delle forze di polizia, della protezione civile et similia non trova
applicazione solo “in presenza di particolari esigenze inerenti il servizio espletato”. La medesima si
applica altresì agli apprendisti maggiorenni. Ne consegue che per i minori, anche se apprendisti,
valgono i diversi limiti prefigurati dalla normativa di protezione.
13. La contrattazione collettiva si era incaricata di abbassare la soglia del limite settimanale di ore
lavorative a 40 ore anziché 48. A 75 anni dal r.d.l. n. 692/1923, l’art. 13, 1° co., della l. n. 196/1997
aveva stabilito che l’orario normale di lavoro dovesse essere fissato in 40 ore settimanali. L’art. 3
del d.lgs. n. 66/2003 riproduce quest’ultima disposizione salve due innovazioni. La prima dice che
le fonti abilitate alla fissazione di un orario inferiore a quello previsto in generale sono i “contratti
collettivi” tout court. È inutile quasi sottolineare l’importanza dell’innovazione nella chiave della
flessibilizzazione anche delle fonti di disciplina della materia. La seconda è il rilievo secondo cui le
innovazioni contenute nella contrattazione valgono “ai fini contrattuali”. È possibile una pattuizione
di orari multiperiodali, con l’osservanza del limite delle 40 ore settimanali come media in un arco di
tempo che può protrarsi fino ad un anno. Ciò significa che potrà essere superato il massimo delle 40
ore purché vi sia la compensazione con periodi di durata inferiore. L’attuale disciplina ne affida per
intero la gestione alla contrattazione collettiva anche di minore livello. Il d.lgs. n. 66/2003
contempla, all’art. 16, un’elencazione di deroghe alla durata dell’orario normale settimanale. Si
tratta di situazioni tratte dalla preesistente normativa, anche se operavano in un contesto in cui era
fissato un limite di durata massima giornaliera della prestazione. Tali deroghe fanno salve “le
condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi”. Vuol dire che la contrattazione
collettiva può stabilire anche dei tetti massimi di orario. Ulteriori deroghe sono previste per i
lavoratori e le attività elencate nel 5° co. dell’art. 17. Anche la nuova disciplina si muove nella
prospettiva di indicare il solo orario normale settimanale di 40 ore, laddove la durata massima
settimanale dell’orario è demandata alla contrattazione collettiva. La legge pone comunque un
limite esterno alla contrattazione collettiva stabilendo che la durata media dell’orario di lavoro non
può in ogni caso superare le 48 ore, comprese le ore di straordinario. Tale durata media è riferita ad
un periodo non superiore a quattro mesi. È una previsione che ha lo scopo di proteggere l’integrità
psico-fisica dei lavoratori e la cui latitudine va confrontata con le limitazioni della durata massima
dell’orario giornaliero di lavoro. L’arco temporale dei quattro mesi può essere dilatato dalla
contrattazione collettiva fino a sei mesi liberamente e fino a dodici mesi, purché in presenza di
ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro. La legge prevede un
meccanismo che supplisca alla mancanza di intervento della contrattazione collettiva. Infatti le parti
sociali possono chiedere, in relazione a talune attività ricomprese in un elenco tassativo, al Ministro
del lavoro o al Ministro della funzione pubblica, l’emanazione di un decreto per stabilire deroghe
all’individuazione dell’arco di tempo entro cui conteggiare la media settimanale in quattro mesi. Il
meccanismo derogatorio è previsto inoltre per il limite del riposo giornaliero, per il regime delle
pause, per le modalità di organizzazione del lavoro notturno e per la sua durata. Un limite generale
alle facoltà derogatorie è costituito dalla circostanza che ai prestatori di lavoro siano accordati
periodi equivalenti di riposo compensativo. L’arco di riferimento della media comunque va
“alleggerito” dei periodi di ferie annuali e di quelli di assenza per malattia. Sono escluse dal
computo dell’arco di riferimento le ore di lavoro straordinario. La norma sulla durata massima
dell’orario settimanale non si applica nei confronti di talune categorie di lavoratori, rispetto ai quali
la durata dell’orario o “non è misurata o non è predeterminata” o “può essere determinata dai
lavoratori stessi”. Si tratta di un aggiornamento ed ampliamento della previsione dell’art. 1, 2° co.,
76
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
del r.d. n. 692/1923, che esonerava dai limiti di orario il “personale direttivo delle aziende”. Su tale
previsione si era formata una giurisprudenza che includeva nella categoria anche i quadri e gli
impiegati con funzioni direttive. L’esenzione non esclude peraltro che l’impegno del dirigente possa
essere considerato eccessivo e lesivo anche dei valori della salute e dell’integrità fisica o che
sussista per il lavoratore l’obbligo di rispettare l’orario. In tali situazioni anche il lavoratore
direttivo avrà diritto ad un compenso ulteriore ragguagliabile all’entità dovuta per il lavoro
straordinario. Nel vigore della legge del 1997 costituiva oggetto di contrasto interpretativo la
prospettiva dell’abrogazione del limite giornaliero delle otto ore, sembrando più ragionevole l’idea
della permanente vigenza di quel limite. Quel limite oggi non è più giuridicamente sostenibile in
ragione dell’espressa abrogazione del r.d.l. del ’23. L’unico limite che residua è quello che deriva
dall’applicazione del diritto ad un riposo continuativo di 11 ore con la conseguenza che è
ipotizzabile una giornata lavorativa di 13 ore e una settimana di 78 ore. Il sistema suscita qualche
dubbio di legittimità costituzionale, non solo per la congruenza del limite prefigurato, ma anche
perché la legge autorizza una lunga serie di eccezioni. Ciò vale per le “attività caratterizzate da
periodi di lavoro frazionati durante la giornata”. Inoltre una deroga può essere prevista in sede
contrattuale collettiva, anche se in questo ambito la contrattazione di secondo livello si deve
muovere in un contesto di regole fissate dalla contrattazione nazionale. È esteso alla deroga alla
durata massima dell’orario giornaliero il meccanismo alla sollecitazione dell’intervento
ministeriale. Il limite orario era riferito dal r.d.l. n. 692/1923 al lavoro effettivo, inteso in una
duplice accezione. Da una parte il riferimento era ad “ogni lavoro che richieda un’applicazione
assidua e continuativa” e dunque erano esclusi i lavori discontinui o di semplice attesa e custodia. In
una seconda accezione si tendeva ad escludere le pause nell’attività produttiva come i riposi
intermedi, le soste di lavoro inferiore a 10 minuti ed il tempo necessario per recarsi al lavoro. Erano
e sono considerate “a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro” le pause di 15 minuti
ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale, per i relativi addetti. Il d.lgs. n.
66/2003, all’art. 1 comma 2 lett. a), definisce come orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il
lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle
sue funzioni”. Quanto alla questione dell’effettività del lavoro, secondo l’art. 8 comma 3, vanno
esclusi dal computo dell’orario di lavoro “i periodi di cui all’art. 5 regio decreto 10/09/1923 n.
1955, e successivi atti applicativi, e l’art. 4 del regio decreto 10/09/1923 n. 1956, e successive
integrazioni”. Sono fatte salve disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva. Secondo
l’art. 8 comma 3 del d.lgs. n. 66/2003 i periodi descritti non sono retribuiti. Deve ritenersi che oggi
sono assoggettate alla nuova disciplina dell’orario anche le “attività discontinue o di semplice attesa
e custodia”. Alla questione del lavoro “effettivo” è collegata quella delle pause. Secondo l’art. 8
comma 1 del d.lgs. n. 66/2003 “qualora l’orario di lavoro ecceda il limite di sei ore il lavoratore
deve beneficiare di un intervallo per pausa, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e
dell’eventuale consumazione del pasto”. Vi è un rinvio alla contrattazione collettiva in ordine alla
concreta determinazione della durata della medesima. La legge inoltre stabilisce un limite, che
appare come un minimo ed inderogabile anche da parte dei contratti collettivi. Al lavoratore deve
essere concessa una pausa, tra l’inizio e a fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non
inferiore a dieci minuti. Non resta intaccato dalla nuova disciplina sul lavoro “effettivo” il regime
della reperibilità, che si ha nel caso in cui il lavoratore sia obbligato a tenersi a disposizione del
datore, anche al di fuori dell’orario di lavoro. I rapporti fra autonomia collettiva, autonomia
individuale e legge in materia di orario di lavoro possono dar luogo a problemi intricati. I rapporti
fra autonomia collettiva ed autonomia individuale giocano anche a proposito dell’estensione della
prestazione lavorativa. Alla prima spetta il potere di determinare l’estensione normale della
prestazione, alla seconda spetta il potere di determinare l’estensione nell’unità di tempo. Altra
77
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
questione attiene alla collocazione temporale della prestazione, cioè alla distribuzione dell’orario
“normale”. Rileva in questo ambito la struttura del contratto di lavoro, al cui interno la
determinazione delle modalità della prestazione rientra fra le prerogative del creditore di lavoro.
Semmai il problema consiste nel chiedersi se, una volta che il datore abbia determinato una
specifica modalità di distribuzione dell’orario, possa poi procedere a modificazioni unilaterali. La
risposta deve essere positiva, potendo siffatto potere essere ricondotto entro l’alveo dello jus
variandi del datore di lavoro. il problema della determinazione dell’orario e della sua modificazione
costituisce l’oggetto di una serie di obblighi strumentali di informazione per il datore. Già l’art. 12
del r.d. n. 1955/1923 imponeva al datore di lavoro gli obblighi di: a) affissione dell’orario di lavoro
in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti; b) trasmissione dell’orario e delle sue
modificazioni all’Ispettorato del lavoro; c) annotazione nel libro-paga delle ore di lavoro ordinario e
straordinario. La violazione di tali obblighi comporta sanzioni amministrative. La nozione di lavoro
“normale” implica quella di lavoro straordinario, prestato al di sopra della soglia stabilita per il
primo. Il d.lgs. n. 66/2003 conferma che il lavoro straordinario costituisce una delle più significative
forme di flessibilizzazione dell’attività produttiva. Si tratta di una flessibilizzazione “interna” al
rapporto di lavoro, perché consente di conformare la dimensione temporale della prestazione alle
esigenze dell’impresa. Il lavoro straordinario non si presenta come una fattispecie ulteriore e
distinta rispetto all’ordinario rapporto di lavoro. Anche se c’è diversità di disciplina, non si dirige
nei confronti degli elementi essenziali del rapporto. Deve piuttosto ritenersi che costituisca una
porzione di prestazione “a disciplina speciale”, compatibile con le varie tipologie di contratti di
lavoro. La nozione di lavoro straordinario è collegata a quella di orario normale. L’idea che il lavoro
straordinario costituisca un “prolungamento” dell’orario normale ha origini risalenti alla prima
regolamentazione dell’istituto e si è trasmessa all’ordinamento vigente. Il d.lgs. n. 66/2003
conferma questa configurazione, laddove lo definisce come il “lavoro prestato oltre l’orario normale
di lavoro così come definito dall’art. 3”. Posto che l’art. 3 fissa l’orario normale settimanale a 40
ore, se ne deduce che il lavoro straordinario è quello che eccede le 40 ore. Una prima questione è
quella di chiedersi se sia venuta meno la distinzione fra lavoro straordinario e supplementare. Tale
distinzione si basava sulle diverse nozioni di orario normale accolte dalla legge e dalla
contrattazione collettiva. La necessità della distinzione si poneva allo scopo di verificare se il diritto
al pagamento della maggiorazione dovesse scattare al superamento della soglia dell’orario legale o
di quella più bassa prevista in sede negoziale. La giurisprudenza aveva avallato le scelte contrattuali
riconoscendo all’autonomia collettiva sia il potere di individuare la nozione di lavoro supplementare
sia quello di graduare il relativo compenso. Oggi la distinzione ha meno ragione di porsi, venendo a
coincidere i due limiti. La distinzione potrà risorgere nel caso in cui la contrattazione collettiva
dovesse provvedere all’abbassamento della soglia “normale”. Essendo il lavoro straordinario una
variante dell’orario “normale” il medesimo pone qualche problema di identificazione con
riferimento all’orario multiperiodale. Sono esclusi dalla disciplina limitativa dello straordinario i
lavoratori che non sono tenuti al rispetto dell’orario. Il lavoro straordinario incontra limiti
procedurali e sostanziali. Sul piano procedurale si prevede che, in caso di superamento delle 48 ore
di lavoro settimanale, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore deve
informare la Direzione territoriale del lavoro. A fronte della precedente regolamentazione, la nuova
trova estensione nei confronti di tutti i settori produttivi. La medesima sostanzialmente liberalizza lo
straordinario nelle imprese che occupano meno di dieci dipendenti. Sul piano sostanziale, su
accordo con il lavoratore, può essere effettuato fino a 250 ore annue. Tali limiti possono essere
derogati dai contratti collettivi. Lo straordinario è inoltre “ammesso” in relazione:
a) a casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarla attraverso
l’assunzione di altri lavoratori;
78
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
b) a casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro
straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato o a un danno alle persone o
alla produzione;
c) ad eventi particolari, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell’art. 19
della legge 07/08/1990 n. 241, come sostituito dall’art. 2 comma 10 della legge 24/12/1993
n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali.
Vi è una zona al cui interno rileva il consenso del lavoratore. Ad essa si contrappone una sfera al cui
interno l’effettuazione del lavoro straordinario costituisce oggetto di un vero e proprio obbligo per il
lavoratore. La formulazione legislativa degli eventi che lo autorizzano è molto ampia ed elastica,
apparendo quelle indicate solo come delle esemplificazioni suscettibili di estensione. Il potere
modificativo è conferito alla contrattazione collettiva di qualsivoglia livello, laddove nella
precedente regolamentazione il riferimento era ai contratti nazionali. Secondo l’art. 5 comma 5 del
d.lgs. n. 66/2003 “il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le
maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro”. I contratti collettivi di lavoro
potranno prevedere, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, che i lavoratori
fruiscano di riposi compensativi. È questa una sorta di legittimazione normativa di meccanismi
quali la “banca delle ore”. Secondo tale istituto le ore di prestazione eccedente l’orario normale
sono accantonate in una sorta di “conto individuale”. Al lavoratore è data la scelta di utilizzare tutto
o parte del monte-ore come riposo o pretendere il pagamento della controprestazione retributiva. Si
discuteva se la nuova disciplina incidesse sull’obbligo del pagamento del contributo previdenziale
aggiuntivo in funzione di disincentivazione: sembrava preferibile la tesi della permanenza
dell’obbligo. Con una direttiva politica opposta a quella diretta a disincentivare il lavoro
straordinario, la legge ha previsto una parziale riduzione dell’imposta gravante sulla retribuzione
dovuta, allo scopo di favorire l’effettuazione dell’attività e salvaguardare il potere d’acquisto dei
lavoratori. Anche il lavoro notturno è sottoposto a limitazioni. La materia è stata regolata con il
d.lgs. 26/11/1999 n. 532. Anch’essa ora rientra nel campo d’applicazione del d.lgs. n. 66/2003. Per
“lavoro notturno” si intende quello svolto “nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive
comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino”. Fermo che si intende per
lavoratore notturno chi svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in
modo normale, sono oggetto di tutela i lavoratori che svolgano lavoro notturno per un minimo di
ottanta giorni lavorativi all’anno. L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta da una
consultazione sindacale. Inoltre il datore è onerato di informare per iscritto i servizi ispettivi della
Dtl dell’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo e compreso in regolari turni
periodici. Sono previste eccezioni nel caso di sopravvenuta inidoneità del lavoratore al lavoro
notturno e c’è il divieto di adibire al lavoro notturno le donne dall’accertamento dello stato di
gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Vi sono poi ulteriori eccezioni.
Formalmente la nuova disciplina nulla prevede in relazione alle maggiorazioni dovute per il lavoro
notturno. In argomento vale l’indicazione contenuta nell’art. 13 comma 2 del d.lgs. n. 66/2003, che
rimette alla contrattazione collettiva “l’eventuale definizione delle riduzioni dell’orario o dei
trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni”. L’organizzazione del lavoro
impone poi la distribuzione dell’orario secondo turni periodici prestabiliti. La distribuzione e
l’entità dei turni varia a seconda del ciclo produttivo osservato dall’impresa. Nel caso in cui il ciclo
sia continuo si avranno normalmente tre turni. Ove il ciclo sia invece semicontinuativo o non
continuativo si avrà una diversa articolazione della turnazione. La materia dell’introduzione e della
modifica dei turni di lavoro costituisce oggetto di confronto con le associazioni sindacali. A
prescindere dalle previsioni della contrattazione collettiva comunque i lavoratori studenti hanno
79
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami e non sono
obbligati a prestare lavoro straordinario.
14. Un’ulteriore pausa che cadenza l’esecuzione della prestazione è quella settimanale. L’art. 36, 3
comma, Cost. stabilisce il principio del diritto irrinunciabile al riposo settimanale. L’art. 2109, 1
comma, c.c. prefigura il diritto ad un giorno di riposo settimanale, di regola coincidente con la
domenica. Si segnalano inoltre la Convenzione OIL n. 14 del 1921, ratificata con l. 20/03/1924 n.
580, la Convenzione OIL n. 106 del 1957, ratificata con d.p.r. 23/10/1961 n. 1660, nonché la
direttiva CE n. 93/104, che ribadisce il diritto ad un riposo di 24 ore per ogni periodo lavorativo di
sette giorni. La materia del riposo settimanale è stata rivisitata dal d.lgs. n. 66/2003. Il fondamento
del principio è da rinvenire nella necessità di recupero delle energie psico-fisiche spese con il
lavoro, quello della normale coincidenza con la domenica nella garanzia di un’adeguata tutela degli
interessi familiari e sociali del prestatore. Si spiega così la ragione per cui la legislazione fin dalle
origini ha sancito il divieto di lavoro domenicale. La prestazione lavorativa prestata
illegittimamente durante il giorno di riposo è nulla, anche se il codice civile fa salvo il diritto alla
controprestazione retributiva. La coincidenza del giorno di riposo con la domenica è esclusa con
riferimento ad una serie di attività, fra cui: le operazioni industriali a ciclo continuo; le attività
stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima od al prodotto dal
punto di vista del loro deterioramento; altre attività per le quali il funzionamento domenicale
corrisponda ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilità. Tali situazioni erano
tassativamente elencate in un decreto ministeriale. Il d.lgs. n. 66/2003 prevede che il Ministro del
lavoro provveda con proprio decreto all’aggiornamento e revisione di quell’elenco. L’accento sul
carattere settimanale implica conseguenze sul piano della sua periodicità. Il riposo deve cadere al
termine di sei giorni lavorativi risultando illegittima ogni regolamentazione che contempli lo
slittamento del riposo oltre il sesto giorno. Il periodo di riposo consecutivo può essere calcolato
come media di un periodo non superiore a 14 giorni. Il d.lgs. n. 66/2003, all’art. 9 comma 2
richiama alcune eccezioni al principio della cadenza settimanale del riposo di 24 ore consecutive. Il
riposo settimanale, quello giornaliero e quello annuale sono fra loro reciprocamente infungibili, nel
senso che il godimento del primo non può essere sostituito da una più ampia durata delle pause
quotidiana e annuale. Non sono nemmeno sovrapponibili, cioè non possono essere assorbiti l’uno
nell’altro. Il giorno di riposo non è di per sé retribuito. Ove al lavoratore sia richiesto di prestare
lavoro nel giorno di riposo settimanale, avrà diritto ad una maggiorazione determinata dalla
contrattazione collettiva. Questione diversa riguarda il lavoro domenicale dei turnisti, che sono quei
lavoratori che si trovano a prestare attività anche durante le domeniche, godendo del riposo in un
altro giorno della settimana. In giurisprudenza si è posto il problema se fossero legittime le
previsioni contrattuali collettive che negavano il diritto ad un compenso ulteriore per il lavoro
prestato la domenica. La giurisprudenza ha ritenuto di ravvisare l’esistenza di un disagio
supplementare nel prestare attività di lavoro domenicale. Il lavoratore ha diritto ad assentarsi dal
lavoro, conservando la retribuzione, durante le festività infrasettimanali. La ratio di tale posizione di
favore è di consentire al lavoratore di solennizzare il giorno festivo. La legge 27/05/1949 n. 260
dichiara giorni festivi 11 ricorrenze religiose e 5 solennità civili, durante le quali i lavoratori
retribuiti non in misura fissa hanno diritto a conservare la normale retribuzione globale di fatto
giornaliera. Il numero delle festività è stato disboscato negli anni settanta nell’intento di ridurre le
diseconomie che incidevano sul costo del lavoro, che ha escluso il carattere festivo di alcune
ricorrenze religiose e delle solennità civili del 2 giugno e 4 novembre. Con il d.p.r. 28/12/1985 n.
792 è stata reintrodotta la festività dell’Epifania e quella dei SS. Pietro e Paolo, e con legge
20/11/2000 n. 336 è stata ripristinata la festività del 2 giugno. Le festività non previste da accordi
con la Santa Sede, le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni cadranno il venerdì o il
80
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
lunedì successivi al giorno della ricorrenza effettiva. Ciò ad esclusione del 25 aprile, del 1° maggio
e del 2 giugno. Discipline speciali sono state poi dettate per il diritto al riposo sabatico biblico per
gli appartenenti alle chiese cristiane avventiste del settimo giorno nonché per gli appartenenti alla
comunità ebraica. Nel caso in cui al lavoratore sia richiesto di lavorare durante un giorno festivo
infrasettimanale al medesimo spetterà oltre alla normale retribuzione (dovuta anche senza lavoro),
la retribuzione relativa alle ore lavorate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Si è posto, in
giurisprudenza, il problema se il lavoratore abbia diritto di rifiutare l’esecuzione di lavoro festivo. Il
lavoratore ha infine il diritto irrinunciabile ad un periodo di ferie annuali retribuite. L’art. 2109
comma 2 c.c. sancisce che il lavoratore ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un
periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La
durata del periodo è stabilita dalla legge, dai contratti collettivi o dagli usi. La Convenzione n.
132/1970 dell’OIL prevede come limite minimo la durata di due settimane lavorative. La funzione
dell’istituto del riposo feriale è anche quella di consentire al lavoratore di dare sfogo ad attività
familiari, ricreative, culturali etc. La norma codicistica stabiliva che le ferie dovessero spettare dopo
“un anno di ininterrotto servizio”. Sennonché la Corte costituzionale ritenne illegittima la
previsione, fissando il principio dell’intrannualità del godimento delle ferie, cioè il diritto del
lavoratore a godere di una proporzionata frazione di periodo feriale. Nella materia delle ferie è
intervenuto il d.lgs. n. 66/2003 provvedendo a legificare la durata minima del periodo feriale,
stabilita in almeno quattro settimane. Con decreto correttivo del 2004 si è precisato che tale periodo
va goduto per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso
dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno
di maturazione. Il potere dell’individuazione concreta del periodo feriale spetta al datore di lavoro
che peraltro deve tenere conto dell’interesse dell’azienda e delle esigenze del lavoratore. Al
lavoratore spetta solo il potere di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo. Il datore
deve comunque provvedere ad una tempestiva comunicazione del periodo feriale. Il datore può
rifiutare la “monetizzazione” delle ferie, imponendone la fruizione ai lavoratori quanto meno entro i
termini di fruizione previsti oggi dalla legge. Per quanto riguarda il rapporto tra ferie e malattia si
pone un duplice ordine di questioni. Ci si chiede se la malattia sospenda il decorso delle ferie o se
costituisca una sorta di rischio che ricade nella sfera del lavoratore. La giurisprudenza ha per lungo
optato per quest’ultima alternativa. Sennonché i termini della questione sono stati ribaltati per
effetto della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2109 c.c., nella parte in
cui non prevede la sospensione del periodo feriale in conseguenza della malattia insorta durante il
suo decorso. La giurisprudenza ordinaria ha fatto proprio tale indirizzo, ripartendosi in due
orientamenti: l’uno che ricollega l’effetto sospensivo a qualsiasi malattia e che quindi considera
illegittime le eventuali clausole collettive difformi, l’altro che assume che l’effetto sospensivo non
abbia valore assoluto, ma si debba ricollegare ai soli eventi morbosi, incompatibili con la funzione
di riposo propria delle ferie. Il contrasto è stato di recente risolto dalle Sezioni Unite della
Cassazione che ha aderito a questo ultimo orientamento. Restano tuttora contrasti giurisprudenziali
su alcuni problemi conseguenziali. Sotto altro profilo ferie e malattia interferiscono nel senso che ci
si chiede se, ai fini della determinazione dell’entità del periodo feriale spettante al lavoratore, debba
prendersi in considerazione il periodo di mera vigenza del rapporto o quello di effettiva presenza
del lavoratore nel luogo di lavoro. Normalmente la questione è risolta sulle indicazioni che circa
l’ambito del computo del periodo feriale fornisce specificatamente la contrattazione collettiva. Il
problema ha trovato soluzione con una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione che ha
optato per la prospettiva più favorevole al lavoratore. Sia il codice civile che la Costituzione
ribadiscono il carattere retributivo dell’assenza di ferie. Il principio è altresì sancito sia dall’art. 7
81
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
della direttiva CE n. 93/104 sia dall’art. 7 comma 1 della Convenzione OIL n. 132/1970, secondo
cui il lavoratore “deve ricevere almeno la normale o media retribuzione, calcolata secondo un
metodo da stabilirsi da parte dell’autorità competente o dell’organismo appropriato di ciascun
Paese”. In assenza di indicazioni il potere di determinazione della retribuzione feriale è demandato
ai contratti collettivi. Quanto ai criteri di computo degli elementi retributivi, la giurisprudenza ha
avallato le scelte con cui i contratti collettivi differenziano il trattamento retributivo feriale da quello
“ordinario, escludendo taluni elementi, con il solo limite costituito dalla soglia della retribuzione
minima tabellare. La più recente disciplina pone l’accento diretto a ristorare le energie spese
nell’attività lavorativa, sulla fruizione effettiva delle ferie. Ove tale evento non si verifichi il
lavoratore ha diritto a un’indennità sostitutiva, nell’ipotesi in cui sia lo stesso lavoratore ad avere il
potere di auto-assegnazione delle ferie, il mancato godimento del riposo, non dà diritto all’indennità
sostitutiva, in mancanza di prova dell’esistenza di eccezionali esigenze aziendali ostative del
godimento delle ferie. L’art. 2109 ultimo comma prevede il principio di non cumulabilità delle ferie
e del periodo di preavviso, nell’intento di garantire la fruizione integrale del periodo di riposo
annuale, senza decurtazioni.
15. Il modello tradizionale di rapporto di lavoro è quello a tempo pieno e indeterminato. È per
questa ragione che per molti anni il rapporto di lavoro a tempo parziale non ha incontrato l’interesse
delle parti. A ciò si aggiunga che il decollo dell’istituto era ostacolato dalla normativa previdenziale
che non prevedeva la possibilità di articolare in quote orarie il minimale retributivo, sul quale si
computano i contributi. Ne deriva per il datore un costo del lavoro del tutto sproporzionato. Le
mutate condizioni sociali ed economiche degli anni ottanta conducono a un diverso atteggiamento
delle arti sindacali rispetto al rapporto ad orario ridotto. Viene in evidenza l’attenzione verso il
“tempo liberato”, il cui recupero è fuor di dubbio favorito da una o più occupazioni a tempo
parziale. Un ruolo essenziale gioca l’attenzione verso le forme di impiego che possono favorire una
flessibilizzazione dell’impiego dei lavoratori. Si spiega così l’attenzione del legislatore a sostegno
dell’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, il cui primo intervento si ha con l’art. 5
della l. n. 863/1984. Le disposizioni contenute nella legge tendono ad incentivare il ricordo al part-
time. Negli anni novanta la materia è entrata nello spazio regolativo comunitario con un accordo
quadro stipulato dalle parti sociali il 06/06/1997, cui è stata data attuazione con la Dir. 15/12/1997
n. 97/81. L’Italia si è adeguata con il d.lgs. 26/02/2000 n. 61. Tale decreto è stato più volte
modificato ed integrato ed ha regolato la materia del part-time fino all’entrata in vigore del d.lgs. n.
81/2015, che regola attualmente la materia, che l’ha abrogato. Una prima innovazione consiste
nell’eliminazione della distinzione fra part-time orizzontale, che si ha quando la riduzione di orario
è in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro, part-time verticale, in cui la prestazione a
tempo pieno è svolta in periodi predeterminati nel corso della settimana, mese o anno e part-time
misto, che si svolge secondo una combinazione dei due precedenti. All’interno della
regolamentazione c’è un implicito riferimento alle varie modalità in cui il medesimo può articolarsi.
La distinzione è ancora implicitamente enucleabile, anche se con maggiori difficoltà. La legge si
limita ad affermare che nel rapporto di lavoro subordinato, l’assunzione può avvenire a tempo pieno
o a tempo parziale. Quanto alle fonti di regolazione c’è un rinvio all’autonomia collettiva, anche se
talvolta dà spazio alle determinazioni unilaterali del datore, mentre in altre situazioni prevede la
necessità di pattuizione presso le commissioni di certificazione. Il contratto a tempo parziale va
stipulato in forma scritta. Devono essere indicate la durata della prestazione e la collocazione
temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno. L’indicazione
della durata può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce
orarie prestabilite. La legge si pronuncia sulla qualificazione dei requisiti di forma e sulle
conseguenze della loro violazione. È prevalente la tesi della natura sostanziale della forma e della
82
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
conseguente nullità del contratto stipulato oralmente. Sennonché le conseguenze che venivano
ipotizzate apparivano privative di tutela per il lavoratore. Poco convincente era anche quel filone
giurisprudenziale che prospettava una conversione del rapporto in ordinario rapporto di lavoro a
tempo pieno. Più ragionevole era optare per la prospettiva secondo cui la forma scritta fosse
richiesta a soli fini probatori e la sua mancanza non rendesse nullo il contratto. L’art. 5 comma 1 del
d.lgs. n. 81/2015 conferma che la forma è richiesta solo ad probationem. Quanto alla mancanza nel
contratto delle indicazioni circa la durata e la collocazione temporale della prestazione la legge
esclude anzitutto la prospettiva della nullità dell’intero contratto. La medesima per altro differenzia
il regime della mancata indicazione della durata e della collocazione temporale. Ove manchi
l’indicazione della durata il lavoratore avrà diritto all’accertamento giudiziale della sussistenza di
un rapporto a tempo pieno; ove manchi quella della collocazione temporale, quest’ultima sarà
determinata dal giudice. Il lavoratore ha comunque diritto ad un risarcimento dei danni da liquidarsi
in via equitativa, in aggiunta alla retribuzione dovuta, per il periodo antecedente alla pronuncia del
giudice. Il nodo centrale dell’amministrazione del contratto di lavoro a tempo parziale è quello che
riguarda i profili della predisposizione dell’orario e delle sue modificazioni. Vengono in evidenza i
contrapposti interessi: quello del datore alla massima flessibilità possibile della prestazione e quello
del lavoratore al contemperamento del lavoro con le esigenze di vita. Nel precedente assetto si
discuteva sulla legittimità di eventuali clausole negoziali che assegnavano al datore il potere di
individuare in concreto i periodi di lavoro, in relazione alle esigenze dell’impresa. La novella del
2003 aveva introdotto una distinzione tra clausola “flessibile” e clausola “elastica”. La prima
riguardava la variazione della collocazione temporale della prestazione nel contratto di tipo
orizzontale; la seconda la variazione in aumento della durata della prestazione, nel contratto di tipo
verticale o misto. Tale distinzione non è più presente nella regolamentazione del 2015, che fa
riferimento solo alle clausole elastiche, predicate sia rispetto alla variazione della collocazione
temporale della prestazione lavorativa sia rispetto alla variazione in aumento della sua durata. Tali
clausole devono rispettare le previsioni dei contratti collettivi e vanno pattuite dalle parti per
iscritto. In tali situazioni il lavoratore ha diritto a un preavviso di due giorni lavorativi. In ogni caso
il lavoratore ha diritto a “specifiche compensazioni” nella misura o nelle forme previste dai contratti
collettivi. Nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini le clausole elastiche, queste possono
essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione. Le clausole elastiche
devono prevedere le condizioni e le modalità con le quali il datore può modificare la collocazione
temporale della prestazione lavorativa e variarne in aumento la durata. Tali modifiche comportano il
diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto. La
facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica è riconosciuto solo ad alcune categorie
di lavoratori che si trovano in condizioni particolarmente disagiate. Si tratta: a) dei lavoratori affetti
da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti; b) dei
lavoratori, il cui coniuge, i figli o i genitori siano affetti dal medesimo genere di affezioni; c) dei
lavoratori che assistano una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa grave;
d) dei lavoratori con figlio convivente di età non superiore ai tredici anni o con figlio convivente
portatore di handicap; e) dei lavoratori studenti di cui all’art. 10 comma 1 dello statuto dei
lavoratori. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce
giustificato motivo di licenziamento. In caso di violazione da parte del datore della disciplina sulle
clausole elastiche, il lavoratore avrà il diritto alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo
di risarcimento del danno. Altro terreno di contrasto fra le posizioni delle parti del rapporto a tempo
parziale è quello del lavoro supplementare, che incide sulla programmabilità della prestazione. Per
lavoro supplementare si intende il lavoro prestato oltre l’orario concordato dalle parti, anche in
relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi. La legge distingue il caso in cui la materia sia
83
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
regolata dalla contrattazione collettiva dall’ipotesi di lacune regolativa. Nel primo caso il datore ne
deve rispettare le previsioni. In caso di omessa regolazione il datore può richiedere lo svolgimento
di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro
settimanale concordate. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove
giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il
lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale
di fatto. Poi la nuova legge prevede la possibilità di svolgimento di prestazioni di lavoro
straordinario, che aveva senso in precedenza rispetto al part-time verticale, alimentando l’ambiguità
dell’eliminazione della distinzione fra i due tipi di part-time. Il passaggio dal tempo pieno al tempo
parziale può costituire l’oggetto di una richiesta del datore o una pretesa del lavoratore che ritiene
opportuno ridurre lo sforzo lavorativo. La legge si preoccupa di predisporre specifiche tutele per il
lavoratore, in particolare nel caso in cui essa venga richiesta dal datore. La legge sancisce il
principio secondo cui il rifiuto opposto dal lavoratore alla trasformazione del rapporto da tempo
pieno a tempo parziale (o viceversa) non può costituire giustificato motivo di licenziamento. Resta
intatto il potere del datore di procedere al licenziamento, nel caso in cui dimostri che la conversione
costituisce l’extrema ratio per evitare il licenziamento. La trasformazione del rapporto può aver
corso previo accordo scritto fra datore e lavoratore. Viene poi valorizzato l’interesse del lavoratore a
tempo pieno a passare a tempo parziale stabilendosi in capo al datore l’obbligo di darne adeguata
informazione al personale già dipendente nelle unità produttive poste nello stesso comune. Il datore
è inoltre onerato di “prendere in considerazione” le domande di trasformazione a part-time di
rapporti a tempo pieno. Deve inoltre ritenersi implicito un onere di giustificazione del rifiuto. Un
diritto soggettivo perfetto al passaggio a tempo parziale è previsto solo a favore dei lavoratori affetti
da patologie oncologiche, i quali hanno anche diritto a richiedere il “ritorno” a tempo pieno. In caso
di diritto del lavoratore al congedo parentale, questi può chiedere, ma una sola volta, la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una
riduzione dell’orario non superiore al 50%. Con l’art. 24 del d.lgs. n. 80/2015 è stato prefigurato,
per le lavoratrici che siano vittime di violenza di genere, anche il diritto alla trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. Su richiesta della lavoratrice poi il
rapporto deve essere nuovamente trasformato in rapporto a tempo pieno. Per i lavoratori il cui
coniuge, i figli o i genitori siano affetti da “patologie oncologiche o gravi patologie cronico-
degenerative ingravescenti” o che assistano una persona convivente con totale e permanente
inabilità lavorativa grave o, ancora, con figlio convivente di età non superiore ai tredici anni o
portatore di handicap, si prevede solo una priorità nella trasformazione del contratto a tempo pieno
in contratto a tempo parziale. La legge inoltre regola l’ipotesi inversa, cioè il passaggio da tempo
parziale a tempo pieno. È previsto un diritto soggettivo di precedenza a favore di chi operi a tempo
parziale solo per i lavoratori che abbiano trasformato a tempo parziale un rapporto originariamente
a tempo pieno. Il trattamento spettante al lavoratore a tempo parziale è ispirato alla regola della non
discriminazione, con il divieto di riservare al part-timer un trattamento meno favorevole di quello
assicurato ad un lavoratore a tempo pieno la cui prestazione sia comparabile. Al lavoratore part-
timer spettano i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile. Ai fini del computo
del numero dei dipendenti dell’impresa i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso
del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno.
Nell’ambito del pubblico impiego l’introduzione del part-time è stata disturbata dal sistema delle
incompatibilità. Con il d.lgs. n. 29/1993 sono state estese le procedure per l’assunzione agli
impieghi anche ai part-timers. È solo con l’art., 56°-65° co., della l. n. 662/1996 che il part-time ha
ricevuto un certo impulso. La trasformazione del rapporto a tempo parziale avviene
automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale il dipendente deve indicare
84
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che intende svolgere, collateralmente al
lavoro pubblico. La pubblica amministrazione ha il potere di negare la conversione nel caso in cui
ravvisi un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio cui il lavoratore è addetto o quella
di differirla nell’ipotesi in cui la trasformazione comporti grave pregiudizio alla funzionalità
dell’amministrazione stessa. Il lavoratore ha comunque diritto al ritorno a tempo pieno. Tale
disciplina e altresì quella che regola i meccanismi concorsuali per le assunzioni erano stati fatti salvi
dalla disciplina dell’originario d.lgs. n. 61/2000, il cui contenuto era estensibile al rapporto di
pubblico impiego. La questione si è complicata a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche al
d.lgs. 61/2000, introdotte con il d.lgs. n. 276/2003, dal momento che quest’ultimo apparato
normativo non si applicava dichiaratamente al pubblico impiego. Ne derivava che ai pubblici
impiegati continuava ad essere applicabile in materia di part-time il d.lgs. n. 61/2000, nella versione
ante-riforma del 2003. Il d.lgs. n. 81/2015 che regola ex novo la materia, dispone l’estensione della
disciplina del lavoro a tempo parziale anche alle pubbliche amministrazioni. Resta comunque
esclusa la possibilità per le pubbliche amministrazioni di richiedere lavoro supplementare e di
pattuire direttamente con il lavoratore clausole elastiche, in assenza di regolamentazione collettiva,
così come si esclude l’applicabilità dell’intero apparato sanzionatorio di cui all’art. 10.
15.1. Con gli artt. da 33 a 40 del d.lgs. n. 276/2003 era stato introdotto il lavoro intermittente. La
particolarità di questo tipo di lavoro sta nella circostanza che il lavoratore viene utilizzato solo “a
chiamata”, cioè quando l’impresa ne abbia necessità. In realtà quello introdotto nel nostro
ordinamento nel 2003 non era propriamente il “lavoro a chiamata” conosciuto in altri paesi.
Comunque il governo di centro-sinistra si era fatto carico di abrogarla integralmente, con la legge n.
247/2007, riproducendo lo schema in una versione minore, limitata ai soli settori del turismo e dello
spettacolo e con lo scopo di contrastare il ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso. Il nuovo
governo di centro-destra, con la l. n. 133/2008, aveva nuovamente riproposto la versione originaria
del contratto di lavoro intermittente ed infine la riforma Monti era intervenuta per ritoccare alcuni
aspetti. Anche la materia del lavoro intermittente è entrata entro lo specchio regolativo del jobs act
renziano, che ha abrogato la pregressa disciplina, cosicché la nuova regolamentazione dell’istituto si
trova nel d.lgs. n. 81/2015 agli articoli da 13 a 18. Secondo l’art. 13 il contratto di lavoro
intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di
lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa per lo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente. Le esigenze che abilitano alla stipulazione sono individuate dai contratti
collettivi, che possono anche autorizzarlo per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del
mese o dell’anno. Titolari del contratto possono solo essere lavoratori ultracinquantacinquenni o di
età inferiore a ventiquattro anni. Il lavoro intermittente incontra un limite complessivo massimo di
giornate, con l’eccezione dei settori del turismo, dello spettacolo e dei pubblici servizi. È infatti
ammesso per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro
nell’arco di tre anni solari. Ove il limite sia superato, il rapporto si trasforma in uno di lavoro a
tempo pieno e indeterminato. Ad esso si applicano i divieti ricorrenti rispetto alle forme flessibili di
occupazione. È infatti vietato il ricorso al lavoro intermittente: a) per la sostituzione di lavoratori
che esercitano il diritto di sciopero; b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto a
licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni o presso unità
produttive nelle quali si sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario che
interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; c) da
parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi. Il trattamento economico e
normativo non può essere meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni
svolte. Il trattamento è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente
eseguita. Il contratto va stipulato in forma scritta e deve contenere: a) l’indicazione della durata e
85
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
della causale; b) il luogo e la modalità della disponibilità e del relativo preavviso di chiamata del
lavoratore; c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione
eseguita, la relativa indennità di disponibilità e i relativi tempi di pagamento; d) l’indicazione delle
forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della
prestazione; e) le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in
contratto. Al datore di lavoro è fatto obbligo di dare alla DTL comunicazione della durata, obbligo
la cui violazione è punita con una sanzione amministrativa. La legge dice che tale comunicazione
può anche essere effettuata tramite sms o posta elettronica. Nel caso in cui il lavoratore si sia
contrattualmente impegnato a rendersi disponibile in relazione alla chiamata, il rifiuto ingiustificato
di rispondervi può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di
disponibilità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento
del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o dal contratto di lavoro. A tale obbligo al
lavoratore spetta l’indennità mensile di disponibilità, la cui misura è determinata dai contratti
collettivi. Tale misura non può essere inferiore a quella prevista con decreto del Ministro del lavoro.
L’indennità è esclusa però dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo e quindi non
può incidere su altri istituti contrattuali. La legge poi si preoccupava di ripartire fra le parti i rischi
dell’impossibilità del lavoratore di svolgere la prestazione. In caso di malattia o di altro evento che
renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto ad informare
tempestivamente il datore di lavoro. Se il lavoratore non adempie all’obbligo di comunicazione
dell’impedimento, perde il diritto all’indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni. Per
il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata dal datore, non è
titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico
e normativo. Il lavoratore intermittente è computato nell’organico dell’impresa in proporzione
all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre. Il d.lgs. n. 81/2015 esclude
esplicitamente l’estensibilità della disciplina del lavoro intermittente alle pubbliche
amministrazioni.
LA PRESTAZIONE DI LAVORO. C) L’ADEMPIMENTO E GLI OBBLIGHI
STRUMENTALI
16. Il tratto tipico della subordinazione consiste nella soddisfazione dell’interesse del datore-
creditore ad organizzare la prestazione del lavoratore nell’ambito del processo produttivo, nella
prospettiva del perseguimento dell’interesse “finale” dell’organizzazione. Alla soddisfazione di tale
interesse deve conformarsi il comportamento del lavoratore. Sul lavoratore incombono, oltre agli
obblighi diretti ad adempiere, anzitutto i cosiddetti obblighi preparatori all’adempimento, che
consentono al lavoratore di porsi nella condizione di adempiere alla prestazione dedotta in contratto.
La specificità del rapporto di lavoro sta nella constatazione secondo cui tali obblighi vanno
temporalmente a collocarsi negli spazi extra-lavorativi del prestatore. Prima che delle regole
giuridiche, dovrebbe assumersi l’irrilevanza di comportamenti privati del lavoratore, anche in
considerazione della preminenza dell’interesse al godimento del riposo. Nessun datore si
sognerebbe di contestare ad un lavoratore degli obblighi preparatori. Ciò non toglie che possa
esservi spazio per la rilevanza della violazione dei doveri preparatori: si pensi alle attività poste in
essere dal lavoratore in costanza di malattia. Esse possono essere valutate come inadempimenti
contrattuali alla luce dell’obbligo del lavoratore di non aggravare le proprie condizioni,
procrastinando il momento della ripresa della collaborazione.
17. L’obbligazione di lavoro va eseguita con correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)
e va valutata alla luce del parametro della diligenza. L’esecuzione con correttezza e buona fede
86
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
comporta in capo al lavoratore l’esecuzione di obblighi ulteriori rispetto al puro e semplice
adempimento della prestazione convenuta. Il parametro della diligenza esprime la funzione di
misuratore dell’entità della collaborazione richiesta al lavoratore per la soddisfazione dell’interesse
del creditore. Secondo l’art. 2104 comma 1 c.c. il lavoratore è tenuto ad usare “la diligenza richiesta
dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della
produzione nazionale”. Si tratta di una regola speciale, a fronte di quella prefigurata dall’art. 1176
c.c. Il parametro della natura dell’attività allude al comportamento del lavoratore necessario per lo
svolgimento delle specifiche mansioni dedotte in contratto. Le modalità di attuazione
dell’obbligazione saranno differenti in funzione della qualità della prestazione. Degli altri due
parametri individuati dall’art. 2104 c.c., quello riferito all’interesse superiore della produzione
nazionale costituisce un retaggio della struttura dirigista data alle norme del Libro V
dall’ordinamento corporativo. In quanto tale non ha oggi alcun significato giuridicamente
vincolante. Intorno al dato dell’interesse dell’impresa si è sviluppato un dibattito fra chi assumeva
che potesse enuclearsi una sorta di interesse oggettivo dell’impresa e chi tendeva a ricondurlo allo
specifico interesse soggettivo del creditore di lavoro. L’inciso non può che alludere all’interesse del
creditore, identificando quest’ultimo nel titolare dell’attività di impresa. La prestazione diligente del
lavoratore deve essere valutata nella prospettiva di consentirne il coordinamento con l’attività altrui
ed il più generale inserimento nella struttura produttiva predisposta dall’altro contraente. La
violazione dell’obbligo di diligenza dà luogo a responsabilità contrattuale del lavoratore. Tale
responsabilità si cumula con la responsabilità disciplinare. La mancanza di diligenza comprende
altresì l’imperizia nell’esecuzione della prestazione. È peraltro coerente ritenere che sia esente da
responsabilità l’imperizia provocata dal fatto del datore-creditore, che adibisca, ad esempio, il
lavoratore a mansioni diverse ed incompatibili con quelle convenute contrattualmente o
conseguente alla carente organizzazione del lavoro. Il lavoratore risponde anche in caso di colpa
lieve, cioè di semplice leggerezza nell’adempimento della prestazione. Accanto all’obbligo di
diligenza l’art. 2104 richiama il dovere di obbedienza, consistente nell’osservanza delle
“disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro”. Si tratta di una sorta di attributo del
“lavorare in modo subordinato”, che si caratterizza per la posizione di soggezione in cui si trova il
prestatore di lavoro. Costituisce dunque il rovescio del potere direttivo, attraverso il quale il datore
dirige la prestazione promessa verso la realizzazione del proprio interesse. La giurisprudenza
riconduce alla violazione del dovere di obbedienza i comportamenti del lavoratore caratterizzati da
insubordinazione. È una nozione che è peraltro utilizzata dalla giurisprudenza in modo alquanto
eclettico, facendovi rientrare sia la pura e semplice violazione degli obblighi contrattuali sia l’aperta
contestazione di una disposizione impartita dal datore o dai suoi collaboratori. La giurisprudenza
ammette il diritto del lavoratore di rifiutare disposizioni illegittime o illecite. È discusso invece se
rientri nel potere direttivo il diritto ad impartire disposizioni relative all’abbigliamento ed all’aspetto
personale del lavoratore.
18. Sotto la rubrica “obbligo di fedeltà” l’art. 2105 c.c. impone al prestatore di lavoro due doveri: a)
non “trattare d’affari in concorrenza con l’imprenditore”; b) non “divulgare notizie attinenti
all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o farne uso in modo da poter recare ad
essa pregiudizio”. Non è enucleabile un obbligo che imponga la fedeltà del lavoratore e che sia
ulteriore rispetto agli specifici divieti prefigurati nel corpo della norma. Tale fedeltà non ha una sua
autonomia concettuale, costituendo una sorta di variante semantica degli obblighi strumentali di
protezione. La medesima non può essere confusa con il carattere fiduciario del rapporto o con le
inferenze della personalità della prestazione. Il rilievo dei doveri di fedeltà è caratteristico delle
relazioni di stampo comunitario, esprimendo esso un legame fra i suoi appartenenti o fra questi e la
comunità, mentre è del tutto incompatibile con i rapporti di scambio. È pacifico che il divieto di
87
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore evoca un’ipotesi di
concorrenza, diversa da quella “sleale”, che si riferisce ai rapporti fra imprese nel mercato, per
assumere un connotato di differenzialità rispetto alle situazioni appena ricordate. In materia la
giurisprudenza è assai rigorosa, bollando con l’illegittimità anche il semplice acquisto di quote di
società concorrenti o l’attività solo preparatoria di quella propriamente concorrenziale. Ricorrenti
sono le affermazioni dell’illegittimità del comportamento concorrenziale anche se attuato per
interposta persona. La violazione del divieto deve implicare la sussistenza di una sorta di
potenzialità offensiva del lavoratore. Il divieto di svolgere attività in concorrenza con il datore di
lavoro ha effetto solo all’interno e nel corso della durata del rapporto. Nel caso in cui invece il
datore intenda assicurarsi che il prestatore non operi in concorrenza anche successivamente alla
cessazione della relazione contrattuale è indispensabile che stipuli un apposito patto di non
concorrenza. Il patto deve, a pena di nullità: a) risultare da atto scritto; b) contenere il divieto di
concorrenza entro puntuali limiti di oggetto, tempo e luogo; c) prevedere un corrispettivo per il
lavoratore. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, per i dirigenti, e a tre anni,
per gli altri prestatori. Anche rispetto al patto di non concorrenza vale la considerazione secondo cui
viene in evidenza la concorrenza differenziale che l’ex-dipendente può porre in essere. Quanto ai
limiti di oggetto il patto può legittimamente riguardare qualunque attività, a prescindere dalle
mansioni in concreto espletate dal lavoratore nel corso del rapporto. In giurisprudenza si ritiene che
l’eccessiva estensione territoriale dei limiti del patto ne comporti la nullità in ragione della
sproporzionata limitazione della libertà di lavoro del prestatore. L’ulteriore obbligo imposto dall’art.
2105 c.c. al prestatore riguarda la riservatezza circa le notizie attinenti all’organizzazione e ai
metodi di produzione. In materia interferisce la normativa penalistica sul segreto professionale ed
industriale, di cui agli artt. 621, 622 e 623 cod. pen. Con la prima è punita la rivelazione di
documenti del cui contenuto l’agente sia venuto abusivamente a conoscenza. Con la seconda è
sanzionata la rivelazione o l’utilizzazione di segreti da parte di soggetti che ne siano a conoscenza
“per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte”, se dal comportamento
dell’agente possa scaturire un danno. Con la terza si punisce invece la rivelazione a proprio o altrui
profitto di scoperte o invenzioni scientifiche da coloro che ne abbiano conoscenza in ragione del
loro ufficio, stato, professione o arte, ed a prescindere dall’esistenza di un danno. Una fattispecie
rispetto alla quale assai spesso i nostri giudici riconoscono la violazione dell’art. 2105 c.c. riguarda
la sottrazione di documenti aziendali ai fini di una loro produzione nell’ambito di controversie
promosse nei confronti del datore.
19. Il tema dell’adempimento della prestazione lavorativa richiama quella situazione che si verifica
nel caso in cui il lavoratore realizzi delle “invenzioni”. Il codice civile, all’art. 2590, sancisce la
regola secondo cui il lavoratore ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello
svolgimento del rapporto di lavoro. L’art. 64 del d.lgs. 10/02/2005 n. 30 (codice della proprietà
industriale) distingue tre diverse situazioni: a) l’invenzione di servizio: in cui l’invenzione venga
fatta nell’esecuzione di un rapporto di lavoro “in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto de
contratto”; b) invenzione aziendale: in cui l’invenzione sia fatta nell’ambito di un rapporto di
lavoro, ma al di fuori di uno specifico impegno; c) invenzione occasionale: in cui l’invenzione sia
realizzata, al di fuori del rapporto, ma rientri nel campo di attività dell’impresa datrice di lavoro.
Nel primo caso i diritti derivanti appartengono al datore, salvo il diritto dell’inventore ad esserne
riconosciuto autore. Nel secondo caso i diritti appartengono al datore ma all’autore spetta un equo
premio per la determinazione del quale si deve tener conto dell’importanza dell’invenzione, delle
mansioni svolte e della retribuzione percepita dall’inventore, nonché del contributo che questi ha
ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro. Nel terzo caso il datore ha solo un diritto di
opzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo, dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto, nonché
88
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
per la facoltà di chiedere od acquisire brevetti all’estero verso corresponsione del canone o del
prezzo. Il datore potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della
comunicazione di avvenuto deposito della domanda di brevetto. Se le parti non raggiungono un
accordo per determinare l’importo dell’equo premio per l’invenzione aziendale o del canone o
prezzo per l’invenzione libera, la legge prevede che alla determinazione dell’ammontare provvede
un collegio di arbitratori. In materie incide l’art. 4 della l. n. 190/1985 che riconosce alla
contrattazione collettiva il potere di definire le modalità tecniche di valutazione e l’entità del
corrispettivo economico dell’utilizzazione, da parte dell’impresa, sia delle innovazioni di rilevante
importanza nei metodi, nei processi di fabbricazione o nell’organizzazione del lavoro, sia delle
invenzioni fatte dai quadri. Con il d.lgs. n. 518/1992 è stata data attuazione alla Direttiva CE
14/05/1991 n. 91/533 sulla tutela dei software. Nel caso di software o di banca-dati realizzati dal
prestatore di lavoro subordinato, il datore è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica
del programma per elaboratore o della banca dati.
I POTERI DEL DATORE NELL’AMMINISTRAZIONE DEL RAPPORTO
20. Per il perseguimento dell’interesse cui è preordinato il contratto di lavoro, l’ordinamento
assegna al creditore di lavoro una serie di posizioni di potere. Secondo l’art. 2086 c.c.
“l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. La
“laicizzazione” del contratto di lavoro ha spogliato i poteri datoriali di tale connotazione. Si è
parlato, oltre che dei classici poteri direttivo e disciplinare, di un potere “determinativo” e di uno “di
conformazione”, di un potere “ordinatorio” e di uno “organizzativo” e via distinguendo ed
enumerando. Costituiscono un’inferenza della posizione creditoria datoriale sia il potere di
impartire direttive sull’esecuzione del lavoro (potere direttivo) sia quello di organizzare tale
prestazione quanto al tempo e al luogo della sua esecuzione (potere organizzativo) sia quello di
controllare l’esecuzione della prestazione (potere di controllo e/o di vigilanza) sia quello di reagire
alle disfunzioni organizzative attraverso l’irrogazione di “pene private” (potere disciplinare). Gli atti
dell’amministrazione del rapporto di lavoro sono caratterizzati da “tipicità”, cosicché possono
considerarsi validi solo se conformi al modello normativo di riferimento. Il nostro ordinamento è
orientato a configurare il controllo sugli atti datoriali come controllo esterno. Il diritto positivo
propone l’impiego di tale tecnica di controllo non solo all’interno del codice civili, ma anche
nell’ambito della legislazione speciale successiva. L’ordinamento lavoristico rifiuta forme di
controllo interno dei poteri, riconducibili alla tecnica dell’interesse legittimo o dell’interesse
“occasionalmente protetto”, come è prospettato rispetto a quelle situazioni in cui la posizione di
diritto del singolo si affievolisce rispetto alla regolamentazione di interessi pattuita in sede
contrattuale collettiva. Si tratta di una concezione che implica una funzionalizzazione dei poteri del
datore ad un fine esterno rispetto al rapporto obbligatorio. Nei rapporti di lavoro l’interesse che
sorregge l’iniziativa economica privata non ha carattere “oggettivo”, ma è rapportabile alle concrete
finalità di profitto individuale. Ugualmente infondate sono le ulteriori posizioni che postulano
forme di controllo interno degli atti di gestione del rapporto attraverso la tecnica dello sviamento
della funzione causale dell’atto o dell’abuso del diritto. Anch’esse si prestano ad un ampliamento
del potere giudiziale di colpire attività negoziali in sé perfettamente legittime. Ciò acquisito,
venendo alle tecniche impiegate per limitare i poteri unilaterali del datore, dobbiamo distinguere
quelle che si esprimono in termini di divieti tassativi dall’impiego dei poteri datoriali con finalità
lesive da quelle che dispongono specifiche modalità di esercizio dei poteri unilaterali. La tecnica
ricordata per prima è posta a presidio di diritti fondamentali di rilevanza costituzionale: ne deriva
che il datore non può in alcun caso realizzare, pena la nullità, atti di gestione del rapporto che siano
diretti al fine di limitare tali diritti fondamentali. Le tecniche dirette a disciplinare le modalità di
89
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
esercizio dei poteri vengono a consistere nell’osservanza di procedure che hanno come destinatari
talvolta i rappresentanti dei lavoratori, con lo scopo di informarli o di negoziare le forme di
esercizio del potere, qualche altra il lavoratore interessato. Un esempio della prima situazione si ha
con i diritti di informazione o agli obblighi di negoziazione in relazione all’impiego di mezzi
audiovisivi. Un esempio della seconda è fornito dalle procedure previste per l’esercizio del potere
disciplinare. I fenomeni appena descritti sono definiti con il neologismo di procedimentalizzazione
dei poteri datoriali, alludendo al meccanismo con cui l’azione del datore è scandita da una serie
collegata di adempimenti funzionalizzati al perseguimento dello scopo finale. Un discorso non
dissimile vale per quelle situazioni in cui sia l’autonomia collettiva a limitare i poteri unilaterali del
datore. Ciò avviene ad esempio nel caso in cui il contratto collettivo imponga al datore l’obbligo di
selezionare i dipendenti più meritevoli attraverso procedure a carattere concorsuale. Anche i
problemi posti da tale fattispecie possono essere affrontati e risolti, valorizzando la “tecnica del
rapporto”. È quindi possibile ritenere che l’azione del lavoratore debba essere valutata come azione
diretta ad ottenere l’adempimento dell’obbligazione. È altresì possibile ritenere che l’obbligo
contrattuale assunto dal datore possa essere oggetto di sindacato giudiziale, avendo riguardo al
rispetto della buona fede e correttezza negoziale. Buona fede e correttezza divengono parametri di
valutazione dell’esattezza dell’adempimento del datore all’obbligazione assunta contrattualmente e
non impossibili supporti ad un’azione diretta a far valere un’inesistente nullità.
21. Una prima serie di limiti deriva dal rispetto dei diritti fondamentali del lavoratore. È questa la
materia sulla quale ha inciso lo statuto dei lavoratori (legge 20/05/1970 n. 300), la cui disciplina è
diretta a garantire l’attuazione dei diritti fondamentali previsti in astratto nella Carta costituzionale.
Rileva su questo piano il rispetto del principio di non discriminazione, che è diretto a limitare ogni
forma di esercizio dei poteri unilaterali del datore di lavoro. L’art. 15 dello statuto dei lavoratori
prefigura la nullità di qualsiasi atto o patto diretto a discriminare il lavoratore. Il divieto si estende
ad atti o patti discriminatori che hanno riguardo ad ogni aspetto della vita del rapporto di lavoro. La
politica antidiscriminatoria è stata rafforzata nel contesto della disciplina dell’immigrazione. Il
nostro paese ha recepito le direttive 2000/43/CE, in materia di parità di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e 2000/78/CE, sulla parità di trattamento in
materia di occupazione e condizioni di lavoro, con i dd.lgs. 09/07/2003 nn. 215 e 216. Con il primo
è vietata ogni discriminazione che sia radicata sulla razza o sull’origine etnica; con il secondo ogni
discriminazione a causa della religione, delle condizioni personali, degli handicap, dell’età o
dell’orientamento sessuale. Al divieto sono assoggettate sia le discriminazioni dirette sia le
discriminazioni indirette. Quest’ultime si hanno quando una disposizione, un criterio etc.,
apparentemente neutri, possono porre in una situazione di particolare svantaggio i soggetti protetti.
Di rilievo è inoltre l’equiparazione alle vere e proprie discriminazioni delle molestie, cioè
comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi discriminatori ed aventi lo scopo di violare la
dignità di una persona e creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo. Al
centro della definizione sta il concetto di indesideratezza della molestia. È un elemento giuridico
che andrà valutato attentamente, per fugare il rischio che la repressione delle molestie passi
attraverso l’esclusivo punto di vista soggettivo della vittima. Il meno che si deve assumere è che il
giudizio valutativo debba essere condotto sul filo di criteri di media ragionevolezza. Viene
equiparato alla discriminazione anche il mero “ordine di discriminazione”, allo scopo di imputare al
datore i comportamenti discriminatori, posti in essere dai dipendenti. Il divieto di discriminazione si
applica a tutti i rapporti di lavoro. La discriminazione è esclusa in tutti quei casi in cui la
prestazione in sé o il contesto in cui viene espletata rendono essenziali le caratteristiche oggetto di
discriminazione. Rilevante è la prefigurazione di uno speciale procedimento giudiziale con cui il
lavoratore discriminato può chiedere al giudice la cessazione del comportamento pregiudizievole
90
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
e/o l’adozione di ogni provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Attualmente si applicano le
regole del rito sommario di cognizione. La competenza territoriale è quella del tribunale del luogo
in cui ha domicilio il ricorrente. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio
personalmente. Ove il lavoratore fornisca elementi di fatto, dai quali si può presumere l’esistenza di
atti discriminatori, spetta al datore l’onere di provare l’insussistenza della discriminazione. Il
giudice può condannare il datore al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la
cessazione del comportamento discriminatorio pregiudizievole, adottando ogni altro provvedimento
idoneo a rimuoverne gli effetti. Può inoltre ordinare l’adozione di un piano di rimozione delle
discriminazioni accertate. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che
l’atto discriminatorio costituisce ritorsione ad una precedente azione giudiziale o ingiusta reazione
ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di
trattamento. Il giudice può inoltre ordinare la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano di
tiratura nazionale.
22. La disciplina dei limiti ai poteri di controllo del datore è contenuta negli artt. da 2 a 6 dello
statuto dei lavoratori. Si inquadra nella logica della legge del ’70 diretta alla protezione dei beni
della libertà e dignità del lavoratore. Oggetto di limitazione è l’impiego delle guardie particolari
giurate, che costituiscono una sorta di “polizia privata”, preposta alla tutela del patrimonio
aziendale. Negli anni cinquanta e sessanta si verificò un impiego anomalo di tale personale, usato
spesso per controllare i lavoratori e non i beni aziendali. L’art. 2 dello statuto riconduce
l’utilizzazione delle guardie giurate alla funzione loro propria di tutela del patrimonio. Poi prevede
che esse non possono essere adibite alla vigilanza sull’attività di lavoro, essendo loro inibito anche
l’accesso ai luoghi di lavoro, se non per specifiche e motivate esigenze attinenti ai loro compiti. La
violazione della norma, oltre alle sanzioni penali di cui all’art. 38 dello statuto, può comportare la
sospensione o la revoca della licenza prefettizia. L’art. 3 dello statuto stabilisce che i nominativi e le
mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa devono essere
comunicati ai lavoratori interessati. La norma non intende precludere al datore il potere di
controllare l’adempimento della prestazione da parte del lavoratore, ma solo evitare forme odiose e
surrettizie di vigilanza. Si riferisce ai soli soggetti che siano addetti alla vigilanza. La
giurisprudenza esclude l’applicabilità dei divieti di cui agli artt. 2 e 3 dello statuto ai controlli
effettuati nei confronti di comportamenti illeciti del lavoratore. È altresì lecito che tali ultimi
controlli vengano effettuati attraverso agenzie investigative. Il sillogismo adottato per giustificare
l’esenzione dal divieto nei casi appena descritti. È, in molte situazioni, l’unico strumento a
disposizione del datore per smascherare truffe o frodi ai suoi danni. Una più articolata disciplina vi
era poi in relazione ai controlli a distanza. L’art. 4 dello statuto faceva divieto dell’adozione di
“impianti audiovisivi” e di “altre attrezzature” che consentissero il controllo a distanza, tranne che
fossero richiesti da esigenze organizzative e produttive o dalla sicurezza del lavoro. In tal caso la
loro installazione ed impiego doveva essere oggetto di accordo con le rappresentanze sindacali
aziendali o con la commissione interna. In difetto di accordo provvedeva il Servizio Ispezione del
lavoro della DTL. La norma alludeva all’impiego di impianti televisivi a circuito a chiuso, mediante
i quali si può controllare a distanza spaziale il processo produttivo. Sennonché l’ampia
formulazione ne aveva consentito l’estensione alle forme di controllo a distanza temporale. L’art. 4
dello statuto è entrato nel novero delle disposizioni da modificare, per effetto della delega contenuta
nella legge n. 183/2014, che all’art. 1 comma 5 si propone di “conseguire obiettivi di
semplificazione e razionalizzazione delle procedure di gestione dei rapporti di lavoro” ed all’art. 1
comma 7 “di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono
in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli coerenti con le
attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo”. Fra i principi e i criteri cui deve attenersi
91
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
il legislatore troviamo la “revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli
strumenti di lavoro”. Con l’art. 23 del d.lgs. n. 151/2015 è stato sostituito il testo dell’art. 4 dello
statuto. La nuova formulazione ribadisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti possono
essere installati solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la
tutela del patrimonio aziendale, previo accordo collettivo stipulato dalle r.s.u. o dalle r.s.a. In
alternativa può essere stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
In assenza di accordo possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del
lavoro o del ministero del lavoro. La novità del provvedimento sta nella circostanza che l’accordo e
l’autorizzazione non sono richiesti per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la
prestazione lavorativa e per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle uscite. Le
informazioni raccolte attraverso tali ultimi strumenti ben possono essere utilizzate dal datore di
lavoro, purché venga data al lavoratore adeguata informazione delle loro modalità d’uso e di
effettuazione dei controlli e pur sempre nel rispetto della disciplina sulla privacy. L’ammissibilità
delle visite personali di controllo sui lavoratori, cioè delle perquisizioni, è in linea di principio
vietata, secondo l’art. 6 dello statuto, mentre è limitata alle situazioni in cui esse risultino
indispensabili per la tutela del patrimonio aziendale. A tutela della dignità dei lavoratori la norma
detta specifiche modalità di effettuazione: devono essere eseguite all’uscita dei luoghi di lavoro, con
la salvaguardia della dignità e della riservatezza del lavoratore e con l’applicazione di sistemi di
selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoro. La norma è stata ritenuta
costituzionalmente legittima, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 41, 2° co., Cost., dalla Corte
costituzionale, posto che i controlli previsti dall’art. 6 non potrebbero essere imposti d’autorità, ma
sono assoggettati al consenso dell’interessato.
23. Il quadro delle tutele del lavoratore si completa con la protezione della libertà di opinione e del
connesso diritto alla riservatezza. Va ricordato il diritto, sancito dall’art. 1 dello statuto, di libera
manifestazione del pensiero, nei luoghi di lavoro. La norma circoscrive uno spazio di libertà
inalienabile del lavoratore, protetto dalla tutela della riservatezza sancita dal successivo art. 8.
L’ampia valenza protettiva dell’art. 1 può dispiegarsi in relazione a quelle libere manifestazioni del
pensiero che coinvolgono anche l’impresa. L’art. 8 dello statuto fa divieto al datore di lavoro di
effettuare indagini, anche a mezzo di terzi sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del
lavoratore nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del
medesimo. Si tratta di una norma a protezione del diritto della riservatezza del lavoratore, il cui
unico limite è costituito dal rilievo di fatti che possano avere un legame diretto con le obbligazioni
dedotte nel contratto di lavoro. L’art. 8 circoscrive il rilievo della persona del lavoratore in relazione
a quanto è funzionalmente collegato con la soddisfazione dell’interesse del creditore di lavoro.
Posto che la legge circoscrive il divieto alle “indagini”, restano escluse quelle situazioni in cui il
datore abbia ricevuto casualmente le informazioni. Vi è poi il divieto, previsto dall’art. 6 comma 1
della l. n. 135/1990 e diretto ai datori pubblici e privati, di svolgere indagini “volte ad accertare nei
dipendenti o in persone prese in considerazione per l’instaurazione di un rapporto, l’esistenza di uno
stato di sieropositività”. L’art. 5, comma 3 e 5, è stato ritenuto illegittimo costituzionalmente nella
parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell’assenza di sieropositività all’infezione da HIV
come condizione per l’espletamento di attività che comportano rischi per la salute di terzi. In
materia di tutela della riservatezza si inserisce poi la legge 31/12/1996 n. 675, sulla tutela delle
persone rispetto al trattamento dei dati personali. La legge è stata abrogata e sostituita dal d.lgs. n.
196/2003. Scopo della legge è quello di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone. Vengono presi in considerazione tutti i
soggetti che detengono una “banca dati”. Quest’ultima è definita come “qualsiasi complesso di dati
personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti”. Agli interessati è riconosciuto
92
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
anzitutto il diritto ad essere informati in ordine alle modalità e finalità del trattamento dei dati, alla
loro natura, al luogo ove vengono custoditi e all’ambito di comunicazione e diffusione dei
medesimi. Una più marcata tutela è prevista per i dati sensibili, “idonei a rilevare l’origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a
partiti, sindacati associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”. Il trattamento di tali dati, oltre a
dover essere consentito dall’interessato, deve altresì essere autorizzato dal Garante, prevedendosi
allo scopo l’obbligo per i titolari delle banche dati di notificazione al Garante della natura delle
informazioni e delle modalità e scopi del loro trattamento. L’apparato di tutela predisposto è
estensibile anche alle banche dati aziendali tenute dai datori. Alla stessa stregua non è richiesto il
consenso dell’interessato in relazione alla raccolta di dati in adempimento di obblighi previsti dalla
legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria o che consegua dall’adempimento di obblighi
che discendono dal contratto di cui è parte l’interessato. In relazione al trattamento dei dati sensibili
nel rapporto di lavoro il Garante rilascia un’autorizzazione generale, derivandone che il datore non
è obbligato a richiedere, volta per volta, l’autorizzazione. I nessi con la disciplina lavoristica non
sono di reciproca esclusione, ma di coordinamento ed integrazione. L’esenzione del datore dalla
richiesta del consenso del lavoratore per il trattamento dei dati personali è legittima in quanto si
muova nella logica della funzionalizzazione all’adempimento degli obblighi contrattuali. Va
segnalato come tratto di innovatività l’allargamento della tutela di natura procedimentale. Il
lavoratore potrà sempre pretendere che i dati che lo riguardano siano oggetto di un trattamento
rispettoso dei limiti imposti dalla normativa generale.
24. Il potere disciplinare ha costituito terreno di scontro teorico, posto che rappresenta una sorta di
unicum nei rapporti privatistici. Il rapporto di lavoro è uno dei pochi rapporti nel cui ambito ad uno
dei due contraenti è attribuito il potere di irrogare al partner contrattuale “pene private”. L’esercizio
della disciplina è caratteristico di contesti in cui rilevano profili comunitari o rigide gerarchie. La
cultura giuridica ha giudicato tale potere compatibile con la prospettiva contrattualistica, in ragione
del suo collegamento con il profilo organizzativo. Questa idea corrisponde all’alto grado di tipicità
sociale acquisito dal potere disciplinare. Il che dà misura del suo carattere strumentale rispetto
all’andamento organizzativo dell’impresa capitalistica o dell’impresa tout court. Basti considerare
che Lenin considerava ineliminabile questo potere in quanto “necessario per qualsiasi lavoro
collettivo”. Ben poche voci hanno segnalato l’opportunità dell’eliminazione del potere disciplinare,
attestandosi la discussione sulle strumentazioni idonee a consentirne un impiego conforme alla
protezione della dignità dei lavoratori. D’altra parte l’idea che i rigori di una certa disciplina
all’interno delle imprese siano eliminabili fa il paio con l’altra secondo cui il potere disciplinare
costituirebbe un beneficio per il lavoratore che non si vedrebbe esposto allo spettro di risoluzione
del rapporto. L’una e l’altra sono accumunate da una buona dose di apriorismo ideologico e
rifiutano una laicizzazione del contratto di lavoro. Le precedenti considerazioni ci consentono di
puntualizzare la questione della natura giuridica del potere disciplinare. Nessuno dei rimedi
caratteristici è appaiabile all’esercizio della disciplina aziendale. Le fonti di regolazione sono l’art.
2106 c.c. e l’art. 7 dello statuto dei lavoratori. Secondo la norma codicistica l’inosservanza degli
obblighi di diligenza e fedeltà “può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la
gravità”. Il riferimento agli obblighi di diligenza e fedeltà evoca all’evidenza ogni sorta di
inadempimento del lavoratore alle obbligazioni contrattuali. La responsabilità disciplinare non
esclude quella per inadempimento, cosicché il datore può sanzionare un determinato
comportamento del lavoratore e pretendere inoltre il risarcimento dei danni causati. Intatta ed
essenziale resta la rilevanza del principio di proporzionalità. Opera sul piano della
predeterminazione del codice disciplinare e vincola sia il datore che l’autonomia collettiva. Implica
93
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
inoltre che la reazione del datore all’inadempimento del lavoratore deve essere commisurata alla
gravità del medesimo. Più difficile è pronunziarsi sull’esistenza di un potere giudiziale di riduzione
della sanzione. Il problema non può essere disgiunto da quello del coordinamento fra il potere di
riduzione e le domande concretamente spese in giudizio. L’esercizio del potere disciplinare deve
essere tempestivo rispetto alla conoscenza che il datore abbia avuto dell’inadempimento. L’art. 7
dello statuto dei lavoratori ha introdotto una disciplina che ha la funzione di coordinare le esigenze
di protezione dell’organizzazione del lavoro con quelle del rispetto della dignità del lavoratore. Ha
nella sostanza procedimentalizzato l’esercizio del potere. Le guarentigie riguardano: a) le
precondizioni per l’esercizio del potere, b) i limiti sostanziali delle sanzioni, c) le procedure per
l’irrogazione delle sanzioni e d) per la loro impugnazione.
a) Precondizione essenziale per l’esercizio dell’azione disciplinare è che un codice disciplinare
esista; che esista cioè un insieme di regole dirette a prevedere le infrazioni e le correlative
sanzioni. Al datore è riconosciuto un potere unilaterale di redazione di un codice
disciplinare. Nel caso in cui per il datore costituisca oggetto di obbligo contrattuale
l’applicazione di un contratto collettivo costituirà altresì un’obbligazione conseguenziale
quella di fare applicazione del codice disciplinare ivi previsto. Anche le previsioni del
contratto collettivo saranno comunque soggette al controllo di legalità. Quest’ultima
affermazione è altresì compatibile con quella secondo cui l’assetto prefigurato in sede
contrattuale collettiva costituisce comunque per il giudice un indice di congruità della
sanzione rispetto al fatto prefigurato. Fra le precondizioni va inoltre collocato l’onere di
pubblicizzazione del codice disciplinare. Questo onere va adempiuto da parte del datore
“mediante affissione in luogo accessibile a tutti”. È una forma di pubblicità a carattere
necessario, cioè non surrogabile per equivalente. L’unica eccezione è quella che ha riguardo
al licenziamento disciplinare, rispetto al quale le clausole della giusta causa e del giustificato
motivo non hanno bisogno di pubblicizzazione. Quanto al contenuto di questo codice è
diffusa l’osservazione secondo cui esso deve rispondere ai requisiti minimi
dell’individuazione delle infrazioni alla disciplina aziendale e delle sanzioni corrispondenti.
b) Sia il datore che la contrattazione collettiva incontrano dei limiti oggettivi nella
prefigurazione della tipologia delle sanzioni. Secondo il 4° comma dell’art. 7 “non possono
essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto;
inoltre la multa non può essere superiore a quattro ore della retribuzione base e la
sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni”. Il legislatore evoca solo
le tradizionali forme di sanzione (multa e sospensione), lasciando però aperta la possibilità
di introdurre tipologie di diversa natura, dato che l’elencazione non ha carattere tassativo.
L’indeterminatezza della tipologia sanzionatoria lascia aperta la discussione in ordine
all’identificazione della natura oggettivamente disciplinare di forme atipiche di
provvedimenti datoriali. Ricordiamo le note di qualifica che costituiscono dei giudizi
valutativi formulati dal datore, allo scopo di consentire o negare l’attribuzione di speciali
benefici economici. La medesima conclusione vale per l’istituto della sospensione cautelare
del rapporto di lavoro, nel caso in cui il lavoratore sia sottoposto a procedimento penale e/o
disciplinare. Un discorso a parte va fatto circa le sanzioni che possono comportare
mutamenti definitivi del rapporto. Non vi è dubbio che il legislatore avesse presente come
caso paradigmatico il mutamento attraverso la retrocessione disciplinare. Dopo l’entrata in
vigore dello statuto il provvedimento sul quale si è aperto il dibattito più serrato è stato il
trasferimento disciplinare. È difficile non annoverarlo fra i “mutamenti definitivi”: in tale
direzione infatti si era, per lungo tempo, orientata la lettura della disposizione normativa.
Sennonché la giurisprudenza più recente ha ritenuto che il trasferimento possa
94
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
legittimamente costituire uno strumento punitivo se ed in quanto sia previsto come sanzione
dalla contrattazione collettiva. L’art. 7 impone inoltre dei limiti massimi alle sanzioni della
multa e della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Rispetto a tale previsione vale la
gerarchia delle fonti, in forza della quale è consentito alla contrattazione collettiva di
disporre in senso più favorevole, provvedendo ad abbassarli.
c) L’art. 7 poi delinea un procedimento ai fini dell’esercizio concreto del potere disciplinare.
La procedura muove dalla contestazione al lavoratore del fatto che il datore ritiene
rimproverabile. La contestazione deve rivestire la forma scritta, in ragione degli scopi
garantistici che la medesima sottende. Deve essere inoltre il più possibile circostanziata e
non generica. E ciò sia perché il lavoratore non sarebbe posto in grado di difendersi, sia
perché essa circoscrive i fatti che non potranno poi essere modificati in sede giudiziale, a
seguito dell’eventuale impugnazione da parte del lavoratore (principio di immutabilità). Il
datore non può procedere ad irrogare la sanzione prima che siano decorsi cinque giorni dalla
contestazione. La funzione del termine consiste nel consentire al lavoratore di espletare le
proprie difese e fornire al datore una pausa di riflessione. Alla stregua del comma 3 dell’art.
7 il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato. Espletate le difese il datore può procedere ad applicare la
sanzione. Una prima questione riguarda il termine minimo per l’irrogazione della sanzione.
Ci si chiede se il datore debba rispettare il termine di cinque giorni anche se il lavoratore
abbia già presentato le proprie giustificazioni. La querelle giurisprudenziale ha visto
contrapposti due partiti: da una parte chi valorizzava la ratio della previsione del termine
non poteva che concludere per la piena legittimità dell’esercizio del potere anche prima
della scadenza del quinto giorno. Chi valorizzava la dizione letterale della norma optava per
la tesi più rigida dell’illegittimità della sanzione emessa ante tempus. Il contrasto è risolto da
un intervento delle Sezioni Unite della Cassazione che si sono pronunciate a favore del
primo orientamento. La querelle si è riaperta al punto che sono di nuovo intervenute le
Sezioni Unite per ribadire il proprio precedente orientamento. La legge non prevede un
termine massimo entro cui procedere all’applicazione del provvedimento disciplinare. La
sanzione va peraltro irrogata entro un ragionevole arco di tempo, perché altrimenti
opererebbe la presunzione che le difese siano state accolte. Nell’irrogare la sanzione il
datore non può tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro
applicazione. Il datore può ricorrere all’istituto della “recidiva”, cioè alla prospettiva di
aggravare il peso della sanzione in ragione della ripetitività della condotta illecita, solo entro
i termini di tempo previsti dalla legge. Secondo la lettura più diffusa il provvedimento di
comunicazione della sanzione non deve contenere una specifica motivazione. Al più si potrà
ritenere che tale obbligo debba essere adempiuto ove in tal senso disponga la contrattazione
collettiva applicabile al rapporto. Successivamente alla comunicazione il datore può
procedere alla sua esecuzione. Si discute se debba attendere lo spirare del termine di 20
giorni, entro il quale il lavoratore può procedere alla richiesta di costituzione del collegio
arbitrale di cui al comma 6 dell’art. 7.
d) Una volta che il datore abbia deciso di irrogare una sanzione e l’abbia comunicata, si apre
per il lavoratore lo spazio per procedere alla sua eventuale impugnazione. Può optare fra
varie alternative: a) il ricorso al giudice del lavoro; b) il ricorso a procedure previste dalla
contrattazione collettiva; c) il ricorso alla procedura arbitrale prevista dal comma 6 dell’art.
7 dello statuto. Alla stregua di quest’ultima può promuovere nei venti giorni successivi, la
costituzione tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di un
collegio di conciliazione ed arbitrato. È speciale procedura cui si riconosce natura irrituale.
95
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
La legge si preoccupa di incentivare il ricorso all’arbitrato collegando alla sua attivazione
l’effetto sospensivo della sanzione. Un analogo effetto sospensivo si ha nel caso in cui sia il
datore ad agire in accertamento negativo davanti all’autorità giudiziaria. Alla mancata
ottemperanza del datore alla nomina del proprio rappresentante fa seguito la decadenza della
sanzione.
Il potere disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato è governato da disposizioni speciali e
dagli artt. 55-55-sexies del d.lgs. n. 165/2001, che costituiscono norme imperative.
GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO. A)L’OBBLIGO DI SICUREZZA E IL DANNO
ALLA PERSONA
25. Il terreno sul quale emerge la fondatezza della constatazione secondo cui nel rapporto di lavoro
è implicata la persona del lavoratore è quello della tutela della salute nei luoghi di lavoro. I primi
interventi furono diretti a riparare le conseguenze dannose dell’insalubrità dell’ambiente di lavoro,
attraverso l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. L’introduzione di tale forma fu resa possibile dall’affermazione del principio del
rischio professionale, che assume a fondamento della responsabilità civile del datore non la colpa,
ma l’esercizio di un’attività potenzialmente pericolosa per la salute e l‘incolumità dei lavoratori.
Quanto alla prevenzione degli infortuni sono da segnalare solo interventi parziali e settoriali; così il
r.d. 18/06/1899 n. 230 si occupava della prevenzione infortuni nel settore industriale e con
riferimento alle grandi imprese ed altri interventi riguardavano attività molto pericolose. È solo con
il codice civile del 1942 che viene introdotto in capo a datore l’obbligo di sicurezza. Secondo l’art.
2087 c.c. “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che sono
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. La norma,
anche se riferita all’imprenditore, si applica a tutti i datori. L’importanza dell’obbligo di sicurezza si
accentua con l’entrata in vigore della Carta costituzionale che prevede quale limite all’iniziativa
economica privata quello del rispetto della sicurezza e della dignità umana. È evidente che la
questione della prevenzione degli infortuni e della salubrità dell’ambiente non potesse essere
affidata ad un solo obbligo. In materia incide il diritto prevenzionistico che fa capo oggi al d.lgs.
09/04/2008 n. 81. Si tratta di una serie di disposizioni che disciplinano gli obblighi dei datori. La
violazione di tale normativa comporta sanzioni penali ed ha come destinatari non solo il datore ma
anche i preposti, cioè quei soggetti cui il datore abbia delegato le funzioni concrete di controllo
circa l’applicazione e l’osservanza delle misure di sicurezza. Una prima questione riguarda i
rapporti fra l’obbligo di sicurezza sancito dall’art. 2087 c.c. e l’apparato di tutela predisposto dal
diritto prevenzionistico; si riassume nel chiedersi se l’osservanza delle prescrizioni del diritto
prevenzionistico esaurisca l’ambito dei suoi obblighi in materia di sicurezza. La risposta deve essere
negativa: la norma impegna il datore a predisporre le misure necessarie. Dunque il datore non può
dirsi esente da responsabilità fin quando non abbia fatto tutto il possibile per prevenire gli infortuni
ed assicurare un sano ambiente. L’art. 2087 si pone come clausola e valvola di chiusura del sistema
prevenzionistico, introducendo un germe di effettività, posto che costringe il datore ad un
adeguamento costante della propria organizzazione produttiva agli standards della sicurezza.
Quanto alla collocazione sistematica dell’obbligo di sicurezza, sembra affermata la prospettiva
secondo cui esse costituisce un vero e proprio obbligo contrattuale. Tale obbligo permea di sé
l’adempimento delle obbligazioni fondamentali. La conseguenza di tale ricostruzione è che il
lavoratore ha un diritto soggettivo perfetto alla precostituzione di un ambiente salubre e potrebbe
rifiutare la prestazione pretesa in condizioni di insalubrità. Il prestatore potrebbe pretendere
l’adempimento dell’obbligo di sicurezza, in relazione agli artt. 1453 e 2087 c.c. Alla giustiziabilità
96
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
del diritto alla salute si frappongono degli ostacoli insormontabili. A parte la necessità di dimostrare
l’esistenza di un diritto a prestare l’attività di lavoro, l’impiego dello strumento coercitivo di cui
all’art. 2931 c.c. è sembrato inapplicabile ad un diritto la cui realizzazione travalica la dimensione
individuale. È ammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ. perché proposto da una
collettività di dipendenti di un’impresa e diretto ad ottenere provvedimenti d’urgenza idonei a
salvaguardare la salubrità dell’ambiente di lavoro. Intuibili ostacoli di fatto si frappongono
comunque all’impiego di tali rimedi.
26. Nel corso degli anni sessanta il massimo di tutela approntata dalla contrattazione collettiva
prevedeva clausole che ponevano l’obbligo di visite periodiche di controllo o che imponevano il
consumo dei pasti fuori dai reparti al cui interno si svolgevano lavorazioni nocive. Queste ultime
erano legittimate attraverso un’indennità di rischio o di lavori disagiati. Una svolta si ebbe con i
rinnovi contrattuali del 1969, che videro al centro delle piattaforme rivendicative i temi della salute
in fabbrica. Le categorie più esposte ai rischi ottennero, non solo il superamento delle indennità di
nocività, ma anche il divieto di lavorazioni che potessero comportare l’esposizione dei lavoratori a
livelli non accettabili di concentrazione di sostanza nocive nell’ambiente e ciò sulla base di apposite
tabelle che stabilissero i massimi di concentrazione accettabili. Inoltre fu attribuito alla
rappresentanza sindacale il potere di controllo e promozione delle misure dirette ad eliminare la
nocività ambientale. Il punto più alto della strategia sindacale di attenzione verso i temi della salute
venne raggiunto con la Conferenza Nazionale, che rivendicava agli stessi lavoratori il diritto di
accertare l’insalubrità ambientale e proporre misure correttive alternative. Nel frattempo il
legislatore aveva introdotto una norma che fornisse sostegno esterno alla strategia sindacale. L’art. 9
dello statuto prevede che i lavoratori hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione
e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. Secondo
l’art. 9 i lavoratori possono costituire delle rappresentanze ad hoc. Tale acquisizione va coordinata
con l’istituzione della figura del rappresentante per la sicurezza. Le potenzialità della norma dello
statuto non sono state utilizzate a pieno dal movimento sindacale. Nella prassi contrattuale ha
prevalso una sorta di ribaltamento delle strategie “unilateralistiche”, con il ritorno a tecniche di
gestione consensuale degli strumenti di controllo e verifica dell’attuazione delle misure di
sicurezza. Questa logica è stata fatta propria del legislatore in ambito di riforma sanitaria, che
propone prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro e prefigura la
promozione e la salvaguardia della salubrità e dell’igiene dell’ambiente di vita e di lavoro. I relativi
compiti sono affidati al Servizio Sanitario Nazionale, che li esercita, a livello locale, attraverso le
ASL. Anche tale attività viene effettuata sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le
rappresentanze sindacali aziendali e il datore.
27. La materia della sicurezza nei luoghi di lavoro è stata oggetto dell’intervento del legislatore
contenuto nel d.lgs. n. 626/1994. Poi però il legislatore ha messo mano ad un progetto di ulteriore
revisione della disciplina in materia di sicurezze. Con la legge 03/08/2007 n. 123 si è provveduto a
delegare il governo ad emanare dei decreti per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Con il decreto legislativo
09/04/2008 n. 81 si è dato così corso alla delega. L’ambito di applicazione comprende tutti i settori
di attività sia privati che pubblici, fatti salvi alcuni settori, rispetto ai quali si dovrà provvedere a
regolamentazioni più specifiche. Quanto all’ambito soggettivo, trova applicazione nei confronti di
tutti i lavoratori subordinati e autonomi, nonché soggetti ad essi equiparati. Quanto alla nozione di
lavoratore, fa riferimento a qualunque persona che svolge attività lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di un datore pubblico o privato. Il datore è individuato come il soggetto che ha
97
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa. L’impianto contempla una serie di disposizioni a carattere generale attuative
dell’obbligo di sicurezza e del diritto prevenzionistico e una serie di norme su aspetti specifici della
prevenzione. La chiave di lettura è contenuta nell’art. 15 comma 1 lett. b) che pone al centro
dell’attenzione la questione della programmazione della prevenzione. Strumento essenziale della
programmazione della prevenzione è la valutazione dei rischi. Il datore deve valutare tutti i rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori. All’esito di tale valutazione deve predisporre un
documento che deve contenere l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione ed il
programma delle misure opportune a garantire il miglioramento nel tempo della sicurezza.
L’organizzazione della sicurezza deve avvalersi di strutture stabili all’interno dell’impresa. Il datore
è onerato della costituzione del servizio di prevenzione e protezione. Quest’ultimo si occupa della
valutazione dei rischi, della proposta dell’introduzione di misure adeguate e dell’opera di
informazione dei lavoratori circa i rischi ambientali. È inoltre prevista, per la sorveglianza sanitaria,
l’istituzione della figura del medico competente. Il testo unico predispone una speciale procedura
per la gestione delle emergenze. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, si allontana dal posto di
lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da
qualsiasi conseguenza dannosa. Inoltre il lavoratore che prende misure per evitare la conseguenza di
pericoli, non può subire pregiudizio per tale azione. Il coinvolgimento dei lavoratori è realizzato
attraverso l’istituzione della figura del rappresentante per la sicurezza. Nel nuovo testo unico del
2008 esso è articolato in vari livelli: territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. A tale
soggetto è dato il diritto di accesso nei luoghi di lavoro, di ottenere dal datore la documentazione
aziendale relativa alla valutazione dei rischi, di formulare proposte per l’attuazione di misure idonee
di prevenzione. Si prevede che il medesimo possa fare ricorso alle autorità competenti qualora
ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate non sono idonee a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro. Il testo unico del 2008 conferma l’idea secondo cui è
fondamentale il ruolo della partecipazione individuale degli stessi lavoratori al processo relativo alla
sicurezza ambientale. Stabilisce l’obbligo del lavoratore di prendersi cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro. Si prevede poi l’obbligo per il
medesimo di sottoporsi a programmi di formazione e addestramento in materia. Bisogna ricordare
l’attenzione posta nell’allargare l’area della responsabilità prevenzionistica anche a soggetti
formalmente estranei al rapporto di lavoro interessato. Ciò con riferimento alle tecniche di
decentramento della produzione. Già la versione del d.lgs. n. 626/1994 all’art. 7 prevedeva in caso
di affidamento in appalto di lavori all’interno dell’azienda, l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico
professionale degli appaltatori e di fornire loro le informazioni sui rischi per la salute e l’incolumità
dei loro dipendenti. Il committente è onerato di elaborare un unico documento di valutazione dei
rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Si prevede inoltre che nei contratti
di somministrazione, appalto e sub-appalto debbano essere esplicitati anche i costi relativi alla
sicurezza del lavoro. C’è inoltre l’obbligo di munire il personale occupato in appalto o subappalto di
una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, che i lavoratori sono tenuti a esporre. Il testo
unico del 2008 ha allargato l’ambito di applicazione degli obblighi agli appalti, sub-appalti o
contratti d’opera riguardanti l’intero ciclo produttivo dell’azienda. L’art. 26 comma 4 del testo unico
ha reso più gravosa la posizione del committente fino a ricomprendere un’obbligazione solidale,
con l’appaltatore e con gli eventuali sub-appaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore,
dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL. È
difficile fugare l’impressione che si tratti, per il committente, di una sorta di responsabilità
oggettiva. Il committente resta esposto alla responsabilità risarcitoria, a prescindere dalla
correttezza del suo agire. La disciplina è completata da un severo apparato sanzionatorio.
98
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
Particolare attenzione è posta nei confronti del lavoro sommerso, in relazione al quale si segnala il
potere conferito agli ispettori del lavoro di adottare provvedimenti di sospensione dell’attività
dell’impresa, nel caso in cui sia riscontrato l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da
altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori
regolarmente occupati. In ambito sanzionatorio rilevante è la previsione dei modelli di
organizzazione e di gestione. Sono tecniche procedurali attraverso cui i datori possono essere
esentati dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al d.lgs. n. 231/2001.
28. Veniamo ora alla descrizione degli strumenti predisposti dall’ordinamento sul piano della
riparazione delle conseguenze dannose subite dal lavoratore in ragione della violazione delle regole
sulla sicurezza del lavoro. Vige il principio dell’esonero da responsabilità civile del datore, in
ragione dell’esistenza dell’obbligo di assicurare i lavoratori presso una pubblica istituzione. In caso
di infortunio l’ente pubblico eroga sia previdenze di carattere sanitario che di carattere economico.
La responsabilità civile del datore risorge nel caso in cui vi sia stata responsabilità per fatto
costituente reato perseguibile d’ufficio, commesso dal datore o da un suo dipendente. In tali
situazioni il datore deve rispondere del risarcimento dei danni ed è altresì esposto all’azione di
regresso da parte dell’istituto assicuratore. Il primo ha diritto al danno differenziale, per la parte
eventualmente eccedente la rendita INAIL. Siffatto risarcimento doveva comprendere solo il danno
patrimoniale, legato alla perdita della capacità lavorativa oltre al danno morale da reato. Sennonché
la Corte costituzionale ha ritenuto che il datore è obbligato al risarcimento altresì del danno
biologico. Questo viene definito come menomazione dell’integrità psico-fisica della persona. La
liquidazione di tale danno va effettuata sulla base di criteri equitativi. Sul tema è intervenuto il
legislatore che ha esteso la tutela assicurativa anche al danno biologico, definito come la lesione
all’integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona. Ne deve
conseguire che riespande l’esonero da responsabilità per il datore. Negli anni più recenti l’art. 2087
c.c. ha costituito l’epicentro di un sistema espansivo degli obblighi datoriali. Si fanno così rientrare
entro la previsione dell’art. 2087 c.c. anche i danni alla professionalità. Va ricordata inoltre
l’emersione del danno esistenziale, che viene fatto consistere nella lesione ai diritti della personalità
costituzionalmente garantiti. La tendenza è diretta ad identificare il danno nella mera lesione
dell’interesse protetto. È la categoria del danno esistenziale a far spostare il baricentro della tutela
dal piano riparatorio a quello sanzionatorio. La giurisprudenza di legittimità sembra aver escluso
l’autonoma rilevanza di un danno esistenziale, optando per la risarcibilità del danno non
patrimoniale ove siano enucleabili lesioni di diritti o interessi inviolabili di natura non patrimoniale
riconoscibili dalla Costituzione.
GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO. B) LA RETRIBUZIONE
29. La retribuzione è un elemento fondamentale del contratto di lavoro che allinea fra i suoi tratti il
dato dell’onerosità. La garanzia retributiva è di tale rilievo da attingere al piano dei diritti di
maggiore rilevanza sociale, tanto da ricevere una regolamentazione già a livello di normazione
costituzionale. L’art. 36 Cost. prevede che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla qualità e quantità del lavoro e sufficiente ad assicurare al medesimo e alla sua famiglia
un’esistenza libera e dignitosa. All’interno della definizione sono perciò enucleabili due profili della
retribuzione: quello che allude ad essa come corrispettivo dell’attività prestata (proporzionalità) e
quello che si riferisce alla soddisfazione di bisogni personali e familiari (sufficienza). La
proporzionalità è definita rispetto alla qualità e alla quantità della prestazione. Il parametro della
sufficienza invece attinge alla categoria del “bisogno”. All’interno dell’art. 36 convivono dunque
un’obbligazione corrispettiva ed un’obbligazione sociale. Il problema è quello di chiedersi quale sia
99
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
la concreta latitudine dei due principi e la loro reciproca interferenza. Una prima questione riguarda
la determinazione della giusta retribuzione. Nel contratto di lavoro, allo scopo di definire il salario,
si dovrebbe lasciare libero campo alla determinazione delle parti individuali. È evidente che la forza
contrattuale del datore di lavoro prevarrebbe su quella del lavoratore. È questa una delle ragioni
fondamentali della nascita delle organizzazioni sindacali. Si pone quindi un legame fra
determinazione della retribuzione ed azione collettiva dei lavoratori. Questo legame è confermato
anche dal diritto positivo. Il ruolo dell’autonomia collettiva in materia retributiva è espresso per
tabulas: l’art. 325 del codice della navigazione delega alla contrattazione collettiva la
determinazione e la regolamentazione della misura e delle componenti della retribuzione. Più in
generale, secondo l’art. 2099 c.c., la misura della retribuzione deve essere determinata dalle norme
corporative, attribuendosi all’autonomia privata un ruolo solo in mancanza di queste ultime. Infine
fonte residuale di determinazione è quella giudiziale. Se si fornisce una lettura aggiornata dell’art.
2099, sostituendo alle norme corporative gli attuali contratti collettivi, si rileva che alla libera
contrattazione delle parti è assegnata la funzione preminente di individuazione della giusta
retribuzione. Sennonché la gerarchia delle fonti non può ritenersi appagante, dal momento che va
rivisitata alla luce del principio costituzionale di cui all’art. 36, avendo specifico riguardo al ruolo
del giudice. Ne viene che la questione della giusta retribuzione tende a collocarsi alla confluenza
della norma civilistica con quella di derivazione costituzionale. È infatti accaduto che i nostri
giudici hanno ritenuto di poter dare attuazione diretta all’art. 36 Cost. Hanno cioè ritenuto tale
norma di carattere immediatamente precettivo. Significa che un lavoratore che lamenti
l’inadeguatezza del salario può invocare direttamente l’art. 36 Cost., chiedendone al giudice la
rideterminazione. La giurisprudenza ha individuato, nelle tariffe salariali contenute nei contratti
collettivi di diritto comune, il parametro di riferimento per la determinazione del giusto salario.
Questo modo di operare costituisce l’estensione al rapporto di lavoro di un principio, codificato
dall’art. 1474 c.c., secondo cui, ove il prezzo non sia fissato dai contraenti, può essere determinato
dal giudice avendo riguardo al suo valore di mercato. Quest’ultimo è rinvenibile nel contratto
collettivo del settore ne cui ambito opera il datore. L’atteggiamento della giurisprudenza valorizza il
legame fra l’art. 36 e l’art. 39, cioè fra l’individuazione di un diritto soggettivo del lavoratore al
giusto salario e la determinazione di quest’ultimo attraverso l’autonomia collettiva. Quella descritta
rappresenta la “via italiana” alla retribuzione sufficiente, che però non è certamente l’unica via
logicamente prospettabile né quella storicamente prevalente.
30. La natura precettiva dell’art. 36 Cost. non implica che debba essere estesa anche a quella
porzione di norma che allude al “salario familiare”. Per questa parte può parlarsi di un programma
diretto al legislatore, allo scopo di assicurarne l’attuazione. In questa luce si è ritenuto che la
funzionalizzazione del salario ai bisogni della famiglia non giustifica l’esistenza di retribuzioni di
diverso valore. Alla stregua la natura costituzionale del diritto alla giusta retribuzione non implica
che tale diritto trasmodi sul piano dei diritti assoluti della personalità. Sembra anzi acquisito che la
retribuzione costituisce un diritto di credito. È presumibile che il legislatore costituente intendesse
assumere la sufficienza come parametro minimo ed invalicabile della controprestazione retributiva.
La nozione di retribuzione sufficiente corrisponderebbe a quella di retribuzione minima elaborata
dalla giurisprudenza con il rinvio alle tariffe salariali contenute nei contratti collettivi. Viceversa la
categoria della proporzionalità sembra alludere ad un nesso di corrispondenza oggettiva fra le due
prestazioni. Una questione di rilevanza è quella della compatibilità con i principi di cui all’art. 36
Cost. di politiche salariali differenti per aree geografiche (gabbie salariali). Ci si chiede se la
contrattazione collettiva possa stabilire tabelle salariali più basse in talune zone, allo scopo di
favorire l’occupazione. La risposta non può che essere negativa. L’art. 36 Cost. contiene un nucleo
protettivo che ha carattere di universalità e il luogo in cui si svolge il rapporto è indifferente ai fini
100
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
della determinazione della garanzia dello standard retributivo minimo. Suscita non poche
perplessità lo spostamento del perno della contrattazione collettiva dal livello nazionale a quello
aziendale, prefigurato dall’accordo interconfederale 28/06/2011 e più di recente dall’art. 8 della l. n.
148/2011, che amplia lo spettro di interventi dei patti aziendali. Queste tecniche normative possono
essere giustificate solo come politiche di intervento eccezionali, dirette a rimediare situazioni di
emergenza.
31. Il procedimento utilizzato dai giudici è stato criticato perché avrebbe comportato
un’interpretazione correttiva dell’art. 2099 c.c., il quale presuppone una lacuna negoziale, dando
luogo alla nullità dell’intero contratto. In realtà la correttezza dell’iter valutativo è recuperabile
avendo riguardo al meccanismo della sostituzione delle clausole nulle ad opera di disposizioni
imperative (integrazione del contratto), che consente l’inserimento del principio prefigurato dall’art.
36 Cost. È abbastanza ricorrente l’affermazione secondo cui va preso in considerazione il salario
nella sua interezza, con esclusione solo delle attribuzioni saltuarie o dei rimborsi-spese. Quanto
all’individuazione della giusta retribuzione è assodato che si debba aver riguardo alle tariffe salariali
relative alla sola retribuzione-base e non agli ulteriori istituti contrattuali., salvo che tale estensione
non si presenti come essenziale. Ambigua è la posizione con riferimento all’indennità di
contingenza che viene ritenuta, in alcuni casi, come un elemento accessorio, mentre in altri diviene
l’elemento essenziale di riscontro dell’adeguatezza della retribuzione. La massima latitudine del
ruolo di fonte atipica è rinvenibile in quell’orientamento che ritiene che il ricorso all’applicazione
delle tariffe dei contratti collettivi costituisca una facoltà e non un obbligo per il giudice. Nella
medesima logica il giudice può disapplicare anche il contratto collettivo che regola il rapporto di
lavoro, ove le relative tariffe salariali siano ritenute inadeguate.
32. Il richiamo dei principi costituzionali evoca la problematica della parità di trattamento. Per
semplificare al massimo il problema ci si chiede se il datore si obbligato ad applicare nei confronti
di tutti i lavoratori dell’impresa il medesimo trattamento economico, favorendo alcuni lavoratori
con speciali gratificazioni ulteriori. Il dibattito dottrinario non ha avuto fortuna in giurisprudenza.
Quest’ultima si è mantenuta fedele all’idea secondo cui il datore è del tutto libero di attribuire
discrezionalmente trattamenti di favore. La discussione è tornata di attualità per effetto di una
pronuncia della Corte costituzionale del 1989. In tale pronuncia si affermava che i poteri
discrezionali del datore non possono esprimersi in termini di discrezionalità ma devono essere
sorretti da una causa coerente con i principi fondamentali dell’ordinamento, senza svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità
umana. La sentenza è stata intesa nel senso che l’ordinamento avrebbe imposto una sorta di
controllo causale sugli atti privati, allo scopo di garantire la tutela della dignità del lavoratore. Parte
della giurisprudenza ha inaugurato un nuovo filone, nel quale viene valorizzato il principio di parità
di trattamento, auspicandosi un controllo di ragionevolezza anche delle disparità indotte dalla
contrattazione collettiva. La questione è stata però ricondotta all’alveo tradizionale, con la conferma
dell’ampia elaborazione giurisprudenziale compiuta prima della sentenza n. 103/89 della Corte
costituzionale, dalle Sezioni Unite della Cassazione. La Cassazione privilegia il carattere
confermativo di giudizi di valore già interni all’ordinamento. Si sarebbe intesa evocare una linea di
tendenza di tutela della parità, desunta da norme quali gli artt. 3 e 37 Cost., ma non affermare
l’esistenza di un diritto generale ed inderogabile di parità di trattamento. È pacifico che non esiste
un potere giudiziale di controllo degli atti privati o di vaglio della correttezza e buona fede. La
valorizzazione dell’impiego delle clausole della buona fede e correttezza avviene nel contesto di
una disciplina negoziale con cui il datore ha avuto lo specifico impegno di selezionare i più
meritevoli. Si tratta di un obbligo assunto dal datore nei confronti di una collettività di soggetti. Nel
101
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
contesto del singolo rapporto di lavoro, l’adempimento del datore va valutato al di fuori da ogni
possibile interrelazione con gli altri rapporti. Quindi il richiamo delle clausole della buona fede e
correttezza non è in grado di autorizzare confronti con l’adempimento da parte del datore
dell’obbligazione assunta nei confronti degli altri lavoratori dell’impresa. Il rifiuto di una
prospettiva paritaria non significa ammettere che il datore non incontri limiti nell’esercizio dei
poteri unilaterali. Tali limiti sono espressi dal principio di non discriminazione, in attuazione
dell’art. 3 Cost. La tutela antidiscriminatoria è stata ampliata per effetto dei d.lgs. nn. 215 e 216 del
2003. Ulteriori misure di diritto diseguale sono preannunciate nei confronti dei lavoratori
svantaggiati. Il che conferma che è la norma giuridica che individua i necessari correttivi delle
disparità, bilanciando libertà ed eguaglianza.
33. L’art. 2099 c.c. enumera le forme di retribuzione distinguendo: a) la retribuzione a tempo, b)
quella a cottimo, c) la partecipazione agli utili o ai prodotti e d) le prestazioni in natura. La forma
più diffusa è la retribuzione a tempo, in cui l’unità di misura è quella della dimensione temporale.
La retribuzione a tempo corrisponde all’interesse del lavoratore di ottenere una garanzia economica.
Storicamente si poneva una distinzione fra la retribuzione dell’operaio, giornaliera (salario), e
quella dell’impiegato, ogni quindici giorni (stipendio). Questa differenziazione peraltro è stata
superata da quando è in atto il regime della mensilizzazione. Uno dei più rilevanti problemi riguarda
la determinazione del divisore, cioè del numero per il quale deve essere divisa la retribuzione
mensile per ottenere la retribuzione giornaliera. La giurisprudenza a lungo è stata orientata nel
ritenere legittime le clausole che dividono per ventisei la retribuzione mensile. Più di recente
prevale invece l’orientamento che legittima il divisore trenta. La contrattazione collettiva si è
incaricata di rendere più complessa la nozione di retribuzione articolandola in una serie di voci che
soddisfano le più disparate funzioni. Per rendersene conto basta esaminare una busta-paga. Al suo
interno, accanto alla retribuzione-base, ossia la controprestazione dovuta in ragione
dell’appartenenza ad una determinata categoria e qualifica, troveremo anche altre voci. Il diritto alla
corresponsione delle varie voci retributive ed i rapporti reciproci fra le medesime è regolato dalla
contrattazione collettiva.
33.1. Il superminimo è un elemento accessorio che si pone al di sopra del minimo tabellare, la cui
fonte istitutiva si trova nella contrattazione collettiva o nel contratto individuale. Rispetto ai
superminimi individuali si pone il problema della sorte in caso di stipulazione di un nuovo contratto
collettivo che stabilisca un trattamento retributivo più favorevole; ci si chiede se il superminimo
debba rimanere intatto nel suo ammontare o si possa riassorbirlo negli aumenti contrattuali. La
soluzione postula che si indaghi sull’effettiva volontà dei contraenti, al fine di verificare la natura
del superminimo, in relazione alla quale negarne o ammetterne la riassorbibilità. In giurisprudenza
prevale l’opinione che assume l’esistenza di una sorta di presunzione di riassorbibilità dei
superminimi individuali, salvo che i contraenti non dispongano diversamente.
33.2. Ulteriori elementi aggiuntivi sono le gratifiche. Originariamente avevano carattere di liberalità
o funzione incentivante, per poi divenire elementi obbligatori a carattere periodico. Il più rilevante
esempio di gratifica è la gratifica natalizia o tredicesima mensilità, trasformata da mera liberalità a
corresponsione stabile. La diffusione dell’istituto ha reso superate le discussioni in ordine
all’obbligatorietà della sua corresponsione. Nel tempo la contrattazione collettiva ha poi introdotto
ulteriori mensilità aggiuntive, come la quattordicesima o la quindicesima. Altro esempio di gratifica
è la gratifica di bilancio, che è un emolumento corrisposto annualmente in occasione
dell’approvazione del bilancio e che è di ammontare variabile. Affini alle gratifiche sono le mance,
da cui differiscono per la circostanza che vengono erogate da terzi. La giurisprudenza ha avuto
102
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
modo di interessarsi delle mance dovute ai croupiers delle case da gioco, nella prospettiva della loro
imponibilità previdenziale e/o fiscale e del loro computo nel TFR.
33.3. Fra gli elementi variabili vi sono altresì i premi, che hanno funzione di incentivo e sono
tipicamente aleatori. Possono essere diretti all’intera collettività dei dipendenti, a gruppi di essi o a
singoli lavoratori. Dal punto di vista oggettivo si possono distinguere in ragione del parametro
adottato per la loro determinazione che può essere correlato a profili tecnico-produttivi o di tipo
economico. Fra di essi è da ricordare il premio di produzione, la cui funzione di incentivo si è
progressivamente affievolita fino a renderlo una sorta di compenso fisso annuale. La contrattazione
collettiva è sovrana nel regolarne le modalità di erogazione e l’obbligatorietà.
33.4. Diffuse sono anche le indennità. Volendo provare una classificazione si può distinguere fra
indennità che remunerano particolari modalità estrinseche e che risarciscono in ragione di disagi o
rischi e indennità che premiano il possesso o l’acquisizione di una specifica qualità della
prestazione. La distinzione ha la sua importanza in relazione alla determinazione del quantum
retributivo che il lavoratore ha diritto di conservare in caso di passaggio a mansioni equivalenti. Fra
le tante indennità ricordiamo quelle legate al luogo di svolgimento della prestazione di lavoro, fra le
quali l’indennità di trasferta. In relazione alla quantificazione di tale indennità, si è aperto, negli
anni ottanta, un dibattito, poi risolto con una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, che ha
distinto la posizione di chi sia obbligato contrattualmente ad operare prevalentemente lontano dalla
sede di lavoro, da quella di chi si sia obbligato solo a recarsi in luoghi diversi, mantenendo la
propria sede di lavoro. Al genus dell’indennità di trasferta appartiene l’indennità estero, la quale è
un emolumento che può avere sia natura risarcitoria sia retributiva. Natura diversa ha l’indennità di
trasferimento, spesso prevista per risarcire il lavoratore in relazione al mutamento della sede di
lavoro.
33.5. Collocazione e trattazione a parte meritano gli automatismi retributivi, cioè quelle componenti
della retribuzione che maturano per il decorso del tempo, senza che sia necessario un impulso legale
o contrattuale, ulteriore rispetto a quello che ne ha costituito la fonte. Fra gli esempi ricordiamo: gli
aumenti periodici, o scatti, di anzianità, l’indennità di contingenza e i trattamenti di fine rapporto.
Gli scatti di anzianità sono degli aumenti della retribuzione che maturano periodicamente in
relazione all’anzianità di servizio del lavoratore nella medesima impresa e nel medesimo livello di
inquadramento. Oggetto di dibattito costituisce il problema dell’individuazione dell’anzianità utile
al fine del calcolo degli aumenti periodici. Pure discussa è la questione della riassorbibilità degli
scatti in caso di promozione del lavoratore a qualifica o categoria superiore. La giurisprudenza
tende ad affermare la regola dell’assorbibilità nell’aumento dovuto per il passaggio di qualifica.
33.6. L’indennità di contingenza ha costituito un elemento di notevole consistenza quantitativa
nell’“accumulo” della retribuzione. È stata introdotta nel dopoguerra allo scopo di predisporre un
meccanismo che tenesse i salari al riparo dalla perdita di potere d’acquisto del denaro per effetto
della svalutazione monetaria. La tecnica di adeguamento consisteva nel riferimento ad un paniere di
beni di consumo, la cui variazione di prezzi forniva l’indicazione dell’aumento del costo della vita.
Dopodiché questo aumento veniva ritradotto o in una “scala mobile” a punti o in una misura
percentuale. La più importante differenza fra i due sistemi stava nel fatto che il primo metodo
comportava un aumento uguale per tutti i lavoratori, mentre il secondo sistema comportava aumenti
di misura diversa a seconda del diverso livello degli stipendi cui si applicava. L’indennità di
contingenza è stata oggetto di pesanti interventi limitativi. Con il Protocollo fra Governo e parti
sociali del 31/07/1992 viene formalizzata la sostanziale abolizione del meccanismo della scala
mobile e con il Protocollo del luglio 1993 si inaugurava un nuovo sistema di regolazione delle
103
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
relazioni industriali e dei rapporti fra livelli di contrattazione, allo scopo di assicurare meccanismi
negoziali che consentano ai lavoratori di essere al riparo dai rischi di inflazione. La strategia si
affida alla ristrutturazione del sistema contrattuale affidata a due livelli negoziali: uno nazionale di
categoria, l’altro aziendale, cui è affidato il compito di definire la porzione di salario legata alla
produttività dell’impresa. Allo scopo di tenere i lavoratori indenni da possibili effetti economici
negativi si prefigurò un’indennità di vacanza contrattuale. È un elemento della retribuzione a
carattere provvisorio, la cui entità è rapportata al 30% del tasso di inflazione programmato. Spetta ai
lavoratori a decorrere dal terzo mese dalla scadenza del contratto collettivo nazionale di categoria.
34. Il codice civile annovera anche la retribuzione a cottimo. È una tecnica di commisurazione della
retribuzione alla quantità di lavoro prestato in una data unità di tempo; l’unità di misura è definita
“unità di cottimo”. Nel sistema del cottimo pieno è corrisposta una quantità di retribuzione per ogni
pezzo prodotto. Il cottimo è stato inquadrato come una forma di lavoro autonomo o come un tipo
contrattuale a sé stante (cottimo-contratto), con cui il lavoratore si impegnava a garantire un
determinato risultato produttivo. Una riflessione sulla struttura del contratto di lavoro e la
scomparsa del cottimo-contratto dall’impiego produttivo lo hanno ricondotto alla dimensione del
lavoro subordinato come forma di retribuzione. Nel cottimo si pone l’accento sul rendimento del
lavoratore. Da tempo non ha più corso il cottimo pieno, lasciando invece corso al cottimo misto, in
cui si ha una combinazione fra la paga-base a tempo ed un’integrazione ulteriore detta
maggiorazione o utile di cottimo. È pacifico che la posizione del lavoratore deve essere tale da
garantire uno standard retributivo minimo conforme ai canoni di cui all’art. 36 Cost. Si ritiene che il
diritto al minimo di cottimo sorge solo in conseguenza dell’effettiva realizzazione del rendimento
minimo. La diminuzione del rendimento quindi, al di sotto del minimo, costituisce inadempimento
contrattuale. Il codice civile stabilisce, all’art. 2100, che la retribuzione a cottimo è obbligatoria: a)
nel caso in cui il lavoratore è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo o b)
quando la valutazione della sua prestazione è operata in base al risultato delle misurazioni dei tempi
di lavorazione. La prima situazione si ha nell’ipotesi in cui l’intensità del lavoro è in buona parte
svincolata dalla partecipazione del singolo lavoratore. La seconda allude alla tecnica produttiva con
cui il datore procede alla misurazione dei tempi di lavoro, fissando il tempo massimo per una
determinata operazione e retribuendo il lavoratore in funzione delle effettive operazioni eseguite.
L’art. 2100 c.c. comma 2 conferma il ruolo primario della contrattazione collettiva nella
regolamentazione della materia della retribuzione a cottimo. L’art. 2101 c.c. detta invece
disposizioni più specifiche. Si prevede che la fonte collettiva può stabilire che le tariffe divengano
definite dopo un periodo di esperimento. Inoltre possono essere sostituite o modificate soltanto se
intervengano mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro. Sono disposizioni poste a tutela
del cottimista e nei confronti di una tecnica produttiva nota come “taglio dei tempi”, che si ha
quando il datore riduce i tempi previsti, avvalendosi del maggior rendimento del cottimista. La
norma presuppone che rientri fra le prerogative unilaterali del datore quella di calcolare la tariffa da
applicare ad ogni lavoratore. Secondo il comma 3 dell’art. 2101 c.c. il datore è onerato di fornire ai
lavoratori una serie di informazioni relative alla retribuzione a cottimo. Anzitutto deve comunicare
dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il
relativo compenso unitario. Inoltre deve comunicare i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e
al tempo impiegato. Il sistema del cottimo è stato gradatamente superato. È per questa ragione che
nella più recente contrattazione collettiva vanno emergendo forme di retribuzione incentivanti,
legate ad ulteriori e diversi parametri.
35. Secondo l’art. 2099 c.c. il lavoratore può anche essere remunerato attraverso la provvigione o la
partecipazione agli utili o ai prodotti. La provvigione è una forma retributiva caratteristica del
104
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
lavoro autonomo e consiste nel corrispondere al lavoratore una percentuale sul ricavato degli affari
conclusi dal lavoratore. Nel lavoro subordinato è una tecnica retributiva applicata ai lavoratori che
trattano affari nell’interesse del datore, come i piazzisti. Inoltre costituisce solo una parte integrativa
del complessivo salario, che comprende in genere una retribuzione minima fissa, garantita a
prescindere. Tra le forme retributive di tipo incentivante e partecipativo distinguiamo la
partecipazione agli utili dalla partecipazione ai prodotti. Anche per tali tecniche vale la l’obbligo del
rispetto della garanzia retributiva minima. La partecipazione agli utili non configura una forma di
compartecipazione del lavoratore all’attività economica né modifica la causa del contratto di lavoro.
Secondo l’art. 2102 c.c. gli utili da prendere a base sono gli utili netti dell’impresa e quelli risultanti
dal bilancio approvato e pubblicato, per le imprese soggette a pubblicazione del bilancio. I
lavoratori non acquistano un controllo sulla gestione dell’impresa, ma solo la possibilità di
controllare la correttezza dei documenti contabili. Di una partecipazione più marcata all’andamento
economico dell’impresa può parlarsi avendo riguardo all’azionariato operaio, che consiste nella
distribuzione di azioni ai dipendenti. La partecipazione ai prodotti è una tecnica diffusa solo in
specifici settori produttivi, perché oscillante tra l’affinità alla retribuzione in natura e al cottimo o
alla provvigione, che consiste nella distribuzione di beni che costituiscono l’oggetto dell’attività
dell’impresa. Le imprese hanno promosso forme di retribuzione incentivante, che garantissero
anche maggiore flessibilità gestionale, consentendo di graduare la variabile retributiva in relazione
all’andamento aziendale.
36. È indiscutibile che la retribuzione in natura può costituire un elemento integrativo del
trattamento economico assicurato al lavoratore. È rilevante anche il marcato sfavore con cui altri
ordinamenti vietano il truck system, cioè la tecnica consistente nel retribuire il lavoratore con la
somministrazione di generi di prima necessità erogati negli spacci aziendali o mediante buoni
spendibili solo nelle catene commerciali dell’impresa datrice. L’importanza della retribuzione in
natura è legata alla concessione dei fringe benefits, che rappresentano dei servizi assicurati al
lavoratore per le ragioni più diverse. Al di là di occasionali concessioni del datore, a livello
individuale, è comunque quasi sempre la contrattazione collettiva a regolarne le condizioni di
accesso e fruizione. Rientrano in questo ambito le forme più varie di retribuzione indiretta. La
questione giuridica più dibattuta in materia è quella della qualificazione in termini retributivi dei
benefici, tanto agli effetti contrattuali, quanto agli effetti previdenziali. Ricordiamo la discussione
che si è sviluppata nell’ultimo quindicennio sull’indennità di mensa, di cui la giurisprudenza aveva
affermato la natura retributiva, agli effetti del computo negli istituti indiretti e l’imponibilità
previdenziale. È poi successivamente intervenuto il legislatore con l’art. 6 del d.l. n. 333/1992, con
cui ha escluso, con effetti retroattivi, la natura retributiva dell’indennità di mensa agli effetti
contrattuali.
37. Quella di retribuzione è una nozione complessa. La complessità si esprime nella molteplicità
delle definizioni di retribuzione. Nel corso dell’evoluzione del diritto del lavoro si è cercato di
delineare una nozione unitaria di retribuzione. L’orientamento giurisprudenziale rinveniva quali
tratti fondamentali, a parte l’obbligatorietà, anche la corrispettività, la determinatezza e la
continuità. Il risultato complessivo è stato la creazione di una nozione onnicomprensiva di
retribuzione, idonea a risolvere ogni problema interpretativo. Ci si è resi conto che nessuno dei
caratteri indicati può considerarsi assoluto e tassativo. La corrispettività presenta un significato
particolare in relazione a quegli emolumenti assicurati dalla legge al lavoratore anche in caso di
assenza della prestazione. Il carattere della determinatezza è da riconoscersi anche a prestazioni che
non necessariamente hanno carattere retributivo. Il carattere occasionale di una prestazione
patrimoniale non è idoneo ad escluderne la natura retributiva. Nonostante le critiche la
105
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
giurisprudenza ha a lungo utilizzato la concezione unitaria della retribuzione, con ricadute
interpretative assai discutibili. Esse hanno avuto riguardo all’individuazione di una nozione
onnicomprensiva di retribuzione (retribuzione-parametro) da utilizzare come base di computo e
determinazione dei vari istituti contrattuali a carattere variabile. È solo negli anni ottanta che la
giurisprudenza accede ad un’idea più articolata e differenziata del concetto di retribuzione, in
particolare di quella utile a discernere le varie ricadute sui trattamenti di origine contrattuale. Si
afferma il primato della contrattazione collettiva nell’individuazione della nozione di retribuzione.
Il principio di onnicomprensività viene cancellato dall’orizzonte ricostruttivo, attribuendosi allo
stesso una funzione del tutto eccezionale. Le conseguenze applicative si sono svolte in varie
direzioni. Si è ritenuto che la retribuzione per il periodo feriale va determinata secondo i parametri
previsti dalla contrattazione collettiva. In relazione alla base della determinazione delle mensilità
aggiuntive, si tende a distinguere tra la tredicesima, per la quale opererebbe la regola
dell’onnicomprensività e le mensilità ulteriori sottratte invece all’operatività del principio e rimesse
alle scelte delle parti collettive. La giurisprudenza si mostra poi sensibile alla regola di
onnicomprensività, tutte le volte in cui è in gioco una definizione di retribuzione di origine legale. È
il caso delle festività infrasettimanali, rispetti alle quali l’onnicomprensività è dedotta dalla nozione
di normale retribuzione globale di fatto giornaliera. È il caso altresì della maggiorazione per il
lavoro straordinario o notturno, rispetto ai quali la giurisprudenza richiama il concetto di
retribuzione dovuta per il lavoro ordinario, anche se si assume il carattere derogabile della
previsione ad opera della contrattazione collettiva. La complessità del concetto è espressa anche
dalla pluralità delle sue definizioni. A parte la nozione contrattuale, circolano anche altre varie
nozioni legali. C’è anzitutto la retribuzione da porre a base delle competenze di fine rapporto del
lavoratore, che fa perno sulla nozione di continuità delle attribuzioni patrimoniali. Ci sono poi
nozioni di retribuzione da valere agli effetti contributivi e fiscali. Queste ultime hanno subito di
recente un processo di avvicinamento. Il concetto di retribuzione a fini contributivi era ancorato alla
nozione di corrispettività, prevedendosi l’assoggettabilità a contribuzione di tutto ciò che il
lavoratore riceveva in denaro o in natura per compenso del suo lavoro. Con una prima riforma della
fine degli anni sessanta il legislatore introdusse una concezione causale dell’imponibile
contributivo. La giurisprudenza ha interpretato in maniera ampia la disposizione. Una complessiva
revisione si è avuta con il d.lgs. 02/09/1997 n. 314. L’imponibile fiscale è definito dal nuovo testo
dell’art. 48 del t.u. delle imposte dirette e allude a tutte le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. L’imponibile previdenziale è definito dal nuovo testo dell’art. 12 della l. n.
153/1969, mediante rinvio alla previsione del comma 1 dell’art. 48 del t.u. delle imposte dirette,
fatte salve ulteriori eccezioni tassative.
38. Posto che la retribuzione costituisce un’obbligazione di dare, il relativo adempimento è regolato
dalle norme civilistiche generali e da quelle specifiche relative alle obbligazioni pecuniarie. L’art.
2099 c.c. comma 2 c.c. dispone che la retribuzione deve essere corrisposta con le modalità e nei
termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. Il luogo di adempimento coincide con quello
di esecuzione della prestazione di lavoro. In mancanza di regolamentazione pattizia o di usi
specifici troveranno applicazione le regole codificate dall’art. 1182 c.c. che richiama il domicilio
del creditore. Il termine di pagamento rinviene nel contratto o negli usi la propria fonte di
determinazione, soggiacendo alla regola della post-numerazione, alla cui stregua il pagamento
avviene dopo che è stato prestato il lavoro. Si tratta di una regola legata alla necessità della
commisurazione dell’entità della retribuzione soprattutto alla quantità di lavoro espletato. Il
pagamento deve avvenire in contanti. La giurisprudenza ammette il ricorso a forme analoghe,
purché non rendano difficoltosa la conversione in denaro. L’art. 1 della l. n. 4/1953 fa obbligo al
106
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
datore di consegnare un prospetto-paga, in cui devono essere indicati la qualifica professionale, il
periodo la cui retribuzione si riferisce, tutti gli elementi della retribuzione e le singole trattenute.
L’omessa o ritardata consegna del prospetto-paga comporta una sanzione, attualmente
depenalizzata.
39. La materia retributiva, nel pubblico impiego, è rimessa alla contrattazione collettiva. Secondo
l’art. 2 comma 3 del d.lgs. n. 165/2001, l’attribuzione di trattamenti economici ai dipendenti di
amministrazioni pubbliche può avvenire solo mediante contratti collettivi. l’autonomia collettiva
non è delegata a definire soltanto la retribuzione tabellare, ma anche i trattamenti economici
accessori collegati: a) alla produttività individuale; b) alla produttività collettiva; c) all’effettivo
svolgimento di attività disagiate o pericolose o dannose per la salute. L’apporto partecipativo di
ciascun lavoratore spetta al dirigente. Si nota l’intenzione del legislatore di utilizzare i trattamenti
economici incentivanti, in funzione di un recupero dell’efficienza della pubblica amministrazione.
Nel pubblico impiego si nota un’attenzione verso la parità di trattamento, che è corollario del
principio di imparzialità della pubblica amministrazione e di uniformità dei trattamenti assicurati
tramite la contrattazione collettiva. Secondo l’art. 45 comma 2 del d.lgs. 165/2001, le p.a. devono
garantire ai dipendenti parità di trattamento contrattuale e trattamenti non inferiori a quelli previsti
dai contratti collettivi. Tale disposizione deve essere interpretata in una prospettiva di tutela dei
pubblici dipendenti contro tecniche di arbitraria discriminazione.
Sezione IV: LA SOSPENSIONE DEL RAPPORTO
1. Il diritto del lavoro ha dovuto confrontarsi con le ipotesi di interruzione della prestazione per
impossibilità sopravvenuta ed ha approntato una regolamentazione speciale di tali situazioni. In
questo ambito si colloca l’istituto della sospensione del rapporto, intendendosi alludere ai casi in
cui, pur non potendo aver corso la prestazione, il rapporto resta giuridicamente in vita. Tali ipotesi si
distinguono dall’interruzione della prestazione riconducibile ai riposi. I problemi giuridici che si
pongono fanno capo a due profili di trattamento: a) la verifica della tenuta del rapporto e quindi le
questioni della sua risolubilità e b) la permanenza delle rispettive obbligazioni delle parti. Quanto a
quest’ultimo profilo dobbiamo distinguere le sospensioni del rapporto che si verificano nella sfera
del lavoratore, nella sfera del datore e le sospensioni concordate. Queste ultime non pongono
particolari problemi: le parti infatti potranno liberamente stabilire se e quali obbligazioni dovranno
continuare ad essere attive durante la fase sospensiva. Il caso più rilevante è quello che riguarda le
sospensioni nella sfera del lavoratore. Entrano qui in gioco le fattispecie previste dalla legge
sull’impiego privato e poi generalizzate dal codice civile agli artt. 2110 e 2111, che regolano gli
effetti sul rapporto di lavoro di malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e servizio militare. Il
carattere sociale dello Stato ha fatto in modo che si allargassero gli spazi di libertà dal lavoro
considerati meritevoli di particolare protezione. Rientrano in questa categoria anche gli spazi
connessi all’esercizio di pubbliche funzioni. Va segnalata la legge 08/03/2000 n. 53 che si propone
di promuovere il riequilibrio dei tempi di lavoro e di quelli di cura, formazione e relazione. In quasi
tutte le situazioni descritte il legislatore ha previsto che il lavoratore mantiene il diritto alla
retribuzione, con una traslazione in capo al datore del rischio per l’impossibilità, più spesso a carico
delle assicurazioni sociali. Che le somme corrisposte al lavoratore abbiano carattere retributivo è
dimostrato dall’obbligazione retributiva, così come descritta dall’art. 36 Cost, che allude alla
soddisfazione di bisogni più ampi rispetto al mero valore della prestazione di lavoro sul mercato.
Tale acquisizione è definita come lo scarto fra sinallagma genetico e sinallagma funzionale, cioè fra
il vincolo che lega il lavoratore al rapporto nel suo insieme e quello che lega le due prestazioni
corrispettive. Occorre aggiungere che dall’esistenza della fattispecie in cui il lavoratore conserva il
107
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
diritto alla retribuzione, non può dedursi che sia venuto del tutto meno il vincolo di corrispettività
che lega reciprocamente le obbligazioni delle parti del rapporto di lavoro. Vero è che le specie
regolate costituiscono delle eccezioni rispetto alla vigenza del principio generale secondo cui, in
assenza di prestazione lavorativa, non è dovuta la retribuzione.
2. Secondo l’art. 2110 comma 1 c.c., in caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio
è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità. Il periodo di assenza per una di tali
cause deve essere computato nell’anzianità di servizio. Ai fini della sospensione del rapporto di
lavoro rileva la malattia o l’infortunio che siano impeditivi dell’adempimento della prestazione, che
rendano cioè inabile il lavoratore allo svolgimento delle specifiche mansioni. All’evento-malattia è
collegata una serie di adempimenti che attengono alla comunicazione, all’accertamento e al
controllo dell’assenza. Per quanto riguarda la comunicazione della malattia al datore è pacifico che
per il lavoratore non sarebbe sufficiente ad ottenere l’esonero da responsabilità contrattuale la mera
certificazione del proprio medico di fiducia. Il rigore di tale conclusione è mitigato nell’esperienza
dalle previsioni dei contratti collettivi che circoscrivono l’onere del lavoratore alla mera produzione
del certificato del medico curante. Talvolta la contrattazione collettiva sdoppia l’obbligo in
questione onerando il lavoratore di un obbligo di comunicazione dell’assenza e di un successivo
obbligo di certificazione. Con il “Collegato lavoro” si è esteso anche al settore privato l’obbligo, per
il medico, di inoltrare all’INPS per via telematica la certificazione dell’assenza. L’invio della
certificazione comporta il sorgere in capo al creditore di lavoro del diritto ad effettuare il controllo
sull’assenza. La materia è stata innovata dall’art. 5 dello statuto dei lavoratori. In passato i controlli
potevano aver corso attraverso medici di fiducia del datore, ma tale prassi si era prestata a notevoli
abusi. La norma dello statuto pone il divieto degli accertamenti sanitari effettuati da parte del
datore. I controlli sono invece affidati a soggetti pubblici che possono garantirne l’imparzialità. I
soggetti abilitati ai controlli erano i servizi ispettivi degli enti previdenziali, per i controlli sulle
infermità, ed enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico, per quanto riguardava le visite
di idoneità al lavoro. Tali competenze sono transitate alle Unità sanitarie locali (ora Asl). Si è
previsto che l’attuazione del servizio di controllo avrebbe dovuto aver corso attraverso la
stipulazione di convenzioni fra le USL e l’INPS. L’accertamento del medico pubblico non ha
carattere esaustivo né preclusivo di ulteriori accertamenti. L’accertamento del medico-pubblico
ufficiale fa piena prova dei soli fatti avvenuti in sua presenza. La qualificazione giuridica della
situazione soggettiva in cui si trova il lavoratore rispetto all’esercizio del diritto di controllo del
datore partecipa sia dei profili dell’obbligo contrattuale che di quello dell’onere. La Corte
costituzionale giudicò legittima la norma dello statuto in riferimento all’art. 13 Cost., assumendo
che essa non imponeva un trattamento obbligatorio, ma lasciava libero il lavoratore di sottoporsi o
no all’accertamento, fatta salva peraltro la sanzionabilità di tale comportamento inadempiente.
L’irrigidimento del sistema dei controlli fu ritenuto da parte degli imprenditori una concausa
dell’espansione dell’assenteismo di breve termine e fu richiesta una modifica della disciplina
legislativa. Fra gli abusi andavano collocati anche i comportamenti tenuti dal lavoratore in costanza
di malattia. Ne è scaturita la riforma del sistema dei controlli prevista dall’art. 5 della l. n. 638/1983.
Il lavoratore è obbligato ad essere presente nel proprio domicilio durante determinate fasce orarie di
reperibilità, nel corso delle quali possono aver corso i controlli. L’assenza ingiustificata dal
domicilio durante tali fasce è sanzionata con la perdita di ogni beneficio economico per i primi dieci
giorni di malattia e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, ove vi sia stata assenza
ingiustificata anche ad una seconda visita. Sul giustificato motivo di assenza alla visita si è formata
una casistica giurisprudenziale, nel cui ambito si sottolinea che ricade sul lavoratore l’obbligo di
cooperare affinché sia resa possibile l’effettuazione del controllo e si riconduce la giustificazione a
quelle ipotesi in cui sussista un motivo ragionevole a far prevalere le esigenze di libertà del
108
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
lavoratore su quelle del controllo. A seguito di una modifica introdotta nel comma 13 dell’art. 5
della l. n. 638/1983, si è rinviata ad un decreto ministeriale l’individuazione delle ipotesi di
esenzione dalla reperibilità per i lavoratori privati. Per quanto riguarda i controlli sull’idoneità
fisica, riguardo a cui l’art. 5 dello statuto l’affidava ad enti pubblici ed istituti specializzati di diritto
pubblico, si è discusso se il divieto dell’impiego di medici fiduciari del datore dovesse estendersi
anche alle visite preassuntive. La tesi che estende il divieto anche a tali ultime visite si basa su un
argomento letterale fragile. Essa è peraltro rifiutata dalla prevalente giurisprudenza. Il problema
delle visite di idoneità fisica va rivisitato alla luce del d.lgs. n. 81/2008. La disciplina vigente ha
introdotto la figura del medico competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, che ha la
funzione di effettuare anche gli accertamenti sia preventivi che periodici allo scopo di valutare
l’idoneità fisica del lavoratore alle mansioni. La più recente disciplina prevede che la visita
preassuntiva sia svolta o dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione dell’ASL.
Secondo le direttive dell’art. 2110 comma 1 c.c. i lavoratori mantengono il diritto al trattamento
economico. Su questo piano vi è una differenza di trattamento fra operai ed impiegati. Agli operai
spetta un’indennità, erogata dall’INPS, per la malattia, o dall’INAIL, per l’infortunio sul lavoro, che
viene anticipata dal datore. L’indennità è dovuta nella misura del 60% della normale retribuzione ed
ha decorrenza successiva al periodo di carenza assicurativa. Gli impiegati invece conservano il
diritto alla retribuzione a carico del datore, in misura integrale fino ad un determinato periodo e
parziale per il periodo successivo. Un cenno va fatto alle assenze allo scopo di consentire la
fruizione delle cure termali. L’originario diritto è stato oggetto nel corso degli anni ottanta di vari
interventi restrittivi. La più recente disciplina prevede che le prestazioni termali possano essere
concesse solo per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative. Nella giurisprudenza si è
consolidata l’opinione avvallata dalla Corte costituzionale, secondo cui la fruizione delle cure
termali è equiparabile alla malattia in presenza di una certificazione medica che attesti
l’impossibilità di un rinvio del loro godimento. Anche i lavoratori tossicodipendenti hanno diritto ad
assentarsi, per accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione, per un periodo non superiore a
tre anni, conservando il loro posto di lavoro. L’aspettativa non è retribuita e non consente il decorso
all’anzianità di servizio.
3. L’ordinamento estende anche alle assenze connesse con l’adempimento degli obblighi militari il
diritto alla conservazione del posto di lavoro, il mantenimento dell’anzianità di servizio e, in certe
situazioni, il diritto al trattamento economico. Sono previsioni in attuazione del principio
costituzionale secondo cui l’adempimento di tali obblighi non pregiudica la posizione di lavoro del
cittadino. Abolita l’obbligatorietà del servizio di leva è ora vigente l’ipotesi di richiamo alle armi,
secondo la l. n. 653/1940, in relazione alla quale spetta a tutti i lavoratori un’indennità mensile pari
alla retribuzione, per i primi due mesi, e, successivamente, un’indennità pari alla differenza tra il
trattamento economico militare e quello derivante dal rapporto di lavoro. Si prevede che alla fine
del periodo di richiamo il lavoratore deve porsi a disposizione del datore per riprendere la sua
occupazione entro il termine di dieci giorni, per richiamo inferiore al mese, di quindici giorni, per
richiami fino a sei mesi, di venti giorni, per richiami da sei mesi a un anno, o di trenta giorni per
richiami superi all’anno. In caso di mancata ripresa, entro tali termini il lavoratore è considerato
dimissionario.
4. La legislazione post-costituzionale ha amplificato gli spazi di libertà protetta dal lavoro. È stata
così data attuazione ai principi che valorizzano la partecipazione del cittadino-lavoratore
all’organizzazione politica e sociale del Paese, l’interesse all’elevazione culturale e professionale e
la tutela della famiglia. Quanto ai congedi familiari occorre ricordare il principio codificato fin dagli
anni trenta secondo cui i lavoratori pubblici e privati hanno diritto per contrarre matrimonio ad un
109
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
congedo straordinario non eccedente la durata di quindici giorni. La materia è stata rivisitata ed
ampliata con la l. n. 53/2000. Si prevede il diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi
in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo
grado o del convivente. I lavoratori possono richiedere, per gravi motivi familiari, un periodo non
retribuito non superiore a due anni. Un’analoga forma di congedo era prevista dalla l. n. 309/1990
da parte dei lavoratori, familiari di un tossicodipendente, ai quali è riconosciuto chiedere
un’aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del
familiare. La legge non indica la durata massima ma ne rinvia la determinazione al servizio
sanitario per le tossicodipendenze. Infine vanno ricordati i permessi per i lavoratori familiari di
soggetti portatori di handicap. A parte il diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di
astensione facoltativa per i genitori, anche i lavoratori che semplicemente assistono una persona con
handicap in situazione di gravità, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito. Tale
diritto non è riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza della stessa persona con
handicap, salvo che si tratti dello stesso figlio per il quale il diritto è riconosciuto ad entrambi i
genitori. Una tutela più ampia è prevista per i pubblici dipendenti, che siano genitori di figli fino a
tre anni di età, i quali possono essere assegnati, a richiesta, ad una sede di servizio posta nella
provincia o regione se l’altro genitore presta attività lavorativa. Con l’art. 24 del d.lgs. sulle
“semplificazioni” si è prevista la possibilità per i lavoratori di cedere a titolo gratuito i riposi e le
ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore, al fine di consentire a questi ultimi
di assistere i figli minori. La regolamentazione della misura, delle condizioni e delle modalità è
affidata ai contratti collettivi. La l. n. 53/2000 ha incrementato la sfera del diritto all’elevazione
culturale e professionale dei lavoratori. La materia del diritto allo studio era già regolata dall’art. 10
dello statuto dei lavoratori che dà diritto ai lavoratori studenti a turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. I medesimi possono rifiutare l’effettuazione di
prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti hanno diritto a
fruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere le prove d’esame. Con la legge del 2000 si è
previsto che i lavoratori, con un’anzianità di almeno cinque anni, possono richiedere una
sospensione del rapporto per congedi per la formazione per un periodo non superiore a undici mesi.
Tali congedi possono essere utilizzati per il completamento della scuola dell’obbligo, al
conseguimento di un titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o della laurea. Si
tratta di assenze non retribuite e non computabili nell’anzianità di servizio né cumulabili con le
ferie, le malattie e gli altri congedi. La regolamentazione dei congedi formativi è rimessa
all’autonomia collettiva. La legge del 2000 introduce poi l’istituto della formazione continua che dà
diritto a congedi formativi e che vede come destinatari sia i lavoratori occupati che quelli non
occupati e che ha la funzione di accrescere conoscenze e competenze professionali. La formazione
può corrispondere ad una scelta del personale del lavoratore o rientrare entro programmi formativi
aziendali concordati con le organizzazioni sindacali. Fra i permessi relativi all’adempimento di
doveri connessi alla solidarietà sociale va collocato il diritto all’astensione dal lavoro previsto a
favore dei donatori di sangue e di emocomponenti per l’intera giornata in cui effettuano la
donazione. Una nuova tipologia di congedo è introdotta dall’art. 24 del d.lgs. n. 80/2015: il congedo
per le donne vittime di violenza di genere. La lavoratrice, che sia inserita nei percorsi di protezione
relativi alla violenza di genere, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di
protezione per un periodo massimo di tre mesi. Per esercitare tale diritto deve dare un preavviso al
datore di almeno sette giorni. Il congedo è retribuito con un’indennità e il periodo di congedo è
coperto da contribuzione figurativa. I datori anticipano l’importo alla lavoratrice e hanno il diritto di
conguagliarlo con i versamenti contributivi dovuti. Per i datori per i quali non è prevista
l’assicurazione per le prestazioni di maternità, l’indennità è corrisposta dall’INPS. Il congedo può
110
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco di tre anni. In caso di mancata
regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, la lavoratrice può scegliere fra la fruizione
giornaliera o quella oraria. Le lavoratrici parasubordinate che si trovino nella medesima situazione
hanno diritto alla sospensione del rapporto per il periodo corrispondente all’estensione, la cui durata
non può essere superiore a tre mesi. Con l’art. 23 del Collegato lavoro, il governo è stato delegato
ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di
congedi, aspettative e permessi, con lo scopo di coordinare il testo delle disposizioni, riordinare le
tipologie dei permessi e ridefinire i presupposti soggettivi. Alla delega è stata data parziale
attuazione con il d.lgs. n. 119/2011.
5. La sospensione può verificarsi anche quale conseguenza di eventi che si collochino nella sfera del
datore. In queste circostanze si ritrovano le ipotesi di temporanea difficoltà dell’impresa. Gran parte
di tali ipotesi sono oggetto di una regolamentazione legislativa che tende a “socializzare” una parte
del rischio d’impresa, con l’intervento della Cassa integrazione guadagni, scaricando sulle
assicurazioni sociali i costi delle ristrutturazioni imprenditoriali o delle crisi produttive. Al di fuori
delle fattispecie prese in considerazione dal legislatore valgono le regole civilistiche relative alla
mora del creditore. Secondo l’art. 1206 c.c. il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo,
rifiuta il pagamento offerto nei modi di rito o non compie quanto necessario affinché il debitore
possa adempiere l’obbligazione. Gli effetti della mora consistono nel porre a carico del creditore sia
l’impossibilità sopravvenuta sia il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell’adempimento,
oltre alle spese conseguenti. Il risarcimento dei danni viene a coincidere con la retribuzione dovuta.
Viceversa in situazioni che evocano la vera e propria impossibilità, il datore può invocare la
sussistenza di un legittimo motivo di rifiuto della prestazione, sfuggendo alle conseguenze della
mora. Rispetto a tali ipotesi il diritto del lavoro ha predisposto una regolamentazione speciale: si
tratta dell’art. 6 ultimo comma del r.d.l. n. 1825/1924 il quale prevede che in caso di sospensione di
lavoro per fatto dipendente dal principale, l’impiegato ha diritto alla retribuzione normale. Una
situazione analoga si verifica in caso di serrata. Posto che la serrata costituisce una mera libertà di
fatto e non un diritto del datore, a differenza dello sciopero, il comportamento del datore che serra
l’impresa, integra l’ipotesi del rifiuto della prestazione e dunque l’applicazione delle regole della
mora credendi. Vi è la sussistenza di un legittimo motivo di rifiuto che può consistere nel rifiuto da
parte del datore di una prestazione inutilizzabile. È pacifico che il datore ha l’onere di predisporre
quanto funzionalmente necessario allo scopo, cooperando all’adempimento dell’altra parte. Anche
la mancata cooperazione all’adempimento produce, a favore del lavoratore, solo effetti risarcitori. Si
esclude quindi che alla posizione di cooperazione datoriale faccia da pendant un vero e proprio
diritto del lavoratore all’esecuzione della prestazione lavorativa. Questo diritto viene riconosciuto
solo in ipotesi in cui l’effettivo svolgimento della prestazione sia fonte di utilità ulteriori per il
lavoratore. Neanche l’idea di un diritto all’esecuzione della prestazione può dedursi da una qualche
valorizzazione della professionalità del lavoratore. Tale valorizzazione deve essere calibrata sulla
specificità dell’apporto del lavoratore. La configurabilità di tale diritto è disturbata
dall’insussistenza di strumentazioni processuali che consentano al lavoratore di ottenere
l’esecuzione in forma specifica dell’obbligazione infungibile del datore di cooperare al relativo
adempimento.
Sezione V: L’ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
IL RECESSO NEL RAPPORTO DI LAVORO
1. Anche sull’estinzione del vincolo obbligatorio si manifesta la specificità del rapporto di lavoro
che ruota sull’implicazione della persona del lavoratore e sulla natura di durata del vincolo. Il diritto
111
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
del lavoro ha individuato modalità tipiche di estinzione dell’obbligazione. La figura centrale è
quella del recesso. Quest’ultimo è un negozio unilaterale con il quale il contraente manifesta
all’altra parte la propria volontà di allontanarsi dal rapporto. Il recesso del datore assume la
denominazione di licenziamento, quello del lavoratore invece prende il nome di dimissioni. Tale
strumento, regolato dall’art. 2118 c.c., costituisce eccezione alla regola generale secondo cui il
contratto senza prefissione di durata può risolversi solo per mutuo consenso. L’istituto del recesso
costituisce la specifica risposta del diritto del lavoro al problema della rottura dei rapporti fra le
parti, dal momento che è sostitutivo dello strumento ordinario della risoluzione per inadempimento.
Il recesso è un atto unilaterale a carattere stragiudiziale che non comporta per la sua efficacia la
necessità di un intervento del giudice. All’interno del recesso dovranno trovare sistemazione anche
le ipotesi di impossibilità sopravvenuta. L’ordinamento ha posto limiti al potere di licenziamento
con l’obiettivo di garantire il più possibile ai lavoratori subordinati la stabilità del posto di lavoro.
Nessun limite è posto al potere di dimissioni del lavoratore. Tale assetto non costituisce un dato
immodificabile, ma è storicamente condizionato da un contesto economico fortemente segnato dalla
disoccupazione. È logico che uno stato socialmente impegnato si preoccupi di porre freni alla
libertà di licenziamento. Per converso non vi è ragione di limitare il potere di dimissioni del
lavoratore. Il discorso appena svolto è il frutto di una specifica situazione di mercato che non vale in
assoluto, ma solo per le fasce generiche di manodopera. Non potrebbe escludersi in astratto
l’introduzione di limitati temperamenti al potere di recesso anche del lavoratore. In tale ultima
prospettiva potrebbe trattarsi solo di limitazioni di carattere economico, potendosi degenerare
altrimenti in ipotesi di lavoro coatto. Una limitazione solo obbligatoria al potere di dimissioni è
prevista in alcuni settori rispetto a lavoratori altamente qualificati, con le clausole di durata minima
garantita del rapporto, con cui il lavoratore si impegna a non recedere prima di una certa data, pena
il pagamento di una penale risarcitoria. È l’esistenza di particolari vincoli al licenziamento e la
correlativa inesistenza di limiti alle dimissioni che pone talora la necessità di una verifica attenta del
negozio di dimissioni, potendo esso celare fattispecie simulatorie: si pensi alle dimissioni rilasciate
in bianco all’atto dell’assunzione e spese dal datore al momento in cui si vuole liberare di un
lavoratore sgradito. Sul tema si è sviluppato un ampio dibattito, al punto che il legislatore ha cercato
di fornire una soluzione con la l. 17/10/2007 n. 188, che aveva introdotto specifici oneri di forma
per le dimissioni. La legge è stata però poi abrogata dalla l. n. 133/2008. Successivamente è di
nuovo intervenuto il legislatore nell’ambito della riforma del mercato del lavoro promossa dal
governo Monti con la legge n. 92/2012. La nuova disciplina prevede che l’efficacia, sia delle
dimissioni che della risoluzione consensuale del rapporto, è sospensivamente condizionata alla
convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego
territorialmente competenti, o presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali. In
alternativa l’efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale è condizionata alla
sottoscrizione di un’apposita dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della
comunicazione amministrativa di cessazione del rapporto di lavoro che il datore deve inoltrare alla
DTL. In assenza di convalida il datore deve invitare il lavoratore ad effettuare la convalida presso le
sedi indicate o la conferma; in assenza di invito le dimissioni o la risoluzione consensuale cessano
definitivamente di avere effetto. Il rapporto si intende risolto se il lavoratore non aderisce, entro
sette giorni dalla ricezione, all’invito a presentarsi presso le sedi indicate per la convalida. Entro tale
spazio di tempo il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni. La revoca può essere comunicata
in forma scritta. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione non sia
stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. La comunicazione contenente l’invito
si considera effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di
lavoro o è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. Il datore che abusi del
112
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
foglio firmato in bianco al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto,
è punito con una sanzione amministrativa. Il legislatore rinvia poi ad un decreto del Ministro del
lavoro l’individuazione di ulteriori modalità semplificate per accertare a veridicità della data e
l’autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle
dimissioni. Nell’ambito del decreto delle “semplificazioni” il legislatore è intervenuto con l’art. 26.
La disposizione contiene un’articolazione della procedura, non mancando peraltro di rinviare ad un
decreto del ministro del lavoro. L’art. 26 fa salve le dimissioni della lavoratrice regolate dall’art. 55
comma 4 del d.lgs. 151/2001 alle quali non si applica la nuova procedura. Le dimissioni e la
risoluzione consensuale devono essere fatte esclusivamente con modalità telematiche su appositi
moduli resi disponibili dal ministero del lavoro. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del
modulo il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le
medesime modalità. L’alterazione dei moduli è punita con una sanzione amministrativa. La
procedura non si applica al lavoro domestico. La legge chiarisce che le dimissioni o la risoluzione
consensuale che facciamo corpo con una conciliazione sottoscritta nelle sedi che la rendono
inoppugnabile non hanno bisogno di soggiacere alla procedura conformativa della volontà del
lavoratore. La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 151/2015 non è immediatamente applicabile.
Troverà applicazione a far fata dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale di determinazione delle procedure attuative. È solo a decorrere da tale data che
verranno abrogati i commi da 16 a 23-bis dell’art. 4 della legge 28/06/2012 n. 92. La nuova
disciplina rende superfluo l’impiego delle tecniche civilistiche con riguardo alle dimissioni estorte
con violenza morale o viziate da errore. In tale situazione il lavoratore può ricorrere allo
strumentario generale dell’azione di annullamento del negozio di dimissioni, il quale resta oggi
come un’alternativa poco praticabile, dovendo il lavoratore fornire la prova della veridicità dei fatti
allegati per mettere in dubbio la genuinità delle dimissioni.
2. Il codice civile del ’42 non evoca la figura del licenziamento, ma si riferisce indifferenziatamente
alla posizione dei due protagonisti del rapporto di lavoro regolando il negozio di recesso. Il recesso
è un atto di autonomia privata avente natura negoziale che costituisce l’alternativa alla perpetuità
dei vincoli obbligatori. Non conta qui interrogarsi sull’effettiva riconducibilità all’autonomia
privata del potere di recesso, talora posta in dubbio. Conta sottolineare la rilevanza di tale natura sul
piano delle conseguenze giuridiche e ricordarne i tratti essenziali, riconosciuti nell’irretroattività,
unilateralità e recettizietà; discussa è l’opinione di chi vi ravvisa anche il tratto dell’astrattezza. La
natura negoziale e unilaterale comporta l’applicabilità delle norme sui contratti a condizione di
compatibilità, secondo la direttiva dell’art. 1324 c.c. È alla luce della medesima natura che va
esaminato il problema dell’apponibilità di condizioni. Da escludere è il potere di apporvi una
condizione risolutiva. Ammissibile è invece l’apposizione di una condizione sospensiva. Ciò può
verificarsi in quelle ipotesi in cui, licenziato un lavoratore per giustificato motivo oggettivo e nel
corso del giudizio proposto dal medesimo per la declaratoria di illegittimità di tale licenziamento, il
datore provveda a comunicare un nuovo licenziamento perché abbia appreso, dopo la cessazione del
rapporto, l’esistenza di fatti disciplinarmente rilevanti. Dato l’effetto istintivo prodotto dal primo
licenziamento, l’efficacia del secondo licenziamento è condizionata sospensivamente alla
declaratoria giudiziale dell’illegittimità del primo. Che al recesso sia apponibile la condizione
sospensiva è oggi confermato dalla disciplina sulle dimissioni in bianco, introdotta dalla legge n.
92/2012. Che il recesso sia irretroattivo significa che l’effetto estintivo collegato alla sua
comunicazione non può che prodursi successivamente alla manifestazione di volontà, essendo
un’ovvia implicazione dell’irrepetibilità delle energie lavorative già spese. Un’eccezione è evocata
dall’art. 1 comma 41 della legge n. 92/2012, secondo cui il licenziamento, intimato all’esito del
procedimento che deve precedere il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, produce effetto
113
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
dal giorno della comunicazione di avviamento delle procedure e quindi retroattivamente. Sono fatti
salvi solo il diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva e la sospensione
degli effetti del licenziamento in caso di impedimento derivante da infortunio sul lavoro. Il recesso
ha carattere recettizio, nel senso che produce effetto dal momento in cui perviene a conoscenza
della persona alla quale è destinato. Il che comporta l’applicabilità del principio della presunzione
di conoscenza, secondo cui gli atti si presumono conosciuti nel momento in cui giungono
all’indirizzo del destinatario. In contraddizione con il principio delle recettizietà la riforma Monti
all’art. 1 comma 41 fa retroagire gli effetti del licenziamento disciplinare al momento della
contestazione. Infine vi era chi si era spinto a sostenere la natura astratta del negozio. Tale
ricostruzione si prestava ad assecondare l’idea della massima latitudine possibile del potere di
licenziamento. In realtà tale opinione era resistita già sul piano tecnico dovendosi osservare che la
causa del negozio di recesso era ben individuabile nella funzione di estinguere il rapporto di lavoro
nella prospettiva dei poteri organizzativi del datore.
3. Il codice civile contempla la regola del recesso libero in contrapposizione al recesso per giusta
causa. La differenziazione è legata al potere della parte recedente di far cessare il rapporto
concedendo all’altra parte un termine di preavviso. La funzione della giusta causa è quella di
consentire al recedente di venire meno alla regola del preavviso. Anche nel sistema del
licenziamento giustificato assolve alla medesima funzione, nel senso che mentre il licenziamento
per giustificato motivo richiede il preavviso, quello per giusta causa consente il recesso immediato.
La logica che presiede alla previsione di un termine di preavviso per la parte receduta consiste nella
necessità di concedere a quest’ultima il tempo per provvedere diversamente ai propri affari. Così il
datore avrà il tempo di reperire un altro dipendente e il lavoratore di trovare una nuova
occupazione. Il preavviso costituisce così l’unico limite al potere di licenziamento. Secondo l’art.
2118 c.c. la durata del preavviso è determinata dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
In mancanza di preavviso il recedente è obbligato a corrispondere all’altra parte un’indennità
equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata durante il periodo di preavviso. L’art.
2121 c.c. detta altresì direttive in relazione alle modalità di computo dell’indennità sostitutiva. In
relazione agli elementi variabili della retribuzione, l’indennità si determina sulla media degli
emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato. Fino alla svolta
giurisprudenziale maturata negli ultimi anni appariva pacifico il principio dell’efficacia reale del
preavviso. Il principio comporta che per tutta la durata del preavviso permangono integri gli effetti
del contratto. Nella stessa logica si riteneva che gli eventi sospensivi incidessero sul preavviso
facendone slittare la scadenza. Oggi, alla luce dell’art. 1 comma 41 della l. n. 92/2012, in caso di
licenziamento disciplinare con preavviso, deve ritenersi che l’effetto sospensivo non operi rispetto
alla malattia generica, ma solo rispetto all’infortunio sul lavoro. Nella logica dell’istituto avrebbe
dovuto ritenersi che la facoltà di scelta fra preavviso lavorato ed indennità sostitutiva dovesse
spettare alla parte receduta. Resta fermo che la conclusione secondo cui, pur in presenza della
corresponsione dell’indennità, il rapporto resta in piedi fino alla scadenza del periodo soddisfa alle
esigenze della parte receduta. Per escludere le conseguenze dell’efficacia reale del preavviso era
necessario che la parte receduta manifestasse in modo inequivoco la volontà di risolvere
immediatamente il rapporto. Per converso la rinuncia del lavoratore alla prosecuzione del rapporto
non implicava rinuncia all’indennità sostitutiva. La più recente giurisprudenza ha mutato opinione
assumendo che il preavviso ha un’efficacia meramente obbligatoria, con la conseguenza che la mera
dichiarazione di recedere immediatamente produce l’effetto della cessazione del rapporto, con
l’unico obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva. Con il descritto mutamento il potere di
scelta fra preavviso lavorato ed indennità sostitutiva si sposta dalla parte receduta a quella del
recedente. La regola del preavviso vale anche nel caso di dimissioni del lavoratore, salvo che non
114
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
sussista una giusta causa di recesso: in tale ipotesi è il lavoratore (parte recedente) ad avere diritto
all’indennità sostitutiva.
4. Qui si parlerà di impossibilità sopravvenuta e potere di recesso.
4.1. All’interno del recesso rifluiscono le ipotesi si impossibilità sopravvenuta della prestazione: sia
quelle che attengono alla sfera del lavoratore, sia quelle che attengono alla sfera dell’impresa che
quelle che attengono ad eventi esterni alle parti. Allo scopo di dimostrarlo prendiamo in
considerazione le situazioni impeditive della prestazione del lavoratore. queste avrebbero dovuto
essere ricondotte all’impossibilità assoluta di prestare. Si trattava di una posizione in conflitto con la
stessa natura di durata del contratto di lavoro. Esclusa la riconducibilità del fenomeno
all’impossibilità totale resta l’alternativa fra le discipline prefigurate per l’impossibilità parziale (art.
1464 c.c.) o per l’impossibilità temporanea (art. 1256 comma 2 c.c.). L’opzione ricostruttiva ha
conseguenze per la determinazione dell’evento estintivo del rapporto, riconducibile, nel primo caso,
al recesso, e nel secondo caso alla risoluzione ipso jure. L’opzione più ragionevole è quella che
riconduce la nostra specie al fenomeno dell’impossibilitò parziale “ratione temporis”, posto che nel
contratto di lavoro non è concepibile un’impossibilità temporanea, che comporti ritardo
dell’adempimento. Il ritardo è configurabile quando la prestazione si esaurisca in un oggetto unico e
indivisibile, ma non quando essa sia frazionata in adempimenti giornalieri, settimanali, mensili, etc.
Ricondotta la vicenda all’impossibilità parziale, affidato al recesso lo strumento risolutorio idoneo a
far valere il venir meno dell’interesse del creditore, resta da verificare se esso sia da ricondurre
all’ipotesi regolata dall’art. 2119 c.c., di recesso per giusta causa, o a quella di cui all’art. 3 della
seconda parte della l. n. 604, di giustificato motivo oggettivo. E cioè se l’evento costituisca un fatto
che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto o attenga al regolare
funzionamento dell’organizzazione dell’impresa. L’opzione a favore della clausola della giusta
causa si lascia preferire per due argomenti. In primo luogo la nozione di giustificato motivo
oggettivo allude ad eventi collocati nella sfera dell’interesse dell’impresa e rende impossibile
ricomprendervi il comportamento del lavoratore. In secondo luogo risulta incompatibile con il
recesso conseguente al venir meno dell’interesse del creditore alla prosecuzione del rapporto la
permanenza del rapporto per il periodo di preavviso. La seconda questione è quella che riguarda
l’individuazione dei parametri idonei a dar corpo all’interesse del creditore alla cessazione del
rapporto. Occorrerà tener conto della collocazione del lavoratore nel processo produttivo, delle
mansioni e della qualifica ricoperta nonché delle dimensioni dell’impresa, operando un
bilanciamento fra l’interesse del lavoratore alla conservazione del posto e quella del datore alla
cessazione del rapporto. La giurisprudenza tende invece a ricondurre al giustificato motivo obiettivo
le più ricorrenti ipotesi di impossibilità. Ciò vale per la carcerazione preventiva del lavoratore e la
sopravvenuta inidoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni contrattuali. La posizione
della giurisprudenza, per quanto riguarda il licenziamento per inidoneità fisica o psichica, è ora
avallata dalla riforma Monti che ricomprende tali forme entro il “motivo oggettivo”. In materia di
recesso per impossibilità sopravvenuta riconducibile a carcerazione preventiva del lavoratore va
altresì segnalato un intervento del legislatore. Con l’art. 24 della l. 08/08/1995 n. 332 si è previsto
che il lavoratore ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro qualora venga pronunciata in suo
favore sentenza di assoluzione. La norma sembra confermare l’esistenza del diritto del datore a
procedere a licenziamento in caso di carcerazione preventiva. Essa susciterebbe perplessità sul
piano costituzionale, ove addossasse al datore i costi dei tempi e delle disfunzioni del processo
penale, imponendo il ripristino della collaborazione anche a distanza di moltissimo tempo. Sembra
pacifico che il concetto di reintegrazione non allude all’applicabilità dell’art. 18 dello statuto dei
lavoratori, riguardo alla tutela reale, dovendosi escludere ogni obbligo retributivo per il datore per il
115
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
periodo anteriore all’assoluzione. I medesimi principi devono applicarsi alle ipotesi di impossibilità
sopravvenuta del datore. Sembrerebbe contraddire tale affermazione la previsione di cui al comma 2
dell’art. 2119 c.c. che esclude che il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa costituiscano
giusta causa di licenziamento. Sennonché l’incongruenza può essere agevolmente giustificata. Non
è infatti detto che cessi l’attività dell’impresa, posto che essa può essere proseguita dal curatore
fallimentare ed è corretto escludere che si possa a priori procedere al recesso per giusta causa. Il
licenziamento potrà aver luogo solo in presenza di una giustificazione soggettiva o oggettiva. La
norma ha la funzione di consentire il godimento da parte del lavoratore dell’indennità di preavviso.
La soluzione codicistica segnale che il legislatore ha inteso costruire una fattispecie di recesso con
preavviso, a soli fini protettivi, in situazioni nelle quali sarebbe rinvenibile oggettivamente una
giusta causa. Identica valutazione è operata per l’ipotesi di morte del lavoratore che comporta il
pagamento dell’indennità di mancato preavviso. È per le ragioni esposte che alle possibili ulteriori
fattispecie di impossibilità nella sfera del datore torna ad essere applicabile l’art. 2119 comma 1
c.c., con esclusione del diritto all’indennità di preavviso, data la tassatività ed eccezionalità delle
ipotesi menzionate dal comma 2 della disposizione codicistica.
4.2. Vi sono alcune ipotesi di impossibilità sopravvenuta prese in considerazione per la costruzione
di una speciale disciplina di tutela, in ragione della peculiarità degli interessi sottesi. Si tratta delle
situazioni ricondotte al fenomeno della sospensione del rapporto di lavoro, le cui manifestazioni più
rilevanti trovano uno schema di riferimento negli artt. 2110 e 2111 c.c. Tali norme prevedono dei
limiti al potere di recesso del datore. Ciò vale per i casi di gravidanza e puerperio, per i quali
dispongono leggi speciali; a tali situazioni va aggiunta la speciale disciplina dei licenziamenti per
causa di matrimonio. Vale poi per l’ipotesi di effettuazione del richiamo alle armi. Vale infine per
l’ipotesi di assenza del lavoratore per malattia, in relazione alla quale l’art. 2110 comma 2 c.c.
dispone che il datore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’art. 2118 c.c., decorso il
periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. In attuazione di
tale principio la contrattazione collettiva prevede un periodo “di comporto”, durante il quale è
inibito al datore di procedere al licenziamento. L’art. 2110 costituisce una conferma dell’operatività
dei principi generali in materia di impossibilità sopravvenuta della prestazione. La norma, da una
parte, riafferma l’operatività del principio secondo cui l’interruzione momentanea della prestazione
non fa venir meno la causa negoziale e la sua agibilità funzionale; dall’altra svolge questa regola
delegando ad una serie di fonti l’individuazione del momento in cui viene meno l’interesse del
creditore all’adempimento della prestazione. Il periodo di comporto rappresenta una determinazione
convenzionale e vincolante del momento in cui viene meno siffatto interesse. L’unica deroga si ha
con riferimento al recesso ad nutum. Pur in presenza di una causa, nulla avrebbe impedito
all’imprenditore di esercitare il potere di recesso e chiudere la partita senza attendere la maturazione
del venir meno del proprio interesse all’adempimento parziale. Il quadro cambia in un diverso
sistema che tipizza le cause giustificative del licenziamento ed esclude il potere di libera
recedibilità. In tale sistema il recesso non potrà essere esercitato negli intervalli fra due periodi di
comporto. Il licenziamento intimato durante il periodo di comporto è inefficace, producendo effetti
solo alla scadenza del comporto, tranne che si tratti di licenziamento per giusta causa. In materia è
rilevante il nuovo testo dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori, secondo cui al licenziamento
intimato in violazione dell’art. 2110 comma 2 c.c. si applica la tutela reale attenuata. Il
licenziamento intimato dopo la scadenza, invece, costituisce una fattispecie autonoma di recesso
con preavviso. Tale situazione si presenta eccettiva rispetto alla regola che riconduce al recesso
senza preavviso il rimedio risolutorio delle ipotesi di impossibilità. Un dibattito si è sviluppato in
giurisprudenza, in relazione al fenomeno dell’eccessiva morbilità del lavoratore, al caso cioè in cui
un lavoratore si discontinuamente assente dal lavoro per malattia. La fattispecie fu inquadrata in un
116
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
primo tempo nell’ambito del giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Un punto fermo nella
discussione è rappresentato da una serie di sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione del 1980,
con le quali la Corte ha riaffermato che anche la materia delle malattie discontinue è tassativamente
regolata dall’art. 2110 c.c. Ha precisato che il giudice deve delibare il problema alla luce della
disciplina del comporto, verificando se tale fonte regola l’ipotesi del comporto “per sommatoria”: se
cioè è possibile cumulare più periodi di malattia breve al fine di raggiungere il tetto complessivo del
periodo di comporto. È solo in caso di mancata regolamentazione del comporto per sommatoria che
il giudice può ricorrere alle fonti succedanee previste dall’art. 2110 c.c., segnatamente all’equità,
proprio perché vi sarebbe un vuoto di disciplina. Il procedimento di valutazione equitativa non sarà
rimesso al libero arbitrio, perché il giudice dovrà contemperare gli interessi contrapposti delle parti.
Dovrà determinare sia il termine interno del comporto sia quello esterno. Mette conto rilevare che la
giurisprudenza successiva si è attenuta alle direttive generali segnate dalle Sezioni Unite, dando
seguito agli ulteriori svolgimenti applicativi.
IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
5. Il principio della libertà assoluta di recesso e di licenziamento appartiene allo strumentario dello
stato liberale. In tale contesto si ammanta dei panni del divieto di perpetuità dei vincoli obbligatori.
Secondo l’art. 1628 c.c. del 1865 nessuno poteva porsi all’altrui servizio che a tempo o per una
determinata impresa. È una regola che ha un’ovvia affermazione di libertà in contrapposizione al
lavoro servile. Sennonché tale principio si presta all’obiezione di garantire una libertà solo
apparente ed una solo formale parità delle parti agli effetti della cessazione del vincolo obbligatorio.
Il carattere “naturale” del principio di libera recedibilità è messo in discussione verso la fine
dell’ottocento da alcuni indirizzi minoritari della giurisprudenza. Esso viene confermato nel
contesto della legge sull’impiego privato e dall’art. 2118 c.c. Secondo quest’ultima disposizione
ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato con il solo limite
del preavviso. Questo limite però non deve essere rispettato nell’ipotesi in cui sussista una giusta
causa di recesso. Il sistema del codice civile del 1942 conferma e perfeziona il sistema del recesso
ad nutum. Dopo la parentesi, legata alla situazione di emergenza dell’immediato dopoguerra del
blocco dei licenziamenti, sono le parti sociali a rendersi attive sul terreno della limitazione del
potere di licenziamento. Vanno segnalati gli accordi interconfederali del settore industriale, a partire
da quello del 07/08/1947, rinnovato con accordi del 18/10/1950 e del 29/04/1965. Omologhe fonti
collettive regolavano la materia dei licenziamenti per riduzione di personale. Con tali accordi
l’autonomia collettiva introduceva il principio della necessaria giustificazione del licenziamento,
dando al lavoratore la possibilità di impugnarlo mediante il ricorso a procedure conciliative o
arbitrali, all’esito delle quali poteva essere emanata una pronuncia che imponeva al datore la
riassunzione o il pagamento di una penale risarcitoria. Sono evidenti i limiti dell’intervento. Si tratta
di una regolamentazione pattizia ristretta al solo settore industriale e che assicura una tutela solo di
carattere obbligatorio. Manca un’effettiva tutela dell’occupazione, ma si ha una mera
monetizzazione della perdita dell’occasione di lavoro. L’entrata in vigore della Carta costituzionale
rende evidente il contrasto fra il codice di impianto liberale e i nuovi valori introdotti: rileva in
particolare il principio del diritto al lavoro sancito dall’art. 4. È facendo leva su tale principio che
qualche costituzionalista ritenne di fondare il superamento della regola del recesso ad nutum, sul
presupposto che la norma costituzionale alludesse al diritto a mantenere il posto di lavoro,
derivandone l’illegittimità di un atto di recesso che limitasse quel diritto. In giurisprudenza prevalse
l’opinione secondo cui la disposizione costituzionale introduceva un impegno della Repubblica a
garantire la piena occupazione e dunque la creazione di nuovi posti di lavoro. Il filone
costituzionalista non è il solo che ha lo scopo di porre la questione del superamento del principio
117
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
del libero recesso. Vi è altresì il tentativo di giungere allo stesso risultato attraverso una revisione
della stessa struttura del contratto di lavoro, che è ascritto al novero dei contratti associativi. È una
prospettazione interpretativa dotata di scarsa forza di convinzione. Secondo un ulteriore filone di
pensiero una limitazione al potere di licenziamento ad nutum potrebbe discendere dall’applicazione
del principio della nullità del negozio per la sussistenza di un motivo illecito unico e determinato.
Anche tale prospettazione non poteva costituire una remora idonea a porre un controllo sulla
motivazione del licenziamento, ma solo tutela nei confronti dei licenziamenti puramente arbitrari.
Verso la metà degli anni sessanta si reputò intollerabile il mantenimento di un sistema che faceva
perno su di una assoluta libertà di licenziamento e la questione venne posta alla Corte
costituzionale, innalzando il contrasto fra l’art. 2118 c.c. e i principi della carta fondamentale. La
Corte, con la sentenza n. 45/1965, rilevò che la soluzione era di stretta pertinenza legislativa, ma
non mancò di invitare il legislatore a provvedere a regolamentare la materia. Tale invito fu accolto
con la legge 15/07/1966 n. 604: con essa tramonta definitivamente il principio della libertà
incondizionata di licenziamento e, poi, con lo statuto dei lavoratori del 1970, la riforma viene
completata con la garanzia della tutela reale del posto di lavoro. Con la legge 11/05/1990 n. 108 il
quadro è completato e perfezionato. Complessivamente il nostro ordinamento si caratterizza per la
compresenza di tre aree di tutela:
a) una zona di rilevanza del licenziamento ad nutum per taluni rapporti (lavoro domestico) o
rispetto ad alcune categorie di lavoratori (dirigenti) o rispetto a lavoratori che sono in
determinate situazioni;
b) una sfera nella quale ha vigore una tutela meramente obbligatoria, che si applica alle
imprese che occupano nelle rispettive unità produttive fino a 15 dipendenti o ai datori che
complessivamente occupano fino a 60 dipendenti e che contempla oneri di forma ed
obblighi di motivazione del recesso;
c) una zona nella quale all’invalidità del licenziamento per violazione delle regole formali e
sostanziali può conseguire per il lavoratore la tutela reale o una tutela economica;
d) un’ulteriore sfera (lavoratori assunti dopo il 07/03/2015) cui si applica, con il contrasto a
tutele crescenti, una tutela prevalentemente economica, salvo talune eccezioni.
Ciononostante quello appena descritto rimane comunque un quadro d’assieme assai imperfetto.
6. I presupposti di legittimità del licenziamento nell’area della disciplina limitativa.
6.1. Il licenziamento è sottoposto a rigidi vincoli formali e sostanziali che ne costituiscono i
presupposti di legittimità. Esso è atto a forma scritta ad substantiam. La materia è regolata dall’art.
2 della l. n. 92/2012. In precedenza il datore poteva limitarsi alla sola comunicazione della sua
volontà di recesso e comunicarne i motivi solo successivamente, su richiesta del lavoratore. Con la
riforma del 2012 la comunicazione deve necessariamente contenere la specificazione dei motivi che
lo determinano. L’omessa comunicazione per iscritto ne determina l’inefficacia. L’obbligo si applica
anche ai dirigenti, ai quali peraltro non si applica la disciplina limitativa dei licenziamenti. È
evidente la ratio della previsione normativa: si tratta di garantire il lavoratore ponendolo in grado di
conoscere le ragioni del provvedimento. La cristallizzazione della motivazione del licenziamento
circoscrive la materia del contendere della controversia promossa dal lavoratore per farne valere
l’illegittimità. Il datore non potrà far valere motivazioni diverse da quelle comunicate a suo tempo.
Il nuovo testo del comma 6 dell’art. 18 dello statuto evidenzia una palese contraddizione nel
momento in cui collega al licenziamento privo di motivazione una sanzione esclusivamente
economica. In tal modo ci sarebbe lo spazio per l’ipotesi in cui il datore si riservi di motivare il
recesso, successivamente alla comunicazione del medesimo. È però un’ipotesi puramente teorica,
118
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
dal momento che nessun datore ragionevole potrebbe rischiare di esporsi a conseguenze ben più
radicali, dal momento che dovrebbe comunque esplicitare le ragioni del recesso. Da quando il
lavoratore è a conoscenza del licenziamento e/o dei suoi motivi, decorrono i termini per
l’impugnazione del recesso datoriale. Il sistema non ammette che il datore possa essere ammesso a
provare che il lavoratore avesse avuto comunque conoscenza della volontà e della motivazione del
licenziamento. La motivazione deve essere specifica e completa. La giurisprudenza ammette solo
che il datore possa fornire in giudizio circostanze ulteriori purché confermative di quanto già
indicato al momento del licenziamento. L’atto di licenziamento viziato sotto il profilo formale o
procedurale è rinnovabile, ma con efficacia ex nunc.
6.2. L’esame della disciplina di cui all’art. 2 della l. n. 604/1966 non esaurisce la problematica della
forma del licenziamento; ulteriori elementi di discussione sorgono con riferimento al licenziamento
disciplinare. La questione si pone in ragione della circostanza che lo statuto dei lavoratori, all’art. 7,
ha introdotto una disciplina garantistica in relazione all’esercizio del potere disciplinare del datore
di lavoro. Ci si è chiesti se la procedura prevista dall’art. 7 fosse estensibile anche al licenziamento
disciplinare, riconducibile cioè ad un comportamento rimproverabile al lavoratore. Sulla questione
si aprì un amplissimo dibattito. La giurisprudenza si assestò, in una prima fase, subordinando
l’applicazione dell’art. 7 alle sole ipotesi in cui la contrattazione collettiva avesse incluso il
licenziamento fra le sanzioni. Sennonché l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione non
ebbe il tempo di affermarsi perché sopravvenne una decisione della Corte costituzionale che
dichiarò l’illegittimità dei primi tre comma dell’art. 7, se interpretati nel senso della loro
inapplicabilità ai licenziamenti disciplinari. Restava comunque aperta la questione della corretta
individuazione del concetto stesso di licenziamento disciplinare. Anche su questo punto si aprì un
dibattito tra i fautori di una lettura restrittiva della decisione della Corte e quelli della tesi estensiva
che guardava alla consistenza in sé del licenziamento. Quest’ultima è l’opinione che è prevalsa
nella giurisprudenza. Sono esclusi dall’area di rilevanza del licenziamento disciplinare solo quegli
atti di recesso in cui la giusta causa gioca un ruolo di veicolo di manifestazione delle ipotesi di
impossibilità sopravvenuta della prestazione. Un problema ulteriore ha riguardato l’estensione
dell’onere previa pubblicizzazione del codice disciplinare previsto dal comma 1 dell’art. 7. Nella
giurisprudenza si è affermata l’opinione secondo cui l’onere di pubblicizzazione va ritenuto ristretto
alle sole situazioni in cui sussista una disciplina regolamentare interna che tipizzi le infrazioni
suscettibili di comportare il recesso dal rapporto di lavoro. Ulteriori profili problematici riguardano
l’applicabilità delle procedure di cui all’art. 7 dello statuto anche nell’ambito del regime di libera
recedibilità. In un primo tempo la giurisprudenza si orientò nel senso della inestensibilità della
norma statuaria. Sennonché anche su tale orientamento si abbatté la mannaia della Corte
costituzionale che dichiarò l’incostituzionalità dell’art. 7, comma 2 e 3, se interpretati nel senso
dell’inestensibilità ai licenziamenti disciplinari intimati dai datori con meno di sedici dipendenti.
Questo è stato metabolizzato dalla giurisprudenza successiva, anche se è rimasta ancora aperta la
discussione circa le conseguenze del licenziamento disciplinare invalido nell’area del libero recesso
e/o della tutela obbligatoria. Neanche la riforma Monti ha fatto chiarezza sul punto, ma ha
comunque riconfermato testualmente l’estensibilità della procedura ex art. 7 dello statuto al
licenziamento disciplinare. L’art. 1 comma 41 della l. n. 92/2012 ha previsto che l’efficacia del
licenziamento disciplinare retroagisce al momento della contestazione salvo l’eventuale diritto del
lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. Gli effetti del recesso sono sospesi in
caso di impedimento derivante da infortunio sul lavoro e il periodo di lavoro svolto si considera
come preavviso lavorato. Un discorso a parte merita il licenziamento disciplinare del dirigente. In
relazione ad esso veniva evocata la spiccata fiduciarietà del rapporto. Qualche decisione di segno
opposto della Cassazione faceva invece leva sui tipi immessi nell’ordinamento dalla sent. n.
119
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
204/1982 della Corte costituzionale e sui valori di civiltà giuridica che avrebbero dovuto condurre
ad estendere le garanzie defensionali anche al dirigente. Quest’ultimo orientamento ebbe il
sopravvento, a seguito della sent. n. 427/1989 della Corte costituzionale, dovendo la Cassazione
prendere atto della ratio sottesa che evocava ineludibili esigenze di parità di trattamento fra
lavoratori collocati nella medesima posizione sostanziale. Ancora una volta la questione è stata
oggetto di revisione ad opera delle Sezioni Unite della Cassazione, che ha riproposto una
concezione del dirigente, non solo escluso dall’applicabilità dell’intero statuto dei lavoratori, ma
rispetto alla cui posizione risulterebbe incompatibile la stessa esistenza di un potere disciplinare. Le
Sezioni Unite della Cassazione sono però tornate sui loro passi, nel 2007, pronunziandosi per
l’estensione delle garanzie di cui all’art. 7 dello statuto dei lavoratori al dirigente tout court.
6.3. La giustificazione sostanziale del licenziamento:
6.3.1. La giusta causa – Con la legge n. 604/1966 tramonta il potere di licenziare senza
giustificazione. L’art. 3 abilita il datore al recesso con preavviso in presenza di disfunzioni del
rapporto addebitabili al lavoratore o all’impresa. Tali nuove clausole vanno ad aggiungersi a quella
della giusta causa. Quest’ultima, mentre prima assolveva alla funzione di consentire il recesso senza
preavviso, nel nuovo sistema diviene uno dei presupposti di validità che va ad affiancarsi al
giustificato motivo. Le parti possono recedere dal contratto in presenza di una causa che non
consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Fin dalle origini il fondamento del potere
di recesso per giusta causa viene ricondotto alla natura fiduciaria del rapporto di lavoro. Una delle
più rilevanti implicazioni consiste nel consentire che rilevino quali giusta causa di recesso fatti
estranei alle obbligazioni contrattuali, comunque idonei a far venir meno la fiducia. In sostanza si
potrebbe recedere anche in presenza di situazioni che non integrano inadempimenti contrattuali.
Con il codice civile del 1942 si afferma l’opinione che tende a far valere sub specie di giusta causa
anche fatti estranei allo stretto adempimento contrattuale: la teoria oggettiva. In contrapposizione a
tale opinione si assume che la concezione fiduciaria del rapporto non potrebbe prescindersi da una
valutazione di compatibilità dei comportamenti extra-lavorativi ritenuti rilevanti con le obbligazioni
contrattuali: teoria contrattuale. Questa posizione è poi più radicalizzata per effetto dell’art. 8, che
stabilisce un limite invalicabile alla sfera di riservatezza del lavoratore ed alla rilevanza dei suoi
comportamenti privati. Il rapporto di lavoro non si risolve nello scambio fra due prestazioni
semplici, ma implica il diuturno contatto tra due sfere di interessi contrapposti. Tali caratteristiche
non possono che condurre ad una considerazione più ampia che deve ricomprendere anche doveri
strumentali di comportamento e obblighi preparatori all’adempimento diretti al soddisfacimento
dello specifico interesse del datore. È naturale che il contesto ambientale in cui si svolge la
prestazione e la natura dell’attività del datore abbiano una loro rilevanza nella valutazione dei
comportamenti del lavoratore anche extra-aziendali. Nell’ordinamento è codificata la connessione
fra inadempimento e risoluzione, se il primo ha una notevole importanza ed è tale da menomare la
fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti. Le discussioni dottrinarie non hanno un’eco
immediata nella giurisprudenza, che invece si attiene a maggiore empirismo, se pure ispirandosi ad
una concezione più vicina alla teoria oggettiva. La Cassazione dà rilievo all’esistenza di una
mancanza del dipendente da valutarsi assumendo a parametri: la sua portata oggettiva e soggettiva,
il grado di colpa o dolo, le circostanze in cui è stata realizzata, i presupposti e gli effetti nella
prospettiva di far venir meno la fiducia del datore. Ne consegue la valorizzazione e la rilevanza
anche di fatti estranei alle obbligazioni negoziali del lavoratore. Ove il comportamento del
lavoratore abbia anche provocato un danno, questo sarà risarcibile secondo il diritto comune, a
prescindere dall’esercizio del potere di licenziamento. Il comportamento del lavoratore deve
essergli imputabile e il giudice deve verificare l’intensità del dolo o della colpa; tale valutazione
120
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
deve essere di carattere oggettivo. Per il licenziamento di giusta causa vale il principio di
proporzionalità della reazione datoriale al fatto addebitato al dipendente. Questo tipo di
licenziamento deve anche avere il requisito dell’immediatezza. Il datore deve cioè reagire al
comportamento scorretto del lavoratore, dovendosi ritenere che egli abbia nella sostanza tollerato le
violazioni della disciplina aziendale. L’immediatezza ha carattere relativo e quindi significa che vi
deve essere una tempestiva rispetto al momento in cui il datore abbia avuto conoscenza del fatto
commesso. In tali situazioni il datore può disporre la sospensione cautelare non disciplinare. Nel
tempo la contrattazione collettiva ha provveduto ad un’opera di tipizzazione delle ipotesi di giusta
causa di licenziamento. La giurisprudenza ritiene che tali previsioni non siano vincolanti per il
giudice né nel senso di escludere la rilevanza quale giusta causa di comportamenti non previsti né di
escludere il potere del giudice di verificarne la proporzionalità rispetto all’illecito commesso. La
questione della tipizzazione assume ora una coloritura particolare alla luce della riforma Monti. Nel
caso in cui il datore accampi un fatto che la contrattazione collettiva non contempla, la sanzione che
ne consegue è meramente risarcitoria ed il giudice dichiara la risoluzione del rapporto, mentre se il
fatto è tipizzato e punito dal contratto collettivo con una sanzione conservativa, scatta la tutela reale
attenuata. Nel caso in cui il lavoratore abbia commesso un reato nell’esercizio delle sue mansioni si
pone il problema dei rapporti fra giudizio penale e controversia di lavoro. La giurisprudenza ritiene
che il giudice del lavoro non sia vincolato all’accertamento svolto in sede penale, potendo valutare
autonomamente la sussistenza della giusta causa. L’autonomia del procedimento penale rispetto a
quello lavoristico è altresì confermata dalla ritenuta inestensibilità a quest’ultimo del principio di
presunzione di innocenza di cui all’art. 27 Cost. Ne deriva che ove il giudizio penale sia concluso
con amnistia resta intatto il potere del giudice del lavoro di ricognizione dei fatti e di valutazione
dei comportamenti.
6.3.2. Il giustificato motivo soggettivo – Il lavoratore può essere licenziato con preavviso in
presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali. La definizione si trova nell’art.
1455 c.c., che ammette la risolubilità del contratto in presenza di inadempimento di non scarsa
importanza. Nella norma codicistica il parametro di riferimento è l’interesse dell’altra parte. La
previsione del giustificato motivo soggettivo ha posto il problema fra questo e la giusta causa. Ci si
è chiesti se fra le due nozioni sussistessero delle differenziazioni di natura qualitativa o se il
discrimine dovesse passare attraverso una valutazione quantitativa della gravità del comportamento
del lavoratore. È prevalsa la seconda opinione, specificandosi che mentre il comportamento
caratterizzato da colpa gravissima o dolo integrerebbe gli estremi della giusta causa, quello
caratterizzato da colpa grave integrerebbe il giustificato motivo. Il riferimento alla violazione di
obblighi contrattuali del lavoratore pone in evidenza sia gli obblighi previsti dalla contrattazione
collettiva o dal regolamento d’azienda, sia quelli più generali codificati sul piano normativo. Vi è
qualche problema nell’ipotesi in cui un determinato comportamento del lavoratore sanzionato con il
licenziamento per giusta causa sia ritenuto dal giudice di minore gravità, ma tale comunque da
integrare gli estremi del giustificato motivo. In queste situazioni si afferma che sarebbe possibile
fare riferimento all’istituto della conversione. Discusso è se sia necessaria un’esplicita domanda del
datore o se il giudice possa procedere d’ufficio a derubricare la fattispecie costitutiva del potere di
recesso. Probabilmente è più corretto ritenere che si tratti dell’esercizio del potere del giudice di
qualificare dei fatti posti a fondamento dell’esercizio del potere di recesso.
6.3.3. Il giustificato motivo oggettivo – Il potere di licenziamento può anche essere esercitato
nell’interesse dell’impresa. A tale interesse allude la seconda parte dell’art. 3 della l. n. 604/1966. Il
datore ha il potere di risolvere il rapporto di lavoro in tutte quelle situazioni che comportino
riorganizzazioni o ristrutturazioni aziendali. Siffatta scelta produttiva rientra nella garanzia di libertà
121
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. La giurisprudenza riconduce al giustificato motivo
oggettivo indifferenziatamente le ipotesi di ristrutturazione aziendale, il ridimensionamento dei
programmi di sviluppo, la scelta datoriale di concentrare l’attività aziendale su alcuni prodotti e di
por fine alla produzione di altri o la riduzione della redditività dell’impresa, sempre che queste
situazioni comportino la soppressione di posti di lavoro. Costituisce avviso diffuso quello secondo
cui il datore è onerato di provare l’impossibilità di utilizzare il licenziando in altre mansioni
all’interno dell’impresa. L’onere della prova va integrato con l’ulteriore dimostrazione che i posti
ricopribili dal licenziato fossero già occupati nonché dalla prova che non siano state fatte assunzioni
nella stessa qualifica del lavoratore licenziato. La questione cruciale è peraltro quella dei limiti del
sindacato del giudice sulla scelta datoriale, nell’alternativa fra un controllo di mera legittimità ed un
controllo di merito. Prevalente è l’opinione che ammette un controllo solo sull’effettività della
scelta economica e sul nesso di causalità fra questa e la posizione dei licenziandi. La previsione del
licenziamento individuale per ragioni produttive pone problemi di coordinamento con la materia dei
licenziamenti collettivi. Sul tema della valutazione da parte del giudice della consistenza della
giustificazione oggettiva accampata dal datore va ricordato che è destinata ad avere un forte impatto
l’innovazione contenuta nella l. n. 92/2012 (riforma Monti), che ricollega la tutela reale alla sola
ipotesi di manifesta insussistenza delle ragioni addotte dal datore, mentre attribuisce una tutela solo
economica nelle altre situazioni. La più rilevante innovazione in materia di giustificazione oggettiva
nella riforma Monti è consistita nell’imposizione di una procedura preventiva obbligatoria,
antecedente alla messa in atto del licenziamento. Secondo il nuovo testo dell’art. 7 della l. n.
604/1966 infatti il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere preceduto da una
comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera
e trasmessa per conoscenza al lavoratore. In tale dichiarazione il datore deve indicare l’intenzione di
procedere al licenziamento per motivo oggettivo, i motivi del licenziamento nonché le eventuali
misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La Direzione territoriale del
lavoro trasmette la convocazione al datore e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla
ricezione della richiesta e l’incontro ha luogo davanti alla commissione provinciale di conciliazione.
La comunicazione è validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore o è
consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. Davanti alla commissione le parti
possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte, da un componente
della rappresentanza sindacale o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Alla commissione è
attribuita una partecipazione attiva allo scopo di esaminare sia il fondamento della scelta datoriale,
sia le alternative messe in campo. La procedura deve concludersi entro venti giorni dalla
trasmissione della convocazione. Se fallisce il tentativo di conciliazione e comunque decorsi venti
giorni il datore può procedere al licenziamento. Se la conciliazione ha esito positivo e si prevede la
risoluzione consensuale del rapporto, si applicano le disposizioni in materia di assistenza sociale per
l’impiego (Aspi) e potrà essere previsto l’affidamento del lavoratore ad un’agenzia di
somministrazione, di intermediazione e/o di supporto alla ricollocazione. Il comportamento delle
parti è valutato dal giudice per la determinazione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18
dello statuto nonché per l’applicazione da parte del giudice degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Secondo l’art. 1 comma 41 della l. n. 92/2012, il licenziamento intimato all’esito del procedimento
di cui all’art. 7 della legge 604/66 produce effetto dal giorno della comunicazione di avviamento
della procedura. Inoltre si prevede che gli effetti restino sospesi in caso di adempimento derivante
da infortunio sul lavoro.
6.3.4. Il licenziamento discriminatorio – Una particolare fattispecie di licenziamento illegittimo è
costituita dal licenziamento discriminatorio. La definizione della fattispecie si trova nell’art. 4 della
l. n. 604/1966 che evocava il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa,
122
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
dall’appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali. Era una definizione
che alludeva al licenziamento per rappresaglia per ragioni ideologiche. Più ampia, e sostitutiva, è la
definizione contenuta nell’art. 3 della l. n. 108/1990. Qui si sommano alle ragioni discriminatorie ai
sensi dell’art. 4 della l. 15/07/1966 n. 604 quelle previste dall’art. 15 dello statuto dei lavoratori,
come modificato dall’art. 13 della l. n. 903/1977. Una nozione ancora più ampia è proposta dall’art.
41 della l. 06/03/1998 n. 40, secondo cui costituisce discriminazione ogni comportamento che
comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore,
l’ascendenza e l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo
scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento dei diritti umani e delle libertà
fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita
pubblica. Il procedimento normativo si basa su una tipizzazione delle situazioni protette.
Ciononostante la giurisprudenza ha esteso la tutela anti-discriminatoria anche ad altre situazioni.
Secondo la legge, il licenziamento acquisisce carattere di discriminatorietà quale che sia la
motivazione addotta. Il che significa che il giudice deve indagare sulle reali ragioni del decesso.
Nonostante che l’indicazione normativa lasci ritenere che il licenziamento sia discriminatorio,
anche se sussista una giustificazione, la giurisprudenza pensa invece ad un orientamento che
assegna alla tutela anti-discriminatoria un ruolo solo residuale, escludendone l’applicabilità tutte le
volte che il datore possa dimostrare una giustificazione. Più corretto è invece ritenere che sia
discriminatorio anche un licenziamento di per sé fornito di giustificazione. Problemi si pongono con
riferimento al licenziamento discriminatorio nell’ambito delle cosiddette organizzazioni di
tendenza. Tali organizzazioni sono caratterizzate dal perseguimento di fini ideologici, perciò è
evidente che il licenziamento di un lavoratore, partecipe della tendenza, tocca il cuore della tutela
della libera manifestazione di espressione di questi. Da tempo si assume che la tendenza entra nella
causa del contratto di lavoro. Ne consegue che il mutamento di opinione del lavoratore si pone in
termini di inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto. Al licenziamento
discriminatorio è collegata la sanzione della nullità, con la conseguente applicabilità della tutela
reale forte, quale che sia la dimensione dell’impresa.
6.3.5. Il controllo dei poteri del giudice nel Collegato lavoro – La legge n. 183/2010 (Collegato
lavoro) introduce limitazioni al potere giudiziale di qualificazione e controllo delle causali del
licenziamento. Il Collegato propone una strategia di controllo della discrezionalità dei giudici
nell’impegno delle clausole generali che toccano la materia dei licenziamenti. Un primo intervento
riguarda l’istituto della certificazione, i cui scopi sono ampliati fino a ricomprendere una finalità di
riduzione del contezioso in materia di lavoro, e non più solo in materia di qualificazione dei
rapporti. L’art. 30 della legge 183/2010 spinge l’originario oggetto della certificazione fino a
ricomprendere le tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti
individuali di lavoro ove stipulati con l’assistenza e la consulenza delle commissioni di
certificazione. La certificazione potrà riguardare gli elementi e parametri fissati dai contratti
certificati in ordine alla definizione delle conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi
dell’art. 8 l. 604/66. Si entra qui in un terreno di estrema delicatezza: quello della formazione del
convincimento del giudice nel gioco fra autonomia e riferimenti legislativi a concetti aperti. Da
sempre i contratti collettivi descrivono le specifiche ragioni idonee a dar conto della rottura del
vincolo fiduciario in materia di licenziamento. L’innovazione legislativa avrebbe un sapore
rivoluzionario ove ritenesse di poter imporre al giudice le scelte pattizie. Sennonché tale
conclusione non è avvalorata dal testo normativo. La tipizzazione negoziale assume il ruolo di un
elemento di valutazione a disposizione del giudice nella verifica della sussistenza dei presupposti di
legittimità dell’atto di recesso rispetto alla fattispecie legale espressa in chiave di norma generale. È
e resterà sempre insostenibile la prefigurazione come giusta causa di recesso in ragione di un
123
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
evidente conflitto sia con la norma-chiave dell’art. 2119 c.c., sia con il principio di proporzionalità
prefigurato dall’art. 2106 c.c. Il leit-motiv del controllo sulla discrezionalità giudiziale torna nel
progetto di controllo diretto sull’impiego delle clausole generali. Secondo l’art. 30 comma 1 in tutti
i casi nei quali le disposizioni di legge contengano clausole generali il controllo giudiziale è limitato
esclusivamente all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato
di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore o al
committente. Si pretende dunque di allargare lo spettro del controllo avendo riguardo alle
disposizioni di legge che contengono clausole generali. Come sottocategoria della precedente ed a
titolo esemplificativo si elencano le norme: a) in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro; b)
esercizio dei poteri datoriali; c) trasferimento d’azienda; d) recesso. In tutti i casi il controllo
giudiziale deve limitarsi all’accertamento del solo presupposto di legittimità dell’atto di esercizio
del potere, senza potersi estendere al merito delle valutazioni tecniche, organizzative e produttive
che competono al datore. I concetti di giustificato motivo soggettivo, giusta causa e giustificato
motivo oggettivo rinviano a loro volta ad altri concetti aperti: la fiducia, l’intuitus personae, la
produzione, l’organizzazione, l’iniziativa economica. In essi l’indeterminatezza è intenzionale ed ha
la funzione di consentire al diritto di dominare il tempo. Il legislatore sospende il giudizio e rinvia la
soluzione del conflitto ad una diversa autorità. Si scarica sul giudice quindi la responsabilità di farsi
interprete di regole non scritte. Resta evidente l’assenza di qualsivoglia originalità nella scelta
legislativa. Da sempre la giurisprudenza limita il controllo al nesso di causalità fra la scelta
economica e le ricadute sulla soppressione del singolo posto di lavoro. Né è sostenibile che la nuova
previsione normativa possa incidere sui numerosi succedanei che la giurisprudenza ha elaborato per
attenuare la rigidità di un ossequio pedissequo alle scelte economiche aziendali. Tutti i succedanei
sono collocabili all’interno del richiamo alla cornice del procedimento valutativo che evoca i
principi generali dell’ordinamento. Un limitato controllo sui poteri datoriali potrà avvenire alla luce
dei principi di tutela della dignità sociale, del diritto al lavoro, della sicurezza e della dignità, in
contrapposizione alla libertà di iniziativa economica ed alla luce del principio di ragionevolezza. I
ragionamenti svolti devono fare i conti con le novità introdotte dalla l. n. 92/2012 che attribuisce
importanza al fine di distinguere fra tutela reale attenuata e tutela meramente economica alla
circostanza che l’inadempimento sia o non sia ricompreso fra le sanzioni conservative alla stregua
delle tipizzazioni della contrattazione collettiva. La medesima legge stabilisce poi che
l’inosservanza da parte del giudice delle disposizioni in materia di limiti al sindacato di merito sulle
valutazioni, costituisce motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto.
7. Le impugnazioni
7.1. Secondo l’art. 6 della l. n. 604/1966 il lavoratore deve impugnare il licenziamento, a pena di
decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione. L’impugnazione può aver corso
attraverso qualsiasi atto scritto, idoneo a rendere nota la relativa volontà. La prefigurazione di un
termine di decadenza persegue lo scopo di evitare che le controversie sulla legittimità del
licenziamento abbiano luogo in epoca lontana dai fatti. Sulla materia ha inciso l’art. 32 della legge
04/11/2010 n. 183 che ha prefigurato ancor di più per il lavoratore la necessità di adire l’autorità
giudiziaria dopo l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, evitando che la situazione di
incertezza si protragga troppo a lungo. Il nuovo testo dell’art. 6 della l. 604/66 prevede che
l’impugnazione diviene inefficace se non è eseguita nel successivo termine di 180 giorni dal
deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia
raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato
a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. La norma prevede che
l’azione possa essere spesa altresì con il ricorso dell’arbitrato. La doppia articolazione dei termini
124
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
non va intesa come una sommatoria dei medesimi. La norma porta a ritenere che il termine per
proporre la controversia decorra dalla data dell’effettiva impugnazione del licenziamento. Secondo
la nuova normativa le modalità di impugnazione descritte si applicano anche a tutti i casi di
invalidità del licenziamento. La previsione evoca un conflitto fra diritto comune e diritto speciale,
avendo riguardo a quelle situazioni in cui è la legge ad assoggettare alcune ipotesi di licenziamento
al regime della nullità. Sembra ineludibile assumere il superamento del regime di diritto comune e
dunque la conseguente necessità per il lavoratore di rispettare il termine di decadenza. Per effetto
della riforma Monti la disciplina delle impugnazioni si applica anche ai contratti collettivi. La legge
n. 183/2010 estende l’onere di impugnazione anche a tutta un’ulteriore serie di ipotesi: a) ai
licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto
di lavoro o alla nullità del termine apposto al contratto; b) al recesso del committente nei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa ed a progetto; c) al trasferimento del lavoratore. Le
medesime modalità valgono inoltre per la cessione di contratto di lavoro, di cui all’art. 2112 c.c.
nonché ad ogni altro caso in cui si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro
in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto. Con il d.l. 29/12/2010 n. 225 si è previsto
che in sede di prima applicazione le disposizioni di cui all’art. 6 comma 1 della legge n. 604/1966
acquistano efficacia a decorrere dal 31/12/2011. Qualche problema si è posto con riferimento alla
legittimazione ad impugnare da parte di soggetti diversi dal lavoratore. Dopo alterni orientamenti le
Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto affermando la sussistenza del potere in
capo al difensore, purché munito di procura scritta. In mancanza di essa è stata inoltre ammessa la
ratifica successiva del lavoratore. Secondo una prospettiva a lungo coltivata anche l’impugnazione
del licenziamento andava considerata alla stregua di un negozio giuridico avente natura ricettizia.
Era coerente con tale configurazione l’affermazione secondo cui, in caso di impugnazione
giudiziale, il ricorso dovesse essere anche notificato nel termine di sessanta giorni. Sennonché su
tale indirizzo è intervenuta di recente la Cassazione a Sezioni Unite che ha esteso l’impugnazione
del licenziamento i principi generali in tema di decadenza degli atti processuali, secondo cui
l’effetto dell’interruzione della decadenza si perfeziona con la consegna dell’atto di impugnazione
al servizio postale. A lungo dibattuta è stata anche la questione dell’applicabilità dell’art. 6 della
legge n. 604 al licenziamento orale. Nel risolvere il contrasto le Sezioni Unite della Cassazione
hanno sposato la prospettiva che esclude l’onere di impugnazione in tali circostanze. Tale
orientamento non sembra intaccato dalla nuova disciplina di cui alla l. n. 183/2010, dal momento
che il nuovo testo dell’art. 6 della l. n. 604/1966 sottolinea che il termine di impugnazione decorre
dalla comunicazione in forma scritta del licenziamento o dalla comunicazione in forma scritta dei
motivi. Bisogna infine rilevare che l’eventuale accettazione da parte del lavoratore delle indennità
per la cessazione del rapporto non costituiscono acquiescenza o accettazione tacita del
licenziamento.
7.2. Impugnato stragiudizialmente il licenziamento il lavoratore ha l’onere di proporre l’azione in
giudizio o di ricorrere alla conciliazione o all’arbitrato entro 180 giorni. Nell’evoluzione della
disciplina siamo passati da un sistema di conciliazione facoltativa ad uno di conciliazione
obbligatoria. A seguito della riforma contenuta negli artt. 69 e 69-bis del d.lgs. n. 29/1993 la
soluzione era stata generalizzata per tutte le controversie di lavoro. In alternativa ai descritti rimedi
si prevedeva che le parti potessero deferire la controversia relativa alla legittimità del licenziamento
a collegi arbitrali. Con la legge n. 183/2010 la materia delle conciliazioni e degli arbitrati è stata
ridisegnata. Anteriormente alla riforma contenuta nella l. n. 92/2012 era pacifico che il lavoratore
potesse avvalersi della procedura d’urgenza prevista dall’art. 700 cod. proc. civ. La legge del 2012
ha introdotto una nuova procedura giurisdizionale speciale dedicata specificamente
all’impugnazione del licenziamento. Si tratta di un nuovo modello processuale d’urgenza. Sono
125
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
escluse le impugnazioni dei licenziamenti ricadenti entro l’area della tutela obbligatoria. Il
lavoratore che ritenga che il datore rientri entro l’ambito di applicazione della tutela reale è onerato
di fornire la prova relativa alla dimensione dell’impresa. Il nuovo rito si applica alle controversie
instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Esso è articolato in una prima
fase sommaria che si conclude con un’ordinanza ed in una successiva fase di opposizione che si
conclude con una sentenza di merito. Quanto alla prima fase sommaria, la domanda si propone con
ricorso al tribunale in funzione del giudice del lavoro. Il ricorso non può contenere domande diverse
da quelle relative all’impugnazione del licenziamento. In seguito il giudice fissa con decreto
l’udienza di comparizione delle parti. Essa deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito
del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a
venticinque giorni prima dell’udienza. Il procedimento è snellito al massimo, posto che il giudice
provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della domanda.
L’efficacia esecutiva del provvedimento non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della
sentenza con cui il giudice definisce il giudizio. La decisione si basa su una valutazione sommaria
dei fatti e su un’acquisizione sommaria degli elementi probatori. L’ordinanza è impugnabile con
ricorso in opposizione, da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto.
Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse. Il giudice fissa con decreto l’udienza
di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando all’opposto termine per costituirsi
fino a dieci giorni prima dell’udienza. Il ricorso deve essere notificato dall’opponente all’opposto
almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione e l’opposto deve costituirsi
mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all’art. 416
cod. proc. civ. È ammessa la possibilità per il convenuto di proporre domanda riconvenzionale, ma
solo se essa è fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale.
Questa fase è a contradditorio pieno e dunque il giudice dovrà attenersi alle regole processuali
caratteristiche del rito del lavoro. La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni
dall’udienza di discussione. L’efficacia della sentenza può essere sospesa dalla Corte d’appello se
ricorrono gravi motivi. La sentenza del giudice di primo grado è impugnabile con reclamo davanti
alla Corte d’appello. Esso si propone con ricorso da depositare entro trenta giorni dalla
comunicazione. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio li
ritenga indispensabili. La Corte d’appello fissa con decreto l’udienza di discussione nei successivi
sessanta giorni e procede poi, sentite le parti, nel modo che ritiene più opportuno agli atti di
istruzione ammessi e provvede con sentenza. Anche la sentenza d’appello deve essere depositata in
cancelleria entro dieci giorni dall’udienza di discussione. Il ricorso per cassazione deve essere
proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza d’appello e la Corte deve fissare
l’udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso. Anche la Corte di
cassazione ha il potere di sospendere l’efficacia della sentenza d’appello per gravi motivi. Ogni
nuovo rito speciale comporta una ridefinizione dei carichi di lavoro fra i vari giudici della sezione e
un rallentamento nella definizione delle altre controversie. Del resto al medesimo obiettivo poteva
pervenirsi semplicemente valorizzando lo strumento della procedura di cui all’art. 700 cod. proc.
civ.
7.3. L’art. 5 della legge n. 604/1966 prevede che l’onere della prova della sussistenza della giusta
causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro. Sorgono problemi
nell’ipotesi in cui il lavoratore impugni un licenziamento orale, allegandone l’inefficacia ed il
datore contesti tale affermazione. In tal caso vi è incertezza addirittura sul negozio cui ricondurre
l’estinzione del vincolo obbligatorio. La questione è stata affrontata e risolta in modo convincente
dalla giurisprudenza, rilevandosi che la prova che incombe sul lavoratore che chiede la
reintegrazione nel posto di lavoro è quella della estromissione, mentre la prova che intende
126
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
ricondurre la cessazione del rapporto ad un negozio di dimissioni, costituendo eccezione in senso
stretto, grava sul datore. Il problema è oggi superato per effetto della l. n. 92/2012 che ha imposto la
forma vincolata delle dimissioni. Per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la
giurisprudenza assume che il datore, oltre a provare la soppressione del posto, dovrebbe provare
anche la sua concreta inutilizzabilità in altre diverse mansioni. A tale prova si collega poi quella
nell’allegare che successivamente non è stato assunto alcun altro al posto del licenziato. L’onere
della prova del carattere discriminatorio del licenziamento e quello diretto a dimostrare l’esistenza
di un motivo illecito sono a carico del lavoratore. Si pone inoltre il problema dell’individuazione del
soggetto onerato della prova della dimensione dell’impresa, agli effetti dell’applicazione della tutela
obbligatoria o di quella reale.
8. Bisogna ora esporre le conseguenze del licenziamento invalido. Le sanzioni sono le seguenti:
a) il licenziamento viziato sul piano della forma è qualificato come inefficace;
b) il licenziamento privo di giustificazione è qualificato come annullabile;
c) il licenziamento discriminatorio è qualificato come nullo.
Ad onta del riferimento alle categorie civilistiche dell’inefficacia, annullabilità e nullità, il relativo
regime giuridico si discosta dal paradigma generale. La circostanza dipende dalla compresenza di
due diverse aree di tutela: e cioè la tutela obbligatoria, per le imprese fino a quindici dipendenti, e la
tutela reale, per quelle di maggiori dimensioni. Il diritto del lavoro riutilizza le categorie civilistiche
dell’invalidità negoziale, piegandole alle proprie esigenze e costruendo una serie di nozioni di
invalidità di diritto speciale. Il quadro delle conseguenze sanzionatorie per il licenziamento
illegittimo è stato ulteriormente complicato dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015 che ha
introdotto il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, con il quale si è prefigurato, per i
soli lavoratori assunti dopo il 07/03/2015, un regime sanzionatorio ancora meno favorevole.
8.1. Il regime dell’inefficacia del licenziamento per vizi di forma, nell’area della tutela obbligatoria,
era equiparato al regime della nullità di diritto comune. Si riteneva che il recesso datoriale non
producesse effetti ed il lavoratore mantenesse il diritto alla retribuzione fino al ripristino del
rapporto o ad una valida comunicazione del licenziamento. Tale regime resta fermo anche a seguito
della legge n. 92/2012. Quest’ultima ha ridefinito l’apparato sanzionatorio, costruendo, per talune
situazioni, sanzioni di generale applicabilità: a) il licenziamento non comunicato per iscritto è
colpito dalla sanzione dell’inefficacia e quale che sia la dimensione del datore, con la conseguente
tutela reale piena; b) il licenziamento privo di motivazione è considerato, nell’ambito del campo di
applicazione dell’art. 18 dello statuto, ugualmente inefficace, ma ad esso si applica una sanzione
solo indennitaria. Sulla base di un orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità con
una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione del 1994, il licenziamento disciplinare
illegittimo, nell’area della tutela obbligatoria, darebbe luogo all’applicazione della sanzione prevista
per il licenziamento ingiustificato. L’opinione ha il pregio della ragionevolezza ed è peraltro viziata
da un eccesso di creatività, dal momento che il problema non è quello di applicare la sanzione che
all’interprete appaia più congrua, bensì quella che sia deducibile dal sistema. È il legislatore che
stabilisce i valori in relazione ai quali appare opportuna l’applicazione di una determinata sanzione.
La sanzione prefigurata dal sistema è quella della nullità per violazione della norma imperativa di
cui all’art. 7 dello statuto dei lavoratori. L’orientamento si è assestato anche perché ha ricevuto
l’autorevole avallo della Corte costituzionale, che ha respinto la questione di legittimità dell’art. 8
della l. n. 604, facendo propria l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Cassazione. Il
regime di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo è quello dell’annullabilità e che
comporta l’applicabilità dell’art. 8 della l. n. 604, secondo cui il datore è tenuto a riassumere il
127
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
lavoratore entro il termine di tre giorni o a risarcire il danno versandogli un’indennità di importo
compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di
fatto. La misura massima dell’indennità può essere aumentata fino a dieci mensilità per il prestatore
con anzianità superiore a dieci anni e fino a quattordici mensilità per il prestatore con anzianità
superiore a vent’anni. Con il “Collegato lavoro” si è limitata la discrezionalità del giudiziale nel
determinare l’indennità risarcitoria, prevedendo che il giudice, nell’ambito della tutela obbligatoria,
tiene conto di elementi e parametri fissati dai contratti collettivi stipulati dai sindacati più
rappresentativi o dai contratti individuali certificati. Ne deriva che oggi le parti collettive e quelle
del contratto individuale concorrono con il giudice nella determinazione dell’entità dell’indennità.
Deve quindi ritenersi che, nell’ambito della tutela obbligatoria, il licenziamento, se pur illegittimo,
costituisce di per sé atto idoneo a risolvere il rapporto: riassunzione o indennità. È altresì acquisito
il carattere alternativo delle due opzioni; bisogna quindi ritenere che, ove la riassunzione offerta
risulti impossibile per fatto del lavoratore, quest’ultimo ha comunque diritto alla penale risarcitoria.
Il licenziamento discriminatorio è qualificato dalla legge come nullo e comporta l’applicabilità della
tutela reale forte. Significa che questa tutela troverà applicazione sia nei rapporti con imprese di
qualsivoglia dimensione sia nei rapporti con datori non imprenditori nella residua area della libera
recedibilità sia anche nel rapporto di lavoro con il dirigente.
8.2. La riforma Monti-Fornero ha modificato l’apparato sanzionatorio dell’art. 18 dello statuto dei
lavoratori. Ne è derivato un quadro in cui è stata ridisegnata e ristretta l’area della tutela reale ed è
stata introdotta, accanto alla prima, una tutela economica, più consistente di quella assicurata al
lavoratore nell’ambito della tutela obbligatoria. La tutela economica è di entità variabile e prevista
in alternativa alla tutela reintegratoria, la cui scelta è affidata alla discrezionalità del giudice. Nella
versione ante-riforma Monti-Fornero, l’art. 18 unificava gli effetti delle tre specie di licenziamento,
stabilendo che il giudice, quando dichiarava inefficace il licenziamento, o annullava il
licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo o ne dichiarava la nullità, disponeva
un doppio ordine di conseguenze giuridiche: a) per il futuro doveva ordinare la reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro; b) per il periodo anteriore alla sentenza doveva condannare il datore
al risarcimento del danno, commisurato nel minimo a cinque mensilità di retribuzione. In sostanza
qualunque fosse il vizio del licenziamento, le conseguenze erano le medesime. L’ambito di
applicazione della tutela reale differenziata disposto dalla l. n. 92/2012, delinea quattro diversi
regimi sanzionatori.
A) La tutela reintegratoria piena per il licenziamento nullo e/o inefficace. Si applica a queste
situazioni:
a1) licenziamento nullo per ragioni discriminatorie o per causa di matrimonio o in violazione dei
divieti legati alla condizione di maternità della donna lavoratrice;
a2) licenziamento genericamente nullo perché riconducibile ad altri casi di nullità o determinato da
un motivo illecito;
a3) licenziamento inefficace perché comunicato oralmente.
Il regime di tutela reintegratoria piena si applica qualunque sia la dimensione occupazionale del
datore.
B) La tutela reintegratoria attenuata per il licenziamento annullabile. Si prevede:
b1) in caso di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ove il fatto contestato non sussista o il
medesimo rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa;
128
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
b2) in caso di giustificato motivo oggettivo connesso all’inidoneità psico-fisica del lavoratore o per
il mancato superamento del periodo di comporto;
b3) in caso di manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo, con la particolarità secondo
cui in tale ipotesi il giudice può applicare il regime attenuato.
Questa tutela consiste nell’ordine di reintegrazione, ma con diversa articolazione del risarcimento
per il periodo intermedio, che non può essere superiore alle dodici mensilità.
C) La tutela risarcitoria forte per il licenziamento annullabile. Consiste nella declaratoria giudiziale
della risoluzione del rapporto di lavoro, con effetto dalla data del licenziamento, e della condanna
del datore al pagamento di un’indennità risarcitoria determinata tra un minimo di dodici e un
massimo di ventiquattro mensilità. Tale regime si applica ad altre ipotesi riconducibili alla nozione
di licenziamento annullabile:
c1) in tutti i casi, diversi da quelli di B), di assenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
c2) in tutti i casi, diversi da quelli di B), di assenza di giustificato motivo oggettivo.
D) La tutela risarcitoria debole per il licenziamento inefficace. È una tutela ancora più limitata,
consistente nella declaratoria di risoluzione del rapporto e nella condanna del datore al pagamento
di un’indennità risarcitoria determinata tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mensilità. È
prevista per il caso del licenziamento dichiarato inefficace:
d1) per violazione del requisito della motivazione di cui all’art. 2 della l. n. 604/1966;
d2) per l’omissione della procedura di cui all’art. 7 dello statuto dei lavoratori (licenziamento
disciplinare);
d3) per violazione della procedura obbligatoria di cui all’art. 7 della l. n. 604/1966 per il
licenziamento per il giustificato motivo oggettivo.
A. La nuova versione dell’art. 18 conserva l’assetto sanzionatorio con riferimento alle ipotesi più
gravi caratterizzate da nullità del recesso datoriale. Tale regime si articola nel diritto alla
reintegrazione nel posto di lavoro ed all’integrale risarcimento dei danni per il periodo intermedio.
Inoltre c’è la possibilità per il lavoratore di optare, in luogo della reintegrazione, per il pagamento di
un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione. Il nucleo fondamentale è costituito dall’ordine
di reintegrazione del posto di lavoro. Il meccanismo di ripristino non è peraltro rimesso all’offerta
del debitore (lavoratore), ma all’iniziativa del datore che deve invitare il lavoratore a riprendere la
collaborazione. Ove entro trenta giorni dall’invito non abbia ripreso servizio né abbia richiesto
l’indennità sostitutiva della reintegrazione, il rapporto si intende risolto alla scadenza dei termini
indicati. L’offerta di ripresa della collaborazione non fa venir meno l’obbligo retributivo, che scatta
dopo la sentenza di reintegrazione. Il datore in caso di ripristino dovrà ricollocare il lavoratore nella
precedente posizione o in una equivalente. All’indomani dell’entrata in vigore dello statuto dei
lavoratori si è discusso sulla sussistenza del diritto del lavoratore di ottenere l’esecuzione in forma
coattiva dell’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro. Si è affermata l’ammissibilità del ricorso
alla procedura di cui all’art. 612 cod. proc. civ., procedendo a nominare un sostituto del datore che
impartisse le istruzioni necessarie per la ripresa della collaborazione. Sennonché ci si è resi conto
che le obbligazioni che nascono dal rapporto di lavoro non si esauriscono nell’impostazione del
contatto fra le due parti, ma presuppongono una continua collaborazione del creditore di lavoro
(datore). È per questo che l’opinione prevalente esclude la coercibilità dell’obbligazione in
questione, facendosi rilevare che l’obbligo di pagamento della retribuzione può funzionare da
129
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
coazione indiretta per indurre il datore all’esecuzione effettiva dell’ordine. Né la situazione è mutata
a seguito della riforma del processo civile attuata nel 2009. Tale riforma ha sì introdotto una
disposizione in forza della quale il giudice fissa la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni
violazione o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento, ma ha escluso che tale previsione
sia applicabile alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409. Anche dopo la riforma del 2012 si pone
la questione circa l’idoneità del licenziamento illegittimo a risolvere il rapporto. La difficoltà
interpretativa nasceva dalla circostanza secondo cui il legislatore aveva assoggettato al medesimo
regime giuridico le tre diverse situazioni dell’inefficacia, annullabilità e nullità, situazioni che
producono effetti ben differenziati. Per il periodo successivo alla sentenza già la versione originaria
dell’art. 18 riferiva al datore l’obbligo di pagare la retribuzione. Restava da spiegare come mai la
legge definisse la prestazione dovuta dal datore come “risarcimento dei danni”, dando l’impressione
che si trattasse di un ristoro per equivalente e non della permanenza dell’obbligo retributivo. Tali
interrogativi possono trovare risposta se si pensa che la prestazione dovuta per il periodo intermedio
dal datore cumula una funzione complessa, perché è non solo reintegratoria delle utilità perdute, ma
anche afflittivo-sanzionatoria, considerando il limite minimo di cinque mensilità comunque dovuto.
Il che fa sostenere che l’ordinamento reagisce al licenziamento illegittimo con un duplice
atteggiamento: da una parte considera il datore inadempiente all’obbligazione di lavoro e lo
condanna alla ricostruzione degli effetti del rapporto, dall’altra prefigura una misura minima del
risarcimento. Quest’ultima si giustifica come sanzione nei confronti dell’impiego arbitrario di un
potere di fatto. L’itinerario ricostruttivo appena evocato può essere ritenuto ancora attuale,
beninteso con riferimento all’ambito di applicabilità della tutela forte. Si continua a prevedere
infatti che, per il periodo intermedio, il giudice deve condannare il datore al risarcimento del danno
subito, stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del
licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e
previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione. Vi è la
conferma della ricostruzione integrale degli effetti del rapporto. Oggi, al licenziamento nullo,
conseguono gli effetti ad esso propri, essendo il recesso datoriale inidoneo a produrre la cessazione
del rapporto. Oggi dobbiamo ritenere che siffatta qualificazione debba valere solo per il
licenziamento nullo, e per quello inesistente, e del licenziamento inefficace, perché viziato sul piano
formale. Per quanto riguarda il problema dei criteri di calcolo del risarcimento dovuto, anche la
riforma del 2012 conferma l’acquisizione secondo cui al lavoratore sono dovute le intere
retribuzioni perdute. In precedenza da tale principio conseguiva l’idea che ricadesse sul datore
l’onere di dimostrare che il lavoratore aveva trovato un’altra occupazione, così da dedurre dal
risarcimento dovuto l’aliunde perceptum e percipiendum, cioè l’entità delle retribuzioni percepite in
un’altra occupazione e che avrebbe dovuto percepire con l’ordinaria diligenza. La novità della più
recente riforma sta nella previsione della necessaria deducibilità da risarcimento dovuto di quanto
percepito dal lavoratore per lo svolgimento di altre attività lavorative, cioè l’aliunde perceptum,
mentre nulla si dice in relazione all’aliunde percipiendum, che deve ritenersi non dovuto in caso di
tutela reale in senso forte. Inoltre il datore è condannato al versamento dei contributi assistenziali e
previdenziali. Resta intatta la possibilità per il lavoratore di provare che il licenziamento gli ha
procurato un danno maggiore. Altra questione riguarda la possibilità per il datore di ripetere le
somme erogate per effetto della sentenza di primo grado che abbia ordinato la reintegrazione nel
posto di lavoro, in caso di riforma di tale statuizione in grado d’appello. La questione nasceva dalla
formulazione del vecchio testo dell’art. 336 cod. proc. civ., che consolidava gli effetti della sentenza
di primo grado esecutiva fino al passaggio in giudicato della sentenza di riforma. Il problema è stato
superato per effetto della nuova formulazione dell’art. 336 cod. proc. civ., che ammette l’integrale
130
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
effetto sostitutivo della sentenza d’appello a fronte di quella di primo grado. Residua in
giurisprudenza la questione della ripetibilità delle somme versate dal datore in ottemperanza della
sentenza di primo grado. Si usa distinguere fra le varie attribuzioni previste dall’art. 18. Il
risarcimento dei danni per il periodo intermedio e l’eventuale indennità sostitutiva sono ritenuti
ripetibili. Sorte diversa hanno le retribuzioni corrisposte dal datore a seguito dell’ordine di
reintegrazione. Nella prima situazione l’irrepetibilità viene argomentata in funzione delle utilità che
comunque il datore ha ritratto dalla prestazione lavorativa. Nella seconda la medesima viene
radicata o sul carattere sanzionatorio dell’obbligo retributivo post-sentenza o sulla circostanza che
comunque il lavoratore si è tenuto a disposizione per riprendere la collaborazione. L’impostazione
ora descritta sembra messa in discussione dalla giurisprudenza, secondo cui tutti gli importi erogati
dal datore in esecuzione della sentenza che ordina la reintegrazione del lavoratore licenziato
costituiscono risarcimento del danno derivante dall’illegittimo licenziamento e come tali sono
interamente ripetibili a seguito della sentenza di riforma in appello. La problematica non sembra
essere intaccata dalla riforma dell’art. 18 contenuta nella l. n. 92/2012. Infine il lavoratore può
optare per il pagamento di un’indennità corrispondente a quindici mensilità della retribuzione
globale di fatto. L’opzione prefigura un diritto potestativo del lavoratore, in quanto tale del tutto
svincolato da ogni consenso del datore, producendo irrevocabilmente l’estinzione del rapporto.
Secondo la Corte costituzionale si tratta di un’obbligazione con facoltà alternativa dal laro del
creditore. Ulteriori problemi sorgono al fine di coordinare il termine dell’esercizio del diritto
d’opzione, l’invito del datore alla ripresa del servizio ed il deposito della sentenza. Prima della
riforma si riteneva che il rapporto dovesse proseguire fino all’effettivo pagamento dell’indennità.
La riforma del 2012 invece chiarisce che la richiesta da parte del lavoratore dell’indennità
determina la risoluzione del rapporto di lavoro. Secondo l’art. 18 comma 3 l’indennità risarcitoria
non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La tendenza dell’art. 18 a proporre
un’unificazione regolativa di tutte le specie di licenziamento illegittimo ha indotto ad evocare una
sorta di capacità espansiva della disposizione, ritenuta idonea a regolare anche fattispecie diverse da
quelle prefigurate. Ciò che semmai va posto in evidenza è la tendenza legislativa ad ampliare
l’ambito di rilevanza della tutela reale. Il che ci lascia ritenere che un’espansione della disposizione
statuaria può venire solo dal diritto positivo e non può essere dedotta dal sistema complessivo. Tale
previsione è stata confermata dal legislatore con la l. n. 92/2012. In effetti nel nuovo testo del
comma 1 dell’art. 18 vengono assoggettate alla sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro
altresì ulteriori situazioni in precedenza sanzionate con la nullità di diritto comune, ma anche tutte
le ipotesi riconducibili ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinati da un motivo illecito.
Si può quindi assumere che sia stata superata l’applicazione al licenziamento nullo delle sanzioni di
diritto comune.
B. La principale novità della riforma del 2012 consiste nell’aver affiancato alla tutela reintegratoria
piena ulteriori tutele minori nei confronti del licenziamento annullabile o inefficace sul piano
formale. Non sono pochi i problemi che pone la nuova formulazione legislativa. Per illustrarli
dobbiamo esaminare le situazioni di annullabilità del licenziamento cui si riferisce e il concreto
regime cui vengono sottoposte. Muovendo dal primo gruppo di questioni esaminiamo l’ambito di
applicazione della tutela reale attenuata con riferimento alla giustificazione soggettiva. La nuova
disciplina prende in considerazione le ipotesi di annullabilità del licenziamento perché il fatto
contestato non sussiste. È indiscutibile che la legge alluda all’esistenza di un inadempimento del
lavoratore ed alla sua imputabilità al medesimo. Ne deriva che il giudice dovrà prendere in
considerazione una condotta posta in essere dal lavoratore e indagarne l’effettività della sua
verificazione concreta. La legge evoca poi le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla
base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti
131
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
collettivi applicabili. Rientrano in questo ambito le ipotesi in cui il licenziamento faccia riferimento
a comportamenti che la contrattazione collettiva prende in considerazione sul piano disciplinare
come meritevoli di sanzioni minori rispetto al licenziamento. Il problema sorge ed è difficilmente
risolvibile avendo riguardo a quelle formulazioni contrattuali in cui la condotta del lavoratore
suscettibile di dar luogo ad un licenziamento sia descritta in modo approssimativo o generico. In tali
situazioni resta incerta la tutela concretamente applicabile. Passando alle fattispecie di
giustificazione oggettiva la tutela reale attenuta trova applicazione solo in caso di manifesta
insussistenza del giustificato motivo oggettivo. Si è molto discusso sulla dizione legislativa. È
questo il nucleo forte della riforma legislativa, che avrebbe dovuto condurre ad una monetizzazione
dell’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La versione approvata
costituisce il frutto di una mediazione fra le contrapposte esigenze. Questo e non altro significato è
possibile attribuire all’espressione “manifesta insussistenza”, che non può che corrispondere ad una
verificabile assenza di presupposti giustificativi. Più discutibile è invece che la formulazione
legislativa intenda alludere all’ipotesi in cui esistano le esigenze aziendali, ma il datore non sia
riuscito a dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità fra queste ed il licenziamento proprio di
quel lavoratore. A ciò si aggiunga che in caso di manifesta insussistenza del fatto posto a base della
giustificazione oggettiva, il giudice può (non “deve”) applicare il regime reintegratorio attenuato. È
evidente che la monetizzazione dei licenziamenti per motivi economici è sostanzialmente realizzata
dal momento che l’area di tutela reale attenuata è non solo residuale, ma pure eventuale, mentre
tutte le altre situazioni rientreranno nell’ambito della tutela indennitaria in senso forte.
Maggiormente circoscritto è il caso di giustificato motivo oggettivo connesso all’inidoneità fisica o
psichica del lavoratore o per il mancato superamento del periodo di comporto. Nel descrivere il
contenuto della tutela reale attenuata, dobbiamo prendere a riferimento l’art. 18 comma 4, che
prevede che il giudice debba annullare il licenziamento e condannare il datore alla reintegrazione
nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione
globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto
quanto il lavoratore ha percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto
avrebbe dovuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. Nel caso
della tutela reale attenuata, dunque, il legislatore dà rilievo anche all’aliunde percipiendum. La vera
novità è la previsione di una sorta di forfetizzazione del risarcimento per il periodo intermedio e si
prevede che esso non possa essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
Resta ferma peraltro la ricostruzione integrale della posizione previdenziale del lavoratore.
Interessante è l’innovazione in forza della quale l’importo dovuto a titolo contributivo deve essere
pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel
rapporto risolto dall’illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza
dello svolgimento di altre attività lavorative.
C. La tutela risarcitoria forte trova un’applicazione residuale con riferimento alle altre ipotesi di
licenziamento annullabile, diverse da quelle ricordate in precedenza, di assenza di giusta causa o
giustificato motivo soggettivo e di giustificato motivo oggettivo. Fra le altre ipotesi in cui il giudice
accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa rientra il
caso in cui il datore abbia sanzionato un comportamento, astrattamente punibile con una sanzione
minore, che però non sia contemplato nelle tipizzazioni previste dalla contrattazione collettiva. Vi è
da chiedersi allora come possa giustificarsi in termini costituzionali la difformità di trattamento che
si genera fra due situazioni sostanzialmente identiche. La tutela indennitaria forte comporta che il
licenziamento è atto idoneo ad interrompere il rapporto di lavoro. Il giudice dichiara risolto il
rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore al pagamento di
un’indennità risarcitoria determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro
132
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
mensilità. Avendo riguardo al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice, ai fini
della determinazione dell’indennità risarcitoria, dovrà inoltre tener conto delle iniziative assunte dal
lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione.
D. La tutela risarcitoria debole si applica nei confronti di una serie di licenziamenti viziati
esclusivamente sul piano della forma e cioè: a) per violazione del requisito della motivazione; b)
per l’omissione della procedura di cui all’art. 7 dello statuto dei lavoratori (licenziamento
disciplinare); c) per violazione della procedura obbligatoria di cui all’art. 7 della l. n. 604/1966 per
il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Questa tutela si applica nel caso in cui il
lavoratore abbia eccepito solo il vizio della forma. Anche in tale situazione il licenziamento è atto
idoneo a risolvere il rapporto, dal momento che il giudice ne dichiara la risoluzione e condanna il
datore al pagamento di un’indennità risarcitoria determinata tra un minimo di sei ed un massimo di
dodici mensilità. Volendo operare una valutazione di sintesi e a riguardare la riforma di cui all’art.
92/2012 possiamo rilevare che non tutti gli obiettivi conclamati sembrano essere stati perseguiti con
i mezzi idonei allo scopo. Riguardo all’obiettivo dell’accelerazione dei tempi di definizione delle
liti relativi al licenziamento, opportuni sono l’imposizione della comunicazione dei motivi e
l’abbreviazione dei tempi di impugnazione. Altrettanto utile è l’introduzione di una procedura
conciliativa obbligatoria preventiva per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Più
discutibile è che al medesimo scopo cospiri l’introduzione di una nuova procedura giurisdizionale
ad hoc per l’impugnazione del licenziamento, potendo il medesimo obiettivo essere perseguito
attraverso qualche minimo ritocco al processo cautelare delineato dall’art. 700 cod. proc. civ. Un
discorso analogo può farsi avendo riguardo alle finalità di aumentare la certezza del diritto nelle
controversie in materia di licenziamento. Positiva è la razionalizzazione delle acquisizioni
giurisprudenziali su taluni punti caldi. Ciò vale per: a) l’eliminazione delle aporie che ancora
circolavano nella giurisprudenza fra nullità di diritto comune e nullità di diritto speciale, con
l’unificazione delle conseguenze sanzionatorie; b) l’applicazione di una tutela indennitaria per il
licenziamento viziato solo sul piano formale; c) la collocazione entro la clausola del giustificato
motivo oggettivo di tutte le fattispecie di licenziamento connesse con la malattia del lavoratore; d)
la razionalizzazione delle tecniche risarcitorie per il periodo intermedio. Discutibile è il discrimine
che la legge introduce fra licenziamenti illegittimi in funzione della natura e/o dell’intensità della
ragione giustificativa addotta. Per quanto riguarda la giustificazione soggettiva, costituirà fonte di
contenzioso la distinzione fra licenziamenti illegittimi. Non è facile cogliere la ratio della
distinzione. L’unico modo per dare un senso è quello di far capo alla maggior alea che la scelta
datoriale incontra quando evochi un inadempimento non previsto dal contratto collettivo. In tali casi
la decisione circa la riconducibilità dell’inadempimento alla giusta causa o al giustificato motivo
soggettivo è rimessa alla discrezionalità del giudice. Di qui la prefigurazione di una sanzione solo
economica che può dare un margine di prevedibilità. Il fatto che l’inadempimento non esista o che il
medesimo sia punibile con una sanzione minore costituiscono tutti fatti dotati di una prevedibilità
per il datore e dunque la violazione di regole conosciute o conoscibili ex ante comporterà il
rispristino della relazione giuridica. Viceversa se la valutazione del comportamento del lavoratore
come inadempimento è il frutto di una decisione unilaterale del datore, l’alea della scelta comporta
una sorta di “sconto” sul piano della reazione sanzionatoria. Il minimo che può rilevarsi è che
l’opzione legislativa possa prestarsi a dubbi di costituzionalità per il fatto di sottoporre situazioni
simili ad effetti diversificati a seconda che la fattispecie sia o non sia prefigurata dal contratto
collettivo. Analoghe considerazioni si hanno per la giustificazione oggettiva. La distinzione fra
manifesta insussistenza e insussistenza del fatto posto a base del giustificato motivo oggettivo è
sospettabile di incostituzionalità per le medesime ragioni illustrate in precedenza con riferimento al
giustificato motivo soggettivo. Fonte di incertezza applicativa sarà l’alternativa fra applicazione
133
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
della tutela reintegratoria e tutela economica affidata alla discrezionalità del giudice. Prima della
riforma del 2012 la revoca del licenziamento poneva non pochi problemi. La revoca è disposta dal
datore in caso di violazione dei requisiti di forma del recesso ed allo scopo di consentirgli di
rinnovare l’atto viziato. In tali situazioni era oggetto di discussione se il lavoratore potesse
pretendere comunque il pagamento delle cinque mensilità anche se il datore avesse revocato il
licenziamento. Nell’ambito del vecchio sistema, la tesi della spettanza del risarcimento minimo
appariva maggiormente condivisibile. La questione appare oggi risolta imperativamente dalla
riforma del 2012. Si prevede che se la revoca del licenziamento interviene entro il limite di quindici
giorni dalla comunicazione al datore dell’impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si
intende ripristinato con il diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla
revoca. Una disciplina ancora più garantistica è prevista nei commi da 11 a 14 dell’art. 18 dello
statuto a favore del sindacalista interno. Tale disciplina sembra oggi essere di generale applicabilità,
dal momento che l’ambito numerico di applicabilità è ristretto ai commi da 4 a 7 della medesima
norma. I destinatari di tale tutela sono i lavoratori di cui all’art. 22 dello statuto e cioè i dirigenti di
rappresentanze sindacali aziendali ed i candidati e membri di commissioni interne. In caso di
licenziamento di tali soggetti si prevede che il giudice può disporre con ordinanza la reintegrazione
nel posto di lavoro. La natura cautelare dell’ordinanza è confermata dall’ammissibilità del reclamo
e dalla possibilità di revoca con la sentenza che decide il giudizio. La tutela si caratterizza per
l’obiettivo che persegue il legislatore di garantire l’effettiva reintegrazione nel posto di lavoro. La
reimmissione del sindacalista è considerata un valore imprescindibile. Allo scopo la legge cerca di
scoraggiare un adempimento esclusivamente economico dell’ordinanza, consistente cioè nel
pagamento della retribuzione senza effettiva reintegrazione. Per raggiungere tale obiettivo si serve
di una coazione indiretta, imponendo al datore il pagamento, ulteriore rispetto alla retribuzione
dovuta, per ogni giorno di ritardo, di una somma pari all’importo della retribuzione a favore del
Fondo adeguamento pensioni. Significa che ogni giorno di mancata reintegra ha, per il datore, un
costo doppio.
8.3. Ai regimi di licenziamento che diversificano il trattamento in funzione della dimensione
dell’impresa, il legislatore del 2015 ha giustapposto un ulteriore regime che diversifica il
trattamento in funzione della data di assunzione del lavoratore. Il riferimento è al d.lgs. 04/03/2015
n. 23 che ha introdotto il contratto di lavoro a tutele crescenti. Si tratta di un nuovo ed assai meno
garantista regime del licenziamento che trova applicazione nei confronti dei lavoratori assunti
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, cioè al 07/03/2015. Il legislatore ha
voluto introdurre un regime di sostanziale monetizzazione delle conseguenze del licenziamento
illegittimo per i soli nuovi assunti, lasciando impregiudicata l’applicazione del precedente regime ai
lavoratori già in servizio. In tal modo all’interno della stessa impresa sono destinati ad esserci sia i
rapporti cui è applicabile l’art. 18 dello statuto, sia quelli cui è applicabile il regime sanzionatorio di
cui al d.lgs. 23/2015. Tale assetto pone problemi di legittimità costituzionale avendo riguardo al
principio di eguaglianza e ragionevolezza. La nuova disciplina si applica ai lavoratori appartenenti
alle categorie di operaio, impiegato e quadro, assunti con contratto a tempo indeterminato a
decorrere dal 07/03/2015. Rientrano nel campo d’applicazione anche i lavoratori il cui rapporto sia
convertito successivamente al 07/03/2015. La legge si occupa inoltre delle imprese che superino la
soglia di quindici dipendenti, successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 23/2015. In tal caso il
nuovo regime si applica anche nei confronti dei lavoratori assunti in precedenza. Per le imprese
minori invece si esclude l’applicabilità della tutela reale attenuata e residua la sola totela
indennitaria, prevista dall’art. 3 comma 1 del d.lgs. 23/2015, in misura dimezzata e con un tetto
massimo di sei mensilità. Significa che all’interno delle imprese minori sono destinati a convivere
lavoratori cui è applicabile la tutela obbligatoria e lavoratori cui è applicabile il nuovo regime nella
134
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
misura ridotta. Un trattamento di miglior favore è previsto per i dipendenti delle organizzazioni di
tendenza. Ai lavoratori assunti successivamente al 07/03/2015 si applica la disciplina di cui al
decreto in questione, ottenendo un miglioramento della loro condizione, dal momento che, prima,
veniva applicata la sola tutela obbligatoria. I regimi sanzionatori introdotti dal d.lgs. 23/2015 in
parte sono riproposti dai regimi previsti dalla riforma Monti, ma con una accentuazione della regola
della monetizzazione del licenziamento a discapito della tutela reale.
a) La tutela reintegratoria piena per il licenziamento nullo e/o inefficace. Si applica al:
a1) licenziamento nullo perché discriminatorio;
a2) licenziamento genericamente nullo perché riconducibile agli altri casi di nullità previsti dalla
legge;
a3) licenziamento inefficace perché comunicato oralmente;
a4) licenziamento del quale sia accertata in giudizio la mancanza di giustificazione del motivo
consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore.
Qui vi è un più sintetico riferimento alle situazioni in cui la legge qualifica il licenziamento come
nullo. È da ritenersi che non ne risulti modificato il riferimento ad ogni specie di discriminazione.
La tutela reale forte è la medesima già prevista dalla riforma Monti, con una sola differenza: la
retribuzione da porre a base per il calcolo del risarcimento dei danni per il periodo intermedio è
commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
b) La tutela indennitaria per il licenziamento annullabile. La riforma del 2015 lancia il messaggio
molto chiaro secondo cui al licenziamento annullabile si applica di regola una tutela di natura
indennitaria, mentre la tutela reale costituisce un’eccezione, ristretta ad ipotesi tassative e davvero
residuali. Nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per
giustificato motivo o della giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto e condanna il datore al
pagamento di un’indennità, che non è assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a
due mensilità dell’ultima retribuzione, per ogni anno di servizio. Ecco dunque spiegate le “tutele
crescenti”: ciò che cresce con l’anzianità di servizio è solo la misura dell’indennità dovuta per il
licenziamento annullabile. In tali situazioni rientra anche la mancanza di proporzionalità della
sanzione.
c) La tutela reintegratoria attenuata per il licenziamento annullabile. L’applicabilità della tutela
reintegratoria attenuata è ristretta alle sole ipotesi di licenziamento per giustificato motivo
soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto
materiale contestato al lavoratore. Rileviamo che qui si è inteso specificare esplicitamente che il
fatto deve essere materiale, ma non solo. La formulazione legislativa sembra alludere ad una sorta
di inversione dell’inversione dell’onere probatorio circa l’esistenza del fatto che ha dato luogo al
licenziamento, che ritornerebbe in capo al lavoratore. Inoltre resta aperto il fronte della discussione
intorno agli ulteriori vizi per solito evocati rispetto al licenziamento disciplinare. Il regime
sanzionatorio del licenziamento per giustificato motivo oggettivo è esclusivamente quello
indennitario, regolato dall’art. 3 comma 1 del decreto legislativo. Nei casi descritti la tutela consiste
nell’ordine di reintegrazione, ma con diversa articolazione del risarcimento del periodo intermedio,
che non può essere superiore a dodici mensilità di retribuzione. Resta ferma la copertura
contributiva per l’intero periodo. Anche in tale situazione la retribuzione-parametro è quella posta a
base della determinazione del TFR. Il percipiendum è parametrato alle condizioni previste dalla
135
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
legge per la perdita dello stato di disoccupazione a seguito di rifiuto senza giustificato motivo di una
congrua offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
d) La tutela indennitaria ridotta per vizi formali o procedurali. È prevista:
d1) per la violazione del requisito della motivazione;
d2) per l’omissione della procedura di cui all’art. 7 dello statuto dei lavoratori (licenziamento
disciplinare).
In tali casi si ha la declaratoria di risoluzione del rapporto di lavoro e la condanna del datore al
pagamento di un’indennità corrispondente ad una mensilità per ogni anno di servizio, in misura
comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità. Resta fermo il caso che il giudice
debba accertare la sussistenza della giustificazione del licenziamento. Speciali regole di computo
sono prefigurate per i lavoratori occupati in attività appaltate. Infatti l’anzianità di servizio del
lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto si computa tenendosi
conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata. Per le
frazioni di anno, le indennità e la somma offerta in conciliazione sono riproporzionate e le frazioni
di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come un mese intero. Il legislatore del
2015 attribuisce importanza all’offerta di conciliazione che il datore può attivare e che evita il
ricorso alla lite giudiziaria. Secondo l’art. 6 del d.lgs. 23/2015 il datore, infatti, può offrire al
lavoratore una somma pari ad una mensilità della retribuzione, con una sorta di datio in solutum
consistente nella consegna al lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione della somma
comporta l’estinzione del rapporto e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento. Il legislatore
stabilisce che l’esenzione è strettamente legata all’erogazione delle somme nella misura
predeterminata e non può estendersi ad ulteriori somme corrisposte al lavoratore in via conciliativa.
Anche al licenziamento nell’ambito del contratto a tutele crescenti si applica la disciplina prevista
per la revoca. In caso di revoca del licenziamento il rapporto di lavoro si intende rispristinato senza
soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente
alla revoca. Sul piano procedurale è coerente con la prefigurazione di una sanzione puramente
economica per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’esclusione dell’applicazione
della previa procedura conciliativa di cui all’art. 7 della l. n. 604/1966. Altrettanto coerente è
l’inapplicabilità del “rito Fornero”, di cui ai commi da 48 a 68 dell’art. 1 della legge 92/2012. Un
discorso a parte merita la regolamentazione delle conseguenze sanzionatorie per il licenziamento
collettivo illegittimo. Si prevede l’applicazione della tutela reintegratoria forte solo per il caso di
omessa osservanza della forma scritta. Per la violazione delle procedure di cui all’art. 4 comma 12
della l. n. 223/1991 o dei criteri di scelta di cui all’art. 5 comma 1 della medesima legge si applica
la sola tutela indennitaria. La questione più spinosa riguarda le future procedure di licenziamento
collettivo che potranno coinvolgere lavoratori assunti prima del 07/03/2015, assoggettati al regime
sanzionatorio di cui alla l. n. 223/1991 e lavoratori assunti successivamente. Come potrà
considerarsi una reazione sanzionatoria sperequata all’interno dello stesso gruppo di lavoratori
destinatari del provvedimento di licenziamento collettivo?
9. Fin dalle origini la disciplina limitativa dei licenziamenti si presentò con caratteri non
universalistici, essendo destinata ad applicarsi ai datori al di sopra di una certa soglia occupazionale.
Essa rappresenta un esempio fra i più significativi di emersione legislativa della rilevanza della
dimensione dell’impresa nel diritto del lavoro. Tale assetto non ha mancato di essere valutato nel
prisma della possibile violazione del principio di eguaglianza. Sennonché la Corte costituzionale ha
sempre ritenuto ragionevole la disparità così indotta fra i lavoratori della grande a quelli della
136
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
piccola impresa, basando la propria argomentazione su due presupposti: a) la necessità di non
gravare di costi eccessivi le imprese di minori dimensioni; b) la spiccata fiduciarietà delle relazioni
di lavoro in tali imprese. Il tentativo di rimuovere tale disparità di trattamento per via referendaria
ha costretto il legislatore ad emanare la legge 180/1990 che ha ridimensionato le disparità. L’art. 18,
così riformulato, stabilisce un tetto massimo complessivo di lavoratori occupati nell’impresa, al di
sopra del quale si applica comunque la tutela reale: tale limite è di sessanta dipendenti. Inoltre
prevede che la medesima tutela si applichi ai datori che nell’ambito dello stesso comune occupano
oltre a quindici dipendenti e alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano
oltre a cinque dipendenti. La tutela obbligatoria si applica ai datori che occupino fino a quindici
lavoratori ed agli imprenditori agricoli che occupino fino a cinque lavoratori. Si applica inoltre ai
datori che occupano fino a sessanta dipendenti, purché articolati in unità produttive che occupino
massimo quindici lavoratori. Come si vede, dunque, la tutela obbligatoria nel nuovo sistema è
divenuta la tutela generalizzata e di base. Anche la legge 180/1990 continua a dare rilievo alle
minori articolazioni dell’impresa, cioè le unità produttive. La questione più dibattuta è quella che
riguarda il significato dell’autonomia di tale articolazione minore dell’impresa. La nuova legge non
apporta argomenti idonei a risolvere il contrasto fra una concezione minimalista e una più rigorosa
che ritiene l’unità produttiva sia anche centro di imputazione di interessi e rapporti. Scarsi apporti
vengono dalla l. n. 108 rispetto al problema relativo alla ripartizione dell’onere della prova circa la
consistenza numerica dell’impresa. L’approdo cui era giunta la giurisprudenza tendeva ad accollare
al lavoratore l’onere di provare la consistenza numerica dell’impresa ai fini dell’applicabilità della
tutela reale, restando in capo al datore l’onere di provare l’applicabilità del regime di recesso ad
nutum. La Cassazione a lungo ha riconfermato questa opinione, anche dopo l’entrata in vigore della
legge del 1990. Solo più tardi si è aperto un dibattito con posizioni contrapposte. Il contrasto è stato
poi risolto con la sentenza 141/2006 delle Sezioni Unite della Cassazione che ha accolto la
prospettiva di porre a carico del datore l’onere probatorio. Ai fini della valutazione del momento
rilevante e dei criteri di computo del personale si afferma la convinzione che debba tenersi conto
della consistenza dell’impresa nel periodo immediatamente antecedente il licenziamento. La legge
n. 108 ha inoltre mancato di prendere posizione sul problema della computabilità nell’organico
dell’impresa dei lavoratori a domicilio. È un’omissione significativa, data la difficoltà di fornire una
soluzione appagante al quesito. Non è detto che l’entità della collaborazione di un lavorante a
domicilio sia equiparabile a quella di un lavoratore interno. Non a caso la giurisprudenza oscilla fra
l’affermazione dell’esclusione dal computo dei lavoranti a domicilio e quella della loro
computabilità. Problemi analoghi si porranno nel caso di sviluppo e diffusione del telelavoro. La
giurisprudenza esclude la computabilità dei soci lavoratori. Il principio non sembra dover subire
modifiche per effetto della nuova disciplina del lavoro del socio di cui alla l. n. 142 del 2001. I
lavoratori a tempo indeterminato e parziale devono essere conteggiati per la quota di orario
effettivamente svolto. A mente dell’art. 47 comma 3 del d.lgs. n. 81/2015 gli apprendisti sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di
particolari normative o istituti. Secondo l’art. 18 del d.lgs. n. 81/2015 i lavoratori intermittenti sono
computati nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto
nell’arco di ciascun semestre. Non si computano il coniuge e i parenti del datore entro il secondo
grado in linea diretta e collaterale. La legge del 1990 ha anche superato la distinzione fra datori di
lavoro imprenditori e non. La l. 108 unifica la platea dei destinatari sancendo l’applicabilità della
disciplina tout court ai datori, fatto salvo il settore agricolo. Prescinde invece dal riferimento
dimensionale quello assicurato dalla legge a favore delle organizzazioni di tendenza. Secondo l’art.
4 comma 1 della l. n. 108 la tutela reale non trova applicazione nei confronti dei datori che svolgono
senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, di religione o di
137
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
culto. Non è chiara però la ratio di tale tutela privilegiata. Un cenno a parte va fatto per la
regolamentazione del licenziamento individuale nel pubblico impiego. Il momento di passaggio è
costituito dal d.lgs. n. 29/1993, che sostiene che la materia debba essere regolata dal diritto privato.
Quanto all’individuazione dei presupposti di legittimità del recesso vale il riferimento, contenuto
nell’art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui i rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa. Ne consegue l’applicabilità degli artt. 2118 e 2119 c.c. nonché della l. n. 604/1966.
Quanto agli effetti del licenziamento illegittimo dispone il comma 2 dell’art. 51 del d.lgs. n.
165/2001 che estende l’applicabilità dello statuto dei lavoratori alle pubbliche amministrazioni.
Significa che la tutela contro il licenziamento illegittimo è, per i pubblici dipendenti, sempre quella
reale. Tale assetto è rimasto impregiudicato anche a seguito della l. n. 92/2012, che ha solo previsto
che le disposizioni di quest’ultima costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di
lavoro dei dipendenti pubblici.
10. Il carattere non universalistico della disciplina ha anche riguardo alle esclusioni soggettive. Fin
dalla disciplina originaria la tutela contro i licenziamenti ha sempre trovato applicazione nei
confronti della categoria operaia e impiegatizia, con esclusione dei dirigenti. Ha avuto seguito in
giurisprudenza la proposta diretta a distinguere nell’ambito dei collaboratori dell’imprenditore
quelli maggiormente vicini al vertice da quelli collocati in posizioni meno elevate. Il licenziamento
del dirigente non è del tutto libero, posto che la contrattazione collettiva prefigura una forma di
tutela a carattere convenzionale. Si stabilisce non solo l’obbligo di comunicazione scritta del
recesso, ma anche l’obbligo di motivazione. In caso di licenziamento il dirigente può ricorrere ad
uno speciale collegio arbitrale irrituale, che può condannare il datore a pagare una penale
risarcitoria. La riforma del 1990 ha ampliato la protezione della categoria dirigenziale, estendendo
sia gli oneri di comunicazione per iscritto del recesso, sia la tutela reale nel caso di licenziamento
discriminatorio. Sono poi esclusi i lavoratori con rapporto di lavoro in prova, ai quali la disciplina è
applicabile quando l’assunzione diviene definitiva e trascorsi sei mesi dall’assunzione. A tale
previsione si è fatta questione di legittimità costituzionale, respinta due volte dalla Corte
costituzionale. Mentre nella prima la Consulta si limitò a rilevare la diversità strutturale fra patto di
prova e rapporto di lavoro, nella seconda ritenne non del tutto insindacabile il recesso del patto di
prova. Fece invece salva la possibile impugnativa per la sussistenza di un motivo illecito,
determinato da ragioni estranee alla verifica dell’opportunità di concludere il contratto definitivo.
La legge non annovera gli apprendisti fra i destinatari della tutela. La lacuna legislativa è stata
colmata con un intervento della Corte costituzionale del 1973. La Corte ha distinto fra recesso
operato nel corso del contratto di apprendistato e quello operato al termine di esso. Il primo va
assoggettato alla disciplina limitativa, mentre il datore rimane libero, quanto alla seconda
situazione, di dare o non dare corso alla conversione del contratto di apprendistato in un ordinario
rapporto. Tale assetto è confermato con l’art. 42 comma 4 del d.lgs. n. 81/2015. È stato previsto il
potere delle parti di recedere ad nutum e con preavviso dal termine del periodo di formazione, con
l’aggiunta che continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se
nessuna delle parti recede il rapporto continua come ordinario rapporto a tempo indeterminato. Il
limite finale della copertura protettiva è costituito, per il lavoratore ultrasessantenne, secondo l’art.
4 comma 2 della l. n. 108/1990, dall’acquisizione dei requisiti pensionistici. Bisogna peraltro tener
conto che con la l. n. 247/2007 il legislatore ha esteso alle pensioni di vecchiaia il sistema delle
“finestre”, meccanismo in funzione del quale il godimento della pensione non decorre dal mese
successivo al compimento dell’età pensionabile, ma è procrastinato a qualche mese di distanza. Con
l’art. 24 comma 4 del d.l. n. 201/2011 si era prevista un’“incentivazione” al proseguimento
dell’attività lavorativa fino al compimento del settantesimo anno d’età. L’interpretazione data a tale
138
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
disposizione assumeva che la legge avesse voluto introdurre un diritto per il lavoratore ad optare per
la prosecuzione del rapporto fino al compimento del settantesimo anno d’età. Sennonché con una
decisione del settembre del 2015 le Sezioni Unite della Cassazione hanno escluso la sussistenza di
un diritto potestativo all’opzione, ritenendo che la disposizione offre al lavoratore solo la possibilità
di concordare con il datore siffatta prosecuzione. L’ultima area di rilevanza del recesso ad nutum è
quella del lavoro domestico. L’art. 4 della l. n. 108/1990 stabilisce che la disciplina di tutela non
trova applicazione nei rapporti disciplinati dalla l. 02/04/1958 n. 239 e tale ultima legge regola i
rapporti di lavoro domestico aventi la durata di almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso
datore di lavoro. Resta fermo che il licenziamento discriminatorio dei lavoratori domestici comporta
il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.
I LICENZIAMENTI COLLETTIVI
11. Distinta dal fenomeno del licenziamento individuale è la vicenda dei licenziamenti collettivi o
per riduzione di personale. Il potere di variare le dimensioni dell’impresa è radicato sulla libertà di
iniziativa economica privata. Il fenomeno del licenziamento collettivo investe una molteplicità di
interessi, oltre a quello individuale dei singoli soggetti destinatari: quello della collettività dei
lavoratori, che non saranno destinatari dell’iniziativa, e quello del sindacato, attento alle vicende
dell’impresa che possano avere ricadute sui livelli occupazionali. È per questa ragione che la
materia è stata oggetto di due Accordi interfederali per il settore industriale, con i quali si sono
fissate alcune regole di comportamento per il datore, e cioè: a) l’obbligo di instaurare una procedura
conciliativa intersindacale, a seguito della preventiva comunicazione dell’intenzione di procedere
alla riduzione di personale; b) l’obbligo di procedere al licenziamento dei lavoratori nel rispetto di
alcuni criteri di scelta, in concorso fra loro. L’assetto regolativo di origine sindacale ha avuto corso
dal momento che la legge del 1966 n. 604, all’art. 11 comma 2, dispose che la materia dei
licenziamenti collettivi per riduzione di personale era esclusa dalle sue disposizioni. Questa scelta
venne riconfermata nei due successivi interventi in materia di licenziamento: l’art. 18 dello statuto
dei lavoratori e la l. n. 108/1990. La giurisprudenza si pose la questione del significato
dell’esclusione, sancita dall’art. 11 della l. del 1966 e dei rapporti fra il licenziamento collettivo ed
il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La giurisprudenza si assestò sull’affermazione di
una differenza strutturale fra licenziamento individuale e licenziamento collettivo. Alla violazione
delle regole procedurali e sostanziali previste dagli Accordi interfederali, avrebbe potuto far capo
solo una tutela di diritto comune.
12. Tra le fonti della disciplina in materia di licenziamenti collettivi vanno ricordate le direttive
dell’Unione Europea. Con la Direttiva CEE 10/02/1975 n. 129, modificata dalla Direttiva CEE n.
92/56, è stata definita una nozione di licenziamento collettivo e quindi fissata una serie di regole
procedurali. Per licenziamento collettivo si intende ogni licenziamento effettuato da un datore per
uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore e avendo riguardo ad un certo numero di
lavoratori. Quanto alle procedure si è previsto per il datore un obbligo di consultazione con i
rappresentanti dei lavoratori, al fine di giungere ad un accordo. Allo scopo il datore deve fornire in
tempo utile tutte le informazioni necessarie. Il lungo astensionismo del legislatore italiano in
materia non è passato inosservato. Lo Stato italiano è stato condannato due volte dalla Corte di
giustizia delle Comunità Europee, per inosservanza degli obblighi derivanti dall’art. 260 TFUE.
L’accusa era solo in parte fondata. La via italiana al controllo ed alla regolamentazione delle
riduzioni di personale faceva leva su un complesso sistema, in cui un ruolo essenziale era dato agli
“ammortizzatori sociali”, che attutivano le conseguenze negative per i lavoratori espulsi dal
processo produttivo.
139
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
13. La caratteristica fondamentale della l. n. 223/1991 è quella di regolare il fenomeno dei
licenziamenti collettivi nel più ampio contesto della gestione delle crisi produttive. L’entrata in
vigore della legge spazza via il castello giurisprudenziale costruito intorno all’autonomia del
licenziamento collettivo e raccoglie il messaggio degli sforzi della dottrina diretti ad unificare le
prospettive di tutela del lavoratore nelle due situazioni. Ciò non toglie che l’art. 24 della legge
supponga la necessità di un coordinamento con l’art. 11 della l. 604, posto che il rapporto fra le due
norme non può porsi nei termini di un’abrogazione della disposizione del 1966. La questione è
risolvibile assumendo che non esiste incompatibilità logica tra l’art. 11 e l’art. 24. Si può anzi dire
che la funzione della nuova disposizione è quella di colmare il vuoto di disciplina lasciato aperto
dall’esclusione dell’art. 11. Tale vuoto è ora riempito da una regolamentazione normativa della
vicenda della riduzione di personale, che ne scandisce i momenti essenziali: a) l’individuazione
della fattispecie; b) disegno delle procedure; c) prefigurazione delle conseguenze giuridiche della
violazione della disciplina.
14. La vicenda del licenziamento collettivo è regolata in un ampio contesto, nel quale un ruolo
fondamentale hanno le procedure di mobilità connesse all’attivazione dell’intervento della Cassa
integrazione guadagni. La legge ipotizza che alla procedura di mobilità possa giungersi sia nel caso
in cui l’impresa ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e
di non poter ricorrere a misure alternative (recesso di mobilità, art. 4), sia nel caso in cui procedere
direttamente, senza la mediazione di ricorso alla CIGS, alla riduzione del personale (licenziamento
collettivo, art. 24). Il problema dei rapporti con la procedura relativa alla collocazione in cassa
integrazione attinge alla necessità di coordinare, a livello di fattispecie, le ipotesi regolate dall’art. 4
e dall’art. 24 della l. 223/91. Per risolvere il problema bisogna osservare che al licenziamento
collettivo, la cui nozione è delimitata dall’art. 24, si applicano le procedure previste per il recesso di
mobilità dagli artt. 4 e 5. Il rapporto del licenziamento collettivo con la disciplina della cassa
integrazione guadagni non si pone nei termini di una necessaria pregiudizialità di quest’ultima
rispetto alla scelta di procedere alla riduzione del personale. Rimane dunque inalterato il rapporto
fra la scelta di ricorrere all’integrazione salariale straordinaria e quella di procedere alla riduzione
del personale. Un secondo interrogativo è quello che riguarda la possibile configurabilità nel
recesso in mobilità di una fattispecie autonoma rispetto al licenziamento collettivo. La tesi più
accreditata è nel senso dell’autonomia fra le due species. In realtà il richiamo operato dall’art. 24 ai
commi dell’art. 4 successivi al primo ha la sola funzione di confermare la non indispensabilità del
ricorso alla CIGS. Non vuol dire che vi sia sovrapponibilità fra il licenziamento collettivo ed il
recesso in mobilità fino ad integrare l’esistenza di un’unica fattispecie giuridicamente rilevante.
Essa appare in contrasto con la valorizzazione dell’interesse pubblico che è sottostante alla
concessione del trattamento di integrazione salariale. Il che significa che nel caso di cui all’art. 4
l’impresa deve rispettare le procedure. Il senso dell’assimilazione delle due figure può essere
recuperato se il perno dell’interesse si sposta sui presupposti causali, che appaiono comuni alle due
diverse ipotesi di recesso. In sintesi il sistema fornisce delle risposte articolate e intersecantisi alle
crisi aziendali. L’impresa può attivare l’intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria,
sulla base di un programma sottoposto al vaglio sindacale e della pubblica amministrazione. Al
contrario può avvenire che, nell’attuazione del programma, sorgano difficoltà che l’impresa ritiene
di non poter risolvere se non ridimensionando i progetti di reimpiego. In tale situazione può
avvisare la procedura di mobilità che culmina nella nuova figura del recesso con la contestuale
messa in mobilità dei lavoratori che ritiene esuberanti. Può infine ritenere fin dall’inizio che ci sia la
necessità di un ridimensionamento: potrà in tal caso procedere al licenziamento collettivo,
rimanendo titolare del potere di por termine al rapporto, fermo restando il diritto dei lavoratori a
percepire l’indennità di mobilità. Ciascuna delle scelte non è del tutto indolore per l’impresa, che è
140
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
chiamata parzialmente a contribuire al finanziamento dell’integrazione salariale e dell’indennità di
mobilità. La legge fornisce un incentivo al raggiungimento di un accordo con il sindacato,
riducendo alla metà il contributo aziendale.
15. Per la definizione del concetto di licenziamento collettivo la legge si affida ad una sommatoria
di criteri: oggettivo, numerico, temporale/spaziale. È collettivo il licenziamento che: a) consegua ad
una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro (oggettivo); b) riguardi almeno cinque
lavoratori (numerico); c) in un arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità
produttive nell’ambito del territorio della stessa provincia (temporale/spaziale). Oggi si può ritenere
che la nozione di “riduzione o trasformazione di attività o di lavoro” costituisce una sorta di sotto-
insieme di quella di giustificato motivo oggettivo. Se i tentativi di diversificazione delle due
fattispecie erano basati su dati incerti, con maggiore fondamento si può riconoscere che tale
conclusione valga rispetto alla legge 223/91. Si può ora passare a fornire il significato interpretativo
dell’espressione “riduzione o trasformazione di attività o di lavoro”. L’espressione è presa alla
lettera dalla definizione fornita dall’accordo interfederale sui licenziamenti collettivi del 1965.
L’opinione prevalente riteneva che il concetto di “ridimensionamento” potesse essere integrato da
una riduzione stabile e non transitoria di attività produttiva che riguardasse esclusivamente o in
modo prevalente uno solo dei fattori aziendali e cioè l’elemento personale. Il riferimento al
requisito della trasformazione di attività rende palese la ricomprensione nella previsione normativa
anche dei licenziamenti tecnologici. La legge include nell’ambito dei licenziamenti collettivi le
ipotesi di cessazione totale dell’attività dell’impresa. In tal modo viene superato l’orientamento
giurisprudenziale che riconduceva tale ipotesi nell’ambito del licenziamento per giustificato motivo
oggettivo. Può ritenersi che la cessazione debba essere definitiva, per abilitare al licenziamento
collettivo. La messa in liquidazione della società, l’ammissione alla procedura di concordato
preventivo ed il fallimento non sono sufficienti a legittimare il recesso per giustificato motivo
oggettivo. La collocazione di tali ipotesi nell’ambito del licenziamento collettivo è oggi confermata
dall’art. 3 della l. 223 che attribuisce al curatore, liquidatore o commissario, la facoltà di collocare
in mobilità i lavoratori eccedenti. Non rientrano nella nozione di licenziamento collettivo le ipotesi
di scadenza di rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili, di fine lavoro per
cessazione dei contratti di appalto di servizi e di attività stagionali o saltuarie.
16. Accanto al requisito oggettivo, la legge colloca un dato numerico/temporale: l’esistenza di
almeno cinque licenziamenti nell’arco di centoventi giorni. In dati numerici non pongono incertezze
interpretative se non per quel che riguarda la costruzione di una sorta di fattispecie a formazione
progressiva, in forza della quale vengono attratti nell’orbita della disciplina tutti i licenziamenti che
siano riconducibili alla stessa riduzione o trasformazione. Tale previsione pone non pochi problemi.
Nel primo senso si tratta di verificarne i nessi con i presupposti causali e con l’intenzione del datore
di procedere ai licenziamenti. Bisogna chiedersi se il riferimento riconduca la vicenda ad una
illimitata libertà del datore di scegliere fra licenziamenti individuali per giustificato motivo
oggettivo e licenziamenti collettivi. sembra quasi ovvio rilevare che “intenzione” sta per
programma del datore. Tale programma non si esaurisce uno actu, ma si estende nell’ampio arco di
centoventi giorni. Qualche problema pone l’estensione degli oneri a tutti i licenziamenti che siano
riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. Questa previsione è stata oggetto di un
intervento legislativo di interpretazione autentica: la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori
deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilità entro 120 giorni dalla
conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione nell’accordo sindacale. Tale
intervento ribadisce che la riconducibilità all’unica scelta di ridimensionamento non può che essere
operata a posteriori. Coerente è quella giurisprudenza che assume che, per il superamento della
141
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
soglia delle cinque unità, occorre far riferimento al programma datoriale. Diversa questione è quella
di chiedersi se siano cumulabili al licenziamento anche le dimissioni o le risoluzioni consensuali,
riconducibili al medesimo presupposto causale del ridimensionamento aziendale. Non vi è dubbio
che debbano essere ricompresi nella soglia i negozi di dimissione, attuati in frode alla legge, al solo
scopo di evitare l’attivazione delle procedure. Meno certa è la cumulabilità delle dimissioni o delle
risoluzioni consensuali, al di fuori di schemi fraudolenti. A favore della cumulabilità milita la
rilettura interpretativa dell’art. 24 alla luce della direttiva 92/56/CEE che equipara tutti i negozi
risolutivi riconducibili alla medesima causa. Deve giocare un suo ruolo anche la considerazione
della volontà del lavoratore, purché non astretta in lacci fraudolenti o altrimenti costretta. Se il
numero di licenziamenti scende, dopo la comunicazione e/o per effetto dell’accordo, a meno di
cinque non se ne immuta la natura collettiva ad ogni effetto. Occorre soggiungere che se
l’intenzione di procedere al licenziamento di più di cinque dipendenti nell’arco di 120 giorni non si
realizza perché è lo stesso datore ad abbandonare questo disegno, l’eventuale licenziamento di un
numero inferiore sarà attratto nella disciplina dei licenziamenti individuali. La progressività della
fattispecie pone anche problemi di ordine processuale. L’eventuale verifica giudiziale della
legittimità dei licenziamenti individuali plurimi potrebbe essere paralizzata o soggetta a
modificazioni nell’ipotesi di sopravvenuta estensione della scelta di riduzione del personale nel
numero minimo di sei lavoratori.
17. Secondo la regolamentazione di cui all’art. 24 della l. 223/91 la nuova disciplina in materia di
licenziamenti collettivi doveva trovare applicazione nei confronti delle imprese che occupassero più
di 15 dipendenti. La materia è stata novellata dal d.lgs. 08/04/2004 n. 110 che ha esteso le
disposizioni sui licenziamenti collettivi anche ai privati datori di lavoro non imprenditori. Ai datori
non imprenditori si applicano le norme che riguardano l’enucleazione dei presupposti di legittimità
del licenziamento, gli obblighi di consultazione sindacale e i criteri di scelta. Non si applica invece
l’apparato sanzionatorio di cui all’art. 5 comma 3, con a conseguenza che la violazione dei criteri di
scelta dà luogo all’applicazione della sola tutela obbligatoria. I lavoratori dipendenti da datori non
imprenditori non percepiscono alcuna indennità. Rimangono estensibili ai soli imprenditori gli
obblighi di versamenti contributivi, così come è conseguenziale che i datori che assumano tali
lavoratori dalle liste di mobilità non usufruiscano di sgravi. Con l’art. 8 comma 2 della l. n.
236/1993 si è estesa l’applicazione degli art. 1, 4 e 24 della legge anche ai soci lavoratori di
cooperative di produzione e lavoro. Risalta ancora la differenza fra l’ambito numerico individuato
dal comma 1 dell’art. 24 della l. 223 e quello cui si riferisce il nuovo testo dell’art. 18 st. lav. Nel
silenzio della legge deve ritenersi che possano estendersi le previsioni dell’art. 18 comma 9 dello
statuto relativamente ai criteri di computo del numero dei dipendenti in relazione alle caratteristiche
del rapporto o ad altri elementi. Pure estensibile sembra essere il riferimento di cui all’art. 1 comma
1 della l. 223 all’organico medio degli ultimi sei mesi. In relazione alle categorie dei prestatori di
lavoro si sono poste varie questioni. Premesso che è pacifica l’applicabilità della legge ad ogni fine
agli operai, agli impiegati ed ai quadri, si sono poste questioni relativamente ai dirigenti ed ai
funzionari. Quanto ai dirigenti si discuteva se il loro licenziamento fosse computabile al fine di
raggiungere la somma minima di almeno cinque licenziamenti nell’arco di 120 giorni. In dottrina
prevaleva l’opinione negativa. Sul tema però la Corte di giustizia UE ha ritenuto la normativa
interna non conforme alla direttiva 98/59/CE proprio nella parte in cui non estende ai dirigenti il
sistema di tutele prefigurato a livello europeo. In seguito è intervenuto il legislatore con la legge
30/10/2014 n. 161 introducendo il comma 1-quinques all’art. 24 della l. 223/91. Oggi quindi se il
datore ha l’intenzione di procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, dovrà dar corso alle
procedure di cui all’art. 4 della legge, con la particolarità che all’esame della posizione dei dirigenti
si deve procedere in appositi incontri. Sul piano sanzionatorio sia le violazioni procedurali che la
142
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
violazione dei criteri di scelta comportano l’applicabilità di una tutela economica. Tale disciplina si
applica anche ai datori non imprenditori. Altra questione è quella che attiene alla computabilità dei
dirigenti nel normale organico dell’impresa. Posizioni contrastanti emergono in relazione
all’applicabilità della procedura anche ai funzionari. Bisogna ora interrogarsi sul regime cui sono
sottoposte le imprese che non attingano al limite di quindici dipendenti. La questione ha ragione di
porsi solo se si ritiene che esista una nozione di licenziamento collettivo che si differenzia da quella
di licenziamento individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo. La risposta positiva è oggi
garantita dall’esistenza di una definizione di licenziamento collettivo introdotta dal legislatore. Si
può quindi ritenere che un problema di coordinamento si ponga solo quando nelle piccole imprese il
datore invochi una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro che comporti il licenziamento
di almeno cinque lavoratori. In mancanza del requisito numerico minimo si deve assumere che il
legislatore abbia ricondotto la disciplina a quella prevista dall’art. 3 della l. 604 per i licenziamenti
individuali. Sembra da respingere una posizione che voglia ritenere che la scelta imprenditoriale di
procedere a riduzioni di personale possa risultare libera da vincoli sia sul piano del rispetto dei
requisiti di forma sia su quello del rispetto dei requisiti sostanziali. Sarebbe infatti paradossale una
posizione che assumesse di sottoporre a limiti e controlli il licenziamento individuale di un solo
lavoratore e non quello di dieci lavoratori per cessazione dell’attività. Dal punto di vista sostanziale
non c’è dubbio che la motivazione di procedere a riduzione/trasformazione di attività o lavoro possa
essere controllata in sede giudiziale al solo scopo di verificarne la veridicità. Ove tale verifica abbia
esito negativo, il licenziamento collettivo dovrebbe essere valutato dal giudice come un recesso
individuale privo di giustificazione. L’applicabilità della tutela obbligatoria sarebbe poi
conseguenziale alla declaratoria di illegittimità del recesso. La soluzione prospettata consente di
rispettare la lettera dell’art. 24 della legge n. 223. Nulla impedisce di ritenere che possa ugualmente
valorizzarsi il prototipo normativo del licenziamento collettivo.
18. La legge affida ad una rete procedimentale preventiva la tutela degli interessi dei lavoratori
coinvolti nella riduzione di personale. È necessaria una comunicazione scritta alle rappresentanze
sindacali aziendali (r.s.a.) costituite ai sensi dell’art. 19 dello statuto nonché alle rispettive
associazioni di categoria. La presenza dell’associazione di categoria è solo eventuale. La questione
di maggior spessore è quella di individuare i soggetti sindacali titolari del diritto di informazione e
trattativa. Non c’è dubbio che le rappresentanze sindacali unitarie (r.s.u.) siano subentrate nelle
prerogative della r.s.a. e dunque la trattativa è espletata dal datore con tali nuovi organismi. Il
carattere unitario delle r.s.u. assorbe l’eventuale dubbio che possa scaturire dalla partecipazione a
tale organismo di lavoratori eletti nel contesto di liste promosse da sindacati che non avrebbero
avuto titolo a costituire le r.s.a. In mancanza delle rappresentanze la comunicazione andrà fatta alle
associazioni di categoria. La comunicazione deve contenere l’indicazione dei motivi che
determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici organizzativi o produttivi; l’indicazione
del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente. Deve
inoltre contenere la comunicazione circa i tempi di attuazione del programma di mobilità e circa le
eventuali misure per fronteggiare le conseguenze sociali. Il Governo ha emanato il d.lgs.
26/05/1997 n. 151, sull’attuazione della Direttiva 92/56/CE, introducendo ulteriori vincoli
procedurali. È stato visto qualora la riduzione sia inevitabile, è esaminata la possibilità di ricorrere a
misure sociali di accompagnamento intese a facilitare la riqualificazione e riconversione dei
lavoratori licenziati. La nuova previsione non sembra modificare il quadro precedente. Con
l’inserimento del comma 15-bis all’art. 4, si è inteso rafforzare l’obbligo datoriale di informazione e
consultazione anche nelle imprese societarie a struttura complessa. Della comunicazione viene
altresì investita la pubblica amministrazione attraverso l’invio di questa alla Direzione territoriale
del lavoro. Alla comunicazione il datore deve allegare copia del versamento all’INPS di una parte di
143
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
quanto corrispondente al trattamento di mobilità che verrà erogato al lavoratore. la comunicazione
costituisce l’atto di avvio del procedimento di consultazione sindacale. Nel fornire le informazioni il
datore deve rispettare le clausole generali della buona fede e correttezza ed avere un contenuto di
concretezza. Il licenziamento è inefficace sia in caso di violazione degli obblighi di informazione,
sia in caso di omessa o generica indicazione dei motivi dell’eccedenza o dei motivi ostativi al
ricorso a misure alternative. La giurisprudenza ritiene che le incompletezze delle informazioni
possano essere sanate nel corso delle trattative con l’intervento del sindacato. Tale acquisizione è
stata confermata dal legislatore che ha previsto che gli eventuali vizi della comunicazione possono
essere sanati nell’ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di
licenziamento collettivo. La legge pone un termine di 45 giorni entro il quale deve esaurirsi la
procedura sindacale. L’apertura delle consultazioni davanti all’ufficio del lavoro è peraltro solo
eventuale. È onere dell’impresa rendere edotta la pubblica amministrazione circa i risultati della
consultazione e i motivi di un eventuale esito negativo. Successivamente il direttore dell’ufficio
territoriale del lavoro, in caso di esito negativo, deve convocare le parti per un ulteriore tentativo.
Anche per tale esame è previsto un termine di 30 giorni. Tutti i termini sono ridotti alla metà se il
numero dei lavoratori interessati è inferiore a 10. Raggiunto l’accordo l’impresa può procedere al
licenziamento collettivo. Il datore dovrà comunicare il recesso per iscritto a ciascun lavoratore e
comunicare alla DTL l’elenco dei lavoratori in mobilità, con la puntuale indicazione delle modalità
con le quali sono stati applicati i criteri di scelta. La violazione di questo obbligo comporta
l’inefficacia del licenziamento. L’affermazione è stata oggetto di un contrasto nell’ambito della
giurisprudenza, al cui interno vi era l’esistenza di un filone che riteneva che l’omessa
comunicazione alla DTL dell’elenco dei lavoratori licenziati non incideva sulla validità ed efficacia
del licenziamento, ma avrebbe solo determinato un’azione di risarcimento dei danni. Il contrasto si
è risolto con due interventi delle Sezioni Unite che hanno affermato l’inefficacia del licenziamento
in caso di violazione degli obblighi di comunicazione finali. Non è chiaro se debba ritenersi
applicabile a tale specie la tutela indennitaria forte. Esaurita la procedura i lavoratori sono collocati
in mobilità. La collocazione in mobilità produce una serie di effetti. Essa dà titolo alla
corresponsione dell’indennità di mobilità. Inoltre i lavoratori interessati sono destinatari di una
disciplina privilegiata diretta a promuovere la loro collocazione al lavoro. Vengono infatti iscritti in
una lista di mobilità. Fra le principali agevolazioni: a) il diritto di precedenza nelle riassunzioni
dell’imprese che li ha licenziati; b) la possibilità per i datori di assumere i lavori in mobilità con
contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi; c) l’incentivazione all’assunzione, per il
tramite di benefici alle imprese. L’iscrizione nelle liste di mobilità è prevista anche per i lavoratori
che non abbiano diritto all’indennità di mobilità. Tale beneficio previsto con norma a termine è stato
poi prorogato. La cancellazione dalle liste avviene alla scadenza del periodo massimo per il quale è
prevista la corresponsione dell’indennità o nel caso in cui il lavoratore non rispetti gli obblighi
previsti dalla legge. La riforma Monti ha inciso sugli “ammortizzatori sociali” e a farne le spese è
stata anche l’indennità di mobilità. L’idea di fondo è quella di unificare i trattamenti all’interno di
un unico trattamento generale di disoccupazione (ASPI). Il governo peraltro si è reso conto delle
conseguenze che l’abolizione immediata avrebbe comportato ed ha scelto una soluzione, rinviando
l’abolizione delle prestazioni ritenute privilegiate al 01/01/2017. Si prevede perciò l’abolizione
delle norme della l. n. 223/1991 che alludono alla collocazione del lavoratore in mobilità. A regime
quindi la legge 223/91 regolerà la sola procedura di licenziamento collettivo, venendo i lavoratori
licenziati inseriti nel circuito generale dell’ASPI. Si prevede una disciplina transitoria che procederà
ad un depotenziamento dell’indennità di mobilità, fino alla definitiva cessazione al 31/12/2016.
19. La scelta del legislatore di affidare la mediazione del conflitto connesso alle riduzioni di
personale ad una gestione intersindacale ripropone delle perplessità. Ci si è chiesti se fosse corretta
144
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
l’opzione di affidare anche alle r.s.a. la competenza negoziale anche per la determinazione in via
contrattuale dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Un minimo di coerenza sistematica
postula che si risponda positivamente. Più in generale è da chiedersi quale debba essere l’efficacia
dell’accordo. Le risposte non sono univoche. Un contributo è venuto dalla Corte costituzionale che,
con la sentenza 22/06/1994 n. 268, ha dichiarato l’infondatezza della questione di costituzionalità
dell’art. 5 comma 1 della legge nella parte in cui prevede che un accordo sindacale possa
determinare criteri di scelta dei lavoratori da licenziare diversi da quelli stabiliti dalla legge. Ha
osservato che la legge avrebbe attribuito alla contrattazione collettiva il potere di contribuire a
procedimentalizzare i poteri unilaterali del datore. Quanto al contenuto dell’accordo si è osservato
che deve prevedere criteri astratti di individuazione del personale esuberante. La sottoscrizione
dell’accordo non rende perciò solo legittimi i licenziamenti e quindi su di esso può aver corso il
controllo del giudice. La sottoscrizione costituisce peraltro una presunzione della sussistenza dei
presupposti di fatto, nonché della congruenza delle ricadute sul personale. Secondo la
giurisprudenza corrente fino alla l. 92/2012 l’accordo sindacale non sostituirebbe il mancato
espletamento della procedura né consentirebbe lo stravolgimento della stessa. Tale conclusione va
oggi misurata con la previsione dell’effetto sanante dei vizi procedurali che produce la
sottoscrizione dell’accordo. Di rilievo è la previsione secondo cui gli accordi sindacali stipulati nel
corso delle procedure che prevedano il riassorbimento dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono
stabilire l’assegnazione di questi ultimi anche a mansioni diverse, anche in deroga all’art. 2103 c.c.
20. L’art. 24 estende ai licenziamenti collettivi l’obbligo altresì di selezionare i lavoratori
esuberanti, in relazione alle esigenze, rispettando dei criteri di scelta la cui fonte di determinazione
viene rimessa ai contratti collettivi stipulati con le associazioni sindacali di categoria. Tali criteri
rieditano nella sostanza quelli previsti dagli accordi interconfederali in materia e cioè: a) carichi di
famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative. Si prevede poi che possano
essere altresì inseriti gli invalidi. Il legislatore ha sancito il principio di sussidiarietà dei criteri legali
rispetto a quelli contrattuali e che tale previsione va ritenuta conforme ai principi costituzionali.
Quanto alla fonte negoziale abilitata all’elaborazione dei criteri è ragionevole l’opinione
universalistica, di determinazione ad ogni livello contrattuale. Quanto ai criteri legali resta la
questione dell’applicazione dei medesimi in concorso fra loro. Secondo la giurisprudenza del
precedente sistema era necessaria una valutazione complessiva, anche se si considerava in generale
legittima la priorità delle esigenze tecniche e produttive. A mitigare l’affermazione si soggiungeva
che la priorità di questo criterio non poteva essere arbitraria e immotivata dovendo trovare
giustificazione in fattori obiettivi. Nella giurisprudenza dopo la legge 223 convivono affermazioni
contrastanti. Un limite esterno al potere datoriale di ridurre il personale è posto dal divieto dei
licenziamenti discriminatori. In materia, il legislatore ha affiancato al d.lgs. 198/2006 una serie di
limiti specifici, previsti per le vicende di riduzione di personale. Con la legge 236/1993 si è inserito
un altro periodo nel comma 2 dell’art. 5 della legge n. 223 che afferma che l’impresa non può
collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di
manodopera femminile presa in considerazione. Nella giurisprudenza più recente si è aperta una
discussione intorno alla legittimità dell’adozione del criterio di scelta della maggiore prossimità del
lavoratore al pensionamento. L’adozione del criterio ha una sua razionalità se si pensa che tende a
licenziare i soggetti che possono contare su un reddito alternativo a quello garantito dall’attività
lavorativa. Nella giurisprudenza della Cassazione c’è l’affermazione della legittimità del ricorso al
criterio in questione. In quella di merito si prospetta qualche voce dissenziente, che ritiene nullo il
licenziamento collettivo quando il criterio sia prefigurato come unico.
145
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
21. La legge n. 223 delinea un quadro delle conseguenze del licenziamento collettivo illegittimo. La
riforma Monti ha armonizzato il sistema sanzionatorio relativo ai licenziamenti collettivi con il
nuovo assetto previsto per quelli individuati nell’ambito della tutela reale, distinguendo tre
situazioni:
1. nel caso in cui il licenziamento collettivo sia intimato senza l’osservanza della forma scritta
si applica la tutela reale in senso pieno;
2. nel caso di violazione delle procedure si applica la tutela indennitaria forte;
3. in caso di violazione dei criteri di scelta si applica il regime di tutela reale attenuata.
Fa da contraltare alla ricostruzione del rapporto nei confronti del lavoratore la valorizzazione
dell’interesse de datore del potere di licenziare un numero di unità pari a quelle che abbiano
ottenuto la reintegrazione nel posto: il repêchage. Sul piano processuale ciò comporta che il gruppo
di lavoratori avrà un puntuale interesse a partecipare al giudizio. Uno sconto è riconosciuto dal
d.lgs. 110/2004 che ha esonerato dall’obbligo di reintegrazione i datori non imprenditori che
svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione o di culto/religione,
assoggettandoli alla sola tutela obbligatoria. Un’interpretazione potrebbe giungere a ritenere che
nessuna sanzione viene riconnessa sulla scelta in sé una volta che siano state rispettate le forme
esterne del licenziamento. In effetti questa è un’opinione più diffusa. Ad essa potrebbe contrapporsi
una prospettiva in cui si postula un controllo sull’effettività della scelta imprenditoriale,
argomentando dalla necessità che vengano giustificati dal punto di vista oggettivo i singoli atti di
recesso o ragionando in termini di controllo causale sull’atto datoriale di gestione dell’impresa. Tale
ultima conclusione va misurata con il nuovo atteggiamento che emerge dalla riforma Monti. È
innegabile che si dovrebbe giungere alla conclusione che solo l’ipotesi della manifesta insussistenza
delle ragioni poste a base della riduzione di personale potrebbe condurre all’applicabilità della
tutela reale attenuata. Va considerato l’affievolimento dell’apparato sanzionatorio che ora contempla
la tutela reale piena solo con riferimento alla totale omissione della forma scritta. Il nuovo assetto
dato alla materia dei licenziamenti dalla riforma del 2012 fa propendere l’opinione nella direzione
di considerare sostanzialmente insindacabile la scelta in sé di ridurre la dimensione dell’impresa.
22. La materia dei licenziamenti collettivi viveva una scissione che l’attraversava trasversalmente,
anche per quanto riguardava la contrapposizione fra le posizioni giurisprudenziali e quelle
dottrinarie. Nel quadro delineato dalla dottrina aveva perduto ogni ragion d’essere la precedente
istanza di distinzione tra licenziamento individuale e licenziamento collettivo. Questa linea di
pensiero è confermata dalla l. n. 223 e non ha subito smentite dalle modifiche introdotte al sistema
dei licenziamenti dalla l. 92/2012. Si può dire che, nel momento stesso in cui il legislatore ha
introdotto una definizione per identificare i connotati per il licenziamento per riduzione del
personale, ha allo stesso tempo sancito l’irrilevanza della distinzione fra licenziamenti collettivi e
licenziamenti individuali. Sul piano strutturale nessuno aveva mai dubitato che il licenziamento
fosse sempre e comunque un atto individuale nella sfera del lavoratore. Tant’è vero che veniva
riconosciuto un tale grado di elasticità alla fattispecie del licenziamento collettivo, da indurre ad un
ritorno alle regole del licenziamento individuale tutte, tutte le volte in cui non ci fosse
corrispondenza fra il concreto recesso e la fattispecie definita sul piano della legge/contratto.
Sennonché la necessità della distinzione non può che venir meno quando il legislatore estende al
licenziamento collettivo il medesimo regime sanzionatorio previsto per il licenziamento individuale
illegittimo. La struttura delle due fattispecie è in sostanza identica. Il licenziamento collettivo
diviene in tale nuovo sistema nient’altro che una nuova ipotesi di licenziamento giustificato che va
ad affiancarsi a quelle già esistenti.
146
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
23. Con le modifiche introdotte nel corpo del fondamentale d.lgs. 29/93 ad opera del d.lgs. 80/98, la
materia delle eccedenze di personale nel pubblico impiego ha ricevuto una regolamentazione simile
a quella in atto nel settore privato. La materia è stata rivisitata dalla l. 183/2011, che ha riscritto
l’art. 33 del d.lgs. 165/2001. Secondo tale disposizione le pubbliche amministrazioni che hanno
situazioni di soprannumero o eccedenze, sono tenute a dare un’informativa preventiva alle
rappresentanze sindacali unitarie e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo
nazionale del comparto o area. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione, l’amministrazione
colloca a riposo il personale esuberante o verifica la ricollocazione del personale in soprannumero.
Si prevede anche che la materia possa essere regolata dai contratti collettivi nazionali, i quali
possono stabilire criteri e procedure per consentire la gestione delle eccedenze attraverso il
passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale. Trascorsi novanta
giorni dalla comunicazione di avvio procedure, l’amministrazione colloca in disponibilità il restante
personale: il che comporta la sospensione delle obbligazioni relative al rapporto di lavoro e il
lavoratore ha diritto a un’indennità pari all’80% dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale,
per la durata massima di ventiquattro mesi, trascorsi i quali il rapporto si risolve. Si prevede infine
che la mancata attivazione delle procedure da parte del responsabile è valutabile a fini disciplinari.
Il personale in disponibilità è collocato in un apposito elenco. La p.a. prima di procedere
all’indizione di nuovi concorsi per l’assunzione deve verificare l’impossibilità di ricollocare il
personale in disponibilità.
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
24. Fin dai primi del secolo si andò diffondendo la prassi di erogare ai lavoratori, all’atto della
cessazione del rapporto, una somma di entità proporzionale all’anzianità di servizio. Essa era
codificata dapprima con l’art. 4 del r.d.lgt. 09/02/1919 n. 112 e finalmente con l’art. 10 della legge
sull’impiego privato del 1924 che ne estese l’erogazione a favore dei soli impiegati. In tale ambito
era dovuta in caso di cessazione del rapporto non riconducibile a dimissioni o a giusta causa di
licenziamento. Il codice civile del 1942 generalizzò l’erogazione dell’indennità, che mutò
denominazione in quella di “indennità di anzianità”. L’art. 2120 prevedeva che dovesse essere
proporzionale agli anni di servizio, mantenendo l’esclusione in caso di licenziamento per colpa del
lavoratore e di dimissioni volontarie. La determinazione del suo ammontare era delegata alla
contrattazione collettiva stessa, sulla base di due parametri: l’ultima retribuzione e la categoria di
appartenenza del lavoratore. L’art. 2121 individuava poi gli elementi retributivi di computo
dell’indennità. Con la l. 1561/1960 si previde che la quota minima della retribuzione da moltiplicare
per gli anni di servizio avrebbe dovuto corrispondere ad una mensilità. Con l’art. 9 della l. 604/1966
fu prevista un’estensione dell’indennità di anzianità in ogni caso di cessazione del rapporto di
lavoro. Si raggiunse un sufficiente consenso che acquisì natura retributiva, spettando
necessariamente all’atto della cessazione del rapporto, e funzione previdenziale. Negli anni settanta
l’indennità venne coinvolta nella politica legislativa diretta a limitare il costo del lavoro. Fu
accusata di costituire un automatismo composto. Sotto questo profilo si previde la sterilizzazione
degli scatti di contingenza successivi al 01/02/1977, nella retribuzione imponibile. Furono così
emanati dei provvedimenti limitativi degli effetti degli automatismi retributivi sull’indennità di
anzianità. Una riforma dell’istituto si rendeva necessaria per almeno altre due motivazioni: a) le
difformità e le sperequazioni di trattamento fra categorie di lavoratori; b) l’ostacolo indotto
dall’indennità di anzianità alla mobilità dei lavoratori, i quali avevano interesse a non frazionarla.
Infatti essa era tanto più vantaggiosa, quanto più lunga fosse l’anzianità di servizio maturata presso
lo stesso datore, posto che il moltiplicatore era costituito dall’ultima retribuzione, usualmente più
alta alla fine della carriera lavorativa.
147
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
25. La riforma dell’istituto che muta denominazione passando a quella di trattamento di fine
rapporto (TFR) ha avuto luogo con la legge 29/05/1982 n. 297, le cui norme si collocano all’interno
del codice civile. La legge si pone come una disciplina di ordine pubblico economico, dal momento
che sancisce il divieto per la contrattazione collettiva di statuire condizioni diverse per la materia
del TFR: sono infatti nulle tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del
trattamento di fine rapporto. Una delle innovazioni più significative concerne le modalità di calcolo
del trattamento. La legge introduce un meccanismo consistente nell’accantonare anno per anno una
somma corrispondente alla retribuzione goduta dal lavoratore, che viene periodicamente rivalutata
secondo determinati coefficienti. Si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari
all’importo della retribuzione annua divisa per 13,5. La retribuzione annua ricomprende tutte le
somme corrisposte in dipendenza del rapporto, a titolo non occasionale. Vi è dunque una
considerazione causale del compenso. In relazione alla nozione di continuità la giurisprudenza
ritiene che sia computabile anche il compenso percepito per il lavoro straordinario. Discussa è la
computabilità dei trattamenti corrisposti per la prestazione svolta dal lavoratore all’estero. Il
trattamento annuo così determinato ed accantonato va poi indicizzato. Il che si realizza attraverso
un incremento, su base composta, alla fine di ogni anno, corrispondente ad un 1,5% in misura fissa
e ad un 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
accertato dall’ISTAT. Ogni anno viene rivalutata sia la base capitale che l’entità dell’incremento. Il
meccanismo della rivalutazione assume come linea di discrimine un’inflazione del 6%, cosicché al
di sopra di tale soglia si ha un recupero parziale dell’aumento del costo della vita, mentre al di sotto
si ha un rendimento superiore al costo della vita. La determinazione del TFR riflette puntualmente
la carriera retributiva ed è indifferente al suo eventuale frazionamento. L’accantonamento ha anche
luogo nelle ipotesi di sospensione del rapporto. Un’importante innovazione è contenuta nella l.
297/1982 e riguarda la possibilità di ottenere anticipazioni sul TFR. Il lavoratore con almeno otto
anni di servizio presso lo stesso datore può chiedere un’anticipazione non superiore al 70% sul
trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data richiesta. Il datore è
tenuto a soddisfare le richieste entro il limite del 10% degli aventi titolo. Il lavoratore è onerato di
giustificare la richiesta allegando la necessità di spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche o per l’acquisto della prima casa di abitazione per
sé o per i figli. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto ed è detratta
dal TFR dovuto all’atto della cessazione. La seconda innovazione è costituita dall’istituzione presso
l’INPS di un Fondo garanzia per il trattamento di fine rapporto, con lo scopo di sostituirsi al datore
insolvente nel pagamento della relativa somma. La sostituzione del Fondo avviene: 1) rispetto al
fallimento, dopo il deposito dello stato passivo o dopo la pubblicazione della sentenza di cui all’art.
99 della legge fallimentare; 2) rispetto al concordato preventivo dopo la pubblicazione della
sentenza di omologazione; 3) rispetto alla liquidazione coatta amministrativa dopo il deposito dello
stato passivo. Il regime sostitutivo del Fondo trova poi applicazione anche nei confronti delle
piccole imprese. In tale contesto l’intervento può aver luogo solo dopo che siano stati esperiti tutti i
rimedi esecutivi nei confronti dei beni del datore ed essi siano risultati in tutto o in parte
insufficienti. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio
spettante sul patrimonio dei datori. L’istituzione del Fondo ha lo scopo di far accollare alla
collettività i rischi dell’insolvenza del datore nel pagamento del TFR. Secondo l’art. 2122 c.c., in
caso di morte del prestatore di lavoro, l’indennità di mancato preavviso e il TFR devono
corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivono a carico del prestatore, ai parenti entro il terzo grado
e agli affini fino al secondo. La ripartizione delle indennità deve farsi sulla base del criterio del
bisogno, se non c’è accordo fra le parti. In mancanza delle persone indicate sono attribuite secondo
le norme della successione legittima. La Corte costituzionale, con la sentenza 8/72, ha dichiarato
148
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
illegittima quest’ultima previsione nella parte in cui esclude che, in mancanza di soggetti indicati, il
lavoratore possa disporre per testamento delle indennità stesse. La legge inoltre considera nullo ogni
patto anteriore alla morte del lavoratore. Il trattamento di fine rapporto è al centro del dibattito
intorno alla previdenza complementare o integrativa. Il nesso fra trattamento di fine rapporto è già
contenuto nell’art. 2123 c.c., secondo cui il datore che ha compiuto volontariamente atti di
previdenza può dedurre dalle somme dovute quanto il lavoratore ha diritto di percepire per effetto
degli atti medesimi. In sostanza le somme dovute per l’indennità di fine rapporto possono essere
surrogate da analoghe forme di previdenza erogate volontariamente dal datore o regolate attraverso
la contrattazione collettiva. Nel cinquantennio post-codicistico sono stati costituiti fondi
pensionistici aziendali, diretti ad assicurare ai lavoratori un trattamento pensionistico integrativo di
quello obbligatoriamente dovuto dall’INPS o un’integrazione del TFR o altre forme di previdenza
volontaria. Negli anni novanta il legislatore ha ritenuto essenziale procedere ad una
regolamentazione generale della previdenza complementare, cui ha affidato il ruolo di assicurare
più elevati livelli di copertura previdenziale. La disciplina di base, contenuta nel d.lgs. 21/04/1993
n. 124, è stata poi rivisitata con il d.lgs. 05/12/2005 n. 252 e parzialmente emendata con la l.
finanziaria del 2006 (l. 296/2006). Possiamo ricordare che i fondi possono essere istituiti dalla
contrattazione collettiva o tramite accordi fra i lavoratori. È prevista la possibilità di adesione a
fondi aperti sia in forza di disposizioni della contrattazione collettiva sia per il tramite di forme
pensionistiche individuali. Si prevede che il finanziamento dei fondi pensione ricada anche sul
datore, sulla base di una contribuzione determinata dalle fonti istitutive nonché attraverso la
destinazione volontaria del TFR. A decorrere dal 01/01/2007 i lavoratori hanno esercitato la loro
opzione diretta a trasferirlo al fondo aziendale ovvero a mantenerlo presso il datore. Tale opzione
per legge poteva aver corso o in forma esplicita o tacita. Resta fermo che, ove manchi l’accordo fra
le parti o non esista un fondo aziendale, il TFR dovrà confluire in una forma pensionistica di
carattere residuale gestita dall’INPS. Con un’ulteriore previsione contenuta nella legge di stabilità
del 2015 è prevista per i lavoratori la possibilità di percepire quota di TFR in via di maturazione
direttamente come parte integrativa della retribuzione mensile, purché il rapporto di lavoro abbia
corso da almeno sei mesi. La disciplina viene introdotta in via sperimentale per il triennio 2015-
2018. Il TFR, che costituiva una forma di auto-finanziamento a basso costo per i datori, si trasforma
in una fonte di finanziamento di attività di pubblico interesse.
26. La l. 297/1982 non trova applicazione nei confronti del pubblico impiego. La materia è ora
regolata dall’art. 2 comma 5, 6, 7 e 8 della l. 335/1995 di riforma del sistema pensionistico, che
prevede che i trattamenti di fine servizio sono regolati sulla base delle disposizioni dell’art. 2120
c.c. per i lavoratori assunti dal 01/01/1996. La contrattazione collettiva è delegata a definire le
modalità di attuazione di tale previsione. Sempre la contrattazione collettiva dovrà definire le
modalità di estensione e applicazione del TFR privatistico anche nei confronti dei lavoratori già
occupati alla data del 31/12/1995. Come punti fermi restano: a) la titolarità dell’erogazione dei
trattamenti in capo all’ente o amministrazione che in precedenza erogava l’indennità di fine lavoro;
b) l’inestensibilità al pubblico impiego privatizzato delle disposizioni sul Fondo di solidarietà. Le
difficoltà nell’attuare un’omogeneizzazione dei trattamenti derivano dalla coesistenza di varie
forme di indennità di fine lavoro nei diversi settori del pubblico impiego. La l. 335/1995 corona un
progressivo avvicinamento fra le varie indennità nel pubblico impiego. Passaggi rilevanti sono stati:
a) la declaratoria di incostituzionalità delle norme riguardanti le indennità di fine rapporto nel
pubblico impiego, per la parte in cui non prevedevano tecniche di indicizzazione paragonabili a
quella del TFR; b) il progressivo riconoscimento della natura retributiva delle indennità in
questione; c) la riconduzione delle relative controversie al giudice del rapporto; d)
l’omogeneizzazione dei trattamenti INADEL ed ENPAS, quanto alle basi di calcolo. Nel processo
149
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
di avvicinamento dei due sistemi si inserisce anche la l. 87/1994 che detta regole per omogeneizzare
il computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione delle indennità di buonuscita dei
pubblici dipendenti.
Capitolo quarto: MERCATO DEL LAVORO E OCCUPAZIONE
Sezione I: INTRODUZIONE
1. La Carta Costituzionale annovera fra i diritti fondamentali il diritto del lavoro (art. 4), il quale è
predicato in una duplice dimensione. Da una parte c’è un significato statico o passivo. Nell’art. 4
comma 2 si vede lo Stato impegnato a non porre in essere discipline giuridiche che limitino la
possibilità per i cittadini di svolgere attività conformi alle proprie possibilità e alle proprie scelte.
Nel contempo il lavoro è configurato come un dovere di svolgere un’attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società. Il diritto del lavoro acquisisce dunque il
significato di un diritto di libertà da o contro intrusioni dello Stato nella sfera dell’individuo. La
seconda parte del comma 1 dell’art. 4 Cost. illustra invece il versante sociale del diritto del lavoro:
impegna la Repubblica a promuovere le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Si tratta di
un programma diretto ad orientare l’intervento statale nell’economia verso attività ad alto impiego
del lavoro o a garantire idonei strumenti di sostegno nelle fasi di non-lavoro. È necessario operare
ulteriori distinzioni: ad esempio, di disoccupazione e di intervento stabile nei confronti della
disoccupazione, si può parlare in diverse accezioni. Se il termine allude alla mancanza di lavoro e se
è meritevole di sostegno solo quella involontaria, è indiscutibile che esistono varie species dello
stesso genus. Vi è infatti lo stato di disoccupazione di chi non è mai entrato nel mercato del lavoro
(disoccupazione giovanile) e vi è la situazione di chi essendovi entrato ne è stato espulso. Quanto a
quest’ultima è rilevantissimo differenziare il contesto nel quale è avvenuta la perdita del posto di
lavoro. Vengono messe in luce le notevoli aporie delle strumentazioni predisposte per le due species
di disoccupazione e le marcate disparità di trattamento dei lavoratori rispetto al medesimo bisogno
risultante dall’intreccio fra le varie forme di intervento pubblico. È si vero che esiste nel sistema un
rimedio generale assicurativo, ma esso non è solo inapplicabile nei confronti di chi non sia mai stato
occupato, ma è erogato in misura tale da non soddisfare le esigenze di vita del destinatario sia pure
per periodi limitati nel tempo. Nemmeno occorre dimenticare che la materia di cui si discute è
fortemente condizionata dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Il nostro Paese non può
più decidere liberamente in quale direzione orientare il sostegno pubblico alle imprese per garantire
l’occupazione. Ne viene così ridimensionata la politica industriale diretta a sostenere con il
finanziamento statale imprese produttive, che rischia di porsi in contrasto con il divieto di assicurare
specifici vantaggi ingiustificati e differenziali a talune categorie imprenditoriali. Di qui
l’indispensabilità di un coordinamento fra le politiche nazionali e quelle europee. È per l’insieme
delle descritte ragioni che quella dell’intervento statuale sul mercato del lavoro costituisce una
materia cruciale del diritto del lavoro. Le caratteristiche della nuova economia impongono al diritto
del lavoro di spostare il baricentro della tradizionale rete protettiva a favore del lavoratore proprio
sul terreno del mercato del lavoro. Vedremo come, a partire dal 2012, i governi si siano impegnati
con l’obiettivo di costruire una forma di provvidenza unica, nel contesto di una più generale
protezione del lavoratore nel mercato più che nel rapporto di lavoro. Il tutto in un contesto nel quale
si vorrebbe limitare al minimo la condizione di disoccupazione.
Sezione II: LA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
150
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
1. Un’altra questione è quella delle strumentazioni predisposte dallo stato per promuovere
l’occupazione giovanile o combattere l’inoccupazione, lo stato cioè in cui si trova chi non è mai
entrato nel circuito lavorativo. La questione si intreccia con il tema della formazione professionale,
la cui promozione costituisce un impegno specifico della Repubblica e la cui gestione rientra fra le
competenze esclusive regionali. Il nesso tra formazione professionale e tutela contro la
disoccupazione è reso manifesto già con l’entrata in vigore della Costituzione delle previsioni
contenute nella l. n. 264/1949 che conteneva un titolo dedicato all’addestramento professionale, con
la prefigurazione di corsi per disoccupati, corsi aziendali di riqualificazione e cantieri scuola. Negli
anni settanta la materia della formazione professionale entra a pieno titolo entro la competenza
normativa regionale. È di quegli anni la legge-quadro sulla formazione professionale: l. 21/12/1978
n. 845. La legge si preoccupa: a) di regolare i confini fra le competenze di stato e regione, b) di
impartire disposizioni generali sull’organizzazione dell’attività e sulla loro tipologia, c) di regolare i
diritti degli studenti, d) di definire gli ambiti della formazione, coordinando quella statale, quella
regionale e quella autonoma del sistema delle imprese. Contemporaneamente matura la
consapevolezza che la formazione professionale può e deve svolgere il ruolo di strumento di
politica attiva del lavoro, diretta ad incentivare l’assunzione di giovani. Quella dell’occupazione
giovanile si segnala come una delle emergenze cui deve far fronte il diritto del lavoro. Si spiega
perciò la variegata tipologia di contratti che coniugano in varia misura il lavoro e la formazione che
si susseguono nella legislazione lavoristica a partire dal prototipo elaborato nella l. 285/1977,
nonché le forme di incentivazione all’assunzione di giovani. Un tentativo di risistemazione della
materia della formazione professionale è contenuto nell’art. 17 della l. 196/1997. La norma
ricapitola una serie di principi che dovrebbero essere ritradotti in norme di natura regolamentare
costituenti la prima fase di un processo di riforma della disciplina in materia. La finalità del
legislatore è quella di assicurare ai lavoratori opportunità di formazione professionale, attraverso
l’integrazione fra sistema scolastico e mondo del lavoro. Gli scopi della formazione sono
individuati sia nel miglioramento della qualità dell’apporto lavorativo, che nell’elevazione delle
capacità competitive del sistema produttivo e nell’incremento dell’occupazione. Gli strumenti
utilizzati sono: a) il ricorso agli stages, per realizzare un raccordo tra formazione e lavoro, b) lo
svolgimento di attività di formazione da parte delle regioni e/o province, c) la destinazione delle
risorse economiche agli interventi di formazione nell’ambito di piani formativi concordati fra le
parti sociali.
1.1. Il tradizionale modo di connettere occupazione giovanile e formazione è il contratto di
apprendistato. La figura del moderno apprendista discende da quella del laborans che operava nella
bottega artigiana e che versava al maestro un compenso per gli insegnamenti ottenuti.
L’industrialismo produce un rovesciamento della prospettiva tradizionale, facendo divenire
l’apprendista un lavoratore come gli altri. Di qui il diritto alla retribuzione. Fin dalle origini
l’apprendistato si caratterizza come un rapporto in cui alla formazione si perviene attraverso lo
svolgimento dell’attività lavorativa. È acquisita la qualificazione del contratto di apprendistato
come contratto speciale a causa mista, in cui convivono lo scambio lavoro/retribuzione e il parallelo
scambio lavoro/istruzione formativa. La disciplina giuridica sul contratto di apprendistato ha trovato
collocazione nel codice civile e nella fondamentale legge 19/01/1955 n. 25. Negli anni sessanta il
legislatore ha ritenuto opportuno intervenire allo scopo di attenuare gli abusi nell’impiego
dell’apprendistato, utilizzato spesso per fruire di manodopera a più basso costo, con la l. 02/04/1968
n. 424, con cui sono stati posti limiti al numero massimo di apprendisti assumibili. L’introduzione
nell’ordinamento della nuova tipologia dei contratti di formazione e lavoro ha provocato una crisi
dell’apprendistato, alla quale si è tentato di sopperire con l’art. 21 della l. 28/02/1987 n. 56.
Ulteriori innovazioni sono state introdotte con l’art. 16 della l. 196/1997. La materia è stata oggetto
151
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
dell’attenzione del d.lgs. 276/2003, che ha introdotto alcune modifiche. Con l’art. 1 comma 33 della
l. 247/2007, il governo è stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi diretti al riordino
delle norme nell’apprendistato. Alla delega è stato dato corso con il d.lgs. 14/09/2011 n. 167. Tale
ultimo provvedimento è caduto sotto la mannaia del furore riformistico renziano; il decreto
legislativo del 2011 è stato infatti abrogato ad opera dell’art. 55 del d.lgs. 81/2015. Sembra
discutibile la scelta di collocare la regolamentazione dell’apprendistato in un contesto normativo
diretto a fornire una disciplina dei contratti di lavoro, così accreditando l’idea che esso costituisca
una delle tipologie di accesso al mondo del lavoro e mettendo in ombra l’essenziale funzione
formativa dell’apprendistato. Anche il decreto legislativo del 2015 conferma il tratto caratterizzante
che attiene ad una sostanziale delegificazione della disciplina dell’apprendistato ed al rafforzamento
del rapporto fra apprendistato e formazione. L’apprendistato è definito come un contratto di lavoro a
tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all’occupazione dei giovani. L’idea che debba
fornire un supporto all’occupazione è discutibile. Ma altrettanto discutibile che esso costituisca una
species del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o si inserisca come una parentesi entro il
rapporto a tempo indeterminato in caso di inserimento dell’apprendista nell’impresa al termine del
periodo. La previsione di un termine massimo di durata avrebbe dovuto comportare il suo
inserimento all’interno dello schema generale del rapporto di lavoro a tempo determinato. Vengono
delineati tre sottotipi:
a) l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) l’apprendistato di alta formazione e ricerca.
Trascurando il terzo modello, è evidente che il primo rende percepibile il nesso tra formazione e
lavoro, mentre il secondo rappresenta l’evoluzione del modello tradizionale dell’apprendistato
diretto a conseguire una qualificazione. La regolamentazione è distinta in una disciplina generale e
in una serie di regole specifiche per ogni sottotipo. Quanto alla disciplina generale c’è una
ripartizione di competenze fra legge e contrattazione collettiva. La legge fissa il principio della
necessaria stipulazione per iscritto del contratto. Esso deve contenere il piano formativo individuale.
Il contratto ha una durata minima non inferiore a sei mesi. Quanto alla cessazione del rapporto, si
conferma il principio secondo cui durante il corso del contratto di apprendistato si applica la
disciplina generale in materia di licenziamenti. Al termine del periodo di apprendistato le parti
riacquistano la facoltà di recedere ad nutum dal contratto ex art. 2118 c.c., con preavviso dalla
scadenza del termine e durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina
del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Gli ulteriori aspetti del contratto trovano la
loro fonte nella contrattazione collettiva. I principi cui deve ispirarsi la regolamentazione negoziale
sono però previsti dal legislatore. L’insieme della disciplina di origine legale e di provenienza
contrattuale conferma la natura di contratto a causa mista propria dell’apprendistato. Il numero di
apprendisti che si possono assumere non deve superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze
specializzate e qualificate in servizio; si prevede una deroga per i datori che occupino un numero di
lavoratori inferiore a 10, i quali possono assumere fino al 100% di apprendisti. Il datore che non
abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o che comunque ne abbia in
numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Un ulteriore limite
alla reiterazione di rapporti di apprendistato è previsto con riferimento ai datori che occupino
almeno cinquanta dipendenti. Per costoro l’assunzione di apprendisti è subordinata alla
prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di almeno il 20% degli
152
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
apprendisti. Dal computo della percentuale indicata sono esclusi i rapporti cessati per recesso
durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Se non viene
rispettata la percentuale al datore è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista con contratto
professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione di tali limiti sono considerati lavoratori
subordinati a tempo indeterminato.
All’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale possono accedere lavoratori che
abbiano compiuto quindici anni di età e fino al venticinquesimo anno. La durata massima varia a
seconda della qualifica o del diploma da conseguire e non può comunque superare i tre anni. La
regolamentazione è rimessa alle regioni. È prevista per i datori la possibilità di proroga fino ad un
anno del contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati per il consolidamento e
l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche. Possono inoltre essere
stipulati di apprendistato per i giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione
secondaria superiore, per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali, rispetto a
quelle già previste dai regolamenti scolastici. Si tratta di un tentativo di collegare l’istruzione
scolastica con la formazione sul campo. Si prevede che i datori che intendano stipulare il contratto
di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale sono tenuti a sottoscrivere un protocollo
con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli
obblighi formativi del datore; lo schema di tale protocollo dovrà essere determinato tramite un
decreto del ministro del lavoro. Con tale ultimo decreto saranno anche definiti i criteri per la
realizzazione dei percorsi di apprendistato e i requisiti delle imprese nelle quali si svolge e il monte
orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in apprendistato. La legge stabilisce la
percentuale massima di ore di formazione impartita nell’istituzione formativa a cui lo studente è
iscritto. Per le ore di formazione svolte presso l’istituzione formativa il datore è esonerato da ogni
obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore è riconosciuta al lavoratore una
retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Il comma 9 dell’art. 43 dispone che,
conseguita la qualifica o il diploma professionale, allo scopo di conseguire la qualificazione
professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato
professionalizzante.
All’apprendistato professionalizzante possono accedere i giovani di età compresa fra i 18 e i 29
anni. Per chi abbia già conseguito la qualifica professionale il contratto di apprendistato
professionalizzante può essere stipulato a partire dai 17 anni. È possibile assumere, senza limiti di
età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Per questi
ultimi si applicano le disposizioni in materia di licenziamenti individuali. Per i lavoratori che
beneficiano dell’indennità di mobilità si applica il regime contributivo agevolato e l’incentivo di cui
alla legge 223/1991. La durata e le modalità di erogazione della formazione sono rimesse agli
accordi interconfederali e/o contratti collettivi. La legge stabilisce comunque che la durata non può
comunque essere superiore a tre anni. La formazione è svolta sotto la responsabilità del datore ed è
integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e per un
monte ore complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio. Entro 45 giorni
dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, la regione comunica al datore le modalità di
svolgimento dell’offerta formativa pubblica. Per i datori che svolgono attività in cicli stagionali i
contratti collettivi possono prevedere specifiche modalità di svolgimento. La legge non evoca la
possibilità di apporre al contratto di apprendistato un patto di prova. Costituisce un’inferenza della
natura dell’apprendistato l’insegnamento necessario all’acquisizione della qualificazione. La
giurisprudenza ha sempre ritenuto che questo insegnamento non deve necessariamente consistere in
lezioni teoriche o teorico-pratiche, ma che è allo scopo sufficiente il concreto esercizio delle
mansioni. Le mansioni cui può essere adibito il lavoratore non possono essere così elementari da
153
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
non sottendere alcun insegnamento. Il trattamento che spetta all’apprendista ricalca quello del
lavoratore subordinato, con l’eccezione della minore entità della retribuzione, tradizionalmente
prevista e ritenuta legittima. La promozione dell’apprendistato è affidata alla prefigurazione di
incentivi a favore delle imprese che vi facciano ricorso. Si stabilisce, quanto agli incentivi
normativi, che gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e
contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituiti. Sul piano contributivo il
rapporto di apprendistato continua a scontare un’aliquota assai favorevole. In ragione della
violazione dei divieti posti a protezione del lavoratore subordinato, l’effetto della violazione delle
norme protettive dell’apprendista è quello di eliminare i tratti di specialità del rapporto, che viene
ricondotto entro lo schema del rapporto di lavoro subordinato. La recente riforma prevede che, in
caso di inadempimento nell’erogazione della formazione, che sia tale da impedire la realizzazione
delle finalità formative, il datore perde il beneficio contributivo ed è tenuto a versare la differenza
fino a concorrenza della contribuzione dovuta con riferimento al livello di inquadramento superiore
e che avrebbe acquisito l’apprendista maggiorata del 100%. Nel caso in cui venga rilevato un
inadempimento nell’erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il
personale ispettivo del ministero del lavoro può adottare un provvedimento di disposizione,
assegnando un congruo termine al datore per adempiere. Inoltre per ogni violazione delle
disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi fissati dalla legge il datore è punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria. Il contratto di apprendistato va tenuto distinto dal praticantato,
in cui il giovane frequenta un’impresa o uno studio professionale allo scopo di apprendere i
rudimenti pratici di una serie di insegnamenti teorici già acquisiti dal praticante. Deve escludersi in
tali circostanze l’instaurazione di una relazione giuridica di lavoro se non addirittura di una
relazione giuridica tout court, potendosi costruire lo schema o come un rapporto di cortesia o come
una species atipica di contratto gratuito.
1.2. Il d.lgs. 276/2003 ha introdotto un sottotipo contrattuale con finalità formative: il contratto di
inserimento. Era uno schema negoziale che intendeva promuovere l’occupazione o la ricollocazione
lavorativa di una lunga serie di soggetti svantaggiati, riconducibili a due tipologie: i giovani in cerca
di prima occupazione e i disoccupati di lunga durata e/o i lavoratori “anziani” (50+) espulsi dal
circuito produttivo. La riforma Monti di cui alla legge 92/2012 ha però abrogato le disposizioni,
eliminando l’istituto dall’ordine giuridico e lasciando in vita tali disposizioni solo nei confronti
delle assunzioni effettuate fino al 31/12/2012.
1.3. Dalla seconda metà degli anni settanta si afferma un nuovo modello contrattuale, il contratto di
formazione lavoro (Cfl), che ha costituito lo strumento privilegiato per coniugare la formazione del
lavoratore con le esigenze di incentivare l’assunzione di giovani. Una risistemazione della materia
si è avuta con l’art. 3 della l. 863/1984, che ancora oggi costituisce lo schema-base del contratto, nei
limiti in cui è ancora vigente. La disciplina va poi integrata con le previsioni dell’art. 16 della l.
451/1994. Il Cfl costituisce un modello ormai residualissimo, la cui applicazione è prefigurata solo
nell’ambito dei rapporti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. L’eventuale violazione da
parte del datore pubblico della disciplina del Cfl non potrà mai comportare il diritto del lavoratore
alla declaratoria della sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato, ma solo il risarcimento dei
danni.
1.4. Distinti dai contratti di formazione e lavoro e dall’apprendistato sono i tirocini formativi e di
orientamento o stages, introdotti fin dalla legge sull’occupazione giovanile del 1977, con i quali
però non si costituisce alcun rapporto giuridico obbligatorio fra le parti. Costituiscono solo una
forma di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro allo scopo di consentire un primo contatto
con la realtà aziendale e produttiva. Con l’art. 18 della l. 196/1997 è stato delegato il Ministro del
154
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
lavoro ad emanare norme dirette alla promozione di iniziative e ad una regolamentazione degli
stages. Con decreto del Ministro del lavoro 25/03/1998 n. 142 è stata data attuazione alla delega. La
disciplina dei tirocini formativi o stages è stata rivisitata con il d.lgs. 276/2003 e ritoccata con il
decreto-legge 13/08/2011 n. 138. Il decreto ministeriale abroga le principali fonti regolative della
materia ancora vigenti e ribadisce una distinzione già presente fra tirocini formativi, diretti a
realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro, e tirocini di orientamento, diretti ad agevolare
le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. I rapporti fra imprese e
tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro subordinato. L’eventuale attività lavorativa prestata è
funzionale solo all’apprendimento. Promotori dei tirocini possono essere unicamente soggetti in
possesso degli specifici requisiti determinati dalle normative regionali in funzione di idonee
garanzie all’espletamento delle iniziative medesime. I soggetti ospitanti possono essere sia datori
pubblici che privati. I potenziali destinatari delle iniziative sono i neo-diplomati o neo-laureati entro
e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo. I tirocini inoltre non possono avere
una durata superiore a sei mesi. Lo strumento tramite il quale si attua in concreto il tirocinio è la
convenzione fra gli enti promotori e i datori ospitanti. Alla convenzione deve essere allegato il
progetto formativo. Il soggetto promotore è obbligato ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni
sul lavoro, stipulando apposita convenzione con l’INAIL nonché ad assicurarli per la responsabilità
civile verso terzi. Dovrà inoltre certificare l’attività formativa espletata dal tirocinante. Non è
previsto il pagamento di indennità né a carico dei promotori né a carico dei datori ospitanti. Il
tirocinante è obbligato a rispettare le norme di igiene e sicurezza del lavoro e a mantenere la
riservatezza su informazioni/conoscenze relative al processo produttivo. Il decreto ministeriale
prevede la concessione di agevolazioni a favore dei datori ospitanti. Tutta la materia è in corso di
revisione per effetto della delega di cui al comma 1 dell’art. 45 della l. 144/1999. In questa chiave la
riforma Monti ha delegato il governo e le regioni a concludere un accordo per la definizione di
linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base di una serie di
criteri, fra i quali il riconoscimento di una congrua indennità in relazione alla prestazione svolta. La
mancata corresponsione dell’indennità comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una
sanzione amministrativa.
2. Per completare il quadro degli strumenti diretti a favorire l’occupazione dobbiamo dar conto
degli interventi di politica attiva. Si tratta di una galassia molto varia, cui si può solo accennare
segnalando alcuni modelli specifici di intervento. Su questo piano si intrecciano gli interventi diretti
a favorire l’occupazione con quelli rivolti nei confronti dei giovani inoccupati. In questo ambito
ricordiamo: a) il premio di assunzione, che riconosceva ai datori che avessero assunto con contratto
a tempo indeterminato i giovani inoccupati o altri disoccupati particolarmente svantaggiati un
beneficio fiscale consistente in un credito d’imposta; b) gli incentivi contributivi per i datori
operanti in aree territoriali particolarmente svantaggiate; c) gli incentivi ad iniziative imprenditoriali
dei disoccupati in forma autonoma o associata; d) gli interventi diretti a favorire l’imprenditorialità
giovanile nelle aree del Mezzogiorno; e) la predisposizione di specifici fondi per l’occupazione che
hanno lo scopo di canalizzare l’insieme delle risorse destinate all’incremento dei livelli
occupazionali; f) i piani straordinari per l’occupazione giovanile. Con la l. 99/2013 si è prevista
l’istituzione di una Banca dati delle politiche attive e passive, che ha lo scopo di raccogliere le
informazioni sui soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore
collocazione nel mercato stesso e le opportunità di impiego. Il legislatore ha provveduto, con il
d.lgs. 21/04/2000 n. 185 ad una regolamentazione degli incentivi all’autoimprenditorialità e
all’autoimpiego. Tale disciplina è stata poi ridimensionata in funzione di controllo della spesa
pubblica. Incentivi all’auto-imprenditorialità sono inoltre contenuti nella disciplina in materia di
NASpI. Con l’art. 1 comma 32 della l. 247/2007 il governo è stato delegato ad emanare uno o più
155
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
decreti legislativi per il riordino della normativa in materia di incentivi all’occupazione e di contratti
di inserimento.
Sezione III: PERDITA DEL POSTO DI LAVORO E DISOCCUPAZIONE
1. L’altra faccia della disoccupazione è quella che riguarda i soggetti che sono già titolari di un
rapporto di lavoro. Può avvenire che l’impresa non sia in grado di proseguire l’attività produttiva,
con l’intero organico dei dipendenti o con una parte di essi. Allo scopo di attenuare le discontinuità
produttive ed occupazionali venne istituita la Cassa Integrazione guadagni per gli operai delle
imprese industriali. All’epoca la sua funzione era solo quella di garantire un reddito agli operai delle
imprese industriali, il cui rapporto fosse momentaneamente sospeso a seguito di impossibilità di
prestare attività a causa di eventi bellici. Si può quindi ricondurre tale fattispecie alla situazione
dell’impossibilità sopravvenuta per eventi oggettivi. L’impossibilità avrebbe liberato dalle
obbligazioni il datore, privando del reddito i lavoratori. Con una forma assicurativa su basi
privatistiche si provvide invece a garantire il reddito dei lavoratori. Il sistema venne recepito dal
legislatore con il d.lgs.lgt. 09/11/1945 n. 788 che istituì la CIG per gli operai dell’industria, e
successivamente esteso e perfezionato con il d.lgs.c.p.s. 12/08/1947 n. 869. In questi primi
interventi mantenne la propria identità originaria diretta a sopperire alle situazioni di impossibilità
oggettiva della prestazione nonché l’ambito di applicazione con riferimento agli operai delle
imprese industriali. Nel tempo venne estesa ad altri settori nonché, sul piano oggettivo, anche ai
lavoratori appartenenti alla categoria impiegatizia. Nella prima fase di vita mantenne la propria
configurazione originaria, e dunque quando si allude alla CIG originaria si intende fare riferimento
alle situazioni riconducibili alla vera e propria impossibilità. Con il trascorrere del tempo la CIG ha
modificato o meglio articolato la propria funzione, divenendo anche uno strumento di sostegno
dell’attività imprenditoriale. Ha rappresentato un’alternativa nei confronti dei licenziamenti per
riduzione del personale, garantendo la permanenza dei posti di lavoro e contribuendo a
sdrammatizzare le conseguenze sociali delle crisi produttive. Si è così affiancata alla gestione
ordinaria la gestione invece straordinaria, diretta nei confronti delle crisi aziendali o settoriali. Dopo
la legge del 1968 il più importante intervento è costituito dalla legge 20/05/1975 n. 164, con la
quale vennero ridefinite le cause integrabili, nonché le procedure chiamate a verificare la genuinità
della richiesta del datore. Con tali interventi non muta la natura sostanziale della CIG che avrebbe
voluto limitarsi a sopperire solo a sospensioni dell’attività comunque transitorie. Nel corso di tutti
gli anni settanta ed ottanta la CIG ha costituito uno strumento attraverso il quale è stato consentito il
parcheggio di un grande numero di lavoratori, snaturandosi così la funzione originaria dell’istituto.
Una riforma radicale della CIG è contenuta nella legge 223/1991, che avrebbe dovuto porre le basi
per il definitivo superamento della prassi invalsa per oltre un ventennio. Il disegno complessivo si
basa su una serie di passaggi così riassumibili:
a) razionalizzazione e riduzione ad unità degli interventi;
b) ripristino della funzione originaria della CIG;
c) riformulazione dell’istituto della mobilità, considerata un’alternativa agli interventi della
CIG straordinaria;
d) collegamento istituzionale della mobilità con la disciplina dei licenziamenti collettivi per
riduzione del personale.
Sennonché negli anni successivi si è tornati ad un impiego disorganico e dissennato della CIG. Al
problema ha cercato di fornire una risposta la riforma Monti che ha rivisitato l’assicurazione contro
la disoccupazione involontaria (definita ASpI), che dovrebbe assicurare un sussidio più consistente
rispetto a quello attuale, eliminando il ricorso alla cassa integrazione. Il passaggio al nuovo sistema
156
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
sarà graduale nel corso del triennio 2013-2016. Una nuova disciplina organica della CIG è stata
introdotta dal d.lgs. n. 148 del 14/09/2015, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 2 lett. a), della
legge 10/12/2014 n. 183 (jobs act). Il decreto contiene una trattazione della CIG, abrogando la
legislazione preesistente. Si articola in una parte generale che detta disposizioni comuni alla CIG
ordinaria ed a quella straordinaria e due parti speciali che si occupano più nello specifico della
prima e della seconda.
1.1. Quanto al campo di applicazione soggettivo della CIG la riforma del 2015 ne dispone la
concessione ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti
con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a
domicilio. È necessaria un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di
presentazione della domanda di concessione del trattamento. Tale limitazione non vi è in relazione
alle domande relative a trattamenti di cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non
evitabili nel settore industriale. Per gli apprendisti l’art. 2 del d.lgs. del 2015 prevede limitazioni che
riguardano i datori che non rientrano nel campo di applicazione dell’integrazione salariale. Inoltre si
prevede che il periodo di apprendistato sia prolungato in misura equivalente all’ammontare delle
ore di integrazione salariale fruite. Quanto alla misura del trattamento di integrazione è confermato
l’importo corrispondente all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro
non prestate. Tale importo, per l’anno 2015, non potrà superare determinati importi massimi mensili
comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici
mensilità. La durata massima complessiva del trattamento è di 24 mesi nell’arco del quinquennio. Si
prevede l’azzeramento dei periodi di trattamento fruiti prima dell’entrata in vigore del decreto
legislativo. La durata dei trattamenti straordinari d’integrazione salariale concessi a seguito della
stipula di un contratto di solidarietà, entro il limite di 24 mesi, viene computata nella misura della
metà. In tal modo si vuole incentivare il ricorso a meccanismi che prevedono la riduzione
dell’orario piuttosto che la sospensione del lavoro. Quanto al finanziamento della CIG resta la
distinzione fra contributo ordinario e contributo addizionale. Il decreto legislativo del 2015
prefigura l’applicazione di un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano
domanda di integrazione salariale non più proporzionale all’organico ma connesso all’effettivo
utilizzo del trattamento. Tale contributo crescerà in proporzione all’impiego effettivo del
trattamento, spaziando dalla misura del 9% fino a quella del 15%. È inoltre rimodulato il contributo
ordinario. Per le due diverse integrazioni salariali ordinaria e straordinaria si prevedono misure
diverse del contributo ordinario. Il periodo durante il quale il lavoratore è in cassa integrazione è
equiparato a quello lavorativo. Quanto alle modalità di erogazione dei trattamenti si prevede che il
pagamento venga anticipato dall’impresa agli aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga.
L’impresa è poi ammessa a chiedere all’INPS il rimborso o ad effettuare il conguaglio tra contributi
dovuti e prestazioni corrisposte, entro un termine di decadenza di sei mesi. Nel caso di documentate
difficoltà finanziarie dell’impresa l’INPS potrà autorizzare il pagamento diretto de lavoratore. Il
lavoratore posto in cassa integrazione è onerato di rispettare una serie di doveri rispetto alla
pubblica amministrazione. Si spiega così la regola che vuole che il lavoratore che svolga attività di
lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale perde il diritto
all’integrazione per le giornate di lavoro effettuate. L’art. 8 del d.lgs. del 2015 estende ai lavoratori
beneficiari di integrazioni salariali per i quali la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sia
superiore al 50%, l’obbligo di stipulare con il centro per l’impiego il patto di servizio
personalizzato, con il quale si impegnano a partecipare alle iniziative organizzate per favorirne
l’occupazione e/o la formazione. Un ulteriore apparato sanzionatorio è previsto dall’art. 22 comma
3 e 4, del d.lgs. 150/2015.
157
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
1.2. L’art. 11 del d.lgs. del 2015 indica quali cause integrabili per la Cassa integrazione guadagni
ordinaria (CIGO): a) le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili
all’imprenditore o ai dipendenti o b) determinate da situazioni temporanee di mercato. Solo le prime
alludono ad eventi riconducibili all’impossibilità sopravvenuta, mentre le seconde prospettano una
mera difficoltà a far fronte agli impegni nei confronti del personale dipendente. Ambedue sono
caratterizzate dalla transitorietà e temporaneità. La situazione si lega con la ragion d’esser
dell’intervento ordinario di integrazione che è strutturalmente di durata limitata nel tempo. Il
periodo massimo è di tredici settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino ad un
massimo complessivo di 52 settimane. Se l’impresa ha fruito di 52 settimane consecutive di
integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere prodotta per la stessa unità
produttiva, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività
lavorativa. Tali limiti non hanno applicazione nei casi di intervento richiesto a causa di eventi non
oggettivamente evitabili. Un limite ulteriore dice che non possono essere autorizzate ore di
integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel
biennio mobile. Il secondo requisito è quello dell’involontarietà dell’evento che è alla base della
richiesta di intervento della CIG. La legge allude a situazioni che sono al di fuori della
programmabilità organizzativa aziendale e che incidono sulla continuità della prestazione
lavorativa. La legge assegna un ruolo essenziale alle parti sociali. Si prevede a) un obbligo di
comunicazione e b) uno di esame congiunto. La procedura ordinaria pretende che l’obbligo di
comunicazione datoriale sia preventivo rispetto all’attuazione delle sospensioni. La comunicazione
deve contenere le cause di sospensione o riduzione, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei
lavoratori interessati. Può far seguito l’esame congiunto della situazione che avrà ad oggetto i
problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa. La
procedura ordinaria dovrà esaurirsi entro 25 giorni dalla richiesta di esame, ridotti a 10 giorni per le
imprese con meno di 50 dipendenti. La procedura abbreviata, in presenza di situazioni connotate da
eventi oggettivamente non evitabili, prevede che l’obbligo di comunicazione possa essere
successivo ad una contrazione o sospensione già avviata dall’impresa. L’obbligo di comunicazione
si dirige ai medesimi soggetti sindacali indicati in precedenza. La comunicazione deve indicare la
durata prevedibile della contrazione o sospensione ed il numero dei lavoratori interessati. Ove la
sospensione o riduzione di orario sia superiore a 16 ore settimanali si potrà precedere ad un esame
congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli
orari di lavoro. La richiesta di esame congiunto va presentate entro tre giorni dalla comunicazione
del datore e la relativa procedura dovrà concludersi entro i cinque giorni successivi. L’ammissione
della CIGO ha luogo a livello locale. L’impresa deve presentare domanda alla sede INPS
competente per territorio, indicando la causa della sospensione o riduzione d’orario e la loro
presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e le ore di lavoro. la domanda va presentata
entro 15 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto
inizio la sospensione o riduzione d’orario. L’ammissione alla CIGO è disposta dalla sede
territorialmente competente. Secondo l’art. 15 comma 4 del d.lgs. del 2015, ove dall’ommessa o
tardiva presentazione della domanda da parte dell’impresa derivi la perdita totale o parziale
dell’integrazione salariale, l’impresa sarà tenuta a corrispondere loro una somma pari
all’integrazione salariale non percepita. Il campo di applicazione della gestione ordinaria si estende
al tradizionale settore industriale nonché alle cooperative agricole e zootecniche.
1.3. L’istituto della CIG straordinaria (CIGS) è quello che più direttamente entro nel vivo delle crisi
industriali, costituendo uno strumento di politica economica, di sostegno all’attività imprenditoriale.
Fin dalla legge 1115/1968 le cause integrabili vennero ricondotte a situazioni di disagio per
l’impresa derivanti dal mercato e a situazioni specifiche della singola impresa. La genericità delle
158
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
indicazioni normative ha consentito un uso più politico che tecnico dei provvedimenti di
concessione. Il tentativo della l. 223/1991 di porre rimedio a tale situazione è stato successivamente
edulcorato da ulteriori interventi normativi. Il d.lgs. 148/2015 ha proceduto all’abrogazione delle
disposizioni dedicate alla CIG nella legge del 1991 e riscritto la relativa disciplina. Le causali
dell’intervento della CIGS riguardano le ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
determinata da: a) riorganizzazione aziendale, b) crisi aziendale e c) contratto di solidarietà. La
procedura per l’ammissione alla CIGS è sostanzialmente coincidente con quello con riferimento alla
CIGO. Non solo la procedura si articola nelle due fasi sindacale ed amministrativa, ma, quanto alla
prima, l’impresa è onerata di seguire un iter molto simile. Le parti devono espressamente dichiarare
l’impossibilità di percorrere la causale di contratto di solidarietà. Quindi il ricorso alla CIGS è vista
come una sorta di extrema ratio. Al centro del confronto con il sindacato vi è il programma che
l’impresa intende attuare. Questi deve essere comprensivo della durata e del numero dei lavoratori
interessati alla sospensione/riduzione e delle ragioni che rendono non praticabili forme alternative
di riduzioni di orario, nonché i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le modalità della
rotazione tra i lavoratori. È evidente che la predisposizione del programma non può prescindere da
un confronto con i rappresentanti dei lavoratori. Di rilievo è la segnalazione di alcuni contenuti
vincolanti del programma concernenti i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere
nonché le modalità della rotazione dei lavoratori da porre in CIGS. La fase amministrativa si
caratterizza per un doppio livello di verifica dell’ammissibilità della richiesta, a livello periferico e a
livello centrale. La domanda di concessione del trattamento di CIGS deve essere presentata in unica
soluzione contestualmente al ministero del lavoro e alle direzioni territoriali del lavoro competenti.
La concessione avviene con decreto del ministero del lavoro per l’intero periodo richiesto. Il
decreto è adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell’impresa. La
pubblica amministrazione è titolare peraltro di un potere di verifica del corretto adempimento del
programma. Infatti le DTL competenti per territorio procedono alle verifiche finalizzate
all’accertamento degli impegni aziendali. Ove emerga il mancato svolgimento del programma il
procedimento amministrativo diretto al riesame del decreto di concessione del trattamento di CIGS
si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali. La
durata dell’intervento straordinario è variabile in relazione alle diverse cause integrabili. Per la
riorganizzazione aziendale la durata massima è pari a 24 mesi, in un quinquennio mobile. Per la
crisi aziendale il trattamento può avere una durata massima di 12 mesi. Inoltre si prevede che una
nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di
quello relativo alla precedente autorizzazione. Per la causale relativa alla stipulazione di contratti di
solidarietà, il trattamento straordinario può avere una durata massima di 24 mesi. Per incentivare il
ricorso ai contratti di solidarietà è previsto che ai fini del calcolo della durata massima del
trattamento, la durata per tale causale viene computata nella misura della metà. Oltre tale limite la
durata di tali trattamenti viene computata per intero. Il finanziamento dell’intervento straordinario è
a carico del bilancio dello Stato, sebbene le imprese siano onerate di un contributo addizionale per
ogni lavoratore in CIGS. Il campo di applicazione delle CIGS si è progressivamente ampliato nel
tempo. Quanto alla dimensione il d.lgs. del 2015 riconferma l’estensione alle imprese che abbiano
occupato più di 15 lavoratori nei sei mesi precedenti la richiesta. Quanto ai settori produttivi al
referente dell’industria si sono aggiunte nel tempo le grandi imprese commerciali e le agenzie di
viaggio e turismo con oltre 50 addetti, le imprese di vigilanza con oltre 15 dipendenti, le aziende di
trasporto aereo e le imprese aeroportuali nonché i partiti e movimenti politici e le loro rispettive
articolazioni e sezioni territoriali. Per i settori che non fruiscono della CIG, la riforma Monti ha
previsto l’obbligatoria adozione di Fondi di solidarietà bilaterali, diretti a garantire ai lavoratori
prestazioni comparabili a quelle della CIG. Tali fondi sono costituiti ex novo presso l’INPS o
159
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
adeguando quelli già esistenti presso enti bilaterali. In caso di inerzia delle parti sociali si prevede
che il ministero del lavoro provveda a istituire un Fondo di solidarietà. Il d.lgs. 148/2015 ha rivisto
la disciplina relativa a tali fondi, confermando i principi di cui alla legge del 2012, ma ridisegnando
l’ambito di estensione dell’istituto e le ulteriori modalità applicative.
1.4. La CIG comporta una interazione fra atti di autonomia del datore, atti di autonomia collettiva e
atti amministrativi. L’insieme di tali attività deve trovare una collocazione ed una sistemazione
all’interno della cornice del contratto di lavoro. L’incerta collocazione sistematica dell’istituto è
riflessa dall’evoluzione dei tentativi di sistemazione del fenomeno, il cui sviluppo ha seguito la
parabola del CIG, che ha modificato ed articolato le proprie funzioni. Negli anni cinquanta ha
prevalso una visione previdenziale della CIG, che la costruisce come una forma assicurativa
trilaterale. A questa fa da sfondo l’idea secondo cui il datore potrebbe sospendere il rapporto, senza
conseguenze risarcitorie. È negli anni sessanta che si hanno ricostruzioni attente alla collocazione
della CIG nell’ambito dell’obbligazione di lavoro, specie con riferimento alle situazioni non
riconducibili all’impossibilità. Nel frattempo si è consolidata la convinzione che la riduzione
unilaterale dell’orario di lavoro da parte del datore non lo liberi dalle obbligazioni scaturenti dal
rapporto. Si pone quindi il problema di ricercare una diversa giustificazione all’intervento
assicurativo. Le principali opinioni cercano di coordinare CIG e contratto secondo due idee
ricostruttive. Secondo un primo percorso l’intervento della CIG sottintende un accordo modificativo
dell’originaria obbligazione, tale da consentire la sospensione del rapporto e la sostituzione
dell’obbligazione retributiva con quella previdenziale. Secondo un’altra opinione il sistema della
CIG integrerebbe una deroga al diritto comune, nel senso che, suo tramite, attingerebbero al livello
dell’impossibilità liberatoria anche situazioni di mera difficoltà del datore. Le due lettere peraltro
convergono nell’assumere la prevalenza del diritto comune sul diritto speciale. Un rimescolamento
delle prospettazioni ricostruttive si ha negli anni settanta. Secondo una lettura in chiave di politica
del diritto la CIGS è stata contestata come strumento di sostegno ed ausilio dell’impresa e ne è stata
negata del tutto l’idoneità a costituire una forma assicurativa a garanzia del salario. In questa logica
la CIGS costituirebbe invece un’assicurazione a favore dell’impresa contro le discontinuità
produttive e del mercato. È più fondata una prospettiva che rinunci ad una ricostruzione unitaria dei
rapporti fra diritto comune e diritto speciale, per ripiegare su prospettive maggiormente articolate.
La sequenza ricostruttiva fatta propria dalla giurisprudenza della Cassazione è la seguente: a) il
datore non può unilateralmente sospendere il rapporto e rifiutare la prestazione offerta; b) il sistema
assicurativo della CIG copre il rischio delle conseguenze sul piano del rapporto della sospensione,
configurandosi come una deroga al diritto comune; c) la mancata attivazione del procedimento di
ammissione all’integrazione salariale da parte del datore comporta per quest’ultimo l’obbligo di
corrispondere l’integrazione salariale non richiesta e/o non autorizzata per fatto a lui addebitabile o
l’obbligo di corrispondere le retribuzioni perdute; d) in ogni caso il datore assume la posizione
giuridica di mandatario ex lege o adjectus solutionis causa solo dopo al provvedimento di
ammissione al trattamento e non prima. La CIG si colloca nell’ambito delle politiche di intervento
dello stato di sostegno ed ausilio all’impresa in occasione di situazioni di crisi e/o discontinuità
produttive che potrebbero condurre ad una restrizione della base occupazionale. Il sostegno
all’impresa realizza inoltre una protezione dei lavoratori che mantengono l’occupazione e il salario.
Tale presupposto giustifica la diffusa convinzione secondo cui la positiva conclusione della
procedura con l’intervento dello Stato esonera di per sé il datore all’obbligo retributivo. Il problema
si restringe nel chiedersi quale sia la fonte dell’esonero del datore dalle ordinarie regole di diritto
comune. Si può assumere che la legge individua nelle procedure le condizioni per la liberazione del
datore o identifica in esse il giusto motivo di rifiuto delle prestazioni offerte dai lavoratori. Occorre
peraltro operare ulteriori distinzioni, posto che il modello appena abbozzato restituisce solo
160
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
parzialmente l’immagine di una realtà assai più complessa. Si tratta di innovazioni che sembrano
mettere in dubbio l’idea che sia possibile la costruzione di un modello unitario di spiegazione dei
rapporti fra CIG e diritto comune. Occorre distinguere la situazione in cui in sede sindacale le parti
si limitino a dar atto della sussistenza delle condizioni per accedere all’intervento della CIG da
quella in cui le medesime dettino altresì regole circa il regime specifico della sospensione/riduzione.
In assenza di accordo sindacale opera il meccanismo derogatorio affidato dalla legge all’atto
amministrativo, il quale ha natura costitutiva. In questo contesto il ruolo del sindacato è di supporto
all’attività ricognitiva della pubblica amministrazione, quale presupposto per la concessione del
trattamento. Il provvedimento costituisce fonte di diritti soggettivi per i protagonisti del rapporto e
dunque le controversie che hanno ad oggetto tali diritti rientrano entro la giurisdizione del giudice
ordinario. Una diversa giustificazione si impone nel caso in cui in sede sindacale le parti dettino
regole per il trattamento giuridico delle sospensioni. In tali situazioni sarà l’accordo sindacale la
fonte della modificazione degli obblighi negoziali del datore e del relativo esonero.
1.5. Un discorso a parte merita la valutazione del ruolo coperto dal sindacato nell’ambito della
procedura. Il problema si pone perché nel nostro ordinamento l’associazione sindacale non ha di per
sé il potere di stipulare patti con efficacia erga omnes. È per questa ragione che la procedura che
coinvolge la partecipazione del sindacato è stata oggetto del sospetto di incostituzionalità per il
ruolo istituzionale che viene affidato al soggetto sindacale. La giurisprudenza ha respinto il sospetto
sul presupposto che il sindacato non svolge la propria tipica funzione negoziale in rappresentanza
degli iscritti, ma al medesimo è affidata una funzione pubblica o di ordine pubblico economico. Ne
consegue che gli accordi raggiunti dalle parti hanno natura endoprocedimentale, hanno cioè lo
scopo di fornire alla pubblica amministrazione il supporto per le scelte che a questa competono.
L’efficacia nei confronti dell’impresa e dei dipendenti è garantita direttamente dalla legge.
1.6. Dibattuta è la questione dei limiti che incontra il datore rispetto alla scelta di chiedere
l’intervento della CIG ed alle decisioni ad essa conseguenziali. Occorre chiedersi se il datore: a)
incontra limiti nell’individuazione dei lavoratori da porre in CIG; b) è obbligato a disporre la
rotazione dei lavoratori in CIG; c) deve motivare la scelta di porre in CIG. Allo scopo di rispondere
è necessario distinguere il regime della CIGO da quello della CIGS. Il sistema normativo della
CIGO non prefigura alcun obbligo in capo al datore. La giurisprudenza ha affermato
l’inestensibilità alla sospensione del rapporto con l’intervento della CIGO degli obblighi in materia
di criteri di scelta e rotazione previsti dalle leggi sui licenziamenti collettivi e sulla CIGS. La
giurisprudenza ha ritenuto di rinvenire in ogni caso una serie di limitazioni. Si parla di limiti interni,
che deriverebbero da un dovere di coerenza della scelta dei cassintegrandi in relazione alla funzione
dell’istituto della CIG: si pretende cioè una giustificazione causale dell’atto di esercizio del potere
di porre in CIG. Non possiamo ribadire che appare largamente discutibile un controllo interno agli
atti di esercizio dei poteri datoriali, che faccia leva sulla sua giustificazione causale. La
giustificazione causale della scelta del datore si presenta ancora più ardua, data la molteplicità delle
funzioni che l’ordinamento assegna alla CIG. La giurisprudenza richiama poi l’obbligo del rispetto
dei limiti esterni, avendo riguardo al divieto di discriminazione e alle clausole generali di
correttezza e buona fede nell’individuazione dei lavoratori da porre in CIGO. Nulla quaestio in
ordine al rilievo secondo cui il datore non può avviare alla CIGO i lavoratori maggiormente sgraditi
per ragioni sindacali, ideologiche, di sesso etc. Più perplessità desta l’obbligo del rispetto delle
clausole generali della correttezza e buona fede nella selezione dei cassintegrandi. Di queste si può
parlare solo in presenza di una specifica previsione di natura pattizia o legale che imponga il
confronto fra i lavoratori. Più articolato è il giudizio della CIGS. In tale ambito il legislatore ha
imposto come regola la rotazione dei lavoratori da porre in CIGS con la connessa necessità che
161
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
vengano esplicitate nel programma le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di
meccanismi di rotazione. Il meccanismo prefigurato dalla legge conferma che nemmeno rispetto
alla CIGS il meccanismo della rotazione costituisce un obbligo ineludibile da parte del datore, tale
da produrre la nullità della procedura, se è vero che la legge fa affidamento su strumenti dissuasivi e
compulsivi, senza imporre direttamente l’obbligo.
2. Una forma atipica di tutela del lavoratore nei confronti della disoccupazione è il
prepensionamento, che consiste nel collocamento del lavoratore in pensione con un anticipo di
cinque o più anni rispetto all’età pensionabile. Tale escamotage è stato adottato a partire dagli anni
settanta e fino agli anni ottanta, allo scopo di consentire alle grandi imprese massicce riduzioni di
personale. La disciplina dei prepensionamenti si pone in rotta di collisione con la tendenza
legislativa che punta all’innalzamento dell’età pensionabile. È per questa ragione che dagli anni
novanta è stato disincentivato l’uso del prepensionamento. Una razionalizzazione si deve alla l.
223/1991 con riferimento ai lavoratori dipendenti di quelle imprese industriali tali da essere definite
di “interesse nazionale”. Di fatto la funzione del pre-pensionamento è oggi svolta dall’indennità di
mobilità lunga.
3. La tradizionale tutela del lavoratore contro la disoccupazione è costituita dall’indennità di
disoccupazione, erogata nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria, gestita dall’INPS. Oggetto
della tutela è la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro e destinatari ne sono i
lavoratori subordinati. Sul piano oggettivo si caratterizza per l’involontarietà, mentre sono escluse
le situazioni di impossibilità legate alla peculiare posizione del lavoratore. Sul piano soggettivo
beneficiari ne sono i titolari di un rapporto di lavoro subordinato. L’obbligo assicurativo per il
datore è escluso rispetto ai rapporti di lavoro dotati di stabilità. La scarsa effettività di tale forma
assicurativa dipende dalla particolare esiguità della misura della prestazione garantita al lavoratore.
Il vuoto lasciato dall’assicurazione contro la disoccupazione è stato colmato dagli interventi relativi
alla disoccupazione speciale. Una parte notevole dello spazio di tutela è assicurata dall’indennità di
mobilità. Quest’ultima è stata istituita dalla l. 223/1991 in superamento del trattamento di
disoccupazione speciale degli operai dell’industria, che è stato esplicitamente abolito. L’indennità di
mobilità garantisce al lavoratore privato un circuito privilegiato di collocamento. Sul piano
soggettivo essa spetta ai lavoratori, con qualifica di operai, impiegati e quadri, che abbiano perso il
posto di lavoro. Quanto all’ambito oggettivo si estende nei confronti delle imprese rientranti nel
campo di applicazione della CIGS. La durata del trattamento di mobilità è di 12 mesi, elevati a 24
per i lavoratori che hanno compiuto quarant’anni ed a 36 per quelli che ne anno compiuti cinquanta.
Nella struttura originaria, delineata dalla l. 223, la durata normale del trattamento poteva essere
prolungata per periodi limitati di tempo ed entro specifici ambiti territoriali, accompagnando il
lavoratore fino alla soglia della pensione: mobilità lunga. Nella legislazione successiva tale assetto
si è stabilizzato. L’indennità di mobilità è corrisposta in misura percentuale decrescente nel tempo
del trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito o che sarebbe
loro spettato nel periodo precedente la risoluzione del rapporto. È riconosciuta ai lavoratori che
intendano intraprendere un’attività autonoma o costituirsi in cooperativa la possibilità di riscossione
anticipata dell’intero ammontare. Il finanziamento del trattamento di mobilità si affida al doppio
binario della contribuzione addizionale generale per i datori che rientrano entro l’ambito di
applicabilità della CIGS e della contribuzione dovuta all’atto della collocazione in mobilità. La
riforma Monti ha inteso riorganizzare tutto il mondo degli “ammortizzatori sociali”, con
l’eliminazione della CIG e l’istituzione di un’unica forma assicurativa contro la disoccupazione:
l’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI). Essa trova applicazione nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti privati e convivrà, fino al 31/12/2016, con l’indennità di mobilità e la CIG.
162
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
L’indennità è riconosciuta ai lavoratori in stato di disoccupazione involontaria che possano far
valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente
l’inizio del periodo di disoccupazione. La durata è di dodici mesi per i lavoratori fino a 54 anni e di
diciotto mesi per quelli di età superiore. È prevista anche una versione minore dell’assicurazione, la
mini-ASpI, per fruire della quale sono sufficienti 14 settimane di versamenti contributivi negli
ultimi dodici mesi. Con la riforma Renzi è stata introdotta una nuova versione dell’ASpI che è stata
definita NASpI, la quale è regolata dal d.lgs. 22/2015. Tale nuova forma assicurativa sostituisce le
prestazioni di ASpI e mini-ASpI, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall’
01/05/2015. Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI, in quanto compatibili. Ne
sono destinatari i lavoratori dipendenti, esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle p.a. e gli
operai agricoli a tempo determinato o indeterminato. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori
involontariamente disoccupati, che possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione nonché
30 giornate di lavoro effettivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Con l’art. 19 del d.lgs. 150/2015 è stata introdotta una definizione dello stato di disoccupazione,
secondo cui sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano al portale
nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con i centri per
l’impiego. La misura dell’indennità è proporzionata alla retribuzione degli ultimi quattro anni e,
quanto alla durata, copre un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione
degli ultimi quattro anni. La sua corresponsione è condizionata alla regolare partecipazione del
lavoratore alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione
professionale proposti dai Servizi competenti. La nuova legge dà un incentivo all’auto-
imprenditorialità, stabilendo che il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata dell’importo
complessivo del trattamento. A determinate condizioni la NASpI è compatibile con un’attività
lavorativa. Il lavoratore è peraltro onerato di comunicare all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio
dell’attività, il reddito annuo previsto. Discorso analogo vale per lo svolgimento di un’attività
lavorativa autonoma o di impresa individuale. Il lavoratore decade dal diritto alla NASpI ove: a)
perda lo stato di disoccupazione; b) raggiunga i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato; c) acquisisca il diritto all’assegno ordinario d’invalidità; d) instauri un rapporto di lavoro
subordinato qualora abbia chiesto l’anticipazione dell’indennità. Una forma ancora più speciale di
indennità di disoccupazione è l’ASDI (assegno di disoccupazione), regolato dall’art. 16 del d.lgs.
22/2015. È un assegno che ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori
beneficiari della NASpI, che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata entro il 31/12/2015, che
siano privi fi occupazione e che si trovino in una condizione economica di bisogno. Uno strumento
al quale è stata data molta enfasi, per la sua idoneità a favorire il percorso di recupero dei
disoccupati, è il contratto di ricollocazione, regolato dall’art. 17 del d.lgs. 22/2015. È un contratto
che il lavoratore stipula con i servizi per i lavori pubblici o privati e che gli dà il diritto di ricevere
da questi ultimi un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di un lavoro. Tale visione ha peraltro
avuto vita breve, dal momento che buona parte dell’articolo che lo regolava è stata abrogata dal
d.lgs. 150/2015, che ha invece introdotto il patto di servizio personalizzato, che esprime il
medesimo concetto. La differenza sta nel fatto che la stipulazione del patto è indispensabile per
confermare lo stato di disoccupazione. Al lavoratore che abbia rispettato le condizioni previste dalla
legge, è riconosciuta una somma denominata “assegno individuale di ricollocazione”, spendibile
presso i centri per l’impiego o presso i servizi accreditati per ottenere un servizio di assistenza
intensiva nella ricerca di lavoro.
4. Nell’ambito degli interventi sul mercato del lavoro diretti a scongiurare la riduzione della base
occupazionale delle imprese o di consentirne l’espansione si colloca l’esperienza dei contratti di
163
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
solidarietà (c.d.s.). È un meccanismo che punta per l’appunto sulla solidarietà dei lavoratori. L’idea
è quella di consentire all’impresa una riduzione di orario di lavoro parzialmente compensata per i
lavoratori da un trattamento previdenziale, allo scopo: a) di scongiurare un licenziamento per
riduzione del personale o b) di consentire l’assunzione di altri lavoratori. Alla prima finalità
corrisponde il c.d.s. “difensivo”, alla seconda il c.d.s. “espansivo” o “offensivo”. Esso è stato
introdotto con la l. 863/1984 e poi integrato e modificato con le ll. 236/1993, 608/1996 e 196/1997.
Un nuovo modello dei c.d.s. è stato previsto dalla l. 223/1991, rinvenibile nel caso in cui il datore
abbia concordato con contratto collettivo la conversione del rapporto di lavoro dei lavoratori
“anziani” in part-time allo scopo di evitare licenziamenti o incentivare nuove assunzioni. Ai
lavoratori in questione è riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia. Si prevede per il
lavoratore la perdita del trattamento pensionistico in caso di risoluzione del rapporto part-time. Con
il d.lgs. 148/2015 i c.d.s. difensivi, introdotti con la l. 863, sono stati ricondotti alle causali della
CIGS ed armonizzati con questa quanto a misura delle prestazioni e contribuzione dell’impresa.
Essi possono essere stipulati per il tramite di contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali
stipulati da associazioni sindacali e di contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro r.s.a. o dalla
r.s.u., stabilendosi una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare la riduzione o la
dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.
5. Fra gli strumenti utilizzati nella lotta alla disoccupazione va segnalato l’istituto dei lavori
socialmente utili (LSU). La più lontana origine va ricercata nella legge-base in materia di
collocamento pubblico ed in successivi interventi. Vanno poi segnalate le leggi 451/1994 e
608/1996. L’idea-base è quella di mettere a frutto l’attività di quei lavoratori che fruiscano a carico
della collettività di un trattamento di disoccupazione. La dottrina è concorde nel ritenere che i LSU
rispondano ad una molteplicità di funzioni. C’è in primo luogo la prospettiva di attenuare gli effetti
della disoccupazione. In questo quadro si ottiene l’obiettivo di mantenere un reddito minimo ai
lavoratori espulsi dal mercato del lavoro. Vi è poi la funzione diretta a consentire alla p.a. la
realizzazione di servizi altrimenti irrealizzabili. E infine vi è lo scopo di garantire un’occupazione
aggiuntiva e promuovere il superamento della disoccupazione giovanile. Un primo assestamento
sistematico si è avuto con il d.lgs. 01/12/1997 n. 468. I LSU venivano definiti come le attività che
hanno per oggetto la realizzazione e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di
particolari categorie di soggetti. La legge individuava le possibili attività, i soggetti promotori, i
soggetti utilizzabili e le modalità di definizione dei progetti. Ci si è interrogati sulla disciplina
giuridica applicabile. È stata anche valorizzata la contrapposizione tra metodo tipologico e metodo
sussuntivo. In applicazione del primo si è sostenuta la possibilità di un’applicazione selettiva di
porzioni di disciplina del rapporto di lavoro, mentre, in coerenza con il secondo, si è negata
l’estensibilità della disciplina del lavoro subordinato. Occorre rilevare che l’istituto non ha
raggiunto gli obiettivi di incremento dell’occupazione e sostegno all’occupazione che all’origine si
proponeva. Il legislatore quindi è intervenuto con un’ulteriore riforma con cui ha soppresso gran
parte delle tipologie dei LSU, mantenendo in vita solo quelle attività svolte dalle p.a. attraverso
l’impiego diretto dei lavoratori che percepiscono trattamenti di natura previdenziale. La legge
finanziaria del 2007 ha previsto nuove convenzioni fra enti locali e ministero per lo svolgimento di
attività socialmente utili. Con l’art. 26 del d.lgs. 150/2015 si è previsto un meccanismo analogo
consistente nell’utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito in costanza
di rapporto. È previsto che tale attività non determini l’instaurazione di un rapporto di lavoro e
debba avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso.
Capitolo quinto: LE GARANZIE DEI DIRITTI
164
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
1. L’ordinamento lavoristico ha sviluppato delle garanzie a vantaggio del lavoratore dipendente.
Sono delle garanzie che riguardano le situazioni soggettive di vantaggio riconosciute a favore del
lavoratore e che si radicano sulla rilevanza sociale degli interessi tutelati. Muovendo dal piano delle
garanzie di diritto sostanziale dobbiamo segnalare la regola della parziale indisponibilità dei diritti,
previsto dall’art. 2113 c.c. Gli atti con cui il lavoratore dispone di propri diritti previsti da norme
inderogabili sono soggetti ad un regime di annullabilità e sono neutralizzati per tutta la durata del
rapporto. Occorrerà dar conto poi del regime della prescrizione dei diritti dei lavoratori, che riceve
una regolamentazione diversa a fronte degli altri diritti. Infine andrà illustrato come si atteggia il
sistema delle garanzie del credito di lavoro sia con riferimento alla problematica della responsabilità
patrimoniale del debitore, sia avendo riguardo agli strumenti assicurativi predisposti per tenere il
lavoratore al riparo dai rischi di insolvenza del datore. Il sistema delle garanzie si svolge attraverso
la predisposizione di una tutela giurisdizionale differenziata, caratterizzata da un rito funzionale alla
realizzazione effettiva dei diritti del lavoratore. Alla tutela giudiziale si affianca poi uno specifico
apparato diretto alla composizione stragiudiziale delle controversie (attraverso la conciliazione e
l’arbitrato). Nel quadro delle garanzie va ricordato anche il sistema dei controlli predisposto
dall’amministrazione statale, allo scopo di verificare l’attuazione della legislazione protettiva e
l’adempimento dell’obbligo contributivo da parte del datore nonché l’apparato sanzionatorio penale
ed amministrativo.
2. L’art. 2113 c.c. introduce una disciplina delle rinunce e transazioni del lavoratore su diritti
previsti da norme inderogabili di legge e di contratto collettivo, riassumibile in: a) annullabilità
degli atti dispositivi, impugnabili entro termini di decadenza; b) neutralizzazione dei termini di
impugnazione in costanza di rapporto; c) piena validità delle rinunce e transazioni che hanno luogo
in certe sedi privilegiate. Se la ratio della previsione normativa appare evidente, meno semplice è
districare i nessi che la norma propone fra le categorie giuridiche dell’inderogabilità e
dell’indisponibilità. L’inderogabilità è un tratto della norma, che contiene diritti non derogabili dalle
parti, mentre l’indisponibilità è una caratteristica dei diritti. Fra le due non c’è nessuna connessione
di carattere logico, potendo sussistere l’una senza l’altra. La vicenda lavoristica ci dimostra che fra i
due esiste solo una connessione logica. Il problema comincia dall’introduzione nell’ordinamento
lavoristico di discipline inderogabili, rispetto alle quali l’autonomia privata risultava limitata dal
divieto di patti contrari. All’inderogabilità della disciplina avrebbero dovuto seguire la nullità di atti
di disposizione di diritti derivanti dalle norme inderogabili. Viceversa la giurisprudenza ritenne di
utilizzare la categoria dell’annullabilità, equiparando la posizione del lavoratore che dismette diritti
in costanza di rapporto a quella di chi sia temporaneamente incapace. La spaccatura fra
l’orientamento giurisprudenziale e l’opinione dottrinaria, che prospettava la nullità dei negozi
dispositivi, venne risolta con la soluzione di un compromesso prevista dall’art. 2113 c.c. La norma,
da una parte, semplificava i problemi connessi con la dimostrazione dell’esistenza della posizione
soggettiva di soggezione psicologica, dall’altra, sottoponeva la loro impugnazione ad un breve
termine di decadenza. Questa posizione è rimasta tale anche dopo la riscrittura della norma ad opera
della l. 533/1973. Le discussioni teoriche si sono pertanto riprodotte anche in tempi recenti. Così
all’opinione estrema di chi ritiene che l’art. 2113 abbia codificato il principio secondo cui
l’indisponibilità sarebbe una conseguenza necessaria dell’inderogabilità, si è contrapposto un
indirizzo che prevede la distinzione fra diritti primari, riconducibili alla norma inderogabile, e diritti
secondari, di natura solo risarcitoria. Agli atti di disposizione dei primi sarebbe riconnesso il regime
di nullità, laddove agli atti di disposizione sui secondi sarebbe applicabile il regime di cui all’art.
2113 c.c. Le contraddizioni e i compromessi cui soggiace l’art. 2113 c.c. non ne consentono una
ricostruzione teorica esente da critiche. Sembra più convincente la prospettiva che fa passare il
discrimine piuttosto fra un piano “genetico”, attinente al profilo dell’inderogabilità della norma, ed
165
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
un piano “funzionale”, che fa capo ai profili gestionali dei diritti sorti sulla base della norma
inderogabile. A tale indirizzo sembra far capo la giurisprudenza che tende a distinguere fra atti di
disposizione che riguardano diritti già sorti, assoggettati al regime dell’annullabilità, ed atti di
disposizione che riguardano diritti futuri, di per sé nulli.
3. Gli atti di disposizione presi in considerazione dall’art. 2113 sono le rinunce e le transazioni. La
rinuncia è un negozio giuridico diretto a manifestare la volontà di dismettere diritti soggettivi del
titolare, mentre la transazione è un contratto tipico, con cui le parti pongono fine ad una lite già
cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. L’oggetto delle rinunce o delle
transazioni sono i diritti del lavoratore previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto o
accordo collettivo di lavoro. Il nuovo testo dell’art. 2113 ha sancito il principio secondo cui anche i
contratti collettivi post-corporativi contengono norme inderogabili. È implicito che la garanzia si
riferisce solo alla sfera dell’inderogabilità senza estendersi viceversa ai diritti derogabili. L’ambito
di applicabilità si estende fino a ricomprendere tutti i rapporti soggetti al rito del lavoro. Sono
esclusi i lavoratori autonomi, organizzati in forma societaria. Il regime giuridico di questa
disposizione dei diritti è quello dell’annullabilità. Le rinunce o le transazioni ai diritti inderogabili
del lavoratore non sono valide e sono impugnabili da parte del lavoratore. La loro impugnazione è
sottoposta a termini di decadenza, decorrenti: a) dal momento della cessazione del rapporto, se gli
atti si sono verificati in costanza di rapporto di lavoro; b) dal momento della rinuncia o della
transazione se queste ultime sono state poste in essere dopo alla cessazione del rapporto. il termine
di decadenza è di sei mesi. La circostanza secondo cui il termine di impugnazione è neutralizzato in
costanza di rapporto costituisce il riconoscimento giuridico di uno stato di soggezione del
lavoratore. In sostanza l’art. 2113 costituisce la più evidente manifestazione della situazione di
inferiorità contrattuale nella quale si trova il lavoratore dipendente. È per tale ragione che
usualmente si esclude la rilevanza di rinunce tacite ai diritti del lavoratore. L’impugnazione può
aver corso con qualsiasi atto scritto, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore. La norma
prevede un meccanismo che consente la legittima disposizione di diritti del lavoratore, in
circostanze nelle quali la sua volontà è assistita e sorretta dalla presenza di soggetti o organi
istituzionali che siano in grado di rendere edotto il lavoratore delle conseguenze delle sue scelte.
Sono valide le rinunce o le transazioni intervenute: a) davanti al giudice; b) davanti alla
commissione di conciliazione istituita presso la direzione territoriale del lavoro; c) nell’ambito delle
ulteriori sedi conciliative. Il d.lgs. 276/2003 ha previsto che la certificazione delle rinunce e
transazioni può essere effettuata anche presso le sedi di certificazione dagli organi relativi. Mette
infine conto ricordare che sono state prefigurate ulteriori ipotesi di rinunzie inoppugnabili. Secondo
l’art. 11 del d.lgs. 124/2004, qualora nell’intervento ispettivo emergano elementi per una soluzione
conciliativa della controversia, la Dtl può avviare il tentativo di conciliazione. Ove venga raggiunto
un accordo fra le parti, ad esso risulta inapplicabile l’art. 2113 c.c. ed il verbale è dichiarato
esecutivo con decreto del giudice del lavoro. Analogo meccanismo opera nel caso in cui emergano
violazioni della disciplina contrattuale, da parte del datore, che comporti l’insorgere, in capo al
lavoratore, di diritti a carattere patrimoniale. In tale situazione il datore può promuovere un
tentativo di conciliazione presso la Dtl ed anche in tale contesto, ove sopraggiunga l’accordo, al
medesimo non risulta applicabile l’art. 2113. Il contenuto dell’effettiva volontà manifestata dal
lavoratore con l’atto dismissivo deve essere oggetto di interpretazione. È per questa ragione che le
quietanze a saldo non costituiscono rinunzie annullabili e dunque non devono essere impugnate
entro i termini di decadenza previsti dall’art. 2113. Queste ultime sono le dichiarazioni che il datore
fa sottoscrivere al lavoratore, consistenti nell’affermazione secondo cui quest’ultimo ha ricevuto
una determinata somma e dichiara di non avere più nulla da pretendere e/o rinuncia ad ogni diritto
derivante dal rapporto. Secondo dottrina e giurisprudenza si tratta però di mere dichiarazioni dirette
166
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
ad indicare l’effettivo ricevimento delle somme, senza l’espressione di alcuna volontà abdicativa di
diritti. Un cenno a parte va fatto rispetto alle transazioni collettive. Sotto a questa espressione si
nasconde talora il contratto collettivo aziendale, che è diretto alla regolamentazione dei rapporti di
lavoro futuri all’interno di una determinata impresa. È dunque sufficiente tale constatazione per
escludere ogni possibilità di riguardare il fenomeno alla luce della regolamentazione limitativa delle
rinunce e delle transazioni. Possono entrare entro lo specchio della norma codicistica solo quelle
intese contrattuali che riguardino una pluralità di lavoratori e con le quali si pongano in essere atti di
disposizione su diritti che sono già nel patrimonio dei singoli. La giurisprudenza è orientata a
ritenere che tali atti siano suscettibili di impugnazione da parte dei singoli.
4. Va ricordato il particolare atteggiarsi dell’istituto della prescrizione dei diritti del lavoratore.
secondo la disciplina del codice civile, i crediti di lavoro sono collocati nell’ambito delle previsioni
relative ai crediti di natura periodica, cui si applica la prescrizione estintiva quinquennale. Secondo
l’art. 2948 n. 4 c.c. sono soggetti a tale prescrizione i crediti che devono pagarsi periodicamente ad
anno o in tempi più brevi. Un riferimento al rapporto di lavoro è operato dall’art. 2948 n. 5, che
assoggetta al medesimo regime le indennità spettanti per la cassazione del rapporto. La prescrizione
ordinaria decennale in materia di lavoro opera invece solo in ipotesi particolari. Quanto alle
prescrizioni presuntive si prevede la prescrittibilità in un anno per il credito del lavoratore per
retribuzioni corrisposte per periodi non superiori al mese e di tre anni per retribuzioni corrisposte in
periodi superiori. Peraltro le prescrizioni presuntive hanno sempre avuto scarsa rilevanza, tanto che
si è affermato che l’istituto della prescrizione presuntiva è incompatibile con i crediti di lavoro.
Secondo l’art. 2935 c.c. la prescrizione dei crediti di lavoro dovrebbe decorrere dal momento in cui
il diritto può essere fatto valere e quindi anche in circostanza di rapporto di lavoro. In argomento
intervenne una decisione della Corte costituzionale (63/66), con cui fu dichiarata la parziale
incostituzionalità degli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 nella parte in cui consentivano che la
prescrizione decorresse in costanza di rapporto. Si spostò quindi il termine della decorrenza al
momento della cessazione del rapporto. Si argomentò tale conclusione dalla speciale natura del
credito retributivo che costituisce un diritto sociale meritevole di tutela rafforzata. Si trovò
conferma della speciale protezione nel principio codificato proprio nell’art. 2113 c.c. per le rinunce
e le transazioni, principio che faceva presupporre una situazione di inferiorità del lavoratore. È stato
questo aggancio alla regolamentazione giuridica del recesso dal rapporto di lavoro che ha consentito
alla Corte costituzionale una parziale correzione del tiro a seguito dell’introduzione del regime
limitativo dei licenziamenti. È stato così introdotto il principio secondo cui la prescrizione dei
crediti di lavoro corre in costanza di rapporto nell’ambito delle relazioni dotate di stabilità.
Attualmente i termini prescrizionali non decorrono in costanza di rapporto solo con riferimento ai
rapporti rientranti entro la tutela obbligatoria nonché entro la sfera di rilevanza del recesso ad
nutum. Quest’ultima conclusione va misurata con il nuovo assetto della tutela reale risultante dalla
riforma Monti. A rigore si dovrebbe ritornare all’originaria regola sancita dalla Corte costituzionale
nel 1966 e ritenere che la prescrizione non possa decorrere in costanza di rapporto neanche rispetto
ai datori che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori. Tale
conclusione vale con riferimento alla prescrizione dei diritti dei lavoratori assoggettati al regime del
contratto a tutele crescenti. Anche nei rapporti non garantiti da stabilità la prescrizione decorre in
costanza di rapporto il termine prescrizionale ordinario decennale.
5. Al fenomeno dell’estinzione dei diritti si riconduce inoltre l’istituto della decadenza. Essa deve
essere esplicitamente prefigurata dalla legge o dall’autonomia privata. Essa opera precludendo al
titolare l’esercizio del potere giuridico connesso ad una situazione di diritto. Essa inoltre annovera
scarsi esempi nell’ambito dell’ordinamento lavoristico. Le più significative applicazioni sono quelle
167
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
che riguardano l’impugnazione del licenziamento individuale e collettivo, che va effettuata entro 60
giorni dalla comunicazione. Il “Collegato lavoro” ha esteso il regime della decadenza
all’impugnazione di molti atti di gestione dei rapporti di lavoro. L’ordinamento non esclude che la
decadenza possa rinvenire la propria fonte in un atto di autonomia privata, statuendo la nullità dei
patti che rendano difficile ad una delle parti l’esercizio del diritto. Sono in particolare i contratti
collettivi che dispongono clausole di decadenza rispetto all’esercizio di taluni diritti del lavoratore.
Nell’ambito di un orientamento giurisprudenziale si assume che la legittimità di tali clausole deve
essere apprezzata avendo come parametro di raffronto l’art. 2113 c.c. Sono considerate illegittime le
clausole che prevedano termini di decadenza inferiori a quelli previsti dalla legge o che consentano
la decorrenza dei termini in costanza di rapporto.
6. Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri e,
in caso di concorso fra più creditori, operano le cause legittime di prelazione. Il credito di lavoro
gode del privilegio generale sui mobili del datore debitore: a) per le retribuzioni dovute sotto
qualsiasi forma, b) per le indennità dovute per la cessazione del rapporto, c) per il risarcimento dei
danni da omesso versamento dei contributi previdenziali, d) per il risarcimento dei danni
conseguente ad un licenziamento inefficace, nullo o annullabile. A tali crediti occorre aggiungere
quello per danni da demansionamento a causa dell’illegittimo comportamento del datore. Tale
privilegio è di secondo grado, dal momento che è messo al secondo posto dopo la soddisfazione
delle spese di giustizia. In caso di infruttuosa esecuzione sui beni mobili del datore-debitore, i
crediti di lavoro sono collocati sussidiariamente sugli immobili, secondo l’ordine di cui: 1) TFR e
indennità di mancato preavviso, 2) crediti di lavoro e comunque tutti gli altri crediti di cui agli artt.
2751, 2751-bis, 2753 c.c., 3) i crediti dello stato di cui all’art. 2752 comma 2 c.c., 4) crediti
chirografari. Questo sistema di garanzie del credito opera anche all’interno del fallimento e delle
altre procedure concorsuali. Nel caso in cui ci sia esercizio provvisorio dell’impresa fallimentare i
crediti maturati dai lavoratori durante tale periodo sono crediti della massa fallimentare e si
collocano al primo posto nella distribuzione dell’attivo in prededuzione. Per i crediti relativi a
periodi diversi vale il sistema delle garanzie connesso alle cause legittime di prelazione. La
comunità europea, fin dal 1980, ha emanato una Direttiva con cui ha vincolato gli stati membri a
porre in essere forme assicurative allo scopo di sollevare i lavoratori dal rischio conseguente
all’insolvenza dei datori. Alla direttiva è stata data attuazione in due fasi: dapprima con la legge
297/82 e con riferimento all’insolvenza relativa al pagamento del TFR; in un secondo tempo avendo
riguardo agli altri crediti di lavoro, con il d.lgs. 27/01/1992 n. 80. Con quest’ultimo si è previsto
che, nel caso in cui il datore sia assoggettato alle procedure di fallimento, il lavoratore può chiedere
a carico del Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro. La medesima garanzia assicurativa
si applica anche nel caso in cui il lavoratore abbia esperito le procedure di esecuzione forzata.
L’intervento del Fondo è ristretto ai crediti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro
rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento di apertura della procedura
concorsuale, b) la data di inizio dell’esecuzione forzata, c) la data del provvedimento di messa in
liquidazione o di cessazione dell’esercizio dell’impresa per i lavoratori che abbiano continuato a
prestare attività lavorativa o la data della cessazione del rapporto. Il trattamento a carico del fondo
non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento
straordinario di integrazione salariale mensile. Con il d.lgs. 186/2005 è stata data attuazione alla
direttiva comunitaria 74/2002, prevedendosi l’intervento del fondo sia per i crediti di lavoro che per
il TFR. Nella stessa logica si collocano i limiti alla possibilità di aggressione del credito di lavoro da
parte dei creditori del lavoratore. La materia era diversamente regolata per i dipendenti privati e per
quelli pubblici. Per i privati si aveva l’art. 545 comma 4 cod. proc. civ., che limitava la pignorabilità
dei crediti per stipendio o salario e per l’indennità di fine rapporto nella misura di un quinto del loro
168
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
ammontare per crediti di qualsiasi natura. Per i crediti di natura alimentare la misura era determinata
dal giudice. Nella medesima misura di un quinto i crediti di lavoro erano sequestrabili, soggetti a
compensazione o cessione di credito. I pubblici dipendenti godevano di un trattamento di miglior
favore. Tale trattamento è stato però dichiarato costituzionalmente illegittimo per effetto di alcune
sentenze della Corte costituzionale. Con la legge finanziaria del 2005 si è previsto che il d.p.r.
180/1950 sia in parte estensibile anche al settore privato. L’effetto più rilevante riguarda l’ipotesi di
concorso di più richieste di pignoramento sulla retribuzione del dipendente privato. Il pignoramento
non può colpire una quota maggiore del quinto dello stipendio al netto delle ritenute di legge. Per il
simultaneo concorso di crediti tra cui sono presenti quelli alimentari, il pignoramento non può
colpire una quota maggiore della metà dello stipendio. La finanziaria del 2005 ha esteso anche al
settore privato le norme che riguardano le condizioni per poter accedere alla cessione dello
stipendio. Ulteriori limiti al pignoramento dei crediti sono stati introdotti dal d.l. 27/06/2015 n. 83
che ha introdotto i commi 7, 8 e 9 nell’art. 545 cod. proc. civ. Le somme dovute a titolo di
stipendio, salario, altre indennità, relative al rapporto di lavoro o di impiego, nonché a titolo di
pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o assegni di quiescenza, nel caso di accredito
su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate quando l’accredito ha
luogo in data anteriore al pignoramento; nel caso in cui l’accredito abbia luogo alla data del
pignoramento o successivamente, le somme possono essere pignorate nei limiti indicati in
precedenza o nei limiti previsti da leggi speciali. L’eventuale pignoramento difforme è inefficace e
l’inefficacia è rilevabile da parte del giudice.
7. Il quadro delle garanzie ricomprende anche le strumentazioni predisposte per rafforzarne la
realizzazione in termini di effettività. Rientra qui l’articolazione delle tecniche di composizione e
risoluzione delle controversie individuali di lavoro. Dobbiamo distinguere tra forme di risoluzione
delle liti a carattere giudiziale e di natura stragiudiziale. Nel primo caso sarà il giudice a trattare e
risolvere la controversia, mentre nel secondo la deliberazione sarà affidata ad un privato. Vi è anche
un’altra distinzione fra attività conciliativa ed attività risolutiva delle controversie. Nel primo caso il
ruolo del terzo si limita a sollecitare un’attività conciliativa. Il risultato dell’opera di mediazione del
conciliatore contribuirà, dall’esterno, alla definizione della controversia attraverso una transazione
che avrà luogo fra le sole parti del conflitto. Il ruolo del conciliatore è affidato sia al giudice sia alla
Commissione di conciliazione istituita presso la Direzione territoriale del lavoro. Dalla mera attività
conciliativa si distingue quella diretta alla risoluzione della lite attraverso l’affidamento ad un terzo
del relativo incarico. Il terzo darà una valutazione della situazione contenziosa ed emanerà un atto
con il quale affermerà o negherà la sussistenza del diritto soggettivo che si presume leso. A seconda
che il terzo sia un giudice dello stato o un privato, avremo la realizzazione della funzione
giurisdizionale, diretta alla realizzazione di una sentenza, o di una procedura arbitrale, che si
concluderà con l’emanazione di un lodo.
8. Per quanto riguarda la conciliazione, con la riforma del processo del lavoro di cui alla legge
533/1973, è stato predisposto un coordinamento istituzionale fra tutela giurisdizionale e previe
procedure conciliative. Con l’art. 5 della l. 108/1990 il tentativo di conciliazione è stato prefigurato
come obbligatorio per le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti nell’area
della tutela obbligatoria e la medesima previsione è stata introdotta nel 1992 con riferimento alle
controversie in materia di pubblico impiego. Per effetto dei d.lgs. n. 80 e n. 387 del 1998 è stata
imposta l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione per tutte le controversie di lavoro privato e
pubblico, allo scopo di ottenere un decongestionamento degli uffici giudiziari. Con il “Collegato
lavoro” è stato operato un ripiegamento sulle precedenti posizioni, tornandosi alla facoltatività del
tentativo di conciliazione. Il tentativo resta obbligatorio solo in caso di impugnazione dell’atto di
169
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
certificazione, secondo quanto previsto dall’art. 80 del d.lgs. 276/2003 e in caso di licenziamento
per giustificato motivo oggettivo. Il quadro delle procedure di conciliazione si può quindi
riassumersi così: a) il tentativo presso la Direzione territoriale del lavoro e presso gli organi abilitati
alla certificazione; b) il tentativo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dai
sindacati; c) ulteriori modalità di conciliazione regolate dall’art. 412-quarter cod. proc. civ., d) il
tentativo davanti al giudice del lavoro. Per le procedure davanti alla commissione costituita presso
la DTL il nuovo testo dell’art. 410 cod. proc. civ. prevede che chi intende proporre in giudizio una
controversia può promuovere un tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione
territorialmente competente. La comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende
il decorso di ogni termine di decadenza. La procedura è più formalizzata rispetto al passato ed è
articolata come un piccolo processo. Si prevede che la richiesta di conciliazione deve essere
predisposta come una sorta di ricorso introduttivo di una controversia di lavoro dovendo contenere
anche l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa. Se la controparte
intende accettare la procedura di conciliazione, è onerata di depositare una memoria contenente le
difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Se la procedura non viene accettata, resta la libertà di adire
l’autorità giudiziaria. La commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di
conciliazione. Il lavoratore può farsi assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce
mandato. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la p.a. non può dar luogo a
responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave. Se la conciliazione riesce, viene redatto un
processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il
giudice lo dichiara poi esecutivo con decreto. Se invece non viene raggiunto un accordo, la
commissione deve formulare una proposta per la definizione della controversia. Se non è accettata, i
termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. A
conferma del legame che lega il comportamento delle parti in sede conciliativa ai profili valutativi
giudiziali, si assume che al ricorso giurisdizionale devono essere allegati i verbali e le memorie
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. La nuova disciplina cerca inoltre di agevolare
il passaggio dalla procedura di conciliazione a forme di risoluzione arbitrale della lite, prevedendo
che in qualunque fase del tentativo di conciliazione le parti possono indicare la soluzione sulla
quale concordano, riconoscendo il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la
risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via
arbitrale la controversia. Ulteriori sedi e modalità di svolgimento di procedure conciliative o
arbitrali possono essere previste dai contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati.
9. Attraverso l’arbitrato le parti deferiscono ad un terzo il potere di risolvere una controversia. La
fonte di questo potere è nel compromesso o nella clausola compromissoria. È fondamentale la
distinzione fra arbitrato rituale e irrituale. Il primo conduce alla realizzazione di un lodo,
assimilabile alla sentenza; il secondo ha natura negoziale. Ambedue subiscono limitazioni in
relazione alle controversie di lavoro. Queste si spiegano in ragione di un primato della funzione
giurisdizionale, ritenuta più affidabile per la garanzia dei diritti. Per l’arbitrato rituale, le
controversie di lavoro possono esserne oggetto a condizione che ciò sia previsto dalla legge o dai
contratti o accordi collettivi di lavoro. L’istituto dell’arbitrato irrituale è stato rivitalizzato con la
riforma del 1998, con lo scopo di rendere più efficiente e rapida la definizione delle controversie e
decongestionare le aule di giustizia. Restano peraltro significative limitazioni. La primitiva
intenzione del legislatore era quella di consentire che il lavoratore potesse pattuire la clausola
compromissoria al momento dell’assunzione e con riferimento a qualunque tipo di controversia
lavoristica. Tale profilo è stato oggetto di rinvio pregiudiziale alle camere da parte del Presidente
della Repubblica, che ha fatto notare la posizione di debolezza negoziale del lavoratore al momento
dell’assunzione e la delicatezza della previsione che includeva anche le controversie in materia di
170
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
licenziamento fra quelle compromettibili in arbitrato. Si prevede che le parti contrattuali possono
pattuire clausole compromissorie, solo in presenza di omologhe previsioni di accordi interfederali o
contratti collettivi di lavoro. La clausola, a pena di nullità, deve essere certificata dagli organi di
certificazione, dovendo le commissioni accertare la effettiva volontà delle parti di devolvere ad
arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. Tenendo conto delle osservazioni
del Presidente, la versione definitiva della legge prevede che: a) la clausola non può essere pattuita
e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova o se non siano trascorsi almeno 30 giorni
dalla data di stipulazione del contratto; b) la medesima non può riguardare controversie relative alla
risoluzione del contratto di lavoro. La legge si preoccupa di regolare l’ipotesi in cui le parti
sindacali non diano corso alla delega in materia di arbitrato irrituale. In tal caso, trascorsi 12 mesi
dall’entrata in vigore della legge, il ministro del lavoro convoca le organizzazioni dei datori e dei
lavoratori allo scopo di promuovere l’accordo. In caso di mancata stipulazione dell’accordo emana
un decreto con il quale individua in via sperimentale le modalità di attuazione delle previsioni in
materia. Gli arbitri potranno decidere la controversia secondo equità, nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento e dei principi regolatori della materia. È una previsione di difficile
attuazione se si tiene mente alla circostanza che il diritto del lavoro è intessuto di norme
inderogabili. Si prevede poi che gli organi di certificazione possono istituire camere arbitrali o
concludere convenzioni con cui prevedere la costituzione di tali camere. La legge delinea le
modalità di svolgimento dell’arbitrato che può nascere da una iniziativa autonoma delle parti o
inserirsi nel corso di un tentativo di conciliazione. Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto
da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo, in funzione di presidente, scelto di
comune accordo. La parte che intenda ricorrere al collegio deve notificare all’altra un ricorso
sottoscritto personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il
quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell’arbitro di parte e indicare
l’oggetto della domanda, le ragioni sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il
valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Se il convenuto intende
accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro
30 giorni dalla notifica procede alla scelta del presidente e della sede del collegio. In caso di
disaccordo il ricorrente può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui
circondario è la sede dell’arbitrato. Se le parti non anno ancora determinato la sede, il ricorso è
presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro. In caso di scelta
concorde del terzo arbitro e della sede, il convenuto deve depositare presso la sede del collegio una
memoria difensiva sottoscritta da un avvocato cui abbia conferito mondato e presso il quale deve
eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni, le eventuali domande in
via riconvenzionale e l’indicazione dei mezzi di prova. Il ricorrente può depositare una
controreplica. Il collegio fissa il giorno dell’udienza, dandone comunicazione alle parti almeno dieci
giorni prima. All’udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione
riesce, si applicano le regole generali sulle conciliazioni. Se non riesce, il collegio provvede a
interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all’immediata discussione
orale. La controversia è decisa mediante un lodo. Il lodo è impugnabile, entro 30 giorni, per le
ragioni previste dall’art. 808-ter cod. proc. civ., davanti al tribunale, in funzione del giudice del
lavoro che decide in unico grado. Decorso il termine per l’impugnazione o nel caso in cui le parti
abbiano dichiarato di accettare la decisione o se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è
depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il giudice
poi lo dichiara esecutivo con decreto.
10. Le tecniche processuali di risoluzione delle controversie di lavoro hanno una storia
caratterizzata dai tratti della specialità, in ragione della natura dei diritti che vengono in gioco
171
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
nell’ambito del rapporto di lavoro. Fu in particolare il legislatore corporativo che mise mano alla
riforma processuale con i r.d.l. 471/1928 e 1973/1934. La successiva integrazione delle controversie
nel codice di procedura civile del 1942 segnò il venir meno di quelle esigenze di celerità e
concentrazione che erano alla base della riforma. La realizzazione di un disegno innovativo in
materia si ha con la legge 11/08/1973 n. 533. Con tale intervento si è posta mano ad una tutela
giurisdizionale differenziata rispetto all’ordinario processo civile. Questo differenziale resta ancora
oggi, anche se in tempi recenti l’enfasi della differenziazione si è in gran parte attenuata. Per quanto
riguarda il campo di applicazione la legge amplia la platea dei destinatari includendo, inoltre, gli
agenti di commercio e i lavoratori parasubordinati, i mezzadri ed i titolari di contratti agrari. La
competenza è affidata in primo grado ad un giudice monocratico. L’appello avverso le sentenze del
giudice monocratico di primo grado si propone alla Corte d’Appello. La tecnica processuale è
finalizzata alle esigenze di garantire i canoni della concentrazione, oralità e immediatezza, la cui
attenzione è sentita in relazione alle situazioni soggettive che si radicano nel contratto di lavoro. La
domanda si propone con ricorso, che deve essere il più esaustivo possibile. Il datore è onerato di
proporre fin dalla memoria di costituzione tutte le difese ed eccezioni a pena di decadenza. Alla
prima udienza il giudice effettua il tentativo obbligatorio di conciliazione e formula alle parti una
proposta transattiva, il cui rifiuto, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile ai
fini della decisione. Espletato il tentativo, il giudice dovrebbe invitare le parti alla discussione
immediata se non c’è bisogno di attività istruttoria. A questo proposito occorre ricordare che il
giudice è munito di più ampi poteri istruttori ufficiosi. Egli può: disporre d’ufficio l’ammissione di
ogni mezzo di prova; interrogare liberamente sui fatti di causa le persone incapaci di testimoniare o
a cui sia vietato deporre; accedere sui luoghi di lavoro e chiede informazioni alle organizzazioni
sindacali. Garanzie più spiccate sono previste in relazione alla fase decisionale. In primo luogo il
giudice procede alla valutazione del quantum dovuto al lavoratore. Alla stessa stregua può emettere
un’ordinanza di immediato pagamento delle somme non contestate o delle quali ritenga sia stata
raggiunta la prova e tale ordinanza costituisce titolo esecutivo. La sentenza di primo grado è
provvisoriamente esecutiva per legge. La sospensione dell’esecuzione può essere disposta dal
giudice d’appello solo quando dalla stessa possa derivare all’altra parte un gravissimo danno. Con
la legge del 1990 è stato integrato il testo originario dell’art. 431 cod. proc. civ. Rilievo essenziale,
nell’impedire che la durata del processo si traduca in uno svantaggio per la parte che ha ragione, ha
la previsione dell’art. 429 comma 3 cod. proc. civ., secondo cui il giudice deve determinare oltre
agli interessi nella misura legale, anche il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la
diminuzione di valore del suo credito, condannando il datore al pagamento. Con tale previsione il
credito di lavoro ha una tutela rafforzata, senza peraltro trasformare la correlativa posizione
d’obbligo in debito di valore, anziché di valuta. Si deve ritenere che la prova del maggior danno
subito dal creditore è presunta in relazione al fenomeno della svalutazione monetaria. L’estensione
di tale disciplina ai crediti previdenziali ne ha provocato un ridimensionamento. Il legislatore è
intervenuto con l’art. 16 della l. 30/12/1991 n. 412 stabilendo la non cumulabilità di interessi e
rivalutazione monetaria rispetto ai crediti previdenziali e ha esteso il divieto di cumulo anche ai
crediti dei lavoratori dipendenti pubblici e privati (art. 22 comma 36 l. 23/12/1994 n. 724).
Quest’ultima norma è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso della sua riferibilità anche ai
crediti dei lavoratori privati. In materia è intervenuta la Corte costituzionale dichiarando, con la
sentenza 459/2000, la parziale illegittimità della norma nella parte in cui estende anche ai lavoratori
privati il principio dell’incumulabilità. Il rito del lavoro si applica inoltre alle controversie in
materia di previdenza e assistenza obbligatorie sia che abbiano corso fra lavoratore ed enti
previdenziali sia che riguardino i rapporti fra datore ed enti. Infine con il d.lgs. 40/2006, si è
proceduto ad una mini-riforma del processo civile, nella quale vanno ricordate le disposizioni che
172
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
hanno riguardato l’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti
collettivi, e l’introduzione fra i motivi di ricorso in Cassazione della violazione o falsa applicazione
dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro. Il giudice del lavoro estende la propria
competenza giurisdizionale anche alle controversie nell’ambito del lavoro pubblico
contrattualizzato, quanto meno con riferimento a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro
successivo al 30/06/1998. Sono escluse dalla competenza del giudice del lavoro, restando devolute
al giudice amministrativo: a) le controversie del personale il cui rapporto non è stato
contrattualizzato; b) le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione.
Nell’ambito dei processi il giudice ha il potere di conoscere e disapplicare gli atti amministrativi
rilevanti nella controversia. Può altresì adottare nei confronti della p.a. provvedimenti di
accertamento, costitutivi o di condanna. Queste affermazioni della legge hanno la funzione di
rimuovere le resistenze che fenomeni di inerzia o pigrizia intellettuale potevano ingenerare nei
confronti dell’affermazione della completa parificazione sul piano dei rimedi giurisdizionali del
pubblico dipendente al lavoratore privato. Con la riforma Monti è stato introdotto un rito speciale
obbligatorio per le controversie in materia di licenziamenti.
11. Un cenno va fatto infine all’apparato protettivo del lavoratore che si realizza in sede
amministrativa e penale. Nell’ambito dell’organizzazione statale, opera il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, che è a sua volta organizzato a livello periferico con Direzioni territoriali e
regionali del lavoro. Le direzioni territoriali sono poi articolate nel Servizio politiche del lavoro e
nel Servizio Ispezione del lavoro. Compito dell’apparato amministrativo del lavoro è quello della
vigilanza in ordine al rispetto da parte dei datori della normativa di protezione sul piano
previdenziale e su quello della sicurezza del lavoro. Ai compiti per primi indicati provvedono gli
Ispettori del lavoro, ai secondi i funzionari delle ASL. Con il d.lgs. 149/2015 è stato introdotto
l’Ispettorato nazionale del lavoro con la funzione di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva.
L’ispettorato nazionale accorperà le funzioni ispettive facenti capo al ministro del lavoro e agli enti
previdenziali. Con d.lgs. 23/04/2004 n. 124 si è provveduto a razionalizzare delle funzioni ispettive.
Il personale ispettivo è considerato ufficiale di polizia giudiziaria ed ha svariati poteri coercitivi nei
confronti dei datori inadempienti: a) la diffida, che è una sorta di messa in mora del datore a
regolarizzare la situazione illegittima rilevata: b) l’ordine o prescrizione, tramite i quali il
funzionario ispettivo dà attuazione concreta ad una previsione astratta della legislazione. La diffida
è ora regolata dall’art. 13 del d.lgs. 124/2004 e ad essa è stato introdotto il verbale di primo accesso
e la verbalizzazione unica; sul potere di prescrizione vige invece l’art. 20 del d.lgs. 758/1994 e l’art.
15 del d.lgs. 124/2004. Con il d.lgs. 124/2004 è stato introdotto l’istituto della conciliazione
monocratica, con cui la DTL può avviare il tentativo di conciliazione. L’eventuale transazione
raggiunta fra le parti è sottratta all’impugnazione di cui all’art. 2113 c.c. e l’avvenuto adempimento
delle obbligazioni contratte con il verbale estingue anche il procedimento ispettivo. I poteri di
vigilanza degli ispettori sono stati rafforzati nella prospettiva di raggiungere l’obiettivo della lotta la
lavoro sommerso. Allo scopo sono stati introdotti degli strumenti diretti a favorire il ritorno alla
legalità delle imprese che si avvalgono di lavoratori occupati in condizioni di evasione
retributiva/contributiva e a disincentivare il ricorso al lavoro irregolare. Al primo ordine di
interventi va ascritta la strategia di “riemersione”, con cui si consente alle imprese di procedere alla
regolamentazione contributiva dei rapporti di lavoro non risultanti dalle scritture contabili e da altra
documentazione obbligatoria, mediante il pagamento di una parte della contribuzione dovuta. Al
secondo è riconducibile la tecnica dell’imporre alle imprese che intendono accedere alla
concessione di benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di
legislazione sociale il possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Questo è un
documento che attesta che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi assistenziali e
173
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
lOMoARcPSD|10832702
previdenziali. Il d.l. 34/2014, emanato dal governo Renzi, prevede una semplificazione in materia di
DURC, diretta ad ottenere la regolarità contributiva dell’impresa. Si prevede poi che, con decreto
del Ministro del lavoro, saranno definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della
verifica nonché le ipotesi di esclusione. La tutela del lavoratore si è espressa anche attraverso
l’apparato sanzionatorio penale. Territorio di elezione di tale strategia è quello della sicurezza del
lavoro. La tendenza legislativa a ricorrere alla sanzione penale è stata soggetta a revisione critica sia
in ragione della sua scarsa deterrenza, sia per la difficoltà ad individuare l’effettivo responsabile
della violazione. È apparso opportuno un processo di progressiva depenalizzazione degli illeciti in
materia lavoristica, trasformati in illeciti amministrativi. Un primo passo lo si è fatto con la l.
689/1981 che ha convertito in illeciti amministrativi i reati in materia previdenziale ed assistenziale
puniti con la sola ammenda. Sono stati poi oggetto di depenalizzazione i reati in materia di
ricollocamento ordinario. Infine con la l. 06/12/1993 n. 499 il Governo è stato delegato ad emanare
decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria relativa ai rapporti di lavoro. La
delega ha anche avuto ad oggetto la trasformazione delle contravvenzioni in materia di lavoro
punite con la sola ammenda in illeciti amministrativi. Il Governo ha dato attuazione alla delega con
i d.lgs. 24/03/1994 n. 211, 09/09/1994 n. 566 e 19/12/1994 n. 758. All’esito di tale revisione
l’intervento sanzionatorio penale è stato limitato a protezione dei preliminari valori della persona
del lavoratore, implicati nel rapporto. Ne deriva un quadro al cui interno l’applicazione della
sanzione amministrativa costituisce la regola per la maggior parte delle violazioni in materia
lavoristica. Deve soggiungersi che con il d.lgs. 08/06/2001 n. 231 è stata prevista la responsabilità
amministrativa degli enti dotati di personalità giuridica, delle società e delle associazioni anche
prive di capacità giuridica, esclusi gli enti pubblici, per i reati commessi nel suo interesse o a suo
vantaggio da amministratori o direttori dell’ente, da persone che esercitano anche di fatto la
gestione e il controllo dello stesso nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei
soggetti appena indicati.
174
Scaricato da gd ggf (macey56471@luxiu2.com)
Potrebbero piacerti anche
- Diritto Del Lavoro PDFDocumento78 pagineDiritto Del Lavoro PDFMarco de BernardiNessuna valutazione finora
- Riassunto Ghera Diritto Del LavoroDocumento127 pagineRiassunto Ghera Diritto Del LavoroCarmen LacuocaNessuna valutazione finora
- Manuale Diritto Del Lavoro Ghera Aggiornato Al 2009Documento121 pagineManuale Diritto Del Lavoro Ghera Aggiornato Al 2009Mariagrazia Vittoria NappaNessuna valutazione finora
- Diritto Del Lavoro GheraDocumento58 pagineDiritto Del Lavoro GheraLayla_cre100% (3)
- Subordinazione e AutonomiaDocumento2 pagineSubordinazione e AutonomiaEnrico BalliNessuna valutazione finora
- La contrattazione collettiva e la qualificazione dei rapporti di lavoroDa EverandLa contrattazione collettiva e la qualificazione dei rapporti di lavoroNessuna valutazione finora
- Diritto Del Lavoro Ghera Edizione 2020Documento147 pagineDiritto Del Lavoro Ghera Edizione 2020Biagio Biandolino100% (1)
- Ghera Diritto Del Lavoro RiDocumento110 pagineGhera Diritto Del Lavoro RiFrancesco BenedettoNessuna valutazione finora
- Diritto Del Lavoro, Riassunti Carinci, Treu, Tosi, de Luca e TamajoDocumento120 pagineDiritto Del Lavoro, Riassunti Carinci, Treu, Tosi, de Luca e Tamajoflorentinaivona100% (1)
- Diritto Del LavoroDocumento8 pagineDiritto Del Lavoroarianna.gazzaneo23Nessuna valutazione finora
- Appunti Lezioni Diritto Del LavoroDocumento113 pagineAppunti Lezioni Diritto Del LavoroCamilla ZanattaNessuna valutazione finora
- Riassunto Diritto Del Lavoro Subordinato Ghera Garilli GarofaloDocumento122 pagineRiassunto Diritto Del Lavoro Subordinato Ghera Garilli GarofaloAlessandra Giada MigliettaNessuna valutazione finora
- Diritto Sindacale Giugni 2010Documento74 pagineDiritto Sindacale Giugni 2010Francesco Villafrate100% (1)
- SindacaleDocumento167 pagineSindacaleFrancesca VertaldiNessuna valutazione finora
- Riassunto Diritto Del Lavoro E. Ghera 2010Documento162 pagineRiassunto Diritto Del Lavoro E. Ghera 2010Francesco BenedettoNessuna valutazione finora
- Carinci Il Diritto SindacaleDocumento113 pagineCarinci Il Diritto SindacaleMike MurdacaNessuna valutazione finora
- Riassunto Diritto Del LavoroDocumento113 pagineRiassunto Diritto Del LavoroAlessandra PignataroNessuna valutazione finora
- Diritto Del LavoroDocumento123 pagineDiritto Del LavoroSara CastellaniNessuna valutazione finora
- Diritto Sindacale GiugniDocumento135 pagineDiritto Sindacale GiugniAda IessiNessuna valutazione finora
- Giugni - Riassunto Diritto SindacaleDocumento157 pagineGiugni - Riassunto Diritto SindacaleLorenzoNessuna valutazione finora
- Appunti Di Diritto Del LavoroDocumento60 pagineAppunti Di Diritto Del Lavorospiga1972Nessuna valutazione finora
- Appunti Diritto Del LavoroDocumento76 pagineAppunti Diritto Del LavoromikhaelspertiNessuna valutazione finora
- La sicurezza sul lavoro tra figure sintomatiche e valutazione dei rischiDa EverandLa sicurezza sul lavoro tra figure sintomatiche e valutazione dei rischiNessuna valutazione finora
- Perulli - Nuove Frontiere Del Diritto Del LavoroDocumento26 paginePerulli - Nuove Frontiere Del Diritto Del LavoroTauredon100% (1)
- La Corruzione tra privati: La guida completa per dirigenti, amministratori delegati e responsabili d’azienda, per districarsi in una norma che in pochi conoscono.Da EverandLa Corruzione tra privati: La guida completa per dirigenti, amministratori delegati e responsabili d’azienda, per districarsi in una norma che in pochi conoscono.Nessuna valutazione finora
- Diritto Sindacale II ParteDocumento63 pagineDiritto Sindacale II Partechiaralonardo2015Nessuna valutazione finora
- Riassunto SindacaleDocumento88 pagineRiassunto Sindacalemarikasonnessa.577900Nessuna valutazione finora
- Diritto Lavoro - Dal PuntaDocumento121 pagineDiritto Lavoro - Dal PuntaGianni Bi Petrucci100% (1)
- Buonocore CommercialeDocumento129 pagineBuonocore CommercialeEnrico AppleNessuna valutazione finora
- Diritto Commerciale - Cap.2Documento22 pagineDiritto Commerciale - Cap.2Silvana LosiNessuna valutazione finora
- Diritto Del LavoroDocumento52 pagineDiritto Del LavoroPaolo BrunoNessuna valutazione finora
- ITA - Livro - Perfis Da Empresa - AsquiniDocumento22 pagineITA - Livro - Perfis Da Empresa - AsquiniNadson CostaNessuna valutazione finora
- Diritto Del LavoroDocumento54 pagineDiritto Del LavoroElena FioreNessuna valutazione finora
- I licenziamenti collettivi dopo il jobs act: Tra legislazione e giurisprudenzaDa EverandI licenziamenti collettivi dopo il jobs act: Tra legislazione e giurisprudenzaNessuna valutazione finora
- Diritto Del LavoroDocumento56 pagineDiritto Del LavoroChiara MarchitelliNessuna valutazione finora
- Diritto Del Lavoro - Riassunto Carinci Treu 8a EdizioneDocumento102 pagineDiritto Del Lavoro - Riassunto Carinci Treu 8a EdizioneLorenzoMaffini100% (2)
- Appunti CommercialeDocumento158 pagineAppunti Commercialegiulia dellabiancaNessuna valutazione finora
- Lezione N. 1 Vessia OriginalDocumento6 pagineLezione N. 1 Vessia OriginalDario PiccoliNessuna valutazione finora
- Diritto Dello Spettacolo Modulo 1Documento12 pagineDiritto Dello Spettacolo Modulo 1Francesco DimizianiNessuna valutazione finora
- 1DirLavFonNaz MercatorumDocumento8 pagine1DirLavFonNaz MercatorumGabrieleNessuna valutazione finora
- Diritto Privato 13.03Documento8 pagineDiritto Privato 13.03Luca CovielloNessuna valutazione finora
- Contratto e Rapporto Di LavoroDocumento61 pagineContratto e Rapporto Di LavoroAngela DatiNessuna valutazione finora
- Riassunti Manuale Di Diritto Sindacale Carinci - Tamajo - Tosi - TreuDocumento58 pagineRiassunti Manuale Di Diritto Sindacale Carinci - Tamajo - Tosi - TreuTiziana Letizia100% (3)
- Riassunto Di Diritto Civile Del Libro I Contratti Di Cataudella - DocxDocumento44 pagineRiassunto Di Diritto Civile Del Libro I Contratti Di Cataudella - DocxJhonny StecchinoNessuna valutazione finora
- Smart working da barriera architettonica a nuova opportunitàDa EverandSmart working da barriera architettonica a nuova opportunitàNessuna valutazione finora
- Diritto LavoroDocumento50 pagineDiritto LavorogiuNessuna valutazione finora
- Schede Lavoro - Di Antonella FaucciDocumento11 pagineSchede Lavoro - Di Antonella Fauccievelina_de_magistrisNessuna valutazione finora
- Diritto Del Lavoro GALANTINO OKDocumento147 pagineDiritto Del Lavoro GALANTINO OKLuca Martini100% (2)
- Diritto Commerciale Di Buonocore 3Documento168 pagineDiritto Commerciale Di Buonocore 3Gianmarco GaldoNessuna valutazione finora
- DIRITTO DEL LAVORO (Zappalà)Documento19 pagineDIRITTO DEL LAVORO (Zappalà)lucaNessuna valutazione finora
- DIRITTO DEL LAVORO Riassunto Del Libro Il Rapporto Di Lavoro Subordinato UTET Prof Tosi Prof TreuDocumento80 pagineDIRITTO DEL LAVORO Riassunto Del Libro Il Rapporto Di Lavoro Subordinato UTET Prof Tosi Prof TreuMike MurdacaNessuna valutazione finora
- Compendio di DIRITTO DEL LAVORO facile facile - Terza EdizioneDa EverandCompendio di DIRITTO DEL LAVORO facile facile - Terza EdizioneValutazione: 1 su 5 stelle1/5 (1)
- I principi generali dell'attività amministrativa ed il legittimo affidamento del cittadinoDa EverandI principi generali dell'attività amministrativa ed il legittimo affidamento del cittadinoNessuna valutazione finora
- Manuale facile per il concorso da Agenti ed Ufficiali di Polizia MunicipaleDa EverandManuale facile per il concorso da Agenti ed Ufficiali di Polizia MunicipaleNessuna valutazione finora
- Il custode giudiziario nelle esecuzioni immobiliariDa EverandIl custode giudiziario nelle esecuzioni immobiliariNessuna valutazione finora
- Appunti Diritto Del LavoroDocumento76 pagineAppunti Diritto Del LavoromikhaelspertiNessuna valutazione finora
- 5910 - Bando Graduatorie Istituto A.A. 2020-2023 Di Pianoforte (Codi-21) e Fagotto (Codi-12)Documento18 pagine5910 - Bando Graduatorie Istituto A.A. 2020-2023 Di Pianoforte (Codi-21) e Fagotto (Codi-12)Jack Daniel BristowNessuna valutazione finora
- Diritto Del Lavoro Corso Completo Prof Andrea Lassandarsi (Università Di Bologna A.S. 2021/2022)Documento57 pagineDiritto Del Lavoro Corso Completo Prof Andrea Lassandarsi (Università Di Bologna A.S. 2021/2022)miriam1skibaNessuna valutazione finora
- ZoppoliDocumento15 pagineZoppoliMarco TrevisanNessuna valutazione finora
- Pet 1B - Técnico em Seg. Do TrabalhoDocumento84 paginePet 1B - Técnico em Seg. Do TrabalhoLaryssa VenturaNessuna valutazione finora