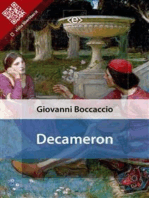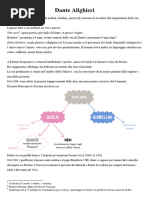Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Boccaccio Riassunto
Caricato da
Annalisa Mazzorana0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
49 visualizzazioni3 pagineTitolo originale
Boccaccio riassunto
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
49 visualizzazioni3 pagineBoccaccio Riassunto
Caricato da
Annalisa MazzoranaCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 3
Giovanni Boccaccio — Fonte: Ansa
Giovanni Boccaccio comincia la stesura del suo
capolavoro, il Decameron, a pochissima distanza dalla grave epidemia di peste che devastò
l’Europa nel Trecento, intorno al 1349 quindi, e continuando il lavoro di scrittura e
revisione fino al 1353.
Alcuni dati lasciano intendere che almeno le prime tre giornate, e le rispettive novelle,
circolassero già prima della stesura definitiva dell’opera: in apertura della quarta giornata
infatti, troviamo un’introduzione dell’autore in cui questo difende il suo lavoro dalle
critiche che dovevano essere state rivolte alle prime novelle.
Approfondisci
Nonostante le critiche, l’opera trova un pubblico
immediatamente entusiasta! Fino al XVII° secolo vengono copiati manoscritti di ogni
fattura e in ogni ambiente sociale (codici ricchi o poveri, posseduti da mercanti oppure a
corte) e con la nascita della stampa il Decameron sarà uno dei testi più diffusi dalle
tipografie. Pietro Bembo, nel delicato periodo che nel Cinquecento è noto come “questione
della lingua” propone di utilizzare il Decameron come testo a modello della prosa
letteraria, una proposta accolta con grandissimo successo. Non fu sempre una storia felice
quella della circolazione dell’opera però: nel 1559 venne inserita nell’Indice dei libri
proibiti ma continuò a circolare sia in forma clandestina – schivando la censura – sia in
strane copie “moralizzate”, cioè mutile delle parti più licenziose e corrotte secondo il
giudizio della Chiesa.
La brigata del Decameron — Fonte: Ansa
In riferimento alla struttura narrativa del Decameron si parla di
una “cornice” entro cui vengono ad inserirsi le novelle. Questo espediente, è un tipo di
struttura molto diffuso nella letteratura medievale (sempre molto attenta a offrire testi
ordinati, coerenti e ricchi di richiami interni ragionati). In cosa consiste allora? La cornice
è la situazione di base e di partenza del racconto, è la situazione narrativa entro la quale si
decide di raccontare novelle che figurano come una seconda situazione narrativa,
un secondo grado della narrazione.
2.1
Baldassarre Calamai, dipinto raffigurante la peste del 1348 descritta
da Boccaccio — Fonte: Ansa
La cornice viene presentata subito all’inizio
dell’opera: un gruppo di giovani, sette ragazze (Pampinea, Fiammetta, Filomena,
Lauretta, Neifile ed Elissa) e tre ragazzi (Panfilo, Filostrato e Dioneo) si incontrano a
Firenze, nella chiesa di Santa Maria Novella, mentre la città è devastata dalla
terribile peste del ’48.
Per sfuggire alla malattia e per dimenticare la sofferenza e la desolazione che regna a
Firenze, i dieci ragazzi decidono di abbandonare la città e di trasferirsi, un mercoledì
mattina, in campagna, in una villa circondata dalla natura, luoghi ameni, e da una pace
incontrastata. Per tenere lontano ogni cattivo pensiero e ogni cattiva notizia che potrebbe
giungere dall’esterno, i giovani decidono che, a turno, racconteranno ognuno
una novella per intrattenersi e riflettere sul significato di ogni storia. A decidere il tema a
cui ogni novella dovrà rispondere sarà il re o la regina della giornata: ogni giorno verrà
eletto un giovane del gruppo che arbitrerà i racconti.
Pensando a questo passatempo dobbiamo ricordarci che le letture e l’ascolto pubblico di
novelle, cantari e facezie, era un’attività diffusissima nel medioevo. Immaginare dei
ragazzi che si incontrano per raccontarsi novelle e storie fantasiose potrebbe far pensare al
prototipo di un gruppo di ragazzi di oggi che si consigliano – e poi vedono assieme – dei
film famosi e particolarmente appassionanti!
Potrebbero piacerti anche
- La grande guerra di Clemente: Itinerarium Poësis in DeumDa EverandLa grande guerra di Clemente: Itinerarium Poësis in DeumNessuna valutazione finora
- Tesi Completa DecameronDocumento18 pagineTesi Completa DecameronEcaterina EcsNessuna valutazione finora
- Shakespeare William - Il Mercante Di VeneziaDocumento157 pagineShakespeare William - Il Mercante Di Veneziazonoz100% (1)
- W. Shakespeare-La TempestaDocumento154 pagineW. Shakespeare-La Tempestacmarino92100% (1)
- 17 Le Origini Della NovellaDocumento13 pagine17 Le Origini Della NovellaColumbro JosephPio100% (1)
- Aleksandr Sergeevic Puskin - Eugene OneginDocumento143 pagineAleksandr Sergeevic Puskin - Eugene OneginLos Ciudadanos HablanNessuna valutazione finora
- Issue Nr. 13: 08. Asino e Asini. Una Lunga Storia - Gian Mario Anselmi (Università Di Bologna)Documento19 pagineIssue Nr. 13: 08. Asino e Asini. Una Lunga Storia - Gian Mario Anselmi (Università Di Bologna)Parole rubate. Rivista internazionale di studi sulla citazione / Purloined Letters. An International Journal of Quotation StudiesNessuna valutazione finora
- Giovanni BoccaccioDocumento2 pagineGiovanni BoccaccioFrancesco MoracaNessuna valutazione finora
- Domande Aperte Della CorteDocumento19 pagineDomande Aperte Della CorteFrancesca clemeno100% (1)
- Boccaccio 1Documento19 pagineBoccaccio 1Ortensia PatriziNessuna valutazione finora
- BoccaccioDocumento3 pagineBoccacciotagliavini.matteo07Nessuna valutazione finora
- Giovanni BoccaccioDocumento9 pagineGiovanni Boccacciosarauccheddu.didatticaNessuna valutazione finora
- Boccaccio Vita e DecameronDocumento5 pagineBoccaccio Vita e DecameronAnna Di PintoNessuna valutazione finora
- Giovanni BoccaccioDocumento11 pagineGiovanni BoccacciovenereNessuna valutazione finora
- Sbobine Letteratura ItalianaDocumento215 pagineSbobine Letteratura Italianamiriam venosiNessuna valutazione finora
- W. Shakespeare-La TempestaDocumento154 pagineW. Shakespeare-La Tempestacmarino92100% (1)
- Shakespeare La TempestaDocumento154 pagineShakespeare La TempestaCarlo Bugli Restauri100% (1)
- La TempestaDocumento154 pagineLa TempestaEnzo Tranese100% (1)
- BoccaccioDocumento4 pagineBoccacciofaty chatNessuna valutazione finora
- Giovanni BoccaccioDocumento6 pagineGiovanni BoccacciogianniNessuna valutazione finora
- Giovanni Boccaccio Opere e PoeticaDocumento5 pagineGiovanni Boccaccio Opere e PoeticaIspasiaNessuna valutazione finora
- Francesco PetrarcaDocumento18 pagineFrancesco PetrarcaClaudio Di BiaseNessuna valutazione finora
- Il Novellino +il Libro Dei Sette Savi InfosDocumento3 pagineIl Novellino +il Libro Dei Sette Savi InfosToni MaffNessuna valutazione finora
- Giovanni BoccaccioDocumento4 pagineGiovanni BoccacciosoniaNessuna valutazione finora
- BoccacioDocumento2 pagineBoccacioViola GagliardiNessuna valutazione finora
- Giovanni Boccaccio NE BRISI222Documento5 pagineGiovanni Boccaccio NE BRISI222Tamara MilovanovićNessuna valutazione finora
- BoccaccioDocumento8 pagineBoccaccioGiada Femino’Nessuna valutazione finora
- BoccaccioDocumento3 pagineBoccacciodavideNessuna valutazione finora
- Boccaccio + Novella Delle PapereDocumento8 pagineBoccaccio + Novella Delle Paperedarrigoflavia9Nessuna valutazione finora
- Anna Klimkiewicz 「Il Sogno Di Polifilo e L'Amorosa Visione Di Giovanni Boccaccio」Documento9 pagineAnna Klimkiewicz 「Il Sogno Di Polifilo e L'Amorosa Visione Di Giovanni Boccaccio」Kerberus BarbarossaNessuna valutazione finora
- TI NBreve BoccaccioDocumento8 pagineTI NBreve BoccaccioantonioxzyNessuna valutazione finora
- Parini GiuseppeDocumento3 pagineParini GiuseppeMarco UrasNessuna valutazione finora
- Le Forme Brevi e La NovellaDocumento2 pagineLe Forme Brevi e La NovellaIreneLunettiNessuna valutazione finora
- Giovanni BoccaccioDocumento3 pagineGiovanni BoccaccioTonia IannielloNessuna valutazione finora
- Letteratura BoccaccioDocumento7 pagineLetteratura Boccacciofrancesca amodioNessuna valutazione finora
- Appunti Filologia II ParteDocumento8 pagineAppunti Filologia II ParteMatilde BoscheleNessuna valutazione finora
- Lezione 2: Il 1300: Firenze Lavoro Guelfi Bianchi Esilio-Tha Hương Divina CommediaDocumento6 pagineLezione 2: Il 1300: Firenze Lavoro Guelfi Bianchi Esilio-Tha Hương Divina CommediaKim Anh NguyễnNessuna valutazione finora
- Il Romanzo: Letteratura Italiana Università Telematica Universitas MercatorumDocumento161 pagineIl Romanzo: Letteratura Italiana Università Telematica Universitas MercatorumGabriele BacollaNessuna valutazione finora
- Giovanni Boccaccio 2Documento5 pagineGiovanni Boccaccio 2Catalina SaboNessuna valutazione finora
- I Settala. L'arte, la scienza e la peste: Da Federico Borromeo ad Alessandro ManzoniDa EverandI Settala. L'arte, la scienza e la peste: Da Federico Borromeo ad Alessandro ManzoniNessuna valutazione finora
- Giovanni Boccaccio Nacque in Un Paese Di FirenzeDocumento3 pagineGiovanni Boccaccio Nacque in Un Paese Di Firenzepart meloNessuna valutazione finora
- Romanticismo - ManzoniDocumento14 pagineRomanticismo - ManzoniTabatha MazzaboNessuna valutazione finora
- BoccaccioDocumento1 paginaBoccacciomarghe.rossato06Nessuna valutazione finora
- Petrarca e Le Opere.Documento9 paginePetrarca e Le Opere.Vincenzo LazzariNessuna valutazione finora
- BoccaccioDocumento7 pagineBoccaccioz8kjqh524mNessuna valutazione finora
- BoccaccioDocumento4 pagineBoccaccioGioia StaffieroNessuna valutazione finora
- Issue Nr. 6: 06. I "Gravissimi Autori" Del "Fuggilozio" - Sandra Carapezza (Università Statale Di Milano)Documento19 pagineIssue Nr. 6: 06. I "Gravissimi Autori" Del "Fuggilozio" - Sandra Carapezza (Università Statale Di Milano)Parole rubate. Rivista internazionale di studi sulla citazione / Purloined Letters. An International Journal of Quotation StudiesNessuna valutazione finora
- I Classici Della LetteraturaDocumento87 pagineI Classici Della LetteraturaresistenzaoltranzaNessuna valutazione finora
- Ippolito Nievo Analisi Storia FilosoficaDocumento8 pagineIppolito Nievo Analisi Storia FilosoficaRita CascellaNessuna valutazione finora
- Filologia Romanza 1Documento12 pagineFilologia Romanza 1Carlotta PennavariaNessuna valutazione finora
- Ricerche Amadis de GaulaDocumento17 pagineRicerche Amadis de GaulaSimone giummoNessuna valutazione finora
- Boccaccio e UmanesimoDocumento15 pagineBoccaccio e UmanesimoMarco UrasNessuna valutazione finora
- Appunti Su Promessi Sposi, Introduzione, Spiegazione A Grandi Linee Del RomanzoDocumento4 pagineAppunti Su Promessi Sposi, Introduzione, Spiegazione A Grandi Linee Del RomanzoSamuele LivraghiNessuna valutazione finora
- BoccaccioDocumento7 pagineBoccaccioCristian ChirNessuna valutazione finora
- Il Sogno Di PicoDocumento37 pagineIl Sogno Di PicoPietro RossiNessuna valutazione finora
- BoccaccioDocumento7 pagineBoccaccioSelene BaccinelliNessuna valutazione finora
- DanteDocumento10 pagineDanteNicole ChurchNessuna valutazione finora
- Corrado Bologna Miti Di Una Letteratura Medioevale: Il SudDocumento31 pagineCorrado Bologna Miti Di Una Letteratura Medioevale: Il Sudoremex100% (1)
- Le Nuove Ferrovie Del Medio OrienteDocumento5 pagineLe Nuove Ferrovie Del Medio OrienteAnnalisa MazzoranaNessuna valutazione finora
- Una Guerra Troppo VicinaDocumento4 pagineUna Guerra Troppo VicinaAnnalisa MazzoranaNessuna valutazione finora
- L'arte Del Dolce Far NienteDocumento5 pagineL'arte Del Dolce Far NienteAnnalisa MazzoranaNessuna valutazione finora
- Petrarca RiflessioniDocumento1 paginaPetrarca RiflessioniAnnalisa MazzoranaNessuna valutazione finora
- Password Wifi VeloceDocumento1 paginaPassword Wifi VeloceAnnalisa MazzoranaNessuna valutazione finora
- Romano Ruggeri: Vi Racconto La Lezione Di Polidoro Virgili - Il Resto Del Carlino Del 3 Marzo 2023Documento2 pagineRomano Ruggeri: Vi Racconto La Lezione Di Polidoro Virgili - Il Resto Del Carlino Del 3 Marzo 2023Università degli Studi di Urbino Carlo BoNessuna valutazione finora
- Alleluia: "Irlandese"Documento1 paginaAlleluia: "Irlandese"Fresia RobertoNessuna valutazione finora
- FRFRRDocumento5 pagineFRFRRapollodoro87Nessuna valutazione finora
- Regole Lupi Ita+EngDocumento2 pagineRegole Lupi Ita+EngIl GobbiNessuna valutazione finora
- BN, Pagine Affiancate - Tales of The Broken IslandsDocumento21 pagineBN, Pagine Affiancate - Tales of The Broken IslandsStefano ZauriNessuna valutazione finora
- Carrozza e Locomotiva in LetteraturaDocumento2 pagineCarrozza e Locomotiva in LetteraturabesciamellaNessuna valutazione finora
- Pathfinder - Scheda Del PersonaggioDocumento2 paginePathfinder - Scheda Del Personaggio*Fabbri*Nessuna valutazione finora
- D.annunzio 1Documento3 pagineD.annunzio 1LuigiNessuna valutazione finora
- Internazionale 1390Documento132 pagineInternazionale 1390IrmaVelasquezNessuna valutazione finora
- La Conquista Dell'impero Dei Sogni: D'Annunzio e PirandelloDocumento20 pagineLa Conquista Dell'impero Dei Sogni: D'Annunzio e PirandelloBruna GulinoNessuna valutazione finora
- Testi Di Foscolo PDFDocumento6 pagineTesti Di Foscolo PDFFrancesca Di GraziaNessuna valutazione finora
- Concezioni Dellanima Nel Pensiero Greco ArcaicoDocumento102 pagineConcezioni Dellanima Nel Pensiero Greco ArcaicoMonica MoresiNessuna valutazione finora
- 455 - Canterò Le Meraviglie Del SignorDocumento5 pagine455 - Canterò Le Meraviglie Del SignorMariassunta PepeNessuna valutazione finora
- Giovanni PascoliDocumento14 pagineGiovanni PascoliTommaso VangelistiNessuna valutazione finora
- Articolo TorinoDocumento22 pagineArticolo TorinoSabrina MancusoNessuna valutazione finora
- Arlecchino 41Documento1 paginaArlecchino 41Teo FavaroNessuna valutazione finora