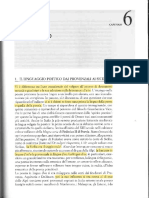Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
La Scuola Siciliana
La Scuola Siciliana
Caricato da
Matteo QuintilianiCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
La Scuola Siciliana
La Scuola Siciliana
Caricato da
Matteo QuintilianiCopyright:
Formati disponibili
LA SCUOLA SICILIANA
Nella produzione poetica siciliana si riscontra una comunanza di temi e di stili riconducibili alla
presenza di un caposcuola, Iacopo da Lentini, che rielabora il modello provenzale. Non va
dimenticato poi che l’aspetto più rivoluzionario di questa scuola consiste nella creazione e
nell’adozione di un codice poetico in lingua volgare. L’attenzione dei poeti della Scuola Siciliana si
concentra totalmente sull’amor fino, cioè perfetto, essi inoltre cercano di esaltare, tramite
similitudini tratte dall’ambito naturalistico e scientifico, lo splendore dell’amata (che appare
sempre meno concreta, quasi sublimata e divinizzata, anticipando quanto avverrà in Guinizelli e
negli stilnovisti). Sul piano delle strutture metriche con la scuola siciliana si affermano
definitivamente nella tradizione letteraria italiana due forme principali: la canzone e il sonetto,
quasi. La lingua poetica usata dai siciliani è di livello alto, curata sotto l’aspetto lessicale e ricca di
artifici retorici: alla base troviamo il volgare siciliano, privato di ogni residuo dialettale e
fortemente influenzato dal periodare latino.
LA LIRICA TOSCANA
La cultura poetica siciliana non sopravvive alla fine del dominio svevo nell’Italia meridionale in
seguito alla battaglia di Benevento. Fortunatamente, la ricca esperienza poetica elaborata alla
corte di Federico non scompare ma si trasferisce al nord nell’area emiliana e toscana. A differenza
dei siciliani, i poeti di questa nuova fase della lirica non possono essere identificati con il termini
unitario di “scuola” per la grande diversità che li caratterizza sia sul piano della poetica sia su
quello del linguaggio. Questi poeti si ispirano e al modello siciliano e a quello provenzale
apportando importanti novità sul piano tematico e formale. Per quanto riguarda le scelte
contenutistiche accanto al tema amoroso, ricompaiono i riferimenti cronachistici, la tematica
morale e soprattutto quella politica. Innovativa è l’adozione di un volgare toscano alto. In Italia
viene introdotta per la prima volta dai rimatori toscani la ballata, sconosciuta ai siciliani.
POESIA COMICO REALISTICA
Genere poetico che, si affermò nel XIII secolo in Toscana. Rustico Filippi, Forese Donati e
soprattutto Cecco Angiolieri furono i massimi rappresentanti di questo genere.
I temi di queste poesie sono popolareschi e legati al dato realistico, e vengono resi in uno stile
comico, ma non perciò poco letterario. In risposta polemica all’idealizzazione poetica stilnovista,
l'amore diventa in questi autori rapporto fisico; alla nobiltà di nascita e d'animo si sostituisce la
ricerca della ricchezza economica, unita a un disprezzo per le raffinatezze culturali.
Potrebbero piacerti anche
- Grammatica Siciliana ARTURO MESSINA 2007 PDFDocumento282 pagineGrammatica Siciliana ARTURO MESSINA 2007 PDFkalorsky0% (1)
- Letteratura Italiana - Sintesi GeneraleDocumento26 pagineLetteratura Italiana - Sintesi GeneraleYuva VikazNessuna valutazione finora
- Cittadinanza DigitaleDocumento21 pagineCittadinanza DigitaleMatteo QuintilianiNessuna valutazione finora
- Analfabetismo1 PPTDocumento50 pagineAnalfabetismo1 PPTAntonella MariniNessuna valutazione finora
- Rima SicilianaDocumento4 pagineRima Sicilianafanfan333100% (1)
- Astrologia Della Trasformazione - RudhyarDocumento748 pagineAstrologia Della Trasformazione - RudhyartonyNessuna valutazione finora
- Bach - Studio Di PasoliniDocumento45 pagineBach - Studio Di PasoliniMatteo Lambardi100% (1)
- Letteratura Italiana Dalle Origini A Meta Cinquecento Manuale Per Studi Universitari MondadoriDocumento59 pagineLetteratura Italiana Dalle Origini A Meta Cinquecento Manuale Per Studi Universitari MondadoriNicoló AnselmiNessuna valutazione finora
- Breve Storia Della Letteratura ItalianaDocumento25 pagineBreve Storia Della Letteratura ItalianaMonica VolpeNessuna valutazione finora
- Breve Storia Della Letteratura ItalianaDocumento158 pagineBreve Storia Della Letteratura ItalianaAnonymous HyP72Jv100% (1)
- Letteratura ItalianaDocumento6 pagineLetteratura Italianafrancone_mNessuna valutazione finora
- Rosacroce Ed ErmetismoDocumento12 pagineRosacroce Ed ErmetismoVale CuzNessuna valutazione finora
- Poesia 200Documento52 paginePoesia 200paola nazzaroNessuna valutazione finora
- Riassunto Letteratura Italiana Fino Al Dolce Stil NovoDocumento6 pagineRiassunto Letteratura Italiana Fino Al Dolce Stil NovoGianbattista BusoneraNessuna valutazione finora
- Verifica 06 4Documento1 paginaVerifica 06 4Giuseppe V. ZechenderNessuna valutazione finora
- La Scuola SicilianaDocumento7 pagineLa Scuola SicilianaNadja PetrovicNessuna valutazione finora
- Riassunti ManualeDocumento3 pagineRiassunti ManualeAlice ZizzaNessuna valutazione finora
- Alfano 1-2-3-4Documento34 pagineAlfano 1-2-3-4GIULIA TOMINessuna valutazione finora
- SCUOLASICILIANADocumento4 pagineSCUOLASICILIANAMatteo QuintilianiNessuna valutazione finora
- Let T Relig Dolce Stil NovoDocumento2 pagineLet T Relig Dolce Stil NovoDavideBoccanfusoNessuna valutazione finora
- Scuola Poetica Siciliana Prodotto FinaleDocumento5 pagineScuola Poetica Siciliana Prodotto Finalerobloxuserjulian321Nessuna valutazione finora
- Italiano 4Documento27 pagineItaliano 4Alessandra PesolaNessuna valutazione finora
- La Scuola SicilianaDocumento2 pagineLa Scuola SicilianamalviynNessuna valutazione finora
- A-B ItalianoDocumento116 pagineA-B Italianobarbara.pirroNessuna valutazione finora
- Esame LetteraturaDocumento53 pagineEsame LetteraturaLudovico FraschiniNessuna valutazione finora
- File 3Documento28 pagineFile 3Gino PinoNessuna valutazione finora
- La Scuola Poetica SicilianaDocumento5 pagineLa Scuola Poetica SicilianaMartaNessuna valutazione finora
- La Scuola SicilianaDocumento2 pagineLa Scuola SicilianaFlorinda TodinoNessuna valutazione finora
- Ferroni Riassunto Da Dante A PascoliDocumento57 pagineFerroni Riassunto Da Dante A Pascoliperrichiara76Nessuna valutazione finora
- La Scuola Poetico SicilianaDocumento2 pagineLa Scuola Poetico Sicilianaandreamastro2706Nessuna valutazione finora
- Letteratura Italiana Manuale Per Studi Universitari Vol 1 e Vol 2Documento76 pagineLetteratura Italiana Manuale Per Studi Universitari Vol 1 e Vol 2sftgukkie 97Nessuna valutazione finora
- Pascoli GiovanniDocumento4 paginePascoli Giovanniilariacafaro98Nessuna valutazione finora
- Letteratura ItalianaDocumento135 pagineLetteratura Italianag.lambertiniNessuna valutazione finora
- Scuola SicilianaDocumento4 pagineScuola SicilianaMariana RodríguezNessuna valutazione finora
- PDF Epoca 1 ''Le Origini''Documento40 paginePDF Epoca 1 ''Le Origini''Cosimo BettoniNessuna valutazione finora
- Pitch - Differenza Tra La Scuola Siciliana e I Poeti Siculo-ToscaniDocumento27 paginePitch - Differenza Tra La Scuola Siciliana e I Poeti Siculo-Toscanibig.ben.bar.123Nessuna valutazione finora
- Letteratura ItalianaDocumento3 pagineLetteratura ItalianaJoseph990Nessuna valutazione finora
- Il NovecentoDocumento19 pagineIl NovecentoMichela AnnoniNessuna valutazione finora
- De Liso 11.10Documento3 pagineDe Liso 11.10federica valenteNessuna valutazione finora
- PASCOLIDocumento3 paginePASCOLIgiuseppe.cacciatoreNessuna valutazione finora
- Tommaso Dallafina Classe Q2 20/02/2020Documento2 pagineTommaso Dallafina Classe Q2 20/02/2020t rexNessuna valutazione finora
- Outline Differenza Tra La Scuola Siciliana e I Poeti Siculo-ToscaniDocumento2 pagineOutline Differenza Tra La Scuola Siciliana e I Poeti Siculo-Toscanibig.ben.bar.123Nessuna valutazione finora
- La Poesia - Dalle Origini Al TrecentoDocumento3 pagineLa Poesia - Dalle Origini Al TrecentoAnna PortesaniNessuna valutazione finora
- Giovanni Pascoli Appunti e Riassunti Molto Utili Per La MaturitaDocumento10 pagineGiovanni Pascoli Appunti e Riassunti Molto Utili Per La MaturitaLN StylinsonNessuna valutazione finora
- Lett ItalianaDocumento2 pagineLett Italianaalice.sardoneNessuna valutazione finora
- LascuolapoeticasicilianaDocumento159 pagineLascuolapoeticasicilianalzNessuna valutazione finora
- La Lirica Del DuecentoDocumento28 pagineLa Lirica Del DuecentoEdina GévaiNessuna valutazione finora
- CallimacoDocumento5 pagineCallimacoGiosuè PacchianoNessuna valutazione finora
- Jacopo Da LentiniDocumento1 paginaJacopo Da LentiniAcciacca QuaNessuna valutazione finora
- Riassunti Esame Ita FilieriDocumento56 pagineRiassunti Esame Ita FilieriAlessandra PesolaNessuna valutazione finora
- La Corte Di Federico II Di SveviaDocumento7 pagineLa Corte Di Federico II Di SveviaGiulia NotarangeloNessuna valutazione finora
- (LAMARQUE VIVIAN) VERZA MARIA - GIULIANA NUVOLI, Vivian Lamarque, Le Raccolte in Versi. Tesi Di Laurea Magistrale in Lettere ModerneDocumento295 pagine(LAMARQUE VIVIAN) VERZA MARIA - GIULIANA NUVOLI, Vivian Lamarque, Le Raccolte in Versi. Tesi Di Laurea Magistrale in Lettere ModerneGigi FrancoNessuna valutazione finora
- Dispensa2 Delle Lezioni Di Dialettologia Italiana - 3 CFUDocumento16 pagineDispensa2 Delle Lezioni Di Dialettologia Italiana - 3 CFUStella GiaciglioNessuna valutazione finora
- Dan Octavian Cepraga, Eteroglossia e imitazione sperimentale: la poesia italiana di Gheorghe Asachi, in Scrittori stranieri in lingua italiana dal Cinquecento ad oggi, a cura di Furio Brugnolo, Unipress, Padova, 2009, pp. 215-31.Documento17 pagineDan Octavian Cepraga, Eteroglossia e imitazione sperimentale: la poesia italiana di Gheorghe Asachi, in Scrittori stranieri in lingua italiana dal Cinquecento ad oggi, a cura di Furio Brugnolo, Unipress, Padova, 2009, pp. 215-31.danoctavian.cepraga7220% (1)
- Francesco RoncenDocumento37 pagineFrancesco RoncenL Gio GraciaNessuna valutazione finora
- Appunti Giacomo Da LentiniDocumento4 pagineAppunti Giacomo Da LentiniGiulioegabriele CalignanoNessuna valutazione finora
- Il Secondo OttocentoDocumento4 pagineIl Secondo Ottocentopaperego69Nessuna valutazione finora
- Marić-1 KolokvijDocumento11 pagineMarić-1 KolokvijAnonymous jt3d09ZNessuna valutazione finora
- La Musica Del Disgelo - Jean Sibelius PDFDocumento1 paginaLa Musica Del Disgelo - Jean Sibelius PDFMarcos Ramon Nuñez CarmonaNessuna valutazione finora
- Lalla Romano: L'archivio, la poetica, i generi letterariDa EverandLalla Romano: L'archivio, la poetica, i generi letterariNessuna valutazione finora
- Sintesi PariniDocumento3 pagineSintesi PariniLiberaMenteMoiNessuna valutazione finora
- Tesina Letteratura Vocale I Alessandra La Vecchia PDFDocumento6 pagineTesina Letteratura Vocale I Alessandra La Vecchia PDFMyriam HairynNessuna valutazione finora
- Letteratura Italiana Appunti 3Documento170 pagineLetteratura Italiana Appunti 3Nicoló AnselmiNessuna valutazione finora
- Skripta AmerickaDocumento4 pagineSkripta AmerickaAnastasieNessuna valutazione finora
- Cap 8 - 9 - 10Documento13 pagineCap 8 - 9 - 10Matteo QuintilianiNessuna valutazione finora
- Personaggi Capitolo 3Documento1 paginaPersonaggi Capitolo 3Matteo QuintilianiNessuna valutazione finora
- Appunti Letterature Comparate - PDF (1) - RemovedDocumento17 pagineAppunti Letterature Comparate - PDF (1) - RemovedMatteo QuintilianiNessuna valutazione finora
- LONGOBARDIDocumento7 pagineLONGOBARDIMatteo QuintilianiNessuna valutazione finora
- La Divina CommediaDocumento8 pagineLa Divina CommediaMatteo QuintilianiNessuna valutazione finora
- Curtis e MonachesimoDocumento8 pagineCurtis e MonachesimoLETIZIA FAMANessuna valutazione finora
- RadicilinguisticheDocumento180 pagineRadicilinguisticheberalenaNessuna valutazione finora
- Enuma Elish ItalianoDocumento6 pagineEnuma Elish ItalianoMiciagialla0% (1)
- PositivismoDocumento2 paginePositivismoPaolo EmilioNessuna valutazione finora