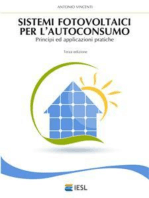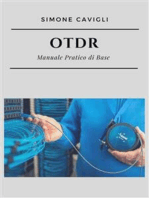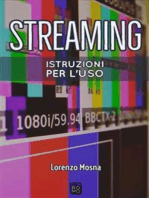Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Eurocodice 5 - UNI ENV 1995-2 Progettazione Delle Strutture in Legno Parte 2 Ponti
Eurocodice 5 - UNI ENV 1995-2 Progettazione Delle Strutture in Legno Parte 2 Ponti
Caricato da
Luciano CortisCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Eurocodice 5 - UNI ENV 1995-2 Progettazione Delle Strutture in Legno Parte 2 Ponti
Eurocodice 5 - UNI ENV 1995-2 Progettazione Delle Strutture in Legno Parte 2 Ponti
Caricato da
Luciano CortisCopyright:
Formati disponibili
Eurocodice 5
NORMA ITALIANA Progettazione delle strutture di legno UNI ENV 1995-2
S P E R I M E N TA L E Parte 2: Ponti
SETTEMBRE 1999
Eurocode 5
Design of timber structures
Part 2: Bridges
NORMA EUROPEA SPERIMENTALE
DESCRITTORI Struttura di legno, ponte, guida, progettazione, calcolo
CLASSIFICAZIONE ICS 91.080.20; 93.040
SOMMARIO La norma, sperimentale, tratta la progettazione della struttura principale
dei ponti, per esempio elementi strutturali per l’affidabilità dell’intera strut-
tura o della maggior parte di essa, realizzata con legno o altri prodotti a
base di legno, sia singolarmente sia abbinati con calcestruzzo-acciaio o
altri materiali.
La norma non copre le regole generali per la progettazione antisismica dei
ponti di legno, si rinvia alla UNI ENV 1998-2.
RELAZIONI NAZIONALI
RELAZIONI INTERNAZIONALI = ENV 1995-2:1997
La presente norma sperimentale è la versione ufficiale in lingua italiana
della norma europea sperimentale ENV 1995-2 (edizione luglio 1997).
ORGANO COMPETENTE Commissione "Ingegneria strutturale"
RATIFICA Presidente dell’UNI, delibera del 23 agosto 1999
RICONFERMA
UNI UNI - Milano 1999
Ente Nazionale Italiano Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento
di Unificazione può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza
Via Battistotti Sassi, 11B il consenso scritto dell’UNI.
20133 Milano, Italia
Gr. 11 Nº di riferimento UNI ENV 1995-2:1999 Pagina I di IV
PREMESSA NAZIONALE
La presente norma costituisce il recepimento, in lingua italiana, del-
la norma europea sperimentale ENV 1995-2 (edizione luglio 1997),
che assume così lo status di norma nazionale italiana sperimentale.
La traduzione è stata curata dall’UNI.
La Commissione "Ingegneria strutturale" dell’UNI, che segue i lavori
europei sull’argomento, per delega della Commissione Centrale
Tecnica, ha approvato il progetto europeo il 15 aprile 1997 e la ver-
sione in lingua italiana della norma il 30 giugno 1999.
La scadenza del periodo di validità della ENV 1995-2 è stata fissata
inizialmente dal CEN per luglio 2000. Eventuali osservazioni sulla
norma devono pervenire all’UNI entro marzo 2000.
La presente norma contiene i valori dei coefficienti approvati dal
CEN/TC 250.
L’indicazione dei coefficienti da utilizzare a livello nazionale, previsti
alla voce "Documento di Applicazione Nazionale (NAD)", nella pre-
messa della presente norma, sarà data, ove ritenuto necessario,
dalla Autorità Nazionale competente, nel rispetto dei livelli di sicu-
rezza stabiliti dalle Regole Tecniche nazionali.
Per agevolare gli utenti, viene di seguito indicata la corrispondenza
tra le norme citate al punto "Riferimenti normativi" e le norme italia-
ne vigenti:
EN 338:1995 = UNI EN 338:1997
EN 384:1995 = UNI EN 384:1997
ENV 1991-1:1994 = UNI ENV 1991-1:1996
ENV 1992-1-1 = UNI ENV 1992-1-1
ENV 1993-1-1 = UNI ENV 1993-1-1
ENV 1995-1-1:1993 = UNI ENV 1995-1-1:1995
ENV 1998-2 = UNI ENV 1998-2
Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni
o di aggiornamenti.
È importante pertanto che gli utenti delle stesse si accertino di essere in possesso
dell’ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti.
Le norme sperimentali sono emesse, per applicazione provvisoria, in campi in cui viene
avvertita una necessità urgente di orientamento, senza che esista una consolidata espe-
rienza a supporto dei contenuti tecnici descritti.
Si invitano gli utenti ad applicare questa norma sperimentale, così da contribuire a fare
maturare l'esperienza necessaria ad una sua trasformazione in norma raccomandata.
Chiunque ritenesse, a seguito del suo utilizzo, di poter fornire informazioni sulla sua appli-
cabilità e suggerimenti per un suo miglioramento o per un suo adeguamento ad uno stato
dell'arte in evoluzione è pregato di inviare, entro la scadenza indicata, i propri contributi
all'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina II di IV
INDICE
PREMESSA 2
1 GENERALITÀ 4
1.1 Scopo e campo di applicazione ........................................................................................................ 4
1.2 Relazione con gli altri Eurocodici ..................................................................................................... 4
1.3 Distinzione fra Principi e Regole Applicative, e valori di riferimento ............................. 5
1.4 Definizioni...................................................................................................................................................... 5
figura 1.1 Esempio di parti connesse con unioni a taglio scanalate e viti ..................................................... 6
figura 1.2 Esempi di impalcati lamellari .................................................................................................................... 6
1.5 Simboli ............................................................................................................................................................ 6
1.6 Riferimenti normativi ............................................................................................................................... 7
2 CRITERI DI PROGETTAZIONE 8
2.1 Generalità...................................................................................................................................................... 8
2.2 Fatica ............................................................................................................................................................... 8
2.3 Coefficienti parziali di sicurezza per i materiali ......................................................................... 8
prospetto 2.1 Coefficienti parziali di sicurezza per le proprietà dei materiali agli stati limite di rottura,
combinazioni fondamentali ....................................................................................................................... 8
3 MATERIALI 9
3.1 Generalità...................................................................................................................................................... 9
3.1.1 Classi di servizio ........................................................................................................................................... 9
3.1.2 Classi di durata del carico.......................................................................................................................... 9
3.2 Resistenza a compressione perpendicolare alla fibratura ................................................. 9
4 DURABILITÀ 9
4.1 Misure costruttive di protezione ........................................................................................................ 9
4.2 Protezione di parti metalliche .......................................................................................................... 10
4.3 Superfici di usura ................................................................................................................................... 10
5 CRITERI DI ANALISI STRUTTURALE 10
figura 5.1 Distribuzione di carichi concentrati con area di contatto di larghezza bw............................... 10
prospetto 5.1 Angoli di diffusione di carichi concentrati........................................................................................... 11
prospetto 5.2 Proprietà del materiale per solette d'impalcato lamellari, perpendicolarmente alla
direzione delle lamelle ............................................................................................................................ 11
prospetto 5.3 Larghezza efficace a in metri per l'analisi semplificata a trave .................................................. 11
figura 5.2 Larghezza efficace per soletta d'impalcato a doppio strato di tavole ...................................... 12
6 STATI LIMITE ULTIMI 12
6.1 Generalità................................................................................................................................................... 12
6.2 Elementi rinforzati .................................................................................................................................. 13
6.2.1 Generalità ..................................................................................................................................................... 13
6.2.2 Legno rinforzato trasversalmente......................................................................................................... 13
figura 6.1 Trave con rinforzo a taglio tipo trave reticolare ............................................................................... 14
figura 6.2 Trave con rinforzo a taglio unidirezionale.......................................................................................... 15
6.3 Solette d'impalcato ................................................................................................................................ 15
6.3.1 Resistenza di sistema .............................................................................................................................. 15
figura 6.3 Coefficiente di resistenza di sistema kls per le solette d'impalcato........................................... 16
figura 6.4 Definizione di blam ..................................................................................................................................... 16
6.3.2 Solette d'impalcato rinforzate ................................................................................................................ 16
6.3.3 Solette d'impalcato pre-sollecitate trasversalmente (stress-laminated) .................................. 16
figura 6.5 Esempio di applicazione dello sforzo di pre-sollecitazione e distribuzione della
tensione relativa ........................................................................................................................................ 18
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina III di IV
6.4 Elementi composti legno-calcestruzzo ...................................................................................... 18
7 STATI LIMITE DI ESERCIZIO 19
7.1 Generalità .................................................................................................................................................. 19
7.2 Vibrazioni causate da pedoni .......................................................................................................... 19
7.2.1 Vibrazioni verticali ..................................................................................................................................... 19
prospetto 7.1 Fattore di configurazione ka ................................................................................................................... 20
figura 7.1 Correlazione fra il coefficiente kvert,f e la frequenza naturale fondamentale fvert ................. 20
7.2.2 Vibrazioni orizzontali ................................................................................................................................ 21
figura 7.2 Correlazione fra il coefficiente khor,f e la frequenza naturale fondamentale fhor .................. 21
7.3 Vibrazioni causate da veicoli ........................................................................................................... 22
7.4 Vibrazioni causate dal vento ........................................................................................................... 22
8 UNIONI 23
8.1 Generalità .................................................................................................................................................. 23
8.2 Unioni legno-calcestruzzo in travi composte .......................................................................... 23
8.2.1 Generalità .................................................................................................................................................... 23
8.2.2 Mezzi di unione a gambo cilindrico sollecitati lateralmente ........................................................ 23
figura 8.1 Cassaforma come strato intermedio ................................................................................................... 23
8.2.3 Mezzi di unione a gambo cilindrico sollecitati assialmente ......................................................... 24
figura 8.2 Modello analitico per mezzi di unione inclinati unidirezionalmente .......................................... 24
figura 8.3 Modello analitico per mezzi di unione inclinati bidirezionalmente ............................................ 24
8.2.4 Unioni scanalate ........................................................................................................................................ 24
9 FATICA 25
10 CONTROLLO 25
APPENDICE A BARRE DI ACCIAIO INCOLLATE 26
(informativa)
A.1 Generalità ................................................................................................................................................. 26
A.2 Barre sollecitate assialmente ......................................................................................................... 26
A.2.1 Generalità .................................................................................................................................................. 26
figura A.1 Interassi e distanze minime per barre caricate assialmente, caricate .................................... 27
A.2.2 Stato limite ultimo ..................................................................................................................................... 27
A.2.2.1 Rottura di una singola barra ................................................................................................................ 27
A.2.2.2 Rottura nell’elemento ligneo ................................................................................................................ 28
figura A.2 Aree efficaci per gli sforzi di ancoraggio paralleli alla fibratura con bef = 6d......................... 28
figura A.3 Larghezza efficace bef e sforzo di ancoraggio agenti sotto un angolo α ............................... 29
A.2.3 Stati limite di esercizio ............................................................................................................................ 29
A.3 Barre sollecitate lateralmente ........................................................................................................ 29
A.3.1 Stato limite ultimo ..................................................................................................................................... 29
A.3.2 Stati limite di servizio............................................................................................................................... 30
figura A.4 Esempio di zone soggette a taglio fra le barre incollate .............................................................. 30
A.4 Barre incollate con sforzi combinati assiale ed a taglio ................................................... 31
A.5 Esecuzione .............................................................................................................................................. 31
APPENDICE B VERIFICA A FATICA 32
(informativa)
figura B.1 Correlazione fra kfat e il numero di cicli n .......................................................................................... 32
prospetto B.1 Valori di kfat∞ ............................................................................................................................................................................. 33
APPENDICE C CAPACITÀ PORTANTE A TAGLIO DI MEZZI DI UNIONE A GAMBO
(informativa) CILINDRICO 34
figura C.1 Esempi di unioni simmetriche ............................................................................................................... 34
prospetto C.1 Rapporti di snellezza λr e λef................................................................................................................ 35
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina IV di IV
Eurocodice 5
PRENORMA EUROPEA Progettazione delle strutture di legno ENV 1995-2
Parte 2: Ponti
LUGLIO 1997
Eurocode 5
EUROPEAN PRESTANDARD Design of timber structures
Part 2: Bridges
Eurocode 5
PRÉNORME EUROPÉENNE Calcul des structures en bois
Partie 2: Ponts
Eurocode 5
EUROPÄISCHE VORNORM Bemessung und Konstruktion von Holzbauten
Teil 2: Brücken
DESCRITTORI Struttura di legno, ponte, guida, progettazione, calcolo
ICS 91.010.30; 91.080.20; 93.040
La presente norma europea sperimentale (ENV) è stata approvata dal CEN,
come norma per applicazione provvisoria, il 15 aprile 1997.
Il periodo di validità di questa ENV è limitato inizialmente a 3 anni. I membri
del CEN saranno invitati dopo 2 anni a sottoporre i loro commenti, in parti-
colare per quanto riguarda la sua trasformazione da ENV a norma europea
(EN).
I membri del CEN sono tenuti a rendere nota l’esistenza di questa ENV nel-
lo stesso modo utilizzato per una EN e a renderla prontamente disponibile
a livello nazionale in una forma appropriata. È possibile mantenere in vigo-
re, contemporaneamente alla ENV, altre norme nazionali contrastanti, fino
alla decisione finale sulla possibile conversione da ENV a EN.
I membri del CEN sono gli Organismi nazionali di normazione di Austria,
Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda,
Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spa-
gna, Svezia e Svizzera.
CEN
COMITATO EUROPEO DI NORMAZIONE
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Segreteria Centrale: rue de Stassart, 36 - B-1050 Bruxelles
CEN 1997
I diritti di riproduzione sono riservati ai membri del CEN.
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 1 di 36
PREMESSA
Obiettivi degli Eurocodici
(1) Gli Eurocodici strutturali costituiscono un gruppo di norme relative alla progettazio-
ne strutturale e geotecnica degli edifici e delle opere di ingegneria civile.
(2) Essi trattano esecuzione e controllo solo nella misura atta a definire la qualità dei
prodotti adoperati nella costruzione ed il livello di preparazione professionale ne-
cessario per soddisfare le ipotesi assunte nella progettazione.
(3) Fin quando non sarà disponibile la necessaria serie delle norme tecniche sui pro-
dotti e sui metodi di prova delle loro prestazioni, alcuni degli Eurocodici strutturali
tratteranno taluni di questi aspetti in specifiche appendici informative.
Cronistoria del programma degli Eurocodici
(4) La Commissione della Comunità Europea (CCE) assunse l'iniziativa di redigere
un insieme di norme tecniche per la progettazione di edifici ed opere di ingegneria
civile che fosse inizialmente una alternativa ai diversi regolamenti in vigore nei va-
ri Paesi membri e, successivamente, sostituirli.
Queste norme tecniche sono state designate Eurocodici strutturali.
(5) Nel 1990, dopo aver consultato i rispettivi Paesi membri, la CCE ha incaricato il
CEN del lavoro di sviluppo ulteriore, emanazione ed aggiornamento degli Euroco-
dici strutturali; la Segreteria dell'EFTA ha accettato di dare supporto ai lavori del
CEN.
(6) Il Comitato Tecnico CEN/TC 250 è responsabile di tutti gli Eurocodici strutturali.
Programma degli Eurocodici
(7) Sono in fase di redazione i seguenti Eurocodici strutturali, ognuno dei quali gene-
ralmente consta di varie parti:
ENV 1991 = Eurocodice 1 Basis of design and actions on structures [Basi di cal-
colo ed azioni sulle strutture]
ENV 1992 = Eurocodice 2 Design of concrete structures [Progettazione delle
strutture di calcestruzzo]
ENV 1993 = Eurocodice 3 Design of steel structures [Progettazione delle struttu-
re di acciaio]
ENV 1994 = Eurocodice 4 Design of composite steel and concrete structures
[Progettazione delle strutture composte acciaio-cal-
cestruzzo]
ENV 1995 = Eurocodice 5 Design of timber structures [Progettazione delle strut-
ture di legno]
ENV 1996 = Eurocodice 6 Design of masonry structures [Progettazione delle
strutture di muratura]
ENV 1997 = Eurocodice 7 Geotechnical design [Progettazione geotecnica]
ENV 1998 = Eurocodice 8 Design provisions for earthquake resistance of structures
[Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle
strutture]
ENV 1999 = Eurocodice 9 Design of aluminium alloy structures [Progettazione
delle strutture di alluminio]
(8) Il CEN/TC 250 ha costituito dei sottocomitati separati in relazione ai diversi Euro-
codici sopra citati.
(9) Questa parte 2 dell’Eurocodice 1995 viene pubblicata dal CEN come norma euro-
pea sperimentale (ENV) per un periodo iniziale di tre anni.
(10) La presente norma sperimentale è utilizzata per applicazioni pratiche e per la pre-
sentazione di commenti.
(11) Dopo circa due anni ai membri CEN sarà chiesto di inviare commenti formali da
prendere in considerazione per definire le future azioni.
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 2 di 36
(12) Nel frattempo, suggerimenti e commenti sulla presente norma sperimentale do-
vrebbero essere inviati alla Segreteria del CEN/TC 250/SC 5 al seguente indirizzo:
Secretariat of CEN/TC 250/SC 5
BST
Box 49044
S-100 28 STOCKHOLM
o all’ente normatore nazionale.
(nota nazionale - per l'Italia: UNI
Via Battistotti Sassi, 11B
20133 MILANO
(tel. 02/70024.1 - fax. 02/70.106.106)
Documenti di Applicazione Nazionale (NAD)
(13) Considerando la responsabilità delle Autorità nei Paesi membri in fatto di sicurez-
za, salute ed altre questioni espresse nei requisiti essenziali della Direttiva "Pro-
dotti da Costruzione" (CPD), ad alcuni fattori di sicurezza contenuti in questa nor-
ma sperimentale sono stati assegnati dei valori indicativi che vengono identificati
da "valori incasellati". Si prevede che le autorità di ciascun Paese membro
rivedano tali "valori incasellati" e possano, per l'uso nelle applicazioni nazionali,
sostituire ad essi dei valori definitivi, alternativi, per questi coefficienti di sicurezza.
(14) Alcune delle norme europee o internazionali di supporto potrebbero non essere di-
sponibili al momento della pubblicazione di questa parte. Si anticipa quindi che
verrà pubblicato da ogni Paese membro o dall'ente di normazione un Documento
di Applicazione Nazionale (NAD), il quale fornirà i valori sostitutivi per i coefficienti
di sicurezza, farà riferimento alle norme di supporto compatibili e rappresenterà
una guida a livello nazionale per l'applicazione della presente norma sperimentale.
(15) Resta inteso che la presente norma sperimentale verrà utilizzata insieme al NAD
valido nel Paese in cui vengono svolti i lavori di edilizia o di ingegneria civile.
Argomenti specifici di questa norma sperimentale europea
(16) La presente norma sperimentale contiene unicamente clausole in aggiunta al-
la ENV 1995-1-1, cioè nessuna prescrizione o regola applicativa presente nel-
la ENV 1995-1-1 viene ripetuta nella presente norma sperimentale.
(17) In questo documento vengono date prescrizioni e regole applicative che coprono
situazioni di progetto specifiche per il dimensionamento di ponti (per esempio gli
stati limite di esercizio) quali ponti pedonali/ciclabili, ponti stradali e ferroviari.
(18) Altre parti del testo riguardano situazioni di progetto o componenti strutturali che
non sono specifici per i ponti, ma normalmente sono più usati nella progettazione
di ponti. Esempi di questo secondo gruppo sono situazioni di progetto quali il com-
portamento a fatica, e componenti strutturali quali il legno rinforzato, i ponti ad im-
palcato lamellare e i bulloni incollati.
(19) I metodi di verifica per le barre incollate al legno sono presentati nell'appendice A
(informativa).
(20) La presente norma sperimentale non riguarda i ponti con legno pre-sollecitato lon-
gitudinalmente.
(21) In caso di verifica a fatica, fatta eccezione del danno da fatica dovuto alle vibra-
zioni causate dal vento, non viene data alcuna prescrizione sui casi in cui una ve-
rifica dovrebbe essere eseguita. Un metodo semplificato di verifica viene illustrato
nell’appendice B (informativa).
(22) Il Comitato di redazione di questa norma sperimentale ha utilizzato i seguenti rife-
rimenti:
- Brücken und Stege aus Holz. Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für
Holzforschung, 1989 [Ponti e passerelle di legno]
- DIN 1074, Holzbrücken. Ausgabe Mai 1991 [Ponti di legno]
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 3 di 36
- Kreuzinger, H. e Mohr, B.: Holz und Holzverbindungen unter nicht vorwiegend
ruhenden Einwirkungen. Technische Universität München, Institut für
Tragwerksbau, Fachgebiet Holzbau, 1994 [Legno e collegamenti di legno
sotto azioni non prevalentemente statiche]
- Ontario highway bridge design code. 3rd edition, Ministry of Transportation, 1992
[Codice di progettazione per i ponti autostradali dell’Ontario]
- Recommended guide for the design of stress laminated timber plate bridge
decks. Part 1 - Design procedures. Roads and Traffic Authority - New South
Wales, 1995 [Raccomandazione per la progettazione di solette d’impalcati di
ponte presollecitate. Parte 1 - Procedure di progettazione. Autorità per il traf-
fico e le strade]
- Ritter, M.: Timber bridges - Design, construction, inspection and maintenance.
United States Department of Agriculture, Forest Service, 1990 [Ponti di legno
- Progettazione, costruzione, verifiche e manutenzione]
- Taylor, R.J. e Keenan, F.J.: Wood highway bridges. Canadian Wood Council, 1992
[Ponti di legno di autostrade]
(23) Alcune dei sopramenzionati codici/raccomandazioni nazionali sui ponti contengo-
no testo informativo che non è incluso nella presente norma sperimentale, in
quanto esso dovrebbe essere reperibile nei manuali di progettazione oppure nei
libri di testo.
1 GENERALITÀ
1.1 Scopo e campo di applicazione
P(1) La ENV 1995-2 tratta la progettazione delle parti strutturali principali dei ponti,
cioè degli elementi strutturali importanti per l'affidabilità dell'intero ponte oppure di
importanti parti di esso, realizzati con legno e con altri materiali a base di legno,
sia singolarmente sia composti con calcestruzzo, acciaio o altri materiali.
P(2) La ENV 1995-2 non considera le regole apposite per la progettazione antisismica
dei ponti di legno, per la quale è pertinente la ENV 1998-2.
1.2 Relazione con gli altri Eurocodici
P(1) Le regole pertinenti fornite nella ENV 1995-1-1 si applicano anche alle parti strut-
turali principali dei ponti, salvo se altrimenti specificato in 1.2P(2) oppure nel testo.
P(2) I seguenti punti della ENV 1995-1-1 non si applicano alle parti strutturali principali
di ponti:
- 2.1 Requisiti fondamentali
- 2.2 Definizioni e classificazioni
- 2.3 Requisiti per la progettazione
- 2.4.3(2) Esempi di protezione minima dalla corrosione
- 3.4.2 Pannello di particelle
- 3.4.3 Pannello di fibre
- 5.4.1.3 Analisi semplificata di capriate
- 5.4.1.4(3) Montaggi - verifica alla resistenza di elementi
- 5.4.1.5 Capriate con unioni con piastre stampate di metallo
- 5.4.2 Diaframmi per tetti e solai
- 5.4.3 Diaframmi per pareti
- 6.5.1.2(3) Riduzione della capacità portante dei bulloni
Nota Un metodo per il calcolo del numero efficace dei mezzi di unione del tipo a gambo cilindrico viene
illustrato nell'appendice C.
P(3) Per i componenti di calcestruzzo e per le barre di armatura, si applicano le prescri-
zioni della ENV 1992-1-1 e della ENV 1992-2.
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 4 di 36
P(4) Per i componenti di acciaio, si applicano le prescrizioni dell'Eurocodice 3, in parti-
colare della ENV 1993-1-1 e della ENV 1993-2.
P(5) Per i criteri di progettazione, vedere punto 2.
(6) Quando si usa questa parte 2, si dovrebbe fare riferimento, laddove pertinente, al-
le seguenti norme sperimentali europee:
- ENV 1991-1-1 Eurocodice 1 Parte 1-1 Basis of design [Basi di calcolo]
- ENV 1991-2-1 Eurocodice 1 Parte 2-1 Densities, self-weight and imposed
loads [Massa volumica, peso pro-
prio e carichi imposti]
- ENV 1991-2-4 Eurocodice 1 Parte 2-4 Wind actions [Azioni del vento]
- ENV 1991-2-5 Eurocodice 1 Parte 2-5 Thermal actions [Azioni termiche]
- ENV 1991-3 Eurocodice 1 Parte 3 Traffic loads on bridges [Carichi
da traffico sui ponti]
1.3 Distinzione fra Principi e Regole Applicative, e valori di riferimento
P(1) In funzione del carattere delle singole clausole, si opera una distinzione fra Prin-
cipi e Regole Applicative.
P(2) I Principi comprendono:
- enunciazioni generali e definitive per le quali non esiste alternativa, nonché
- requisiti e modelli analitici per i quali non è consentita alcuna alternativa a me-
no che ciò non sia specificamente dichiarato.
P(3) I numeri dei punti dei Principi sono anticipati dalla lettera P.
P(4) Le Regole Applicative sono generalmente regole riconosciute, che applicano i
Principi e ne soddisfano le prescrizioni.
P(5) È ammesso l'uso di regole di progettazione alternative che differiscano dalle Re-
gole Applicative, purché sia dimostrato che le regole alternative concordano con i
pertinenti Principi e sono almeno equivalenti per quanto concerne la resistenza
meccanica, funzionalità e durabilità raggiungibili per la struttura, con il presente
Eurocodice.
1.4 Definizioni
In aggiunta alle definizioni fornite nella ENV 1995-1-1, sono applicabili le seguenti defini-
zioni:
1.4.1 unione scanalata: Unione a taglio consistente nell'alloggiamento di una parte essenziale,
rotonda o rettangolare di un elemento nella faccia a contatto dell'altro elemento. Le parti
unite sono, di solito, tenute assieme mediante viti, bulloni, ecc. Vedere figura 1.1.
1.4.2 impalcato lamellare: Impalcato da ponte realizzato con lamelle individuali tenute assieme
da chiodature o incollaggi e/o da una pressione laterale permanente per garantire l'attrito
tra le facce delle lamelle. Vedere figura 1.2.
Nota Impalcati da ponte pre-sollecitati, ma non incollati sono spesso chiamati "stress-laminated decks" con le su-
perfici del legno segate oppure piallate.
1.4.3 pre-sollecitazione: Effetto permanente dovuto a forze controllate e/o a deformazioni impo-
ste su una struttura.
Nota Un esempio è dato dalla pre-sollecitazione di impalcati di ponti di legno mediante barre o tiranti, vedere figura
1.2 da b) a d).
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 5 di 36
figura 1.1 Esempio di parti connesse con unioni a taglio scanalate e viti
figura 1.2 Esempi di impalcati lamellari
Legenda
1 Chiodo
1.5 Simboli
Ai fini della presente norma sperimentale si applicano i seguenti simboli principali:
Aef Area efficace
As Area della barra di rinforzo
E Modulo di elasticità
E0 Modulo di elasticità parallelo alla fibratura
Emean Valore medio del modulo di elasticità
F Forza
Fax,Ek Forza caratteristica assiale nella barra
Ft , Fc Forza di trazione e di compressione
FV,Rk Capacità portante caratteristica a taglio
G0 Modulo di elasticità tangenziale alla fibratura (panel shear)
G90 Modulo di taglio perpendicolare alla fibratura (rolling shear)
Kser Modulo di scorrimento
V Forza di taglio
avert, ahor Accelerazione, verticale e orizzontale
bef Larghezza efficace
blam Larghezza della lamella
d Diametro
h Altezza della trave
fvert, fhor Frequenza fondamentale naturale di vibrazioni verticali e orizzontali
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 6 di 36
fv,d Resistenza a taglio di progetto
fv,k Resistenza a taglio caratteristica
fm,d Resistenza a flessione di progetto
fc,90,d Resistenza a compressione di progetto perpendicolare alla fibratura
fy,d Resistenza allo snervamento di progetto per l'acciaio
fu,k Resistenza ultima caratteristica dell'acciaio
fh,k Resistenza caratteristica al rifollamento
kmod Coefficiente di correzione
kls Coefficiente di resistenza del sistema
m Massa; massa per unità di superficie
t Tempo
ν Velocità
γM Coefficiente parziale di sicurezza per materiali
γM,fat Coefficiente parziale di sicurezza per materiali, per la verifica a fatica
ρk Massa volumica caratteristica
µd Valore di progetto per il coefficiente di attrito
σc Tensione di compressione
ζ Rapporto di smorzamento
1.6 Riferimenti normativi
La presente norma europea rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni
contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati
del testo e vengono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive
modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte
nella presente norma europea come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non da-
tati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento.
ISO 2631-1 Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure
to whole-body vibration - General requirements [Vibrazioni e
shock meccanici - Valutazione della esposizione alle vibrazioni di
tutto il corpo - Requisiti generali]
EN 338:1995 Structural timber - Strength classes [Legno strutturale - Classi di
resistenza]
EN 384:1995 Structural timber - Determination of characteristic values of
mechanical properties and density [Legno strutturale - Determina-
zione dei valori caratteristici delle proprietà meccaniche e della
massa volumica]
*)
prEN 1193 Timber structures - Test methods - Structural timber and glued
laminated timber - Determination of additional physical and
mechanical properties [Strutture di legno - Metodi di prova - Le-
gno strutturale e legno lamellare incollato - Determinazione delle
proprietà aggiuntive fisiche e chimiche]
prEN 1194**) Timber structures - Glued laminated timber - Strength classes and
determination of characteristic values [Strutture di legno - Legno
lamellare incollato - Classi di resistenza e determinazione dei va-
lori caratteristici]
ENV 1991-1:1994 Eurocode 1 - Basis of design and actions on structures - Part 1:
Basis of design [Eurocodice 1 - Basi di calcolo ed azioni sulle
strutture - Parte 1: Basi di calcolo]
ENV 1992-1-1 Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 1-1: General
reules - General rules and rules for buildings [Eurocodice 2 - Pro-
gettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-1: Regole gene-
rali - Regole generali e regole per gli edifici]
*) Nota nazionale - La norma è stata pubblicata nel 1997.
**) Nota nazionale - La norma è stata pubblicata nel 1999.
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 7 di 36
ENV 1992-2 Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 2: Bridges [Eu-
rocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 2:
Ponti di calcestruzzo]
ENV 1993-1-1 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-1: General rules
and rules for buildings [Eurocodice 3 - Progettazione delle struttu-
re di acciaio - Parte 1-1: Regole generali - Regole generali e rego-
le per gli edifici]
ENV 1993-2 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 2: Bridges [Euroco-
dice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 2: Ponti di
acciaio]
ENV 1995-1-1:1993 Eurocode 5 - Design of timber structures - Part 1-1: General rules
- General rules and rules for buildings [Eurocodice 5 - Progettazio-
ne delle strutture di legno - Parte 1-1: Regole generali - Regole per
gli edifici]
ENV 1998-2 Eurocode 8 - Design provisions for earthquake resistance of
structures - Part 2: Bridges [Eurocodice 8 - Indicazioni progettuali
per la resistenza sismica delle strutture - Parte 2: Ponti]
Nota Progetto di norma europea:
prEN (112.406) Wood-based panels - Characteristic values for established products [Pannelli a
base di legno - Valori caratteristici per prodotti affermati]
2 CRITERI DI PROGETTAZIONE
2.1 Generalità
P(1) Si applicano le ENV 1991-1 ed ENV 1995-1-1, 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3.
2.2 Fatica
P(1) Gli stati limite correlati alla fatica devono essere trattati come stati limite di rottura.
2.3 Coefficienti parziali di sicurezza per i materiali
P(1) I coefficienti parziali di sicurezza γM per le proprietà dei materiali agli stati limite di
rottura, combinazioni fondamentali, sono dati nel prospetto 2.1.
prospetto 2.1 Coefficienti parziali di sicurezza per le proprietà dei materiali agli stati limite di rottura, combinazioni
fondamentali
Legname e materiali a base di legno
- verifica normale γM = 1,3
- verifica a fatica γM,fat = 1,0
Acciaio usato nelle unioni
- verifica normale γM = 1,1
- verifica a fatica γM,fat = 1,0
Acciaio usato in elementi composti γM,s = 1,15
Calcestruzzo usato in elementi composti γM,c = 1,5
Connettori a taglio in elementi composti
- verifica normale γM,v = 1,25
- verifica a fatica γM,v,fat = 1,0
Elementi d’acciaio usati nella presollecitazione γM,s = 1,15
P(2) Per le combinazioni eccezionali, tutti i coefficienti parziali di sicurezza γM sono
uguali ad 1.
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 8 di 36
3 MATERIALI
3.1 Generalità
3.1.1 Classi di servizio
P(1) Ponti o parti di ponti che non sono protetti dall'acqua oppure dall'azione diretta
delle intemperie devono essere assegnati alla classe di servizio 3.
Nota L'acqua può essere portata sul ponte dai veicoli. Esempi di protezione dall'azione diretta delle in-
temperie sono i ponti coperti da un tetto, oppure gli impalcati che si comportano essi stessi come un
tetto, oppure le tecniche di protezione del legno tramite impregnazione con creosoto.
3.1.2 Classi di durata del carico
(1) Le azioni variabili dovute al passaggio del traffico, di norma, sono considerate
azioni di breve durata.
(2) Le forze di pre-sollecitazione durante la costruzione, di norma, sono considerate
azioni di breve durata.
(3) Le forze residue di pre-sollecitazione, di norma, sono considerate azioni di lunga
durata.
3.2 Resistenza a compressione perpendicolare alla fibratura
(1) Per un volume uniformemente sollecitato la resistenza a compressione per-
pendicolare alla fibratura di norma viene determinata mediante prove conformi
al prEN 1193.
Nota I valori per la compressione perpendicolare alla fibratura forniti nelle EN 338:1995 ed EN 384:1995
punto 8.4 sono all'incirca maggiori del 100% rispetto a quelli determinati sperimentalmente.
(2) Per carichi concentrati si applica la ENV 1995-1-1:1993.
4 DURABILITÀ
4.1 Misure costruttive di protezione
(1) L'esposizione diretta di parti di legno alla pioggia e alla radiazione solare dovreb-
be essere evitata, oppure ridotta tramite misure costruttive di protezione.
(2) Laddove non sia realizzabile una copertura parziale o completa degli elementi
strutturali principali, si dovrebbero prendere in considerazione una o più misure
fra le seguenti:
- limitazione dell'acqua ristagnante sulle parti di legno mediante un'appropriata
inclinazione delle superfici;
- limitazione delle aperture, intagli, ecc. in cui l'acqua può accumularsi o infil-
trarsi;
- limitazione dell'assorbimento diretto di acqua (per esempio assorbimento ca-
pillare dalle fondazioni di calcestruzzo) attraverso l'uso di appropriate barriere;
- limitazione delle fessurazioni e delaminazioni, specialmente in tutte le posizio-
ni in cui risulterebbero esposte sezioni di testata degli elementi lignei, tramite
sigillatura e/o scossaline di copertura;
- limitazione dei movimenti di rigonfiamento e ritiro assicurando un'umidità ini-
ziale appropriata e riducendo le variazioni di umidità attraverso un'adeguata
protezione delle superfici;
- uso di legname con adeguata durabilità naturale, oppure di legno trattato, ve-
dere la ENV 1995-1-1.
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 9 di 36
4.2 Protezione di parti metalliche
P(1) Le parti metalliche usate nelle unioni acciaio-legno o le barre di pre-sollecitazione
che risulteranno inaccessibili una volta che il ponte sarà completato, devono es-
sere adeguatamente protette per la durata di vita in opera prevista dal progetto.
P(2) Tutte le parti metalliche devono avere un'adeguata protezione contro la corrosione.
(3) In condizioni severe (per esempio quando non può essere esclusa l'utilizzazione
di sostanze anti-ghiaccio corrosive), dovrebbero essere utilizzati acciaio inossida-
bile di adeguata composizione oppure speciali rivestimenti addizionati, oppure le
parti dovrebbero essere facilmente sostituibili.
P(4) La possibilità di corrosione dell'acciaio deve essere tenuta in considerazione.
(5) Le parti di acciaio inglobate nel calcestruzzo, come le barre d'armatura e i cavi di
pre-sollecitazione, dovrebbero essere protette conformemente ai pertinenti punti
delle ENV 1992-1-1 ed ENV 1992-2.
4.3 Superfici di usura
P(1) Laddove degli elementi di legno strutturale sono esposti ad abrasione dovuta al
traffico, l'altezza adottata nel calcolo deve essere quella minima ammessa prima
della sostituzione.
5 CRITERI DI ANALISI STRUTTURALE
(1) I carichi dovrebbero essere riferiti al piano medio della soletta d'impalcato.
(2) Per carichi concentrati, si dovrebbe fare riferimento ad un'area di contatto efficace
rispetto al piano medio dell'impalcato, vedere figura 5.1,
dove:
bW è la larghezza dell’area del carico sulla superficie di contatto con la so-
letta d'impalcato;
bW, middle è la larghezza dell'area del carico riferita al piano medio della soletta
d'impalcato;
β1, β2 sono angoli di distribuzione conformemente al prospetto 5.1.
figura 5.1 Distribuzione di carichi concentrati con area di contatto di larghezza bw
Legenda
1 Pavimentazione
2 Soletta d'impalcato di legno
3 Asse mediano della soletta d'impalcato di legno
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 10 di 36
prospetto 5.1 Angoli di diffusione di carichi concentrati
β1 o β2
Attraverso la pavimentazione, tavoloni e tavole 45°
Attraverso impalcati lamellari
- in direzione delle lamelle 45°
- perpendicolarmente alle lamelle 15°
Attraverso impalcati di compensato 30°
(3) Le solette d'impalcato dovrebbero essere analizzate sulla base della teoria delle
lastre ortotrope.
(4) Per le solette d'impalcato, realizzate con lamelle di conifere, le relazioni per le pro-
prietà perpendicolarmente alle lamelle dovrebbero essere desunte dal prospetto
5.2. Il rapporto G90,mean/G0,mean dovrebbe essere considerato come:
G 90, mean
----------------------- = 0, 1 [5.1]
G 0, mean
prospetto 5.2 Proprietà del materiale per solette d'impalcato lamellari, perpendicolarmente alla direzione delle
lamelle
Tipo di soletta d’impalcato E90,mean/E0,mean G0,mean/E0,mean
Lamellare inchiodato 0 0,02
Lamellare pre-sollecitato trasversalmente
segato 0,015 0,03
piallato 0,020 0,04
Lamellare incollato 0,030 0,06
(5) Per un'analisi semplificata, le solette possono essere considerate sostituite da
una o più travi in direzione delle lamelle, con la larghezza efficace bef calcolata come:
bef = bw,middle + a [5.2]
dove:
bw,middle è calcolata conformemente a (2);
a in metri, dovrebbe essere desunta dal prospetto 5.3.
prospetto 5.3 Larghezza efficace a in metri per l'analisi semplificata a trave
Sistema di soletta d’impalcato a
Lamellare inchiodato 0,1
Lamellare pre-sollecitato trasversalmente oppure lamellare incollato 0,3
Composto legno-calcestruzzo 0,6
(6) Per solette d'impalcato a doppio strato di tavole con un angolo pari ad α = (60 ± 5)°
fra le direzioni delle tavole e delle travi di sostegno, la larghezza efficace per cia-
scun strato dovrebbe essere considerata pari a (vedere figura 5.2):
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 11 di 36
0, 2 l b + 2 b w, t
b ef = -------------------------------------
- [5.3]
sin α
dove
lb è la distanza fra gli assi delle travi di sostegno del tavolato;
bw,t è la larghezza dell'area di contatto (ruota) misurata nella direzione nor-
male alle travi di sostegno.
P(7) Per sistemi di impalcato a struttura composta, si deve considerare l'influenza dello
scorrimento nelle unioni.
figura 5.2 Larghezza efficace per soletta d'impalcato a doppio strato di tavole
6 STATI LIMITE ULTIMI
6.1 Generalità
P(1) I modelli di calcolo per i differenti stati limite devono prendere in considerazione,
laddove pertinenti, i seguenti punti:
- differenti proprietà dei materiali (per esempio modulo di elasticità, resistenza e
modo di rottura);
- differente comportamento dei materiali nel lungo periodo (viscosità, rilassa-
mento);
- differente comportamento al clima dei materiali (temperatura, variazioni di
umidità);
- differenti situazioni di progetto (fasi di costruzione, cambiamento delle condi-
zioni di appoggio).
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 12 di 36
P(2) Per strutture o parti di strutture per le quali le forze o le tensioni ecc. siano funzioni
del tempo, deve essere eseguita una verifica al tempo iniziale e finale della situa-
zione di progetto pertinente.
(3) La ENV 1995-1-1, 5.1.7.1 (2) può essere applicata anche per gli appoggi interme-
di di elementi continui.
6.2 Elementi rinforzati
6.2.1 Generalità
P(1) Questo punto riguarda gli elementi lignei rinforzati con altri materiali, per esempio
legno di altre specie, materiali a base di legno, fibre di vetro o fibre di carbonio, op-
pure con acciaio, solidarizzati al legno.
(2) Il calcolo degli effetti di progetto delle azioni dovrebbe essere basato su valori me-
di delle proprietà di rigidezza e scorrimento, per la classe di servizio e la durata
del carico in questione.
Nota Nella ENV 1995-1-1 il modulo di elasticità è considerato pari a:
E mean
E = --------------------
1 + k def
dove kdef è stimato in base al prospetto 4.1 della ENV 1995-1-1.
6.2.2 Legno rinforzato trasversalmente
P(1) La resistenza a trazione del legno perpendicolarmente alla fibratura non deve es-
sere considerata.
(2) Posto che esista un rinforzo longitudinale con ab ≥ 5d, per una trave con rinforzo
a taglio tipo trave reticolare come mostrato nella figura 6.1, si applicano (3), (4),
(5) e (9).
(3) La resistenza di progetto a taglio VRd di norma viene considerata pari a:
V + 0, 5 V Rd, s
V Rd = min. Rd, timber [6.1]
0, 5 V Rd, timber + V Rd, s
dove:
VRd,timber è la resistenza a taglio di progetto del legno in funzione della direzione
della fibratura e della forza;
VRd,s è la resistenza a taglio di progetto del rinforzo, determinata usando un
modello reticolare, vedere (5).
(4) Per le conifere la resistenza a taglio del legno massiccio e del legno lamellare in-
collato, in direzione radiale-tangenziale (vedere figura 6.1) può essere presa pari
a 0,15 volte la resistenza a taglio parallela alla fibratura.
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 13 di 36
figura 6.1 Trave con rinforzo a taglio tipo trave reticolare
(5) Posto che l'inclinazione β delle barre di acciaio sia compresa fra 40° e 50°, la re-
sistenza a taglio di progetto del rinforzo dovrebbe essere assunta pari a:
VRd,s = 0,7 fy,d As [6.2]
dove:
fy,d è la resistenza allo snervamento di progetto della barra di acciaio;
As è l'area delle barre di rinforzo inclinate.
(6) Posto che esista un rinforzo longitudinale con ab ≥ 5d, per un rinforzo a taglio uni-
direzionale come mostrato nella figura 6.2, si applicano (7), (8) e (9).
(7) La resistenza di progetto a taglio dovrebbe essere considerata pari a:
V
Rd, timber + 0, 5 V Rd, s
V Rd = min. 0, 5 V Rd, timber + V Rd, s [6.3]
1, 5 V
Rd, timber
purché la distanza as delle barre non sia maggiore dell'altezza h della trave.
(8) La rigidezza a taglio dell'elemento rinforzato dovrebbe essere considerata accre-
sciuta nello stesso modo della resistenza a taglio.
(9) La resistenza allo snervamento di progetto della barra di acciaio fy,d non dovrebbe
essere assunta maggiore di 350 N/mm2.
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 14 di 36
figura 6.2 Trave con rinforzo a taglio unidirezionale
6.3 Solette d'impalcato
6.3.1 Resistenza di sistema
(1) Le resistenze a flessione e a taglio della soletta d'impalcato dovrebbero essere
calcolate come segue:
Fm,d,deck = kls fm,d,lam [6.4]
Fv,d,deck = kls fv,d,lam [6.5]
dove:
fm,d,lam è la resistenza a flessione di progetto delle lamelle;
fv,d,lam è la resistenza a taglio di progetto delle lamelle;
kls è il coefficiente di resistenza per il sistema.
(2) A meno che non venga eseguita un'analisi più dettagliata, dovrebbero essere
adottati i valori di kls elencati nella figura 6.3, per la resistenza a flessione e a ta-
glio delle solette d'impalcato lamellari.
(3) Il numero n di elementi caricati dovrebbe essere preso pari a:
b ef
n = ----------
- [6.6]
b lam
dove:
bef è la larghezza efficace conformemente al punto 5, sottopunto (5);
blam è la larghezza delle lamelle, vedere figura 6.4.
(4) La resistenza di progetto a flessione "di piatto" per travi di legno lamellare incollato
[vedere figura 6.4 a)] dovrebbe essere presa pari alla resistenza a flessione "di
fianco" fm,d,lam delle lamelle.
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 15 di 36
figura 6.3 Coefficiente di resistenza di sistema kls per le solette d'impalcato
Legenda
1 Lamelle inchiodate
2 Lamelle pre-sollecitate o pre-sollecitate e incollate, oppure lamelle realizzate con travi di legno
lamellare incollato
n Numero di lamelle sottoposte a carico
kls Coefficiente di resistenza di sistema
figura 6.4 Definizione di blam
6.3.2 Solette d'impalcato rinforzate
P(1) Si applicano i principi di 6.2.
(2) Si applicano le regole pertinenti di 6.2.
6.3.3 Solette d'impalcato pre-sollecitate trasversalmente (stress-laminated)
P(1) Le forze di pre-sollecitazione devono essere tali da non provocare alcun scorri-
mento verticale fra le lamelle.
(2) Le forze di pre-sollecitazione dovrebbero agire in maniera centrata rispetto alla
sezione retta del legno.
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 16 di 36
Dovrebbe essere soddisfatto il requisito seguente:
FV,Ed ≤ µd σp,min h
dove:
FV,Ed è lo sforzo di taglio di progetto per unità di lunghezza;
µd è il valore di progetto del coefficiente di attrito;
σp,min è la tensione di compressione minima residua di lungo periodo dovuta al-
la pre-sollecitazione (vedere figura 6.5);
h è lo spessore della soletta d'impalcato.
(3) Dovrebbero essere adottati i seguenti valori di progetto per il coefficiente di attrito µd:
- legno segato su legno segato: µd = 0,3;
- legno piallato su legno piallato: µd = 0,2;
- piallato su segato: µd = 0,2;
- legno su calcestruzzo: µd = 0,4.
Nota Il coefficiente di attrito è funzione della specie legnosa, della rugosità della superficie di contatto, del
trattamento del legno e della tensione residua fra le lamelle.
(4) In aree soggette a carichi da ruote, la tensione a compressione minima residua a
lungo termine σp,min dovuta alla pre-sollecitazione (vedere figura 6.5) fra lamelle di
conifere non dovrebbe essere minore di 0,35 N/mm2.
Nota La forza di pre-sollecitazione residua di lungo periodo viene normalmente determinata attraverso
misurazioni per il tipo di soletta pre-sollecitata considerato.
P(5) Per la compressione perpendicolare alla fibratura in corrispondenza delle piastre
di ancoraggio deve essere soddisfatta la seguente condizione:
σpl,d ≤ kc,90 fc,90,d
dove:
σpl,d è la tensione di compressione localizzata fra la piastra di contatto e il legno;
kc,90 deve essere adottato in conformità alla ENV 1995-1-1, 5.1.5 P(1).
(6) Il numero di giunti di testa deve essere limitato ad uno considerando quattro la-
melle adiacenti qualsiasi, all'interno di un tratto di lunghezza pari a 30 volte lo
spessore delle lamelle.
(7) Nel calcolo della resistenza di impalcati pre-sollecitata (stress-laminated), la se-
zione dovrebbe essere ridotta in proporzione al numero di giunti di testa.
(8) Per ponti stradali e ferroviari, i giunti di testa dovrebbero essere sostenuti in corri-
spondenza di ogni giunto, a meno che l'integrità dell'impalcato sia assicurata da
una pre-sollecitazione maggiorata.
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 17 di 36
figura 6.5 Esempio di applicazione dello sforzo di pre-sollecitazione e distribuzione della tensione relativa
Legenda
1 Ripartitore di acciaio o legno duro
2 Piastra individuale di ancoraggio
3 Barra di pre-sollecitazione
4 Zona con pressione uniforme
5e6 Zone di introduzione del carico
6.4 Elementi composti legno-calcestruzzo
P(1) Questo punto fornisce prescrizioni aggiuntive a quelle della ENV 1995-1-1 per gli
elementi composti legno-calcestruzzo, soggetti principalmente a flessione.
(2) La larghezza efficace dell'ala di calcestruzzo di impalcati misti legno/calcestruzzo
dovrebbe essere determinata come per una sezione a T di calcestruzzo, vedere la
ENV 1992-1-1, sottopunto 2.5.2.2.1.
P(3) Il collegamento deve essere progettato in modo da trasmettere tutte le forze ine-
renti alla struttura composta. L'aderenza naturale non deve essere considerata.
P(4) La distribuzione nel senso della lunghezza delle forze di scorrimento fra il legno e
il calcestruzzo deve essere determinata sulla base della distribuzione ipotizzata
delle tensioni normali. La condizione di equilibrio deve risultare soddisfatta in ogni
parte della trave composta.
(5) Per situazioni di progetto in cui è prescritta la verifica a fatica, l'effetto dell’azione
di progetto sulle unioni dovrebbe essere minore del 40% della resistenza di pro-
getto.
(6) Per stati limite di rottura diversi da quello a fatica, si può considerare il comporta-
mento elasto-plastico del connettore.
(7) In aggiunta a 5.3.3 - 5.3.4 della ENV 1995-1-1, si applicano le prescrizioni di se-
guito elencate.
(8) Per le parti singole (legno e calcestruzzo) può essere assunta una distribuzione li-
neare delle deformazioni.
P(9) La resistenza a trazione del calcestruzzo deve essere trascurata ai fini della veri-
fica della capacità portante.
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 18 di 36
(10) Dovrebbero essere considerate le concentrazioni di tensioni quando si abbiano:
- brusche variazioni del modulo resistente della sezione;
- intagli;
- discontinuità nei dispositivi di unione (nella disposizione e/o nella rigidezza);
- introduzione di forze concentrate.
7 STATI LIMITE DI ESERCIZIO
7.1 Generalità
(1) Laddove non vengano indicati altri requisiti, dovrebbe essere verificato:
- che il comportamento elastico sia assicurato in modo da escludere deviazioni
dalla geometria prevista;
- che le inflessioni e gli incurvamenti siano limitati così da escludere effetti dina-
mici indesiderati dovuti al traffico;
- che le frequenze naturali fondamentali siano limitate in modo da escludere:
- vibrazioni dovute al traffico pedonale o veicolare o al vento, che causino
disturbo alle persone sul ponte;
- danno da fatica causato da fenomeni di risonanza.
Nota Per indagini speciali riguardanti il comfort umano in presenza di vibrazioni, un metodo viene fornito
nella ISO 2631-1.
(2) Per i ponti ferroviari i criteri prestazionali vengono forniti nella ENV 1991-3. Per pon-
ti pedonali/ciclabili e stradali i criteri prestazionali vengono forniti in 7.2, 7.3 e 7.4.
7.2 Vibrazioni causate da pedoni
7.2.1 Vibrazioni verticali
(1) L'accelerazione verticale avert dovrebbe soddisfare la condizione:
m
a vert ≤ [ 0, 7 ] ----2- per f vert < 5 Hz
s
(2) Nel calcolo della frequenza naturale fondamentale fvert dovrebbero essere adottati
valori medi del modulo di elasticità E0,mean e del modulo di scorrimento Kser con-
formemente alla ENV 1995-1-1, 4.2(1).
(3) Per configurazioni del ponte conformi al prospetto 7.1, l'accelerazione verticale
avert in m/s2 dovrebbe essere valutata come:
avert = avert,1 kvert,f [7.1]
Per ponti attraversati da file di pedoni, in aggiunta l'accelerazione verticale avert in
m/s2 dovrebbe essere calcolata anche come:
avert = 0,027 l b avert,1 kvert,f [7.2]
con:
– 2πnζ
1–e
a vert, 1 = 165 k a ------------------------- [7.3]
M ζ
M=mlb [7.4]
dove:
l è la luce in m, vedere prospetto 7.1;
b è la larghezza del ponte in m;
m è la massa per unità di area (peso proprio) del ponte in kg/m2;
ζ è il rapporto di smorzamento;
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 19 di 36
l
n = --------- è il numero di passi necessari per attraversare la luce l;
0, 9
ka è un coefficiente di configurazione che dovrebbe essere ottenuto dal
prospetto 7.1;
kvert,f dovrebbe essere ottenuto dalla figura 7.1.
Nota Questo metodo semplificato è basato sull'assunzione che la frequenza di passo corrisponda alla fre-
quenza naturale fondamentale fvert della struttura, oppure alla sua metà. L'espressione [7.1] corri-
sponde all'eccitazione del ponte da parte di un piccolo gruppo di pedoni, caso normale per la mag-
gior parte dei ponti. L'espressione [7.2] corrisponde all'eccitazione del ponte da parte di un flusso
continuo di pedoni, come si verifica in molte aree urbane con un traffico pedonale pesante. Per ponti
più piccoli di lb ≤ 37 m2 è valida l'espressione [7.1].
prospetto 7.1 Fattore di configurazione ka
Configurazione del ponte ka
1,0
0,7
per l1/l = 1,0 0,6
per l1/l = 0,8 0,8
per l1/l ≤ 0,6 0,9
figura 7.1 Correlazione fra il coefficiente kvert,f e la frequenza naturale fondamentale fvert
(4) Il rapporto di smorzamento dovrebbe essere pari a:
ζ = 0,010 per strutture principali senza unioni meccaniche;
ζ = 0,015 per strutture principali con unioni meccaniche.
(5) Per configurazioni di ponte diverse rispetto a quelle riportate nel prospetto 7.1,
l'accelerazione verticale avert,1 dovrebbe essere calcolata per la forza:
Fvert(t) = 0,28 sin(2π fvert t) [7.5]
che si muove sul ponte con velocità:
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 20 di 36
νvert = 0,9 fvert [7.6]
dove:
Fvert(t) è in kN;
νvert è in m/s;
fvert è la frequenza naturale fondamentale in direzione verticale in s-1;
t è il tempo in secondi.
7.2.2 Vibrazioni orizzontali
(1) L'accelerazione orizzontale ahor dovrebbe soddisfare la condizione:
m
a hor ≤ [ 0, 2 ] ----2- per f hor < 2, 5 Hz
s
(2) Nel calcolo della frequenza naturale fondamentale dovrebbero essere adottati va-
lori medi del modulo di elasticità E0,mean e del modulo di scorrimento Kser confor-
memente alla ENV 1995-1-1, 4.2(1).
(3) Per configurazioni del ponte conformi al prospetto 7.1, l'accelerazione orizzontale
ahor dovrebbe essere valutata come:
ahor = ahor,1 khor,f [7.7]
Per ponti attraversati da file di pedoni, in aggiunta l'accelerazione orizzontale ahor
in m/s2 dovrebbe essere calcolata anche come:
ahor = 0,027 l b ahor,1 khor,f [7.8]
con:
– 2πnζ
1–e
a hor, 1 = 40 k a ------------------------- [7.9]
M ζ
M = m⁄b [7.10]
dove:
l è la luce in m, vedere prospetto 7.1;
b è la larghezza del ponte in m;
m è la massa per unità di area (peso proprio) del ponte in kg/m2;
ζ è il rapporto di smorzamento;
l
n = --------- è il numero di passi necessari per attraversare la luce l;
0, 9
ka è un coefficiente di configurazione che dovrebbe essere ottenuto dal
prospetto 7.1;
khor,f dovrebbe essere ottenuto dalla figura 7.2.
figura 7.2 Correlazione fra il coefficiente khor,f e la frequenza naturale fondamentale fhor
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 21 di 36
Nota Questo metodo semplificato è basato sull'assunzione che la frequenza di passo corrisponde al dop-
pio della frequenza naturale fondamentale fhor della struttura. L'espressione [7.7] corrisponde all'ecci-
tazione del ponte da parte di un piccolo gruppo di pedoni, caso normale per la maggior parte dei ponti.
L'espressione [7.8] corrisponde all'eccitazione del ponte da parte di un flusso continuo di pedoni, che
si verifica in molte aree urbane con traffico pedonale pesante. Per ponti più piccoli di lb ≤ 37 m2 diventa
pertinente l'espressione [7.7].
(4) Il rapporto di smorzamento dovrebbe essere pari a:
ζ = 0,010 per strutture principali senza unioni meccaniche;
ζ = 0,015 per strutture principali con unioni meccaniche.
(5) Per configurazioni di ponte diverse rispetto a quelle riportate nel prospetto 7.2,
l'accelerazione orizzontale ahor,1 dovrebbe essere calcolata per la forza:
Fhor(t) = 0,07 sin(2π fhor t) [7.11]
che si muove sul ponte con velocità:
νhor = 1,8 fhor [7.12]
dove:
Fhor(t) è in kN;
νhor è in m/s;
fhor è la frequenza naturale fondamentale in direzione verticale in s-1;
t è il tempo in secondi.
7.3 Vibrazioni causate da veicoli
P(1) Questo punto fornisce prescrizioni per evitare il disagio dei pedoni.
(2) Si applicano i punti 7.2.1(1) e (2).
(3) Per travi e solette d'impalcato l'accelerazione verticale avert e la frequenza natura-
le fondamentale fvert possono essere calcolate come segue:
4 Fν
a vert = --- -------------------- [7.13]
π 2 µE I
π EI
f vert = -------2- ------ [7.14]
2l µ
dove:
µ è la massa del ponte per unità di lunghezza;
F è la forza concentrata che rappresenta il veicolo;
ν è la velocità del veicolo;
EI è la rigidità a flessione della struttura;
l è la luce della struttura semplicemente appoggiata oppure la luce più am-
pia di una struttura continua, vedere prospetto 7.1.
(4) L'accelerazione verticale avert dovrebbe essere determinata per un veicolo del pe-
so pari a 240 kN e una velocità pari a 15 m/s.
7.4 Vibrazioni causate dal vento
(1) Non è prescritta la verifica per l'eccitazione aerodinamica delle travi principali del
ponte per:
- ponti stradali aventi una luce efficace minore di 50 m;
- ponti pedonali e ciclabili aventi una luce efficace minore di 30 m.
(2) Come luce efficace si dovrebbe considerare la luce effettiva massima, oppure me-
tà della lunghezza d'onda della frequenza naturale fondamentale a flessione o a
torsione (la maggiore delle tre).
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 22 di 36
8 UNIONI
8.1 Generalità
P(1) Per ponti con azioni da traffico variabili con frequenza, si applicano le seguenti
prescrizioni, in aggiunta a quelle fornite nel punto 6 della ENV 1995-1-1.
Nota 1 Metodi di verifica per barre incollate sono riportate nell’appendice A (informativa).
Nota 2 Un metodo per il calcolo del numero efficace di spinotti è riportato nell’appendice C.
(2) Le unioni devono essere simmetriche per quanto riguarda dimensioni e parametri
di rigidezza, a meno che gli elementi dell'unione non siano stabilizzati mediante
controventature.
Nota 1 Esempi di unioni simmetriche sono mostrate nell’appendice C, figura C.1.
Nota 2 Un esempio di unione non-simmetrica è l'unione fra la trave secondaria e la trave principale quando
la trave secondaria è posizionata fra le travi principali e la rotazione della trave principale è impedita
dalle controventature.
P(3) L'effetto-fatica deve essere considerato conformemente a 9.
8.2 Unioni legno-calcestruzzo in travi composte
8.2.1 Generalità
(1) La capacità portante e il modulo di scorrimento dell'unione dovrebbero essere de-
terminati mediante prove. Nei casi in cui i valori sono riportati di seguito, le prove
non sono richieste.
8.2.2 Mezzi di unione a gambo cilindrico sollecitati lateralmente
(1) La resistenza delle unioni con viti, spinotti e chiodi con gambo a scanalatura anu-
lari o ad elica, inseriti perpendicolarmente al piano di scorrimento, dovrebbe esse-
re maggiorata del 20% rispetto a quella dei corrispondenti giunti legno-legno con-
formemente alla ENV 1995-1-1.
(2) La rigidezza delle unioni con viti, spinotti e chiodi con gambo a scanalatura anulari
o ad elica, inseriti perpendicolarmente al piano di taglio, dovrebbe essere maggio-
rata del 100% rispetto a quella dei corrispondenti giunti legno-legno conforme-
mente alla ENV 1995-1-1.
(3) Nel caso di uno strato intermedio non strutturale fra legno e calcestruzzo (per
esempio per la cassaforma), vedere figura 8.1, i parametri di resistenza e rigidez-
za dovrebbero essere determinati mediante una speciale analisi oppure mediante
prove.
figura 8.1 Cassaforma come strato intermedio
Legenda
1 Calcestruzzo
2 Strato intermedio non strutturale
3 Legno
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 23 di 36
8.2.3 Mezzi di unione a gambo cilindrico sollecitati assialmente
(1) Nel caso di mezzi di unione inclinati tutti nella stessa direzione, si dovrebbe assu-
mere che le forze di taglio V si trasmettano come forze di trazione Ft assorbite dai
mezzi di unione e come forze di compressione Fc, come mostrato nella figura 8.2.
(2) L'angolo β non dovrebbe essere preso maggiore di 20°.
Nota Ciò corrisponde a µd ≈ 0,4, vedere 6.3.3(3).
(3) Nel caso di mezzi di unione inclinati in due diverse direzioni, si dovrebbe assume-
re che le forze di taglio V vengano assorbite come forze di trazione e di compres-
sione Ft e Fc come mostrato nella figura 8.3.
(4) I mezzi di unione inclinati unidirezionalmente non dovrebbero essere usati se la
direzione della forza può variare.
figura 8.2 Modello analitico per mezzi di unione inclinati unidirezionalmente
Legenda
1 Calcestruzzo
2 Legno
figura 8.3 Modello analitico per mezzi di unione inclinati bidirezionalmente
Legenda
1 Calcestruzzo
2 Legno
8.2.4 Unioni scanalate
(1) Per unioni a scanalature rettangolari oppure cilindriche, vedere figura 1.1, si do-
vrebbe assumere che la forza di taglio sia assorbita tramite la pressione diretta di
contatto fra il legno e il calcestruzzo gettato nella scanalatura.
(2) Si dovrebbe verificare che la resistenza a taglio della parte di calcestruzzo e della
parte di legno dell’unione sia sufficiente.
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 24 di 36
9 FATICA
P(1) Per strutture o parti strutturali e per connessioni soggette a frequenti variazioni
tensionali a causa del carico dovuto al traffico o al vento, deve essere verificato
che nessuna rottura o danno rilevante potrà verificarsi in seguito a fatica durante
la durata di vita prevista.
Nota Un metodo semplificato di verifica è riportato nell’appendice B (informativa).
(2) Per i carichi da traffico sui ponti pedonali/ciclabili, la verifica a fatica non è richiesta.
P(3) Le vibrazioni di elementi innescate da vortici di vento devono essere limitate per
evitare danni da fatica.
Nota Direttive sul calcolo delle tensioni indotte dall'eccitazione da vortici sono contenute nella ENV 1993-2,
appendice M.
10 CONTROLLO
(1) L'umidità delle lamelle al momento della pre-sollecitazione dovrebbe essere
uguale o minore dell'umidità media prevista in esercizio per il ponte o per i suoi
componenti.
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 25 di 36
APPENDICE A BARRE DI ACCIAIO INCOLLATE
(informativa)
A.1 Generalità
(1) L'uso di barre di acciaio incollate dovrebbe essere limitato a parti strutturali nelle
classi di servizio 1 e 2.
(2) Dovrebbe essere verificato che le proprietà dell'adesivo e la sua adesione all'ac-
ciaio e al legno siano affidabili per tutta la vita in esercizio della struttura, entro i
campi di temperature e umidità previsti.
(3) Le barre dovrebbero essere filettate o sagomate.
Nota La durabilità dell'adesione di superfici di acciaio lisce non è ben nota. L'adesione può essere nega-
tivamente influenzata per esempio dalla corrosione.
(4) Dovrebbe essere considerato che la capacità portante di un gruppo di barre incol-
late che agiscono assieme è normalmente minore della somma delle resistenze
delle singole barre incollate prese individualmente.
Nota Questo effetto è normalmente causato da modi di rottura fragile.
(5) Per le barre inserite perpendicolarmente alla fibratura, dovrebbe essere preso in
considerazione il rischio di spacco del legno derivante dalle variazioni di umidità.
A.2 Barre sollecitate assialmente
A.2.1 Generalità
(1) La capacità portante delle unioni realizzate con barre incollate caricate assial-
mente dovrebbe essere verificata per i seguenti modi di rottura:
- rottura della barra di acciaio;
- rottura dell'adesivo e del suo collegamento all'acciaio e al legno;
- rottura del legno adiacente alla linea di colla;
- rottura dell'elemento ligneo (per esempio rottura per sfilamento di un intero
blocco di legno con alcune barre incollate).
(2) La capacità portante dovrebbe in generale essere limitata dalla resistenza della
barra, non dalla capacità di trasferimento del carico da parte dell'adesivo e dal suo
incollaggio alla barra e al legno, oppure dalla resistenza del legno.
Nota Questo requisito tende ad impedire una rottura fragile.
(3) Le espressioni fornite sono basate sia sul diametro esterno d della barra; sia,
quando la resistenza dell'adesivo non è critica, su un diametro equivalente dequ
uguale al più piccolo valore fra il diametro del foro e 1,25d.
Nota Per le barre filettate, il diametro esterno è uguale al diametro nominale; per la maggior parte delle
barre di armatura sagomate, il diametro esterno è circa il 10% maggiore del diametro nominale.
(4) Gli interassi e le distanze minime dovrebbero essere conformi alla figura A.1.
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 26 di 36
figura A.1 Interassi e distanze minime per barre caricate assialmente, caricate
(5) La lunghezza minima di ancoraggio la,min dovrebbe essere pari a:
0, 4 d 2
l a, min = max. [A.1]
8d
dove:
la,min è la lunghezza minima di ancoraggio in mm, vedere figura A.1;
d è il diametro esterno della barra in mm.
Nota Usando la lunghezza di ancoraggio la = la,min conformemente all'espressione [A.1] diventa determi-
nante la perdita dell’adesione.
A.2.2 Stato limite ultimo
A.2.2.1 Rottura di una singola barra
(1) La resistenza assiale in trazione della barra di acciaio dovrebbe essere determi-
nata in riferimento alla resistenza allo snervamento dell'acciaio; in compressione,
la possibilità di cedimento per carico di punta dovrebbe essere presa in conside-
razione per tensioni di compressione di progetto maggiori di 300 N/mm2.
(2) La resistenza assiale caratteristica corrispondente allo scorrimento nel legno do-
vrebbe essere considerata pari a:
Fax,Rk = π dequ la fv,k [A.2]
(3) La resistenza a scorrimento locale del legno attorno al foro dovrebbe essere de-
terminata, per legno di conifera e per tutti gli angoli tra barra e fibratura del legno,
come segue:
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 27 di 36
–3 – 0, 2 1, 5
f v, k = 1, 2 × 10 d equ ρk [A.3]
dove:
fv,k è la resistenza a taglio caratteristica del legno in N/mm2;
dequ è il diametro equivalente in mm, vedere A.2.1(3);
ρk è la massa volumica caratteristica del legno in kg/m3.
(4) La resistenza a scorrimento dell'adesivo e della sua aderenza all'acciaio e al le-
gno, dovrebbe essere verificata mediante prove.
(5) Per la classe di servizio 2 i valori di kmod conformemente alla ENV 1995-1-1 do-
vrebbero essere ridotti del 20%.
Nota Nei riguardi dello stato limite ultimo vengono normalmente utilizzati gli stessi coefficienti di correzio-
ne kmod sia per il legno massiccio che per il legno lamellare incollato, nonché per le loro connessioni,
sia per la classe di servizio 1 che per la 2. Prove di sfilamento su bulloni, incollati in legno di conifere
con la direzione del carico parallela alla fibratura, hanno dimostrato un significativo decremento nel-
la resistenza ad umidità del legno elevate.
A.2.2.2 Rottura nell'elemento ligneo
(1) L'area efficace di rottura nel legno, Aef, di una barra, vedere figura A.2, soggetta
ad una forza assiale parallela alla fibratura, dovrebbe essere considerata come il
più piccolo valore fra:
- una larghezza efficace bef pari a 2,5d su ciascun lato della barra, oppure
- l'area derivata dalla geometria effettiva.
(2) In un gruppo di barre, la resistenza caratteristica parallela alla fibratura di una bar-
ra, Fax,Rk, non dovrebbe essere assunta maggiore di:
Fax,Rk = ft,o,k Aef [A.4]
dove:
Fax,Rk è la capacità portante caratteristica di una barra;
ft,o,k è la resistenza caratteristica a trazione del legno;
Aef è l'area efficace di rottura nel legno.
(3) L'area efficace Aef di una barra non dovrebbe essere considerata maggiore di
quanto corrisponde ad una larghezza efficace bef pari a 2,5d su ciascun lato della
barra, e non maggiore di quanto corrisponde alla geometria effettiva, vedere figu-
ra A.2.
figura A.2 Aree efficaci per gli sforzi di ancoraggio paralleli alla fibratura con bef = 6d
(4) Quando gli sforzi di trazione di ancoraggio Fax,Ek agiscono sotto un angolo α ri-
spetto alla fibratura, vedere figura A.3, per l'ancoraggio in legno di conifere la ca-
pacità portante caratteristica Fax,Rk di una singola barra, oppure, se più barre agi-
scono parallelamente in linea con la forza, la capacità portante caratteristica Fax,Rk
di questo gruppo di barre, non dovrebbe essere considerata maggiore di:
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 28 di 36
0, 15 0, 7 0, 7 a 0, 2
F ax, Rk = ------------- a b ef --- ρ k [A.5]
sin α h
dove:
a è la profondità di ancoraggio delle barre, misurata perpendicolarmente al-
la fibratura, in mm;
α è l'angolo fra la barra e la direzione della fibratura;
bef è la larghezza dell'area efficace di una barra, in mm;
h è l'altezza dell'elemento legnoso, in mm;
ρk è la massa volumica caratteristica del legno, in kg/m3.
figura A.3 Larghezza efficace bef e sforzo di ancoraggio agenti sotto un angolo α
Nota Questo requisito tende ad evitare la rottura fragile a spacco del legno. Quando più barre agiscono
parallelamente in linea con la forza, la capacità portante caratteristica del gruppo di barre non è
maggiore della capacità portante di una singola barra tenuto conto della resistenza del legno.
(5) Nel calcolo, il rapporto a/h non dovrebbe essere assunto maggiore di 0,7.
(6) La larghezza efficace bef non dovrebbe essere assunta maggiore di quella corri-
spondente a 3d per ciascun lato della barra, e non maggiore di quella corrispon-
dente alla geometria effettiva.
(7) Per le zone fra le barre soggette a forze di taglio, vedere figura A.4, dovrebbe es-
sere verificato che:
FV,Ed = fv,d bef hef [A.6]
dove:
FV,Ed è la capacità portante di progetto a taglio;
fv,d è la resistenza di progetto a taglio;
hef è definita nella figura A.4.
A.2.3 Stati limite di esercizio
(1) Il modulo di scorrimento istantaneo Kser in N/mm per barra dovrebbe essere preso
uguale a:
Kser = 0,005 d 1,8 ρk1,5 [A.7]
dove:
d è il diametro della barra in mm;
ρk è la massa volumica caratteristica del legno in kg/m3.
A.3 Barre sollecitate lateralmente
A.3.1 Stato limite ultimo
(1) Si applicano le prescrizioni della ENV 1995-1-1 per gli spinotti sollecitati lateral-
mente.
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 29 di 36
(2) Per barre incollate caricate lateralmente e inserite parallelamente alla fibratura, la
resistenza al rifollamento dovrebbe essere considerata pari al 10% della resisten-
za al rifollamento perpendicolare alla fibratura.
(3) Per barre incollate inserite a formare un angolo α con la fibratura, dovrebbe esse-
re applicata l'interpolazione lineare.
A.3.2 Stati limite di servizio
(1) Per barre inserite perpendicolarmente alla direzione della fibratura, il modulo di
scorrimento istantaneo Kser in N/mm per barra dovrebbe essere assunto uguale a:
Kser = 0,05 d ρk1,5 [A.8]
dove:
d è il diametro efficace della barra in mm;
ρk è la massa volumica caratteristica del legno in kg/m3.
figura A.4 Esempio di zone soggette a taglio fra le barre incollate
Nota Per le barre filettate il diametro efficace della barra corrisponde a circa il 90% del diametro esterno;
per le barre da armatura ad aderenza migliorata il diametro efficace corrisponde al diametro nominale.
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 30 di 36
(2) Per barre inserite parallelamente alla fibratura, Kser è opportuno sia assunto pari a:
Kser = 0,01 d ρk1,5 [A.9]
(3) Per barre incollate inserite formando un angolo α rispetto alla fibratura, dovrebbe
applicarsi l'interpolazione lineare.
A.4 Barre incollate con sforzi combinati assiale ed a taglio
(1) Per barre incollate con sforzi combinati assiale ed a taglio, dovrebbe essere sod-
disfatta la seguente condizione:
F ax, Ed 2 F la, Ed 2
----------------
- + ---------------- ≤ 1 [A.10]
F ax, Rd F la, Rd
dove:
Fax,Rd e Fla,Rd sono le capacità portanti di progetto della barra incollata sotto il
solo sforzo assiale Fax,Ed o il solo sforzo a taglio Fla,Ed.
A.5 Esecuzione
(1) Le superfici dei fori devono risultare da lavorazione eseguita con taglio netto.
(2) Dovendo serrare più barre raggruppate, il serraggio deve avvenire in modo uniforme.
(3) Occorre verificare che il foro sia completamente riempito con l'adesivo.
(4) Al momento di incollare le barre, l'umidità del legno non dovrebbe essere maggio-
re del 3% dell'umidità minima prevista in esercizio, mediata su tutta la sezione del
pezzo.
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 31 di 36
APPENDICE B VERIFICA A FATICA
(informativa)
(1) Una verifica semplificata dovrebbe essere riferita all'intervallo di tensioni ∆σ:
∆σ = σmax - σmin [B.1]
dove:
σmax è la tensione caratteristica massima derivante dall'azione a fatica;
σmin è la tensione caratteristica minima derivante dall'azione che indica la fatica.
(2) La tensione dovrebbe essere determinata mediante un'analisi elastica sotto
l'azione specificata.
(3) Nel calcolo delle tensioni si dovrebbero prendere in conto sia le tensioni in unioni
rigide o semi-rigide, nonché gli effetti secondari delle deformazioni e distorsioni.
(4) Una verifica a fatica non è richiesta se ∆σ è non maggiore del 10% della corri-
spondente normale resistenza di progetto.
(5) Per un carico periodico con n cicli, dovrebbe essere verificato che:
∆σ ≤ ffat,d [B.2]
dove ffat,d è la resistenza di progetto a fatica.
(6) La resistenza di progetto a fatica dovrebbe essere calcolata come:
k fat f k
f fat, d = ---------------
- [B.3]
γ M, fat
dove fk è la resistenza caratteristica per carichi statici e kfat viene riportato nella fi-
gura B.1.
(7) Il valore di kfat ∞ dovrebbe essere ricavato dal prospetto B.1.
figura B.1 Correlazione fra kfat e il numero di cicli n
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 32 di 36
prospetto B.1 Valori di kfat∞
kfat,∞
Elementi lignei soggetti a
- compressione perpendicolare e 0,60
parallela alla fibratura
- flessione 0,30
trazione
trazione/compressione alternate
- taglio 0,20
Unioni con
- spinotti 0,25
- chiodi 0,15
(8) Per un carico periodico con ampiezza variabile, dovrebbe essere verificato che:
ni
∑ -----
N
≤1
i
dove:
ni è il numero di cicli nell'intervallo di tensioni ∆σi durante la durata di vita
prevista dal progetto;
Ni è il numero di cicli nell'intervallo di tensioni ∆σi che provocano la rottura.
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 33 di 36
APPENDICE C CAPACITÀ PORTANTE A TAGLIO DI MEZZI DI UNIONE A GAMBO CILINDRICO
(informativa)
(1) Le espressioni riportate in 6.2.1 della ENV 1995-1-1 per determinare la capacità
portante di progetto di bulloni, spinotti e viti dovrebbero essere usate soltanto per
un singolo mezzo di unione.
Nota Si intende che le prescrizioni di questo punto vengano trasferite alla ENV 1995-1-1.
(2) La capacità portante di progetto di n bulloni, spinotti o viti sollecitati a taglio, allineati
lungo la direzione del carico, dovrebbe basarsi sul numero efficace nef dato da:
k j λr
n ef = 2 ---
n
[C.1]
2
con il rapporto di snellezza relativa λr del mezzo di unione:
λ ef
λ r = ------
- ma λr ≤ 1 [C.2]
λy
dove:
kj è un coefficiente che tiene conto della geometria dell'unione e delle tolle-
ranze di fabbricazione, vedere (3);
λef, λy sono rapporti di snellezza, vedere (4).
(3) A meno che non possa essere verificata una migliore prestazione, il coefficiente kj
dovrebbe essere preso come kj = 0,8.
(4) I rapporti di snellezza λy e λef dovrebbero essere desunti dai prospetti C.1:
dove:
t, t1, t2 sono spiegati nella figura C.1;
d è il diametro del mezzo di unione;
fu,k è la resistenza a trazione caratteristica dell'acciaio;
fh,1,k è la resistenza caratteristica a rifollamento dell'elemento laterale;
fh,2,k è la resistenza caratteristica a rifollamento dell'elemento centrale.
Per rapporto t/d compresi fra 0,5 e 1,0 può essere applicata l'interpolazione
lineare.
figura C.1 Esempi di unioni simmetriche
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 34 di 36
prospetto C.1 Rapporti di snellezza λr e λef
Unioni a doppio taglio
Legno-legno Legno-legno Elementi laterali Elementi laterali spessi
t1 fh,1,k ≥ 0,5 t2 fh,2,k t1 fh,1,k < 0,5 t2 fh,2,k sottili di acciaio di acciaio
t ≤ 0,5 d t≥d
vedere figura C.1 a) vedere figura C.1 a) vedere figura C.1 b) vedere figura C.1 b)
t2 t1 t2 t2
λef --- --- --- ---
d d d d
2 f h,2,k f 1,15 2 f h,1,k f f u,k f u,k
λy 1, 15 -------------------------
u,k
--------
- [C.3] --------- -------------------------
u,k
--------
- [C.4] 1, 15 --------- [C.5] 1, 55 --------- [C.6]
f h,1,k + f h,2,k fh,2,k 2 f h,1,k + f h,2,k f h,1,k f h,2,k f h,2,k
Taglio doppio Taglio multiplo Taglio singolo
Elemento centrale di acciaio Elemento centrale di acciaio Elementi laterali sottili di acciaio Elementi laterali spessi di acciaio
Per tutti i rapporti t/d Per tutti i rapporti t/d t ≤ 0,5 d t≥d
vedere figura C.1 c) vedere figura C.1 d) vedere figura C.1 e) vedere figura C.1 e)
t1 t2 t1 t1
λef --- --- --- ---
d d d d
1, 15 f u,k 2 f u,k f u,k f u,k
λy --------- --------- [C.7] 1, 55 --------- [C.8] 1, 37 --------- [C.9] 0, 77 --------- [C.10]
2 f h,1,k f h,2,k f h,1,k f h,1,k
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 35 di 36
PUNTI DI INFORMAZIONE E DIFFUSIONE UNI
Milano (sede) Via Battistotti Sassi, 11B - 20133 Milano - Tel. 0270024200 - Fax 0270105992
Internet: www.unicei.it - Email: diffusione@uni.unicei.it
Roma Via delle Colonnelle, 18 - 00186 Roma - Tel. 0669923074 - Fax 066991604
Email: uni.roma@uni1.inet.it
Bari c/o Tecnopolis CSATA Novus Ortus
Strada Provinciale Casamassima - 70010 Valenzano (BA) - Tel. 0804670301 - Fax 0804670553
Bologna c/o CERMET
Via A. Moro, 22 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - Tel. 0516250260 - Fax 0516257650
Brescia c/o AQM
Via Lithos, 53 - 25086 Rezzato (BS) - Tel. 0302590656 - Fax 0302590659
Cagliari c/o Centro Servizi Promozionali per le Imprese
Viale Diaz, 221 - 09126 Cagliari - Tel. 070349961 - Fax 07034996306
Catania c/o C.F.T. SICILIA
Piazza Buonarroti, 22 - 95126 Catania - Tel. 095445977 - Fax 095446707
Firenze c/o Associazione Industriali Provincia di Firenze
Via Valfonda, 9 - 50123 Firenze - Tel. 0552707268 - Fax 0552707204
Genova c/o CLP Centro Ligure per la Produttività
Via Garibaldi, 6 - 16124 Genova - Tel. 0102476389 - Fax 0102704436
La Spezia c/o La Spezia Euroinformazione, Promozione e Sviluppo
Piazza Europa, 16 - 19124 La Spezia - Tel. 0187728225 - Fax 0187777961
Napoli c/o Consorzio Napoli Ricerche
Corso Meridionale, 58 - 80143 Napoli - Tel. 0815537106 - Fax 0815537112
Pescara c/o Azienda Speciale Innovazione Promozione ASIP
Via Conte di Ruvo, 2 - 65127 Pescara - Tel. 08561207 - Fax 08561487
Reggio Calabria c/o IN.FORM.A. Azienda Speciale della Camera di Commercio
Via T. Campanella, 12 - 89125 Reggio Calabria - Tel. 096527769 - Fax 0965332373
Torino c/o Centro Estero Camere Commercio Piemontesi
Via Ventimiglia, 165 - 10127 Torino - Tel. 0116700511 - Fax 0116965456
Treviso c/o Treviso Tecnologia
Via Roma, 4/D - 31020 Lancenigo di Villorba (TV) - Tel. 0422608858 - Fax 0422608866
Udine c/o CATAS
Via Antica, 14 - 33048 S. Giovanni al Natisone (UD) - Tel. 0432747211 - Fax 0432747250
Vicenza c/o Associazione Industriali Provincia di Vicenza
Piazza Castello, 2/A - 36100 Vicenza - Tel. 0444232794 - Fax 0444545573
UNI
Ente Nazionale Italiano La pubblicazione della presente norma avviene con la partecipazione volontaria dei Soci,
di Unificazione dell’Industria e dei Ministeri.
Via Battistotti Sassi, 11B Riproduzione vietata - Legge 22 aprile 1941 Nº 633 e successivi aggiornamenti.
20133 Milano, Italia
UNI ENV 1995-2:1999 Pagina 36 di 36
Potrebbero piacerti anche
- Uni 10809 Ringhiere e Parapetti (Uni)Documento12 pagineUni 10809 Ringhiere e Parapetti (Uni)luigicorvagliaNessuna valutazione finora
- Eurocodice 9 - Progettazione Delle Strutture in AlluminioDocumento210 pagineEurocodice 9 - Progettazione Delle Strutture in AlluminioGiuseppe Gori100% (3)
- Uni en 12056 - 2Documento38 pagineUni en 12056 - 2Carlo Rico GardiniNessuna valutazione finora
- Uni 11235Documento42 pagineUni 11235zefiro15100% (1)
- Eurocodice 5 - Uni Env 1995-1-2 Progettazione Delle Strutture in Legno Parte 1-2 Regole Generali Progettazione Strutturale Contro L'IncendioDocumento44 pagineEurocodice 5 - Uni Env 1995-1-2 Progettazione Delle Strutture in Legno Parte 1-2 Regole Generali Progettazione Strutturale Contro L'IncendioDanilo CataniaNessuna valutazione finora
- Uni en 13509Documento36 pagineUni en 13509Danilo Infantino100% (1)
- Nuovo Esame per Esperto in Gestione dell'Energia Settore Industriale: Test e temi di esame svolti per sostenere l’esame di Esperto in Gestione dell’Energia del Settore IndustrialeDa EverandNuovo Esame per Esperto in Gestione dell'Energia Settore Industriale: Test e temi di esame svolti per sostenere l’esame di Esperto in Gestione dell’Energia del Settore IndustrialeNessuna valutazione finora
- Nuovo Esame per Esperto in Gestione dell'Energia - Settore Civile: Test e temi di esame svolti per sostenere l’esame di Esperto in Gestione dell’Energia del Settore CivileDa EverandNuovo Esame per Esperto in Gestione dell'Energia - Settore Civile: Test e temi di esame svolti per sostenere l’esame di Esperto in Gestione dell’Energia del Settore CivileNessuna valutazione finora
- Uni 10779Documento24 pagineUni 10779Peng LuNessuna valutazione finora
- UNI 12237 - 2004 - CompressedDocumento14 pagineUNI 12237 - 2004 - CompressedMaseNessuna valutazione finora
- Eurocodice 3 Parte 6 Apparecchi Di SollevamentoDocumento58 pagineEurocodice 3 Parte 6 Apparecchi Di Sollevamentofabio manenteNessuna valutazione finora
- EC3Documento132 pagineEC3FedericoNessuna valutazione finora
- En 1991-1-2 - 2004Documento51 pagineEn 1991-1-2 - 2004Paolo FurioliNessuna valutazione finora
- Uni 11292Documento18 pagineUni 11292Claudio Della RoccaNessuna valutazione finora
- Eurocodice 2 - Uni Env 1992-1-2 Progettazione Delle Strutture Di Calcestruzzo Parte 1-2 Regole Generali Progettazione Della Resistenza All'IncendioDocumento78 pagineEurocodice 2 - Uni Env 1992-1-2 Progettazione Delle Strutture Di Calcestruzzo Parte 1-2 Regole Generali Progettazione Della Resistenza All'IncendioRoberto_Enriqu_1386Nessuna valutazione finora
- Eurocodice 3 - Parte 1.2 (UNI ENV 1993-1-2) Progettazione Delle Strutture in Acciaio - Regole Generali Progettazione Della Resistenza All'IncendioDocumento62 pagineEurocodice 3 - Parte 1.2 (UNI ENV 1993-1-2) Progettazione Delle Strutture in Acciaio - Regole Generali Progettazione Della Resistenza All'IncendioRoberto_Enriqu_1386Nessuna valutazione finora
- Univ1994 1 2 2001 EitDocumento92 pagineUniv1994 1 2 2001 EitNicola TunziNessuna valutazione finora
- Univ1993 1 4 1999 EitDocumento60 pagineUniv1993 1 4 1999 EitNicola TunziNessuna valutazione finora
- Eurocodice 6 - UNI ENV 1996-1-1 Progettazione Delle Strutture Di Muratura - Regole Per La Muratura Armata e Non ArmataDocumento114 pagineEurocodice 6 - UNI ENV 1996-1-1 Progettazione Delle Strutture Di Muratura - Regole Per La Muratura Armata e Non ArmataRoberto_Enriqu_1386Nessuna valutazione finora
- Univ1993 1 7 2002 EitDocumento46 pagineUniv1993 1 7 2002 EitNicola TunziNessuna valutazione finora
- Univ1992 3 2000 EitDocumento28 pagineUniv1992 3 2000 EitNicola TunziNessuna valutazione finora
- Univ1999 1 1 2002 Eit PDFDocumento210 pagineUniv1999 1 1 2002 Eit PDFLupu DanielNessuna valutazione finora
- Univ1993 4 1 2002 EitDocumento106 pagineUniv1993 4 1 2002 EitNicola TunziNessuna valutazione finora
- Univ1991 2 5 2001 EitDocumento50 pagineUniv1991 2 5 2001 EitNicola TunziNessuna valutazione finora
- Univ1993 3 1 2002 EitDocumento94 pagineUniv1993 3 1 2002 EitNicola TunziNessuna valutazione finora
- Univ1991 2 6 2000 EitDocumento30 pagineUniv1991 2 6 2000 EitNicola TunziNessuna valutazione finora
- Eurocodice 8 - UNI ENV 1998-1-1 Indicazioni Progettuali Per La Progettazione Sismica - Azioni Sismiche e Requisiti Generali Per Le StruttureDocumento22 pagineEurocodice 8 - UNI ENV 1998-1-1 Indicazioni Progettuali Per La Progettazione Sismica - Azioni Sismiche e Requisiti Generali Per Le StruttureRoberto_Enriqu_1386Nessuna valutazione finora
- Univ1993 4 3 2002 EitDocumento32 pagineUniv1993 4 3 2002 EitNicola TunziNessuna valutazione finora
- Univ1998 5 1998 EitDocumento32 pagineUniv1998 5 1998 EitNicola TunziNessuna valutazione finora
- Eurocodice 7 - EnV UNI 1997-1 Progettazione Geotecnica - Regole GeneraliDocumento104 pagineEurocodice 7 - EnV UNI 1997-1 Progettazione Geotecnica - Regole GeneraliLuciano CortisNessuna valutazione finora
- Eurocodice 3-4-2 - ITDocumento48 pagineEurocodice 3-4-2 - ITAgliozzoNessuna valutazione finora
- Univ1991 5 2002 EitDocumento60 pagineUniv1991 5 2002 EitNicola TunziNessuna valutazione finora
- Univ1991 1 1996 EitDocumento58 pagineUniv1991 1 1996 EitNicola TunziNessuna valutazione finora
- Eurocodice 7 - Env Uni 1997-3 Progettazione Geotecnica - Progettazione Assistita Da Prove in SitoDocumento136 pagineEurocodice 7 - Env Uni 1997-3 Progettazione Geotecnica - Progettazione Assistita Da Prove in SitoLuciano CortisNessuna valutazione finora
- Uni10832-99 Serbatoi GPLDocumento22 pagineUni10832-99 Serbatoi GPLluca di pasqualeNessuna valutazione finora
- Sistemi Di Scarico Acque Nere - UNI 12056-1Documento20 pagineSistemi Di Scarico Acque Nere - UNI 12056-1Carlo Rico GardiniNessuna valutazione finora
- Uni9165 Condotte Gas Fino A 5 Bar ProgDocumento28 pagineUni9165 Condotte Gas Fino A 5 Bar Progluca di pasqualeNessuna valutazione finora
- Eurocodice 1, Parte 2-1Documento30 pagineEurocodice 1, Parte 2-1Lorenzo CampaniniNessuna valutazione finora
- UNI en 12464-1 - Luce e Illuminazione - Illuminazione Dei Posti Di Lavoro in InternoDocumento42 pagineUNI en 12464-1 - Luce e Illuminazione - Illuminazione Dei Posti Di Lavoro in Internopippo2kNessuna valutazione finora
- Univ1993 1 6 2002 EitDocumento92 pagineUniv1993 1 6 2002 EitNicola TunziNessuna valutazione finora
- Norme Uni en Iso 14683 Ponti Termici SemplificatoDocumento26 pagineNorme Uni en Iso 14683 Ponti Termici SemplificatoArchi Tutti100% (1)
- UNI ENV 1991-2-3bDocumento50 pagineUNI ENV 1991-2-3blodo_85Nessuna valutazione finora
- Cei 20-38 1Documento30 pagineCei 20-38 1gandalf92Nessuna valutazione finora
- Uni en 40-3-1Documento20 pagineUni en 40-3-1antenna55Nessuna valutazione finora
- Uni 10200Documento22 pagineUni 10200Paolo100% (1)
- UNI EN 1993-1-2-2005 ITA IncendioDocumento82 pagineUNI EN 1993-1-2-2005 ITA IncendioNiccolò PassariniNessuna valutazione finora
- Cei 20-17Documento28 pagineCei 20-17gandalf92Nessuna valutazione finora
- 10083-1 Uni en PDFDocumento52 pagine10083-1 Uni en PDFShalu Babu100% (1)
- Uni-En-12478 - 2003-Torni e Centri Di Tornitura Di Grandi DimensioniDocumento38 pagineUni-En-12478 - 2003-Torni e Centri Di Tornitura Di Grandi DimensioniantonioNessuna valutazione finora
- Uni en 22553 - 1997Documento58 pagineUni en 22553 - 1997Amine DabbabiNessuna valutazione finora
- UNI1264 - Sistema RadianteDocumento22 pagineUNI1264 - Sistema RadianteAntonio CoscoNessuna valutazione finora
- Power Supply Units For Electrostatic Precipitators: Impianti E Sicurezza Di EsercizioDocumento22 paginePower Supply Units For Electrostatic Precipitators: Impianti E Sicurezza Di EsercizioDIEGO TERANNessuna valutazione finora
- UNI EN 13747 - 2005 - Lastre Per SolaiDocumento78 pagineUNI EN 13747 - 2005 - Lastre Per SolaiEmanuele MastrangeloNessuna valutazione finora
- UNI 12237 - 2004 - CompressedDocumento14 pagineUNI 12237 - 2004 - CompressedMaseNessuna valutazione finora
- Condominio 2024: Guida pratica di diritto per la gestione del tuo condominioDa EverandCondominio 2024: Guida pratica di diritto per la gestione del tuo condominioNessuna valutazione finora
- Medial Cat 2012 Ita-Eng WebDocumento82 pagineMedial Cat 2012 Ita-Eng Webpollucite_1Nessuna valutazione finora
- 030 - Norme CartiglioDocumento23 pagine030 - Norme CartiglioAngeloNessuna valutazione finora
- PAVONI CATALOGO MacchineDocumento48 paginePAVONI CATALOGO MacchinevasketeNessuna valutazione finora
- AlimentadorDocumento63 pagineAlimentadorEletronica ReparNessuna valutazione finora
- Acuastato Honeywell 111Documento20 pagineAcuastato Honeywell 111nside1Nessuna valutazione finora
- ARDF Doppler IW2NDH Manuale UtenteDocumento18 pagineARDF Doppler IW2NDH Manuale Utenteag1tatorNessuna valutazione finora