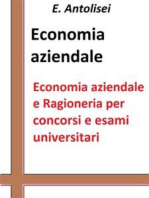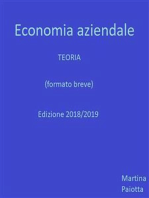Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Capitolo 1 Riassunto Potito
Caricato da
Nello AccettoCopyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
Capitolo 1 Riassunto Potito
Caricato da
Nello AccettoCopyright:
Formati disponibili
02/10/2014
Azienda
ed Economia Aziendale
Lattivit umana
volta alla soddisfazione di bisogni o desideri,
attraverso la ricerca di beni o risorse di ogni tipo
BISOGNI
BENI
Il bisogno uno stato di sofferenza psico fisica
avvertito dalluomo, che pu essere rimosso
procurandosi i beni idonei a soddisfarlo
2
02/10/2014
i BENI per la soddisfazione dei bisogni
BENI NON ECONOMICI
Sono disponibili in natura
in quantit illimitate
e si presentano liberamente
e agevolmente acquisibili
Soddisfano senza limitazioni
i bisogni di chiunque li ricerchi
BENI ECONOMICI
Si presentano scarsi rispetto
alle esigenze degli individui,
i quali non possono
facilmente acquisirli
Inducono gli individui a compiere
scelte per rimuovere
i bisogni avvertiti
3
La nozione di BENE: alcune puntualizzazioni
La nozione di bene atto a soddisfare i bisogni comprende:
i beni provvisti di materialit, ma anche i servizi di
qualunque specie (commerciali, professionali e artigianali,
sanitari, connessi alla formazione e allistruzione, ecc.)
i beni immateriali o, pi in generale, le risorse intangibili
(conoscenze, informazioni, rappresentazioni artistiche,
manifestazioni di carattere religioso, eventi musicali e
culturali, ecc.)
02/10/2014
Lattivit economica
Lattivit umana diventa attivit ECONOMICA
quando comporta
lluso
uso di beni
beni, risorse ovvero di mezzi scarsi,
scarsi
per la soddisfazione dei bisogni
I momenti tipici dellattivit economica
Consumo
Produzione
Trasferimento
5
Linfluenza dei fattori extraeconomici:
alcune puntualizzazioni
Le SCELTE ECONOMICHE non sono esclusivamente
il frutto di calcoli di pura razionalit economica
Esse risentono
dellinfluenza
dell
influenza di taluni fattori extraeconomici
(di natura culturale, etica, religiosa, sociale,
nonch legati allesperienza,
alle preferenze individuali, alle convinzioni politiche)
6
02/10/2014
Unit economiche e Aziende
Nel sistema economico odierno svolgono attivit economica
diversi soggetti (UNIT ECONOMICHE):
Singoli
individui
Gruppi
di persone
Entit
organizzate
e complesse
Non tutte le unit economiche sono aziende.
Occorre riscontrare la presenza di alcune qualit che la dottrina ha
ha,
nel corso della sua evoluzione, riconosciuto necessarie
i caratteri distintivi dellAzienda
Una unit economica pu considerarsi AZIENDA,
se possiede i seguenti caratteri:
COORDINAZIONE SISTEMICA
ECONOMICIT
AUTONOMIA
Solo in presenza di questi caratteri lunit economica
riesce a garantire la continuit del suo funzionamento
in prospettiva nel tempo
02/10/2014
COORDINAZIONE SISTEMICA
Lazienda composta da un insieme di elementi interagenti
e interdipendenti, vale a dire legati tra loro da relazioni e
rapporti di dipendenza reciproca. In tal senso essa
costituisce un SISTEMA;
I due elementi fondamentali che compongono la struttura di
unazienda sono il LAVORO e il PATRIMONIO;
Lazienda assume le sembianze di una
COORDINAZIONE SISTEMICA, che una conseguenza
della comune finalit verso cui tendono tutti gli elementi
della combinazione.
9
COORDINAZIONE SISTEMICA
Lazienda un SISTEMA APERTO; in quanto tale, essa
interagisce continuamente con lambiente circostante,
da cui trae gli input e a cui cede gli output.
Poich lambiente in continuo movimento, lazienda
chiamata ad essere fortemente dinamica e flessibile,
adeguando
d
d
con frequenza
f
e rapidit
idit le
l
proprie
i
combinazioni produttive alle modificazioni delle
condizioni esterne.
10
02/10/2014
ECONOMICIT
Lobiettivo generale perseguito dalle aziende
di ogni specie quello di operare nel tempo
in costanti condizioni di EQUILIBRIO
Equilibrio
economico
Equilibrio
finanziario
Equilibrio
monetario
Economicit significa altres
Efficacia
Strategica
(azienda proattiva)
Efficienza
operativa
11
11
AUTONOMIA
Lautonomia rappresenta lo stato di unazienda
che riesce a autodeterminarsi senza interferenze di altri soggetti
potenziale conflitto di interesse
in p
Unazienda autonoma quando riesce ad operare in condizioni di
economicit, evitando la sistematica subordinazione
allottenimento
ll tt i
t di risorse
i
d
da tterze economie
i
ma il concetto di autonomia reso sfumato da due fenomeni
Reti aziendali
Gruppi aziendali
12
02/10/2014
La Missione delle aziende
lo svolgimento della FUNZIONE DI PRODUZIONE
di beni e servizi, utili a soddisfare bisogni umani
L ffunzione
La
i
produttiva
d tti prevede
d tre
t momenti
ti tipici:
ti i i
Lacquisizione allesterno di ogni risorsa necessaria
ad intraprendere lattivit produttiva
Il consumo delle risorse acquisite per eseguire
i processi produttivi
La destinazione allesterno attraverso lo scambio
(cessione derivante da una libera negoziazione dietro
corrispettivo monetario) o lerogazione (cessione in assenza
di negoziazione)
13
Classi di aziende
SECONDO LA MODALIT CON LA QUALE
SI RAPPORTANO AL MERCATO
E MISURANO IL VALORE CREATO
Rispetto al MERCATO,
le aziende possono cos essere distinte:
ASSOCIAZIONI
E FONDAZIONI
IMPRESE
COOPERATIVE
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
14
02/10/2014
La MISURAZIONE del VALORE CREATO
valore
produzione
che il mercato attribuisce alla p
realizzata e ai fattori consumati
Imprese
Cooperative
Riferimento indiretto al mercato
Amministrazioni
pubbliche
Alt i parametri
Altri
t i ((ad
d es.: lla qualit)
lit)
Fondazioni
Associazioni
Grado di realizzazione di fini istituzionali
15
IMPRESE
Aziende che acquisiscono sul mercato
(alle condizioni per loro pi convenienti possibili)
le risorse ad esse necessarie, e cedono sul mercato,
con liberi scambi e alle migliori condizioni possibili,
il risultato delle loro produzioni
N ll iimprese possibile
Nelle
ibil apprezzare il valore
l
creato
t
contrapponendo, da un lato,
i valori di scambio che si determinano al momento
dellacquisizione degli input e, dallaltro, i valori che si
formano quando vengono ceduti gli output
16
02/10/2014
COOPERATIVE
Aziende che operano,
p
dal lato della domanda o dellofferta,
su mercati particolari e limitati, caratterizzati dal fatto che
i fornitori di alcuni fattori della produzione
i clienti destinatari dellofferta
coincidono con gli stessi proprietari
I soci esercitano la funzione imprenditoriale e possono essere:
conferenti dei fattori specifici
della produzione
Coop. di produzione e lavoro
o in quelle agricole
destinatari dei beni
o dei servizi prodotti
Coop. di consumo o di utenza
17
ASSOCIAZIONI
E FONDAZIONI
Acquisiscono gratuitamente
la disponibilit di alcuni fattori della produzione
e/o cedono gratuitamente
beni e servizi a talune categorie di utilizzatori
Si tratta di aziende,
spesso dette
d tt organizzazioni
i
i i non
profit
fit o del
d l terzo
t
settore
tt
che, pur producendo beni e servizi di rilevanza pubblica,
(ad es., lassistenza ai disabili di una certa comunit territoriale)
non appartengono alla pubblica amministrazione
18
02/10/2014
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
Comprendono unit economiche che cedono gratuitamente
o a prezzi politici e quindi non remuneratori
i propri servizi alla collettivit organizzata su un territorio
Lo Stato e le sue articolazioni territoriali sono tenuti a
contemperare obiettivi di natura economica
con altri di carattere politico e sociale
Le amministrazioni pubbliche spesso operano in condizioni di
monopolio naturale.
19
Soggetto giuridico e Soggetto economico
Soggetto
giuridico
Soggetto
economico
il titolare dei diritti
il soggetto che esercita
e degli obblighi assunti
il governo dellazienda,
determinandone gli indirizzi
d ll i d neii confronti
dallazienda
f ti
di fondo e ritraendone
dei suoi interlocutori
i conseguenti benefici
20
10
02/10/2014
soggetto giuridico e soggetto economico
nella DITTA INDIVIDUALE
Soggetto
giuridico
i idi
UNICO
PROPRIETARIO
PERSONA
FISICA
Soggetto
economico
21
SOCIET
un istituto giuridico con cui
due o pi persone conferiscono beni o servizi
per lesercizio in comune di unattivit economica
allo scopo di dividere gli utili
societ di PERSONE
9 societ semplice
9 societ in nome collettivo
9 societ in accomandita semplice
societ di CAPITALI
9 societ per azioni
9 societ in accomandita per azioni
9 societ a responsabilit limitata
9 societ cooperativa
I soci sono
personalmente e solidalmente
responsabili dei debiti
della societ
I soci rispondono solo
nei limiti della quota di capitale
da loro sottoscritta
22
11
02/10/2014
soggetto giuridico e soggetto economico
nelle SOCIET DI PERSONE
(schermo debole che si interpone tra socio e azienda)
Soggetto
gg
giuridico
Nelle societ di p
persone, i soci
assumono la funzione di
governo. Essi rispondono
SOCI
nei confronti dei terzi
con il patrimonio sociale,
ma se questo
t non sufficiente,
ffi i t
Soggetto
economico
rispondono anche con il proprio
patrimonio personale
23
soggetto giuridico e soggetto economico
nelle SOCIET DI CAPITALI
(schermo forte che si interpone tra socio e azienda)
Soggetto
giuridico
SOCIET
PERSONA
GIURIDICA
Quando la propriet ripartita tra un numero molto elevato di soci,
la funzione di governo viene, in genere, affidata ad altri soggetti
PROPRIET
Soggetto
economico
(ristretta base sociale)
MANAGER
(propriet diffusa)
S.E.
di diritto
S.E.
di fatto
24
12
02/10/2014
Modelli aziendali
Le aziende possono essere distinte anche in funzione della
STRUTTURA PROPRIETARIA e della posizione con cui questa
sii pone neii confronti
f
ti dellazienda
d ll i d stessa
t
Impresa
a propriet concentrata
- impresa familiare -
Impresa
a propriet diffusa
- public company -
La propriet appartiene a una sola
La propriet frazionata e diffusa
persona o a un numero ristretto di
tra una moltitudine di soci.
soci Il
soggetti. I proprietari esercitano
governo non esercitato da chi
il potere di guida e di governo.
detiene il capitale, ma dai manager.
Tra questi due opposti ed estremi modelli,
nella realt si trovano tipologie intermedie di imprese.
Modelli aziendali
Impresa
a propriet concentrata
- impresa familiare PREGI
CRITICIT
Flessibilit
Rapidit decisionale
Necessit di adeguata
visione strategica e capacit
innovativa da parte dei proprietari.
Difficolt nel reperimento di
finanziamenti esterni se i proprietari
non vogliono diluire
le proprie quote di partecipazione.
Si pu far ricorso a manager esterni.
Crescita vincolata alla dimensione
C
del patrimonio dei proprietari
e al possesso di idonee
competenze.
Gestione adeguata
del passaggio generazionale.
26
13
02/10/2014
Modelli aziendali
Impresa
a propriet diffusa
- public company N
Non sii identifica
id tifi limpresa
li
con una persona o un insieme
i i
di persone,
ma si considera unopportunit dinvestimento, in cui,
secondo calcoli di contingente convenienza, simpiegano
e/o si disinvestono mezzi liquidi.
I soci sono generalmente poco stabili.
Il mercato, ampio e aperto, la principale fonte di finanziamento
delle imprese.
imprese
radicata una grande fiducia nellefficienza del mercato,
ipotizzando che esso sia in grado di misurare con immediatezza
i risultati aziendali, riflettendoli sui valori di mercato delle azioni
ed esercitando in tal modo unazione di controllo sulloperato
di un management inefficiente.
27
Modelli aziendali
I due modelli si differenziano,
oltre che per la propriet (concentrata o diffusa) e per la posizione con cui
questa si pone nei confronti dellazienda, anche per altri due fattori:
modalit di CONTROLLO sul governo dellazienda
e FONTE di FINANZIAMENTO esterno.
Impresa
a propriet concentrata
- impresa familiare -
Impresa
a propriet diffusa
- public company -
CONTROLLO
DIRETTO
esercitato dalla propriet
INDIRETTO,
attraverso il mercato
FINANZIAMENTO
ESTERNO
BANCHE,
prevalentemente
MERCATI FINANZIARI,
prevalentemente
28
14
02/10/2014
Modelli aziendali
MODELLO TEDESCO (detto anche RENANO)
caratterizzato da una profonda compenetrazione
tra banche e imprese.
Le banche non si limitano a finanziare le aziende,
ma assumono partecipazioni nel loro capitale
ed esercitano il controllo nominando propri rappresentanti
negli organi sociali.
N
Nelle
ll iimprese, pur non mancando
d una certa
t diff
diffusione
i
d
della
ll propriet,
i t
coesiste una forte e stabile fascia di soci, composta da famiglie
di imprenditori, banche (in percentuali spesso elevate),
nonch rappresentanti dei dipendenti.
La stabilit di tale fascia di soci assicura un sostegno
durevole allimpresa.
29
Lambiente: definizione e struttura
AMBIENTE
insieme delle condizioni e delle circostanze,, di varia natura,,
nelle quali le aziende operano
Subsistemi
Subsistemi
ambientali
ambientali
specifici
generali
VINCOLI E OPPORTUNITA
30
15
02/10/2014
AZIENDA
Ambiente economico generale
31
Responsabilit sociale dellazienda
Il rapporto con lambiente alla base
d ll d
dellandamento
t ed
deii risultati
i lt ti di qualsiasi
l i i azienda
i d
La Corporate Social Responsibility (CSR)
si occupa della gestione e del miglioramento
dellimpatto sulla societ e sullambiente
dellattivit aziendale
La CSR risponde alle attese di natura sociale,
etica e ambientale dei vari stakeholders
32
16
02/10/2014
(Segue): responsabilit sociale dellazienda
Esempi di comportamenti socialmente responsabili
nei confronti dei dipendenti:
p
apprestare
pp
ambienti di lavoro confortevoli,, asili nido,,
strutture per il tempo libero, facilitazioni per gli alloggi, formazione continua, eventuali
remunerazioni superiori ai minimi contrattuali, etc.
verso lambiente: impiego razionale dellenergia, riciclo degli scarti di lavorazione,
attenzione alle emissioni verso lesterno (compreso lo smaltimento dei rifiuti),
preferenza dei trasporti su rotaia, rispetto a quelli su gomma, etc.
verso i consumatori: uso di materie prime il pi possibile naturali e non nocive alla
salute, approntamento di prodotti non pericolosi per la salute dei consumatori;
nei riguardi dei fornitori: assicurarsi che coloro da cui ci si approvvigiona non
impieghino manodopera minorile o condizioni di lavoro inique;
verso tutti gli stakeholders: fornire ampie e dettagliate informazioni su principi e
condotte di ispirazione etica e sociale che si dichiara di perseguire.
33
Il Rischio e lambiente
RISCHIO
Potenziale verificarsi di eventi che siano in
contrasto con gli obiettivi dellazienda
dell azienda
CAUSE
Complessit
del futuro
Limitata capacit
previsionale
34
17
02/10/2014
Il Rischio e lambiente
Rischio aziendale
Rischi particolari
Pu essere inteso come
rischio economico-generale,
oppure come
possibilit che lazienda
perda la sua attitudine
a remunerare congruamente
i soggetti che forniscono
i fattori produttivi
Parziali manifestazioni
del rischio
economico-generale
(ad es
es.:: rischi operativi
operativi,
rischi di mercato,
rischi di credito,
rischi reputazionali, ecc.)
35
Entit del rischio
Probabilit
dellevento
rischioso
i hi
Entit del
danno
ENTIT DEL
RISCHIO
Durata del
rischio
Durata delle
manifestazioni
di rischio
36
18
02/10/2014
GESTIONE DEL RISCHIO
Azioni volte ad attenuare
A i i volte
Azioni
lt ad
d attenuare
tt
gli effetti dannosi del rischio,
lentit del rischio,
agendo sulle cause
trasferendoli
nel tempo e nello spazio,
con adeguati
g
che lo determinano
provvedimenti
Nessuna alternativa strategica
pu garantire leliminazione totale del rischio
37
Alleanze e Accordi tra aziende-imprese
Sono collaborazioni, accordi e alleanze
di varia natura e tipologia.
Possono essere pi o meno stabili, pi o meno formali.
Rappresentano strumenti utili per diversi fini.
Conquistare
o consolidare un
vantaggio competitivo
Condividere
esperienze
e conoscenze
Ripartire rischi
Incrementare
capacit nellarea
produttiva
e nellarea commerciale
Sviluppare
nuove tecnologie
Accedere
a nuovi mercati
38
19
02/10/2014
Alleanze e Accordi tra aziende-imprese
Accordi di vario tipo, informali
o precisamente regolati su base contrattuale
Alleanze
strategiche
e di scadenza non breve. Servono, ad esempio,
per accedere al mercato della controparte
o per esercitare in comune alcune funzioni.
Il titolare di un brevetto, di un marchio e cos via,
Accordi
di licenza
concede a un terzo (licenziatario) il diritto
a farne uso, a fronte del pagamento di un compenso
(royalty) che, solitamente, rappresenta una
percentuale delle vendite derivanti dallutilizzazione.
39
Alleanze e Accordi tra aziende-imprese
Unimpresa industriale o produttrice di servizi
(franchiser) concede a unimpresa commerciale
(franchisee) il diritto a vendere in una determinata area
i propri beni e servizi
servizi, usandone il marchio
marchio.
Franchising
In genere, il capitale apportato dal franchisee,
ma il franchiser simpegna, a fronte
del compenso periodico che riceve,
a trasmettere esperienze e assistenza.
Joint
Ventures
Si tratta di strutture organizzative comuni,
cui si assegna anche unautonomia
un autonomia giuridica,
giuridica
costituite da due (o pi) soggetti imprenditoriali
che ne hanno il controllo congiunto e paritario
ciascuno dei quali conserva la propria
indipendenza operativa. Sono ben formalizzate
e non a tempo indeterminato.
40
20
02/10/2014
Alleanze e Accordi tra aziende-imprese
Consorzi
Sono alleanze ben formalizzate e regolate
anche sul piano giuridico (art. 2602 ss. cod. civ.),
con cui due o pi imprese creano unorganizzazione
comune per svolgere alcune attivit
che si predeterminano allinizio del rapporto,
pur conservando ciascuna di esse autonomia
economica e giuridica.
Consorzi
con attivit interna
Consorzi
con attivit esterna
servono a svolgere
alcune funzioni allinterno
e nellinteresse
dei consorziati
servono a svolgere alcune
funzioni volte allesterno
a vantaggio dei consorziati,
attraverso un ufficio comune e
un fondo consortile
41
Alleanze e Accordi tra aziende-imprese
Reti
(Networks)
Sono collaborazioni organizzate in diverse forme
fra una pluralit di aziende, che oggi peraltro
possono trarre vantaggio dalla diffusione
delle tecnologie informatiche.
informatiche Sono caratterizzate
dallinterdipendenza e dalla complementariet
che si creano fra le aziende partecipanti,
pur restando ciascuna di esse autonoma
sul piano giuridico, economico e decisionale.
Distretti
Industriali
Una pluralit di aziende, in genere di piccole e medie
dimensioni, tutte appartenenti a un determinato settore
e legate a un medesimo territorio, danno luogo
a una comunit. Decidono di condividere
le loro conoscenze e di cooperare sotto diversi profili,
pur restando indipendenti e concorrenti fra loro.
42
21
02/10/2014
Crescita aziendale
Limpresa che intende essere vincente nel lungo termine, quindi
assicurarsi condizioni di equilibrio duraturo, si pone costantemente
llobiettivo
obiettivo di CRESCERE, sia nella dimensione, sia sul piano qualitativo
(nel senso di incrementare conoscenze e competenze, efficienza nei
modi di produrre e di commercializzare, reputazione, posizione sul
mercato, capacit di tenere i rapporti con i soggetti esterni e cos via).
Crescita interna
Crescita esterna
Si usano mezzi e capacit
di cui si dispone;
portando a compimento adeguati
programmi di investimento.
Si acquisiscono altre imprese,
combinando i punti di forza
dellacquirente e dellacquisita.
Si ottimizzano le risorse
complessive.
43
Crescita aziendale
ACQUISIZIONI (alcune modalit per realizzarle)
Acquisto
di altra impresa
Fusione
Acquisizione
del capitale
della societ
che possiede
limpresa
Assunzione della propriet di unimpresa,
corrispondendone il prezzo al suo titolare.
Assunzione della propriet di unimpresa,
concordando con il titolare (se non una persona fisica)
il suo ingresso nella compagine sociale del compratore,
corrispondendogli quote del capitale della societ
risultante dalla fusione e condividendo il possesso
del pi ampio complesso aziendale che risulter
dallunificazione delle due imprese.
Acquisizione realizzata acquistando la maggioranza
o la totalit del capitale della societ che possiede
limpresa-obiettivo (partecipazione)
e lasciando le aziende giuridicamente separate.
44
22
02/10/2014
Crescita aziendale
Acquisizione
del capitale
della societ
che possiede
limpresa
(segue)
Principali Motivazioni
chi acquista intende gestire partecipazioni;
si ritiene che i vantaggi competitivi di cui dispone lacquisita potrebbero
danneggiarsi per effetto dellintegrazione;
lautonomia giuridica serve a salvaguardare lidentit e limmagine
dellacquisita;
dell
acquisita;
si cerca di rendere il sistema dimprese controllate maggiormente
flessibile;
si intende favorire accordi con altre imprese, senza estenderli allintero
insieme di attivit gestite.
()
45
Il Gruppo aziendale
Acquisizione
del capitale
della societ
che possiede
limpresa
Loperazione lascia le imprese acquisite sotto soggetti
giuridici distinti. Nel patrimonio della societ acquirente
sii iiscrive
i una partecipazione
t i
i
di controllo,
t ll sii rende
d cos
palese che essa divenuta proprietaria
della societ acquisita e, perci, della rispettiva impresa.
Nasce cos il GRUPPO, con alla testa la capogruppo o (holding) e
con un insieme di controllate, ovvero una pluralit di aziende,
indipendenti dal punto di vista giuridico, ma fra loro collegate
dal fatto di essere tutte direttamente o indirettamente
sotto il controllo di un unico soggetto.
46
23
02/10/2014
Il Gruppo aziendale
Alcune caratteristiche del GRUPPO
Le Attivit di indirizzo e coordinamento delle singole
g
aziende sono svolte
dalla capogruppo;
LAutonomia decisionale della singola azienda ridotta o inesistente;
()
Alcune politiche seguite nella formazione dei GRUPPI
Acquisizione di imprese che svolgono la medesima attivit, ma in
diverse aree;
Acquisizione di imprese che operano in settori diversi;
Acquisizione di imprese per fini puramente finanziari e speculativi;
()
47
Il Gruppo aziendale
Nella realt le strutture di gruppo si presentano assai variegate e
dalle dimensioni differenti. Si va dai piccoli gruppi con una
holding che direttamente controlla due o tre societ ai gruppi
molto
lt complessi
l
i dove,
d
a causa dellelevato
d ll l
t numero di societ,
i t sii
proceduto a creare sottoinsiemi di societ distinti per settore,
posti sotto il controllo diretto di subholding, a loro volta controllate
dalla capogruppo.
I gruppi differiscono anche per la diversa misura con cui sono
presenti soggetti terzi (con quote di minoranza) nel capitale della
stessa capogruppo e di ogni altra controllata.
La holding pu avere natura giuridica pubblica o privata.
La capogruppo pu occuparsi esclusivamente del coordinamento
e della gestione delle partecipazioni (holding pura), oppure
esercitare anche una propria attivit operativa (holding mista).
48
24
02/10/2014
Lazienda in CRISI
unazienda non in buona salute, nel senso che il suo equilibrato
divenire presenta qualche difficolt.
L azienda in crisi non semplicemente colpita da brevi alterazioni
Lazienda
o isolate disfunzioni, perch queste rientrano nella normale
dinamica aziendale. Occorre qualche grado pi elevato di
instabilit.
Di regola, la crisi un processo evolutivo lento e graduale, anche
se non mancano crisi dovute ad eventi del tutto eccezionali e
imprevedibili.
Uno dei primi sintomi della crisi lalterazione dei flussi finanziari.
Se lequilibrio economico e quello patrimoniale non sono stati
compromessi, una tempestiva ristrutturazione del passivo e
lottenimento di nuova liquidit possono sanare le disfunzioni
finanziarie.
49
Lazienda in CRISI
La crisi pu essere causata da FATTORI INTERNI e FATTORI ESTERNI,
ma spesso la crisi deriva da scelte errate o tardive del management.
Le CAUSE DI ORIGINE INTERNA che
L
h solitamente
lit
t sindividuano,
i di id
sono:
linadeguatezza strategica e la carenza di programmazione,
lincompetenza dei dirigenti, la mancata innovazione, le inefficienze
presenti in una o pi aree aziendali, in strutture operative e/o
organizzative poco flessibili oppure sovradimensionate, negli squilibri
finanziari.
Le CAUSE DI ORIGINE ESTERNA, che spesso sono solo concause di
quelle interne sono ad esempio le crisi di settore, il rapido progresso
tecnologico e cos via.
Se la crisi non irreversibile, si pu intraprendere un intervento di
RISTRUTTURAZIONE E DI RISANAMENTO.
Se la crisi irreversibile, compromessa la continuit aziendale e non
resta che procedere alla LIQUIDAZIONE dellazienda.
50
25
02/10/2014
LEconomia Aziendale
ORIGINI
Le
origini
della
scienza
dellEconomia
Aziendale
sono
convenzionalmente collocate a inizio 900, e vengono poste in
relazione ad alcuni fenomeni evolutivi, tra cui innanzitutto:
il pensiero filosofico, politico, economico, sociale e scientifico
manifestava segni di insoddisfazione e voglia di rinnovamento
le aziende diventavano pi complesse, dal punto di vista
dimensionale, tecnologico, merceologico e finanziario
51
LEconomia Aziendale
In dottrina, si riconosce il merito di aver saputo interpretare
lesigenza di rinnovamento e di aver dato una sistemazione
scientifica oltre che un notevole contributo alle evoluzioni in
corso, allopera del prof. Gino Zappa.
Nel 1927 egli propugna, nelle Tendenze Nuove negli studi di
ragioneria, lintegrazione di tre diversi rami di studio/ricerca:
Gestione
Rilevazione
Organizzazione
Scienza
dellEconomia
dell
Economia
Aziendale
Insieme di conoscenze collegate e
ordinate secondo princpi 52
26
02/10/2014
Prima di Zappa
Gli studi di Ragioneria erano sostanzialmente circoscritti agli
aspetti
p
della rilevazione.
Si avvertiva linsufficienza dellattenzione alla sola tenuta dei conti
ma si esitava a integrarla con i principi di gestione in una vera e
propria Scienza dellAmministrazione (Villa, Cerboni e,
soprattutto, Besta).
Gli studi sulla Gestione (tecnica commerciale) erano
prevalentemente
l t
t dedicati
d di ti alla
ll d
descrizione
i i
di singoli
i
li gruppii di
operazioni o tipi di aziende.
Gli studi di Organizzazione erano piuttosto limitati e ben lungi
dallinquadrare in sistematiche indagini di contenuto economico
funzioni, ruoli e relazioni tra organi.
53
I pilastri della concezione zappiana:
Lazienda viene definita come:
Istituto economico atto a perdurare che, per il
g umani, compone e svolge
g in
soddisfacimento dei bisogni
continua coordinazione, la produzione o lacquisizione e il
consumo della ricchezza
principale elemento qualificante della visione zappiana
la ipotizzata necessaria unitariet nel tempo e nello spazio
del fenomeno aziendale a fini di speculazione scientifica
Zappa dedic primaria attenzione allimpresa e al reddito
che essa genera, poich in essa si manifestano in misura
massimamente articolata, completa e integrata i processi di
trasformazione economica
54
27
02/10/2014
I pilastri della concezione zappiana:
Sul piano delle rilevazioni:
Il sistema del
reddito
sostituisce il
Il sistema dei costi e dei ricavi
traduce in quantit economiche il
sistema delle operazioni aziendali
Visione unitaria e
dinamico-evolutiva
Il sistema del
patrimonio
Attenzione focalizzata sugli
g
elementi del patrimonio
Visione disaggregata e
statico-strutturale
55
Le successive evoluzioni dellEconomia Aziendale
Soprattutto per laccresciuta complessit del fenomeno
aziendale e anche per linfluenza degli studi nordamericani,
attenzione focalizzata su problematiche specifiche:
aspetti parziali della gestione (es. SBU)
fenomeni aggregativi (gruppi aziendali, reti di imprese)
momenti di discontinuit (operazioni straordinarie)
rendicontazione sociale e ambientale
p
commerciali,, industriali,, banche,,
settori di attivit ((imprese
aziende non-profit, pubbliche amministrazioni, etc.)
funzioni aziendali (finanza, marketing, controllo, strategia, sistemi
informativi, etc.)
patrimonio intangibile
misurazione delle performance
etc.
56
28
02/10/2014
LEconomia Aziendale come scienza in evoluzione
Le evoluzioni rapidamente tratteggiate non segnano il tramonto
del pensiero zappiano, bens confermano la natura evolutiva
dallo stesso Zappa ripetutamente ribadita della scienza
economico-aziendale, che tende a modificare nel tempo i propri
paradigmi
Ogni scienza si sviluppa per salti ed equilibri provvisori. Per
lEconomia Aziendale, levoluzione proficua se sempre
ancorata
t all riferimento
if i
t empirico
ii
(
(concrete
t caratteristiche
tt i ti h del
d l
fenomeno aziendale)
Nessuna successiva evoluzione ha comunque scardinato la
lettura sistemica e in chiave economica del fenomeno aziendale
57
LEconomia Aziendale e le altre scienze economiche
LEconomia Aziendale studia lazienda dallinterno, si interessa di
fatti e fenomeni concreti letti in funzione dei loro riflessi sulle
prospettive
p
p
di durevole esistenza,, inquadrando
q
in tale chiave di
lettura anche losservazione dei fenomeni esterni. Mentre:
La Macroeconomia studia i comportamenti collettivi e i loro effetti
aggregati a livello nazionale o sovranazionale: cicli economici,
domanda aggregata, offerta aggregata, prezzi, inflazione, prodotto e
reddito nazionale, fattori di crescita e sviluppo di un paese, etc.
La Microeconomia studia scelte e comportamenti delle singole unit
La
economiche guardate dallesterno, nei riflessi sul sistema economico
generale
LEconomia Industriale studia lorganizzazione produttiva dei settori,
le politiche delle imprese che ne fanno parte e la struttura e il
funzionamento dei relativi mercati
58
29
Potrebbero piacerti anche
- Mercati Finanziari: Scopri Tutti i Segreti del Mercato. La guida Completa per Capire la Finanza, Sviluppare la tua Economia e Puntare ai Giusti Investimenti.Da EverandMercati Finanziari: Scopri Tutti i Segreti del Mercato. La guida Completa per Capire la Finanza, Sviluppare la tua Economia e Puntare ai Giusti Investimenti.Nessuna valutazione finora
- Capitolo 1Documento49 pagineCapitolo 1Farell ZambouNessuna valutazione finora
- Economia aziendale e Ragioneria per concorsi pubblici e esami universitari: L'azienda, la contabilità, l'organizzazione e la gestione aziendaleDa EverandEconomia aziendale e Ragioneria per concorsi pubblici e esami universitari: L'azienda, la contabilità, l'organizzazione e la gestione aziendaleNessuna valutazione finora
- BILANCI AZIENDALI RiassuntiDocumento34 pagineBILANCI AZIENDALI Riassuntisaragurpotti14Nessuna valutazione finora
- Economia Aziendale - Teoria (formato breve)Da EverandEconomia Aziendale - Teoria (formato breve)Valutazione: 5 su 5 stelle5/5 (1)
- Economia AziendaleDocumento120 pagineEconomia AziendalesienaccediNessuna valutazione finora
- 1.1 - Limpresa e Il Suo FunzionamentoDocumento66 pagine1.1 - Limpresa e Il Suo FunzionamentoAli Raza CheemaNessuna valutazione finora
- Lez 3 EA NardoDocumento29 pagineLez 3 EA NardoSonia RivaNessuna valutazione finora
- 2) RiassuntoDocumento64 pagine2) Riassuntofrancepila06Nessuna valutazione finora
- Appunti Economia AziendaleDocumento22 pagineAppunti Economia AziendalemattiaNessuna valutazione finora
- Economia Aziendale A. MontroneDocumento8 pagineEconomia Aziendale A. MontroneNicoletta Alexandru100% (1)
- Domande Svolte Esame Di Economia AziendaleDocumento18 pagineDomande Svolte Esame Di Economia AziendaleCarrie1989bq100% (1)
- Riassunto Economia AziendaleDocumento7 pagineRiassunto Economia AziendaleNavigata ChicNessuna valutazione finora
- Appunti EconomiaaziendaleDocumento46 pagineAppunti EconomiaaziendaleNiya IvanovaNessuna valutazione finora
- Slide Sulle Forme GiuridicheDocumento14 pagineSlide Sulle Forme GiuridicheGianluca ParadisoNessuna valutazione finora
- 1 L'aziendaDocumento29 pagine1 L'aziendaCarmen EnacheNessuna valutazione finora
- Economia AziendaleDocumento55 pagineEconomia AziendaleFelice Sinibaldi100% (1)
- Riassunto Economia e Gestione 122Documento120 pagineRiassunto Economia e Gestione 122gNessuna valutazione finora
- Lettura e Analisi Di BilancioDocumento52 pagineLettura e Analisi Di BilancioAlexia DeLargeNessuna valutazione finora
- Economia Sociale e Il Sistema FinanziarioDocumento15 pagineEconomia Sociale e Il Sistema FinanziarioGiulia MoriNessuna valutazione finora
- Fondamenti Di ManagementDocumento89 pagineFondamenti Di ManagementFederico FontanaNessuna valutazione finora
- Corso Di Economia Aziendale Di AiroldiDocumento32 pagineCorso Di Economia Aziendale Di AiroldidavideNessuna valutazione finora
- Capitolo 1 Di Economia AziendaleDocumento22 pagineCapitolo 1 Di Economia Aziendaleariannaserena01Nessuna valutazione finora
- RAGIONERIADocumento44 pagineRAGIONERIAsomma.giugiNessuna valutazione finora
- Adriano PropersiDocumento90 pagineAdriano PropersicronosNessuna valutazione finora
- Lezioni Di Economia-1Documento66 pagineLezioni Di Economia-19rzcjjmgbhNessuna valutazione finora
- Lineamenti Di Economia AziendaleDocumento66 pagineLineamenti Di Economia AziendaleMiriamR.ViliaCuscitoNessuna valutazione finora
- Capitolo 1Documento14 pagineCapitolo 1Lorena BiniNessuna valutazione finora
- Domande Di Economia AziendaleDocumento15 pagineDomande Di Economia AziendaleClaudio De MartinoNessuna valutazione finora
- 7 2022 Aziende Consumo ErogazioneDocumento32 pagine7 2022 Aziende Consumo ErogazioneClaudia MacrìNessuna valutazione finora
- Appunti Economia AziendaleDocumento48 pagineAppunti Economia AziendaleAntonio Russo50% (2)
- Economia Aziendale 2021Documento24 pagineEconomia Aziendale 2021Daniela VivonaNessuna valutazione finora
- Economia e Gestione 100 PagineDocumento101 pagineEconomia e Gestione 100 PaginegNessuna valutazione finora
- Diritto Commerciale 1 ParteDocumento144 pagineDiritto Commerciale 1 Partealiceram2000Nessuna valutazione finora
- Slide 2 Mod Di Impresa B (Comprende Diritto)Documento5 pagineSlide 2 Mod Di Impresa B (Comprende Diritto)MetalFingerzNessuna valutazione finora
- AZIENDADocumento2 pagineAZIENDALeda HoxhaNessuna valutazione finora
- Riassunto Economia Aziendale Di Fabbrini e MontroneDocumento46 pagineRiassunto Economia Aziendale Di Fabbrini e MontronePifu100% (1)
- Slide Lezioni Corporate GovernanceDocumento46 pagineSlide Lezioni Corporate GovernancesaraNessuna valutazione finora
- Dispensa Riassunto ECONOMIA AZIENDALE Saita (Completo) Libro Vecchia EdizioneDocumento22 pagineDispensa Riassunto ECONOMIA AZIENDALE Saita (Completo) Libro Vecchia EdizionePierpaolo Beretta100% (2)
- Classificazione Delle Imprese e Definizione Di SocietàDocumento7 pagineClassificazione Delle Imprese e Definizione Di SocietàLalla SannaNessuna valutazione finora
- Economia Domande Per EsameDocumento57 pagineEconomia Domande Per EsameAlice lamorteNessuna valutazione finora
- Riassunto Sciarelli La Gestione Dell Impresa Tra Teoria e Pratica Aziendale Parte 1Documento45 pagineRiassunto Sciarelli La Gestione Dell Impresa Tra Teoria e Pratica Aziendale Parte 1Danila MancinoNessuna valutazione finora
- Appunti Economia Aziendale by Giacomo GargiuloDocumento24 pagineAppunti Economia Aziendale by Giacomo GargiuloJessica AndreozziNessuna valutazione finora
- Egi Appunti Presi in ClasseDocumento57 pagineEgi Appunti Presi in Classepoiata.a03Nessuna valutazione finora
- Societa Ss SNC SasDocumento21 pagineSocieta Ss SNC SasFedericoNessuna valutazione finora
- Lezioni Di Economia AziendaleDocumento81 pagineLezioni Di Economia AziendaleDalila SartorNessuna valutazione finora
- ImpresaDocumento6 pagineImpresaHessam Sepasi TehraniNessuna valutazione finora
- Economia AziendaleDocumento87 pagineEconomia AziendalesaraNessuna valutazione finora
- Definizione Di AziendaDocumento61 pagineDefinizione Di AziendaPasquale GiaccoNessuna valutazione finora
- Slides PrimaparteDocumento63 pagineSlides Primapartericca.mattia99Nessuna valutazione finora
- Economia e Gestione Parte 1-6Documento22 pagineEconomia e Gestione Parte 1-6pollohjNessuna valutazione finora
- Diritto Commerciale Le SocietàDocumento94 pagineDiritto Commerciale Le Societàalteriuris100% (3)
- Elementi Di Management AziendaleDocumento61 pagineElementi Di Management AziendalegelsominapecchiaNessuna valutazione finora
- RagioneriaDocumento30 pagineRagioneriaChiara FanizziNessuna valutazione finora
- Appunti Di Economia AziendaleDocumento16 pagineAppunti Di Economia Aziendalestefano.cavo2001Nessuna valutazione finora
- AZIENDA - Diritto CommercialeDocumento25 pagineAZIENDA - Diritto CommercialeMatta MeneghettiNessuna valutazione finora
- La Gestione Dell'impresaDocumento99 pagineLa Gestione Dell'impresaludogio02Nessuna valutazione finora
- Campobasso Diritto Delle SocietÃDocumento151 pagineCampobasso Diritto Delle SocietÃGiacomino MeladàNessuna valutazione finora
- La Danza Come Agire Professionale, Corporeo e ArtisticoDocumento605 pagineLa Danza Come Agire Professionale, Corporeo e ArtisticoRoxinaNessuna valutazione finora
- ProntoFido - Cani Smarriti, Ritrovati e Da AdottareDocumento3 pagineProntoFido - Cani Smarriti, Ritrovati e Da AdottareStill RageNessuna valutazione finora
- CV L. GirardiDocumento9 pagineCV L. GirardiSalvatore GalloNessuna valutazione finora
- Parole D'onore Teatro - Le Voci Della MafiaDocumento10 pagineParole D'onore Teatro - Le Voci Della MafiaArteNessuna valutazione finora
- Heede Le ApparizioniDocumento4 pagineHeede Le Apparizionigiordana214Nessuna valutazione finora
- Leggere e Analizzare Il Bilancio Di EsercizioDocumento16 pagineLeggere e Analizzare Il Bilancio Di Eserciziometal760% (2)
- La Redazione Della Tesi Di LaureaDocumento3 pagineLa Redazione Della Tesi Di LaureazlrvkamlNessuna valutazione finora
- Contro Il Metodo Feyerabend SpiegazioneDocumento6 pagineContro Il Metodo Feyerabend SpiegazioneAnita AlecciNessuna valutazione finora
- Enneagramma, Famiglia e 5 Leggi BiologicheDocumento12 pagineEnneagramma, Famiglia e 5 Leggi BiologichefifiNessuna valutazione finora