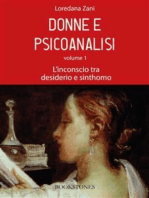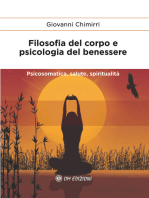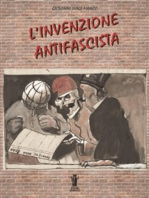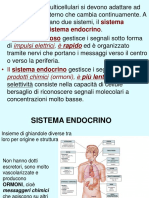Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
045 Seminario 2011 01
Caricato da
nuoveprospettiveTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
045 Seminario 2011 01
Caricato da
nuoveprospettiveCopyright:
Formati disponibili
- 1 -
n
.
1
,
2
0
1
1
- 2 -
IN RICORDO DEL MERCOLED 18 GENNAIO 1978.
IL MESSAGGIO DI ERICH FROMM*
Boris Luban Plozza
Conobbi Erich Fromm nel 1970, quando aveva ancora una residenza
in Messico, a Cuernavaca. Tre anni dopo si stabil denitivamente a Muralto,
in Svizzera. La pergamena per la sua nomina di cittadino onorario recitava:
Scrut con amore i misteri delluomo percorrendo le vie del mondo. Scelse
e da qui irradi scienza e saggezza. Avevo il privilegio di incontrarlo alme-
no una volta la settimana: divenni suo allievo e - se oso dire - amico. Queste
note sono un tentativo di rievocare latmosfera in cui lavorava Erich Fromm
mentre gestiva Avere o Essere. Da anni ormai Fromm era considerato,
accanto a Sigmund Freud e a Carl Gustav Jung, uno dei pi importanti psi-
canalisti del nostro secolo.
Erich Fromm era nato nel 1900. Compiuti gli studi a Francoforte sul
Meno, sua citt natale, a Heidelberg, Monaco e Berlino, a 22 anni aveva gi
conseguito il dottorato a Heidelberg. Come membro della celebre Scuola
di Francoforte, fu costretto a emigrare per motivi razziali e, dopo un sog-
giorno di cura a Davos, nel 1934 si trasfer a Nuova York. Qui la sua fama si
estese rapidamente e ben presto il suo nome fu conosciuto anche fuori dei
conni degli Stati Uniti. Nel 1935, senza peraltro abbandonare la profes-
sione attiva di analista, Erich Fromm cominci a tenere lezioni in svariate
Universit, non esclusa quella assai rinomata di Yale. Nel 1940 ottenne la
cittadinanza americana. Nel Messico, a Cuernavaca, fond lIstituto di Psi-
coanalisi.
Ma ecco come Fromm stesso motiva questa sua scelta: I motivi per
cui il problema del movente delle azioni umane ha acquistato per me un
interesse cos dominante si potrebbero cercare nel fatto che sono glio uni-
co, con un padre ansioso e di carattere difcile e una madre con tendenza
depressive. Avevo quindi stimoli sufcienti per rivolgere il mio interesse alle
ragioni insolite e misteriose delle reazioni delluomo. Nel corso degli ultimi
cinquantanni, Erich Fromm scrisse almeno 20 libri e un centinaio di saggi,
la maggior parte dei quali ormai conosciuta in tutto il mondo. Dei suoi
libri sono state vendute, soltanto negli Stati Uniti, pi di 6 milioni di copie.
Molti di essi sono stati adottati come libri di testo in numerosi istituti e scuo-
le superiori.
Anche lesposizione scientica del pensiero di Fromm ha raggiunto
livelli di cui ben pochi altri studiosi viventi possono vantarsi. Cos, gi nel
1972 si contavano circa 30 lavori che si riferivano a Fromm e fra questi tutta
una serie era stata redatta da teologi cattolici. Erich Fromm infonde nelle
sue opere scientiche una qualit diventata sempre pi rara. Mentre quasi
tutti gli scienziati si concentrano su di ununica disciplina di cui possono
proclamarsi specialisti, Fromm tenta di ottenere una visione dinsieme che
comprenda i risultati conseguiti nei pi diversi rami dello scibile. Per questo
tiene conto, nelle sue indagini, dei sintomi di patologie analizzabili in sede
scientica, delle strutture sociali e delle decisioni di carattere politico.
- 3 -
Mi sono interessato di politica - scrive - sin da quando avevo undici
o dodici anni: ne parlavo allora con un socialista che lavorava nella ditta di
mio padre, ma mi sono anche reso conto che, per temperamento, non ero
adatto alla politica attiva. Il bene integrale delluomo il motivo che lo
spinge a intervenire con gli scritti e con tutto il peso della sua personalit
per assicurare la pace a questo nostro pianeta nellera atomica. Sigmund
Freud scriveva nel 1893: Come mai (in medicina) gli uomini vedono sem-
pre e soltanto ci che hanno, a suo tempo, imparato a vedere? E come me-
raviglioso il fatto che si possano tutto a un tratto vedere come nuove (come
stati patologici nuovi) cose che probabilmente sono vecchie quanto luma-
nit. Goethe dice addirittura che luomo vede soltanto ci che conosce.
Per Fromm il problema fondamentale, quello di vedere luomo, di vedere
laltro uomo che accanto a noi, ma soprattutto di conoscere luomo che
in noi. La struttura del suo lavoro multidisciplinare risulta, ci sembra, preci-
samente dal tentativo di sistematizzare la vita utilizzando anche i presuppo-
sti del pensiero orientale, che conosceva perfettamente. Nella sua ricerca,
Fromm elabora i concetti con cui motivare e sorreggere lazione.
In ultima analisi, si tratta di far maturare nelluomo - non pi mezzo
ma ne - la facolt di scegliere, la capacit e la volont di essere protagonista
della propria vita, cio di liberarlo.
Occorre rendere conscio linconscio, disse Fromm ad Ascona nel 1977
alla prolusione del 5 Incontro Balint: cio sostituire ovunque sia possibile,
lirrazionale con la consapevolezza. Il punto chiave, per Fromm, che una
parte fondamentale della nostra personalit - precisamente il carattere - non
immutabile ma pu cambiare in due tempi, attraverso la cosiddetta opera-
zione liberante. In primo luogo, dobbiamo arricchire la nostra conoscenza
del mondo esterno se vogliamo impostare la nostra vita in modo consapevo-
le, maturo e dinamico. In secondo luogo, sforziamoci sempre di scoprire in
noi gli impulsi inconsci, le motivazioni profonde del nostro agire, che ten-
diamo a razionalizzare (cio a mascherare). In una parola, tentiamo sempre
di portare a livello di coscienza quanto possiamo del nostro subconscio. In
questo sforzo di penetrazione del mondo esterno e del nostro ego profondo
sta il tentativo di pervenire alla consapevolezza della realt. Per me e per
tutti coloro che lhanno visto anche solo pochi istanti, Fromm emanava
qualcosa di particolare. Forse era la sua radice culturale, quel suo saper di-
scutere, con il losofo di losoa, con il sociologo di sociologia, con il teolo-
go - soprattutto, direi - di teologia. Non dimentichiamo che il Professor Auer
della Facolt di Teologia a Tubingen al Simposio organizzato a Locamo per
i 75 anni di Fromm, aveva dichiarato: Fromm, non cattolico, il miglior co-
noscitore vivente del cattolicesimo. Certo era un uomo controverso, un mi-
noritario per vocazione (soprattutto dal prolo politico). Il mondo, tuttavia,
lo conosceva soprattutto come maestro della psicanalisi. Quando si ammal
nel settembre 1977, stava lavorando molto intensamente a un nuovo libro,
molto critico, sulla psicanalisi. Si deniva semplicemente studioso di carat-
terologia. Ma la sua spinta primaria era molto umana, semplice. Quando
si parlava con lui, si aveva limpressione che volesse soprattutto far luce sulla
malattia principale delluomo, che lo spinge a privarsi della libert. Quella
malattia che ha descritto, ma sempre con accento di speranza, nel suo libro
Fuga dalla libert.
- 4 -
La libert, in questo contesto, basata sulla coscienza delle reali possi-
bilit e delle loro conseguenze, in contrasto con la credenza nelle possibilit
false o irreali, che sono un narcotico e distruggono il nostro potenziale di
libert. Bisogna diventare uomini liberi, liberi non solo dalle catene, ma di
fare dello sviluppo di tutte le potenzialit lautentico scopo della propria
vita: uomini che trovano il senso dellesistenza nello sforzo produttivo. Luo-
mo non ha un innato spirito di progresso, ma spinto dalla necessit di
risolvere la sua contraddizione esistenziale, che risorge ad ogni nuovo livello
di sviluppo. Questa contraddizione - o meglio le possibilit diverse e con-
traddittorie delluomo - costituisce la sua essenza.
I gusti delluomo vengono manipolati. Il carattere di homo consu-
mens, nelle sue forme pi estreme, un ben noto fenomeno psicopatologi-
co. Esso si riscontra in molti casi di persone depresse o ansiose che si rifugia-
no nel mangiar troppo, nel comprare in quantit eccessiva, o nellalcolismo
per compensare la depressione o lansiet nascoste. Lavidit consumistica
(forma estrema di ci che Freud chiamava il carattere orale-ricettivo!) sta
diventando la forza psichica dominante dellattuale societ industrializzata.
Lhomo consumens vive nellillusione della felicit, mentre inconsciamente
egli soffre della sua noia e della sua passivit. Pi potere egli ha sulle macchi-
ne, pi impotente diventa come essere umano; pi egli consuma, pi diven-
ta schiavo dei bisogni costantemente in aumento che il sistema industriale
crea e manipola. Egli scambia emozioni ed eccitazioni per gioia e felicit, e
la comodit materiale per vitalit, lavidit soddisfatta diventa il signicato
della vita, la lotta per raggiungerla una nuova religione. La libert di con-
sumare sta diventando lessenza della libert umana. Troppa libert sembra
per anche inibente, perch non si ha neanche pi il gusto di poter fare
cose proibite. Luomo non si libera se non si responsabilizza.
A Fromm, dente riformatore, le imperfezioni e deformazioni della
natura umana appaiono conseguenze deprecabili, ma non incurabili della
civilt. Non nelluomo, ma nella societ, in specie quella contemporanea,
la fonte del male e dellirrazionalit: di qui ha origine il conitto tra
loriginariamente sana natura delluomo e la societ malata (un modello
di societ sana era gi stato da Fromm delineato e discusso appunto in
The Sane Society, New York: 1955). La crisi dellimmagine della famiglia
come norma di realt ha aperto la porta allo studio critico della societ, che
ha trovato nel socratico Erich Fromm il suo esponente pi signicativo.
Amare, oltre uomo e libert, la grande parola, la terza grande parola
dellinsegnamento di Fromm. Egli ha teorizzato lamore in quel famosis-
simo libretto, tradotto praticamente in tutte le lingue (oltre 12 milioni di
copie) Larte di amare. Come dire che amore non qualcosa di gratuito,
ma soprattutto ricerca, conquista, conclusione di un processo nel quale ci
sentiamo coinvolti. Arrivare ad amare pienamente signica essere diventati
nalmente maturi, veri, attivi, completi e forse anche pi sani, o forse guari-
ti. Curare signica rimuovere gli ostacoli che impediscono agli impulsi verso
lamore di essere efcaci; ma non distinguendo - sottolinea Fromm - troppo
il malato dal sano, riabilitando soprattutto il nevrotico, o almeno quello che
noi chiamiamo il nevrotico, umanamente spesso meno inibito di quanti si
considerano normali e che noi chiamiamo sani. Il nevrotico non disposto
ad arrendersi nella battaglia per la difesa del proprio io, forse un io anche
- 5 -
un po sbagliato. E il prodotto soprattutto di un mondo diventato sempre
pi insicuro. Eppure il nevrotico, forse pi dei normali continua a battersi,
pi degli altri riuta la fuga dalla libert. La psicoanalisi, si rallegra Fromm,
sta nalmente per ammalarsi ed un bene. Il suo futuro che torni a
diventare una teoria critica e criticata che aiuti non solo luomo cosiddetto
malato, ma anche luomo sano in una societ malata; che additi come quelli
delluomo i conitti del sistema, la patologia della Societ. Tornando cri-
tica la psicanalisi rischia di diventare di nuovo impopolare e quindi minori-
taria e combattuta. Proprio questo potrebbe essere il segno che ci troviamo
sulla strada giusta.
Il penultimo libro di Fromm tratta dellaggressivit. Luomo desidera
lasciare una traccia, produrre un effetto. Perno il bambino, senza nessuna
effettiva presa di coscienza, fa di tutto per farsi notare, grida, sporca, inventa
inesplicabili bizze pur di lasciare appunto una traccia di s soprattutto in
coloro che gli sono vicini e che gli vogliono bene.
*Intervento al Saluto inaugurale del Simposio Internazionale Nuovi orientamenti della
psichiatria e della psicoanalisi organizzato dalla International Foundation E. Fromm
(Presidente: B. Luban Plozza) al Centro Congressi, Montecatini Terme, 7-9 Ottobre, 1988.
N.B. - Riproponiamo questo articolo che mi diede B. Luban-Plozza, gi allievo di M. Balint
e di E. Fromm, nellanno 1989. Collaboratore Scientico della nostra Rivista stato mae-
stro ed amico del Dott. Fausto Agresta. E scomparso nel 2003, ad Ascona.
Psichiatra, Professore ad Honorem Universit di Heidelberge di altre Universit. Reparto
di Psicosomatica - Clinica S. Croce Orsolina (Locarno). Collaboratore Scientico della Ri-
vista N. Prospettive in Psicologia.
Indirizzo dellAutore: Prof. Boris Luban Plozza M. D.
P.zza Pedrazzini
CH - 6600 LOCARNO (Svizzera)
- 6 -
TOSSICODIPENDENZA*
(da: Il linguaggio del corpo in psicoterapia)
Fausto Agresta
1. Introduzione. Il problema della tossicodipendenza ha come obiet-
tivo quello di enucleare vari aspetti di una visione sistemica, psicodinamica
e complessa: gli stati di tossicodipendenza vengono inquadrati negli aspetti
intrapsichici, simbolici e relazionali. Si presuppone che ogni fenomeno sia
un evento che acquista signicato allinterno di un sistema di riferimento
globale, che a sua volta va a costituire il senso dellevento stesso: questa
la visione olistica (Lorenz K., 1991; Prigogine I., 1981). Daltra parte, se le
tossicomanie pongono il problema dei rapporti fra psiche, soma e dipendenza
(Gilliron E., 1991) devono inoltre essere considerati, nelle loro inuenze
reciproche, il piano delle interazioni sociali, di quelle intrapsichiche (Berge-
ret J., 1983; Meltzer D., 1983) e interpersonali - familiari (Cancrini L., 1991;
Cirillo S., 1999), nonch quelle simboliche e dei miti che informano una
data cultura (Filippini R., 1990, 1991, 1992). Come nelle gravi patologie,
il paziente tossicomane deve essere inquadrato nel suo contesto familiare,
dove egli vive un nucleo simbiotico che ci riporta alla situazione fetale
e dove lorganizzazione dei bisogni primari molto semplice e si esplica
solo allesterno e la situazione tossicomanica si presenta come un blocco
di crescita o - come scrive R. Morelli - come una nascita mai avvenuta
(1985). Esamineremo, schematicamente e separatamente (solo per una
questione didattica), laspetto intrapsichico e laspetto familiare e gruppale.
La tossicodipendenza grave inserita nellarea delle perversioni, come per lanoressia e
la bulimia. Il paziente tossicomane, come un lattante dipendente totalmente
dalla madre, ha paura di stare da solo con s stesso, se non in una maniera
trasgressiva. Molti Autori sono dellavviso che la tossicomania sia legata al-
leccitazione psichica, al piacere delleccitazione e questo status psichico
rintracciabile allinizio dellattivit di fantasmatizzazione del lattante e del
bambino poi - capacit questa strettamente legata alla dipendenza (amo-
re - odio) dalla madre e poi dagli altri membri della famiglia, che interagi-
scono secondo le dinamiche consce e inconsce come avviene in un gruppo,
in stretto rapporto con la organizzazione psichica dei personaggi (legame e
ruolo dei genitori e dei nonni sia a livello reale che fantasmatico e simbo-
lico). Dagli studi pi recenti e dai risultati delle nostre esperienze cliniche
con centinaia di soggetti nel corso di 25 anni di attivit varia e molteplice
(psicoterapie con una gamma di pazienti che vanno dai bambini agli adulti,
dalle coppie alle famiglie, no ai gruppi), possiamo con sicurezza affermare
che lorganizzazione psichica della personalit si costruisce nei primi anni di
vita; limprinting, con i primi movimenti e le prime costruzioni della mente,
li ritroviamo nelle patologie gravi, in quelle che si estendono dallarea bor-
derline a quella narcisistica, dalle pre
psicosi, alle varie forme di perver-
sioni, no alle psicopatie e alle psicosi schizofreniche. Al di l di presunte e
poco dimostrate ipotesi genetiche - laspetto comunicazionale e simbolico,
quello relazione e il mondo intrapsichico dei genitori e dei nonni, senza
trascurare i condizionamenti contestuali, religiosi, culturali - tutto concorre
- 7 -
a costruire una personalit che, nel tempo, ripropone alcuni schemi nei
rapporti, prima con la famiglia e, poi, con gli altri personaggi, pi o meno
importanti (insegnanti, professori, amici, sacerdoti, autorit varie). Nel
caso del tossicodipendente possiamo sostenere che il legame con la gura
materna di tipo piacere relazionale e dipendenza ed caratterizzata da
una forma stilizzata di anticipare le risposte alle richieste del bambino.
Scrivevo nel 1997: In questo caso la madre interviene anticipando sempre
il bisogno di fame del bambino (bisogno legato al piacere delleccitazio-
ne) (Agresta F., 1997). E. Gilliron, nei suoi studi sui legami precoci, del
parere che il fatto di dare il seno al bambino diminuisce leccitazione e se
ci permette di condividere un piacere, il processo di mentalizzazione, in
questo caso, non esiste pi. Il fatto di ritrovarsi in un rapporto condiviso e
agito (contemporaneamente) ha leffetto di diminuire questa situazione,
cio leccitazione che provoca la mentalizzazione. Lideale, nei rapporti ma-
dre bambino, dovrebbe specicarsi secondo questo schema (Fig. 1), dove
lintervento della madre dovrebbe avvenire dopo un certo tempo (Gilliron
E., cit. in Agresta F., 1997, pag. 265). Quando la madre arriva sempre in anticipo
non favorisce lesperienza dellattesa del bambino, nella misura in cui lei che rispon-
de al bisogno nascente del suo bambino, il quale ha bisogno di uno spazio e di un
tempo necessari ad esprimere le proprie necessit con giusta intensit e nel rispetto del
proprio tempo. Vediamo i tre schemi:
IL BAMBINO CHIAMA. LA MADRE ARRIVA:
Fig. 1 - Agresta F. (1997): Malattie Psicosomatiche e Psicoterapia Analitica; II ediz. 2004.
Se per costruire il fantasma c bisogno di: a. una immagine della
madre e b. dellarrivo della madre reale, di conseguenza avremo delle dif-
colt nei due casi estremi, cio quello del ritardo e quello dellanticipazione.
Abbiamo accennato al problema della anticipazione. Se la madre arriva sem-
pre in ritardo il bisogno si trasforma in dolore: infatti, essendo il bambino
esausto, snito nellattesa, ormai non piange pi. Il piacere, che la base
pulsionale eccitante dellattesa della venuta della madre, tende ad abbassa-
re la sua soglia normale di attesa (il piacere del desiderio attesa) da un
punto pi alto a uno pi basso in picchiata e pian piano, ci che era pia-
cere si trasforma in dolore (attesa dolorosa perch la madre non arriva!).
In questo modo il bimbo imparer a non erotizzare la relazione o il piacere
di mangiare (Gilliron E., 1991, pag. 22). Questo cortocircuito non permet-
te lesperienza dello sviluppo dellimmaginario in maniera semplice ed equi-
librata, come quando il bambino costruisce il fantasma dellarrivo della
madre nellesperienza del piacere dellattesa. Oppure, quando il bisogno
viene negato (il cibo e le cure di manipolazione, di pulizia, di carezze che
arrivano sempre in ritardo, o la soddisfazione dei bisogni sempre rinviati), la
- 8 -
stessa attesa si trasformer in dolore e il bambino non vivr, in quel momen-
to, una esperienza piacevole, vivr una disconferma alle sue aspettative e
tender a negare sempre pi lo sviluppo dellimmaginario. A questo riguar-
do, in entrambi i casi, c una tendenza alla alessitimia: sia nel paziente tossi-
comane, sia come abbiamo visto nel paziente psicosomatico. Per esem-
pio, abbiamo riscontrato che diverse madri molto egocentriche non riesco-
no a decodicare e a comprendere i reali bisogni dei loro bambini: il loro
comportamento superciale o di tipo abbandonico. Dal lato opposto, pos-
sono essere molto iperprotettive o molto rigide o confuse: da queste situa-
zioni si svilupperanno altre patologie nelle relazioni precoci madre-bambi-
no, gi inserite, peraltro, nel triangolo pre edipico: madre bambino pa-
dre. Nelle madri egocentriche abbiamo notato che esse sono attente soltanto
alla loro persona e, di solito, il loro punto di vista sempre unilaterale. Altre
madri, pur se sono dedite ai bisogni dei bambini, si esprimono con rigidit,
con un pensiero ossessivo, con mancanza di espressione di emozioni; queste
sono legate stereotipicamente al solo rispetto delle regole e dei doveri e
sono incapaci di manifestare le proprie emozioni e affetti. Possiamo immagi-
nare che la madre la droga e leroina del bambino, senzaltro insostitui-
bile a quellet. Forse, non solo per questo, questa madre e quel padre
continuano a drogare il loro glio, ovvero insistono nel non dare nessun
vero attaccamento, di cui parla Bowlby, nel corso degli anni. Nella dinami-
ca del bisogno e piacere nella tossicodipendenza avviene il contrario del-
lanoressia: c la separazione tra piacere e bisogno e il tossicodipendente fa
come se il bisogno non esistesse; la conittualit basata solo sul piacere. Il
piacere ricercato e la conittualit tra il tossicodipendente e gli altri si basa
sulleccitazione, sul piacere. La madre del tossico si occupata del bambino
solo eccitandolo, mentre il rapporto di protezione, di bisogno, non ha fun-
zionato. C un rapporto di tipo erotico, ma non c protezione, c solo un
rapporto di tipo perverso nella relazione madre bambino. Il tossicomane
gioca con la droga, manipola una sostanza che eccita. Se il bulimico, come
vedremo, gioca e manipola il cibo, cio qualcosa legato al bisogno, laltro
manipola qualcosa legato al piacere, come letilista. Dunque il tossicomane
sempre al limite, gioca con tutto. Ma non un gioco normale, un gioco
auto distruttivo, nel senso che lui deve essere sempre vicino alla morte. La
droga mette in crisi il rapporto con gli altri, nega limportanza degli altri e
mette in evidenza il problema sociale e la rende ridicola. E una ideologia
basata sul piacere in s, non basata sullidea del rapporto con gli altri. In-
fatti un piacere di tipo narcisista, la negazione del rapporto degli altri:
ma questo tipo di atteggiamento conduce alla morte e lui accetta: un po
come lanoressica grave. Il tossicodipendente usa la droga contro la famiglia.
La famiglia immaginaria non esiste, negata, quindi anche quella reale. Egli
non riuscito ad aver questo legame. Paradossalmente egli dipendente,
spesso negandolo alla propria famiglia. Per questo aspetto, J. Bergeret
(1983) precisa che il comportamento di dipendenza si esplicita nellincapa-
cit di integrare certi aspetti ambivalenti e troppo angoscianti dellimmagi-
nario personale e degli elementi pulsionali che vi sono legati, particolar-
mente nel campo della violenza primitiva. Al contrario la violenza, cos
come allinizio della vita, deve in seguito globalmente integrarsi in un ca-
nale di elaborazione libidica che struttura la vita affettiva nella relazione
- 9 -
diadica madre bambino. A questo punto il legame di interdipendenza
sano e reciproco pian piano fallisce, mentre contemporaneamente si assiste
ad un rinforzo di tutto ci che riguarda leccitazione e il piacere soggettivo
individuale; si tratta di una situazione ben diversa da quella di un piacere
condiviso, come quello che si sperimenta nella buona relazione madre bambi-
no, il facilitating environment di Winnicott D. (1951). Egli ha delineato, nei
suoi studi, anche i concetti di holding e handling, che esprimono il tenere in
braccio, il sostegno in chiave psicologica e il tenere in braccio a livello -
sico, corporeo, come esperienza del toccare. Secondo le ultime ricerche di
V. Ruggieri, la mancanza di queste esperienze nel primissimo periodo di vita
portano anche a delle modicazioni nellesecuzione dei comportamenti
istintivi come quello oro alimentare e sessuale: in particolare, nel primo
caso si hanno patologie da carenze di stop che dipendono proprio da una
mancanza di buone informazioni dalla periferia corporea (la cute) e quindi
dal contatto interpersonale madre bambino. Se scomponiamo gli elemen-
ti di questa relazione troviamo che, oltre allo sguardo, hanno un ruolo im-
portante informazioni tattili, di calore, di carezza, lesperienza integrata e
gestaltica dellabbraccio, il dondolamento del cullare e, soprattutto, per il
bambino, il potersi appoggiare. La madre rappresenta il sostegno solido e
caldo che consente al bambino di ridurre o di abolire del tutto, in risposta a
tali segnali tattili e tonico muscolari integrati, la tensione muscolare []
Noi riteniamo che le componenti relazionali del comportamento afliativo
siano un importante segnale di stop [] Per cui anche le informazioni della
vita di relazione (cute e muscoli) acquistano signicato di stop. E tra i segna-
li della vita di relazione non dimentichiamo lo sguardo, la voce, le parole
con i loro contenuti semantici, ed il sorriso (Ruggieri V., 2000). Il fallimen-
to di questi aspetti di evoluzione positiva e di integrazione a pi strati da
ascriversi a livelli di soggettivit preposta alla personalit della madre prima,
e a quella del padre, dopo. E la madre che non riuscita a risolvere il pro-
blema della propria separazione dal bambino, cos come non riuscita ad
elaborare lesperienza di amore e odio che tale problema risveglia in lei. E
la madre che non riuscita a separarsi dalla propria madre, dai livelli di
vissuti emozionali a livello profondo e inconscio e dai legami intergenerazio-
nali. Abbiamo avuto diversi casi che hanno confermato questo tipo di lega-
me, specialmente negli adolescenti con struttura borderline. Essi non hanno
sperimentato limportante fase della separazione individuazione secondo i
canoni ormai accreditati. In situazioni gravi abbiamo a che fare con soggetti
con una struttura di tipo perverso, spesso pre edipica, legata a fantasie ora-
li e sadico anali. Quando entra la droga entra unaltra madre, ben pi
pericolosa e molto pi distruttiva. La droga, come messaggio sintomatico,
spesso ha per scopo (espresso in maniera non immaginabile, dunque nem-
meno inconscio, ma puramente comportamentale), di rompere le relazioni
con laltro, intrattenendo uno stato di eccitazione simile allunico tipo di le-
game che unisce il tossicomane alla madre. Come psicoterapeuta, mi preme
sottolineare che gli operatori spesso si lasciano coinvolgere dalla situazione
sintomatica della tossicodipendenza nella sua drammaticit e nella sua vio-
lenza: cio essa viene considerata e interpretata solo dal punto di vista del
comportamento manifesto, mentre le basi latenti delle manifestazioni este-
riori della dipendenza sono messe in secondo ordine. Da un punto di vista
- 10 -
sociale il tossicodipendente uno strumento nelle mani della societ; egli
preso nel tranello, come lo stato nella sua famiglia. Si crede onnipotente
perch lui capace di affrontare la morte; sembra proprio cos facile essere
contro la societ: come se fosse vincente. Anzi, lo , perch accetta di mo-
rire, pi forte degli altri. Egli rappresenta lonnipotenza della autodistru-
zione.
2. Alessitimia e tossicodipendenza. Questa problematica investe, in
linea generale, di pi larea nevrotica e psicosomatica che quella della per-
versione. In questi casi, le espressioni verbali e i pochi sogni, spesso dram-
matici riportati dai soggetti (nella terapia individuale, in quella familiare e
di gruppo) ripropongono in maniera gruppale le dinamiche pre - edipiche
non risolte (dipendenze gravi, gelosie profonde, violenze sessuali, seduzioni
patologiche, sentimenti di odio e amore mai elaborati, patologia della co-
municazione). Naturalmente, il ruolo del padre viene segnalato come secon-
dario. Sappiamo che quando linteriorizzazione del modello paterno, gi
nelle fasi pre-edipiche, subisce un rallentamento o una difcolt che come
specchio si riverbera anche sulla madre, il processo di identicazione inte-
riorizzazione fallisce proprio nelle fasi successive. Di conseguenza, la Legge
del Padre nei pazienti tossicodipendenti rimane lettera morta, non incide
nella dinamica patologica madre glio: la parola del padre, come nelle
famiglie ad andamento schizofrenico, passa per la tangente, non entra nel
campo dinamico madre gli. Ricordiamo che la squalica del genitore, in
questo caso il padre, pu avvenire anche da piccoli e per gioco.
3. Casi clinici. Segnaliamo il caso di un paziente tossicodipendente,
Nando, il quale ricordava che quando era piccolo diceva al padre stupido,
stupido per gioco e tutti si divertivano quando si rivolgeva cos al padre.
Questo perch il bambino era diventato un po balbuziente dopo la nascita
della sorellina; cos gli permettevano di dire tutto senza contraddirlo. Nel
corso degli anni non aveva pi cambiato questo atteggiamento: la madre pri-
ma scherzava, poi diceva al marito di non farci caso e di lasciar parlare senza
contraddire il glio perch era stato un po balbuziente e quindi rinforzava
sul piano reale lalleanza e il legame col glio a discapito della triangola-
zione edipica. La madre non ha mai rimproverato il glio per queste frasi,
mentre il padre lo faceva senza che le sue interdizioni castrassero il legame
diadico madre glio. La dinamica interpersonale riferita alla descrizione
della balbuzie del glio certo indicativa di un atteggiamento di fondo della
madre, ripetuto in mille altri eventi quotidiani, e connesso a dinamiche in-
trapsichiche della donna: ultima di diversi gli, era stata indotta a dominare
la propria madre e ad instaurare legami affettivi intensamente competitivi
e sottilmente aggressivi svalutanti e impercettibilmente ricattatori. Inol-
tre ella era rimasta orfana di padre n dallinfanzia. Dal canto suo il pap,
uomo educato in maniera troppo rigida e troppo rispettoso dei genitori (in
particolare della propria madre) non ha mai potuto ribellarsi a loro e dire
questo non va bene, anche se lo pensava. E signicativo ricordare che egli
continuava a rivolgersi ai propri genitori col voi.
Tornando al paziente, egli raccontava che da adulto era ormai convin-
to che suo padre fosse uno stupido, anche perch si era sentito sempre pi
forte di lui per il fatto che era spalleggiato dalla madre. Questo un esem-
pio di come la interiorizzazione della legge del padre nei casi di tossicodipenden-
- 11 -
za rimane superciale ed esteriore, quasi impersonale, e squalica la relazio-
ne stessa padre glio. Ricordiamo che il tossicomane chiede i soldi per la
droga alla madre, succhia i liquidi alleroina madre come faceva da piccolo
senza che qualcuno abbia mai potuto dire: basta. Daltra parte la parola
del padre, quando dice basta, non riesce a scindere lalleanza ormai strut-
turata sul piano psichico e sul piano interpersonale. Nella visione olistica
della tossicodipendenza il corpo assume un valore non solo sintomatico,
come la parte brutta o cattiva che viene scissa dalla mente o dalla sostanza.
Il corpo diventa loggetto della relazione tossicomanica e la tossicomania una chiara
manifestazione psicosomatica, in quanto coinvolge lunit psiche soma del
soggetto e quella del corpo - gruppo e famiglia (Agresta F., 1991; 1997).
Laspetto peculiare del nostro approccio consiste nella considerazione delle rela-
zioni fra i diversi piani citati, a un tempo costituite dal, e costituenti il, fenomeno in
oggetto. A ci siamo stati indirizzati dallesperienza clinica e dalla grande im-
portanza data ai primi colloqui di consultazione e di terapie brevi (Gilliron
E., 1998; Agresta F., 2000), senza tralasciare la diagnosi di organizzazione di
personalit che nel tossicodipendente acquista un signicato indispensabile
e progettuale prima di qualsiasi tipo dintervento. In particolare, una consi-
derazione complessa che tenga conto degli aspetti simbolici e mitici forniti
dal collettivo, si rivela indispensabile in quanto nella maggior parte della
personalit dei tossicodipendenti manca la capacit di elaborazione simbo-
lica intrapsichica e interpersonale (modalit di relazione tossicomanica e
alessitimica; Sifneos P., 1991). In questa area di studio e di ricerca abbiamo
riscontrato lincapacit di comunicare e di esprimere le proprie emozioni
e reazioni attraverso le parole, la negazione del mondo interiore e della
sofferenza psichica, la difcolt della elaborazione onirica e la tendenza alla
razionalizzazione degli stati comportamentali. Insomma: il gesto e la sua
ratio al posto della sensazione del proprio esistere. Tossico ci che indi-
cato come tale in ogni tempo dal mito corrente, dalle allusioni condivise e
non discusse di un dato gruppo culturale o sociale (Filippini R., 1991): pu
essere una sostanza stupefacente, una ideologia totalizzante, una relazione
interpersonale (Meltzer D., 1983): un persecutore che si presenti come
protettore da angoscia e da sgomento interiori, che monopolizzi ogni oncia
di attivit psichica e di realt esterna, e in cambio dia certezze, possibilit
di non pensare e rush momentanei di sensazioni di esistenza. In realt non
ben chiaro se lalessitimia nei disturbi di tossicodipendenza sia primitiva
o secondaria allabuso di sostanze psicoattive (Bellio G., Fiorin A., 1994).
Quello che ci preme sottolineare che lalessitimia , in ogni caso, un feno-
meno che si accompagna agli stati tossicomanici, instaurandosi con essi un
circuito ricorsivo come quelli descritti nei fenomeni complessi (A > processo
che porta ad A). Ogni tipo di intervento deve essere prima di tutto familiare
e / o gruppale, senza escludere il rapporto individuale. Alla luce di questa
impostazione teorico clinica gli A.A. riportano un caso clinico (tra i diversi
che abbiamo incontrato) trattato su tre livelli: 1. Approccio individuale; 2. ap-
proccio dinamico familiare (o situazione inversa) 3. psicoterapia analitica di gruppo.
In particolare si vuole dimostrare come il processo di mentalizzazione che si
avvia durante la psicoterapia sblocca lincapacit di esprimere le emozioni
o ricordare i sogni, tipico status dei tossicodipendenti nella fase pi difcile
o quando sono allinizio della terapia, quando lagire segnala la tipica espres-
- 12 -
sione del comportamento tossicomanico a discapito della riessione o della
presa di coscienza: questo come indice della mancanza di una minima trac-
cia di mentalizzazione.
Caso Mario. Mario un giovane di venticinque anni venuto alla consul-
tazione perch inviato da un medico di famiglia. I primi incontri con la fa-
miglia hanno evidenziato una dinamica familiare classica, dove esiste unal-
leanza tra madre e glio e un riuto di colloquio tra glio e padre. Laltra
glia, pi grande di quattro anni, invischiata in maniera apertamente
seduttiva con la gura paterna. Si tratta di una famiglia cosiddetta scismati-
ca. Il trattamento familiare si protratto per circa un anno e il giovane ha
continuato per un altro anno con la terapia individuale. Poi, daccordo, ha
iniziato il percorso di ri - nascita in un gruppo di terapia. Con i primi sogni
nel gruppo, che allinizio non ricordava, Mario cominciava a vivere le sue
angosce prima represse e annebbiate dalleroina. Durante il trattamento
era lontano dalla droga ormai da due anni. Un sogno di inizio di terapia di
gruppo e di mentalizzazione questo: Mario racconta nel gruppo un sogno
di un grave incidente che gli era capitato due anni prima. Egli si era fatto
una dose, aveva preso la moto e subito dopo aveva subto un incidente stra-
dale. C stato un ricovero perch nellimpatto, oltre alla rottura di un brac-
cio, aveva perso sangue dal naso. Egli racconta questo sogno: Ho sognato che
avevo fatto lincidente, proprio come era accaduto, ho sentito un forte dolore alla testa
e ho perso sangue dal naso mentre sognavo. Il paziente si svegliato che perde-
va ancora sangue. Dopo questo episodio, un po alla volta, ha cominciato a
ricordare i sogni senza somatizzare il dolore, lansia e laggressivit, che pian
piano hanno perso il valore di intensit perch il processo di mentalizzazio-
ne in un soggetto alessitimico aveva preso corpo nella terapia di gruppo. Pi
aumentato il processo di mentalizzazione, meno M. agiva istintivamente e
tanto pi esprimeva le sue emozioni pi profonde. Altri sogni di ex-tossico-
dipendenti riguardano le immagini violente e pre-edipiche di una seduzione
materna con scene molto esplicite. Quando c la fase del distacco della
ri-nascita i sogni dei giovani e delle giovani esprimono la nostalgia del distac-
co. Carlo sognava che vedeva sua madre passargli davanti nuda ma col seno
afosciato. Andrea, uscito dal tunnel delleroina, sogna prima di avere rap-
prti sessuali con la propria madre e, pian piano, racconta sogni di distacco
e di crescita. Chiaramente, nella storia dei tossicodipendenti, ci sono, come
abbiamo detto, storie di fantasie di ricoprimento e di dipendenza reali
e immaginarie. Comunque una mancanza della presenza della funzione
genitoriale con una conseguente seduzione della gura materna e sogni in-
cestuosi. Da non dimenticare, putroppo il ruolo dei nonni che assume una
valenza negativa quando invadono la sfera privata dei genitori e, in parte,
responsabili del mancato svincolo come insegnano i terapeuti familiari.
Alcuni sogni di Romeo: 1. Sto in atteggiamenti intimi in un letto con
Stella e Virginia e ci sono i miei genitori che stanno intorno al letto come ad
osservare e commentare; 2. Sto a Roma, appare Giuliana, faccio petting; poi
faccio sesso con mia madre, lei ha il pancione (grasso-incinta) ed i seni rag-
grinziti, come svuotati; 3. Sto in intimit con Giovanna di J.., al momento
della penetrazione lei mostra una vagina dentata. Il desiderio bloccato
dalla paura: appare il Dott. Agresta che tenta di spiegare, dare lezioni;
4. C mia madre, io sono arrabbiato perch ho problemi a causa sua. La
- 13 -
mando a ffanculo. Lei ringiovanisce; 5. Sto riparando un orologio, c
mio padre che mi mette fretta; lorologio fa fumo mi arrabbio e dico:
non mettermi fretta!; 6. Sono morto, c una ragazza; vuol fare un glio
(con me), se ne parla, sono resto (cos ho scritto sul diario quando mi
sono svegliato); 7. Sto vedendo la Tv con pap; appare sullo schermo una
ragazza con il seno lungo e grosso, poi due ragazze nude con un clitoride
molto grande, secernono un liquido (sul diario eiaculano) giallo e se lo
spalmano addosso. Provo schifo e cambio canale; 8. Sto a letto, c anche
mia madre; parliamo mentre guardiamo la Tv, mi sento a disagio e provo
ansia. Penso che tardi e che ho passato troppo tempo a letto. Penso a pap
che lavora; 9. Mamma vuole divorziare da pap. Questultimo, per reazione,
se ne vuole andare in casa in campagna, a Ripattoni. Io intervengo e dico a
pap che non pu, deve rimanere e parlare, lui si irrita e poi accendiamo il
camino (Interpretazione: accendere il camino, mantenere viva la famiglia, il
dialogo padre-glio, riferito al simbolo-funzione paterna); 10: Cammino per
il mio quartiere con R. (amico buono), ci troviamo dinanzi alla tabaccheria
dove ci sono ledicolante (donna) ed una bella ragazza che offrono da man-
giare. Prendiamo qualcosa, buono; 11: Vado a fare un giro per il mio paese
con una Jeep, la macchina si ferma e non riparte. Arriva zio B. (che abita di
fronte casa mia ed un po il centro di incontro del quartiere), T. (glio di
zia Maria), Giose, mio fratello ed una ragazza grassa. La jeep riparte, andia-
mo al quartiere vicino dove andavamo a giocare da piccoli. C un torneo di
tennis, lo vediamo. Io cerco delle ragazze ma non ne trovo; 12. Mi trovo in
un luogo simile al mio paese. Salgo delle scale al secondo piano, incontro
Giulio (cugino alla lontana che ha avuto problemi con leroina, andato in
comunit ma pare non abbia ancora risolto questi problemi) che si lamenta
e si pente del suo passato tossico. Io, scendendo le scale gli dico: vabb, ab-
biamo fatto la stronzata ma vediamo di andare avanti, abbiamo capito, ades-
so basta; 13. Mi trovo ad una festa a casa di mia nonna (e di mia zia Maria).
Ci sono amici di Roma; c Eliana, parliamo, le faccio cenno di uscire a fare
un giro con me. Le tocco il sedere, lei si sente acca, la prendo in braccio.
In una viuzza ci sono dei ragazzetti e delle ragazzette vestite punk, molto
colorito, sono tutti ubriachi e drogati. Me ne vado con Eliana in braccio,
cercando di farla riprendere.
Conclusioni. Si ribadisce limportanza della domanda daiuto del tossi-
comane che dovrebbe essere esaminata nella sua complessit di domanda
nascosta dal sintomo che la motiva e che dovrebbe implicare una ricostru-
zione della storia naturale della scelta tossicomanica. Tutto ci per solle-
citare le varie risposte terapeutiche possibili da incanalare, poi, sul piano
olistico della concezione mente corpo (transfert controtransfert) con
una interpretazione complessa e intersistemica rispetto a percorsi setto-
riali e riduzionisti, che contribuiscono solo a rinforzare difensivamente una
concezione dualista della struttura di personalit (scissione mente corpo
e terapie sintomatiche). Daltra parte, non esiste un unico prolo familiare
che sia patognomico della tossicomania: alcuni Autori hanno delineato e
individuato caratteristiche familiari comuni che possono essere individuate
e trattate soltanto con approcci di tipo olistico, che pongono in essere sia il
trattamento individuale e di coppia, che quello familiare e di gruppo.
PS. Un buon lavoro di prevenzione stato proposto sia nelle Scuole
- 14 -
primarie, sia in quelle dove il fenomeno pi reale, come nelle Scuole me-
die e Superiori un lavoro concreto di crescita gruppo per docenti e famiglie,
non solo a livello di informazione ma, soprattutto, a livello di FORMAZIO-
NE con diverse tecniche psicologiche consolidate. Dal Training Autogeno
con Visualizzazione Guidate per i ragazzi, al Social dreaming per Docenti e i
genitori e ai Gruppi Balint per docenti. Colloqui preliminari di sostegno per
docenti, insegnanti e genitori per avviare eventuali psicoterapeie speciche.
BIBLIOGRAFIA
1. A.A. V.V., (1983), La maladie dpressive, Ciba - Geigy, Rueil- Malmaison (Paris);
2. A.A. V.V., (1993), Le Tossicodipendenze, Psicobiettivo, Cedis, Roma sett. dic., Anno XIII,
n. 3;
3. Agresta F., (1997), Malattie Psicosomatiche e Psicoterapia Analitica (Pref. E. Gilliron), N.
Prospettive in Psicologia, Pescara; II Ediz. 2004;
4. Agresta F., (2001), Modelli Psicoterapeutici in Psicosomatica, Congresso Naz. SIMP, Siena,
Atti del XVII Congresso (a cura di M. Reda e D. Benevento), Universit di Siena, Facol-
t di Medicina, Istituto di Psicologia;
5. Bellio G., Fiorin A., (1994), Alessitimia e tossicodipendenza: uno studio preliminare su eroino-
mani, Medicina Psicosomatica, Vol. 39, n.3;
6. Bergeret J., Fain M., Bandelier M., (1983), Lo psicoanalista in ascolto del tossicomane, Ed.
Borla, Roma;
7. Cancrini L., (1991), La Rosa, Il vaso di Pandora, NIS, Firenze;
8. Ciof R., (2000), Approcci tecnico teorici delle psicoterapie di gruppo nellanoressia mentale,
Medicina Psicosomatica, Vol. 45.n. 4 ottobre dicembre;
9. Cirillo S. et alii, (1999), La famiglia del tossicodipendente, R. Cortina Editore, Milano;
10. Croce E. B., (1987), Tossicomania: lavoro del sogno, lavoro del gioco, Psichiatria e Psicotera-
pia Analitica, Vol. VI, n. 2;
11. De Clerq F., (1990), Tutto il pane del mondo, Sansoni Editori, Firenze;
12. Dolto F., (1988), La cause des adolescents, Poket, Paris;
13. Dolto F., (1988), La cause des adolescents, Robert Laffont, Paris;
14. Gilliron E., (1991), Piacere e dipendenza, Nuova Psyche, Padova, CISSPAT, Anno IX, n. 2;
15. Laplance J. Pontalis J. B., (1993), Enciclopedia della psicoanalisi, Laterza, Bari;
16. Meltzer D., (1983), Stati sessuali della mente, Armando, Roma;
17. Morelli R., Slepoy V., (1985), Leroina e i simboli di un rito mancato, RIZA Psicosomatica,
N.52;
18. Ruggieri V., (2000), Semeiotica di processi psicosiologici e psicosomatici, Il Pensiero Scienti-
co Editore, Roma;
19. Ruggieri V., Galati D., Lombardo G., (1993), Processi di costruzione dellimmagine corporea,
Realt e Prospettive in Psicosiologia, A.S.P.I.C., Roma, n. 5/6/7, maggio;
20. Stanton M.D., (1982), The family of drugs abuse and treatment, Guilford, New York.
*dal libro: IL LINGUAGGIO DEL CORPO IN PSICOTERAPIA, Glossario di Psicosomatica,
Prefazione di Piero Parietti, Edizioni ALPES, Roma, 2010, pagg. 252, Euro 19,00.
- 15 -
Fausto Agresta Psicologo e Psicoterapeuta analista, individuale e di gruppo. Libero
professionista dal 1976, per dieci anni ha insegnato prima nella Universit di LAquila e
poi di Chieti (Facolt di Psicologia G. dAnnunzio). Si specializzato in Psicoterapia
ad indirizzo psicosomatico e psicoanalitico presso la Scuola Quadriennale di Medicina
Psicosomatica e Psicoanalitica della SIMP Abruzzese (Dott.: R. Di Donato). Ha completato
la sua formazione psicoanalitica individuale e di gruppo in Italia, in Svizzera e in Francia,
ed ha avuto come formatori gli Psicoanalisti: S. Erba, L. Cofano, P.L. Sommaruga (SPI),
L. Tremelloni, E. Gilliron (IPA), P. Sifneos, K. Rohr. E, in pi, i noti rappresentanti della
Medicina Psicosomatica: P. Parietti B. Luban-Pozza, M. Sapir (SPF). E Didatta e Docente
IPAAE e conduttore G. Balint. Ha insegnato presso la Scuola Romana Analitica Balint (L.
Ancona) e presso lIREP (Dir. E. Gilliron). Attualmente docente di Psicosomatica pres-
so la SIPSI di Roma (Dir. D. Nesci). E membro e co-fondatore del Gruppo di Ricerca in
Psicosomatica (GRP) e Membership of International College of Psychosomatic Medecine
(ICPM). E socio e membro del Consiglio Direttivo della SIMP (Societ Italiana di Medici-
na Psicosomatica), Responsabile Nazionale Area Psicologi SIMP e Coordinatore Pescarese
della SIMP, gi socio, formato alla SGAI (Societ Gruppoanalitica Italiana). E autore di 16
libri ed ha prodotto, su diverse riviste scientiche nazionali, oltre 160 pubblicazioni e ricer-
che nel campo della psicologia dellet evolutiva, della psicosomatica e della psicoterapia
analitica individuale e gruppale. Malattie psicosomatiche e psicoterapia analitica, (Pref. E.
Gilliron), N. Prospettive in Psicologia, 2004; Problemi di Psicosomatica clinica, Quaderni del
CSPP, 2007; Quotidianit del medico e dello psicologo secondo la metodologia dei G. Balint (Pref.
K. Rohr), Quaderni del CSPP, 2007. Per le Edizioni Alpes, Roma: I sogni dei pazienti bor-
derline (con D. Agresta, P. Petrini). Ultimo libro: Il linguaggio del corpo. Glossario di Psicoso-
matica da cui stato tratto questo articolo. Nel 2005 ha fondato (con Colleghi) e dirige il
Centro di Psicologia, Psicosomatica Clinica e Psicoterapia Analitica e di Gruppo (CSPP). Esercita
privatamente a Pescara.
Indirizzo dellAutore: Dott. Fausto Agresta - Via Bologna, 35 - 65121 - Pescara
E-mail: fagresta@hotmail.com
- 16 -
IL DIALOGO DEGLI INCONSCI:
LASCOLTO MEDIATO DA RAPPRESENTAZIONI
MENTALI EMERGENTI
Marco Alessandrini
1. Da un inconscio allaltro
In uno scritto del 1915, Linconscio, Freud accenna un tema che nella
sua opera si affaccia in altre ricorrenze, sebbene apparentemente occasiona-
li. Scrive: assai interessante che lInc di una persona possa reagire allInc
di unaltra eludendo il C (Freud S., 1915, pag. 78). A questo riguardo, gi
nel 1913 aveva precisato: Ma io ho alcuni buoni motivi per sostenere che
ogni uomo possiede nel suo inconscio uno strumento con il quale in gra-
do di interpretare il modo in cui si esprime linconscio degli altri (Freud S.,
1913, pag. 238).
Da queste pur brevi notazioni in realt possibile trarre un procedi-
mento tecnico, o meglio una disposizione mentale, tale da ampliare ci che
in psicoanalisi o in psicoterapia analitica viene denominato ascolto o revrie
del terapeuta.
Sempre Freud, su questo tema, prescrive al terapeuta unattenzione
uttuante, specicando: La regola per il medico pu essere espressa nel
modo seguente: Si tenga lontano dalla propria attenzione qualsiasi inusso
della coscienza e ci si abbandoni completamente alla propria memoria in-
conscia, oppure, in termini puramente tecnici: Si stia ad ascoltare e non ci
si preoccupi di tenere a mente alcunch (Freud S., 1912, pag. 533).
La memoria inconscia, allora, intesa freudianamente come stru-
mento in grado di interpretare le modalit di espressione dellinconscio
degli altri, diventa il concetto e lapproccio cruciali grazie a cui lascolto da
parte del terapeuta pu essere in grado di attingere a quel livello mentale
che Ferenczi, a sua volta, denisce dialogo degli inconsci (Ferenczi S.,
1915, pag. 151). Se per sia Freud che Ferenczi precisano che tale capacit
inconscia elude il C (ossia la coscienza), il terapeuta dovr invece essere in
grado, proprio tramite la sua coscienza e quindi intenzionalmente, di dispor-
visi e di attivarla. Dovr disporre di tale capacit coscientemente, in modo da
eleggerla a strumento di dialogo con ci che di profondo, inconscio e radi-
cale abita, in un determinato istante, il dire e lesistere del paziente. Occorre
in pratica che la coscienza del terapeuta si disponga a uttuare in sintonia
con il proprio inconscio, producendo rappresentazioni che condividano, at-
tenuando labituale reciproca delimitazione, la logica del processo primario
(inconscia) e quella del processo secondario (cosciente).
Le conseguenti rappresentazioni avranno dunque una struttura parti-
colare, in quanto loro natura possedere le peculiarit dello strumento
che, nellinconscio del terapeuta, nel commisto alla coscienza grazie allat-
tenzione uttuante, reagisce allinconscio del paziente interpretandolo.
Le peculiarit di queste rappresentazioni, che insorgono in tale livello
mentale raggiunto dallattenzione uttuante, sono soprattutto due: da un
lato, lestrema capacit di ragionare tramite condensazioni, vale a dire
- 17 -
integrando, in una sola rappresentazione, molteplici informazioni; dallaltro
lato il prevalere di un impatto sensoriale. In sostanza, le rappresentazioni
tramite cui il terapeuta pu attingere al proprio inconscio, a sua volta in
dialogo con linconscio del paziente, contengono in forma condensata
molteplici informazioni, e possiedono inoltre una natura prevalentemente
sensoriale. In generale, daltronde, la sensorialit risponde a una logica
emotivo-intuitiva e inconscia, e per suo tramite perci possibile ricollegare
la coscienza ai pi ampi, e per essa impensabili, processi inconsci.
2. Tra vuoto e revrie
A questo proposito Marion Milner, in uno scritto del 1975, nel discu-
tere una tesi di Masud Khan scrive: [la] mente profonda [] inafferra-
bile da parte della mente di supercie, non per la rimozione di contenuti
sgradevoli ma per la sua struttura; e [] proprio per questa sua peculiare
struttura, essa pu adempiere a compiti di integrazione che superano di
molto le capacit dellattivit mentale conscia di supercie (Milner M.,
1975, p. 346). In pi, la Milner aggiunge che per queste sue caratteristiche
lattivit della mente profonda o inconscia viene percepita dalla mente
di supercie come una lacuna della coscienza (ibidem). Si pu allora pro-
porre unanalogia con il concetto di O formulato da Wilfred Bion: il segno
O, che equivale a origine, indica secondo questo autore la realt assoluta
e inconoscibile in atto in qualunque situazione, in questo caso nellincontro
tra analista e paziente (Bion W.R., 1965). Ne deriva pertanto, come scrivono
alcuni commentatori del pensiero bioniano, che lo psicoanalista dovrebbe
riuscire a creare la cornice mentale in cui poter essere ricettivo rispetto a O;
e questo dipender, sempre nel linguaggio di Bion, dalla sua capacit di
essere at-one-ment [ossia allunisono] con O (Grinberg L., Sor D., Tabak de
Bianchedi E., 1991, pag. 111). Bion ritiene tuttavia che O sia percepibile
attraverso modalit non sensoriali. In realt, le rappresentazioni in grado di
cogliere O, vale a dire capaci di raccogliere l interpretazione che il pro-
prio inconscio offre dellinconscio del paziente, hanno una veste sensoriale.
per vero, concordando con quanto afferma Bion, che in tali rappresenta-
zioni la sensorialit soltanto il tramite dei procedimenti condensati, intuiti-
vi e al di l della pura sensorialit, peculiari della mente profonda.
Resta il fatto che la coscienza, per consentire a simili rappresentazioni
di emergere, deve disporsi ad accettare, come afferma la Milner, una lacu-
na o un vuoto, un non-pensare, anzi unimpossibilit a capire e a pensare.
O, infatti, impensabile agli occhi della mente conscia di supercie, poi-
ch possiede una struttura differente: una struttura condensata e plurisigni-
cante, e poi sensoriale. Sebbene la sensorialit, bisogna ribadirlo, sia qui
soltanto il velo attraverso cui si affaccia unintuizione di per s non sensoria-
le. Intuizione che poi il porre in forma, da parte del proprio inconscio,
linconscio del paziente, vale a dire il nucleo profondo sottostante, in un
determinato momento, al discorso cosciente del paziente. Inne, le rappre-
sentazioni che in questo modo aforano possono anche essere considerate
una particolare variante del controtransfert, l dove si vericano, da parte
del paziente, la scissione di parti di s e il loro conseguente trasferimento
nella mente dellanalista. Sarebbe insomma in gioco, da parte del paziente a
livello inconscio, un bisogno comunicativo consistente nel far sperimentare
- 18 -
al terapeuta aspetti di s mai giunti a un sufciente grado di mentalizza-
zione. Ecco allora che proprio lo scarso grado di elaborazione psichica di
questi aspetti del S, una volta che linconscio del terapeuta li abbia accolti,
richiede da parte del terapeuta stesso, afnch essi possano giungere alla
sua coscienza, strumenti mentali strutturalmente vicini ai processi primari
dellinconscio. Tali strumenti mentali possono consistere proprio nelle rap-
presentazioni plurisignicanti e sensoriali aforanti dallinconscio del tera-
peuta in contatto con linconscio del paziente.
3. Le rappresentazioni mentali emergenti
Viene cos a delinearsi, in base a queste considerazioni, una particola-
re modalit di ascolto. Disporsi in O, secondo la terminologia di Bion, o in
un sentimento di vuoto e di lacuna della coscienza, in base alle denizioni
della Milner, la prima tappa cui il terapeuta dovrebbe sottoporsi in fasi
della seduta avvertite come stagnanti, o viceversa critiche. Il terapeuta pu
sottoporvisi in realt in qualunque altro momento, anche soltanto sotto lur-
genza di una spontanea spinta a farlo.
Qui innanzitutto richiesta, al terapeuta, la capacit di tollerare le
proprie reazioni emotive suscitate dal momentaneo non-capire. Sempre
Bion, riformulando a proprio modo lo schema delle posizioni evolutive
kleiniane (Klein M., 1957), ha sottolineato la necessit per il terapeuta di at-
traversare, prima di formulare uninterpretazione, ora un vissuto schizo-pa-
ranoide, nel quale pu assalirlo il timore che il non-capire sia frutto di una
sorta di opposizione malevola da parte del paziente, ora un vissuto depres-
sivo, in cui il non-capire invece avvertito come soverchiante, e soprattutto
come conseguenza di una propria colpa. Bion parla perci della necessit di
attraversare una crisi emotiva (Bion W.R., 1992, pag. 291). A voler tuttavia
seguire le citazioni freudiane di apertura, e soprattutto a trarre ispirazione
da concrete esperienze cliniche, non obbligatoriamente il non-capire, con
la correlativa crisi emotiva, il motore portante della particolare modalit di
ascolto qui proposta. Lo piuttosto, azzardandosi a coniare una denizione,
un apertura allinconscio, anzi un desiderio di inconscio: una semplice
attitudine a lasciar uttuare la propria attenzione. E questa anche e soprat-
tutto unattitudine, per dirlo parafrasando il titolo di un libro di Ogden, a di-
sporsi al conne del sogno (at the Frontier of Dreaming) (Ogden T.H., 2001).
esattamente questo il punto, ossia la condizione mentale, in cui
possibile lemersione delle suddette, peculiari rappresentazioni. E queste
possono assumere, per esempio, forma visiva, presentandosi in pratica come
immagini, scenari, fantasie, dove solitamente, anche se non sempre, risulta
protagonista il paziente. Possono tuttavia anche possedere forme sensoriali
diverse, vedi la veste di frasi uditive mentali, di vissuti somatici, o via prose-
guendo. Per meglio comprendere a quale ordine di rappresentazioni occor-
re disporsi, pu essere particolarmente utile la denizione di immagine
fornita dal neuroscienziato Antonio Damasio. Questultimo scrive: Con il
termine immagine intendo una congurazione mentale con una struttura
composta di elementi di ciascuna delle modalit sensoriali: visiva, uditiva, ol-
fattiva, gustativa e somatosensitiva. La modalit somatosensitiva comprende
svariate forme di sensorialit: tattile, muscolare, della temperatura, del dolo-
re, viscerale e vestibolare. La parola immagine non indica soltanto unimma-
- 19 -
gine visiva e non suggerisce neanche qualcosa di statico (Damasio A.R.,
1999, pag. 382). dunque laforare di una vasta congerie di immagini,
e vasta perch, secondo quanto affermato da Damasio, polimorfa e multi-
sensoriale, ci a cui la mente del terapeuta deve disporsi. Poi per in ogni
terapeuta, cos come in qualunque persona, tender a prevalere, e perci a
ricorrere, una sola tipologia o modalit di rafgurazione.
Possono comunque aforare, occorre ripeterlo, stimoli uditivi, come
brani musicali o frasi mentali, o altrimenti sensazioni somatiche, per esempio
di dolore o di piacere a varia localizzazione, o ancora sensazioni tattili, gusta-
tive, olfattive. Per di pi, i differenti elementi sensoriali possono raccogliersi
e contemperarsi, dando luogo a spezzoni compositi di carattere quasi lmico.
Per un utile raffronto, inne opportuno ricordare che in ambito
freudiano lunico terapeuta ad aver tratteggiato un procedimento in parte
afne, sebbene limitato a rappresentazioni visive, Roberto Speziale-Ba-
gliacca (Speziale-Bagliacca R., 1997, pp. 237-243; 2010, pp. 252-259).
4. Il senso di ESSERE
Alcune esemplicazioni cliniche possono adesso offrire un breve spac-
cato di qualche possibile evenienza.
In una prima situazione clinica, durante la seduta con una paziente
che chiamer Alessandra, come di regola, distesa sul lettino, mi dispongo,
sia mentalmente, secondo quanto indicato pi sopra, sia sicamente, tra-
mite un intenzionale rilassamento, ad accogliere eventuali rappresentazioni
emergenti. Mi accade cos, allimprovviso, di visualizzare Alessandra mentre
supina e a gambe leggermente divaricate affonda in un mare dalle acque
scure. un mare cupo e intenso che ricorda quello dove, con i miei geni-
tori, mi recavo in estate durante la prima infanzia. Limmagine ha carattere
visivo ma nel contempo si lega a sensazioni somatiche e a vissuti affettivi:
vissuti di pesantezza, di stagnazione, di nostalgia. Potrei dire che il mio sen-
timento complessivo, riguardo a ci che vedo mentalmente, insieme non
avvertire via duscita e un grande dolore, in particolare da stasi e da lutto,
anzi da sprofondamento in un interminabile e vischioso lutto. Nella mia
immagine, daltronde, Alessandra pur se viva come se fosse morta, perch
in effetti quella posizione, qualora nella realt dovesse accadere a qualcuno
di assumerla in acqua, verrebbe comunemente denita fare il morto. Ales-
sandra, dopo alcuni secondi e senza che io le abbia comunicato nulla di ci
che andavo rappresentandomi, dice: come se dovessi accettare che ci
che nellinfanzia, da parte di mia madre, mi mancato, incolmabile, non
recuperabile. Subito aggiunge: come se in me la bambina, da allora,
fosse rimasta l ad attendere che qualcuno vada a curarle le ferite. Penso in
quel momento che la mia revrie abbia rafgurato questa sua plumbea passi-
vit, la passiva, dolorosa attesa di lei immersa - come a fare il morto - nelle
emozioni buie e ferite dellinfanzia. Restando vicino alla rappresentazione
aforata, le dico: La tua vita in questi anni stata come un cadere sempre
pi a fondo senza fare nulla. Risponde: Il fatto che io penso che nes-
suno la vada a prendere [la bambina ferita] sento che cos e sento
che questa bimba come se si aspettasse qualcosa, qualcuno che si accorga
di lei. Prosegue: Ora vedo limmagine di questa bambina che mi tende le
braccia, come se mi chiedesse di fare qualcosa. Domando: Che cosa puoi
- 20 -
fare?. E lei: La posso prendere in braccio, la posso abbracciare. Allora
concludo: Ora comunque la stiamo accogliendo anche noi qui. A
questo punto, Alessandra scoppia a piangere. Dice: La bambina per nella
mia immagine molto gioiosa, molto giocosa proprio giocosa, come se
tutte queste cose non le avesse vissute molto felice, come se mi aspettas-
se, come se avesse aspettato questo momento.
In questo esempio, dunque, la rappresentazione emersa, con la sua
piena intensit visiva, cenestesica ed emotiva, sembra aver raccolto linterpre-
tazione, da parte del mio inconscio, di un particolare stato inconscio della
paziente. E a questo riguardo si potrebbe anche proporre un paragone, pur
se a titolo puramente euristico, con molte tradizioni meditative quali quelle
orientali, dove in genere occorre visualizzare mentalmente determinate im-
magini, spesso rafguranti speciche divinit. Si ritiene infatti che tramite
una tale tecnica di meditazione, durante la quale ci si identica poi con
limmagine della divinit visualizzata, sia possibile sperimentare un corrispon-
dente stato coscienziale, del quale limmagine, anzi la divinit, sarebbe in
pratica lespressione e il tramite (Landaw J., Weber A., 1993; Von Brck M.,
Von Brck R., 1996, pp. 75-84). Perci, seguendo questa possibile analogia,
il frammento clinico relativo alla seduta con Alessandra attesterebbe che la
rappresentazione emersa in me, quale terapeuta che vi si era disposto, ha
consentito a entrambi una sintonizzazione (o identicazione) con una
divinit, o contenuto mentale (coscienziale) inconscio, emergente in
quel momento nella relazione, o volendo, nella comunicazione tra il mio
inconscio e quello della paziente. Inoltre, in tali tradizioni limmagine che
lo sguardo interiore visualizza non deve essere osservata nel suo solo aspetto
manifesto, ma contemporaneamente come trasparente, aperta sul fonda-
mento illimitato e senza forma dal quale si suppone scaturisca. In effetti,
sempre accettando unipotetica analogia, anche il dialogo con Alessandra
sembra aver condotto ben al di l dellimmagine stessa in me aforata. Infatti
le sue associazioni libere, a loro volta di carattere visivo, non solo hanno crea-
to lopportunit, da parte mia, di offrire a lei laccoglimento emotivo da esse
implicitamente richiesto, ma le hanno permesso di essere e di percepirsi,
percependo, in sostanza, un fondamento narcisistico preriessivo: un senti-
mento del S, anzi di essere un S, e per anche di essere un S in rappor-
to di duciosa continuit con loggetto, in questo caso con me. Si tratterebbe
perci di un fondamento situato al di l dellimmagine: al di l della dicibilit
e della rafgurabilit coscienti. Un fondamento presumibilmente paragona-
bile, in quanto stato mentale irrafgurabile e matriciale, a ci che Winnicott
denisce elemento femminile o essere. Scrive infatti Winnicott: La mia
idea che [] il puro elemento femminile ha rapporto con il seno (o con la
madre) nel senso che il bambino diventa il seno (o la madre), nel senso che loggetto
il soggetto. [] [e] nessun senso di s potr emergere se non sulla base di questo esse-
re in rapporto nel senso di ESSERE (Winnicott D.W., 1971, pp. 142-143).
Io, di fatto, non ho comunicato ad Alessandra limmagine aforata
in me, eppure lei sembra aver prodotto unimmagine analoga nello stesso
istante, o per lo meno un vissuto speculare e afne. I miei commenti hanno
seguito a quel punto il lo comune della mia e della sua immagine, dispo-
nendo me e lei a una sensazione nella quale, come dice Winnicott, logget-
to il soggetto: ossia in cui io ero lei, per lei, e lei era me, per me. Uno sta-
- 21 -
to non solo di simbiosi, ma piuttosto di co-costruzione, in forma cosciente,
di un vissuto circolante nel suo inconscio e da l nel mio.
5. Da conitti e pulsioni ai bisogni primari
Sorge per spontaneo domandarsi quale ruolo svolga, in processi di
questo genere, la soggettivit del terapeuta. Si pu rispondere che trattan-
dosi di processi controtransferali occorre postulare, come annotano Cecilia
Albarella e Mario Donadio (Albarella C., Donadio M., 1986, pag. 19), che
latteggiamento dellanalista (il suo controtransfert) sia una sorta di com-
promesso tra le sue personali tendenze e le richieste del paziente. Perci
nel gioco tra nuclei inconsci del paziente e del terapeuta, sempre compito
di questultimo possedere la disponibilit a lasciarsi eventualmente toccare
l dove, a suo tempo, la propria analisi personale non sia giunta, o dove co-
munque rimangano nodi irrisolti.
Citando allora un secondo esempio clinico, ecco che mentre ascolto
Giovanni, un paziente affetto da depressione e tormentato, ma anche sor-
retto, da imperativi superegoici colpevolizzanti, dopo essermi predisposto ad
accogliere eventuali rappresentazioni mentali, mi appare, in unimprovvisa
revrie, in piedi nelle vesti e nellattitudine di una sorta di fabbro. Nellimma-
gine, lui martella il ferro sopra a unincudine, tuttavia come fosse svogliato,
disinteressato, apatico. Dico allora: Lei forse fa le cose senza appassionarsi,
quasi meccanicamente. Lui risponde: S, vero, proprio cos. E in
quel momento, al di l di questo scambio di battute, avverto in realt quanto
la sua condizione vada a incontrare un mio nucleo depressivo, riattivando
la relativa tendenza, che in forme diverse anche di Giovanni, a pensare
che le situazioni e la mia stessa vita siano senza uscita, costrette a ripetersi,
a trascinarsi passivamente. Mi chiedo allora: la revrie parla di lui o di me?
In realt, parla della nostra relazione e di ci che a livello inconscio vi si
svolge: di una condivisione, o di un restare insieme, in unarea di decit e
di trauma, con il rischio di arrestarsi in questa irrisolta condizione comune,
ma anche con la potenzialit, da parte mia, di evitare io il mio e il suo ar-
resto, mobilizzando pulsioni aggressive e risorse narcisistiche, sia in me che
poi, da l, in lui. Ma allora, come sempre, piuttosto in gioco la relazione, e
allinterno di questa, accanto allarea dellinterpretazione che riguarda pul-
sioni e conitti, larea dei bisogni primari, relativi alla coesione e alla consi-
stenza del S. Larea dellESSERE, insomma, di cui come si detto parla
Winnicott, o anche larea pre-istintuale, come la denisce invece Gaddini
(Gaddini E., 1975). Unarea dove fondamentale la capacit dellanalista di
far s che la relazione fornisca vissuti di volta in volta adeguati ai livelli e ai
bisogni spesso arcaici, poco mentalizzati, che abitano il proprio S e il S del
paziente.
allora questa una breve, ultima descrizione di quanto il genere di
revrie e di rappresentazioni cui n qui si accennato possa essere effetto
e al tempo stesso causa di processi riguardanti larea pre-istintuale o del-
lESSERE. Processi consistenti, in altri termini, in una modalit di ascolto
in grado di collocarsi a livello del dialogo degli inconsci, e di mantenervisi
fornendo, a quel punto, non solo ascolto ma mentalizzazione e soddisfaci-
mento a bisogni primari, sia pure insieme ad associazioni e interpretazioni
relative a pulsioni e conitti.
- 22 -
BIBLIOGRAFIA
1. Albarella C., Donadio M., (1986), Introduzione al controtransfert, Liguori, Napoli, pp. 3-24;
2. Baranger W., Baranger M., a cura di, (1969), La situazione psicoanalitica come campo biper-
sonale, Raffaello Cortina, Milano, 1990;
3. Bion W.R., (1962), Apprendere dallesperienza, Armando, Roma, 1972;
4. Bion W.R., (1965), Trasformazioni, Armando, Roma, 1973;
5. Bion W.R., (1992), Cogitations. Pensieri, Armando, Roma, 1996;
6. Bourguignon A., Cotet P., Laplanche J., Franois R., (1989), Traduire Freud, Presses Uni-
versitaires de France (PUF);
7. Damasio A.R., (1999), Emozione e coscienza, Adelphi, Milano, 2000;
8. Ferenczi S., (1915), Anomalie psicogene del timbro di voce, Op. vol. 2, Raffaello Cortina,
Milano, 1990;
9. Freud S., (1912), Consigli al medico nel trattamento psicoanalitico, Op. vol. 6, Boringhieri,
Torino, 1974;
10. Freud S., (1913), La disposizione alla nevrosi ossessiva, Op. vol. 7, Boringhieri, Torino, 1975;
11. Freud S., (1915), Linconscio, Op. vol. 8, Boringhieri, Torino, 1976;
12. Gaburri E., (a cura di), (1997), Emozione e interpretazione. Psicoanalisi del campo emotivo,
Boringhieri, Torino;
13. Gaddini E., Ricerca, controversie ed evoluzione della tecnica terapeutica in psicoanalisi, in Te-
deschi G. (a cura di), La psicoterapia oggi, Il Pensiero Scientico, Roma, 1975, pp. 10-25;
poi in: Gaddini E., Scritti (1953-1985), Raffaello Cortina, Milano, pp. 372-386;
14. Grinberg L., Sor D., Tabak de Bianchedi E., (1991), Introduzione al pensiero di Bion, Raf-
faello Cortina, Milano, 1993;
15. Klein M., (1957), Invidia e gratitudine, Martinelli, Firenze, 1969;
16. Landaw J., Weber A., (1993), Visioni di Illuminazione. La Pratica della Divinit nellArte
Tibetana, Chiara Luce, Pomaia (Pisa), 1998;
17. Milner M., (1975), Discussione dellarticolo di Masud Kahn Alla ricerca dellesperienza del
sognare, in La follia rimossa delle persone sane, (1987), Borla, Roma, 1992, pp. 344-348;
18. Ogden T.H., (2001), Conversazioni al conne del sogno, Roma, Astrolabio-Ubaldini, 2003;
19. Speziale-Bagliacca R., (1997), Colpa, Astrolabio-Ubaldini;
20. Speziale-Bagliacca R., (2010), Come vi stavo dicendo, Astrolabio-Ubaldini;
21. Von Brck M., Von Brck R., (1996), Il Buddhismo tibetano, Neri Pozza, Vicenza, 1998;
22. Winnicott D.W., (1971), La creativit e le sue origini, in Gioco e realt, Armando, Roma,
1974, pp. 119-150.
Marco Alessandrini Psichiatra, Psicoterapeuta analista, Responsabile dellUnit Opera-
tiva Trattamenti Integrati del Centro di Salute Mentale di Chieti, professore a contratto
presso la Laurea Magistrale della Facolt di Psicologia dellUniversit di Chieti. direttore
scientico della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica Breve di Chieti
(riconosciuta dal M.I.U.R.). direttore della Collana Psicopatologia ieri e oggi delle Edi-
zioni Scientiche Ma.Gi. di Roma. autore di numerosi articoli in riviste scientiche e in
volumi, oltre che traduttore e curatore di testi psicoanalitici, letterari e di arti gurative.
Ha al suo attivo 8 volumi: Presente assenza, o la visibile invisibilit delle psicosi (Roma 2000);
Tra teatro e follia (Roma 2001); Eco a me stesso. La metamorfosi schizofrenica di Holderlin in eco
(Roma 2002); Immagini della follia. La follia nellarte gurativa (Roma 2002); Vedere il Sosia. Le
emozioni come Doppio impensabile (Roma 2003); Ripensare la schizofrenia (Roma 2004); Un treno
per le stelle. Psichiatria e psicoanalisi senza (Roma 2006); La mente spiegata da Edvard Munch.
Psicoanalisi in dialogo con un artista (Roma 2009).
Indirizzo dellAutore: lucesegreta@libero.it
- 23 -
INTERVISTA
CONVERSAZIONE PARIETTI - MINERVINO*
*Questa conversazione, reperibile sul sito www.simpitalia, sostituisce la
serie delle nostre Interviste ai Personaggi. Siamo lieti di poter riproporre
questa conversazione a proposito del prossimo XXXIII Congresso Nazionale
della SIMP dal titolo Pregiudizio e Terapie, che si terr a Parma a maggio
2011.
PARIETTI: Parliamo del XXXIII Congresso Nazionale della SIMP che
stai organizzando a Parma per maggio 2011 e al quale hai dato il titolo di
Pregiudizio e terapie.
MINERVINO: Un congresso su pregiudizio e terapie e non solo sul
pregiudizio perch in questo caso larea tematica sarebbe stata pi difcile
da circoscrivere. Lidea nasce dallevidenza che qualunque atto terapeutico
ha a che fare tanto con lo specico meccanismo dazione quanto con tutta
una serie di variabili che possiamo indicare come aspeciche ma non per
questo meno importanti. Fra questi elementi cosiddetti aspecici uno molto
caro a noi della Simp la relazione, allinterno della quale quellatto tera-
peutico viene prescritto e ricevuto. Altri invece si riferiscono proprio alla
dimensione del pregiudizio. Pregiudizio in chi prescrive o propone latto
terapeutico e pregiudizio in chi quellatto terapeutico lo chiede e lo riceve.
PARIETTI: Pertanto il pregiudizio ha valenze tanto in senso positivo
che in senso negativo.
MINERVINO: Pregiudizio nel senso letterale di una valutazione preli-
minare, un giudizio che sta prima e che pu essere tanto un giudizio negati-
vo quanto un giudizio positivo.
PARIETTI: Ci si potrebbe chiedere che relazione c fra pregiudizio e
placebo.
MINERVINO: Il pregiudizio ha a che fare con il placebo tanto quanto
ha a che fare con qualunque altra forma o altro atto terapeutico. Infatti il
placebo viene usato come un atto terapeutico propriamente detto, quindi
pi suggestiva lidea che la dimensione del pregiudizio giochi molto sul
placebo ma senza avere una particolare specicit rispetto a quanto non lo
possa avere per qualunque altro atto terapeutico. E pur vero che il placebo
viene comunemente inteso come un atto terapeutico, la prescrizione e la
somministrazione di qualcosa che in teoria dovrebbe essere neutro, ma che
in realt produce un risultato. E noto invece che il placebo produce risulta-
ti tant che fa da riferimento in quasi tutte le sperimentazioni dei farmaci
e il valore riferito alluso del placebo sempre un numero signicativo il
che vuol dire che esattamente neutro non . Quindi il discorso del placebo
rimanda di pi agli elementi aspecici di una terapia piuttosto che al discor-
so del pregiudizio. Si pu pensare al placebo come allintenzionale volont
di un terapeuta di indicare o prescrivere un atto terapeutico che non faccia
nulla valutando pregiudizialmente lesito di questa azione.
- 24 -
PARIETTI: Il pregiudizio ha delle correlazioni col contesto culturale,
ambientale in cui si pu svolgere la terapia?
MINERVINO: Sicuramente il contesto e la cultura hanno uninuenza
sul pregiudizio. Si pu immaginare per esempio che in alcune culture anco-
ra improntate alla dimensione rurale o contadina determinati convincimen-
ti inducano a pensare pregiudizialmente che certi atti terapeutici siano pi
accettabili o meno accettabili, consentiti o non consentiti, rispetto ad altri
contesti culturali per esempio industrializzati o metropolitani allinterno dei
quali il pregiudizio si muove in direzione completamente opposta.
PARIETTI: Molto interessante diventa da questo punto di vista lanalisi
dei ussi dei migranti che attraversano lItalia e lEuropa.
MINERVINO: Certamente pregiudizio e terapie confrontati con il
fenomeno dei ussi dei migranti pongono questioni impegnative legate al-
lincontro non sempre felice fra culture molto diverse. Spesso succede che
noi, detentori della cultura ospitante rispetto alla cultura migrante, invece
di aprirci alla conoscenza dellaltro riteniamo che sia (pregiudizialmente)
corretto, dovuto, etico imporre allaltro quelli che sono i dispositivi che
connotano la nostra cultura ed il nostro modo di fare. Quando tutto ci poi
si trasforma nelle pratiche delle salute e quindi nelle terapie i problemi
possono diventare drammatici perch anche nelle culture che ospitiamo
esistono pregiudizi in termini positivi o negativi di cui noi non siamo asso-
lutamente a conoscenza. Di quelle culture per noi straniere non solo non
conosciamo gli elementi costituitivi ma ne ignoriamo anche i risvolti pratici
e comportamentali. Da ci nasce il bisogno di assumere atteggiamenti di
distanza prodotti quindi dalla nostra ignoranza e dalla paura del diverso.
C troppa poca curiosit e troppa poca cultura dellaccoglienza e la scena
spesso si riempie di sordi e di muti. I migranti sono portatori di un bisogno
di salute spesso difcile da interpretare; esprimono, quando ce la fanno e
per quanto distorte, domande che se prese in considerazione ci consentono
di imparare a conoscere i nostri pregiudizi, a conoscere i loro e a creare un
dialogo.
PARIETTI: Proprio per questo motivo parte dei lavori del congresso
sar ad impronta antropologica e sociologica.
MINERVINO: Infatti noi dobbiamo chiedere alle altre culture e alle
altre scienze umanistiche di aiutare i professionisti della salute a creare un
contesto allinterno del quale i propri atti terapeutici ed i propri comporta-
menti ritrovino un senso che non sia solo quello di una magica ed onnipo-
tente capacit tecnologica, ma anche quello di una capacit di accoglienza.
PARIETTI: Un Congresso di psicosomatica che si porr lobiettivo, fra
gli altri, di produrre nuovi stimoli e nuove aperture.
MINERVINO: E un Congresso che vuole ripescare uno dei paradigmi
fondanti la psicosomatica italiana, la psicosomatica secondo la Simp: il pa-
radigma relazionale. La relazione col proprio paziente, ma anche le relazioni
con le altre discipline, con le altre culture, con gli altri saperi. Potremmo
- 25 -
dire che in fondo coltiviamo lambizione di un nuovo Rinascimento nella
misura in cui rinascimentale un atteggiamento che mette insieme culture,
saperi, esperienze attorno alla dimensione umana.
PARIETTI: Superare quindi anche il pregiudizio verso la psicosomatica.
MINERVINO: Questo certamente un passaggio molto importante. Il
pregiudizio sulla psicosomatica sempre stato quello che faceva della psico-
somatica una disciplina il cui oggetto era in sostanza lignoranza della medi-
cina. La psicosomatica come disciplina che si occupa della sofferenza delles-
sere umano per difetto, nel senso di occuparsi di tutto ci che la scienza non
riesce a ricondurre nelle proprie categorie diagnostiche o negli ambiti della
propria conoscenza. Questa ignoranza diventa lelemento costitutivo della
psicosomatica. Naturale quindi che loggetto della psicosomatica, nato dal-
lignoranza, susciti disprezzo e difdenza cos come poco amati sono sempre
stati i cosiddetti pazienti psicosomatici e poco amata stata la diagnosi psi-
cosomatica dai pazienti. E forse pi naturale pensare che si abbia a che fare
con la paura suscitata dallavere a che fare con fenomeni che non rientrano
nella nostra conoscenza. Questo atteggiamento pregiudiziale ha impedito
per troppo tempo al sapere psicosomatico di essere utilizzato come una
risorsa per approcciare una vasta dimensione della sofferenza delluomo. Di-
mensione resa esplicita dai dati epidemiologici che indicano quanto alta sia
la presenza di questo genere di sofferenza nei circuiti della sanit.
PARIETTI: Dobbiamo quindi lavorare per una nuova prospettiva che
dia alla psicosomatica la possibilit di esprimere tutte le proprie potenzialit
con ricadute positive in ambito sanitario, sociale ed economico, visto che
un approccio psicosomatico consente non solo una efcace azione di pre-
venzione e di cura ma anche un contenimento dei costi data la presenza di
numerosi pazienti psicosomatici fra i cosiddetti alti utilizzatori.
MINERVINO: Ci sono molti aspetti da questo punto di vista che van-
no riportati allattenzione di tutti. Il primo quello che citavi tu: introdurre
buone pratiche nellerogazione delle prestazioni sanitarie, nelle risposte
alla sofferenza. Si tratta di introdurre quella che potremmo indicare come
una formula felice, per la quale il portatore di un bisogno trova una risposta
compiuta e lerogatore della risposta trova unefcacia in ci che fa con un
incremento della soddisfazione professionale. Ancora oggi spesso la formula
piuttosto quella che produce infelicit dato che lincontro tra chi porta
un bisogno spesso poco compreso e lerogatore di una prestazione spesso
troppo poco efcace. Formula che produce soprattutto alti consumatori dei
sistemi sanitari e burn out. Dedicare un congresso al tema del pregiudizio e
delle terapie consente di portare attenzione a fenomeni di questo tipo. Ma
attenzione va data anche al pregiudizio su certe categorie di farmaci, come
i farmaci per la salute mentale o per altre patologie. Ci comporta una li-
mitazione del loro uso appropriato e dellaccesso a questo genere di risorsa
da parte di pazienti che ne avrebbero bisogno. Il pregiudizio getta ombra
sulluso di molte terapie non solo farmacologiche ma anche siche: ancora
troppo poco apprezzate sono le potenzialit della medicina sica e quanti-
stica. Quanti di noi conoscono, pur avendoci a che fare quotidianamente,
limportanza dellacqua? Ma il pregiudizio esercita analoga forza anche ne-
- 26 -
gli atteggiamenti e nei comportamenti dei portatori del bisogno di terapia.
Ci si rif al discorso iniziale: chi entra nel circuito delle prestazioni sanitarie
ritiene di sapere a secondo del proprio percorso, della propria cultura, della
propria famiglia che determinate cose che possono essere fatte per fargli
riconquistare la salute sono buone o non buone, chiedibili o non chiedibili.
Chi opera nella sanit spesso si dimentica che esiste una cultura della salute
che tipica della famiglia. Ogni famiglia crea una cultura della salute per cui
nei suoi armadietti dei farmaci o nelle sue pratiche della salute esistono cose
che sono tipiche per lei e che per i suoi componenti costituiscono un costan-
te riferimento. Si tratta di una variabile importante che incide sulla possibi-
lit che quello che io prescrivo sia pi o meno sintonico con quellambiente
culturale e familiare e che pu renderlo efcace o no, accessibile o no.
PARIETTI: Parliamo ora del pregiudizio verso la psicoterapia, pregiu-
dizi presenti tanto negli operatori quanto nei pazienti legati alla difcolt ad
aprirsi a dimensioni psicologiche, emotive e relazionali. E non bisogna igno-
rare i pregiudizi presenti anche nellambito della psicoterapia come quelli
esercitati da un approccio psicoterapico nei confronti di altri approcci. La
stessa psicoanalisi stata allinizio oggetto di pregiudizi anche molto ostili,
di cui anche la psicosomatica ha risentito.
MINERVINO: Certamente bisogner porre attenzione alle psicoterapie
e tener conto delle evidenze sempre pi forti della efcacia dei trattamenti
integrati. Daltro canto bisogner impegnarsi e portare attenzione al pregiu-
dizio esercitato su alcune categorie diagnostiche: per citarne solo alcune si
pu indicare la follia, il dolore, il cancro. Sicuramente si tratta di categorie
che prestano molto pi facilmente il anco allazione del pregiudizio. In
realt bisogna evitare il rischio di lasciare in ombra il discorso per il quale
ogni forma di sofferenza e di malattia pu risentire negativamente dellazio-
ne del pregiudizio. Bisogna quindi puntare per insistere su un discorso caro
allapproccio psicosomatico secondo la Simp, per il quale in una relazione
consapevole e competente che il rischio del pregiudizio pu stemperarsi.
La competenza relazionale un dispositivo che pu far s che gli elementi
di pregiudizio, presenti tanto nel terapeuta quanto nel paziente, possano
essere portati alla visibilit, alla trasparenza, alla consapevolezza. Se gli attori
della scena della terapia sono in una dimensione dellincontro e sono in un
ambiente relazionale sufcientemente sano allora gli aspetti pregiudiziali e
pregiudizievoli si stemperano. Quindi lambizione non solo quella di in-
crementare la dimensione del sapere rispetto alla questione del pregiudizio
ma di trasformare questa consapevolezza del sapere in un atto, in uno stare
in terapia che tenga conto di queste cose.
- 27 -
RIFLESSIONI E COLLOQUI
IN UN CENTRO DI TERAPIA DEL DOLORE*
Pierluigi Ciritella
1. Introduzione
Il dolore uno dei problemi pi importanti dellumanit. Il dolore
acuto utile perch avverte lindividuo di qualsiasi anormalit e costituisce
un mezzo diagnostico per il medico; tuttavia nella sua forma patologica cro-
nica, impone gravi sollecitazioni emozionali e siche al paziente ed alla sua
famiglia (Bollica J., 1984). Ci ancora pi vero e pressante quando ad amma-
larsi e a soffrire un bambino: al dolore del bambino ladulto non preparato.
Lospedalizzazione del bambino unesperienza molto stressante sia per il
bambino sia per i genitori; lidea della malattia e della sofferenza associata
al bambino difcile da accettare, assurda. La possibilit che un bambino
possa essere in pericolo di vita a causa di una grave malattia, possa soffrire,
risulta a chiunque crudele e del tutto inaccettabile e per gli adulti spesso
difcilmente comprensibile, e non lascia emotivamente indifferente nemme-
no chi, per scelta professionale, si confronta quotidianamente con questa
realt. Prova n che, nonostante i primi studi sulle reazioni psicologiche
del bambino allesperienza della malattia e del dolore risalgano agli anni 30
con le osservazioni di Anna Freud, linteresse per la conoscenza del dolore
nel bambino e per il suo trattamento risale solo allultimo decennio. Infatti,
se per ladulto sono state condotte ricerche sempre pi approfondite, per il
bambino sono ancora in vigore i miti secondo i quali la sensibilit infantile
al dolore sarebbe minore di quella delladulto e il bambino non sarebbe ca-
pace di memorizzare tali percezioni n di organizzare adeguate reazioni di
difesa contro di loro. Tutto ci ha fatto s che il dolore del bambino fosse ne-
gato con il risultato che le istituzioni non hanno creato, se non in pochissimi
casi, strutture dedicate al problema. Eppure il bambino possiede gi in et
molto precoce coscienza della propria condizione di malattia e della gravit
del proprio stato, la sente nel corpo e pi ancora la riconosce nellespres-
sione degli adulti signicativi per lui. Pertanto il trattamento del dolore del
bambino rappresenta una vera e propria sda vista la quasi totale assenza
di punti di riferimento e di esperienze ma, soprattutto, per lintenso carico
emozionale ad esso legato. Affrontare il dolore del bambino vuol dire tener
presenti diverse prospettive: intorno al bambino che soffre ruota una galassia
di persone, ciascuna con i suoi stati danimo, e ciascuna di esse apporta pi
o meno inconsapevolmente sollievo o altra sofferenza. I genitori vivono la
malattia del loro glio come un disperato bisogno di dare amore (ma anche
di riceverne e di essere sostenuti a loro volta), il che si traduce spesso in una
forma di iperprotezione; si trovano nellincapacit di comprendere ed accet-
tare le comunicazioni dei sanitari: sono disorientati ed increduli, impotenti
e disperati. Si difendono nella negazione: lincredulit alla diagnosi si espri-
me nel suo riuto ed il genitore oppone tutte le energie alla realt dolorosa
e spesso anche a coloro che la propongono con altrettanta veemenza. Ci
pu rendere difcili i rapporti con i medici e gli infermieri, facile bersaglio
di critiche nella disperata ricerca di trovare disconferme alla realt. Quando
- 28 -
inizia a farsi strada una qualche accettazione della realt i genitori comincia-
no a cercare delle spiegazioni sulle cause della malattia: incomprensibile
che il loro glio sempre sano sia ora cos malato e soffra cos tanto.
2. Genitori e bambini
Nei casi in cui possibile individuare una causa specica i genitori si
interrogano sul perch tutto questo stia accadendo proprio al loro bambino,
quando invece leziologia sconosciuta si aggiunge altra incertezza ed ansia
per il non sapere - n loro n i curanti - esattamente cosa stia succedendo.
Sotto il peso di queste penose emozioni il genitore regredisce, diventa de-
bole, vulnerabile e indifeso, bisognoso egli stesso di sostegno e protezione,
vittima di un aggressore esterno indistinto e indistinguibile al quale non pu
sottrarsi, n sa come farvi fronte. Il reparto, i medici, gli infermieri, sono
facilmente fatti oggetto di queste ansie persecutorie e accusati di volta in
volta di essere freddi, insensibili, distanti e punitivi, col rischio che si venga
a creare un clima di conittualit. E necessario che nel colloquio queste
ansie siano verbalizzate e comprese, accettate e non restituite con aggres-
sivit, come spesso accade, mascherate sotto forma di regole e divieti solo
in apparenza tesi ad una migliore assistenza sanitaria al bambino e che im-
pediscono, invece, ai genitori di collaborare attivamente alla gestione delle
pratiche terapeutiche e alle cure corporali del glio. Per contrastare tali rea-
zioni necessario incoraggiare i genitori a stare vicino al proprio bambino;
questo rafforza la loro ducia nella capacit di essere ancora bravi genitori,
amorevoli, efcaci e competenti. Attraverso la rassicurazione e la conferma
delle loro competenze genitoriali si favoriscono inoltre lalleanza terapeuti-
ca, la capacit di collaborare con il personale, evitando cos che il bambino
sia strumentalizzato dai bisogni degli adulti: di controllo, di onnipotenza, di
sicurezza, di stima. Il colloquio diventa dunque unoccasione per offrire so-
stegno ai genitori sollecitandoli allassistenza del bambino, ed insegnandogli
le modalit diverse di prendersi cura e comunicare col loro glio, inconsa-
pevolmente sollievo o altra sofferenza.
3. Il corpo: il nemico esterno
Qualunque cosa avvenga negli organi interni, o qualunque cosa acca-
da al suo corpo, le esperienze di dolore, tensione, bisogno, disagio, il bambi-
no tender ad attribuirle ad agenti esterni e a viverle in modo persecutorio.
Il bambino non sente in altre parole i suoi dolori sici come la conseguenza
di accadimenti interni, ma di unaggressione o, quantomeno, di una man-
canza di protezione da parte dellesterno e perci si sente nel dolore trattato
male, minacciato, punito, in pericolo. Dolori sici anche molto intensi, tera-
pie invasive, la stessa ospedalizzazione, possono essere meglio sopportati dal
bambino nch non siano caricati di angosce e di paure legate ai signicati
che al dolore stesso sono attribuiti (abbandono, riuto, punizione, colpa,
ecc.). Quando langoscia aumenta, il dolore diventa per il bambino un avve-
nimento traumatico e insopportabile, del quale si ricorder a lungo e contro
la cui ripetizione cercher di proteggersi con meccanismi di evitamento o di
tipo fobico. Di fronte allesperienza di malattia e dolore il bambino tende
a regredire, si fa pi piccolo, bisognoso di maggiore protezione e conteni-
mento anche sico da parte della madre, solitamente lunica in grado di
- 29 -
salvaguardarlo e di difenderlo. Questa regressione ha come conseguenza
un aumento della dipendenza, anche quando un certo grado di autonomia
era gi stato raggiunto (es. perdita del controllo snterico, bisogno di essere
lavato, imboccato, ecc). La malattia induce una brusca trasformazione del
modo di considerare e trattare il corpo del bambino: prima oggetto di tene-
rezza e cure delicate, ora assoggettato a disposizioni incomprensibili, fatto
bersaglio di misure terapeutiche, talora con scarso rispetto delle esigenze di
riservatezza e di gestione autonoma del proprio corpo. Anche le manovre te-
rapeutiche sono percepite come attacchi alla propria incolumit, il bambino
reagisce in genere nella fase iniziale opponendosi energicamente ai tratta-
menti con angosciosa protesta, rabbia, sentimenti dira e vendetta, fa seguito
un migliore adattamento quando entrano in azione i meccanismi di difesa e
in particolare la funzione protettiva della regressione simbiotica. Al protrarsi
delle cure, inoltre, possono subentrare sentimenti di angoscia legati al timo-
re che la situazione non abbia ne, vissuti che si traducono in abbattimento,
stati depressivi, sensi di colpa e atteggiamenti di sottomissione passiva. Simili
reazioni si osservano in genere quando prevale nei bambini il sentimento
di essere inutilmente aggrediti anzich curati ed a ci reagiscono con un
atteggiamento di chiusura, riuto, disperazione. Ladolescente, invece, vive
la sua sventura in maniera particolare: ci potr essere un abbandono pi
o meno totale di ogni tentativo di autonomia e il ragazzo ritorner bambi-
no instaurando di nuovo quei rapporti di dipendenza parentale che aveva
abbandonato o stava per abbandonare, altrimenti si sentir offeso, tradito
e tenter di colpevolizzare ladulto riutando tutto quanto proviene da lui,
con il solo risultato di chiudersi in un ostinato e tragico isolamento. Qualsia-
si rapporto con gli altri caratterizzato da improvvisi cambiamenti dumore,
pu essere aggressivo e disperato, indifferente o timido, riutare qualsiasi
forma di conforto, oppure lasciarsi andare a lunghi pianti silenziosi. Lango-
scia del ragazzo pi profonda e grave di quella del bambino: egli vive senza
poterla comunicare, la paura della malattia e della morte. Uno dei drammi
pi sconvolgenti per ladolescente, costituito dal fatto che la malattia e le
cure che questa comporta ledono la sua integrit corporea, la sua bellezza;
spesso perde i capelli a causa della chemioterapia, talvolta quel corpo cui tie-
ne tanto deturpato da cicatrici, il dimagrimento, la spossatezza, la febbre,
il dolore stesso, accano ogni sua voglia di fare.
4. Le relazioni con gli altri
Ogni tentativo di relazione sociale viene in questo modo abolito e la
malattia vissuta con rabbia e disperazione. Gli operatori non tollerano di
essere percepiti solamente come aggressori, ma intanto, lemotivit del bam-
bino espressa in modo dilagante induce loperatore non psicologicamente
formato ad essere aggressivo. Questo si realizza in vari modi: attuando rispo-
ste punitive sul piano sico (manovre costrittive e violente durante lesecu-
zione delle procedure o scarsa o nulla attenzione al dolore), su quello verba-
le (affermazioni che mirano ad ottenere la collaborazione del bambino ma
che hanno un tono o un contenuto minaccioso, per es. se non smetti di agitarti
ti far ancora pi male) o su quello emotivo (procedure effettuate in un clima
di distacco, freddezza, silenzio difensivo). In tal modo il medico e linfermie-
re vanno davvero ad impersonare il ruolo fantasticamente attribuito loro dai
- 30 -
bambini, che vedono cos confermati e rinforzati i loro sentimenti di timore
e di rabbia. Queste vicende, e soprattutto le procedure mediche, sono in
grado di produrre reazioni comportamentali patologiche anche durature.
Le procedure terapeutiche, infatti, hanno per il bambino una valenza nega-
tiva e producono un effetto di disagio e, di conseguenza, una reazione op-
positiva. Di solito il bambino si aspetta di ricevere stimoli avversivi sulla base
del proprio comportamento, qui invece, la sofferenza incomprensibile,
quasi gratuita. Inoltre i comportamenti del bambino usualmente efcaci nel
produrre la cessazione di uno stimolo avversivo, come ad esempio piangere,
protestare, o mostrarsi condiscendenti, non hanno adesso efcacia nellevi-
tare le valenze vissute come inspiegabilmente punitive delle procedure me-
diche. Gli stimoli avversivi che il bambino riceve sono quindi indipendenti
dalla risposta: qualsiasi cosa far non avr modo di sottrarsi a loro, n potr
in alcun modo prevedere quando levento negativo si vericher. Inoltre
poich il personale medico - infermieristico ad effettuare le procedure,
esso diventa di per s un elemento negativo e gi da solo sar in grado di
provocare la reazione oppositiva del bambino che comincer a piangere e a
dimenarsi disperatamente anche alla sola vista di un camice bianco. Qui la
soluzione non tanto ridurre gli stimoli avversivi (le cure devono comunque
essere effettuate secondo schemi e protocolli per il suo bene), ma piutto-
sto aumentare il numero di stimoli positivi che sono forniti (contatti visivi,
interazioni verbali, gesti di affetto) in modo che il personale non sia legato
solo ad esperienze negative.
5. Esperienze nel Centro
Verr qui proposta lesperienza in un centro di terapia del dolore del-
let pediatrica ed evolutiva. Il Centro stato costituito nellottobre 2002 e
lavora con bambini ospedalizzati per gravi malattie. Al momento della stesu-
ra di questa relazione, sono stati presi in carico 15 pazienti di et compresa
fra 4 e 17 anni, 9 maschi e 6 femmine, affetti da malattie ematologiche (leu-
cemie e linfomi) o neoplasie solide. Tutti i piccoli pazienti lamentavano do-
lore di vario tipo ed intensit. La pi anziana di questo piccolo gruppo di
ammalati, della quale si dir pi estesamente dopo, presentava anche unim-
portante condizione di depressione reattiva. Il lavoro con il bambino amma-
lato pi complesso e sensibilmente differente rispetto al trattamento del
dolore nelladulto. Mentre questultimo si rivolge direttamente al terapeuta,
per il bambino lintervento richiesto in genere da altri medici. Nelladulto
il rapporto medico - paziente diretto e non vi sono interferenze importan-
ti, nel bambino tale rapporto diventa medico - famiglia e le interferenze co-
stituiscono la prassi. Perci al momento della richiesta di consulenza algolo-
gica partecipano sempre, in una prima fase preliminare, il bambino, i geni-
tori ed il medico del reparto che lo ha in carico. Sono cos presenti tutte le
gure signicative che curano il bambino. Molto spesso il medico del repar-
to, che peraltro viene periodicamente informato dello svolgimento della te-
rapia del dolore e dei risultati, vede con soddisfazione lintervento dellalgo-
logo e volentieri diluisce con lui la responsabilit e il peso, non solo terapeu-
tico ma anche e soprattutto emotivo, del caso. Il coinvolgimento dei geni-
tori fondamentale sia nellinstaurare la necessaria collaborazione per il
buon esito della terapia, sia perch sostenendoli con un ascolto emotiva-
- 31 -
mente partecipe ed un comprensivo accoglimento, si ottiene un comporta-
mento meno aggressivo, meno ansioso ed ansiogeno a tutto vantaggio del
benessere del bambino. Il colloquio si svolge in una stanza tranquilla e con-
fortevole dove il bambino ed i suoi genitori si trovano a loro agio. Voluta-
mente non indosso il camice, n divise di lavoro: non servono ma, soprattut-
to, il bambino pu percepire la mia presenza come quella di un dottore di-
verso dagli altri. Lilluminazione diffusa nelle ore pomeridiane mentre
unampia nestra consente lingresso di luce naturale nelle ore diurne. Lar-
redamento sobrio ed in colori pastello, una sala giochi attrae lattenzione
dei pi piccoli. In ogni caso il colloquio si svolge alla presenza di entrambi i
genitori e del piccolo paziente e la sua durata non pi lunga di 30-35 mi-
nuti. Durate superiori affaticano gli interlocutori e possono dare la sensazio-
ne di voler sapere tutto e decidere tutto, tutto in una volta e una volta per
tutte: il giorno dopo si pu sicuramente continuare ed anche la frequenza
degli incontri favorisce la crescita di una relazione. In genere, superata una
breve fase sociale di conoscenza reciproca, i genitori descrivono i sintomi
del loro piccolo ed in particolare le caratteristiche del dolore. I pi grandi-
celli descrivono qualche volta da soli il loro problema. In questa prima fase
pongo lattenzione sulla postura degli adulti e del bambino e sugli aspetti
emotivi con cui informazioni apparentemente solo tecniche, vengono
espresse. C chi espone tutto in maniera meticolosa, chi, invece, tralascia i
particolari, descrive a grandi linee i problemi e si chiude nel silenzio, o, in-
vece, preso dallangoscia, esplode in un pianto dirotto e cerca solo conforto
e rassicurazioni. Attraverso laiuto di semplici scale algometriche, fra cui
lanalogo visivo del dolore (VAS), cerco di quanticare, per quanto possibi-
le, il livello di dolore avvertito dal piccolo paziente. Questo espediente un
semplice ed orientativo punto di riferimento per una verica longitudinale,
nel tempo, dellandamento della terapia, ma soprattutto un pretesto per
cominciare a parlare col bambino e non pi del bambino. Anche in questa
fase osservo i comportamenti del piccolo paziente. In questo modo, cercan-
do di conquistare la ducia di bambino e genitori, il colloquio va avanti. La
necessit di trattare il dolore richiede da subito una prescrizione farmacolo-
gica. Lefcacia di tale prescrizione costituir un altro momento di incontro
e di discussione. Ultimata la serie iniziale di colloqui, in genere due o tre, la
cadenza diventa bisettimanale e poi settimanale. Inizialmente le richieste dei
genitori sono di rassicurazione, di sostegno, di ulteriori informazioni. In se-
guito, una volta ottenuto un ruolo attivo e collaborativo, i colloqui serviran-
no a vericare landamento della terapia e ad accompagnare bambino e ge-
nitori lungo la difcile strada dellevoluzione della malattia che, purtroppo,
non sempre trova un esito positivo. Il colloquio per la terapia del dolore in
apparenza non si discosta molto dal colloquio medico convenzionale. Anche
qui come l si raccolgono dati anamnestici, informazioni cliniche e di labo-
ratorio, immagini radiologiche e di altri esami, ma qui lattenzione anche
orientata ad un ascolto di ci che emotivamente viene trasmesso con la pre-
sentazione dei dati. Lattenzione al bambino durante il colloquio costante
anche se spesso non possibile condurre con lui un vero e proprio dialogo,
ma i suoi atteggiamenti, il pianto o il suo modo di lamentarsi indirizza alla
giusta comprensione della dimensione del problema. Altre volte si osserva
una discrepanza fra lentit del dolore e la sua espressione. Dolori allappa-
- 32 -
renza lievi o moderati (ad es. uniniezione) sono vissuti con angoscia, e non
si tratta solo di bassa soglia al dolore! Spesso lansia dei genitori scatena inar-
restabili crisi di pianto disperato che, a loro volta, determinano un ulteriore
aumento dellansia in un circolo vizioso che possibile spezzare solo con un
comportamento da parte del medico comprensivo e nello stesso tempo au-
torevole (non autoritario!) in una relazione che afanchi alla modalit ma-
nipolativa (io so quello che bene per te) anche quella identicatoria
(mi metto nei tuoi panni). Alcune settimane dopo lapertura del Centro,
nellincontro mattutino con i colleghi del Reparto, mi viene proposto un
caso difcile. Si tratta di Laura, una ragazza di 17 anni ricoverata per una
brutta recidiva di leucemia, malattia di cui aveva gi sofferto sette anni pri-
ma superandola senza grossi problemi. Aveva ripreso la scuola e la vita di
tutti i giorni. La fase di remissione era durata sette anni: un periodo cos
lungo da far pensare ad una guarigione denitiva. Invece la febbre, la spos-
satezza, il sanguinamento dalle gengive e dal naso, avevano drammaticamen-
te riportato Laura a quando, sette anni prima, ancora bambina, fu ricoverata
durgenza dal padre medico, angosciato e impotente. Allora non capiva
bene cosa le stesse accadendo, era solo tanto spaventata. Ma adesso Laura
vive in prima persona il suo dramma ed ogni passaggio della sua malattia e
della necessaria terapia hanno il sapore di un amaro e pauroso dej vu. I col-
leghi che le curano la leucemia sono molto preoccupati, colgo in loro la s-
ducia e quasi la rassegnazione: il trattamento delle recidive spesso non co-
ronato da successo, in pi la forma di Laura sembra anche essere particolar-
mente resistente alla terapia; a tutto questo si aggiunge che la ragazza riuta
le cure! Sarebbe necessario impiantare sotto pelle un piccolo catetere in sili-
cone per infondere direttamente in una grossa vena del torace i potentissimi
farmaci chemioterapici. Un intervento che dura non pi di mezzora, ma
che Laura ostinatamente riuta di effettuare. Raccolgo queste informazioni
in maniera distratta, quello che mi colpisce pensare alla sfortuna di Laura,
al suo dolore, alla sua rabbia e mi chiedo quale sia il signicato del riuto di
curarsi, e cosa posso fare io per lei. Laura una bella ragazza, ha lunghi ca-
pelli castani ed un paio di occhioni neri che risaltano ancora di pi nel volto
reso pallido dalla leucemia. distesa sul letto della sezione sterile, girata su
un anco, assistita dal padre che ha laria stanca e spaventata. Ha combattu-
to tanto insieme alla glia ma alla ne deve arrendersi di fronte ad un nemi-
co invisibile, incomprensibile, imbattibile. Mi dice che Laura non vuole sa-
perne di mettere il catetere venoso, ha paura, sono giorni che non parla. Mi
presento a Laura e le chiedo, banalmente, come sta; la sua prevedibile rispo-
sta male!. Provo a chiederle della scuola: frequenta il liceo classico. Non
faccio altre domande, n lei le fa a me. Rimango ancora un po in silenzio
accanto a lei. Prima di andare via le passo una mano sui capelli. Quel gesto
spontaneo ed istintivo non lha infastidita, anzi ho avuto la sensazione che lo
avesse gradito. La saluto, saluto il padre rimasto in anticamera e preannun-
cio che ci saremmo visti lindomani. Il giorno successivo ritorno da Laura:
ha la febbre alta e le guance sono rosse e congeste. Ho pensato molto allin-
contro ed alla carezza e penso che lunico sistema per comunicare con Lau-
ra sia il contatto: per un quarto dora le accarezzo i capelli, il volto, il collo,
le braccia, le mani, le gambe. Lei mi fa fare, il padre non capisce, ma la sua
sensibilit gli fa intuire che qualcosa accade: Laura non riuta il contatto,
- 33 -
pur nel suo silenzio. Ogni giorno per un quarto dora il mio incontro era
ormai codicato: un appuntamento con il suo corpo tornato quello di una
bambina piccolissima, di pochi mesi incapace di parlare, che ora come allo-
ra ha bisogno di essere accudito e accarezzato. Mentre laccarezzo le parlo,
proprio come potrebbe fare una mamma mentre fa il bagnetto al suo picco-
lo. Le parlo dellinverno, di quello che succede fuori della sua cameretta
sterile, ma anche di lei e del fatto che mi piace star l con lei. Dopo quattro
giorni di incontri mi assento per due giorni di ferie ma dimentico di prean-
nunciarle la mia assenza. Quando ritorno Laura arrabbiata con me, vuol
sapere perch sono andato via senza dirglielo e che aveva fatto chiedere di
me nel timore che non tornassi pi. Mi scuso con lei e le faccio notare che
non tutti i mali vengono per nuocere visto che le ritornata la parola. Lei
accenna ad un sorriso. Riprendo le carezze e questa volta scoppia in lacrime
confessandomi tutta la paura di morire e di morire nel dolore, mi dice con
disperazione questa volta non ce la faccio. La sua angoscia tagliente, non
resisto pi di un quarto dora con lei. Lindomani ritorno a trovarla mentre
devastata dalla febbre scuotente. uno straccio, mentre laccarezzo sento
che brucia, la sua pelle mi sembra anche pi sottile. Le propongo di mettere
il catetere. Non mi risponde ma il suo silenzio questa volta ha un senso diffe-
rente. Il giorno dopo Laura mi accoglie con una maschera di disperazione,
io sono inquieto, so che se non comincia subito la terapia, non avr ancora
molto tempo e ancora una volta le ripropongo limpianto. Questa volta lei
acconsente ma alla condizione che sia io stesso ad effettuarlo.
6. Conclusione e riessioni
Dopo limpianto Laura comincia la terapia che, per, come previsto
dai colleghi, non molto efcace, anzi una grave complicanza si aggiunge
alla leucemia minacciandole gravemente i polmoni. La ragazza rischia seria-
mente di morire non tanto per la leucemia ma per laspergillosi polmonare.
Il padre disperato: si sente impotente come padre e fallito come medico.
I suoi sensi di colpa lo rodono, pensa di essere responsabile per non aver
saputo proteggere e curare la glia. Dopo il quarto dora con Laura, mi trat-
tengo nella mia stanza col padre per ascoltare il suo dolore e la sua angoscia.
Con me dice di sentirsi meglio, sa che non potr fare molto per Laura, ma
sa anche che ci che sto facendo forse lunica cosa da fare. Intanto levolu-
zione della malattia di Laura continua, non d segni di arresto. Adesso la
ragazza avverte anche forti dolori ossei e muscolari e necessita di analgesici
sempre pi forti, respira male, a fatica, il conne tra la vita e la morte ades-
so diventato sottile. Continuo a vedere Laura e, nella mia stanza, il padre.
Ogni volta questi incontri mi lasciano privo di forze, come se le mie si trasfe-
rissero a loro ed io ne rimanessi svuotato. In uno dei nostri incontri, sempre
di poche parole, fatti soprattutto di contatti, Laura si interessa a me e chiede
incuriosita perch ho un approccio tanto diverso dagli altri medici a lei ed
alla sua malattia. La invito a fare delle fantasie, le chiedo perch le sembro
diverso. Mentre parla dice di avere dolore e vuole un dosaggio supplementa-
re di analgesico e quindi chiama linfermiera. Continua a parlare e parla di
s, della scuola che le manca, della voglia di andare sulla neve, del fatto che
le sono simpatico; per la prima volta Laura parla e, soprattutto non parla
della sua malattia. Dopo un po arriva linfermiera con lanalgesico, ma non
- 34 -
serve pi, Laura dice che non ha pi dolore e che le bastato parlare per
sentirsi meglio. Da quel giorno Laura ha gradualmente, insperatamente, co-
minciato a migliorare il suo stato di salute e dopo oltre tre mesi di degenza
ha lasciato lospedale con una remissione della leucemia ed un nettissimo
miglioramento della polmonite. Prima di andar via voluta venire a salu-
tarmi nel mio studio per ricambiare almeno una delle tante visite: com-
pletamente calva a causa della chemioterapia, si reggeva a mala pena a due
stampelle, ma il suo volto era di nuovo illuminato da un sorriso. La mente
e il corpo in ununica visione, globale e sincretica: calva e col sorriso, mi
ripetevo nei diversi giorni dopo lultima volta che lho vista.
Per quanto riguarda la concezione dellunit psicosomatica vorrei con-
cludere con le parole del libro Dottore, posso guarire?, di G. Gastaldo e M.
Ottobre: Non esiste una funzione del Sistema Nervoso che non implichi,
direttamente o indirettamente, anche le funzioni degli altri apparati. Non
esiste un mutamento di qualsiasi altro apparato che non inuenzi il S.N.,
non esiste nessun mutamento di questultimo che non comporti un riassetto
dellintero nostro essere (2002).
BIBLIOGRAFIA
1. Agresta F., (2010), Il Linguaggio del Corpo in Psicoterapia. Glossario di Psicosomatica, Al-
pes, Roma;
2. Anzieu D., (1994), LIo-pelle, Borla, Roma;
3. Bonica J., (1980), Pain, Raven Press, New York;
4. Cataldo M.F., Bessman C.A., Behavioural assessment for paediatric intensive care unit, Appi.
Behav. Analysis, 19/9; 2:83-9;
5. Ercolani A., (1997), Malati di dolore, Zanichelli, Bologna;
6. Freud A., Bergman A., (1978), Bambini malati: un contributo psicoanalitico alla loro compren-
sione, Boringhieri, Torino;
7. Kreisler L., Fain M., Soul M., (1976), Il bambino e il suo corpo, Astrolabio, Roma;
8. Gastaldo G., Ottobre M., (2002), Dottore, posso guarire?, Armando, Roma, rist. 2007.
P.L. Ciritella Medico, Anestesista e Counselor di indirizzo psicanalitico. tra i soci
fondatori dellASSIR, Referente del Centro di Terapia del dolore e dellet pediatrica ed
evolutiva dellIRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di S. Giovanni Rotondo (FG).
* La presente relazione, aggiornata e rivisitata, stata presentata al II Convegno Mente-
Corpo, Francavilla a mare (CH) il 25/26 aprile 2003, organizzato dalla SIMP Abruzzese e
Pescarese (Dott. R. Di Donato e F. Agresta e Coll.), Hotel Villa Maria, San Silvestro (Pesca-
ra). Atti del Convegno (a cura) di F. Agresta, R. Di Donato, Atti del Convegno in, Prospet-
tive in Psicologia (Supplemento, n. Aprile, 2003).
Indirizzo dellAutore: Dott. Pierluigi Ciritella
Via Trieste, 46 - 71100 Foggia
- 35 -
DALLA MITOLOGIA ALLANTROPOLOGIA:
LA RISATA DEGLI DEI PUO FAR RIFIORIRE LA TERRA?... *
Alfonso M. di Nola
(a cura di) Andrea Mosca
Ride Apollo, ride Hermes, ride ciascuno degli di
e il loro riso trasmette sostanza alle cose intramondane
e d energia ai legamenti di esse
Platone, Timeo
In molti miti, quando la divinit diventa triste e cessa di ridere i campi
si seccano e le messi muoiono; solo il riso del dio far rinascere la terra. Ed
una risata il mezzo con cui, in tradizioni diverse, luniverso viene creato.
Il discorso antropologico sul riso non facile, n agevolmente riassumibile.
Il riso, infatti, diviene signicante non come manifestazione siologica, ma
come segnale psicologico e culturale. La modicazione del piano mimico-
facciale o anche dellintero piano organico (scuotimento del corpo a causa
del riso) diviene rilevante a livello di psicologia individuale e di intercomu-
nicazione sociale soltanto perch esprime messaggi che ne sono prelimine
e contenuto. In tale senso gli animali non ridono o, se anche atteggiano la
propria immagine corporea a variazioni muscolari simili al riso umano, non
ci trasmettono particolari messaggi, n possiamo immaginarli come preli-
mine del loro presuntivo ridere. Le strutture siologiche proiettano cio, un
universo interno, emozionale, ideativo, che dovrebbe essere di volta in volta
decodicato per essere compreso al di l del riso che veicola.
In effetti, le diverse espressioni facciali sono connesse alle diverse
emozioni (Ekman, 1992; Izard, 1971, 1997). Queste non solo indicano lo
stato emotivo di una persona ma ne inuenzano anche le componenti sio-
logiche soggettive. In uno studio classico, i ricercatori dissero ai partecipanti
di contrarre i muscoli facciali in particolari modi (Ekman et al., 1983), ad
esempio nella tipica congurazione indicante lespressione di felicit: i sog-
getti mantennero queste congurazioni per dieci secondi, durante i quali
furono misurati due parametri siologici, il battito cardiaco e la temperatu-
ra delle dita. I ricercatori trovarono una relazione causale sorprendente tra
il semplice atto di modicare lespressione facciale e gli schemi di risposta
autonoma. Altre ricerche documentano sia unattivit EGG diversa in corri-
spondenza delle differenti pose sia modicazioni nellesperienza soggettiva
che accompagnano i cambiamenti del volto (Ekman e Davidson, 1993; Izard,
1990; Lanzetta et al., 1976).
G. H. Luquet, nel 1930, osservava correttamente: Il riso non in s
uno stato psichico, ma un insieme di fenomeni siologici che presuppongo-
no una grande variet di impulsioni psichiche, onde impossibile ridurre
a ununica specie tutte le forme di riso (Le rire dans les lgendes ocanniennes,
in Journal de Psycologie normale et pathologique, XXVII, 1930, pagg. 268-
288). Lo stesso Luquet, infatti, ne elenca un arco notevolmente ampio, a
seconda che il riso sia provocato da solletico, da travestimento, da gesti e mi-
- 36 -
miche grotteschi, da soddisfazione, da sorpresa, da sensazione dellinatteso,
da astuzia, da atti sconvenienti o da altro. Pi recentemente Fabio Ceccarelli
ha indagato in uno studio di grande rigore e in direzione biontropologica
questi fenomeni, giungendo a una precisa elencazione delle forme in cui il
messaggio psichico si avvale del piano sico del riso (Sorriso e riso. Saggio di
antropologia biosociale, Torino, Einaudi, 1988). Un risultato particolarmente
importante dagli studi sul fenomeno la constatazione che il riso o la ri-
sata esprimono, quasi sempre, a livello siologico, un processo interiore di
degradazione e superamento dei fattori ansiogeni e angoscianti. Si fa qui ri-
ferimento a situazioni di tensione individuale o collettiva, nelle quali il riso,
provocato da specici eventi, determina luscita dalla tensione. Di tale dina-
mica del riso abbiamo celebri esempi mitici, che riettono sicuramente par-
ticolari esperienze umane. In alcuni miti, distanti nel tempo e appartenenti
a culture diverse, emerge uno stato di radicale crisi individuale o cosmica.
Per esempio, nel VI-VII secolo a.c. la dea Demetra, emblema della crescita
dei cereali, entra in una condizione di depressione e di lutto poich le
stata rapita la glia Kore dal dio degli Inferi; e tale depressione, signicata
subito attraverso il non ridere (la dea, in questa fase della storia mitica
chiamata Agelasa, la non-ridente) comporta linaridimento delle messi e il
decadere dellintera natura. La gura divina esce dalla crisi e la produttivit
agricola torna alla normalit, quando la dea scoppia in una grande risata,
dopo che le vengono esibiti, in una tarda versione mitica, gli organi sessuali
da un altro personaggio, chiamato Baubo (strettamente connesso a termini
che indicano la vagina). Analogamente in Egitto, documenti del XIV-XV se-
colo a.C. riferiscono il tema del dio solare Ra- Harakhte che, entrato in col-
lera, si ritira nelle sue tende celesti e provoca la rovina della terra egiziana.
Esce dalla sua iraconda solitudine soltanto quando unaltra dea, il cui nome,
Hathor, signica vulva, esibisce la sua sessualit, provocandogli il riso. Un
testo giapponese di epoca tarda (VI-VII secolo d. C.)
,
ma testimonianza di
tradizioni molto arcaiche, riferisce che la dea del Sole, Ama-Terasu, si chiu-
de, per essere stata offesa dal dio del Mare Susa-No-Wo, in una caverna cele-
ste, mentre la terra e i campi di riso inaridiscono.
Il Poseidone nipponico le ha imbrattato di sterco le sacre stanze e
per buona misura vi ha squartato un cavallo al contrario! Non si conosce il
motivo di tanta sudicia e truculenta insolenza, fatto sta che (anche stavolta)
la dea si ritira in unimpenetrabile caverna, sorda a ogni richiamo, con il
(solito) risultato di oscurare il creato con conseguente catastrofe planetaria.
Ancora una volta una schiava a risolvere la tenebrosa faccenda: davanti
agli di (otto milioni!) assiepati sulla soglia della caverna, lancella Ameno-
Uzeme-No-Mikoto, improvvisamente, sciolti i lacci della veste, si denuda:
allo spettacolo, del tutto incongruo per la situazione, tutti si sganasciano
dal ridere: otto milioni di divine risate simultanee! Ama-Terasu, incuriosita
da tanta ilarit, fa capolino; lesto un dio ad afferrarla per i capelli e trarla
fuori dalla caverna. In un attimo il mondo torna alla luce. Qui la cessazione
della crisi ottenuta indirettamente (sono altri a ridere), ma lepisodio ci
fornisce un elemento in pi: il riso contagioso e spinge alla curiosit chi
non ne preda.
I miti appena esposti presentano sostanzialmente la stessa struttura: c
un evento che innesca una crisi cosmica; c una donna che ostenta la sua
- 37 -
nudit; c una risata liberatoria che mette ne alla catastrofe. Potremmo
cos sintetizzare che: morte + riso (sesso) = resurrezione della vita. Dunque
per far ridere gli di c bisogno di unoscenit, del basso mostrato impu-
dicamente e allimprovviso. Non curioso che entit cos elevate risolvano
le loro crisi nel rapporto (diremmo provocatorio) con il corpo, il basso, con
una schietta risata? In presenza di una morte generalizzata, c bisogno di
spingere le divinit allo sghignazzo, per sospendere il lutto e riconsiderare la
carne, il sangue, il sesso. Cos il riso di queste divinit viene interpretato da
altri autori come la gioia che si manifesta davanti alla rivelazione del sesso,
in quanto simbolo del piacere, dal quale scaturisce la creazione della vita.
questa, dunque, la connotazione divina del grembo della donna, cio lim-
pulso alla creazione insito nel piacere sessuale. Lalto degli di si tocca con
il basso del corpo: il cerchio della vita si chiude grazie ad una risata (Fiora-
vanti S., Spina L., La Terapia del Ridere, RED Edizioni).
Avremmo in tutti questi casi (A.M. Di Nola, Antropologia religiosa, Roma,
Newton Compton, 1984) una qualicazione del riso come un corto circuito
solutorio, che si verica nella conittualit fra emergenza di un nucleo emo-
zionale serio (ansia da crisi) e un evento banale o triviale (oscenit),
che funge da atto incongruente o non atteso. A. Schopenhauer (Il mondo
come volont e rappresentazione, trad. ital. di Savi-Lopez e G. Di Lorenzo, libro
1,13) osservava che il riso volta per volta nasce da unincongruenza, im-
provvisamente percepita, fra un concetto e gli oggetti reali che erano pensa-
ti. la medesima tesi della descending incongruity (la incongruit degradante,
liberante, sminuente) di H. Spencer e di molti altri pensatori. Ed una tesi
che possiamo vericare quotidianamente nelle esplosioni di riso cui assi-
stiamo. evidente, per esempio, che le azioni, i comportamenti, gli atteg-
giamenti operativi sono assoggettati da uneconomia della nostra ideazio-
ne, che in forma previsionale costruisce, senza fermarsi sui singoli movimenti
costituenti la serie degli atti, lintero processo nalistico che conduce al loro
compimento nale. lelemento inatteso a provocare la risata; una leg-
ge mentale che riguarda la seriazione della quale si compongono le azioni
complessivamente intese: nellosservare il camminare, per esempio, mental-
mente noi prevediamo landamento comportamentale di chi cammina e le
sue diverse attivit muscolari dirette al ne deambulatorio, senza soffermarci
sopra ciascuna di esse. Se, nello sviluppo della seriazione prevista, interviene
un elemento casuale ed estraneo alla previsione, e in tale senso incongruo,
come una buccia di banana lungo il percorso, con conseguente caduta, si
verica quella incongruit che determina il riso. Gi Kant scriveva, nella Cri-
tica del giudizio che il riso unaffezione, Affekt, che si origina dallimprovviso
mutarsi di unattesa in nulla, e cio nellinterrompersi improvviso di quan-
to ci aspettavamo avvenisse. E proprio in ci lefcacia delle storielle e delle
gestualit che appartengono alla comicit, e che sono fondate sullemergere
inatteso di quanto non attendevamo.
In unaltra prospettiva di approfondimento in una materia i cui termi-
ni possono appena essere qui accennati, il riso si congura come esplosione
di vitalit, di pienezza, di vigore, di libido ed Eros in senso freudiano (gli dei,
in Grecia e in India creano, ridendo, il mondo!), opposta a Thanatos, al senso
del crollo del s e del mondo. In questo senso mi sembra signicativa una
mia diretta esperienza di lavoro sul campo durante la preparazione di una
- 38 -
mia ricerca sui signicati del lutto. Il lutto, lo si sa, una situazione ango-
sciante determinata dalla perdita delloggetto di investimento affettivo che
stimola un vissuto di crollo e ne del mondo avvertito come senza futuro
e speranza, situazione psichica, del resto, analoga a quella depressiva o ma-
linconica secondo i risultati di celebri pagine freudiane. Ora, in vari ambiti
di culture di contadini, da me studiate in Italia (ma con referenti analoghi in
molte culture europee) si realizzano, durante il lutto, certe situazioni desti-
nate a determinare il riso del gruppo di luttuati, attraverso la narrazione di
episodi osceni durante la veglia funebre o anche attraverso toccamenti ses-
suali (E. De Marino ignorava i casi molto frequenti italiani e si era rifatto a
un esempio rumeno!). Addirittura in alcune narrazioni popolari sarde, sici-
liane e calabresi si legittimano questi comportamenti, destinati a provocare
il riso e il detensionamento, ricorrendo a modelli sacrali. La stessa Vergine,
si dice, avrebbe incongruamente riso quando era calata nel lutto radicale
sotto la croce, perch un animale, ora la tartaruga, ora il rospo, le si presen-
ta, esprimendo la meraviglia per il dolore cos intenso di lei, quando, rospo
o tartaruga, perdono continuamente i loro nati senza piangere. E come se i
sistemi sociali che spiegano il lutto abbiano contrapposto alla crisi deterio-
rante del dolore e della disperazione una terapia del riso, come veicolo di
risalita alla normalit del vivere e a quella elaborazione denitiva del cordo-
glio segnalata dallo stesso Freud. Negli aspetti qui studiati, che potrebbero
essere integrati da molti altri punti di osservazione del fenomeno, il riso, che
gi Aristotele specicava come qualit propria del uomo (diviene uomo il
fanciullo che ride per la prima volta, dice il losofo), assume aspetti di un
riattingimento della vitalit repressa o attraversata da mali psichici e riapre
luomo alla speranza. Esso la gioia medesima del vivere. Non a caso, del
resto, le antiche liturgie cattoliche, no alla ne del Settecento, osservavano
un risus pascalis, che il predicatore doveva far esplodere, anche attraverso la
narrazione di barzellette, nei fedeli, dopo la liturgia della Resurrezione del
Cristo, nelle chiese o dal pulpito, quasi a signicare la vittoria sulla morte e
sul male cosmico.
dunque lecito parlare di funzione apotropaica del riso che caratte-
rizza, ad esempio, anche la commedia di Menandro (IV sec. a. C.). Senza
dubbio, il commediografo greco inuenz la commedia Romana di Plauto
e soprattutto di Terenzio e, indirettamente, la commedia europea moderna,
a partire dal Rinascimento. Tuttavia, la commedia greca ha una valenza ben
diversa da quella che noi moderni intendiamo oggi. Il termine comico in-
tendeva un momento in cui il nostro riso nel senso siologico del termine,
che viene denito da Kant come una discordanza discendente esplode,
liberando la nostra forza nervosa accumulatasi in ununica, scrosciante risata
(Guidorizzi G., Il mondo letterario greco, Einauidi, 2004). Laggettivo apotro-
paico deriva dal greco
(apotrpein = allontanare) e viene soli-
tamente attribuito ad un oggetto o persona atti a scongiurare, allontanare
o annullare inussi maligni. Si parla, ad esempio, di monile apotropaico,
rito o gesto apotropaico. Nel mondo letterario ha assunto il carattere di rito
che allontana il male, dunque esorcizzante. Questi tipi di simboli ed oggetti si
incontrano di sovente nelle abe e nei racconti mitologici, dove assumono
spesso la medesima funzione che assumono allinterno di un sogno od un
ricordo soggetto ad analisi.
- 39 -
BIBLIOGRAFIA
1. Ceccarelli F., (1988), Sorriso e riso. Saggio di antropologia biosociale, Torino, Einaudi;
2. di Nola A. M., (1984), Antropologia religiosa, Roma, Newton Compton;
3. Ekman P., (1992), Facial expression of emotion: New ndings, new questions. Psychological
Science, 3, 34-38;
4. Ekman P., Davidson R., (1993), Voluntary smiling changes regional brain activity. Psycholo-
gical Science, 4, 342-345;
5. Fioravanti S., Spina L., (1999), La Terapia del Ridere, RED Edizioni;
6. Guidorizzi G., (2004), Il mondo letterario greco, Einaudi, (2004);
7. Izard C., E., (1971), The face of emotion, New York, Appleton;
8. Izard C., E., (1997), Emotion and facial expressions: a perspective from differential emotions
theory. New York, Cambridge University Press.
9. Luquet G., H., (1930), Le rire dans les lgendes ocanniennes, in Journal de Psycologie nor-
male et pathologique, XXVII, 1930, pagg. 268-288;
10. Schopenhauer A., Il mondo come volont e rappresentazione, trad. ital. di Savi-Lopez e Di
Lorenzo G., libro 1, 13, 1986.
Alfonso M. di Nola (Napoli, 9 gennaio 1926 - Roma, 17 febbraio 1997) stato Psichiatra,
Antropologo e Storico delle religioni. Ha insegnato nelle Universit di Siena e di Roma
e allIstituto Orientale di Napoli. Dopo gli studi sugli apocri cristiani e sul misticismo
ebraico, si occupato d religiosit popolare (1976), di folkore italiano (1983, 1994) e della
gura del diavolo (1987). Ha diretto lEnciclopedia delle religioni (1970-76), della quale ha
redatto tutte le voci sulle religioni non cristiane. Allantropologia della morte e del lutto
sono dedicati i lavori degli ultimi anni (1995). Ha pubblicato diversi articoli per la nostra
Rivista.
Nota Redazionale. Il Dott. Andrea Mosca - Psicologo, specializzando in psicoterapia, re-
sponsabile della segreteria di redazione della Rivista N. Prospettive in Psicologia e membro
del CSPP e della SIMP - ha revisionato e ampliato il presente articolo. Di fatto ci era stato inviato
qualche anno fa dal Prof. di Nola come base per un lavoro da ampliare. Una sintesi era gi
stata pubblicata da RIZA Psicosomatica, Agosto 1990, N. 114.
- 40 -
LA VALUTAZIONE CLINICA DEL DISADATTAMENTO
LAVORATIVO E LE PROBLEMATICHE CONNESSE
F. Pellegrino, A. Gambino, A. Milone, W. Di Munzio
Introduzione
La valutazione clinica delle conseguenze individuali dello stress lavora-
tivo difcile da operare per la presenza di numerose variabili non sempre
facili da identicare e gestire; lindividuo stressato, pi esposto al rischio
dinfortunio o errori professionali, rende di meno, pi vulnerabile allo
sviluppo di patologie siche o psichiche.
Tutto ci comporta inevitabilmente una riduzione complessiva della
sua qualit di vita ed una riduzione della performance lavorativa con danni
indiretti a carico dellazienda.
Nel valutare le situazioni cliniche correlate allo stress lavorativo occor-
re avere ampie prospettive di veduta e conoscere a fondo le dinamiche e le
problematiche dellorganizzazione dove il soggetto presta la propria attivit
professionale. Con la nuova legge 81/2008 in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro le Aziende sulla base dellAccordo
quadro europeo del 2004 sullo stress lavoro-correlato dovranno procedere
alla valutazione del rischio psicosociale e di ogni situazione che ne favorisce
linsorgenza. Ci per rendere possibile ladozione di idonee misure naliz-
zate a stemperare le situazioni di stress e a promuovere il benessere dellin-
dividuo.
Per la valutazione diagnostica e terapeutica delle problematiche e
delle patologie psichiche correlate al mondo del lavoro lASL Salerno (ex
SA1) ha inteso istituire un Ambulatorio afferente al Centro per lo studio, la
prevenzione e la clinica del disadattamento lavorativo.
Lambulatorio effettua attivit clinica con interventi farmacologici e
psicoterapeutici, con relativo nei casi previsti rilascio di certicazione,
anche in ragione del recente aggiornamento dellelenco delle malattie pro-
fessionali dove sono stati inseriti tra i nuovi agenti patogeni le disfunzioni
dellorganizzazione del lavoro e le malattie ad esse connesse.
Dal punto di vista clinico lambulatorio ha consentito di evidenziare
speciche problematiche cliniche e terapeutiche che sono diventate motivo
di riessione.
Psicopatologia e lavoro
In primo luogo in un momento di crisi economica in cui linserimento
lavorativo di pazienti affetti da patologie psichiatriche difcoltoso e di non
facile realizzazione, se non allinterno di progetti predisposti ad hoc (1),
assume particolare rilevanza la conservazione del posto di lavoro; infatti
noto che le difcolt di tali soggetti a sostenere gli impegni lavorativi li ren-
dono pi vulnerabili alla perdita del posto di lavoro. Pazienti con disturbo
delirante o bipolare, soggetti con schizofrenia o disturbi di personalit che
hanno un lavoro stabile possono, nei momenti di acuzie, avere difcolt a
sostenere gli impegni lavorativi e a rendere di meno.
Altrettanto rilevanti risultano anche alcuni quadri psicopatologici
- 41 -
cosiddetti minori come la distimia, lipocondria e la somatizzazione che
possono seriamente compromettere il rendimento lavorativo. Ci pone alcu-
ni problemi di non facile gestione dal punto di vista clinico.
Innanzitutto la possibilit di monitorare costantemente il trattamento
terapeutico, poich luso di farmaci come gli antipsicotici o gli antidepressi-
vi, va tarato in rapporto al quadro clinico e la tipologia lavorativa. In alcune
circostanze la comparsa di effetti collaterali, come la sedazione, possono in-
fatti interferire con lattivit lavorativa ed essere potenzialmente rischiosi; di-
venta pertanto importante prevedere programmi terapeutici compatibili con
lattivit lavorativa. Una maggiore sensibilizzazione del datore di lavoro pu
essere utile per allentare le tensioni che usualmente insorgono nel mondo
del lavoro; il ruolo del medico competente pu essere fondamentale per la
gestione di questi pazienti e nel rilevare i segni precoci di malattia. Molto
spesso la sensibilit delle aziende verso queste problematiche non adegua-
ta, con il risultato che vengono attuate strategie espulsive o di isolamento
(ostracismo). Interventi preventivi, in tal senso, possono senzaltro essere di
aiuto e sostegno sia al dipendente che al datore di lavoro, lavorando sia sullo
stigma legato alla patologia mentale, sia sulla necessit ed opportunit di
tutelare una fascia di lavoratori che, per peculiari patologie, possono presen-
tare in alcuni frangenti una diminuzione della performance lavorativa (2).
Un altro problema emergente nellambito delle problematiche di
disadattamento lavorativo dato dalle condizioni di abuso di alcolici che,
indipendentemente dallattivit lavorativa, motivo di preoccupazione sia
perch correlato ad infortuni lavorativi, sia per la rilevante compromissione
della funzionalit dellindividuo. Lassunzione di alcolici e lelevata comor-
bidit psichica che si accompagna al comportamento tossicolo richiede
un trattamento medico di non facile attuazione poich ci si trova di fronte
a soggetti non collaborativi con problematiche lavorative che nel tempo si
sono strutturate in situazioni difcili da sostenere; in tali situazioni se da un
lato lazienda pu adottare atteggiamenti di tolleranza relegando il soggetto
a compiti meno gravosi, dallaltro pu diventare difcile trovare allinterno
dellazienda una idonea collocazione del soggetto, anche per le rilevanti im-
plicazioni di tipo legale; in questi casi, proprio per la scarsa consapevolezza
e collaborazione da parte del soggetto, diventa difcile pianicare interventi
terapeutici, se non allinterno di strutture specialistiche.
Infortunio lavorativo e psicopatologia
Loccorrenza di infortuni lavorativi pone tutta una serie di riessioni
in merito alla gestione delle possibili conseguenze psicologiche che ne con-
seguono, soprattutto in presenza di traumi che comportano menomazioni
importanti. In tali casi se allinizio prevalgono vissuti di rabbia, allorquando
si ha una maggiore consapevolezza dei danni subiti, possono subentrare
quadri depressivi che richiedono un trattamento farmacologico e psicotera-
peutico. anche possibile linsorgenza di disturbi dello spettro ansioso con
la comparsa ad esempio di condotte di evitamento che limitano lefcacia
lavorativa; linsorgenza di specici disturbi - il disturbo post-traumatico da
stress pu dar luogo al riconoscimento della malattia professionale.
Linfortunio lavorativo pone quindi alcune problematiche che vanno
dalla gestione dellacuzia, spesso polarizzata agli effetti dellinfortunio sulla
- 42 -
propria salute, alla gestione di possibili quadri psicopatologici che spesso
insorgono a distanza di alcuni mesi dallinfortunio. Occorre precisare che
anche traumi a forte valenza emotiva (assistere ad esempio alla morte di un
collega sul luogo di lavoro) possono congurare un vero e proprio infortu-
nio lavorativo.
Laddove i postumi del trauma risultano stabilizzati ma comportano
delle limitazioni funzionali si pone il problema della ricollocazione lavorati-
va del soggetto in rapporto alla menomazione subita, che in alcuni casi pu
non essere pi compatibile con lattivit lavorativa.
anche possibile che speciche condizioni contrattuali come ad
esempio lattivit a tempo determinato possano costituire la premessa per
il licenziamento del lavoratore, laddove anche infortuni di modesta entit
vanno ad incidere sulla performance lavorativa.
Malattie siche e attivit lavorativa
Lelevata incidenza di patologie ad andamento cronico e che necessi-
tano di un monitoraggio clinico continuo pone in ambito lavorativo una se-
rie di problematiche in quanto condizioni di stress possono compromettere
ulteriormente lo stato di salute dellindividuo; la presenza infatti di soggetti
affetti da patologie somatiche, come linfarto cardiaco, lipertensione ed il
diabete, pu avere notevoli ripercussioni sul rendimento lavorativo e con-
correre allo sviluppo, soprattutto in situazioni di particolare stress, di quadri
psicopatologici che richiedono un trattamento specico. Soggetti che in pie-
no benessere si ritrovano a vivere uno stato di malattia hanno bisogno di un
periodo di adattamento che pu comportare assenze anche prolungate dal
lavoro ed un complessivo calo del rendimento lavorativo. Si osservano con
sempre maggiore frequenza anche quadri clinici caratterizzati dallinsorgen-
za di disturbi dello spettro ansioso-depressivo a polarizzazione ipocondriaca;
la preoccupazione relativa al proprio stato di salute diventa unideazione
prevalente che arriva a compromettere le capacit cognitive del soggetto,
con scarsa concentrazione, vuoti di memoria, difcolt a gestire le proble-
matiche lavorative; tali quadri psicopatologici possono avere una particolare
rilevanza clinica e richiedere specici trattamenti. Importante in tale con-
testo il ruolo del medico di medicina generale e del medico competente
poich una diagnosi precoce con relativo trattamento pu evitare la strut-
turazione dei sintomi in disturbi di maggiore gravit; opportuno quindi
prevedere un monitoraggio alle patologie siche poich la sovrapposizione
di quadri psicopatologici (comorbidit) oltre a rendere pi complesso il trat-
tamento inuisce negativamente sulla prognosi.
Dal punto di vista clinico le problematiche che si evidenziano sono di
particolare importanza poich la somministrazione di farmaci, antidepressivi
o ansiolitici, pu comportare linsorgenza di effetti collaterali che vanno
ponderati in rapporto alla tipologia lavorativa; inoltre occorre considera-
re lampio discorso delle politerapie poich lassociazione di pi farmaci,
ad esempio antipertensivi, ipoglicemizzanti ed antidepressivi, aumentano
lincidenza di effetti collaterali, richiedendo un attento monitoraggio. Tali
considerazioni assumono unimportanza relativa anche alla sicurezza del
lavoratore e richiamano lobbligo della valutazione del rischio psicosociale
allinterno dellazienda poich situazioni di stress possono incidere in modo
- 43 -
signicativo sulle patologie somatiche; in questo senso ladozione di speci-
che misure di protezione possono favorire un complessivo miglioramento
della qualit della vita dei soggetti con patologie siche.
Stress lavorativo e patologie psichiche
Situazioni di particolare stress spesso non percepito o sottostimato
rendono lindividuo pi vulnerabile allo sviluppo di quadri psicopatologi-
ci; tensioni lavorative, conittualit, carico di lavoro eccessivo soprattutto
se concentrato in particolari periodi dellanno , problematiche speciche
della tipologia di lavoro, possono favorire lo sviluppo di patologie psichiche,
come lansia e la depressione (3).
In molte circostanze lo stress lavorativo sostiene lo sviluppo di stili di
vita disfunzionali, con aumento del fumo di sigarette, disturbi dellalimenta-
zione, irritabilit, abuso di alcolici, gambling, tutti fattori che non solo com-
promettono il rendimento lavorativo ma si ripercuotono negativamente sul
benessere dellindividuo. Anche limpegno necessario per sostenere i ritmi
lavorativi ordinari e le responsabilit connesse pu essere considerato in tal
senso una fonte di disagio e di stress.
Negli ultimi anni stanno inoltre emergendo condizioni di disagio psi-
chico o di franche patologie psichiatriche in rapporto alla crisi di particolari
settori produttivi. La gestione ad esempio di unattivit autonoma come
un negozio o lattivit di venditore ambulante stata oggetto di un profon-
do stravolgimento ed alcuni settori hanno subito in maniera pi diretta gli
effetti della crisi economica; losservazione di soggetti che hanno sviluppato
una sintomatologia dello spettro ansioso-depressivo dovuta allo stato di
impotenza rispetto alla crisi e al dover rimodulare il proprio tenore di vita in
rapporto allandamento dei ricavi utili per sostenere lattivit stessa.
Il senso di impotenza, pu in tali circostanze, prevalere sulla proget-
tualit futura e sulla possibilit di innovare lattivit di cui si titolari per
indirizzarla in settori pi produttivi; ci in ogni caso condiziona in modo
negativo landamento produttivo.
Lindividuazione ed il trattamento della patologia psichica consente
di aiutare il soggetto a riprendere il controllo della situazione; infatti noto
come la presenza di un quadro ansioso o depressivo pu alterare la perce-
zione della realt amplicando in modo eccessivo anche problematiche che
in assenza di quei quadri clinici possono essere affrontate in modo agevole.
In molti casi pu essere indicato un trattamento psicologico mirato al
controllo della sintomatologia in essere attraverso lindividuazione di strate-
gie di coping utili ad affrontare in modo adeguato la situazione di crisi.
Disoccupazione e psicopatologia
Se il lavoro pu essere fonte di stress e disagio psichico non meno im-
portanti possono essere le conseguenze derivanti dalla mancanza di occupa-
zione che pu essere alla base di gravi quadri psicopatologici, con un elevato
rischio suicidario.
Sono noti infatti gli effetti psicologici legati alla perdita del posto di
lavoro, soprattutto laddove la ricollocazione del soggetto in ambito lavorati-
vo problematica o difcile da attuarsi; in queste circostanze pu prevalere
un senso di impotenza, di disperazione rispetto ad una condizione non
- 44 -
gestibile. Le reazioni psicopatologiche possono essere varie ed in rapporto
alla personalit del soggetto, alla sua capacit di attuare strategie di coping
adeguate, alla specica professionalit e alle opportunit di ricollocazione
presenti, al sostegno familiare e sociale presente, allet e al carico familiare.
Il non poter assolvere al sostentamento dei gli, il sentirsi smarrito e incapa-
ce di far fronte agli impegni economici, la mancanza di qualsiasi prospettiva
futura pu generare quadri depressivi di particolare intensit clinica.
Stress, conittualit e mobbing
Vi sono, inne, situazioni di aperta conittualit tra azienda e lavora-
tore, con il ricorso ad iter giudiziari lunghi ed estenuanti per entrambi; in
questi casi pu prevalere dal punto di vista clinico laspetto medico-legale
che sottende la richiesta di una certicazione. In ci opportuno attenersi
alla valutazione dello stato clinico tramite un preciso protocollo diagnosti-
co e terapeutico volto ad attestare le condizioni psichiche dellutenza, non
entrando tuttavia in merito alle vicende giudiziarie, n al nesso di causalit
tra la diagnosi e le problematiche lavorative; lobiettivo centrale dellambu-
latorio attiene esclusivamente ad una valutazione dello stato di salute della
persona in termini diagnostici e terapeutici (2,4).
Conclusioni
Le patologie correlate al mondo del lavoro hanno un impatto non solo
sul benessere psichico della persona ma anche sulla sua salute sica in quan-
to il rischio psicosociale ritenuto un importante fattore causale/concausa-
le di patologie come quelle cardiovascolari o come il diabete; inoltre alla
base di stili di vita disfunzionali (fumo di sigaretta, irritabilit ) che rap-
presentano un altro importante fattore di rischio per la salute dellindividuo.
Il contributo che pu dare un ambulatorio per la Clinica del Disadat-
tamento lavorativo appare pertanto utile, oltre che per le valutazioni diagno-
stiche e terapeutiche, a creare un momento di riessione e discussione in un
ambito in cui, anche per lattuale momento di crisi economica, la gestione
appropriata dello stress e delle risorse umane appare di difcile attuazione
(5, 6), ma a maggior ragione indispensabile.
BIBLIOGRAFIA
1. ISFOL, 2010, Strumenti per Inclusione partecipata nella salute mentale. Dalle reti come esigenza
alle reti come esperienza, ISFOL, Roma;
2. F. Pellegrino, 2006, Oltre lo stress, burn-out o logorio professionale, Centro Scientico Edito-
re, Torino;
3. F. Pellegrino, 2007, Psicopatologie emergenti, Mediserve, Milano-Firenze-Napoli;
4. F. Pellegrino, 2010, Stress lavorativo, come malattia professionale: il rischio psicosociale, Mo-
mento Medico, Salerno;
5. F. Pellegrino, 2007, Valorizzare le risorse umane, Mediserve, Milano-Firenze-Napoli;
6. F. Pellegrino, 2010, Personalit ed autoefcacia, Springer, Milano.
* Psichiatra, Responsabile Ambulatorio - Clinica del Disadattamento lavorativo - ASL Salerno
** Psicologo tirocinante
***Direttore DSM ASL Salerno (ex Sa1)
Indirizzo dellAutore (per tutti): Dott. Ferdinando Pellegrino:
Corrispondenza: ferdinandopellegrino1@tin.it
- 45 -
QUESTIONI FONDAZIONALI DELLE SCIENZE UMANE
DALLIPNOSI CLASSICA A QUELLA ATTUALE:
LIPNOSI ERICKSONIANA NELLA PIIEC
(SECONDA PARTE)
Piero Parietti, Elisa Faretta
La prima parte stata pubblicata sul numero precedente della Rivista
N. Prospettive in Psicologia, Anno XXV, n. 2, novembre 2010 (Fasc. n. 44).
Abbiamo concluso la prima parte del nostro contributo citando lap-
proccio pluridimensionale, che caratterizza la nostra modalit di utilizza-
zione dellipnosi nella pratica clinica e citando alcune caratteristiche di tale
approccio, abbiamo concluso che sulla base dei dati citati e sulla loro
articolata integrazione che il terapeuta induttore elaborer le sue diverse
modalit operative, che troveranno nellapproccio induttivo adottato lelemen-
to orientativo del suo intervento. In realt tutta la storia dellipnosi, sin da
quando era indicata come mesmerismo, stata caratterizzata dalle diverse
modalit di induzione della condizione ipnotica, cio dalle operazioni attuate
dallinduttore nei confronti del soggetto indotto, cio da quelle pratiche che
saranno indicate da Braid come ipnotismo ed aventi la nalit di produrre la
condizione di ipnosi (ipnotica). Ed stato proprio nellambito delle moda-
lit induttive che, a partire dalla prima met del 1900 si vericata quella
che stata indicata come la rivoluzione ericksoniana caratterizzata dal passag-
gio delle induzioni dirette a quelle indirette che ha contribuito a rafforzare
un contesto culturale sempre pi caratterizzato (Angelozzi) da una nuova
prospettiva ermeneutica, inserendo in tale contesto nuovi modelli. Modelli
costruiti secondo unimpostazione per la quale gli effetti della terapia con-
sisterebbero in un mutamento dellimmagine affettiva e cognitiva che il sog-
getto ha del mondo. Si tratta di un mutamento che attribuisce ai sintomi
uno specico senso [nalit] e, proprio in quanto dotati di senso, un loro
diritto allesistenza ed un ruolo nella terapia.
Si venuto pertanto costruendo un approccio di tipo particolare nel
quale il mutamento psicoterapeutico si realizza attraverso una restituzione di
valore ad una prospettiva che comprende la possibilit di una modicazione
della realt vissuta dal soggetto. Aspetto questo, che consentirebbe di acce-
dere ad un altro mondo possibile in cui i sintomi come tali non avrebbero pi
posto o lo troverebbero in una prospettiva diversa e ricca di senso. Milton Eri-
ckson ha fornito a questo tipo di approccio un contributo fondamentale so-
prattutto nellambito ipnoterapeutico, ove ha sperimentato, ripercorrendoli
i vari modelli successivamente elaborati dalla ricerca psicoterapeutica, sino
ad approdare, inne, ad elaborare un personale e particolare approccio
terapeutico. Nellambito delle sue esperienze professionali, infatti, Erickson
si costantemente mosso, utilizzando lipnosi, secondo le diverse modalit
tecniche elaborate nei diversi periodi storici. Si trattato di modalit che, a
partire dalle tradizionali rimozioni del sintomo, utilizzando le tecniche indut-
- 46 -
tive dirette, sono poi transitate attraverso le tecniche ipnoanalitiche, ma dif-
ferenziandosi nettamente dallimpostazione freudiana, sino a giungere alla
costruzione di meccanismi pi rafnati, imperniati su quelle caratteristiche
fondamentali dellipnosi costituite dal rapporto interpersonale tra induttore e
indotto [in questa prospettiva pi correttamente denibile come relazione
tra terapeuta e paziente], e le correlate modalit di induzione della trance
[attraverso la tecnica dellutilizzazione di tecniche indirette tendenti a co-
struire laspetto pi ampio della tecnica di utilizzazione. In queste tecniche
la ritualit dellinduzione di tipo classico viene sostituita da particolari strate-
gie che sono elaborate in funzione della patologia e/o della problematicit
presentata dal paziente e dalle speciche situazioni contestuali e relazionali
in atto.
Tali tecniche si avvalgono di particolari e personali rapporti comu-
nicativi tra terapeuta e paziente [ipnologo e soggetto] nei quali la comu-
nicazione si svolge a seguito di espedienti tecnici particolari per cui: 1. la
componente consapevole e razionale della mente del soggetto [paziente],
viene coinvolta in scambi e/o compiti che la impegnano; 2. lasciando cos
un libero accesso alla componente inconscia della stessa.
Le possibilit terapeutiche sarebbero pertanto connesse alle possibilit
creative dellinconscio attivato e, in parte, alle immagini suggerite dal terapeuta.
Erickson non per giunto alla conclusione della sua impostazione
solo sulla base di intuizioni o di speculazioni teoriche, ma soprattutto sulla
base di sperimentazioni pratiche.
Ad esempio, nei primi anni del 1900 pareva indiscutibile che attraverso
lipnosi loperatore controllasse direttamente lesperienza del soggetto ipno-
tizzato e C. Hull era un convinto assertore di tale impostazione. Nel 1923 -24
proprio Hull organizz un seminario sullipnosi a cui partecip Erickson, il
quale osserv come durante i suoi esperimenti i soggetti quasi naturalmente
sviluppavano nei periodi di introspezione delle trance sonnambuliche spon-
tanee, con ci evidenziando linfondatezza delle posizioni sostenute dalla
tradizione ipnotica.
Questa esperienza osservativa fu alla base di altre scoperte tra cui quel-
la basilare relativa alle suggestioni che non costituirebbero tanto dei comandi
da seguire (ti ordino di), quanto invece un punto di partenza per ottenere
un comportamento responsivo (Erickson, 1964a, p. 22).
Lesattezza di tale impostazione trov ripetute conferme, negli anni,
dalla sua attivit professionale.
Con migliaia di soggetti che gli fecero anche scoprire come quanto
pi la tecnica applicata era semplice, permissiva e non invadente, tanto pi
questa si dimostrava efcace dal punto di vista sperimentale e terapeutico. Il
che lo convinse del fatto che quanto meno fa loperatore, lasciando fare al
soggetto con ducia e aspettazione, tanto pi facilmente ed efcacemente
potr venire attuata la condizione ipnotica e la fenomenologia correlata.
Il tutto in armonia con le capacit proprie del soggetto, non inuenzato
da tentativi di compiacere loperatore (Erickson, 1964a, pp. 26-27). Line-
vitabile conclusione di tali osservazioni fu che lipnotista ininuente nel
determinare i risultati ipnotici, a prescindere dalle sue conoscenze e dalle
sue intenzioni.
Quali saranno i fenomeni ipnotici manifestati lo determina ci che il
- 47 -
soggetto comprende e ci che fa, e non i desideri delloperatore (Erickson,
1964a, p. 28). Erickson auspicava pertanto che la ricerca ipnotica del futuro
fosse basata sulle valutazioni del soggetto e sulla sua prestazione, piuttosto
che sulla valutazione dello sperimentatore.
In conclusione la teoria ericksoniana, se di teoria si pu parlare, im-
plicherebbe la possibilit di un apprendimento creativo nell autoipnosi.
Importanza delle rappresentazioni mentali
La sia pure sintetica illustrazione dellimpostazione ericksoniana di
relativa astinenza interventiva dello psicoterapeuta ipnologo, costituisce un
elemento del nostro tipo approccio terapeutico che impostato sulle com-
ponenti essenziali dellintegrazione e dell immaginazione.
Ed proprio nel contesto illustrato che assume unimportanza fon-
damentale il ruolo svolto dallattivit immaginativa tecnicamente indotta e/o
stimolata.
Attraverso lipnosi, soprattutto con risonanze tradizionali, quando si
utilizzano le rappresentazioni mentali evocate [consapevolmente ricercate],
si pu focalizzare limmaginazione su molteplici particolari delle scene rap-
presentate, con ci integrando quelle spontaneamente formate e viceversa.
Questo permette anche di coinvolgere, a livello immaginativo, numero-
si canali sensoriali con conseguente attivazione di molteplici circuiti o proli
neuronali tra loro interagenti. Lattivit immaginativa in condizioni ipnotiche
pu essere inizialmente guidata nella costruzione di scene, ambientazioni,
situazioni, nelle quali il soggetto stimolato ad agire eseguendo compiti,
compiendo azioni, utilizzando operazioni che, in condizioni di coscienza
normale (vigile) compie in maniera automatica ed in modo inconsapevole.
Una condizione, questa, che comporta il richiamo e lutilizzazione della me-
moria implicita che viene attivata proprio dalla funzione immaginativa. Il rac-
conto dellesperienza immaginativa vissuta, con i contenuti e le sensazioni
sperimentate che vengono riferiti verbalmente al terapeuta chiamano invece
in causa la memoria dichiarativa, soprattutto nella sua componente seman-
tica di traduzione nel linguaggio verbale delle esperienze immaginative
rappresentate con modalit espressive di tipo analogico. Secondo la modali-
t ipnotica tradizionale, a livello di pratica operativa si pu operare un con-
dizionamento tra una manifestazione ipnotica (ad esempio la catalessi di un
braccio), e sensazioni di tranquillit, sicurezza e benessere, enunciate verbal-
mente e/o prodotte immaginativamente, sia riferite ad esperienze positive
gi sperimentate dal soggetto, sia create immaginativamente e proiettate nel
futuro. In questi casi si fa ricorso alla memoria procedurale implicita di tipo po-
sitivo o, meglio, inserita in un contesto operativo positivo. Contesto che pu
essere contrapposto a quello negativo prodotto dallevento traumatico (azio-
ni incongrue, improduttive, blocchi, fughe...). In queste condizioni, favorite
dallipnosi, si pu utilizzare la memoria dichiarativa con contenuti e vissuti
positivi. Si potrebbe quindi ipotizzare che, in queste condizioni, una parte
forse non secondaria delleffetto terapeutico dellapproccio in questione,
consista in quella che potremmo denire come: recupero integrativo delle memo-
rie del trauma in un contesto correttivo. Tale recupero essendo utilizzato sia nel
contesto della dinamica psicoterapeutica attuata, sia come tecnica particola-
re di terapie integrate, in particolare quelle dedicate alle patologie paniche.
- 48 -
La nostra tecnica
Sulla base di quanto sinora prospettato potremmo chiederci come
lipnosi attuale di derivazione eriksoniana possa essere utilizzata in maniera
integrata nellambito della nostra modalit tecnica integrata. Per cercare
di rispondere per necessario qualche accenno a tale approccio che si
muove nel contesto di terapie secondo un approccio psicosomatico e, nel
caso specico della PIIEC. La concezione psicosomatista, al di l delle affer-
mazioni teoriche e di scuola, rileva il ruolo e lincidenza che le modalit di
funzionamento del mentale (emozioni, affetti, idee, pensieri), svolgono,
anche in senso patologico, sullintegrit delle funzioni e/o delle strutture
dellorganismo, negli organi e nei suoi apparati. Questa poli-articolazione
di momenti e vissuti diversi, implicanti tanto il biologico, quanto il sociale
delle situazioni contestuali, rende particolarmente difcile, sia decifrare la
patologia, sia intervenire efcacemente a livello terapeutico. Nellambito
psicosomatico un intervento che si muova solo nella dimensione del biolo-
gico (leggi farmaco) si sino ad ora rivelato insufciente. Daltra parte un
tipo di intervento che si esplichi solo a livello del simbolico (leggi psicotera-
pia verbale) non ha, a sua volta, offerto risultati pi signicativi. Cos stando
le cose, si posta lesigenza di ricercare forme di intervento che possano
considerare i diversi momenti ed aspetti della patologia psicosomatica o,
meglio, dellapproccio psicosomatista alla persona ammalata. Sorse quindi
la necessit di cercare una forma di terapia, che potesse contemplare tanto
il ricorso mirato al biologico del farmaco, quanto la creazione di uno spazio
relazionale idoneo per elaborare a livello simbolico gli aspetti della sintoma-
tologia presentata dal paziente, sia in quanto tale, sia come particolare modalit
comunicativa (seppure distorta ed inadeguata) utilizzata in speciche condi-
zioni contestuali. Il tutto facendo riferimento al corpo e collocando lo stes-
so, con le sue funzioni: sia al centro dell intervento terapeutico biologico
(farmaci o altro), sia quale riferimento nellelaborazione dei vissuti persona-
li del soggetto (leggi paziente). Una terapia quindi che, passando attraverso
il corpo, strutturi una relazione con nalit terapeutica l dove lespressione
passante per il corpo stia a signicare che il corpo (nelle sue dimensioni
reali ed immaginarie) si pone come focus del lavoro terapeutico. Que-
ste esigenze comportano lipotesi, peraltro suffragata dalloperare clinico,
sviluppatasi nel tempo, della strutturazione di un progetto terapeutico (che
non esclude leventuale ricorso al farmaco inserito comunque nel contesto
di una relazione terapeutica) che prevede lintegrazione di due momenti:
uno a focalizzazione corporea con la chiamata in causa di svariate funzioni
dellorganismo quali strumenti e, nello stesso tempo, destinatarie di modi-
cazioni indotte dei livelli di coscienza. Un altro di lavoro terapeutico verbale ad
impostazione psicodinamica correlato anche al tipo di formazione personale e
professionale del terapeuta.
La focalizzazione corporea
Se passiamo a considerare il lavoro a focalizzazione corporea rileviamo
come, a questo livello, giochino un ruolo fondamentale due fattori: la parola
considerata nelle due caratteristiche di veicolo portatore di informazioni
(cosa fare) ed evocatrice di atmosfere- emozioni- memorie; la funzione tonica
intesa, con Lemaire, quale nodo psicosomatico in quanto luogo di interazioni
- 49 -
psicosiologiche complesse che sono particolarmente attivate dallartico-
lazione dinamica dell iper e dell ipotonia muscolare e che, nelle rispettive
funzioni definite da de Ajuriaguerra, da richiamo e da soddisfazione,
avrebbero il ruolo di instaurare la relazione primaria del bambino con la
gura materna. Il ricorso, a livello di tecnica terapeutica, di tale dinamica,
articolata tra iper ed ipotonia, sarebbe in grado di riattivare i sottesi fantasmi
relazionali primari.
Lattivit immaginativa
Dallinterazione tra parola e funzione tonica verrebbe attivata, tramite la
modicazione dei livelli di coscienza indotti dal rilassamento, la produzione
immaginativa del soggetto. Attivit immaginativa intesa come possibilit e ca-
pacit di rappresentazione mentale di oggetti, persone, scene... che, al mo-
mento, non sono presenti nel campo percettivo sensoriale del soggetto.
Produzione immaginativa che, sia spontaneamente, sia a seguito di
specici procedimenti tecnici, pu assumere variabili caratteristiche di real-
t soggettiva in grado di coinvolgere molteplici canali sensoriali.
Psicoterapia Integrata Immaginativa ad Espressione Corporea
Lattivit clinica ci ha portato alla progressiva elaborazione di una
particolare tecnica terapeutica che, per le sue caratteristiche, pu essere de-
nita come: Psicoterapia Integrata Immaginativa ad Espressione Corporea
(P.I.I.E.C.) comportante lintegrazione di due livelli di lavoro:
- quello verbale ad impostazione psicodinamica
- quello a focalizzazione corporea che persegue una duplice nalit:
1. sfruttare gli effetti curativi della funzione trofotropica che propria del
rilassamento psicosico.
2. utilizzare la produzione immaginativa sviluppata dal soggetto
- sia in quanto tale
- sia quale materiale per lelaborazione simbolica a livello logico-razionale.
Distensione Immaginativa
La modalit operativa che la tecnica pone alla base del proprio ope-
rare quella denita come Distensione Immaginativa in cui la detensione
muscolare ed i vissuti correlati sono prevalentemente utilizzati per modica-
re il livello di coscienza ed attivare una produzione immaginativa correlata
al corpo. La produzione immaginativa sviluppata che viene attivata dalle
sensazione provate attraverso il proprio corpo, vissuto in una relazione par-
ticolare con laltro (il terapeuta), raccolta ed utilizzata per costruire un
testo che fornisce il materiale per lelaborazione e la decodicazione della
produzione immaginativa emersa ed intesa nel suo aspetto di signicante di
un possibile signicato sotteso. La decodicazione della produzione imma-
ginativa avviene secondo parametri formali (canali sensoriali utilizzati a livello
immaginativo) e parametri di contenuto (negli aspetti simbolici - relazionali
- contestuali). La tecnica in questione si colloca in uno spazio compreso
tra le tecniche del rilassamento progressivo (Jacobson) con verbalizzazione
dei vissuti, le tecniche di rilassamento riferite agli aspetti relazionali (Sapir,
de Ajuriaguerra), alcune delle tecniche di imagerie mentale (red - analisi
- 50 -
fantasmatica). La possibilit di ottenere una produzione di immagini atti-
vata da funzioni somatiche nel contesto di una relazione col terapeuta, e la
decodicazione delle immagini emerse tramite il lavoro sul testo (ascolto
del racconto verbale o scritto dellesperienza, osservazione ed elaborazio-
ne di ipotesi interpretative) appare particolarmente utile nellapproccio
terapeutico alla patologia psicosomatica. Un ambito, quello psicosomatico,
in cui lipotesi di un radicamento delle emozioni a livello somatico, unita-
mente alla operativit del pensiero e quella della conseguente opacit
del sintomo somatico, rendono pi che arduo, sia il lavoro diagnostico, sia
quello terapeutico. Sulla base di quanto espresso pare assumere signicato
la nostra modalit di utilizzazione dellipnosi secondo lorientamento PIIEC
fondamentalmente basata su di un approccio psicodinamico. Approccio
comportante pi laspetto formativo personale del terapeuta che non la scel-
ta delle tecniche che vanno comunque sempre personalizzate ed inserite nel
contesto relazionale terapeuta/paziente. Contesto relazionale inteso quale cor-
nice al cui interno si svolge il lavoro psicoterapeutico attivato dalla domanda
di aiuto del paziente e dalla risposta tecnica (ma non solo) del terapeuta.
In questa prospettiva possono essere scelte ed utilizzate tecniche che sono
sorte ed utilizzate secondo modelli teorici molteplici. Ci anche per la con-
siderazione che la focalizzazione del lavoro psicoterapeutico pu avvenire in
riferimento alla storia del paziente o alle prospettive future dello stesso. Una
focalizzazione del lavoro centrato quindi sulle carenze, debolezze blocchi,
conitti inconsci irrisolti del paziente utilizzando anche tecniche ipnotiche
alla ricerca delle loro origini, causalit e senso (Tecniche tradizionali di ip-
noanalisi).
Scoprire le risorse
La focalizzazione del lavoro pu per essere anche centrata sulla
scoperta e individuazione delle potenzialit o risorse non conosciute o non
utilizzate o bloccate del paziente (modalit di derivazione ericksoniana).
Questo senza dimenticare le possibili correlazioni esistenti, da una lato tra
le componenti psicoemotive e le strutture e funzioni cerebrali, dallaltro, tra
i meccanismi relazionali e i meccanismi di destrutturazione neurosiologica
funzionale che propria dello stato/relazione ipnotica. partendo da queste
basi che attuiamo un approccio terapeutico che, partendo dai sintomi porta-
ti e/o dalle problematiche vissute dal paziente, cerca di agire, contempora-
neamente, sia sul versante psicologico/relazione sia su quello neurofunzio-
nale. Ed secondo tale prospettiva che lipnosi, attraverso una integrazione
tra modalit tradizionali aggiornate e modalit evolute di derivazione erick-
soniana ed anche integrata con altre modalit compatibili assume un ruolo
importante e signicativo a livello terapeutico.
Qualche curiosit sulle tecniche ericksoniane
Nelle tecniche induttive indirette la ritualit dellinduzione viene sostituita
da particolari strategie che vengono elaborate in funzione:
- della patologia e/o della problematicit presentata dal paziente e
- delle speciche situazioni contestuali e relazionali in atto.
Tali tecniche utilizzano in maniera particolare i personali rapporti
comunicativi tra terapista e paziente nei quali lazione si svolge a seguito di
- 51 -
espedienti tecnici particolari che coinvolgono la mente razionale del paziente
in scambi e/o compiti che la impegnano, lasciando cos un libero accesso alla com-
ponente inconscia della stessa.
Le possibilit terapeutiche sarebbero, in tal modo, legate alle possibili-
t creative dellinconscio attivato e, in parte, alle immagini suggerite dallip-
nologo. Le suggestioni con nalit induttiva utilizzate da Erickson spaziano,
in realt, dalle modalit dirette con cui loperatore ordina al soggetto [al
suo inconscio] che cosa fare; tali tecniche possono rivelarsi utili nei casi in
cui la autorit dellinduttore sia molto elevata per il soggetto indotto. In-
dirette: sono indicate nei casi in cui si voglia facilitare una ricerca inconscia
nalizzata alla soluzione di un problema. Risultano utili, per la loro permis-
sivit, quando il transfert [rapporto] tra il soggetto indotto e linduttore non
molto intenso e si pone pertanto la opportunit di una collaborazione del
soggetto per ottenere risultati utili. Nel corso della pratica terapeutica cen-
trata sullipnosi si possono manifestare delle resistenze (palesi o inconsce) nei
confronti del lavoro e che ostacolano la realizzazione della trance ipnotica.
Per superare tali difcolt Erickson ha elaborato diversi approcci particolar-
mente permissivi [apparentemente], con la nalit sia di aggirare tali resi-
stenze, sia di favorire la creativit del soggetto che spesso risulta essere molto
elevata in condizioni di trance utilizzandole sempre con nalit ben denite.
Alcuni esempi di tali tecniche
Disseminazione
Questa tecnica consiste nel fare passare le suggestioni in modo che
queste siano colte soltanto dalla parte inconscia del soggetto.Tali suggestioni
vengono opportunamente disseminate allinterno di una conversazione, su un
qualunque argomento, in modo tale che sfuggendo alla consapevolezza del sog-
getto vengano invece colte dal suo inconscio. Esempio: per indurre un pazien-
te che ha difcolt a parlare di un suo problema, il terapeuta potrebbe par-
lare di quel problema in generale, come per caso in modo tale che il paziente,
prima o poi, colga loccasione di affrontare egli stesso il problema.
Truismi
Si tratta di una constatazione di fatto, presentata al paziente relativa ad
un aspetto della realt che questi non pu negare. Inserite in un contesto
adeguato, tali constatazioni [truismi] possono funzionare come suggestioni
efcaci. Esempio: nel caso in cui il terapeuta persegua la nalit di ottenere la
chiusura degli occhi del paziente pu, senza ordinarlo direttamente [tec-
nica diretta - dura- autoritaria], dire a questi lei ha certamente avuto occasione
di vedere come, spesso, le persone molto stanche, fanno molta fatica a reggere le palpe-
bre e i loro occhi niscono per chiudersi. In terapia tali truismi possono servire a
rendere accettabili le suggestioni induttive in quanto esse non sono contestabi-
li. Ad un soggetto che si ritiene abbia la necessit di quello che viene comu-
nemente indicato come un rafforzamento dellIo [un supporto alla personale
autostima], si potrebbe dire: il vento non riesce facilmente ad abbattere una quer-
cia bene piantata per terra . Un truismo pu essere utilizzato per ogni evento
che sia o sia stato oggetto di esperienza o che sia, comunque immaginabile
come anticipatorio di un evento ricercato [es. il sollevamento-levitazione di
un braccio]. In questo caso potrebbe essere utile dire: tutte le persone che si
sono rilassate sdraiandosi su quella poltrona [sedendosi su quella sedia] hanno speri-
mentato che il loro braccio destro [sinistro] si sollevato verso lalto da solo.
- 52 -
Non sapere e non fare
Consiste in inviti [non saper e non fare] che possono entrare in ogni
tipo di suggestione con la nalit di renderla pi efcace, in quanto al sog-
getto non viene richiesto di sapere e non chiamato a fare cose in quanto
non responsabile della responsivit (risposta allinput ricevuto) inconscia che
prescinde tanto dalla ragione, quanto dalla volont. Esempio: probabile che
fra poco il suo braccio destro diventi leggero... leggero... e si sollevi... lei
non ha bisogno di sapere perch ci si verica... ne deve fare alcunch per
farlo sollevare. In questo caso si tratta di una suggestione che preannuncia il
vericarsi di un evento [cio quanto suggerito] mentre, nello stesso tempo,
invita il senso critico e la volont del paziente a non interferire.
Suggestioni a nale aperto
Si tratta della utilizzazione di suggestioni sotto forma di domanda che
hanno la nalit di permettere all inconscio creativo del paziente di scegliere
i mezzi pi idonei ad ottenere una risposta terapeutica. Si tratta cio, di
sceglier i mezzi pi appropriati per promuovere lattivazione dei processi
mentali nalizzati alla soluzione di problemi.
Suggestioni composte
In queste induzioni vengono combinate tra loro due o pi suggestioni
per fare s che le stesse vengano reciprocamente rafforzate. In genere la
prima parte di una di tali suggestioni composte consiste in un truismo [dato
di fatto o affermazione ovvia] cui fa seguito la seconda parte che deve realiz-
zare qualche cosa. Esempi: seduta, perch allora non rilassarsi completamente ?,
mentre la sua mano sinistra si alza la destra si abbassa
Si pu notare che negli esempi citati la prima parte una constatazione,
mentre la seconda parte ci che deve essere realizzato.
Suggestioni a contenuto implicito
Sono costituite da suggestioni in cui alla realizzazione di una premessa
segue un risultato.
Ve ne sono di vari tipi tra cui alcuni esempi:
se...allora: se ti siedi allora puoi entrare in trance;
appena...: appena... ti senti a tuo agio, entrerai in trance;
quando...: quando... ti senti rilassato le tue palpebre si abbassano.
Suggestioni di legame
In queste induzioni al paziente viene lasciata la scelta tra due o tre
possibili modalit di entrare in trance a volte con collegamenti temporali:
tra poco o subito?
Esempio: vorrebbe entrare in trance stando seduto o disteso?.
Conclusioni
Dalla lettura delle due parti del nostro scritto, pensiamo sia emerso
come, storicamente, la teoria e la pratica ipnologica possano venire suddi-
vise in due fasi: quella pre e quella post ericksoniana, caratterizzate dalla
differenziazione tra tecniche induttive dirette e indirette. Come spesso
avviene, in ogni branca del sapere, quando una modalit originale si diffe-
renzia dalla tradizione, si pu operare una suddivisione, a volte estremizzata,
- 53 -
tra i cultori della disciplina in relazione alla loro formazione, producendo
scelte ed adesioni pregiudiziali alluna o allaltra impostazione. Nonostante
M. Erickson abbia sperimentato ed utilizzato, innovando le molteplici moda-
lit induttive, tale separazione si vericata anche in ambito ipnologico, per
cui alcuni cultori utilizzano solo modalit induttive dirette ed altri solo
modalit indirette.
Noi (soprattutto per ragioni anagrache, uno di noi) ci siamo formati
seguendo inizialmente le modalit tradizionali, anche se, seguendo limpo-
stazione guantieriana, abbiamo ben presto cominciato ad operare secondo
modalit consapevolmente integrative, inserendo le tecniche ipnotiche, cos
come altre tecniche, nella struttura della PIIEC. Ma questo aspetto potr
essere oggetto di un altro scritto in un successivo articolo.
BIBLIOGRAFIA
1. Angelozzi A., (1985), Lapproccio ericksoniano fra terapia sistemica e psicodinamica, Atti Con-
gresso Internazionale di Ipnosi e Terapia della Famiglia, Roma;
2. Benatti G., (1985), Il linguaggio del corpo in ipnosi e sua importanza diagnostica: un contributo
clinico di depressione mascherata, Atti 36 Congresso Societ Italiana di Psichiatria (1985),
Milano, Unicopli;
3. Bongartz W., (1991), Lipnosi, Psicologia Contemporanea, n. 104;
4. Brugnoli A., (2000), Autoipnosi e sindrome del bourn-out, Acta Hypnologica, n. 2;
5. De Benedittis G. et al., (1997), Ipnosi e sistema nervoso autonomo, Rassegna di Psicoterapie.
Ipnosi. Medicina psicosomatica. Psicopatologia forense v2 - n1;
6. Del Castello E., (1995), Cosa dovrebbe sapere il paziente per ottenere il massimo benecio dal
trattamento ipnotico, in Del Castello Loriedo op. cit.;
7. Di Summa M., (1997), Suggestioni dirette e indirette: un confronto, Rassegna di Psicoterapie.
Ipnosi. Medicina psicosomatica. Psicopatologia forense n3;
8. Erickson M., (1984), Opere, Volumi 1
:
4 Opere Astrolabio, Roma;
9. Erickson M., Rossi E., (1982), Ipnoterapia, Astrolabio, Roma;
10. Erickson M., Rossi E., (1984), Tecniche di suggestione ipnotica, Astrolabio, Roma;
11. Faretta E., Sconggere il Panico (Affrontarlo e vincerlo con lEMDR), Riza Scienze n.153, Milano;
12. Faretta E., (2000), Il panico e lEMDR. Lidap Onlus, Numero e, pg. 6-9, Parma;
13. Faretta E., (2001), Panico, Memoria Traumatica ed Intervento Integrato con lEMDR, Atti XI
Congresso Nazionale AIAMC, Palermo.
14. Faretta E., Fernandez I., (2003), Lintegrazione dellEMDR nel trattamento del Disturbo da at-
tacchi di panico, in Rovetto F. a cura (2003) Panico: origini, dinamiche, terapie, McGraw-
Hill, Milano;
15. Faretta E., Fernandez I., (2007), EMDR in the Treatment of Panic Disorder with Agoraphobia
ed. Sage Pubblications, Febb. 2007, USA;
16. Faretta E., Parietti P., (2001), Terapia Ipnotica e Trauma: LEMDR nel Panico e nel PTSD in
Il signicato della visione olistica nella medicina moderna. Atti 18 Congresso Nazio-
nale - SIMP - Milano;
17. Faretta E., Parietti P., (2002), La Psicoterapia ipnotica e lEMDR nel disturbo da attacco di Pa-
nico. Modello integrato di trattamento. In ACTA HYPNOLOGICA, Istituto H. Bernheim,
Verona;
18. Faretta E., Parietti P., (2002), Ipnosi e EMDR: un approccio integrato. Atti del 9 Congresso
della European Society of Hypnosis in Psychotherapy and Psychosomatic Medicine,
Roma;
19. Faretta E., Parietti P., (2002), Memoria Traumatica e Panico, Atti del 9 Congresso della
European Society of Hypnosis in Psychotherapy and Psychosomatic Medicine, Roma;
20. Faretta E., Parietti P., (2002), La risata il migliore dei farmaci, Riza Scienze n.171;
- 54 -
21. Faretta E., Parietti P., (2005), Vivere senza ansia, Riza Scienze n. 200, Milano;
22. Faretta E., Parietti P., (2006), EMDR e Psicoterapia Ipnotica in EMDR uno strumento di
dialogo tra le psicoterapie a cura di M Balbo; Mc Graw Hill, Milano;
23. Faretta E., Parietti P., (2006), Ridere allunga la vita, Ed. Riza, Milano;
24. Faretta E., Parietti P., (2006), Ben Essere e Felicit, Le Guide di Riza, Ed. Riza, Milano;
25. Ferrari E., (1993), Lipnosi come terapia e come comunicazione, Rivista di Psicoterapie. Ipnosi
n 1-2;
26. Giani Gallino T., (1985), Tecniche immaginative in ipnosi, in Parietti op. cit.;
27. Gocci G., (2000), Ipnosi moderna e comunicazione, Acta Hypnologica n 1;
28. Granone F., (1995), Tecniche dirette e indirette in ipnosi, in Del Castello - Loriedo op.cit.;
29. Granone F., (1995), Ci che ipnosi: i principali attributi che la deniscono e la differenziano
da ci che non lo , Rassegna di Psicoterapie, Ipnosi, v.1 n2;
30. Granone F., (1996), Lipnosi alle soglie del 2000, Rassegna di Psicoterapie, Ipnosi, v.1 n 1;
31. Guantieri G., (1974), Fenomenologia dellipnosi, Rassegna di ipnosi e medicina psicosoma-
tica, 24 - 238;
32. Guantieri G., (1974), Lipnosi medica: problemi antichi, fondamenti e prospettive attuali, Rasse-
gna di Ipnosi e Medicina Psicosomatica, 25 - 395;
33. Guantieri G., (1974), Ipnosi e psicosomatica: correlazioni sperimentali e cliniche, Rass. Ipnosi e
Med. Psicos.;
34. Guantieri G., (1975), Posizione e ruolo dellipnosi in medicina psicosomatica, Medicina Psico-
somatica 3-197;
35. Guantieri G., (1978), Lipnosi quale modalit di terapia psicosomatica, Congr. Eur. ipnosi/
psicosom. Malmoe;
36. Guantieri G., (1982), Linduzione ipnotica e medicina psicosomatica, Riv. ital. di ipnosi clini-
ca e sper. 2-57;
37. Guantieri G., (1985), Lipnosi oggi, 1 Congresso Nazionale Bernheim 1985 in Guantieri-
Ischia op.cit.;
38. Guantieri G., (1987), Lipnosi in prospettiva psicosomatica, in rencontres internationales
Balint, Ascona;
39. Guantieri G., (1987), Linduzione di ipnosi quale comunicazione terapeutica, Atti 11 Congrs-
so Simp, Messina;
40. Guantieri G., (1987), Il vissuto del corpo in ipnosi, 2 convegno mente-corpo, Milano;
41. Guantieri G., (1988), Lipnosi nella terapia del dolore, Riza Psicosomatica, gennaio 1988;
42. Guantieri G., (1989), Ipnosi e terapia del dolore, Newsletter, v 2 - n. 2 - Ed. Bernheim;
43. Guantieri G., (1998), Fondamenti e prospettive dellipnologia (1967), Acta Hypnologica, n. 2-3;
44. Guantieri G., (1987), Schema di tecnica induttiva ipnotica, Acta Hypnologica n 2-3 - 1999;
45. Guantieri G., Parietti P., (1977), La preparazione del medico ipnologo, Atti 3 Congresso Me-
dic. Psicosomatica;
46. Guantieri G., Parietti P., (1980), Problemi e prospettive di soluzione nella didattica dellipnosi,
Ipnosi, 1-50;
47. Guantieri G., Parietti P., Santini M., Lipnosi nellinformazione e nella formazione del medico e
dello psicologo, in Guantieri-Ischia op.cit.;
48. Gullotta G., (1995), Un approccio psicosociale alla psicoterapia e alla ipnosi, in Del Castello
Loriedo op.cit.;
49. Kline M.V., (1972), Ipnosi e processo terapeutico, Bollettino n 2 del centro di ipnosi H:
Bernheim;
50. Jamoli S., Andreoli R., (1985), Cos lipnosi in psicologia, v.7 Curcio;
51. Lapenta A., Randone A., (1990), Ipnosi, Attenzione e Concentrazione, ovvero le possibilit del-
lipnosi al di fuori del setting ipnotico, Rivista di psicoterapie, ipnosi v. 1 - n 1;
52. Loriedo C., (1995), Linduzione diretta come tecnica indiretta nella psicoterapia ipnotica, in
Del Castello op.cit.
53. Loriedo C., (1998), La tecnica della disseminazione, Rassegna di psicoterapie, ipnosi, n2 - v 3;
- 55 -
54. Modenese M., (1995), Immagini mentali: una prospettiva, Res n 2;
55. Mosconi G.P., (1962), Alcuni aspetti deontologici e morali nelluso dellipnosi medica, in Ipnosi
Medica, Amisi;
56. Mosconi G.P, (1962), Lipnosi applicata al parto, in Ipnosi Medica, ed Amisi, Milano;
57. Muzi P.G., (1974), Suscettibilit e refrattariet allipnosi, Rassegna di Ipnosi e Medicina Psi-
cosomatica 24-335;
58. Parietti P., (1970), Lipnosi quale ausilio alla psicoprolassi ostetrica, Medicina Psicosomati-
ca 15-1-56;
59. Parietti P., (1970), Sulla preparazione psicologica del medico ipnologo, Rass. ipnosi medic.
psicos. 6-13-90;
60. Parietti P., (1972), Ipnoterapia nelle affezioni psicosomatiche, Medicina Psicosomatica 17-1-
41;
61. Parietti P., (1973), La preparazione della gestante al parto mediante ipnosi, Atti Symposium
Arco di Trento;
62. Parietti P., (1974), Lipnosi nella preparazione della gestante, Medicina Psicosomatica, 24-
366;
63. Parietti P., (1977), La formazione dellipnoterapeuta, Rassegna di ipnosi e medicina psico-
somatica 34-999;
64. Parietti P., (1980), La formazione psicologica delloperatore sessuologo, Sessuologia 5- 15;
65. Parietti P., (1983), Il rilassamento ipnotico in psicosomatica, Atti 9 Congresso Simp, Tori-
no;
66. Parietti P., (1987), Esperienze di ipnosi in psicoterapia, Prospettive in Psicologia, gennaio
1987;
67. Parietti P., (1989), La tecnica ipnotica, in Del Corno - Lang, Psicologia Clinica, F.Angeli
ed.;
68. Parietti P., Guantieri G., (1977), Ipnosi e Psicoterapia, Rassegna di ipnosi e medicina psi-
cosomatica;
69. Parietti P., Minella E., (1970), Psicoprolassi ostetrica e metodiche ipnoterapiche, Atti Congres-
so Sippo, Milano;
70. Pavesi P., (1962), Lipnosi medica in Italia e allestero, in Ipnosi medica, ed Amisi, Milano;
71. Piazza C., (1999), Aspetti di rilievo nella formazione del personale impegnato nel trattamento di sog-
getti con problemi psichiatrici: la relazione ipnotica come strumento, Acta Hypnologica n 2 - 3;
72. Piazza C., (2000), Dalla frammentazione specialistica alla comunicazione unicante; lipnosi
nellottica psicosomatica, Acta Hypnologica n 1;
73. Piazza C., Brugnoli A., Guerra G., (2000), Lutilizzazione dellipnosi nel dolore cronico, Acta
Hypnologica n1;
74. Zeig J.K., (1995), Metodi diretti e indiretti: artefatto ed essenza, in Del Castello- Loriedo,
opera citata;
75. Zenoni M.L., (1987), Il tradursi dellaggressivit verbale e non verbale attraverso il linguaggio
del corpo in ambito ipnologico - Atti XI Congresso Simp 1987, Messina.
Piero Parietti Psichiatra, Psicoterapeuta, Pres. Societ Italiana di Medicina Psicosomati-
ca - Direttore Scientico Centro Studi Psicoterapia Integrata Immaginativa ad Espressione
Corporea.
Elisa Faretta Psicologa e Psicoterapeuta, Responsabile e Coordinatrice Centro PIIEC
- Milano, Cotrainer e Supervisore EMDR Italia ed Europa. Direttivo SIMP e EMDR.
Indirizzo degli Autori: Centro PIIEC Milano
e.faretta@piec.com - p.parietti@piiec.com
sito: www.piiec.com
- 56 -
COSCIENZA / ESPERIENZA
MEDICINA E PSICOLOGIA SUL CAMPO
LA TERAPIA SISTEMICO - RELAZIONALE:
BASI TEORICHE.
Esperienza di Tirocinio con Studenti in Psicologia
Sabrina Iansante, Fausto Agresta, Alessio Bianconi,
Alessandra DAmato, Ilary Furno, Caterina Mangifesta,
Roberta Rastelli
Molti allievi di Freud, durante il periodo nazista, giungono in Europa,
in Svizzera e in Olanda, altri in America. Quindi in America, gi dagli anni
30 -40, si comincia a fare ricerca, in vista della guerra, sulle capacit intel-
lettive dei soldati attraverso luso dei test. Ci allo scopo di individuare, in
base alle caratteristiche psichiche, chi fosse pi idoneo a ricoprire determi-
nati ruoli.
In quel periodo, fu Kurt Lewin a sviluppare la psicologia sociale.
E. Tolman, il grande psicologo americano, ebbe a scrivere, in occasione del-
la morte di K. Lewin nel 1947: Nella storia della nostra epoca psicologica vi
sono due nomi, io credo, che spiccheranno su tutti gli altri: quelli di Freud e
di Lewin: Freud sar ricordato per aver per primo rilevato le complessit del-
la storia individuale, e Lewin per aver, per primo, mostrato le leggi dinami-
che secondo cui gli individui si comportano cos come fanno gli ambienti a
loro contemporanei. Freud, il clinico e Lewin lo sperimentalista, questi sono
i due uomini che saranno sempre ricordati per il fatto che il loro penetran-
te potere di osservazione, contrastante ma complementare, per primo rese
la psicologia una scienza applicabile ai reali individui e alla reale societ
(A. Ossicini, 1972). Si dice infatti che Kurt Lewin abbia fatto per il pensiero
sociale quello che Freud ha fatto per la psiche individuale. Grazie al suo
lavoro, e a quello dei suoi allievi, tra cui David Rapaport e Merton M. Gill,
la teoria sociale comincia a diffondersi stimolando molte ricerche nellam-
bito della relazione interpersonale e in quello dello studio pi specico dei
legami tra i membri di un gruppo. Prima dello studio delle famiglie molte
esperienze erano indirizzate, in tutti i paesi, sulla relazione diadica madre-
bambino ed erano nalizzate alla conoscenza intrapsichica di tipo analitico
ed al trattamento terapeutico dei soli bambini sempre pi disturbati, come
i ritardati gravi, gli autistici e gli schizofrenici. Tra il 40 e il 50 si studiava,
specie negli Stati Uniti, rispetto allInghilterra, la relazione sociale madre-
bambino, a senso unico, come se la relazione madre-bambino non si potesse
studiare liberamente; lo studio delle carenze materne confermarono, in
generale, il concetto della madre schizofrenogica che Frieda Fromm-Rei-
chmann coni nel 1948; al tempo stesso, J. Rosen identic nelle madri
perverse un aspetto nocivo del rapporto col glio. Forse, da questa posi-
zione, dalla monade alla diade inizi il percorso evolutivo della relazione
del reciproco madre-bambino. Dal 1950 al 1960 queste ed altre ricerche
si focalizzarono non solamente sulla diade madre-bambino, ma sul ruolo
del padre e, quindi, della famiglia come responsabile della salute emotiva
- 57 -
del bambino. Cos lapproccio terapeutico si spost dal provare a cambiare
una persona col provare a cambiare sequenze di comportamento tra le
persone (F. Agresta, 1997). Di conseguenza, negli anni 50, molti terapisti
familiari convocavano e portavano in terapia famiglie intere con lo scopo di
cambiare la relazione (o le relazioni) tra i membri stessi della famiglia.
Le ricerche in ambito sociale cominciano cos a moltiplicarsi e di parti-
colare rilievo sono quelle condotte dagli studiosi della scuola di Palo Alto in-
torno agli anni 50. Si tratta di un gruppo di studiosi eterogeneo, di cui face-
vano parte loso, epistemologi, sici, dai quali ci giungono importanti ricer-
che sulla comunicazione. Figure di spicco furono G. Bateson e P. Watzlawick.
In America lambito di studio sociale ebbe grande impulso tanto che si
giunse, tra la ne degli anni 50 e l inizio degli anni 60, a prendere in consi-
derazione la malattia mentale (autismo, anoressia) come frutto del sociale.
Lampliamento del focus attentivo degli studiosi dalla diade alla triade
fa s che nelle ricerche non si prenda pi in considerazione soltanto la rela-
zione madre-bambino, ma anche il ruolo del padre: il contesto di interesse
ne risulta ampliato. Quindi avviene un primo passaggio dalla diade alla tria-
de e successivamente verr presa in considerazione tutta la famiglia.
Finch la scienza si interessata allo studio dei rapporti lineari, uni-
direzionali e progressivi di causa-effetto, molti fenomeni di estrema impor-
tanza sono stati esclusi dallimmenso territorio che la scienza ha conquistato
negli ultimi quattro secoli. Con lavvento della cibernetica e la scoperta della
retroazione stato possibile introdurre il concetto di circolarit. Una catena
in cui levento a produce levento b, e poi b produce c, pu sembrare che
abbia le propriet di un sistema lineare deterministico, ma se c riconduce ad
a il sistema circolare e funziona in modo completamente diverso. Quindi,
i sistemi interpersonali gruppi di estranei, coppie sposate, famiglie ecc.
possono essere considerati circuiti di retroazione, poich il comportamen-
to di ogni persona inuenza ed inuenzato dal comportamento di ogni
altra persona (P. Watzlawick P. et alii, 1971). I comportamenti rappresentano
la modalit comunicativa attraverso la quale i membri del sistema interagi-
scono. In questa ottica il sintomo di colui che viene denito paziente desi-
gnato, allinterno di un sistema familiare, assume il signicato dellespres-
sione di un disagio di tutta la famiglia.
Ecco perch il terapeuta sistemico-relazionale prende in terapia tutta
la famiglia: al suo interno tutti hanno gli stessi diritti, stessi doveri, stesse re-
sponsabilit. Bisogna quindi avere una visione globale, gestaltica delle rela-
zioni nella famiglia e la mancanza anche di un solo membro non consente di
intraprendere il percorso terapeutico. Di solito gli stessi familiari hanno una
concezione lineare del sintomo: mio glio che sta male!. Compito del
terapeuta sistemico-relazionale quello di renderli consapevoli del fatto che
ognuno ha le proprie responsabilit. Questo un passaggio fondamentale
perch soltanto dopo lacquisizione di questa consapevolezza sar possibile
lavorare sulle dinamiche comunicazionali del sistema familiare. Queste an-
dranno prima attentamente osservate per poi, in un secondo momento, far
notare ai membri di questo sistema ci che si osservato: quando c un sinto-
mo c una modalit comunicativa disfunzionale e su questa bisogna lavorare.
Basi teoriche della comunicazione. Presentiamo ora un esempio, de-
scritto in Pragmatica della comunicazione umana di P. Watzlawick et alii,
- 58 -
per introdurre un concetto fondamentale riguardante lo studio del com-
portamento: un uomo improvvisamente colto da malore viene portato in
ospedale. Il medico che lo visita riscontra: stato di incoscienza, pressione del
sangue bassa e in genere un quadro clinico compatibile con quello causato
da intossicazione acuta da alcool e stupefacenti. Le analisi per non rilevano
nessuna traccia di tali sostanze: la condizione del paziente resta inspiegabile.
Una volta ripresa coscienza, luomo spiega di essere un ingegnere minerario
e di aver lavorato per due anni in una miniera di rame sulle Ande a quasi
quattromila metri di altezza e di esserne appena tornato.
Le informazioni ulteriori che vengono fornite permettono di capire
che la condizione del paziente non una malattia nel senso che di solito
diamo a questo termine, ma il problema di adattamento di un organismo
clinicamente sano ad un drastico cambiamento di ambiente. Un fenomeno,
quindi, resta inspiegabile nch non includiamo, nel campo di osservazio-
ne, informazioni sul contesto. Per cui ogni comportamento, incluso il
sintomo, inteso come comunicazione disfunzionale, acquista signicato se
correlato al contesto e alle interazioni che in esso avvengono. Questo con-
cetto assume grande importanza nellambito clinico: la comprensione del
paziente sar ben diversa se lo inquadriamo in base alla visione della psichia-
tria classica che si focalizza esclusivamente sul portatore del sintomo o se
invece inseriamo, inscriviamo, il suo comportamento in un contesto familia-
re attraverso una lettura che pone lattenzione sulle modalit comunicative
tipiche di quella famiglia.
Primo assioma della comunicazione: Introduciamo ora il primo assioma
della comunicazione attraverso uno sketch. Il contesto: due passeggeri, un
uomo e una donna, sono in aereo, luno a anco allaltra. Due studenti si
preparano alla piccola esperienza: Luomo cerca di avviare una conversazio-
ne con la donna che per si dimostra disinteressata:
U: No, sono un po teso, no Mi crea un po di Partiamo ok
No, e poi questa sciarpa E poi In effetti ho anche una caramella per la
gola Cos, e No, veramente, ho un mal di gola assurdo,e poi Marted
scorso Credo di essermi raffreddato l Perch poi stavo giocando a cal-
cetto no e E poi io a farmi il go, con la maglietta andavo sbracciato
cos quindi Che poi giustamente mia madre dice: logico tu , lo
so per capisco che in un contesto del genere bisogna anche adattarsi, poi
quali sono le condizioni Non so. Tu che pensi?
D: Silenzio Sbuffa
U: No, perch poi uno se ci pensi bene No, ci sono delle situazioni
in cui uno non sa cosa dire, in effetti no Eh, allora c un Mi ricordo
un amico di mio padre mi diceva: No, guarda tu, mi raccomando, quando
sei nelle condizioni che non sai cosa dire parla o del tempo come fanno gli
inglesi oppure chiedi: A cosa pensi? E quindi interessante questa cosa
cos No belle le scarpe comunque Sono Sono belle
D: Silenzio
U: Sai, avevo una ragazza La mia ex ragazza Ci siamo lasciati gi
da un po Da un anno e mezzo o due Sai che somigliava molto a te?...
No, no, davvero Mi devi credere Non lo sto dicendo per Cos per
veramente, e poi carina come te e Come ti chiami?
D: Silenzio Guarda altrove
- 59 -
U: Eh, lo so, sei un tipo tosto che non parla per ti assicuro che
questa ragazza era carina come te Poi anche il segno zodiacale impor-
tante Lei era dello scorpione E tu? Di che segno zodiacale sei? Beh, io
sono nato a settembre Un tipo interessante No, dicono che quelli nati
a settembre sono tutti inquadrati, tutti precisi S, in effetti vero, lo dice
anche il mago Joseph Lo conosci In televisione Quello che legge le
carte Hai una caramella?
D : Sbuffa
U: Ah, lo psicodramma! Ma anche tu fai lo psicodramma? Scommet-
to Scommetto che tu fai la musa!
Commento: I due attori dicono di aver provato entrambi disagio. Lui
cercando di instaurare una conversazione con una persona che, sia pure
attraverso il non verbale, manifestava il suo riuto; lei dovendo subire
lintrusivit dellaltro. Dal momento che egli dice di aver percepito il riuto
e un senso di disagio, possiamo asserire che laltra, pur stando in silenzio,
qualcosa labbia comunicato. Ecco quindi il primo assioma della comunicazione:
NON SI PU NON COMUNICARE. Ogni comportamento comunicazio-
ne. Lattivit o linattivit, le parole o il silenzio hanno tutti valore di messag-
gio: inuenzano gli altri e gli altri, a loro volta, non possono non rispondere
a queste comunicazioni e in tal modo comunicano anche loro.
(Esperienza attiva e pratica con i Tirocinanti che hanno recepito an-
che le linee teoriche generali della Terapia sistemico- familiare).
BIBLIOGRAFIA
1. Agresta F., (1988), Dialoghi e sogni in psicoterapia, (Pref. G. Lai), Riza, Milano.
2. Agresta F., (1997), Malattie psicosomatiche e Psicoterapia Analitica. Individuo, Coppia, Fami-
glia, Gruppo, (Pref. E. Gilliron), N. Prospettive in Psicologia, Pescara; II Edizione, 2004.
3. Agresta F., (1999), Modelli Psicoterapeutici in Psicosomatica: Il processo di mentalizzazione in
una coppia psicosomatica, Atti XI Congresso della SIMP, Universit di Siena, (a cura di M.
Reda e D. Benevento).
4. Agresta F., (2002), Problemi di Psicologia Generale e Clinica, ed. Nuove Prospettive in Psi-
cologia, Pescara.
5. Agresta F., (2003), La Coppia Hurricane. Psicoterapia dinamica, N. Prospettive in Psicolo-
gia, Anno IX, n. 2., novembre 2001, (fasc. n. 30).
6. Agresta F., (2007), Problemi di Psicosomatica Clinica, Ed. Quaderni del CPP, n. 3, Pescara.
7. Agresta F., (2007), Psicosomatica clinica e processo di mentalizzazione in Quaderni di Psico-
terapia dellIREP (a cura di L. Cianciusi, M. Baldassarre, P. Petrini), Famiglie oggi e
psicopatologia. Famiglie ieri e nuove patologie emergenti, Alpes, Roma.
8. Agresta F., (2006), Sindrome di somatizzazione multipla: Clara, i suoi sintomi e le vertigini,
Med. Psicosomatica, 51 (2): 97-106.
9. Agresta F., (2007), Psicoterapia Analitica, tecniche di rilassamento corporeo, approccio familiare
e farmacoterapia: Gianni e la sua rettocolite ulcerosa, Med. Psicosomatica, 52 (4): 167-176.
10. Agresta F., Rotondo A. M., Agresta D., De Luca R., Franchi B., Sigillo E., Fulcheri M.,
(2008), Artrite reumatoide e bromialgia. Caso clinico di coppia psicosomatica, Med. Psico-
som., 53 (3): 135-146.
11. Agresta F., (2010), Il Linguaggio del Corpo in Psicoterapia, Glossario di Psicosomatica,
(Pref. P. Parietti), Ed. Alpes, Pescara.
12. Amerio P., (1973), Fondamenti teorici della psicologia sociale, Nuova Italia, Firenze.
13. Andol M., (1977), La terapia con la famiglia, Astrolabio, Roma.
14. Ashby W. Ross, (1956), An introduction to Cybernetics, London, Chapman & Hall, Ldt.,
[trad. It. Introduzione alla cibernetica, Torino, ed. Einaudi].
15. Assoun P. L., (1997), Corps et Symptme. Tome 1. Clinique du Corpos, Anthropos, Paris.
- 60 -
16. Caill P., (1993), La coppia, questa sconosciuta e la sua domanda, in la Terapia di coppia,
Psicobiettivo, Anno XIII, n. 1.
17. Delle Chiaie R., (2004), Presentazioni atipiche dellansia: quadri somatoformi, situazionali e
forme subsindromiche, Med. Psicosom., 49 (1-2):9-16.
18. Dolto F., (1984), Limmagine inconscia del corpo, Editions du Seuil, Paris.
19. Eiguer A., Rufot, et alii, (1984), La Terapia psicoanalitica di coppia, Borla, Roma, 1986.
20. Galli A., Lacerenza A., (1992), Note sulla comunicazione, Realt e Prospettive in Psico-
siologia, n.3/4, Roma.
21. Garavaglia S., (2007), Diario di Psicosomatica, Tecniche Nuove, Milano.
22. Gilliron E., (1993), Manuale di Psicoterapia Analitica, EUR, Roma.
23. Gilliron E., (1997), Il primo colloquio in psicoterapia, Borla, Roma.
24. Haley J., (1975), Verso una teoria dei sistemi patologici, in Zuk, La famiglia, cit.
25. Helgeland H., Sandvik L., Mathiesen S. K., Kristensen H., (2010), Childhood predictors of
recurrent abdominal pain in adolescence, Journal Psychosomatic Research, 68; 359-367.
26. Kaufman J. C., (1997), La trame coniugale, Editions Natan, Paris.
27. Kohler W., (1961), La psicologia della Gestalt, Ed. Giunti, Firenze.
28. Kronholm E., Partonen T., Salminen J.K., et alii, (2008), Alexithymia, Depression and Sleep
Disturbane Symtomps, Psychotherapy and Psychosomatics, 77:63-65.
29. Kronholm E., Partonen T., Salminen J.K., et alii, (2008), Alexithymia, Depression and Sleep
Disturbane Symtomps, Psychotherapy and Psychosomatics, 77:63-65.
30. Lewin K., (1951), Field Theory in social science, Harper and Brothers, New York.
31. Lichtenberg J. D., (2005), Mestiere e ispirazione. Guida alle psicoterapie esplorative, Raffaello
Cortina Editore, Milano, 2008.
32. Lorenz K., (1978), Laltra faccia dello specchio, Adelphi, Milano, 1991.
33. Maremmani I., et alii, (1988), Sintomatologia depressiva ansiosa e malattie reumatiche: con-
fronto tra pazienti affetti da artrite reumatoide, bromialgia, spasmolia e depressione maggiore
ricorrente, Medicina Psicosomatica Vol 33, n.2, pagg. 125-138.
34. Marty P., (1991), Mentalisation et Psicosomatique, Les Empcheurs, Paris.
35. Masina E., (1988), Patologia della coppia coniugale: i sintomi psicosomatici, Medicina Psico-
somatica, 33: 2171-279.
36. Minuchin S., Rosman B. L., Baker L., (1975), Famiglie psicosomatiche: lanoressia mentale
nel contesto familiare, Astrolabio, Roma, 1980.
37. Norsa D., Zavattini G. C., (1997), Intimit e collusione. Teoria e tecnica della psicoterapia
psicosomatica di coppia, Raffaello Cortina Editore, Milano.
38. Onnis L., (1984), Lorientamento sistemico in psicosomatica, Aggiornamenti, Med. Psicoso-
matica 29:509-533.
39. Onnis L., (1996), La narrazione analogica. Luso del linguaggio metaforico, Psicobietti-
vo, Settembre/Dicembre 1996, Anno XVI, n.3, Roma.
40. Onnis L., (1997), Se mio glio ha lasma, F. Angeli, Milano.
41. Onnis L., (2001), La terapia familiare oggi: sviluppi e integrazioni, Intervista (a cura di F.
Agresta), N. Prospettive in Psicologia, Anno IX, (Fasc. n. 26).
42. Ossicini A., (1972) Kurt Lewin e la psicologia moderna, Ed. Armando, Roma.
43. Psicobiettivo (1993), La Terapia di coppia, Anno XIII, n. 1, Roma.
44. Saccani P., (1982), Psicoanalisi e terapia familiare, Il Ruolo terapeutico, Milano, n. 32.
45. Telfener U., Malagoli Togliatti M, (1983), Dal modello omeostatico al modello evolutivo, in
La terapia familiare: nuove tendenze in terapia familiare, ed. Astrolabio, Roma.
46. Trevi M., (1996), Simbolo e simbolico. Oscillazione di signicato, Simboli, metafore e psico-
terapia, Psicobiettivo, Settembre/Dicembre 1996, Anno XVI, n.3.
47. Watzlawick, Beavin J. H., Jackson D.D., (1971) Pragmatica della Comunicazione Umana,
Casa Editrice Astrolabio Ubaldini Editore, 1975, Roma.
48. Watzlawick P. e al., (1965), Pragmatica della comunicazione umana, Casa Editrice Astrola-
bio Ubaldini Editore, Roma;
49. Zavattini G.C., (1977), Dalla monade al sistema: saggio sullapproccio relazionale di Palo Alto,
ed. Bulzoni, Roma.
Redazione
Direzione
- 61 -
PSICOSOMATICA NEL MONDO OCCIDENTALE
ED ORIENTALE:
DAL SIGNIFICATO AGLI SVILUPPI TEORICI*
(seconda parte)
Edoardo Giusti, Bonessi Alessandra, Garda Virginia
[La prima parte stata pubblicata sul n. 2, Novembre, 2010 (Fasc. n. 44),
di N. Prospettive in Psicologia].
Gli anni 80-90 portano ad una piena oritura della psiconeuroimmu-
nologia, tuttavia soltanto dal 2000 in poi che si dato inizio alla valutazio-
ne attendibile della letteratura disponibile. Molti studi non possono essere
considerati validi essendo metodologicamente scorretti (campioni troppo
piccoli, analisi statistica insufficiente o assente, scarsa compatibilit dei
dati). Il dato certo in ogni caso che, al di l di tutte le ricerche effettuate,
metodologicamente corrette e non, esiste una relazione tra la guarigione
psicologica e spirituale e linatteso recupero da malattie diagnosticate a volte
come mortali, come nel caso della patologia cancerogena, e i dati a disposi-
zione indicano che il sistema immunitario coinvolto. Il concetto di sistema
immunitario introdotto dalla nuova immunologia si propone in tal modo
come organo di senso, come rete cognitiva, composta da un insieme di unit
di riconoscimento dellambiente interno. Il limite di questo modello, per,
sempre quello di considerare lorganismo come uomo-macchina, la cui
identit psicosomatica viene recuperata solo a livello della biologia e della
chimica. Insieme agli approcci di causalit lineare, come il modello medi-
co-biologico, sono da considerare i contributi provenienti dallarea sociale,
che hanno favorito ricerche soprattutto nellambito dei legami tra i membri
di un gruppo; si fa strada, cos il modello sistemico, basato su una causalit
circolare. Al sintomo si attribuisce un valore di comunicazione e signica-
to stabilendo una relazione di inuenza reciproca tra paziente e contesto
interattivo, sostituendo, cos, ad un modello lineare uno di tipo circolare.
Varie sono le ricerche sulle relazioni gruppali e i progetti di studio con le
famiglie patologiche e/o normali in quanto ci si rende conto che tutta la
famiglia in gran parte responsabile della salute emotiva dellindividuo.
Prima ancora dello studio delle famiglie, molte ricerche erano indirizzate
soprattutto alla relazione diadica madre-bambino, nalizzate alla conoscen-
za intrapsichica e al trattamento terapeutico di bambini con ritardi gravi,
autistici, schizofrenici, mirando in particolare a cambiare la percezione
dellindividuo indipendentemente dalla gura che se ne prendeva cura,
in genere la madre. Molti studi sulle psicosi infantili, per, prendevano in
considerazione il comportamento della madre, molto spesso negativo e
nocivo, e sottovalutavano laltro aspetto della relazione, ovvero linuenza
negativa sullo sviluppo del bambino. Dalle ricerche sulla famiglia comincia-
ABBIAMO RICEVUTO
- 62 -
va a emergere che il paziente designato rispondeva allatteggiamento della
madre nei suoi confronti, come dimostrano le ricerche di Spitz sul marasma
o lospedalizzazione, quella di Bettelheim sulla madre nociva, le ricerche di
Levy sulliperprotettivit materna e la carenza affettiva e quelle di Rank sul
bambino atipico (Agresta, 1997). Le ricerche successive degli anni 50, 60
coinvolsero oltre la diade madre-bambino anche il padre, dunque la famiglia
intera (triade) come contenitore della salute emotiva del bambino. Siamo
ancora per ancora nellottica causale lineare in cui la famiglia rappresenta
la causa di una qualche malattia del paziente; solo successivamente, tra la
ne degli anni 60 e gli inizi degli anni 70, si approda ad un orientamento
sistemico della malattia psicosomatica. Si allarga, cos, il concetto di famiglia
in cui si colgono le interdipendenze dei membri come facenti parte di un
sistema come unit strutturale. La famiglia come sistema ununit inscindi-
bile dove il sintomo che compare in un membro parte della dinamica inte-
rattiva delle relazioni familiari; ad esempio, il sintomo di un glio polarizza
solo su di s lattenzione della famiglia e ne controlla lequilibrio. Il paziente
che si fa portavoce del sintomo non una vittima passiva ma attivamente
contribuisce al perpetuarsi degli eventi che coinvolgono lintera famiglia
attraverso meccanismi di retroazione. Secondo L. Onnis, noto studioso ita-
liano dei disturbi psicosomatici, il sintomo, anche se psicosomatico, acquista
valore di comunicazione allinterno di unorganizzazione interattiva, stabili-
sce uninterrelazione reciproca, per cui famiglia e sintomo psicosomatico si
rinforzano circolarmente e di conseguenza lintervento terapeutico non
pi orientato solo allindividuo ma allintero sistema familiare di cui fa parte
(Agresta, 1997). Nel lavoro terapeutico condotto con famiglie di pazienti
con disturbi psicosomatici, il sintomo psicosomatico diventa leggibile se lo
si osserva nel contesto in cui compare. A tal proposito, numerose ricerche
cercano di esplorare le dinamiche intrafamiliari ed i condizionamenti che
possono provocare, agendo come stress emozionali, la comparsa dei distur-
bi psicosomatici. A questo proposito, c in lone dincontro tra le teorie
sistemico- relazionale e la psicoanalisi, da una parte, e la visione olistica
e psicosomatica, dallaltra: segnaliamo, per questo, due volumi di Fausto
Agresta, particolarmente interessanti e stimolanti sul versante della clinica
psicosomatica e della psicoterapia analitica: Il primo, Malattie Psicosomatiche e
Psicoterapia analitica (1997; II Ediz. 2004); laltro recentissimo, Il Liguaggio del
corpo in psicoterapia. Glossario di Psicosomatica, Alpes (2010). un testo molto
importante per conoscere, attraverso i casi clinici, ci che accade in psicote-
rapia psicosomatica con indirizzo analitico.
Gi le ricerche di Pinkerton (1967), in particolar modo sullasma
bronchiale, cercano di stabilire una correlazione tra gravit del disturbo ven-
tilatorio di un gruppo di bambini asmatici e le tensioni emotive derivanti
dalle rispettive dinamiche familiari, distinguendo le famiglie, sulla base del-
lattitudine affettiva e interattiva dei genitori nei confronti del bambino, in
prevalentemente iperprotettive, prevalentemente riutanti e ambivalen-
ti (Del Verme, Paga et all., 1989). Questi studi dimostrano come il sintomo
psicosomatico, anche in un contesto relazionale osservabile, sia portavoce di
una rete comunicativa; si sposta quindi lattenzione dallindividuo al sistema.
Si ipotizza inoltre, che alcuni sistemi familiari siano strettamente correlati
allo sviluppo e al mantenimento di disturbi psicosomatici nei bambini e che
- 63 -
tali sintomi giochino un ruolo importante nel mantenimento dellomeostasi
familiare. Lo confermano, ad esempio, le ricerche di Minuchin su famiglie
con diversi disturbi psicosomatici: famiglie di pazienti diabetici, anoressici,
obesi o asmatici che, indipendentemente dal sintomo psicosomatico presen-
tato, rivelano modelli di interazione in cui sono presenti caratteristiche di-
sfunzionali che contribuiscono a mantenere equilibri, anchessi disfunziona-
li. Secondo Minuchin, i modelli interattivi inadeguati che caratterizzano la
struttura familiare sono quattro: invischiamento, iperprotettivit, rigidit e
mancanza di risoluzione del conitto; attraverso la terapia Minuchin preve-
de di modicare le rigide regole interattive di queste famiglie per attenuare
il sintomo. Tali studi mettono in evidenza il passaggio da una concezione di
causalit lineare ad una circolare, superando il concetto di famiglia nociva
o di genitore patogeno e scoprendo che anche il paziente inuenza attiva-
mente lorganizzazione familiare cos come essa inuisce su di lui e sulla sua
malattia. proprio questa iterrelazione circolare tra i membri che permette
di considerare la famiglia come un sistema (Del Verme, Paga et alii, 1989).
Gli studi di Minuchin sono ritenuti validi ancora oggi dalla maggior parte
dei terapeuti familiari, non solo da quelli ad orientamento sistemico. Pur-
troppo, per si ancora troppo ancorati ad un modello scientico alquanto
tradizionale e ad un approccio terapeutico individuale, laddove la concezio-
ne moderna della psicosomatica implica, come sottolineato pi volte, una
visione globale ed unitaria che integri vari punti di vista con le eventuali dif-
ferenze e contraddizioni. Solo in unottica dinsieme si pu restituire alles-
sere umano la sua complessit; ci signica inserire la totalit psicosica
dellindividuo nel proprio contesto sociale ed ambientale, superando la con-
cezione monocausale delle malattie e proponendo una visone multifattoria-
le della concezione psicosomatica. Un apporto importante alla psicosomati-
ca lo ha dato la bioenergetica con Lowen, medico psicoanalista, formatosi
alla scuola di Reich e direttore dellIstituto di Analisi Bioenergetica di New
York. Lowen ha spostato il baricentro della societ occidentale troppo con-
centrato nella testa, ai plessi energetici centrali e inferiori; egli riequilibra le
energie della persona lavorando sul piano logoterapeutico, sul corpo nel qui
ed ora, sulle emozioni e sulle percezioni motorie impiegando veri e propri
esercizi ginnici, di respirazione, di vocalizzazione, di correzione della postu-
ra e massaggi (Chimirri, 2004). La bioenergetica associa, quindi, il lavoro sul
corpo con quello sulla mente considerandoli funzionalmente identici; quel-
lo che succede nella mente riette quello che succede nel corpo e viceversa.
La relazione tra corpo, mente e processi energetici espressa attraverso una
formulazione dialettica. I processi energetici del corpo sono in relazione
con lo stato di vitalit del corpo stesso. Pi si vivi, pi energia si ha e vice-
versa. La rigidit e la tensione cronica diminuiscono la vitalit e abbassano
lenergia; la rigidit dovuta alle tensioni muscolari croniche il risulto di
conitti emotivi irrisolti. Ogni fattore stressante produce uno stato di tensio-
ne nel corpo che persiste anche quando il fattore di stress eliminato. Tali
tensioni muscolari croniche disturbano la salute emotiva riducendone
lenergia; occorre alleggerire la tensione cronica se si vuole che lorganismo
riacquisti vitalit e benessere emotivo (Lowen A., Lowen L., 1979). La bioe-
nergetica lavora sul corpo per aiutare le persone ad entrare in contatto con
le proprie tensioni e a rilasciarle attraverso movimenti appropriati. Sottoli-
- 64 -
nea il contatto sico con la persona, massaggi, pressioni controllati e leggeri
contatti per rilassare i muscoli contratti e ci costringe ad una lettura del
corpo e ad una riorganizzazione del proprio Io. Tali lavori bioenergetici aiu-
tano la persona ad acquistare maggiore padronanza di se stessa e migliorano
lo stato di vibrazione del corpo. Allentamento delle tensioni corporee, libe-
razione delle tensioni trattenute ed insight, sono i tre fattori determinanti
secondo lanalisi bioenergetica. Ogni persona composta da una corazza
caratteriale e da una corazza muscolare come evoluzione e risposta dei
traumi infantili non risolti. Sulla base dei cinque diritti fondamentali del
bambino (il diritto di esistere, il diritto di avere bisogno, il diritto di essere
autonomo, il diritto dimporsi, il diritto di amare sessualmente), Lowen indi-
vidua cinque tipologie caratteriali, con i relativi tratti somatici e psichici: il
carattere schizoide, il carattere orale, il carattere psicopatico, il carattere ma-
sochista, il carattere rigido. Il carattere una struttura costruita dallIo nel
corso del suo sviluppo e funziona come difesa dal dolore derivante dai biso-
gni primari non soddisfatti. Non esistono strutture caratteriali pure, ma su
un tratto di base, che corrisponde alla fase in cui si creato il primo blocco,
si aggiungono altri tratti difensivi, in base al tipo di risposte ambientali allin-
dividuo durante la crescita (Giusti, Montanari, Montanarella, 1997). La
bioenergetica lavora sulla stretta interdipendenza tra corpo e psiche miran-
do a ristabilire le energie siche e psichiche della persona. Lintegrazione
strutturale (Rolng) creata dalla biochimica e siologa Rolf una tecnica
che mira a correggere le imperfezioni e distorsioni nella struttura corporea
mediante lo scioglimento delle tensioni somatiche, attraverso massaggi pro-
fondi. Lintegrazione posturale Postural Integration, ideata dal dr. Jack W.
Painter, un approccio corporeo che considera lindividuo nella sua totalit
psicosomatica riconquistando lunit mente-corpo originale. Con lintegra-
zione postulare Painter si propone di rinormalizzare quegli spazi sici e
mentali necessari per riportare lindividuo nel suo normale e corretto equili-
brio dinamico. un processo di sviluppo del potenziale presente nellessere
umano e pone lattenzione non solo sul contatto sico, ma su cosa la perso-
na sente, su come percepisce e pensa nellimmediatezza dellesperienza
corporea nel qui ed ora. un metodo unicato che mira a migliorare la po-
stura, lo schema e limmagine del proprio corpo, a rilassare e a riorganizza-
re il sistema muscolo-facciale posturale, a valorizzare le risorse psicologiche
personali, a migliorare le capacit espressive, a integrare i cambiamenti nel-
le relazioni di vita. Il metodo Feldenkrais (dal nome del suo fondatore), detto
anche metodo dellintegrazione funzionale, ha anchesso contribuito allo
sviluppo della psicosomatica; lobiettivo quello di migliorare la motilit del
corpo e, soprattutto, promuovere cambiamenti nel sistema nervoso impri-
mendo nella propria mente una nuova immagine di s. Il metodo stato
applicato a molte patologie gravi come le paralisi cerebrali, le poliomeliti e
le meningiti. La meditazione trascendentale, che ha origine nelle losoe e
religioni orientali, ha fornito una perfetta integrazione del corpo con la
mente nellottica della migliore qualit della vita delluomo. Il corpo rilas-
sandosi profondamente riequilibria le pulsioni, risolve i conitti emozionali,
distende la coscienza e recupera il proprio s. una tecnica che ha avuto
una grande espansione in Occidente; realizzata attraverso la ripetizione di
un proprio riposo profondo e una serie di modicazioni siologiche che
- 65 -
sono documentate dalla riduzione del consumo dellossigeno, da modica-
zioni del ritmo respiratorio, da un aumento della resistenza cutanea e da un
rallentamento del ritmo cardiaco di circa tre battiti al minuto (Castrogiovan-
ni, Maremmani, 1993). Anche il Training Autogeno, messo a punto dal neuro-
logo berlinese J.H. Schultz agli inizi del Novecento, adotta un metodo di la-
voro sul corpo e sulla mente; egli lo denisce metodo di rilassamento con-
centrativo. Attraverso il Training la persona pu acquistare la capicit di ri-
manere tranquilla e calma; Autogeno sta per conseguimento con i propri
mezzi (Luban-Plozza, Pldinger, 1984). Il Training Autogeno caratterizza-
to dal fatto che facilmente apprendibile, richiede una apllicazione di tem-
po relativamente breve e soprattutto un esercizio assiduo. Sono esercizi che
vengono effettuati senza sforzo, piacevolmente, rappresentando i propri sen-
si sici e determinati cambiamenti del corpo in modo intenso e chiaro.
Schultz riconosce che limmaginazione profonda dei vissuti corporei che
comportano la distensione; la capacit di ritornare in completo rilassamento
dopo unattivit stata una misura perduta dalluomo oggi. Numerosi sono i
metodi, orientali ed occidentali, che hanno inuenzato lo sviluppo e lap-
profondimento della psicosomatica, contributi che fanno della salute e del
benessere psicosomatico una visione dinsieme, olistica, multidisciplinare.
La psicosomatica moderna, come si visto, una scienza relativamente gio-
vane e la matrice dualistica della visone scientica ha opposto resistenza al-
lintegrazione della pluralit di teorie, approcci, concezioni che compongo-
no lampio universo della psicosomatica. Attualmente, la modalit con la
quale si concepisce la salute e la malattia ancora troppo ancorata ad un
modello meccanicistico. Si valuta il corpo come un insieme di organi, si se-
para la malattia dallindividuo, si separano le emozioni dalle parti del corpo
ad esse connesse, si cerca di delimitare i sintomi anzich le cause, conside-
rando la malattia e non il malato e delegando ad altri la responsabilit della
propria salute. Si considera, pertanto, lindividuo come somma di tante parti
anzich una totalit; si orientati ancora troppo verso la specializzazione, la
frantumazione, perdendo di vista lunit biopsicospirituale dellindividuo.
La tendenza a credere che individuando una malattia la si possa controllare
e/o guarire pu servire ad eliminare i sintomi, ma non certo latteggia-
mento adeguato per eliminare le cause, che hanno radici dentro di noi; la
malattia ci segnala che c qualcosa di molto profondo da rivedere, da muta-
re, da risolvere. Dai vecchi codici meccanicistici e causalistici che avevano
contribuito alla cultura della frammentazione, dal paradigma dicotomico
della divisione cartesiana tra corpo e anima, tra scienza e spiritualit che
ha prodotto una scienza senza anima di tipo meccanicistico, si passa alla
cultura della globalit, ad una visione olistica del mondo e di se stessi che
propone una nuova vita basata sullevoluzione interiore, sul rispetto delles-
sere umano e della natura (Frigoli, Cavallari, Ottolenghi, 2000). Olismo, dal
greco holos che signica lintero, il tutto, un modo unitario e organico di
vedere la realt, lessere umano e lesistenza; riconosce che anche lorgani-
smo vivente parte integrante di sistemi pi ampi: lambiente sico e socia-
le, con i quali in continua interazione, capace di modicare il soggetto ed
anche di essere modicato in profondit dallorganismo. Il concetto di oli-
smo, ovvero di Gestalt, di Totalit centrale in tutte le psicoterapie ad orien-
tamento fenomenologico-esistenziale; , dunque, ununit inscindibile in s,
- 66 -
il superamento della scissione soggetto-oggetto, il sentirsi nel corpo, nel-
le sensazioni, nella vita, laddove lesperienza umana oscilla continuamente
tra la sensazione di avere un corpo e quella di essere il nostro corpo, si sciol-
gono le rigide divisioni tra corpo, mente e spirito, si passa dalla testa al cuo-
re e si sperimenta un modo pi immediato di sentire lenergia che anima il
nostro essere. Il paradigma olistico un modo unitario e organico di vedere
la realt, lessere umano e lesistenza, non si tratta di una semplice concezio-
ne losoca che pu essere acquisita studiando, ma di una visione che pre-
suppone una analoga esperienza olistica del proprio essere. Cinque secoli fa
Theophrastus Paracelsus (1493-1541) insegnava i principi di una medicina a
misura duomo; egli sosteneva che lorigine delle malattie nelluomo e
non fuori di esso; ma le inuenze esterne agiscono sullintimo e fanno svi-
luppare le malattie Un medico dovrebbe conoscere luomo nella sua
interezza e non solo nella sua forma esterna. La malattia vista come un
indice di disagio ad altri livelli oltre quello sico, ed un segnale che ci per-
mette di individuarlo e risolverlo. Adottando questo punto di vista vedremo
che qualsiasi malattia ci induce a compiere un viaggio alla scoperta di noi
stessi, il cui risultato sar una trasformazione della nostra vita. Lapproccio
psicosomatico, pertanto, nega lesistenza del dualismo e vuole sottolineare la
totalit della persona, piuttosto che focalizzarsi sulla malattia, anche se man-
cano cause psicogene alla malattia stessa. La malattia, quindi, non unenti-
t autonoma, ma solo un effetto di un sistema di apparati collegati tra loro.
La pratica clinica dimostra che i pazienti, comunque vengano classicati i
loro disturbi, esprimono una sofferenza che allo stesso tempo sica ed
emozionale. Oggi si cerca soprattutto di recuperare la voce del malato, dopo
che stato a lungo considerato un organismo muto. Non c mai una ma-
lattia, ma una persona malata, che va trattata interiormente. Il senso della
sofferenza, infatti, non si scopre ricercando solo linterazione di una cellula
o di un tessuto, ma piuttosto attraverso un approccio multidisciplinare verso
il malato, i cui problemi vengono considerati a livello biologico, psicologico
e sociale. Nella concezione olistica, oltre alla considerazione che tutto in-
terconnesso e ci che accade in un luogo si ripercuote istantaneamente su
tutto ci che esiste, si assume che ogni parte contenga lintero; in ogni no-
stra cellula riprodotto lintero programma della nostra salute, noi siamo
tutto ci che esiste e tutto ci che esiste in noi, dentro di noi vi lintero
universo. In questa concezione, ogni istante presente eterno e comprende
la totalit del tempo e dello spazio. Dal punto di vista olistico, tutto ci che
pensiamo, che mettiamo in atto per guarirci condiziona e pu aiutare anche
gli altri. Se pensiamo olisticamente, i nostri sintomi, la nostra malattia, la
nostra esperienza diventeranno i nostri alleati, poich ci indicheranno la
strada per risolvere gli squilibri, per ristabilire lo stato di salute, ovvero ripri-
stinare lequilibrio che in un certo momento si era incrinato. Nella conce-
zione olistica della malattia psicosomatica, inne, i pazienti devono prender-
si la responsabilit della loro salute senza degradarla; riconosce che un sinto-
mo pu essere sico, ma la causa pu essere mentale. Gli organi e tutto il
corpo non sono pi disgiunti tra di loro, il corpo non pi scisso dalla men-
te, e corpo e mente non sono pi separati dallo Spirito. Non esiste un pri-
mato del corpo sulla psiche, n viceversa, perch lo psichico si esprime nel
linguaggio del corpo ed il corpo in quello dello psichico. Tutto intercon-
- 67 -
nesso in questa nuova visione che privilegia linterdipendenza; solo in que-
stottica globale possiamo adeguatamente affrontare il signicato della
malattia psicosomatica. Abbiamo esaminato i vari modelli che hanno caratte-
rizzato la medicina psicosomatica no ad oggi, ma ogni teoria e i diversi
modelli psicoterapeutici rappresentano solo un particolare punto di vista di
un osservatore in un determinato contesto sociale, culturale, storico. Lo stes-
so paziente visto in situazioni e periodi di vita diversi pu presentare proble-
mi che richiedono luso di modelli differenti rispetto a quelli usati inizial-
mente nellincontro con il cliente. Il terapeuta deve essere in grado di valu-
tare con attenzione quali sono le procedure terapeutiche pi adeguate per
la persona ed il suo problema, e denirne circostanze e tempo. Solo il tera-
peuta che possiede un punto di vista pluralista pu individuare i vari proble-
mi di sofferenza del paziente e intervenire utilizzando i diversi contributi da
ogni singolo modello (Giusti, Montanari, Montanarella, 1997). La psicotera-
pia un processo strutturato ed interattivo di una prassi complessa e essibi-
le allo stesso tempo, in cui due umane presenze si incontrano per collabo-
rare verso obiettivi di cambiamento (Giusti, Montanari, Lannazzo, 2000).
Varie ricerche hanno evidenziato come nessun modello psicoterapeutico
pu condursi lunico valido efcace per produrre il cambiamento terapeuti-
co. Per questo motivo, un terapeuta che ha una conoscenza operativa dei
diversi approcci psicoterapeutici ha una visione pi ampia che gli permette
di lavorare con varie tipologie di persone e di disagi, a differenza del tera-
peuta che rimane circoscritto al suo modello adottando lo stesso approccio
ed intervento terapeutico per ogni tipo di paziente e problematica. La scelta
delluno o dellaltro modello, infatti, produce una diversa valutazione del
problema e una diversa strategia di intervento psicoterapeutico. Un modello
secondo Falco (2001), pu essere denito integrativo nella misura in cui ri-
conosce che esso integra in modo coerente elementi di altri modelli, ritenu-
ti limitati, e nello stesso tempo mantiene la consapevolezza di essere un mo-
dello storico che dovr diventare parte di un modello superiore da cui sar a
sua volta superato (metamodello). Considerare la malattia psicosomatica
sotto un prolo pi eclettico, globale, pluralistico-integrato, signica anche
uscire da un prolo e da un intervento solo di tipo medico, offrendo strate-
gie di lettura e dintervento pi aperte e differenziate. I primi studi con in-
tento integrazionista risalgono ai primi anni 40 e avevano lobiettivo di tra-
sferire concetti e metodi di un approccio psicoterapeutico ad un altro, ma
tra gli anni 80 e90 che la psicoterapia integrata ha acquisito una congura-
zione specica, favorita soprattutto da una serie di fattori individuati da Na-
cross e Newmann (1992), quali: un numero sempre maggiore di psicotera-
pie; il fallimento di singole terapie rispetto allefcacia; una mancanza di
una correlazione diretta tra il successo della terapia e leffettivo cambiamen-
to del comportamento; laumento di terapie focalizzate a breve termine; una
maggiore comunicazione tra teorici motivati alla terapia integrata; un limita-
to supporto socioeconomico da parte di terzi per una psicoterapia tradizio-
nale a lungo termine; lidenticazione di alcuni fattori comuni a tutte le
psicoterapie che favoriscono il successo terapeutico; organizzazioni profes-
sionali, convegni, conferenze e giornate di studio sul tema della psicoterapia
integrata. Negli ultimi trentanni, sulla scia anche di questi fattori, c stato
un grande incremento di psicoterapie; negli anni 80 si individuavano pi di
- 68 -
460 tipi diversi di psicoterapie. Inizialmente la rigidit delle posizioni che
caratterizzavano gran parete degli approcci rendeva difcile il dialogo rivol-
to al rispetto della differenza e di punti di vista in comune; nellultimo de-
cennio la competizione ideologica si andata attenuando e vengono fatti
dei tentativi concreti per avere una maggiore cooperazione tra teorici e cli-
nici e una maggiore disponibilit anche da parte dei terapeuti di cercare
anche in altri orientamenti quei fattori che possono essere utili per il tratta-
mento di pazienti e problemi differenti. Ci ha reso utile la necessit di ri-
cercare gli elementi in comune che rendono efcaci le varie psicoterapie; le
ricerche di Grencavage e Narcross (1990), hanno messo in evidenza, come
anche altri studi precedenti, che il fattore comune che rende efcace la psi-
coterapia la relazione terapeutica, a seguire, gli aspetti connessi alle quali-
t del terapeuta e alle caratteristiche del paziente. Costruire una relazione
stabile, sicura, nutriente che aumenta notevolmente la motivazione e limpe-
gno nel processo terapeutico no a promuovere presupposti per un cambia-
mento terapeutico. Cambiamenti superciali e profondi non si escludono a
vicenda e possono alternarsi a seconda del momento che il paziente attra-
versa. Non si pu affermare a priori che un dato intervento produrr un
cambiamento pi o meno profondo rispetto ad altri, ma quello che pu fare
un terapeuta che sposa qualsiasi approccio di mettere il cliente in condi-
zione di attivare la propria riorganizzazione. Il rapporto terapeuta-paziente
assume infatti, notevole importanza e diventa potente agente terapeutico,
indipendentemente dalle tecniche utilizzate. La qualit e la forza della rela-
zione quindi fondamentale per determinare il cambiamento (Giusti,
1989). Nellambito della relazione sono state utilizzate due tendenze: quella
del saper fare il terapeuta e quella del sapere essere un terapeuta; luna o
laltra inuenza la struttura e la direzione che assumer il processo terapeu-
tico. Il modello fenomenologico esistenziale insiste sul saper essere un buon
terapeuta anche se le due direzioni non si escludono reciprocamente, il sa-
per fare diviene un problema quando si usa troppo la tecnica in maniera
tale da distorcere la relazione terapeutica (Giusti, 1997). Le qualit che fan-
no del terapeuta un buon agente di cambiamento riguardano la capacit di
essere empatico ed aperto, di accogliere e rispettare il cliente. La modalit
agevolativa da parte del terapeuta contiene sia gli elementi tradizionali della
terapia centrata sul cliente come il calore, lempatia, la trasparenza, la ge-
nuinit e laccettazione incondizionata, sia lagevolazione nei lavori terapeu-
tici, ovvero la non direttivit nel processo. Pi il cliente percepisce il tera-
peuta come reale, autentico, empatico, pi egli si allontaner da una moda-
lit di funzionamento interpersonale, rigida, orientandosi verso una modali-
t di funzionamento accettante e con sentimenti personali differenziati. Un
altro fattore centrale che fa della terapia un indice di cambiamento sono le
caratteristiche del cliente. Il coinvolgimento attivo e motivato del cliente
fanno di lui un potenziale agente di cambiamento. Il cliente trova conforto
e aiuto da una relazione duciosa con un terapeuta coinvolto, che mette in
gioco anche gli aspetti personali, si alimenta dellaccettazione e dellatteg-
giamento rassicurante e di conferma del terapeuta tale da elevare il suo po-
tenziale di autostima e di orientarlo al cambiamento. Il cliente, infatti, con-
trariamente al passato, pu sentire che realmente il terapeuta crede nelle
sue capacit, che non riutato quando esprime sentimenti aggressivi e che
- 69 -
resta saldo di fronte a sentimenti di forte sofferenza e disperazione rispet-
tando il suo conne. Con questa esperienza interpersonale correttiva il
cliente interiorizza gli atteggiamenti del terapeuta, imparando a far proprio
il suo lavoro, no a diventare terapeuta di se stesso. Il cliente il miglior
esperto della sua vita, agente proattivo e risolutore dei propri problemi a
differenza della visione classica che vedeva il terapeuta come lesperto e
agente del cambiamento (Greenberg et all., 2001). Tali fattori confermano
sempre pi che la qualit e la quantit di addestramento dei terapeuti ai vari
approcci nellottica dellintegrazione, cos come la loro personalit, sono
variabili determinanti per lefcacia. In tale ottica pluralistica, la malattia
psicosomatica implica losservazione attraverso una pluralit di modelli di
interpretazione e di lettura della realt, la cui integrazione non un omolo-
gazione semplice di un modello allaltro, n un tentativo di riprodurre un
modello totalizzante che pretende di riassumere gli altri, ma sottolinea lap-
plicazione di un sistema operativo e strutturato di conoscenze che permetto-
no al terapeuta di valutare i pazienti e i loro problemi, e di intervenire in
modo appropriato. I sistemi integrati concordano sul fatto che non esiste
nessuna forma di miglioramento terapeutico superiore, o pi importante, di
una qualsiasi altra. Essi riconoscono limportanza di tutti i livelli di vita psi-
cologica nella patologia e nella salute: motivazioni inconsce, esperienze con-
sapevoli, affetti, cognizioni, comportamenti e relazioni interpersonali. Inol-
tre, ogni ambito desperienza deve essere considerato come potenzialmente
equivalente ad ogni altro, come causa o conseguenza di un comportamento
disturbato o sano (Gold, 2000). Lintervento integrato sceglie lapplicazione
di determinate tecniche terapeutiche invece che altre in base a quanto evo-
ca il cliente, alle sue caratteristiche di personalit e alla sua storia, mante-
nendo lattenzione alla relazione e alla compatibilit cliente-terapeuta. Solo
il terapeuta, con un percorso di addestramento sistematico e accurato nel-
lottica pluralista pu entrare nei diversi stadi di sofferenza del paziente ed
individuare lintervento per lui pi indicato. Le conoscenze tecniche dello
psicoterapeuta, le abilit interpersonali e la condivisione di una certa etica
professionale permettono di lavorare con il paziente psicosomatico nellotti-
ca dellintegrazione, quella che Mahrer (1989) ha denito la combinazione
della molteplicit delle teorie in un numero maneggevole di elementi ope-
rativi comuni e in un vocabolario di termini dal signicato condiviso. Lin-
tegrazione, dunque, permette di superare lottica clinica tesa alla medicaliz-
zazione della malattia psicosomatica e di passare da un approccio pi uni-
versale orientato alla promozione del benessere psicosico secondo il con-
cetto base di salute olistica.
Bibliograa: consultare il volume.
*Questo testo tratto dal volume: Salute e malattia psicosomatica: signicato, diagnosi e cura,
Giusti E., Bonessi A., Garda V., (2006), Capitolo 3 pag. 97 - 127, Editrice Sovera, Roma.
Ringraziamenti: Si ringrazia il Prof. E. Giusti per la pubblicazione di questo interessantissimo
lavoro, tratto dallimportante pubblicazione.
- 70 -
Edoardo Giusti Presidente dellAISPEC e direttore della scuola di specializzazione in Psicote-
rapia Integrata autorizzata con Decreto Ministeriale. E professore a contratto presso la Scuola
di specializzazione in Psicologia Clinica dellUniversit degli Studi di Padova. Svolge attivit di
ricerca clinica e di supervisone didattica per psicoterapeuti.
Indirizzo dellAutore: Prof. Edoardo Giusti
Via Vittore Carpaccio, n. 32 00147 Roma
Tel: 06 5413513 Fax:06 5926770
E-mail: aspic@mclink.it
Web: http://www.aspic.it
Alessandra Bonessi Psicologa e psicoterapeuta e consulente in sessuologia clinica. Svolge at-
tivit privata ed opera in ambito scolastico sia con lo sportello dascolto sia conducendo gruppi
di educazione socio-affettiva. Inoltre ha approfondito la tematica del fenomeno dellintrover-
sione come possibile fenomeno di disagio.
Virginia Garda Psicologa e psicoterapeuta, svolge attivit privata a Roma e Salerno. Col-
labora con la Societ Italiana di Medicina Psicosomatica, sezione Salernitana. Si occupa di
formazione e della conduzione dei gruppi esperienziali allinterno dei corsi ECM per medici
di medicina di base.
ABBONAMENTO A
Nuove PROSPETTIVE IN PSICOLOGIA
Il costo di UN SOLO NUMERO della Rivista di DIECI (10) Euro.
L'Abbonamento annuale A DUE (2) NUMERI della Rivista N. PROSPETTIVE
IN PSICOLOGIA di SEDICI (16) Euro.
LAbbonamento per LESTERO di VENTI (20) Euro.
L'importo relativo (abbonamento, numero singolo o altro) deve essere versato
sul CC POSTALE N. 188.836.52 ed intestato: ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIA-
NA Nuove PROSPETTIVE IN PSICOLOGIA - Via Bologna, 35 - 65121 PESCARA (I).
P.S. Specicare bene la causale del versamento.
La rivista on line: Rivista Nuove Prospettive in Psicologia
http://www.prospettiveinpsicologia.com/sinapsi.html
ON-LINE: http://www.prospettiveinpsicologia.com/index.html
- 71 -
GLI ASPETTI PSICOSOMATICI DELLA GASTRITE
E DELLULCERA. CASI CLINICI
Ilarj Furno, Anna Maria Rotondo,
Emilia Sigillo, Fausto Agresta
Gastrite acuta e cronica. Prime ricerche
Utilizzando la denizione del Dizionario di Psicosomatica di R. Morelli, P.
Parietti et alii: La gastrite uninammazione della mucosa dello stomaco (mucosa
gastrica) le cui cause sono tutto ci che aumenta lacidit gastrica o diminuisce le bar-
riere protettive della mucosa, come stress psicologici o ingestioni di agenti corrosivi, tos-
sici e farmacologici. Nella classicazione di Anacleto Peracchia, Okolicsanyi Lajos,
Roncoroni Luigi, in Malattie dellapparato gastrointestinale (2004), i vari tipi di
gastrite sono suddivisi nella maniera classica: gastriti acute e croniche. Per
quanto riguarda le gastriti acute, sono forme di gastriti transitorie, caratteriz-
zate da lesioni erosive. Talvolta rimangono silenti, altre volte hanno esordio
anche drammatico con emorragia massiva e rischio per la sopravvivenza.
Nella forma cronica manca la componente erosiva, ma ritroviamo gli inltrati
tipici delle inammazioni croniche. Per quanto riguarda la sintomatologia,
nelle forme acute, la persona avverte forte dolore e/o bruciore nella parte
alta e centrale delladdome che si irradia talora al petto quando coinvolto
anche lesofago, con nausea e vomito. Nelle forme croniche presente sen-
so di pesantezza, bruciore, gonore addominale, digestione laboriosa con
eruttazione (Segen J. C., 2006). Gi alla ne del 1800 e agli inizi del secolo
scorso due grandi siologici inglesi, William M. Bayliss e Edward H. Starling,
avevano postulato la cosiddetta legge dellintestino come ci viene ricordato
nellarticolo Il cervello intestinale: neurologia e neurobiopatologia dellapparato
digerente (De Giorgio R., et alii, 2008). Sin dagli studi pionieristici dei due
siologi si not lesistenza di un sistema nervoso intestinale capace di agire in
maniera indipendente. La gastrite attacca, dunque, lo stomaco, un serbatoio
- come lo ha denito B. Luban-Plozza (1989) - che ha la funzione principale
di accumulare il cibo ingerito. Che cosa accade, nei pazienti psicosomatici?
Cosa signica vivere situazioni indigeste che non si riescono a mandar gi?
Il cibo che ingeriamo ricco di signicati simbolici. Come ci ricorda B. Lu-
ban-Plozza (1989): Il cibo rappresenta la forma primaria di possesso per assicurare
lesistenza, mentre la digestione la prima di tutte le forme di gestione e di utilizzo di
una cosa acquisita. In uno studio importante si evince chiaramente la stretta
correlazione tra funzioni gastro-intestinali ed emozioni. Barbara Mittelmann
e Helmut G. Wolff (1958) in, Emotions and Gastroduodenal Function. Experi-
mental Studies on Patients with Gastritis, Duodenitis and Peptic Ulcer, hanno no-
tato unipermotilit ed unipersecrezione gastrica associate a frustrazione,
senso di colpa e ansia. Lansia cronica, e gli stati di conitto che producono
reazioni ostili e tendenze aggressive, aumentano la secrezione gastrica e, se
persistono, provocano alterazioni della mucosa gastrica come avviene, ap-
punto, nella gastrite (Karger S., et alii, 1972).
Sappiamo che i pazienti psicosomatici si caratterizzano per lincapacit
ad esprimere verbalmente le emozioni, centrando, per contro, tutto linte-
- 72 -
resse sugli oggetti e sulla realt esterna. Hanno, inoltre, una scarsa tendenza
allintrospezione, sono poveri di attivit fantasmatica, incapaci di stabilire corretti
rapporti oggettuali nellinfanzia cos come afferma L. Kreisler (1981) nel suo
libro Lenfant du desordre psychosomatique. Particolarmente evidente il lin-
guaggio scarno, la notevole difcolt nel trovare le parole appropriate per
descrivere i propri sentimenti, la tendenza a lamentarsi prevalentemente ri-
guardo ai disturbi somatici; nello specico, i pazienti con patologie gastroin-
testinale, descrivono i sintomi in una grande variet di modi, come leggeri
gorgoglii o dolori laceranti o sensazione di vuoto al mattino (Cabras P.L., et
alii, 1985).
Ulcera Peptica (gastroduodenale). Prime ricerche
Lulcera (dal latino ulcus) una lesione della pelle o di un tessuto epi-
teliale, a lenta o difcoltosa o assente cicatrizzazione (Galimberti U., 1992).
R. Morelli, P. Fornari (2007) scrivono: Lulcera gastroduodenale la lesione
delle pareti interne dello stomaco (mucosa gastrica) e del duodeno, il primo tratto
dellintestino. Si sviluppa per azione dellacidit del succo gastrico (peptos vuol dire
acido), probabilmente a causa di uno squilibrio tra il grado di acidit e i meccanismi
protettivi. Il sintomo - come viene illustrato nel libro Le basi patologiche delle
malattie a cura di Vincenzo Eusebi (2007) - pi frequente dellulcera rap-
presentato dal dolore o da un bruciore molto forte e di solito ristretto ad
una piccola zona, posta in alto e al centro delladdome (spesso indicata da
coloro che ne soffrono come bocca dello stomaco). Il dolore ha un anda-
mento periodico durante la giornata e si presenta di solito a digiuno: per
esempio, durante le ore notturne o al mattino presto, si riduce con i pasti
oppure con gli antiacidi, ma si ripresenta qualche ora pi tardi. La lettera-
tura psicosomatica ha dedicato molta attenzione al paziente ulceroso. Il pa-
dre della Medicina Psicosomatica, F. Alexander, affermava: I pazienti ulcerosi
non appartengono a nessuno specico gruppo di personalit; tuttavia c sempre una
situazione conittuale in cui sono ostacolati desideri e bisogni derivanti dalla sfera
orale dellesperienza (affetto, ricompensa e dipendenza). Questa frustrazione trasfor-
mata da un meccanismo regressivo in un bisogno di ricevere cibo; di conseguenza, lo
stomaco riceve stimoli vagali anche al di fuori della fase digestiva (in, Luban-Ploz-
za, 1992). La teoria psicoanalitica di A. Garma sulletiologia delle ulcere ga-
stro-intestinale esposta in questo modo: La madre cattiva interiorizzata ma-
nifesta un comportamento aggressivo contro lindividuo rimasto in fase di regressione
digestiva-orale. () Di conseguenza, si accentua nellindividuo limmagine della
madre cattiva interiorizzata che lo aggredisce dal di dentro. Queste aggressioni interne
nei soggetti predisposti ad affezioni gastroduodenali, acquistano di preferenza caratte-
re digestivo. I soggetti, a causa di questo particolare sviluppo istintuale progressivo si
trovano in stato di regressione digestivo-orale (in, Ammon G., 1977). A. Garma,
come F. Alexander, daccordo su questo messaggio indirizzato dai genitori
al futuro ulceroso: Sii laborioso, sii abile, lavora altrimenti non farai nulla nella
vita. Ogni bisogno di protezione, ogni desiderio di amore stato represso
e la necessaria compensazione viene ottenuta attraverso una vita iperattiva,
ambiziosa, con evidenti desideri di dominazione e di grandezza. Lintreccio
di questo modus vivendi sarebbe lo scatenatore degli impulsi nervosi che,
provocando lipersecrezione e la contrattilit dello stomaco, causerebbero la
formazione dellulcera (Garma A., 1972).
- 73 -
Il paziente con gastrite. Ricerche attuali
Spingendoci oltre, negli studi pi ampi del settore, comprendiamo
che la malattia psicosomatica - come sostiene F. Antonelli (1973) - non un in-
cidente che colpisce dallesterno ma un evento ricco di senso, radicato senza eccezioni
nella reattivit della personalit profonda, determinato da problemi di adattamento.
Un malattia organica pu fare le veci di una turba psichica; un organo si
sacrica in difesa della persona e patognomica della storia del soggetto sa-
rebbe la scelta dellorgano. La scelta dellorgano comprensibile per il mezzo
di un simbolismo organico e quanto pi il sintomo somatizzato, tanto pi il
simbolo nascosto (Agresta F., 2007). Per inquadrare, a livello psicosomatico,
il disturbo del paziente gastritico necessario premettere qualche considera-
zione sulla psicologia del processo nutritivo e sullidenticazione tra cibo ed affetto,
afnch sia chiaro anche il linguaggio simbolico e la specica signicativit
dei disturbi psichici che sono somatizzati, quando laggressivit, lansia o
langoscia si scaricano sul corpo, in questo caso scegliendo lapparato
digerente o una determinata parte di esso (Agresta F., 2010).
Fin dalla prima infanzia lintero processo digestivo ha una ricca espres-
sivit emotiva che va dal valore simbolico del cibo e delle feci, allindubbia
inuenza degli stati emotivi acuti e cronici sulla funzionalit della digestio-
ne. La prima tensione emotiva percepita dal bambino la fame. Essa si placa
con lassunzione di cibo ed seguita dal soddisfacente senso di saziet, inti-
mamente connesso con la sensazione di sentirsi sicuro, protetto, amato. L
incorporazione orale, per usare un termine freudiano, un modo precocissi-
mo di placare la tensione spiacevole causata da un bisogno insoddisfatto, ma
anche di garantirsi un piacere (Antonelli F., 1973) .
Il bambino cerca di impossessarsi di ci che gradisce e di aggredire e
distruggere o respingere ci che lo disturba. Oggetti e soggetti, situazioni e
persone, vengono vissuti come cibo. Ci sono per degli esempi patologici
del simbolismo del cibo come i disturbi delle funzioni digestive, in particolar
modo, le nevrosi gastriche. La nevrosi gastrica riportando le parole di F. Anto-
nelli: un disturbo che costituisce il primo passo verso unulcerazione della mucosa
gastrica. Fattori organici e psichici convergono con pari frequenza e responsabilit.
Ma opportuno notare che alcuni fattori organici sono a loro volta espressione di
disturbi psichici. A tal proposito B. Luban-Plozza parla di suicidio intestinale
come equivalente suicida di un sintomo psicosomatico. Si riscontra nei
pazienti affetti da questa sindrome uneziologia emozionale comune: una
nutrice vissuta come ostile pu favorire una sovralimentazione oppressiva,
una ingestione forzata di cibo nauseante, un drenaggio illogico degli intesti-
ni cos che il bambino non riuscir mai a controllare il suo tratto intestinale.
La tendenza autodistruttrice interferisce progressivamente nel meccanismo
delle funzioni intestinali (Agresta F., 2007). In Salute e malattia psicosomatica.
Signicato, diagnosi e cura, Edoardo Giusti, Alessandra Bonessi e Virginia
Garda (2006), fra i disturbi del tratto gastrointestinale, considerati come
psicosomatici, indicano la gastrite, la stitichezza cronica e la diarrea cronica.
Questi sono indicati come processi inammatori che indicano in termini
psicosomatici, quanto una persona stia affrontando situazioni di stress detta-
ti da fattori contingenti che limitano la sua libert esercitando un controllo
eccessivo su ogni aspetto della vita.
- 74 -
Il paziente ulceroso. Ricerche attuali e internazionali
Molti studi vanno alla ricerca dei fattori che contribuiscono alla forma-
zione dellulcera peptica. Nel 1983 venne condotta una ricerca presso lUni-
versit di Atene, poi pubblicata su Psychoterapy and Psychosomatics. Nellartico-
lo dal titolo Peptic Ulcer in Adults. Psychopathological, Environmental, Characte-
rological and Hereditary Factors, gli studiosi presentano le loro osservazioni sui
fattori ereditari, psichiatrici, psicologici e psicosociali nei bambini affetti da
ulcera peptica. Nel gruppo dei pazienti ulcerosi, messo in relazione ad un
gruppo di controllo, si nota una frequenza elevata di disturbi psichiatrici, di
personalit introversa, di tentati suicidi. In questa ricerca, lipotesi dello stu-
dio di George N. Christodoulou, Bertha H. Alevizos, Edward Konstantakakis
era che lulcera peptica nei bambini, fosse causata da un evento traumatico
nel primo anno di vita del bambino e i risultati confermarono ci che era
stato ipotizzato. Lo studio venne poi replicato alla popolazione adulta in cui,
dopo lutti familiari o altri eventi stressanti della vita, era stata diagnosticata
lulcera dopo aver trascorso un vissuto di ansia e depressione.
Nel 1985 al X Congresso SIMP (Chieti-Pescara) G. Stracquadaneo,
dirigente del Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) di Imperia,
espose una ricerca condotta con i suoi collaboratori basata sullesame di vari
gruppi di pazienti affetti da ipertensione, ulcera peptica, asma bronchiale e
psoriasi nei quali si valuta lesistenza o meno di concomitante patologia psi-
chica, con particolare riferimento ai disturbi affettivi.
Nel 2009 stato pubblicato uno studio su Journal of Psychosomatic Re-
search dal titolo Autonomic activity and somatic symptons in response to success vs.
failure on a cognitive task: A comparison of chronic abdominal pain patients and well
children. Questo studio va ad analizzare un comune problema pediatrico,
ossia il dolore addominale cronico associato ai disturbi gastrointestinali. Martina
Puzanovova, Patrick G. Arbogast, Craig A. Smith, Julia Anderson, Andr
Diedrich, Lynn S. Walker analizzano due gruppi di pazienti, coloro che la-
mentano dolori addominali e un gruppo di bambini sani, cercando di ca-
pire la causa dellinsorgenza del disturbo nei bambini. Innanzitutto c una
correlazione molto alta tra gli eventi vissuti nel periodo della scuola, ritenuti
stressanti, e i dolori addominali. Gli studi dimostrano che le situazioni che
si presentano negli anni scolastici possono causare turbe al tratto superiore
dellapparato digerente.
Modelli teorici e prassi clinica. La psicoterapia Analitica
La gastrite e lulcera peptica sono delle patologia di conne tra la Me-
dicina Interna e la Psichiatria che rientrano nel classico paradigma di ma-
lattia psicosomatica. Dal punto di vista strettamente medico le caratteristi-
che psicologiche dei pazienti affetti da tali patologie, si evidenziano dopo la
comparsa della malattia che pu coincidere con uno stress emotivo molto gra-
ve in soggetti che hanno gi una personalit tale da renderli pi fragili verso
una malattia che segna il corpo. Gli aspetti caratteristici studiati dai diversi
Autori sono lanalisi del linguaggio meticoloso e ricercato, spesso contorto e
confuso, lalessitimia abbastanza pronunciata con mancanza di fantasie e di
ricordi di sogni (Agresta F., 2007), laggressivit non espressa, la depressione
somatizzata a livello intestinale (Luban-Plozza B.,1992); poi, la mancanza di
fantasmatizzazione e una forte rimozione e negazione dei ricordi dei sogni
- 75 -
(Agresta F., 2010). Riguardo ai sogni, dai trattamenti analitici di pi pazien-
ti, essi appaiono dopo un inizio di terapia e sono chiamati sogni crus, cru-
di, come se fossero arrugginiti dentro le parole, in una strettoia ossessiva
tra signicato e signicante (Agresta F., 1997). F. Agresta, a proposito del
ricordo dei sogni che vengono ricordati con lavanzare della cura, sottolinea
che anche che questo ricordo favorisce la crescita e la possibilit che il mate-
riale crudo e sporco depositato da anni possa emergere, come processo
di mentalizzazione e di integrazione strutturata nellunit mente-corpo. Molto
importante la riattivazione della memoria legata a fatti emozionali forti e
conittuali (desomatizzazione) (2010). Questo processo dinamico-psicosoma-
tico, come pi volte ricordato nel libro di F. Agresta, Malattie Psicosomatiche e
psicoterapia analitica (1997) sottoscritto, nel testo, dagli argomenti di M. Sa-
pir e di E. Gilliron. Il processo pu iniziare soltanto partendo dalle terapie
corporee che favoriscono la possibilit di parlare di emozioni e di ritrovare
il preverbale relazionale, lallentamento delle difese psichiche e il rafforza-
mento delle difese immunitarie (Biondi M., 2003). Rispetto alla dimensione
qui denita preverbale, altrettanto importante considerare la possibilit
di trasformazione del pensiero secondo la funzione che W. Bion denisce
di revrie che la madre svolge nellinterazione con il proprio bambino. Il
sogno, nella teoria di Bion, evacua il materiale emozionalmente tossico. Ci
che resta, il pensiero cosciente, il frutto utilizzabile coscientemente dal
pensiero. Il paziente che soffre di patologie legate al tratto superiore dell
apparato digerente molto riluttante ad accettare la psicoterapia. Pertanto
la psicoterapia a lungo termine di solito viene di solito evitata dai pazienti
ulcerosi anche se le ricerche di M. Biondi hanno convalidato, senza ombra
di dubbio, che i dati biologici sono modicabili dalle parole, dalla talking
cure di freudiana memoria.
La Psicoterapia di Gruppo e la Gruppoanalisi
Nei gruppi di derivazione analitica, fondamentalmente di derivazione
freudiana, distinguiamo tre tipi di modalit di psicoterapia di analitica di
gruppo: analisi in, di, attraverso il gruppo. Queste tre diverse predisposizioni
indicano in modo paradigmatico che il gruppo lagente principale del pro-
cesso trasformativo che si svolge nel contesto delle tre pi diffuse modalit
di psicoterapia analitica gruppale (Agresta F., 1997). La terapia in gruppo, si
identica col lavoro terapeutico che viene svolto su ogni singolo partecipante.
La terapia di gruppo, si identica col lavoro terapeutico che viene perseguito
utilizzando tutte le dinamiche emotivo/relazionali ed interattive che parto-
no dal gruppo. La terapia attraverso il gruppo (o Gruppoanalisi), si identi-
ca, principalmente, col lavoro che il gruppo, non come somma di individui,
produce. Il gruppo, la mente del gruppo diventa il motore della terapia e il
leader, perde lattivit esteriore e rimane pi in ombra. E la forma pi estre-
ma di psicoanalisi di gruppo, fondata da Siegfried Heinrich Foulkes. Proprio
S. H. Foulkes, per primo, aveva in terapia pazienti psicosomatici ed egli ne
riportava degli esempi sulla psicosomatica a pi riprese, gi nei suoi primi
scritti, come per esempio, nel 1948: Un individuo ha unulcera duodenale, una
malattia o perlomeno una sindrome ben denita e ben nota. I dolori ed i disturbi sono
tipici, possono essere dedotti dallesame sico. Ma qual la causa? Lulcera un effet-
to collaterale di una lunga catena di eventi (Foulkes S. H., Anthony E.J., 1958).
- 76 -
interessante approfondire uno degli studi pi importanti riguardo i
pazienti ulcerosi. Lo studio di Angel Garma, discusso nel libro Peptic Ulcer
and Psychoanalysis (1958) che descrive il processo di un gruppo terapeutico
composto inizialmente da soli membri affetti da ulcera. La psicodinamica in-
trapsichica dei pazienti ulcerosi dominata dal vissuto di una madre aggres-
siva interiorizzata e dalla regressione alla fase digestivo-orale. Per esempio,
la stasi del processo di gruppo stata superata accettando due pazienti con
colite ulcerosa e con dinamica opposta. Lautore, forte di tale esperienza, ha
successivamente trattato i pazienti ulcerosi solo in gruppi eterogenei. Lau-
tore not che questo gruppo di pazienti affetti da ulcera gastroduodenale
spesso taceva durante le sedute analitiche. A. Garma aveva limpressione che
il silenzio fosse dovuto ad una caratteristica evidentemente comune a tutti
i pazienti con questa sindrome: ingoiare, ossia tenere dentro di s quello
che li opprime. La terapia di gruppo ebbe termine dopo una anno e mezzo
di sedute settimanali. Nessuno dei pazienti, come A. Garma ipotizz, era
organicamente guarito; sia essi che i congiunti ritenevano per di notare un
progresso psichico di notevole portata.
Il Training Autogeno con Visualizzazioni Guidate
Il Training Autogeno con Visualizzazioni Guidate una tecnica di rilas-
samento corporeo iniziata da L. Peresson e da C. Widmann e, in seguito, ela-
borata dal Dott. F. Agresta, secondo il suo modello dinamico psicosomatico.
Nella struttura delle tavole di visualizzazioni rientrano il simbolismo, la metafora
e le analogie, il linguaggio del corpo, letto in chiave psicosomatica e psicodinamica
(Agresta F., 2001). Questo metodo si svolge attraverso esercizi base di H.
Schultz e afancate da visualizzazioni guidate, simboliche e programmate
che variano da seduta a seduta. Gli esercizi base hanno una nalit psico-
siologica e si propongono lattenuazione del sintomo e labbassamento dei
livelli di ansia, mentre le visualizzazioni guidate si occupano pi dellaspetto
catartico, psicologico, relazionale e sono nalizzate a dinamizzare lincon-
scio e a favorire la desomatizzazione di vari disturbi psicosomatici, specialmente
per tutti pazienti psicosomatici e alessitimici. Il T.A., quindi, favorisce la
normalizzazione dei fattori stressanti collegati alle patologie dellapparato
digerente, e non solo, tramite lautoregolazione delle funzioni motorie, va-
somotorie e secretive dellapparato gastrointestinale. Come affermano Pier
Luigi Cabras, Gian Paolo La Malfa, Fabio Giovannini, et alii, in Applicazio-
ne del training autogeno alle psicosomatosi gastrointestinali (Congresso SIMP,
1985), i soggetti che presentano una tipica modalit agli eventi stressanti
di tipo viscerale, possono trarre vantaggio da un contatto pi profondo e
rassicurante con il proprio corpo; un giovamento che probabilmente non
si limita allo smorzamento della risonanza affettiva, cio ad una riduzione
della risposta siologica allo stress. Il ne generale, di derivazione dal Rilas-
samento di M. Sapir, quello di abbassare le difese psichiche e preparava
- nelle parole di Sapir - il paziente di poche parole e chiuso nel proprio dolore alla
eventuale psicoterapia verbale (Sapir M., 1986).
Casi clinici. Anita: lulcera duodenale e il glaucoma nascosto
Anita, di 40 anni, venne inviata 6 anni fa da un medico dietologo,
amica del terapeuta. Quando arriv Anita sembrava una borghese quasi de-
- 77 -
caduta che si lamentava, sorridente e polemica dei suoi problemi di salute
e che lei, razionalmente, addebitava al tempo, al mangiare, ai problemi di
lavoro, alla storia, travagliatissima e ormai nita, con un uomo importante.
Gi dallinizio c stata una richiesta di aiuto sulla sua vita sregolata, su
una relazione con un uomo divorziato. Anita desiderava fare una terapia,
prendeva coscienza di stare male (dormiva solo due ore per notte) ed era
diventata abbastanza obesa e gonata (venti chili in pi). Parlava spesso
di questa storia damore nita male dove lei era stata scaricata, dove lei si
portava dietro problemi economici diretti e indiretti per le attivit che aveva
avuto insieme col suo uomo vip. Ora lei stava male in tutti i sensi, ma non
lo diceva apertamente. Infatti, Anita agiva da malata, ma parlava da persona
sana e non ammetteva, minimamente, che il terapeuta potesse allude-
re al suo stato psichico molto provato. Era molto sospettosa e polemica:
naturalmente, il simbolismo, lanalogia e la metafora, ovvero lo scherzo e
il gioco, non albergavano nella sua mente. Si era stabilita una psicoterapia
analitica di una seduta alla settimana che and avanti per tre anni circa.
Anita, del suo buco allo stomaco, non ne aveva parlato se non dopo circa
6 mesi. Durante il primo anno di terapia Anita aveva ripreso a dormire nor-
malmente, anche se aveva avuto attacchi di angoscia e per due volte era an-
data al Pronto soccorso. Analizzando lultimo anno di analisi, quello in cui
ci sono stati i maggiori cambiamenti possiamo dire che le problematiche ini-
ziali sono cambiate: in particolare adesso Anita racconta pi sogni, meno
logorroica, sopporta il silenzio, accetta di pi il lavoro interpretativo, comin-
cia a prendere coscienza di cose pi profonde e si difende molto meno. Il
discorso analitico e simbolico andato avanti, no alla ne della terapia tra
minori resistenze e maggiori aperture al simbolismo, alla metafora, al corpo
e ai sogni. Negli ultimi tempi Anita parlava solo di sogni, di simboli e, nal-
mente, anche lorario e gli occhi che spiavano erano cose del passato. Ani-
ta non andava nemmeno pi dalloculista per il suo glaucoma (la pressione
era normale). Per la prima volta, pentita, calma, si distende tranquilla e
racconta questo sogno: Ho sognato la morte e un piangere sommesso di mia ma-
dre. Era qualcosa di indescrivibile, poi langoscia si attenuata e mi rammaricavo di
non avvertirlo pi: questo nel sogno. Parliamo dellangoscia di morte che lei ha
sentito, dentro, nel sogno, per la prima volta senza somatizzare.
Anita, ritorna dopo lanalisi di tre anni e afferma che ha fatto un sogno
importante. Terapeuta: E la ne dellanalisi, come lha vissuta?. Anita dice
che non stata male se non per qualche giorno, e poi, Bene, bene, pensavo a
lei, dottore...ah, lho sognata, ma non lei, con la faccia del lavavetri: ho sognato che
mi puliva le vetrine. Io ho pensato a lei, ecco questo il Dottore Agresta. Chi mi pu
lavare, per...no, non mi lav in quel giorno perch venne pure dopo qualche giorno
questo signore...non solo la facciata esterna delle mie vetrine (del suo negozio) ma
entr anche dentro il negozio, quindi gli diede una bella ripulita. Dopo mi sono detta:
Eccolo qua, che cos questo lavavetri che ho sognato, ha pulito tutte le facciate, sono
stata bene...quando ho avuto degli attacchi, raramente, sono sincera, di angoscia,
per sapevo le cause, quindi mi sono calmata.
Gianni, 24 anni: i sogni incestuosi e i sensi di colpa
Gianni un universitario che stato inviato dal medico di famiglia per
una forma di gastrite che si riaccende da qualche tempo, anche se la prima
- 78 -
diagnosi era stata fatta circa due anni prima. Il ragazzo viene proprio con la
richiesta di curare la sua gastrite. Pian piano, comincia ad aprirsi e il quadro
familiare si struttura intorno ad una famiglia molto rigida e seria, repressi-
va e, al tempo stesso, la gura materna molto seduttiva ( una bella donna
e gira per casa in maniera discinta). Il giovane molto chiuso in se stesso,
parla molto di tutte le esperienze concrete: poche emozioni espresse, pochi
sogni, poche fantasie. La gura del padre quella di una personalit auto-
ritaria che accentra ogni cosa attorno a s, la moglie e laltra glia soppor-
tano ogni suo atteggiamento o comando, ma non fa mancare niente dal
punto di vista economico. Ad una condizione, cio, bisogna chiedere ogni
cosa: in questo modo tutti sono molto dipendenti dal padre. Questi vissuti,
dopo tre mesi, cominciano a venir fuori dai pochi sogni di Gianni. In parti-
colare, ci sono sogni legati alla gura materna che compare sotto altre vesti
donna che cucina, vecchia discinta, giovane donna senza sposo, etc., al
punto che Gianni sogna spesso la madre in atteggiamenti sessuali provocanti
e in espliciti inviti ad avere rapporti sessuali con lei. Spesso si sveglia con
eiaculazioni notturne, accompagnati da sogni erotici e incestuosi, sogni che
si riettono con estremo dolore allaltezza dello stomaco. I sensi di colpa
si fanno sentire non solo come somatizzazioni, ma anche come riessioni
coscienti. Il Terapeuta rappresenta il padre che ascolta i sogni provocatori
ed incestuosi. Cos il conitto inconscio amo mia madre e devo fare i conti
con mio padre, e il livello di realt nella relazione transfert-controtransfert
ri-somatizzato al livello di conitto intrapsichico e interpersonale col Tera-
peuta. Pian piano, questa dinamica si risolta e Gianni, non portando sogni
di ragazze che fa conoscere al padre, non deve pi difendersi dai sensi di
colpa edipici e vive adesso una vita psichica pi libera e meno conittuale.
BIBLIOGRAFIA
1. Agresta F., (1997), Malattie psicosomatiche e psicoterapia analitica. Individuo, coppia, fami-
glia, gruppo. (Pres. E. Gilliron). Nuove Prospettive in Psicologia, II Edizione, 2004
Pescara;
2. Agresta F., Serroni A., Rilassamento e visualizzazioni. Gruppi di formazione e dispense
non pubblicate, Seminari S.I.M.P. sez. Pescarese, 2002/2003;
3. Agresta F., (2006), Appunti delle lezioni Universit di Chieti, maggio - giugno;
4. Agresta F. (cura di), (2007), Problemi di Psicosomatica Clinica, CSPP, Pescara;
5. Agresta F., (2010), Il linguaggio del corpo in psicoterapia. Glossario di Psicosomatica. Alpes
Italia, Roma;
6. Alexander F., (1935), The logic of emotions and its dynamic back-ground, in International
Journal of Psychoanalisis, New York;
7. Antonelli F., (1973), Elementi di Psicosomatica. II Edizione, Rizzoli Editore, Milano;
8. Cabras P.L., La Malfa G.P., Giovannini F., et alii (1985), Applicazioni del training autogeno
alle psicosomatosi gastrointestinali. Medicina Psicosomatica, Vol. 30, Num. 4, Societ Edi-
trice Universo, Roma;
9. Christodoulou G.N., Alevizos B.H., Konstantakakis E., (1983), Peptic Ulcer in Adults. Psy-
chopathological, Environmental, Characterological and Hereditary Factors. In Psychoterapy and
Psychosomatics. S. Karger A. G., Basel;
10. De Giorgio R., Fustini E., Barbara G., et alii, (2008), Il cervello intestinale: Neurologia
e neurobiopatologia dellapparato digerente. Rivista di Nuove Prospettive in Psicologia,
Num. 39, Pescara;
- 79 -
11. Eusebi V., (a cura di), (2007), Le basi patologiche delle malattie. 7 Edizione, Elsevier
Italia, Milano;
12. Foulkes S. H., Anthony E.J. (1958), Lapproccio psicoanalitico alla psicoterapia di gruppo (a
cura di R. Pisani). Edizioni Universitarie Romane, 1998, Roma;
13. Galimberti U., (1992), Dizionario di psicologia. Unione tipograco Editrice Torinese,
Torino;
14. Garma A., (1971), Psicoanalisi dei sogni. Editori Boringhieri, Torino;
15. Garma A., (1958), Peptic Ulcer and Psychoanalysis. Williams and Wilkins Co, USA;
16. Giusti E., Bonessi A., Garda V., (2006), Salute e malattia psicosomatica. Signicato, diagnosi
e cura. Sovera multimedia s.r.l., Roma;
17. Karger S., (1972), Psychosomatic Classic. Buchdruckerei National-Zeitung AG, Basel;
18. Kreisler L., (1981), Lenfant du desordre psychosomatique. Privat Editeur, Toulouse;
19. Luban-Plozza B., Poldinger W., Kroger F., (1992), Il malato psicosomatico e la sua cura.
Casa Editrice Astrolabio, Ubaldini Editore, Roma;
20. Morelli R., Fornari P., Caprioglio V., et alii, (2007), Dizionario di Psicosomatica, a cura
dellIstituto Riza di Medicina Psicosomatica. Edizioni Riza, Milano;
21. Peracchia A., Lajos O., Roncoroni L., (2004), Malattie dellapparato gastrointestinale.
3 Edizione, Milano, McGraw-Hill;
22. Puzanovova M., Arbogast P.G., Smith C.A., et alii, (2009), Autonomic activity and somatic
symptons in response to success vs. failure on a cognitive task: A comparison of chronic abdominal
pain patients and well children, Journal of Psychosomatic Research, Elsevier, Milano;
23. Sapir M., (1984), Medico-Paziente: un corpo a corpo. Liguori Editore, Napoli;
24. Sapir M, (1986), Conversazioni registrate private (SIMP Pescarese: Dott. F. Agresta);
25. Segen J. C., (2006), Dizionario di Medicina Moderna. McGraw-Hill, Milano;
26. Stracquadaneo G., (1985), Un contributo clinico allo studio dei rapporti fra depressione ed
ulcera peptica. in Atti del X Congresso Societ Italiana di Medicina Psicosomatica Chieti-
Pescara, Edizioni Riza, Milano.
Ilarj Furno, Psicologa, Specializzanda in Psicoterapia c/o IPAAE, Redazione Rivista, SIMP
Pescarese.
Anna Maria Rotondo, Medico, Psicoterapeuta, Dirigente medico di Primo Livello ASL di
Ortona(CH), Direzione scientica Nuove Prospettive in Psicologia. Ha una formazione
psicoanalitica e psicosomatica e si formata nel Corso di Formazione della SIMP con F.
Agresta (individuale e gruppo SIMP: Pescara) e con il Prof. E. Gilliron (Supervisioni,
IREP: Roma). Membro dellA.E.R.P.S.Y. (Associazione Europea in Psicoterapia Psicoa-
nalitica) e ha conseguito il diploma di psicoterapeuta in sessuologia presso la Scuola
Superiore per la formazione e la ricerca in sessuologia (Presidenza: Prof. ssa J. Baldaro
Verde). Esperta di Tecniche di Psicoterapia Immaginale (Dr. A. Dacrema, Dott. F. Agresta)
e Docente e Didatta del CSPP. Ha pubblicato diversi lavori nel campo della psicosomatica
e del burn-out.
Emilia Sigillo, Psicologa CSPP, Specializzanda in Psicoterapia c/o IPAAE, SIMP Pescarese
e Redazione.
Fausto Agresta, Psicologo e Psicoterapeuta di formazione analitica, libero professio-
nista dal 1976.
Indirizzo degli Autori (per tutti): Dott. Fausto Agresta Via Bologna, 35 - 65121 Pescara
E-mail: fagresta@hotmail.com
- 80 -
SOCIAL DREAMING E MUSICOTERAPIA.
RIFLESSIONI SUI LABORATORI DI MUSICOTERAPIA
(Parte prima)
Domenico Agresta, Maria Clara Di Giamberardino
Esiste una risonanza tra mente e suono nellesperienza dellascolto
musicale? Ed il sogno una sorta di risonanza che, nel racconto e nella
condivisone di esso, permette di portare alla luce nuove connessioni e temi
dellesperienza tali da modicare losservazione del contesto, del campo,
della funzione e della qualit dei rapporti? Sappiamo da diverse ricerche ed
esperienze cliniche che queste domande trovano risposte positive ed affer-
mative. Secondo una proposta di Licia Sbattella, nel testo La mente orchestra
(2006), troviamo una analogia sulla funzione della musica e sul funzion-
amento della mente in relazione allascolto ed in rapporto al signicato del-
la funzione del sogno. Questo Autore parla di risonanza psichica della mu-
sica, come promotrice della logica psichica della musica e come promotrice
della logica affettiva dellesperienza, la quale compie un vero e proprio
lavoro di orchestrazione. La musica sviluppa armonie e connessioni sintat-
tiche fra parti dellesperienza molto eterogenee fra loro e, a volte, ancora in-
decifrabili cognitivamente o date da una semantica non denita. Nel sogno
e nellesperienza del gruppo ci maggiormente osservabile: si pu analiz-
zare e conoscere un qualcosa di simile se si associa a questa orchestrazione
il fatto del tema gruppale che diventa oggetto di analisi nel lavoro del rac-
conto del sogno e di trasformazione/conoscenza per i membri del gruppo.
La nascita del tema inconscio, non solo dellindividuo che porta il sog-
no, ma anche dellintero gruppo al lavoro, un esempio di orchestrazione.
Il gruppo, infatti, drammatizza, attraverso il sogno, lesperienza di un tema
che molto simile al lavoro della session musicale o della improvvisazione
di un gruppo di musica di insieme: nel suonare come se si stesse portando
alla luce ed in supercie un tema, esattamente come avviene nel campo del
gruppo di terapia. Questa la nostra ipotesi rispetto alle riessioni che sono
emerse durante i laboratori di musicoterapia. Lelaborazione della risonanza
psichica della musica, infatti, genera attaccamenti relazionali, associazioni
simboliche, catene di signicanti; genera signicati, costruisce mappe di
senso, congurazioni del S. Contrariamente a ci che affermano gli stu-
diosi degli approcci computazionali, la mente sembra pi funzionare come
una sorta di orchestra che come un computer che elabora linformazione
attraverso un percorso lineare e consequenziale. Inoltre, il sogno ha la stessa
modalit di orchestrazione e di regolazione delleconomia psichica della
persona ma anche dei processi di conoscenza che si basano e sono osserv-
abili in una logica differente e specica, quella simmetrica e asimmetrica,
denita poi da I. Matte Blanco bi-logica. La bi-logica cos denita per
il particolare articolarsi nella mente di due logiche antinomicamente com-
presenti in un pensare-sentire, cio la logica asimmetrica e la logica sim-
metrica, rispettivamente allorigine di un sentirsi parte del mondo oppure
tuttuno col mondo - stata in questi ultimi anni al centro di un fecondo
orire di studi nellambito di campi del sapere diversi, cio dallepistemo-
logia allestetica, dalla clinica psicoanalitica alle teorie della letteratura, no
- 81 -
allarcheologia. Il sogno, nella sua funzione e nel suo signicato relazionale,
porta alla scoperta di nuove esperienze ed anche, nel lavoro della ampli-
cazione tematica, alla costruzione di un signicato condiviso ed a un cam-
biamento intrapsichico unico ed originale. Nel lavoro dellesperienza della
Matrice di Sogno Sociale si possono osservare modalit di lavoro molto simili
a ci che accade in una seduta di musicoterapia di gruppo se il linguaggio
musicale e quello onirico/simbolico utilizzato come strumento di scambio
e di conoscenza al tempo stesso. Queste riessioni e queste prime analisi di
materiale musicale ed onirico, studiate ed osservate in gruppo, nascono da
esperienze di formazione e di didattica con musicoterapeuti.
Il Laboratorio ha permesso di riformulare ipotesi e pensieri in rela-
zione alle esperienze che i membri della Matrice hanno potuto vivere nei
loro interventi di musicoterapia. Non stata una esperienza di supervisione,
tantomeno di formazione in senso stretto, ma una situazione/esperienza
di educazione al pensiero sistemico, complesso ed inconscio. In tale modo,
una volta che si stati sensibilizzati ed indirizzati ad osservare il campo at-
traverso lenti nuove, si pu orientare una osservazione in un nuovo modo
creativo, pi approfondito e caratterizzato da un linguaggio complesso e
arricchito di nuovi signicati e contenuti. La caratteristica fondamentale
del Social Dreaming (SD) sta nellessere uno strumento che permette di en-
trare negli spazi aperti del divenire, nel rivelare la realt in movimento e di
scoprire nuove letture nelle relazioni dei membri di un preciso Sistema os-
servato. In questi termini, esso un valido strumento di ricerca intervento;
per i partecipanti: il SD pu facilitare la scoperta di aspetti fondamentali per
cogliere le sfumature presenti nella relazione daiuto senza giudicare, n
categorizzare, e senza entrare nella dimensione intima e psicopatologica dei
soggetti. Allo stesso tempo, la natura stessa del SD determina una sensibilit
maggiore al pensiero creativo che alla base di una buona relazione se lo
si associa allesperienza del costruire pensieri nuovi. Il laboratorio stato
un vero e proprio apprendimento allesperienza interumana. Il lavoro si
concentrato su di una modalit di studio di tipo dinamico e relazionale e,
fra lo stretto rapporto affettivo-conoscitivo, fra la cosa appresa, il discente
e il contesto: ci trasforma tutti i termini in gioco proprio perch si creano
nuove dimensioni emergenti del sapere della relazione che a sua volta ne
orientano lo sviluppo e ne condizionano il futuro.
La nostra ipotesi che anche la musica prodotta nellimprovvisazione,
durante la seduta, una creazione unica, musica creata in un tempo ed in
uno spazio particolare che non sar mai uguale ad unaltra improvvisazione.
Anche se venisse registrata, trascritta e riprodotta ci sarebbero comunque
delle sottili differenze nellesecuzione. Il fare o rieseguire la musica
unesperienza unica e irripetibile (Bunt L.,1997). In alcune culture e gruppi
sociali deniti group-individual, la musica, come il sogno, stata associata
con il modo attraverso il quale si costruisce il pensiero: entrambi svolgono
una funzione di conoscenza e di identit culturale. In questo senso ed in
questa tipologia di gruppo, lindividuo esiste per mezzo del gruppo e quindi
il suo pensiero il gruppo, cos come la sua identit. Nelle sedute di labo-
ratorio, nel momento in cui si passava dalla condivisione del sogno come
costruzione e conoscenza di pensiero, al lavoro di traduzione del linguaggio
musicale/sonoro come espressione emotivo-affettiva del linguaggio onirico,
i membri riferivano di vivere una esperienza di unisono. In questi gruppi,
- 82 -
non difcile associare al come si pu creare, nel campo del gruppo, un
modo di funzionare della mente che fa coincidere il pensare-sentire
allessere parte di un tutto e, allo stesso tempo, una parte del tutto: il termine
ed il concetto di Matrice ci sembra pi che appropriato per descrivere questa
esperienza. In effetti, la musica curativa fu spesso rivelata alluomo in sogno,
e la musica faceva parte della cura del sonno. Essa poteva anche svolgere
la funzione di ponte tra il reale e lirreale, il conscio e linconscio e questa
sua caratteristica stata documentata da un suo uso culturale e conoscitivo
nei gruppi sociali pi primitivi. Non solo: ad esempio, una ninna-nanna,
pu favorire il passaggio dalla veglia al sonno, o pu riportare alla luce, tra-
mite il fonosimbolismo, un ricordo da lungo tempo sopito (Alvin J., 1966).
Loscillazione dal conscio allinconscio ci porta a fare una considerazione in
musicoterapia rispetto al come si lavora nel processo psicoanalitico e, per
analogia, al come si pu intendere limprovvisare in musica: il processo pu
essere visto come il fantasticare o il sognare di tutti i giorni, in cui possiamo
esporre alcuni dei nostri sentimenti pi selvaggi ed incontrollabili (Bunt L.,
1997). A proposito dellosservazione dei contenuti inconsci e del modo in cui
si presentano al coscienza nel sogno, in musicoterapia, Rolando Benenzon
paragona gli archetipi di Jung al principio delliso
3
universale che racchiude
tutti i suoni ereditati dallindividuo ontogeneticamente e logeneticamente.
Fanno parte delliso universale gli archetipi sonori come il battito cardiaco,
i suoni di inspirazione ed espirazione, il suono dellacqua, del vento, in-
somma tutti quei suoni che sono comuni a tutti gli individui indipendente-
mente dalla razza o dalla cultura a cui appartengono (Benenzon R., 2005).
Anche il modello di musicoterapia analitica attiva di Mary Priestley,
elaborato negli anni 70, prende come riferimento la psicoterapia analitica
di stampo junghiano. Nel lavoro di gruppo, il fare pensiero attraverso la
condivisione del sogno, ci porta a creare trascrizioni uniche ed irripetibili.
chiaro, a questo punto, che il gruppo il luogo e lo spazio pi adatto per
osservare questo funzionamento mentale cos complesso. Il lavoro svolto in
ambito musicoterapico ha permesso di rilevare alcune interessanti analogie
del come la mente ed i processi inconsci si presentano ai membri del gruppo
nei due momenti distinti di lavoro: la social dreaming Matrix ed il gruppo
di condivisione musicale. Si possono, individuare, inoltre, alcune analogie
tra una matrice di SD e una seduta di musicoterapia: il qui e ora presente
molto importante in entrambe le situazioni, limprovvisazione musicale
paragonabile al uire dei sogni nella matrice cos da svelare la dinamica in-
conscia utile ad analizzare il pensiero del gruppo; ascoltare un brano di mu-
sica un po come essere in una matrice dove si ascolta un quadro completo
creato dai sogni e dalle associazioni libere. Ascoltando un brano la nostra at-
tenzione pu rivolgersi su di una traccia musicale o su un singolo strumento
ma, entrambi, si trovano sempre allinterno dello stesso brano, nel tutto e
nel campo. La stessa cosa avviene in una Matrice: infatti, si ascolta la compo-
sizione creata dai sogni piuttosto che il singolo sognatore; il dialogo sonoro
in musicoterapia favorisce il miglioramento della condizione del paziente;
allo stesso modo il dialogo nella matrice favorisce il cambiamento intrap-
sichico e lallentamento delle gabbie mentali come base della formazione
3
Il termine iso deriva dal greco, signica semplicemente uguale; cio che lumore ed il tempo
della musica devono essere in isorelazione con lo stato danimo del paziente (Bunt L.,1997). Per
maggiori approfondimenti consultare il testo (Benenzon R., 2005).
- 83 -
di pregiudizi e, come ultimo dato, poich nella matrice si colgono gli aspetti
culturali, sociali e istituzionali comuni delle persone che vi partecipano, la
matrice pu essere paragonata alliso gruppale dei partecipanti.
Ritorniamo al gruppo di condivisione musicale. Questultima fase di
lavoro stata particolarmente utile per il fatto di aver facilitato la traduzione
e forse un modo di collegare il pi direttamente possibile i diversi linguaggi
ed i diversi livelli di osservazione degli oggetti, degli elementi e i temi emersi
nella matrice favorendo la scoperta di nuovi pensieri. Il linguaggio musicale,
in fondo, pu essere considerato come uno speciale linguaggio non verbale.
Secondo la nostra ipotesi, nel linguaggio non-verbale sono raggruppati tutti
i fenomeni che costituiscono il movimento, il suono, il rumore ed, in ultima
analisi, la musica intesa come struttura e modello di pensiero originale e
con una connotazione emotiva molto forte. Anche le parole utilizzate non
per il loro simbolismo ma per il timbro, lintensit, il volume, il ritmo e
la densit che le caratterizzano determinano un modo di far risuonare un
dialogo, una relazione. In questo senso, la musicoterapia attiva sostituisce
completamente il verbale attraverso una relazione muta di parole ma ricca
di linguaggi non verbali dove il dialogo sonoro sostituisce il canale del
verbale. La musica perci intesa, in questa tecnica di intervento, come
un pensiero rafnato ed elaborato in grado di essere analizzato nel suo es-
sere processato/condiviso nella relazione terapeutica. Per questo motivo
la musicoterapia utilizzata insieme ad altre tecniche riabilitative e psico-
terapiche come la GIM (Guided Imagery Music), dove la potenzialit della
musica usata come evocatrice dimmagini e come strumento di esplora-
zione allinterno della coscienza; come nel modello di Mary Priestley (Mu-
sicoterapia Analitica) dove, attraverso la musica ed i rimandi simbolici ad
essa legati, il paziente manifesta i suoi disagi, li elabora e riesce ad esplorare
nuove possibilit espressive capaci di integrare i suoi vissuti conittuali. At-
traverso il linguaggio non-verbale si cerca di aprire un canale di comunica-
zione con il paziente no ad arrivare al dialogo sonoro per mezzo del quale
si fanno rivivere situazioni inconsce che porteranno il musicoterapeuta alla
conoscenza del paziente e al paziente a rielaborare e aiutarlo a risolvere i
suoi problemi. molto importante, in questo senso ed esattamente come
avviene in psicoterapia, stabilire ed analizzare il processo terapeutico; una
sola seduta di musicoterapia non ha unazione terapeutica n pu stabilire
un legame terapeutico: soltanto dopo una serie di cicli, dincontri ripetuti
e cio quando si stabilisce un inizio e una ne si pu parlare di percorso/
processo terapeutico. Il processo dar origine a una relazione terapeutica
tra paziente e terapeuta. Nel processo terapeutico possiamo osservare il
modo di funzionare della mente, il contesto e le rappresentazioni affettive.
(Fine prima parte. La seconda parte, con la Bibliograa, verr pubblicata sul prossimo numero,
Fascicolo, n. 46, Novembre 2011).
Domenico Agresta psicologo e psiconcologo. Membro de The International Association
for Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP), socio dellAssociazione social-
dreaming.it e membro del Social Dreaming Institute of London, UK, Docente del
Laboratorio di Musicoterapia, Conservatorio L. dAnnunzio di Pescara. Direzione
Scientica della Rivista, coadiutore della SIMP Pescarese, Vice Presidente del CSPP.
Maria Carla Di Giamberardino musicoterapeuta e musicista. Diplomata in solfeggio can-
tato e parlato presso il Conservatorio L. dAnnunzio di Pescara.
Indirizzo (per tutti): Dott. Domenico Agresta
Via Bologna, 35 - 65121 Pescara. E-mail: mimmoag@hotmail.com
- 84 -
PROSPETTIVE IN LIBRERIA
FAUSTO AGRESTA
IL LINGUAGGIO DEL CORPO IN PSICOTERAPIA
Glossario di Psicosomatica
(Prefazione: Piero Parietti)
Alpes Italia, Roma: I Edizione, marzo 2010, pagg. 272; Euro:19,00
Il linguaggio del corpo in psicoterapia: Libreria Edison, Pescara: Presentazione Libro di F. Agresta
il 20 giugno 2010. Da sin: Franco Farias, M.V. Costantini, F. Agresta, E. Faretta. e P. Parietti.
DALLA PREFAZIONE di Piero Parietti
La psicosomatica una disciplina dai signicati ambigui e dalle attribuzioni molteplici
e spesso apparentemente antitetiche. Il collega Fausto Agresta uno studioso serio ed
appassionato che ha preso sul serio la psicosomatologia diffondendone la conoscenza e
cercando di strutturarne, per quanto possibile, i concetti esplicativi, sia nellambito della
propria attivit professionale di docente e di psicoterapeuta individuale e di gruppo, sia
nel contesto della Societ Italiana di Medicina Psicosomatica quale organizzatore di Corsi,
Convegni, come Coordinatore della Sezione di Pescare e di responsabile dell
area di
attivit degli Psicologi. per anche lautore di pubblicazioni interessanti ed originali di
cui gli esempi pi signicativi sono, a mio parere, il testo pubblicato nel 1997 Malattie
Psicosomatiche e Psicoterapia Analitica e la rivista semestrale Nuove Prospettive in Psi-
cologia giunta ormai al XXIII anno dalla sua fondazione ed al quarantesimo fascicolo. Il
libro citato illustra infatti in maniera chiara, tanto la storia della Medicina Psicosomatica,
quanto la critica elencazione delle teorie e dei modelli teorici progressivamente elaborati,
sempre con il supporto esplicativo di situazioni cliniche affrontate. Un testo che dovrebbe
essere letto e studiato da quanti si occupano di psicosomatica. La rivista, tramite contri-
buti originali e interviste a tutto campo a livello nazionale ed internazionale, ha trattato e
tratta, di tutte le impostazioni di lavoro teoriche e pratiche tradizionali, ma anche attuali
in ambito psicologico (ma non solo) secondo unottica psicosomatologica. Lattuale pub-
blicazione costituisce un ulteriore importante contributo allattivit svolta, con merito
e successo, dallautore nella sua costante diffusione di conoscenza della psicosomatica,
con una modalit pratica ed originale bene espressa dal suo titolo IL LINGUAGGIO DEL
CORPO IN PSICOTERAPIA e dal sottotitolo: Glossario di Psicosomatica. Ritengo che il dare
particolare risalto alla dimensione corporea in psicoterapia, ove comunemente predomina
la dimensione del mentale, costituisca una precisa scelta dettata dallorientamento psico-
somatista dellautore. Questo in quanto la chiamata in campo del corpo pone in primo
- 85 -
piano la duplice caratterizzazione dello stesso tra corpo reale fondato sul codice biologico
e focalizzato sulla oggettivit della osservazione clinica, e corpo vissuto o fantasmatico,
basato su di un codice simbolico ed espresso dalla soggettivit individuale della persona sof-
ferente. Differenziazione bene espressa dai fenomenologi di lingua tedesca, con i termini
rispettivi di koerper [corpo biologico] e di Leib [corpo vissuto], che costituisce una
articiosa separazione sostanzialmente messa in atto nella operativit clinica dalla medi-
cina focalizzata sul koerper e dalla psichiatria centrata sul leib, e che la psicosomatica
tende invece ad unicare soprattutto attraverso il coinvolgimento dei soggetti implicati in
quella particolare relazione terapeutica che Michel Sapir ha indicato con lespressione di
corpo a corpo tra medico e paziente. Formulazione che richiama linuenza balintiana
sulla impostazione culturale di questo autore francese che ha avuto un ruolo fondamen-
tale assieme a quello di Boris Luban
-
Plozza nella scelta balintiana fatta dalla SIMP negli
anni settanta del secolo scorso, per lattivit formativa dei propri soci. Due amici scompar-
si quelli citati, il francese Michel e lo svizzero Boris, entrambi di origine russa e il maestro
di origine ungherese Michael Balint, che hanno fortemente e positivamente inuenzato
latmosfera culturale della SIMP di cui Fausto Agresta un autorevole esponente. Ma la
chiamata in causa del corpo, secondo la prospettiva indicata, comporta anche una pos-
sibilit di integrazione pratica tra le due componenti culturali, sorte nellambito della
psicosomatica e della sua storia evolutiva, costituite da quelle che lo psichiatra Carlo
Lorenzo Cazzullo, riconosciuto maestro e pioniere della medicina psicosomatica in Italia,
indicava come nosograca e metodologica. La prima, quella nosograca prende
(prendeva) in considerazione alcune particolari forme di malattia, denite appunto come
psicosomatiche, la cui origine sarebbe da individuare in dinamiche conittuali psichi-
che inconsce somatizzate. La seconda, quella metodologica (pi attuale), centrata non
tanto sullaspetto nosograco della malattia, quanto invece sul tipo di approccio da parte
del terapeuta allindividuo comunque sofferente, considerato secondo una prospettiva
globale comprendente anche la relazione terapeutica attivata. La chiamata in causa della
IL LINGUAGGIO
DEL CORPO
IN PSICOTERAPIA
Glossario di Psicosomatica
di FAUSTO AGRESTA
Volume di 272 pagine
Prezzo di copertina: 19,00
possibile ordinare il volume
a 19,00 (+ spese di spedizione):
scrivendo a: ALPES ITALIA srl,
Via Cipro 77 - 00136 Roma
mandando una e-mail con i propri
dati a: info@alpesitalia.it
telefonando o inviando un fax
al numero: 06.39738315
oppure
sul sito www.alpesitalia.it
( 19,00
+ 3,00 per spese di
spedizione)
Su richiesta presso le librerie
- 86 -
relazione interpersonale tra lindividuo sofferente e lindividuo (professionista) che lo
assume in cura appare come un superamento della articiale ed assurda suddivisione tra
forme psicosomatiche e non di malattia. Nel glossario, che comporta la illustrazione di
terminologie molteplici con la citazione di modalit terapeutiche derivate da modelli teo-
rici diversi ed arricchite dalla esemplicazione di casi clinici ricavati sia dalla letteratura,
sia dalla esperienza clinica personale le problematiche prima indicate trovano adeguata
espressione. Al termine del libro nellappendice NUOVO TIPO DI INTERVENTO IN
PSICOSOMATICA: Gruppoanalisi e Psicosomatica, Agresta esplicita, anche con la cita-
zione di esperienze cliniche affrontate, la propria modalit operativa esponendola, corag-
giosamente (in quanto non spesso avviene), alle valutazioni ed alle critiche dei Lettori,
quale base per riessioni e possibili elementi di discussione tra addetti ai lavori ed anche
questo motivo di merito. Come ulteriore motivo di merito lavere voluto fornire un
utile strumento di studio e di lavoro tramite lelencazione di oltre mille indicazioni bi-
bliograche sullargomento.Tutti motivi quelli citati per cui ho accettato di buon grado di
fornire una presentazione al lavoro dellamico Fausto che ringrazio affettuosamente per
la sua richiesta.
Piero Parietti,
Psichiatra, Psicoterapeuta, Presidente della Societ Italiana di Medicina Psicosomatica
(SIMP) e Responsabile della Formazione. Direttore della Scuola ad indirizzo Psicosoma-
tico Riza, Milano.
* * *
NATASCIA RANIERI
IL CORPO LESO
Clinica psicoanalitica del fenomeno psicosomatico
Casa Editrice Bruno Mondadori, Milano-Torino, 2010, Pagg. 118, Euro: 13,00
Natascia Ranieri Psicoterapeuta, vive e lavora a Milano. Ha conseguito le specializzazioni
nella clinica psicoanalitica dei nuovi sintomi e nelle psicopatologie dei disturbi alimentari.
Nel 2003/2004 diventata consulente psicologa presso lIstituto Fisiochinesiterapico di
Zingonia (Bg) nellambito di un reparto per il trattamento dei disturbi alimentari. Ha
coordinato la sede Jonas Onlus di Milano dal 2004 al 2009. E membro ALI (Associazione
Lacaniana Italiana di psicoanalisi) e docente IRPA (Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Appli-
cata). Ha collaborato con lUniversit degli Studi di Bergamo e attualmente collabora con
la cattedra di Psicopatologia del comportamento alimentare presso lUniversit degli studi
di Pavia. Questo prezioso libro indaga la clinica dei fenomeni psicosomatici utilizzando gli
insegnamenti della psicoanalisi, in particolare, seguendo un iter che parte da Freud e pas-
sa per Lacan, senza lasciare fuori i contributi pi attuali di autori quali Marty, MUzan, For-
nari, McDougall e Ansermet. In particolare, lautrice mette in evidenza il forte contrasto
che c tra quel corpo isterico, quel teatro delle emozioni cos minuziosamente descritto
da Freud, con il corpo psicosomatico. In questo senso, seguendo il percorso di pensiero
tracciato da Lacan, il corpo psicosomatico pu essere descritto come un signicante che
ha perso il suo signicato, come una funzione non rappresentativa, come un corpo leso
che stato marchiato nelle carni poich non simbolizzabile dal soggetto. Il corpo psicoso-
matico si contrappone al corpo isterico nel setting proprio per questa mancanza di una co-
municazione sepolta, di un linguaggio da decifrare, come un grido che per non si rivol-
ge a nessunAltro. E il corpo stesso ad essere sepolto nellevento psicosomatico, e lattacco
che ad esso viene recato pu essere letto come una traccia di morte nella vita del corpo.
Natascia Ranieri ricorda che Lacan ha sempre insistito nel vedere il corpo come il luogo stesso
dellinconscio e che la madre abisso, il padre escluso e il bambino-tappo della castrazione
dellAltro deniscono lorizzonte degli antecedenti familiari della somatizzazione. Nella
somatizzazione qualcosa gode al di l del principio di piacere e nella clinica del fenome-
no psicosomatico non centrale la coppia rimozione-ritorno del rimosso, ma piuttosto il
suo fallimento. Lautrice ha realizzato un testo il cui pi evidente pregio quello di aver
- 87 -
ricostruito dettagliatamente il percorso di pensiero di Lacan su questa particolare temati-
ca; difatti, Lacan non mai sembrato realmente interessato al fenomeno psicosomatico.
Per concludere, questo un testo molto preciso e ben predisposto a coinvolgere il lettore
nel guardare il fatto psicosomatico non pi come una seccatura, o un disagio, ma come
lespressione di un universo interno che non mai stato realmente comunicato. Unaltra
pietra nella costruzione del linguaggio del corpo che parla e che gli studiosi vanno sco-
prendo e non negando!
Alessio Bianconi
* * *
GUAMPAOLO LAI
LETERNIT SULLA PIAZZA DEL MERCATO
BILATERAL VERBAL TRADE
V&P (Vita e Pensiero), Milano, giugno 2011
Al centro di questo libro il fenomeno diffuso delle persone che si recano in uno dei
mercati a disposizione non tanto per comprare loggetto di cui avrebbero bisogno quanto
per intrattenersi sul luogo del mercato. Loggetto da comprare diventa allora loccasione,
il pretesto, la garanzia per andare al mercato e l restare, no alleternit. Lo studio del fe-
nomeno si basa sulla teoria del bilateral verbal trade, mercato di parola bilaterale, che tratta
tutte le conversazioni come negoziazioni di beni di parola tra due mercanti, trader vendito-
re e trader compratore, convenuti sulla Piazza del Mercato con la speranza di un guadagno.
Quando il trader compratore va alla Piazza del Mercato con la speranza contingente di
guadagnare beni di parola che estinguano i suoi debiti, che riempiano i suoi vuoti, che bo-
nichino i suoi mali, parliamo di commercial trade. il caso del paziente che va nello studio
dello psicoanalista con la speranza di arginare le crisi di panico, ridurre la paura dei ragni,
sciogliere il tarlo dellindecisione, o al-
meno comprenderne il senso. Quando
invece il trader compratore, pur portan-
do con s paure, confusione, incertezze,
disperazione, patimenti del corpo, va
alla Piazza del Mercato nella speranza
trascendente di restarci per sempre, di
ritagliarsi una nicchia di eternit perso-
nale, allora parliamo di collateral trade.
Questo libro dunque tutto sulla spe-
ranza, lesprance de gain: speranza di
conseguire un guadagno materiale
e speranza di aprire alleternit sulla
Piazza del Mercato. Non facile pre-
dire quando la speranza delleternit
porter guadagni materiali n in che
modo. Ma il lettore attento potr uscire
dallincertezza, o scegliere di restarci,
confrontando la propria esperienza con
i ventisette esempi di incontri sulla Piaz-
za del Mercato raccolti nel volume.
Il libro sindirizzi a tutti i professionisti
della parola, conversazionalisti, psicoa-
nalisti, insegnanti, giornalisti, e agli
studenti delle discipline psicologiche,
economiche e forensi.
(dalla retrocopertina)
- 88 -
NOTIZIE
CONGRESSO NAZIONALE SIMP del 2011:
PREGIUDIZIO E TERAPIA
a partecipazione internazionale
Parma, 19 - 22 maggio 2011
XXIII Congresso Nazionale SIMP PARMA: 19-22 maggio 2011 PREGIUDIZIO E TE-
RAPIA. Presidenti: Piero Parietti, Giampaolo Lai, Carlo Maggini
SIMP PESCARESE (Coordinatore: Dott. Fausto Agresta) - Proposta:
SIMPOSIO: Psicoterapia Integrata: il processo terapeutico della Psicosomatica e
della Psichiatra
1. Ferdinando Pellegrino (Salerno): Psichiatria di Liason e Psicosomatica
2. Maria Vincenza Costantini (Chieti): La Rappresentazione del corpo nella mente
3. Fausto Agresta, AnnaMaria Rotondo (Pescara): La funzione del sogno in psicotera-
pia psicosomatica. Caso Clinico.
WORKSHOP: SIMP PESCARESE
Gruppi esperienziali di Training Autogeno con Visualizzazioni Guidate.
Conduttori: F. Agresta, A.M. Rotondo, A. Serroni, C. Pelusi
Gruppi Balint con la Partecipazione del Dott. Klaus Rohr (Lucerna).
Sede: Centro Congressi Camera di Commercio - Via Verdi, 2 - Parma
Presidenti del Congresso: Piero Parietti, Giampaolo Lai, Carlo Maggini
Comitato scientico: i membri del direttivo Simp eletto, i coordinatori delle sezioni locali, i
responsabili darea, i rappresentanti delle societ scientiche partner, altri a vario titolo da
segnalare.
Segreteria scientica: presieduta da Antonino Minervino, composta da: Maria Zirilli, Fausto
Agresta, Massimo Rosselli, Elisa Faretta, Carlo Simionato, Luisa Merati, Rocco Cacciacar-
ne, Giovanna Bronzini, Massimo Rosselli, Antonio Suman.
Per il programma vedere il Link del Congresso:
http://it.calameo.com/read/000364640236db109640e
PROGRAMMA CONGRESSO SIMP
- 89 -
- 90 -
- 91 -
- 92 -
- 93 -
CONVEGNO su
LA PSICOTERAPIA NEL SETTING ISTITUZIONALE
(Pescara: 5 MARZO 2011- Sala dei Marmi del Palazzo della Provincia)
Organizzato da: The International Institute for Psychoanalytic Research and
Training of Health Professionals in collaborazione con la SIMP (Societ Italiana
di Medicina Psicosomatica, Sezione Pescarese).
Dopo i due Seminari alla Facolt di Psicologia allUniversit di Chieti e un Convegno,
organizzato dallOrdine degli Psicologi, sempre allUniversit, sono per la prima
volta a Pescara, con nostro immenso piacere, due studiosi importanti che molti gi
conoscono: il Prof. Nesci e il Prof. Poliseno.
Ringraziamo soprattutto il Dott. Domenico Agresta che ha pianicato lorganizzazione
dellevento attraverso la sinergia tra la SCUOLA INTERNAZIONALE SIPSI, la SIMP
e il nostro Centro di Psicoterapia Analitica (CSPP), diretto dallo psicoterapeuta, Dott.
Fausto Agresta che ha introdotto i lavori della mattinata.
La profonda capacit di addestrarsi al rapporto interpersonale e, quindi, alla relazione,
testimoniata da diversi allievi che seguono i corsi allUniversit Cattolica di Roma
e dagli specializzandi della SCUOLA INTERNAZIONALE SIPSI. Nella formazione
non ci si pu fermare...formazione continua!
F. Agresta ha rimarcato, come Nesci e Polisenso delle loro conversazioni, hanno cos
rimarcato la necessit indefettibile della formazione che sinserisce, tra laltro, in un
periodo storico particolarmente problematico, in cui la crisi didentit dello psicologo
e dello psicoterapeuta - crisi dai molteplici risvolti e dalle critiche conseguenze -
appare quanto mai profonda. Paul Parin, famoso psicoanalista svizzero, per primo, 30
anni fa, parlava di medicocentrismo nella psicoanalisi.
Oggi si pu parlare di biologismo della psicologia.
Gi negli anni 70-80 la formazione era il motore centrale della possibilit di lavorare
in maniera ottimale.
* * *
- 94 -
Saper fare, saper lavorare ma, soprattutto, lavorare grazie ed in virt di una robusta
FORMAZIONE DI BASE sicuramente una possibilit di piacere relazionale, per
usare unespressione cara a Balint, che metta sempre in luce la presa di coscienza
della propria stupidit e quindi della continua messa in gioco!
Nelle strutture pubbliche sappiamo che non sempre la formazione relazionale e
terapeutica del personale positiva. Allora, la necessit di aumentare le nostre
possibilit terapeutiche in quei Setting Istituzionali dove il disagio ai limiti diventa
imprescindibile: nei Dipartimenti di Salute Mentale, nei Reparti di Oncologia e di
Oncologia pediatrica, ecc.
Fuori dai nostri conni, ad esempio, gi allospedale Pierre Marty di Parigi, dove
c una grande tradizione psicosomatica, i pazienti vengono inviati allo psicologo
o psicoterapeuta proprio dai reparti di medicina che conservano, comunque, la
responsabilit della terapia medica. Nel nostro contesto territoriale questa sinergia
tra medicina e psicologia, troppo spesso, lungi da una concreta attuazione,
ma precisa responsabilit etica, sociale e deontologica, auspicare una simile
collaborazione sulla scia del modello francese, che permetterebbe, oltretutto, la
creazione di numerosi posti di lavoro.
I giovani sentono ormai la necessit di formazione alla pratica della Psicoterapia:
il Prof. Domenico A. Nesci (psicoanalista della Societ Canadese di Psicoanalisi e
dellIPA) ed il Dr. Tommaso A. Poliseno (gruppoanalista della COIRAG) illustreranno
quali sono i nuovi orientamenti internazionali nel campo della psicoterapia. Levento
stato organizzato con la collaborazione del Dott. Domenico Agresta del Social
Dreaming Institute of London, UK.
I Relatori hanno presentato la Psicoterapia Multimediale, recentemente creata dal
Prof. Nesci, il workshop cinema e sogni (una variazione del social dreaming inventato
da Gordon Lawrence, al Tavistock Institute di Londra) ed il format televisivo Doppio
Sogno che rende divulgabile per un pi ampio pubblico concetti difcili e profondi del
metodo psicoanalitico.
Lincontro ha altres focalizzato i punti salienti del percorso originale della Scuola
Internazionale di Psicoterapia nel Setting Istituzionale (SIPSI) che legata da una
convenzione per il tirocinio degli Allievi presso il Policlinico Universitario Agostino
Gemelli e presso numerose ASL del territorio nazionale. Caratteristica essenziale
di questa Scuola lattenzione ai pazienti gravi, quelli che vengono seguiti nelle
istituzioni di cura (Dipartimenti di Salute Mentale, Ospedali, ecc.) in modo da formare
psicoterapeuti che siano in grado di lavorare non solo nello studio privato ma, anche,
in quipe, nelle istituzioni pubbliche. La riessione scientica di Nesci e Poliseno
prende le mosse dallo studio dei rapporti mente/corpo (osservazioni ecograche
della vita prenatale, studi di psicosomatica, psico-oncologia, arte e psicoanalisi) alla
luce delle riessioni di Freud sullIo corporeo come ente del limite.
Laspetto della problematica psicosomatica apre nuovi orizzonti e nuovi scenari per
lo psicoterapeuta: dai disturbi somatoformi alle malattie psicosomatiche, dove la
collaborazione con la medicina molto stretta oltre che ineludibile: ulcera, asma,
strutture perverse come la bulimia, anoressia e varie dipendenze, dove il corpo
massicciamente e drammaticamente coinvolto. Sono state esplorate, poi, le
implicazioni nel corpo sociale e quindi le dinamiche della costruzione del setting nelle
diverse istituzioni dove si svolge un lavoro psicoterapeutico. Sono stati cos integrati
concetti psicoanalitici, gruppoanalitici ed etnopsicoanalitici, come contenitore/
contenuto, campo, le tematiche del doppio, la funzione del terzo nei processi di
cambiamento, sia individuali che istituzionali, limago placentare ed in particolare la
leadership placentare e la membership sinciziale.
Tutti concetti importanti per comprendere le dinamiche della costruzione del capro
espiatorio nei gruppi, e quindi la sindrome del burnout degli operatori sanitari, il
mobbing, ed altri fenomeni di grande attualit e rilevanza sociale.
Andrea Mosca
- 95 -
* * *
DREAMS Cooperativa Sociale ONLUS
una nuova realt, nata da un gruppo di professionisti esperti dellarea
socio-sanitaria e fonda le sue radici nellesperienza pi che decennale di
The International Institute for Psychoanalitic Research and Training of Health
Professionals (I.I.P.R.T.H.P.). Questo Istituto, che ente gestore della formazione
in psico-oncologia dellUniversit Cattolica del Sacro Cuore di Roma e della
Scuola di Specializzazione in psicoterapia S.I.P.S.I., da sempre impegnato
a concepire e sviluppare programmi di ricerca e formazione nelle aree pi
trascurate della medicina e dei servizi socio assistenziali. I soci di DREAMS
sono in possesso di requisiti professionali e scientici di alto livello; inoltre,
la formazione continua e la supervisione fornita dallI.I.P.R.T.H.P. garantisce
leccellenza delle prestazioni fornite.
Le nalit della cooperativa DREAMS sono:
la prevenzione e lassistenza psicologica rivolta a:
individui con problematiche causate da malattia, disagio psicologico, infertilit
e problemi di inserimento sociale e lavorativo;
istituzioni pubbliche e private;
leducazione socio-sanitaria e tutela delle fasce a rischio o deboli;
lorganizzazione e la realizzazione di programmi di educazione continua in
medicina (ECM) tramite la collaborazione con lI.I.P.R.T.H.P..
* * *
SCUOLA INTERNAZIONALE DI PSICOTERAPIA
NEL SETTING ISTITUZIONALE - S.I.P.S.I.
riconosciuta con decreto ministeriale 12 Febbraio 2002
LA TEORIA
La S.I.P.S.I. una Scuola di psicoterapia psicoanalitica internazionale (molti
Docenti sono psicoanalisti dellInternational Psychoanalytic Association I.P.A.)
caratterizzata da unattenzione specifica alle dinamiche del setting, dalla
tendenza ad integrare lorientamento psicoanalitico con altri orientamenti diffusi
nella pratica psicoterapeutica istituzionale al ne di formare operatori capaci di
lavorare efcacemente in quipe, oltre che nello studio privato. Lo studio dei
processi di cambiamento in psicoterapia dimostra infatti che lintegrazione di
conoscenze provenienti da campi disciplinari e prospettive teoriche diverse ne
aumenta lefcacia, in particolare nel trattamento di pazienti gravi.
- 96 -
LA FORMAZIONE E PRATICA
La didattica prevede, oltre agli insegnamenti teorici e teorico-clinici di
psicopatologia psicodiagnostica e psicoterapia psicoanalitica, seminari clinici e
seminari di supervisione, sempre in un setting gruppale e supervisioni individuali
gratuite a richiesta. Sono inoltre previste esperienze in gruppi di formazione di
operatori sanitari e workshops internazionali (ad esempio, il workshop cinema
e sogni in collaborazione con RAISAT Cinema e lIstituto di Stato per il Cinema
e la Televisione). La Scuola convenzionata col Policlinico Universitario A.
Gemelli di Roma per il tirocinio pratico, oltre che con altri Enti, ed comunque
disponibile a convenzionarsi con altre Istituzioni scelte dagli Allievi nelle loro
Regioni di appartenenza. In sintonia con gli orientamenti dei programmi di
psicoterapia organizzati da molti Istituti psicoanalitici nordamericani, lanalisi
personale non obbligatoria ai ni dellammissione e del conseguimento del
Diploma ma viene promossa come coronamento di un percorso formativo, anche
per evitare ambiguit tra momenti terapeutici (personali) e didattici (istituzionali).
CONTATTI
I.I.P.R.T.H.P.: 06 35491914 (lasciare il proprio numero di telefono per essere
richiamati). Dr. Domenico A. Nesci: 333 5820723; Dr. Tommaso A. Poliseno:
338 6560514.
PENSIERO
La Scuola nasce da un percorso di ricerca psicoanalitica che prende
le mosse dallo studio dei rapporti mente/corpo (amenorrea psicogena,
psico-oncologia, metamorfosi chirurgiche, osservazioni ecograche
della vita prenatale) alla luce delle riessioni di Freud sullIo corporeo
come ente del limite, per esplorarne poi le implicazioni nel corpo
sociale e quindi le dinamiche della costruzione del setting nelle diverse
istituzioni dove si svolge un lavoro psicoterapeutico (Nesci e Poliseno).
Vengono cos integrati concetti psicoanalitici gruppoanalitici ed
etnopsicoanalitici, come i contributi di Bion su contenitore/contenuto,
il concetto di campo, le tematiche del doppio e la funzione del
terzo nei processi di cambiamento, sia individuali che istituzionali.
Contributo originale della Scuola quello sullimago placentare (Nesci:
La Notte Bianca Armando Editore) quale elemento inconscio presente
nella risoluzione degli aspetti simbiotici delle relazioni umane.
Potrebbero piacerti anche
- Psicologia Sociale Myers .OdtDocumento60 paginePsicologia Sociale Myers .OdtEleonora RudilossoNessuna valutazione finora
- Erich Fromm - La Disobbedienza e Altri SaggiDocumento60 pagineErich Fromm - La Disobbedienza e Altri SaggiramonaNessuna valutazione finora
- Ebook La Guardia Medica 2022Documento316 pagineEbook La Guardia Medica 2022dr.rakhshnda shafiqNessuna valutazione finora
- Erich Fromm I Cosiddetti Sani PDF Ita Saggio PsicologiaDocumento2 pagineErich Fromm I Cosiddetti Sani PDF Ita Saggio PsicologiaBuffyNessuna valutazione finora
- La FolliaDocumento41 pagineLa FolliaPinni Waldorf33% (3)
- Il Culto Del Littorio - Emilio GentileDocumento12 pagineIl Culto Del Littorio - Emilio GentileGiada Pierallini0% (2)
- La Persona in Psicologia Sociale - Burr PDFDocumento58 pagineLa Persona in Psicologia Sociale - Burr PDFIgnacio VenturiniNessuna valutazione finora
- Wilhelm Reich - La Funzione Dell'orgasmo (Il Saggiatore)Documento257 pagineWilhelm Reich - La Funzione Dell'orgasmo (Il Saggiatore)Federico Diotallevi100% (2)
- Psicologia Delle Folle RiassuntoDocumento19 paginePsicologia Delle Folle Riassuntoguido100% (1)
- Lio E 1989Documento6 pagineLio E 1989DİLAN ERGÜNNessuna valutazione finora
- Emma Golman, Anarchia e Femminismo PDFDocumento20 pagineEmma Golman, Anarchia e Femminismo PDFbeatriceNessuna valutazione finora
- Erich Fromm - Il Bisogno Di Credere PDFDocumento96 pagineErich Fromm - Il Bisogno Di Credere PDFalfredo89100% (1)
- Hannah ArendtDocumento3 pagineHannah ArendtPaola VitaglianoNessuna valutazione finora
- 2 FichteDocumento3 pagine2 FichteMatt PiNessuna valutazione finora
- Scuola FrancoforteDocumento4 pagineScuola FrancoforteFulvioNessuna valutazione finora
- TesinaDocumento21 pagineTesinaMarco MenegonNessuna valutazione finora
- La società malata. L'umanesimo di Erich Fromm tra Marx e FreudDa EverandLa società malata. L'umanesimo di Erich Fromm tra Marx e FreudNessuna valutazione finora
- Alcuni FilosofiDocumento3 pagineAlcuni Filosofiborgiannidavide27Nessuna valutazione finora
- James Hillman Psicologia AlchemicaDocumento5 pagineJames Hillman Psicologia AlchemicaI cristalli Di LemuriaNessuna valutazione finora
- Hannah Arendt FilosofiaDocumento18 pagineHannah Arendt FilosofiaMarica LucariniNessuna valutazione finora
- AA. VV. - La Dimensione Etica Nelle Società ContemporaneeDocumento139 pagineAA. VV. - La Dimensione Etica Nelle Società ContemporaneeMarco Cagol100% (1)
- O.O. 333 Libertà Di Pensiero e Forze Sociali 1a e 2aDocumento63 pagineO.O. 333 Libertà Di Pensiero e Forze Sociali 1a e 2aJenny Del PreteNessuna valutazione finora
- Erich Fromm Avere o Essere IntroduzioneDocumento3 pagineErich Fromm Avere o Essere IntroduzionegiovacaneNessuna valutazione finora
- ANTROPOLOGIADocumento4 pagineANTROPOLOGIAElena della VellaNessuna valutazione finora
- 1984 RelazioneDocumento3 pagine1984 Relazionecristina scrimaNessuna valutazione finora
- Riassunto Libertà in DiscussioneDocumento23 pagineRiassunto Libertà in DiscussioneVinci LisaiNessuna valutazione finora
- Eddie BernaysDocumento4 pagineEddie BernayspatriziaNessuna valutazione finora
- Il Mondo in Questione-RiassuntoDocumento31 pagineIl Mondo in Questione-RiassuntoAleandra GiardinaNessuna valutazione finora
- La Scuola Di FrancoforteDocumento3 pagineLa Scuola Di FrancoforteSimona GarofaloNessuna valutazione finora
- Leopardi (Obiettivi Minimi)Documento1 paginaLeopardi (Obiettivi Minimi)Emilia PalmieriNessuna valutazione finora
- Ayn Rand e Il Fascismo EternoDocumento5 pagineAyn Rand e Il Fascismo EternoangelomichelemazzaNessuna valutazione finora
- Heidegger RiassuntoDocumento5 pagineHeidegger RiassuntoMichele De LillaNessuna valutazione finora
- Donne e psicoanalisi. Volume 1. L'inconscio tra desiderio e sinthomoDa EverandDonne e psicoanalisi. Volume 1. L'inconscio tra desiderio e sinthomoValutazione: 4 su 5 stelle4/5 (1)
- Positivismo, Comte e NietzscheDocumento12 paginePositivismo, Comte e NietzscheValeria LarucciaNessuna valutazione finora
- Zygmunt BaumanDocumento5 pagineZygmunt BaumanmussoNessuna valutazione finora
- 24 La Rivoluzione Dei Lumi 16 07 06Documento7 pagine24 La Rivoluzione Dei Lumi 16 07 06marcosabatiniNessuna valutazione finora
- Popper Karl BreviarioDocumento107 paginePopper Karl BreviarioMassimo IntelviNessuna valutazione finora
- Amore e FolliaDocumento40 pagineAmore e FolliaGabriele StratocasterNessuna valutazione finora
- Chi Sono I Filosofi Oggi?Documento18 pagineChi Sono I Filosofi Oggi?Dr. Ajith Rohan J. T. F.Nessuna valutazione finora
- Tesina AntropologiaDocumento4 pagineTesina Antropologianicolo marangoniNessuna valutazione finora
- Trascendentalismo e AutoriDocumento5 pagineTrascendentalismo e AutoriMaryNessuna valutazione finora
- La Fascinazione-Un Analisi Psicostorica-Barbara TampieriDocumento118 pagineLa Fascinazione-Un Analisi Psicostorica-Barbara Tampierigrifonec100% (1)
- Nella Libertà La Verita IntroducciónDocumento58 pagineNella Libertà La Verita IntroducciónjuanNessuna valutazione finora
- Illuminismo - Romanticismo.Documento3 pagineIlluminismo - Romanticismo.Giuseppe RoccoNessuna valutazione finora
- SBGDTFDocumento51 pagineSBGDTFAnnachiara Sibillano100% (1)
- ILLUMINISMODocumento11 pagineILLUMINISMOAnna TartaroNessuna valutazione finora
- Mathes - LA PERSONA IN MARTIN BUBER E NEL PERSONALISMO AUSTRIACO PDFDocumento15 pagineMathes - LA PERSONA IN MARTIN BUBER E NEL PERSONALISMO AUSTRIACO PDFapintilieseiNessuna valutazione finora
- FreudDocumento4 pagineFreudSerena MantelliNessuna valutazione finora
- Che Cosa E' L'antropologia Filosofica PDFDocumento53 pagineChe Cosa E' L'antropologia Filosofica PDFClaudio GodoyNessuna valutazione finora
- Filosofia del Corpo e Psicologia del Benessere: Psicosomatica, salute, spiritualitàDa EverandFilosofia del Corpo e Psicologia del Benessere: Psicosomatica, salute, spiritualitàNessuna valutazione finora
- FilosofiaDocumento2 pagineFilosofiaMattia IbbaNessuna valutazione finora
- Eutanasia Germ. NazistaDocumento31 pagineEutanasia Germ. NazistaSara CascioNessuna valutazione finora
- (Antropologia) Marco Aime - Antropologia CulturaleDocumento8 pagine(Antropologia) Marco Aime - Antropologia CulturalelbartolessiNessuna valutazione finora
- AntropologiyyyDocumento9 pagineAntropologiyyyfrancesco biancoNessuna valutazione finora
- Umberto Cerroni - Lessico Gramsciano-Editori Riuniti (1978)Documento136 pagineUmberto Cerroni - Lessico Gramsciano-Editori Riuniti (1978)maNessuna valutazione finora
- FichteDocumento3 pagineFichteValerio Senigagliesi BriziNessuna valutazione finora
- 042 Seminario 2009 02Documento96 pagine042 Seminario 2009 02nuoveprospettiveNessuna valutazione finora
- 047 Seminario 2012 01Documento96 pagine047 Seminario 2012 01nuoveprospettiveNessuna valutazione finora
- 041 Seminario 2009 01Documento96 pagine041 Seminario 2009 01nuoveprospettiveNessuna valutazione finora
- 044 Seminario 2010 02Documento96 pagine044 Seminario 2010 02nuoveprospettiveNessuna valutazione finora
- 043 Seminario 2010 01Documento96 pagine043 Seminario 2010 01nuoveprospettiveNessuna valutazione finora
- 048 Seminario 2012 02Documento96 pagine048 Seminario 2012 02nuoveprospettiveNessuna valutazione finora
- Gillo Dorfles - Il Pseudo-Evento e I Mass MediaDocumento6 pagineGillo Dorfles - Il Pseudo-Evento e I Mass MediaOoNessuna valutazione finora
- Cimicifuga RacemosaDocumento18 pagineCimicifuga Racemosadade1964Nessuna valutazione finora
- Rapporto Favo 2011Documento224 pagineRapporto Favo 2011iaiadodiNessuna valutazione finora
- Approcciocontestuale PDFDocumento23 pagineApprocciocontestuale PDFshadowling2013Nessuna valutazione finora
- Sistema EndocrinoDocumento26 pagineSistema EndocrinoGiulia LanzafameNessuna valutazione finora