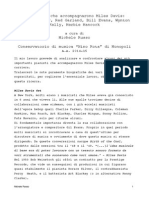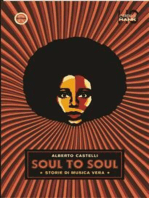Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Kind of Blue Corriere della sera Venerdì 8 marzo
Kind of Blue Corriere della sera Venerdì 8 marzo
Caricato da
saxcb0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
0 visualizzazioni5 pagineCopyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
0 visualizzazioni5 pagineKind of Blue Corriere della sera Venerdì 8 marzo
Kind of Blue Corriere della sera Venerdì 8 marzo
Caricato da
saxcbCopyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 5
Rassegna musicale/1
Kind of blue, storia del capolavoro di Miles
Davis (e Bill Evans)
di ALESSANDRO TROCINO
Bill Evans e Miles Davis
Sono passati 65 anni ed estrarlo dalla sua custodia,
appoggiarlo sul piatto, spostare la puntina, sentire il fruscio e le
prime note al pianoforte di So What, rimane un’emozione
incredibile. Chi non ha più il vinile, lo trova sulle piattaforme. Su
Spotify, per esempio, la terza traccia, Blue in Green, l’hanno
trovata e ascoltata 148 milioni di volte.
:
Kind of blue è un piccolo miracolo, con una bella storia.
Esce nel 1959, anno magico, se non irripetibile per il jazz: in
dodici mesi fanno la loro apparizione Mingus Ah Um di Charles
Mingus, Time Out di Dave Brubeck (con Take Five), The
Shape of Jazz to Come di Ornette Coleman. E Kind of Blue di
Miles Davis.
Ma non solo di Miles Davis. Nel pomeriggio di lunedì 2 marzo
1959, sette musicisti entrano nel 30th Street Studio della
Columbia Records, un’ex chiesa, per iniziare a registrare
l’album che allora si chiama Columbia Project B 43079, nome
di studio non proprio accattivante. Insieme a Davis, ci sono i
«suoi» musicisti: i sassofonisti John Coltrane e Julian
«Cannonball» Adderley, il bassista Paul Chambers, il
batterista Jimmy Cobb e il pianista Wynton Kelly. All’ultimo,
arriva un altro pianista, notizia che non entusiasma Kelly: è Bill
Evans.
Ed è proprio Evans il partner più importante del disco. Aveva
lavorato a lungo quelle tracce, prima di un burnout, causato
anche dalla malattia del padre. Poi aveva lasciato, ed ora eccolo lì,
sulla Third Avenue. Era un bianco Evans, a differenza degli
altri, e aveva una formazione classica. Anni prima, mentre
suonava al Village Vanguard, aveva alzato lo sguardo e aveva
intercettato gli occhi acuti, impenetrabili, di Miles, che lo
fissavano. Qualche tempo dopo Davis lo chiamò a collaborare.
Non era scontato. Evans era bianco e allora il jazz era
considerato roba per neri. Certo, ce n’erano stati altri e ce ne
sarebbero stati molti ancora — da Benny Goodman a Lee
Konitz, da Uri Caine a John Zorn — ma il reclutamento di
:
Bill fu accolto con molto malumore dall’ambiente. Racconta
James Kaplan su The Atlantic, che «Evans, che
era davvero bianco, occhialuto, professorale, incorse in un
risentimento immediato e diffuso tra i musicisti neri e il pubblico
nero». Anche Davis lo trattava con qualche fastidio e non
mancava di rimproverarlo ad alta voce, forse per far capire che
stava dalla parte giusta, quella dei neri: «Ehi Bill, basta, non
vogliamo opinioni bianche!». Ma era una posa, perché poi
diceva che quando si trattava di musicisti, era «daltonico».
Davis in quel periodo stava ascoltando musica diversa, voleva
provare a uscire dai sentieri classici del genere, era stufo di
standard e delle solite armonie. Era ossessionato dalla
registrazione di Arturo Benedetti Michelangeli del 1957 del
Concerto per pianoforte e orchestra in sol di Maurice
Ravel: ottavino e tromba, danze e cambi di ritmo frequenti.
Amava Aram Khachaturian e la musica asiatica. Ma poi
tornava sempre a Evans: «Ho concepito quell’album intorno
al suo pianoforte».
Intorno al suo pianoforte voleva aggiungere mondi nuovi. Gli
piaceva la kalimba, il pianoforte africano a pollice e risuonavano
ancora nella mente le voci dei cantanti gospel neri che sentiva
intorno alla fattoria dei suoi nonni, nell’Arkansas. Alla fine, Miles
non fu del tutto soddisfatto del risultato. Più avanti avrebbe
condotto le sue esplorazioni molto lontano, spostandosi senza
pace dal cool jazz all’hard bop fino al rock elettronico.
Avrebbe cambiato quattro o cinque volte direzione, conservando
lo sguardo truce, riempiendo di parolacce i giornalisti,
suonando con le spalle al pubblico in segno di disprezzo.
A un certo punto, come tutti o quasi i musicisti dell’epoca, si
:
imbattè nell’eroina. Per liberarsene, adottò la tecnica del «cold
turkey», il tacchino freddo: «Mi sdraiai sul letto e mi misi a
guardare il soffitto per dodici giorni di fila, durante i quali
imprecai contro tutti quelli che non mi piacevano. Era come avere
una grave forma di influenza, però un po’ peggio. Vomitavo tutto
quello che cercavo di mandar giù. I miei pori erano dilatati e
puzzavo come se fossi immerso in un brodo di pollo. Poi finì».
Davis veniva da una famiglia della buona borghesia
nera, che voleva elevarsi al di sopra dei «niggers», e per tutta la
giovinezza la rinnegò. Non andò ai funerali di sua madre, contestò
suo padre. Disse che uno dei primi ricordi era di «un uomo
bianco che mi correva dietro per la strada gridando
‘niggers niggers’». Come scrive Arrigo Polillo nel suo «Jazz»,
«non amava i bianchi», pensava che «non possono capire
la musica afro-americana (non il jazz, che non esiste — diceva
— è solo una parola inventata dai bianchi per i ‘niggers’)».
Sulla paternità nera del jazz ha scritto pagine interessanti Davide
Sparti, in «Suoni inauditi», dove ricostruisce le origini della
musica, ancora controverse e immerse nella leggenda: «La prima
generazione di schiavi importati in America, confluiti soprattutto
a New Orleans, proveniva per lo più dall’Africa occidentale,
perché i francesi nel cui territorio della Louisiana il jazz dette i
primi segni di vita, avevano delle preferenze per i neri provenienti
dal Dahomey. Che cosa essi importarono musicalmente è un fatto
dibattuto, ma è ovvio che non sbarcarono dalle navi dei
negrieri suonando jazz». Ci sono però alcuni elementi che si
trovano sia nella musica tradizionale africana che nel jazz delle
origini: «Una ritmica percussiva, l’accento sull’off beat, la
poliritmia (l’esecuzione contemporanea di due o più ritmi
:
eventualmente in contrasto tra loro) e l’uso di call and response
patterns». Ovvero i botta e risposta, dove la seconda frase,
suonata da un altro musicista, risponde alla prima.
Detto questo, dice Sparti, bisogna stare attenti a cadere nel
«primitivismo», che è quello per cui «solo l’aura esotica del
nero garantisce l’autenticità del jazz». Il jazz è una
musica sporca, un costrutto ambiguo, che si è trasformato
mille volte nel tempo e nello spazio. Come diceva il
trombettista Clark Terry: «A una nota non interessa chi la
suona — se sei nero, bianco, verde, marrone o opaco». Kind of
blue — frutto del lavoro e dell’improvvisazione di due geni della
musica, il fieramente nero Miles Davis e l’outsider bianco Bill
Evans — resta nella storia come qualcosa di magico e
irripetibile. Per fortuna, possiamo estrarre per la milionesima
volta il vinile dalla sua custodia e cominciare ad ascoltare le prime
note di So What.
Rassegna storico-politica
L’intellettuale furioso e il veterano lucido:
la coscienza di Israele
di GIANLUCA MERCURI
:
Potrebbero piacerti anche
- Congiuntivo Trapassato Esercizi 1Documento1 paginaCongiuntivo Trapassato Esercizi 1Octavio Contreras100% (1)
- Pierluigi Cassano Dispense Jazz PDFDocumento19 paginePierluigi Cassano Dispense Jazz PDFGiuseppe RussoNessuna valutazione finora
- Storia Del Jazz 2Documento11 pagineStoria Del Jazz 2SimoneGoffredoAmorusoNessuna valutazione finora
- La Storia Del Jazz - Walter MauroDocumento102 pagineLa Storia Del Jazz - Walter Maurosaxily0% (1)
- Tesi Di Laurea - L'Armonia e L'improvvisazione Blues Di Joe PassDocumento28 pagineTesi Di Laurea - L'Armonia e L'improvvisazione Blues Di Joe Passsittidav100% (1)
- 1le Origini Della Musica NeraDocumento4 pagine1le Origini Della Musica NeraStefano CiliaNessuna valutazione finora
- I Pianisti Che Accompagnarono Miles Davis - Michele RussoDocumento17 pagineI Pianisti Che Accompagnarono Miles Davis - Michele RussoMicheleRusso0% (1)
- Bill EvansDocumento12 pagineBill EvansAntonio100% (2)
- Charles MingusDocumento7 pagineCharles MingusRocco MangioneNessuna valutazione finora
- ColtraneDocumento21 pagineColtraneAntonio MasiNessuna valutazione finora
- Gil EvansDocumento4 pagineGil EvansLuca de LeonardisNessuna valutazione finora
- Caporaletti Electrique+Miles+Davis 2020Documento16 pagineCaporaletti Electrique+Miles+Davis 2020Gianluca SalcuniNessuna valutazione finora
- La Musica JazzDocumento5 pagineLa Musica JazzFrancesca TeriacaNessuna valutazione finora
- Bill Evans at Town HallDocumento69 pagineBill Evans at Town HallFrancesco DimizianiNessuna valutazione finora
- Il JazzDocumento9 pagineIl Jazzilaria01dfrNessuna valutazione finora
- Storia Del JazzDocumento10 pagineStoria Del JazzVoxtone voxtoneNessuna valutazione finora
- Il Jazz in Italia - Tesi Di MaturitàDocumento12 pagineIl Jazz in Italia - Tesi Di MaturitàMicheleKrnjakNessuna valutazione finora
- George RussellDocumento5 pagineGeorge RussellLuca de LeonardisNessuna valutazione finora
- Breve Storia Del Jazz PDFDocumento3 pagineBreve Storia Del Jazz PDFGianluca CasamichelaNessuna valutazione finora
- Breve Storia Del Jazz PDFDocumento3 pagineBreve Storia Del Jazz PDFSalvatore MerolaNessuna valutazione finora
- Biografia Frank ZappaDocumento7 pagineBiografia Frank Zappanovalis100% (1)
- La Storia Del Jazz Stefano ZenniDocumento4 pagineLa Storia Del Jazz Stefano ZenniFilippo BongiorniNessuna valutazione finora
- Be-Bop e Cool JazzDocumento2 pagineBe-Bop e Cool JazzAnonymous ndDdTbAfNessuna valutazione finora
- MusicaDocumento3 pagineMusicamanuelaconyNessuna valutazione finora
- New Capitolo 17Documento9 pagineNew Capitolo 17Muhssin98Nessuna valutazione finora
- Skip JamesDocumento3 pagineSkip JamesEnricoNessuna valutazione finora
- Il JazzDocumento9 pagineIl JazzSolda Andy AndreaNessuna valutazione finora
- Appunti Storia JazzDocumento7 pagineAppunti Storia JazzLaura BoccaNessuna valutazione finora
- Storia Del JazzDocumento4 pagineStoria Del JazzfrancispastoriusNessuna valutazione finora
- La Musica Afro-Americana e I Diritti UmaniDocumento5 pagineLa Musica Afro-Americana e I Diritti UmaniMarco Ernesto RossettiNessuna valutazione finora
- Ornette Coleman (Tesi Storia)Documento9 pagineOrnette Coleman (Tesi Storia)Gennarino ParsifalloNessuna valutazione finora
- Musica AfroamericanaDocumento2 pagineMusica AfroamericanaKamillaNessuna valutazione finora
- Il Jazz AmericanoDocumento4 pagineIl Jazz AmericanoGiovanni PaolinoNessuna valutazione finora
- Profondo Sud: Storie dal profondo Sud americano per capire la lotta dei neri per la conquista dei diritti civili - Teatro documentarioDa EverandProfondo Sud: Storie dal profondo Sud americano per capire la lotta dei neri per la conquista dei diritti civili - Teatro documentarioNessuna valutazione finora
- Storia e Sviluppo Del Jazz Attraverso Il BluesDocumento19 pagineStoria e Sviluppo Del Jazz Attraverso Il BluesHorace BasileNessuna valutazione finora
- Minstrelsy e Ragtime - OdtDocumento2 pagineMinstrelsy e Ragtime - OdtStefania BurestaNessuna valutazione finora
- Microstoria Di Un Gruppo Di Trad JazzDocumento72 pagineMicrostoria Di Un Gruppo Di Trad JazzGino RomanoNessuna valutazione finora
- L'Albero Della MusicaDocumento5 pagineL'Albero Della MusicadomingojazzNessuna valutazione finora
- Quarenghi Le Note Tragiche Del JazzDocumento20 pagineQuarenghi Le Note Tragiche Del JazzLIDIA VALERINessuna valutazione finora
- Walter Mauro La Storia Del JazzDocumento102 pagineWalter Mauro La Storia Del JazzLuciano BuosiNessuna valutazione finora
- Rock 500 Dischi Fondamentali (B - Frederick EddyDocumento562 pagineRock 500 Dischi Fondamentali (B - Frederick EddyGiorgio PaganelliNessuna valutazione finora
- Alias Il ManifestoDocumento2 pagineAlias Il Manifestoharck181Nessuna valutazione finora
- Paolo RicucciDocumento17 paginePaolo RicuccialiceadslNessuna valutazione finora
- Tesina Bill Evans - Odt - 0Documento31 pagineTesina Bill Evans - Odt - 0Jacopo Perra100% (2)
- Cool JazzDocumento4 pagineCool JazzAlessandro BucciNessuna valutazione finora
- Le Origini Del Jazz PDFDocumento23 pagineLe Origini Del Jazz PDFgigiokingo_478057196Nessuna valutazione finora
- La Storia Del JazzDocumento5 pagineLa Storia Del Jazzarandes62Nessuna valutazione finora
- Miles DispensaDocumento61 pagineMiles DispensaAnnaRitaNessuna valutazione finora
- Storia Del JazzDocumento6 pagineStoria Del JazzVincenzo MoscaNessuna valutazione finora
- Tu Vuò Fa' L'afro-AmericanoDocumento25 pagineTu Vuò Fa' L'afro-AmericanoImt VocalProjectNessuna valutazione finora
- Dizzy GillespieDocumento3 pagineDizzy GillespieSimoneGoffredoAmorusoNessuna valutazione finora
- Charles MingusDocumento8 pagineCharles MingusCarlo FerroNessuna valutazione finora
- Miles DavisDocumento45 pagineMiles DavisTasto BiancoNessuna valutazione finora
- La Musica JazzDocumento5 pagineLa Musica JazzGiulia BalestraNessuna valutazione finora
- BERGOGLIO - Jazz e PoliticaDocumento23 pagineBERGOGLIO - Jazz e PoliticaKatleen FalvoNessuna valutazione finora
- Storia Della Musica JazzDocumento27 pagineStoria Della Musica JazzLorenzo Di FranciaNessuna valutazione finora
- New Orleans Revival - Gino RomanoDocumento125 pagineNew Orleans Revival - Gino RomanoGino Romano100% (1)
- Come Imparare 100 Standard Jazz A Memoria, Guida Allo StudioDocumento18 pagineCome Imparare 100 Standard Jazz A Memoria, Guida Allo StudiosaxcbNessuna valutazione finora
- Volumi & Open Interest - Analisi TecnicaDocumento3 pagineVolumi & Open Interest - Analisi TecnicasaxcbNessuna valutazione finora
- EasytradingDocumento5 pagineEasytradingsaxcbNessuna valutazione finora
- VTCFH VTCF - R02 20Documento8 pagineVTCFH VTCF - R02 20saxcbNessuna valutazione finora
- Riepilogo ScambiatoriDocumento4 pagineRiepilogo ScambiatorisaxcbNessuna valutazione finora
- Gasketed Plate Heat Exchangers: Scambiatori Di Calore A Piastre IspezionabiliDocumento18 pagineGasketed Plate Heat Exchangers: Scambiatori Di Calore A Piastre IspezionabilisaxcbNessuna valutazione finora
- Einstein e L'immaginazione ScientificaDocumento229 pagineEinstein e L'immaginazione ScientificasaxcbNessuna valutazione finora
- Solari Integrati Sistemi Termici: C ATA LO G ODocumento228 pagineSolari Integrati Sistemi Termici: C ATA LO G OsaxcbNessuna valutazione finora
- Dia PsicroDocumento48 pagineDia PsicrosaxcbNessuna valutazione finora
- Vincent Starry Starry NightDocumento4 pagineVincent Starry Starry NightAndre Giovani FavaNessuna valutazione finora
- 10 - Script - PHP - Per - Configurare - Gli - Accessi - Ad - Internet - Di - Un - Router - CISCODocumento13 pagine10 - Script - PHP - Per - Configurare - Gli - Accessi - Ad - Internet - Di - Un - Router - CISCOFlaviano SaccàNessuna valutazione finora
- Call For Performer 2021Documento4 pagineCall For Performer 2021Lorenzo BiguzziNessuna valutazione finora
- Catalogo Schede MonicelliDocumento205 pagineCatalogo Schede Monicellidavis2aNessuna valutazione finora
- Routine Quotidiana Donna EdenDocumento3 pagineRoutine Quotidiana Donna EdenAndrea CappannariNessuna valutazione finora
- Cinema AfricanoDocumento13 pagineCinema Africanodrago_rossoNessuna valutazione finora
- 8regolamento Concorso Internaizonale Di Musica Lucia Iurleo 2022Documento4 pagine8regolamento Concorso Internaizonale Di Musica Lucia Iurleo 2022Nunzio CurcurutoNessuna valutazione finora
- Tu Accordi Per Chitarra Umberto TozziDocumento3 pagineTu Accordi Per Chitarra Umberto TozziSerio LudicoNessuna valutazione finora
- CLI115 5632a 05Documento60 pagineCLI115 5632a 05Carlos de HasburgoNessuna valutazione finora
- PREPOSIZIONIDocumento9 paginePREPOSIZIONIMauro VentrigliaNessuna valutazione finora
- Raccolta R Commentata CaleffiDocumento55 pagineRaccolta R Commentata CaleffiDunkMeNessuna valutazione finora
- 06 Sanguinetti Scala PDFDocumento29 pagine06 Sanguinetti Scala PDFElena PallottaNessuna valutazione finora
- Saqmsung SF-360 Series ITDocumento78 pagineSaqmsung SF-360 Series ITo_gradyrNessuna valutazione finora
- Sottodiciotto Catalogo 2013Documento212 pagineSottodiciotto Catalogo 2013juanesrcNessuna valutazione finora