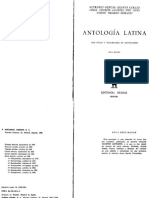Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
374 visualizzazioni10 pagineLa Peste Camus
Il documento riassume la storia della peste nera che colpì l'Europa nel 1347, descrivendo la sua diffusione e gli effetti devastanti sulla popolazione. Vengono inoltre analizzate le reazioni e le interpretazioni dell'epidemia nel contesto sociale e culturale dell'epoca.
Caricato da
giovanniCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato DOC, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Il 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
374 visualizzazioni10 pagineLa Peste Camus
Il documento riassume la storia della peste nera che colpì l'Europa nel 1347, descrivendo la sua diffusione e gli effetti devastanti sulla popolazione. Vengono inoltre analizzate le reazioni e le interpretazioni dell'epidemia nel contesto sociale e culturale dell'epoca.
Caricato da
giovanniCopyright
© © All Rights Reserved
Per noi i diritti sui contenuti sono una cosa seria. Se sospetti che questo contenuto sia tuo, rivendicalo qui.
Formati disponibili
Scarica in formato DOC, PDF, TXT o leggi online su Scribd