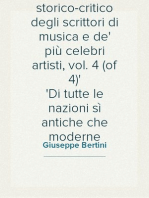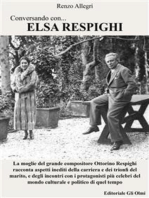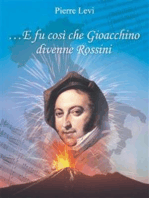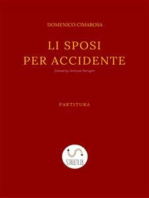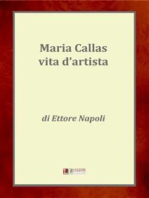Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Introduzione Fu Il Lauro Sempre Verde
Caricato da
Emanuele Salvatore Paolo Duchetta0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
303 visualizzazioni4 pagineanalisi
Copyright
© © All Rights Reserved
Formati disponibili
DOCX, PDF, TXT o leggi online da Scribd
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoanalisi
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
0 valutazioniIl 0% ha trovato utile questo documento (0 voti)
303 visualizzazioni4 pagineIntroduzione Fu Il Lauro Sempre Verde
Caricato da
Emanuele Salvatore Paolo Duchettaanalisi
Copyright:
© All Rights Reserved
Formati disponibili
Scarica in formato DOCX, PDF, TXT o leggi online su Scribd
Sei sulla pagina 1di 4
Introduzione
Il madrigale Fu il lauro sempre verde di Annibale Stabile
1
fa parte de il Lauro Secco, Libro Primo di
Madrigali a Cinque Voci di Diversi Autori (1582)
2
, opera collettiva
3
, nata nellambito dellAccademia dei
Rinnovati
4
di Ferrara. A firma della stessa Accademia la dedica Ai virtuosi lettori
5
, posta ad inizio della
raccolta, la quale chiarisce gli intenti, le modalit e gli esiti del Lauro Secco: ponendo lopera fuori dalla
protettetione di alcun Prencipe, offre i madrigali alla merc vostra fatti degni che si accompagnino con le
vostre voci ed anticipa luscita di un Verde Lauro. Il riferimento alle voci di cui si fa menzione va
ricondotto nellambito dellambiente di corte ferrarese, in particolar modo, al cosiddetto Concerto delle
dame
6
, ensemble di musiciste, in grado di cantare e suonare diversi strumenti. Lo stesso duca di Ferrara
Alfonso II dEste aveva voluto e sostenuto tale Concerto, che esibiva orgogliosamente agli ospiti di riguardo
1
Alcune notizie su Annibale Stabile: nato a Napoli presumibilmente nel 1535, fu un fanciullo cantore presso la basilica
S. Giovanni in Laterano della quale ricopr in seguito la carica di maestro di cappella, ruolo che ricopr in seguito presso
il Collegio Germanico in SantApollinare e a Santa Maria Maggiore. Dal 1595 documentata la sua attivit in Polonia
presso la corte di re Sigismodo III. Allievo di Palestrina, membro della virtuosa compagnia dei musici di Roma, fu
ordinato sacerdote nel 1582 godendo dei benefici ecclesiastici da parte di S. Lorenzo di CollAlto, diocesi di Nocera. Su
Stabile vedi: voce in The New Groove Dictionary of Music ed Utet. In mancanza di lavori monografici sulla produzione
profana si rimanda a studi che toccano la figura di Stabile nellambito del madrigalismo romano: Ruth Irene Deford,
Ruggiero Giovannelli and the madrigal in Rome (dissertation), pp. 149-154, Harvard University, Cambridge; Marco
Bizzarini, Marenzio: la carriera di un musicista tra Rinascimento e Controriforma, Promozione Franciacorta, 1998.
2
Ecco il frontespizio: IL LAURO SECCO /LIBRO PRIMO DI MADRIGALI A CINQUE VOCI/DI DIVERSI AUTORI/ IN FERRARA,
per Vittorio Baldini, 1582. Cfr. repertori: Rism, Repertoire International des Sources Musicales- Recueils Imprimes des
sec. XVI e XVII, p. 314; Alfred Einstein, Printed Collection in Chronological order, appendice a Emil Vogel, Bibliothek der
gedruckten weltlichen Vocalmusik Italiens aus des Jahren 1500-1700, pp. 429 e 475; Robert Eitner, Bibliographie der
Musik-Sammerlwerke des XVI und XVII Jahrhunderts, Berlin, Lieppmannssohn, 1877, pp. 778. La seconda stampa del
Lauro Secco del 1596, di cui il frontespizio: LAURO SECCO/ LIBRO PRIMO DI MADRIGALI a Cinque Voci DI DIVERSI
AUTOTORI/ Nuovamente Ristampato/ In Venetia presso Angelo Gardano/ M.D. LXXXXVI. [RISM] p. 373, 1596.
3
Sintende precisare il significato di opera collettiva intesa come produzione consapevole di un gruppo di autori che si
uniscono dando i loro diversi contributi alla creazione di un lavoro che tratta un determinato argomento. Diverso il
caso dellAntologia, termine comunemente impiegato per le stampe madrigalistiche cinquecentesche, che indica una
selezione (creativa o non) di testi o passi di opere di uno o pi autori, esercitata su materiali dati o gi editi. Differente
anche il significato di Miscellanea, che una raccolta eterogenea di materiale musicale. Cfr. Marco Giuliani, intr. a Lieti
Amanti, Firenze, Olschki, 1990; Franco Piperno, Musicisti e mercato editoriale nel 500: le antologie dambiente di
polifonia profana in Musica e Realt, V, 1984; Franco Piperno, Gli Eccellentissimi musici della citt di Bologna, Firenze
Olshki, 1985, p.2 nota 9; Lorenzo Bianconi, Parole e Musica il Cinquecento e il Seicento in Letteratura Italiana VI
(teatro musica tradizione dei classici) a cura di Alberto Asor Rosa, Torino, Einaudi, 1996.
4
Scarse le notizie riguardo lAccademia dei Rinnovati, i cui membri sono anche curatori dei testi poetici del Lauro
Secco e del Lauro Verde. Fra questi un ruolo importante lo ebbero sicuramente Torquato Tasso e Ippolito Gianluca
come ipotizza Marco Giuliano (op. cit.), a cui vanno aggiunti anche, tra gli autori dei testi: Ercole Cavaletto, Alberto
Parma, Alessandro Guarini, tutti letterati che operavano nellambito della corte ferrarese (vedi Brunella Maria
Maugeri, testi poetici per i concerti di dame a Ferrara)
5
Ecco il testo integrale: A virtuosi lettori del Lauro Secco: come dotta mano ritoccando ben temprate corde fa
mirabil concento, cos parimente speriamo noi, che i Madrigali di questo Secco Lauro da noi con esquisita diligenza dai
pi Eccellenti Compositori dItalia raccolti, et hora stampati, et voi dedicati, se fien merc vostra fatti degni che si
accompagnino con le vostre voci, potran con la lorarmonia scoprir se stessi meriteuoli della vostra protettione; et noi,
che padri loro siamo, per giusti giudici, poi che sin hora habbiamo raffrenata laffetione vostra verso di loro,
aspettando che sia misurata dallinfallibil giuditio vostro: sotto alla cura giudicisoa, am benigna censura, di corto
porremo vnaltra scielta di Madrigali, composti sopra vn nuouo et verde Lauro, dalle cui pregiate et fresche radici non
si possonaspettare che maturi et dolcissimi frutti, dequali, se alcuno per esser intempestivamente colto restasse
acerbetto, sar indubitamente condito nel soauissimo mele della Musica. In tanto noi confidati nella candida et
sincera intentione, per fuggir il morso deglinuidi, non la abbiamo voluto ammantarsi della protettione di alcun
Prencipe, come ricerca il costume dhoggid, tanto pi che non bramiamo altro premio della nostra fatica che la buona
vostra vniversal gratia; in cui ci raccomandiamo. I RINNOVATI
6
Cfr. Elio Durante/ Anna Martellotti, Cronistoria del Concerto delle Dame Principalissime di Margherita Gonzaga
dEste, Firenze, 1979, S.P.E.S.
in occasione di importanti ricevimenti di corte. Le protagoniste di questi esclusivi trattenimenti privati
erano Ludovica dArco, Anna Guarini e Laura Peverara
7
. Questultima dorigine mantovana
8
, virtuosa del
canto, arpista
9
e danzatrice, si trasfer dalla sua citt natale a Ferrara, dove fu dama di compagnia
10
della
duchessa Margherita Gonzaga dEste. La Peverara con ogni probabilit la destinataria dellomaggio
11
del
Lauro Secco. La scelta oculata dei musicisti, la cornice autorevolissima delliniziativa editoriale, le
dimensioni delle raccolte e la sontuosa veste editoriale, sono fattori tutti, che portano a pensare al Lauro
Secco come un dono in occasione delle nozze della stessa Peverara con il conte Annibale Turco (sebbene
manchi nella raccolta madrigalistica un esplicito riferimento). Laccenno, posto nella lettera dedicatoria, al
Lauro Verde, indica la stretta relazione tra le due raccolte. Il progetto letterario che sottintende ad
entrambe le opere, tratta lamore in due temi monografici dialetticamente collegati e contrapposti: la
donna che ha cessato di amare e che dunque inaridita agli occhi del poeta (Lauro Secco) ed la
consapevolezza dessere usciti salvi dai conflitti del cuore (Lauro Verde). A queste due raccolte va aggiunto
il manoscritto n.220 dellAccademia Filarmonica di Verona
12
, datato 1580 e dunque antecedente i due
Lauri
13
, al cui interno vi sono dei madrigali in onore di Laura Peperara. E molto interessante notare come in
7
Laura Peperara nata a Mantova nel 1563 (m. Ferrara 1600) figlia di Vincenzo Peperaro letterato al servizio della
famiglia Gonzaga e di Margherita Costanzi. Cresciuta alla corte di Mantova, fu istruita alleducazione musicale e al
canto dal maestro di cappella Giaches de Wert, rivelando sin da subito unarte eclettica. Cfr. Elio Durante/ Anna
Martellotti, Giovinetta peregrina - la vera storia di Laura Peperara e Torquato Tasso, Firenze, Olshki, 2010; Elio
Durante/ Anna Martellotti op. Cit.
8
La documentazione che ci informa del trasferimento di Laura Peperara da Mantova a Ferrara, si ritrova nella lettera
dellambasciatore Orazio Urbani al granduca Francesco de Medici (f.2899 conservata presso larchivio di Stato di
Firenze Archivio Mediceo) in cui si descrive come Alfonso DEste vedendo una giovane che essendo assai bella. Et
oltre a ci havendo virt di sonare e cantare eccellentemente, gli venne desiderio di haverla a Ferrara, e giunto qua ha
procurato che la Signora Duchessa le mandi a ricercar per sua Dama".
9
Il Duca Alfonso II commission appositamente per Laura Peperara un nuovo strumento. Vedi Nunzia Lanzetta,
Musica a Corte e in Collezione dagli strumenti musicali in casa dEste alle collezioni storiche, Modena, Galleria
Estense, 20 Giugno/ 07 Luglio 2002, dove oltre la delineazione dellorganologia dellepoca compare anche la
descrizione dellarpa di Laura: unarpa in legno dacero decorato composta da una doppia fila di 58 corde con le
decorazioni del pittore Giulio Marescotti; lo strumento dotato di un fregio realizzato da Orazio Lamberti, fiammingo
di Aarsele. Larpa fu trasferita nel 1601 a Modena dove cadde nel dimenticatoio per anni dopo a seguito dello
scioglimento del Concerto delle Dame; riscoperta nell800 dal conte Francesco Valdrighi e da Adolfo Venturi storico
dellarte.
10
Cfr. Marco Materassi, Il Primo Lauro Madrigali in onore di Laura Peperara manoscritto n.220 dellAccademia
Filarmonica di Verona (1580), , Treviso, Diastema Fiori Musicali, 1999, dove si dice: Erano state rapide le trattative di
Alfonso II dEste con il suocero Guglielmo Gonzaga per il trasferimento di Laura da Mantova, dove il duca ferrarese
laveva incontrata nel marzo precedente e subito sera adoperato per portarla al proprio servizio in quello che sarebbe
stato il suo tanto celebrato e imitato concerto delle donne.
11
Oltre agli omaggi del Lauro Secco, Lauro Verde e del manoscritto n.220 (vedi Brunella Maria Maugeri op. cit. e
Anthony Newcomb, the three antologies for Laura Peperara, 1580-1583, Firenze, Olshki,1975) vi furono altre dediche
rivolte alle eccezionali doti della cantante: M. Ccala, Giovanni Giovenale Ancina letterato in Annales Oratori fasc. III,
Roma, pg.90 riferisce di una dedica di Giovan Battista Guarini alla Peverara in riferimento al madrigale Mentre Vaga
Angioletta (in G.B. Guarini, Rime, 1598), dove si parla esplicitamente del cantar della signora Laura; sempre di
Guarini anche la dedica del sonetto IX Taccia il cielo e la terra al novo canto; Muzio Manfredi, accademico degli
Invaghiti di Mantova e Principe dellAccademia degli Innominati di Parma, dedica sempre a Laura Peperara il sonetto
LIII Move da gli occhi e dal suo canto Amore (pubblicato nella raccolta Cento Donne). Nota poi la vicenda
dellinnamorato di Torquato Tasso per la Peverara, al quale compare in diverse opere del poeta, tra cui: io mi sedea
tutto soletto un giorno/ sotto gli ombrosi crini/ di palme. Abete e pini/ e cos ascoso udia/ Lauretta insieme a Lia/ nel
solitario orrore (Rime).
12
Cfr. Marco Materassi op. cit.
13
Anthony Newcomb ha analizzato i rapporti delle tre antologie dedicate a Laura Peperara. Vedi Anthony Newcomb
op.cit.
entrambe le raccolte ferraresi vi sia la presenza di autori romani
14
o riconducibili allarea romana
15
. Dei
ventinove musicisti che trattano il topos provenzale della donna crudele nel Lauro Secco
16
troviamo in
ambito romano: Luca Marenzio, Ruggero Giovanelli, Alessandro Striggio, Annibale Zoilo, Annibale Stabile e
Giovanni de Macque e Nicol Puru; nel Lauro Verde: Luca Marenzio, Ruggero Giovannelli, Paolo Bellasio,
Giovan Battista Locatello, Giovanni de Macque e Bartolomeo Roy. Oltre la falsa opinione di presunte
ristrettezze imposte dal Concilio di Trento sulla base di costumi morigerati, stato dimostrato come
esistesse unattiva produzione profana a Roma. La mancanza di una corte secolare dava la possibilit a
molti esponenti appartenenti alle varie casate nobiliari, dessere committenti o mecenati
17
. Qualora venisse
a mancare una vera committenza i musicisti avevano la possibilit di aggregarsi tra loro. A tal proposito
bisogna ricordare la formazione della Congregazione dei musici di Roma posta sotto linvocazione della
Beata Vergine, di Gregorio Magno e di Santa Cecilia
18
, ufficializzata nel 1845 da Sisto V
19
. In un contesto
cos ampio di possibilit comune la presenza della produzione sacra parallelamente a quella profana in
molti musicisti. In tal senso Stabile un ottimo esempio di maestro di cappella che ha per anche una
discreta produzione profana
20
. Ad oggi la delineazione delle caratteristiche di un stile madrigalistico
14
A proposito Anthony Newcomb sostiene: although produced in Ferrara, Lauro Secco incluedes nearly as many
roman composers ad ferrarese. On the 30 composers on il Lauro Secco, ten, the greatest number to be actice in a
single area, we active in Ferrara. But close behind was Rome whit seven composers *+
15
Quando si parla di area di produzione madrigalistica romana si vuole far riferimento non solo ad musicisti nati a
Roma, ma anche a coloro che a vario titolo ricorpirono incarichi e operarono nellambito della vita musicale della citt
papale, in vari contesti quali: cappelle musicali, casate nobiliari e cardinalizie, ambasciate. Cfr. Anthony Newcomb op.
cit.
16
Ecco elenco completo dei ventinove musici e dei rispettivi madrigali nellordine in cui compaiono nel Lauro Secco:
Luca Marenzio, Mentre laura spir nel verde lauro; Hippolito Fiorentino, Ode lanima mia gioia infinita; Costanzo
Porta, Io pensai dolce e grato; Lelio Bertati, Movi il tuo plettro Apollo; Giaches de Wert, Hor fuggi infedel ombra; Giulio
Heremita, M pur stato dal core; Luzzasco Luzzaschi, Se il Lauro sempre verde; Andrea Gabrieli, (O) Primavera
eterna; Alessandro Milleville, Tra mille e pi arboscelli un dolce alloro; Ruggiero Giovannelli, Nel foco dun bel lauro;
Paulo Isnardi, A pi dun lauro che soavi venti; Tiburtio Massaini, La fiamma chai nel petto; Claudio da Correggio,
Mentre il lauro gentil dai rami invan taffanni; Alessandro Striggio, Con laura di sospir lacque di pianti; Annibale Zoilo,
Invano ascondi il vero; Innocentio Alberti, Dal mio bel lauro amore; Paolo Virchi, Arsi mentre a voi piacque; Francesco
Manara, Chi ama viva in core; Alberto dal Oca, Per sei coronato e trionfante; Nicol Peruue, Sei tu quel lauro che si
verde Amore; Vincenzo Fronti, Come hor la terra nove erbette e fiori; Bartolomeo Spontone, Tamai frondosa pianta;
G.B. Mosto, Secco larbor gentile; Girolamo Belli, Amor con larbor mio secco mia speme; Horatio Vecchi, Fummo
felici un tempo; MarcAntonio Ingegneri, Gi non mi meraviglio; Annibale Stabile, Fu il lauro sempre verde; Francesco
Pigna, Giusto disdegno amore; Giovanni Bardi, Lauro ohim lauro ingrato; Giovanni di Macque, Goditi pur novo terren
quel lauro; Luca Marenzio, Quel lauro che fu in me gi cos verde.
17
Cfr. Nino Pirrotta, intr. a Dolci Affetti (1582): i musici di Roma e il madrigale, Firenze, Olshki,1985
18
Riguardo la Congregazione dei Musici di Roma vedi: Raffaele Casimiri, Lantica congregazione di Santa Cecilia fra i
musici di Roma nel XVII in Note dArchivio, I, 1924 pp. 15 sgg; Remo Giazzotto, Quattro secoli di storia dellAccademia
Nazionale di Santa Cecilia, Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 1970; Sergio Pagano, la congregazione di
Santa Cecilia e i Barnabiti: pagine inedite della prima attivit ceciliana in Nuova Rivista Musicale italiana, XV, 1981, pg
34-39; William J. Summers, The Compagnia dei Musici di Roma, 1584-1604: a preliminary report in Current
Musicology, XXXIV, 1982, pg. 7-25
19
Lufficiliazzazione avvenne tramite la bolla Rationi congruit
20
Stabile parallelamente ai ruoli in cappelle ecclesiastiche (vedi nota 1) presente in diverse antologie
madrigalistiche, tra queste quelle specificatamente romane: Dolci Affetti [DOLCI AFFETTI/MADRIGALI A CINQUE VOCI
DE DIVERSI ECCELLENTI MUSICI DI ROMA, Venezia, Erede di G. Scotto, 1582; cfr RISM 1582, 1585,1590 e Nino Pirrotta,
Dolci Affetti op. cit.], Le Gioie [LE GIOIE/ MADRIGALI A CINQUE VOCI DI DIVERSI ECCELMI MUSICI DELLA COMPAGNIA
DI ROMA LIBRO PRIMO, Ricciardo Amandino, Venezia, 1589; cfr RISM 1589, 1890 e Giuliana Gialdroni, le Gioie,
Roma-Lucca, Accademia Nazionale di Santa Cecilia Libreria Musicale Italiana, 1993. I volumi monografici di Stabile
come madrigalista sono: Libro Primo di Madrigali a Cinque Voci di Annibale Stabile, Scotto Girolamo Erede, Venezia,
1586; Il Terzo Libro dei Madrigali a Cinque Voci, appresso lherede di Girolamo Scotto, 1585. Insieme a Nanino
pubblica lantologia: Madrigali a Cinque Voci di G.M. Nanino et Annibale Stabile, Angelo Gardano, Venezia, 1581
(ristampato presso lo stesso editore nel 1587).
dambito specificatamente romano ancora oggetto di studio, salvo delle precisazioni sul materiale
rinvenuto ed esaminato
21
.
21
Nino Pirrotta in op. cit. precisa infatti che il madrigalismo romano necessita ancora di uno studio serio e una di
precisa definizione delle sue caratteristiche. Accostando per i Dolci Affetti a le Gioie individua delle precise
caratteristiche che possono essere daiuto nello studio del madrigalismo romano: tendenza ad una scrittura che salvo
enfatiche esclamazioni scandite insieme da tutte o quasi tutte le voci, tende a disegnare contrappuntisticamente
linizio degli episodi (con figurazioni suggerite abbastanza spesso da madrigalismi scontati) ma si sviluppa poi con una
spiccata sensibilit per il fluire scorrevole vorremmo quasi dire logico delle armonie risultanti *+ sono rari i
cromatismi melodici *+ lapparire del diesis e del bemolle produce invece il pi delle volte al nostro orecchio il
risultato non di un urto ma di un agevole persuasiva modulazione ad uno dei toni vicini a quello di partenza.
Limpressione generale quella di una espressivit arioso che si avvia verso una cantabilit gi intrisa del nuovo
sentimento della tonalit armonica anticipando la codificazione barocca del sistema tonale.
Potrebbero piacerti anche
- Dizionario storico-critico degli scrittori di musica e de' più celebri artisti, vol. 4 (of 4) Di tutte le nazioni sì antiche che moderneDa EverandDizionario storico-critico degli scrittori di musica e de' più celebri artisti, vol. 4 (of 4) Di tutte le nazioni sì antiche che moderneNessuna valutazione finora
- Tarantole, tarantolati e tarantelle nella Spagna del Siglo de oroDa EverandTarantole, tarantolati e tarantelle nella Spagna del Siglo de oroNessuna valutazione finora
- Dizionario storico-critico degli scrittori di musica e de' più celebri artisti, vol. 1 (of 4) Di tutte le nazioni sì antiche che moderneDa EverandDizionario storico-critico degli scrittori di musica e de' più celebri artisti, vol. 1 (of 4) Di tutte le nazioni sì antiche che moderneNessuna valutazione finora
- Lococo, Giusepina - I Testi Del Petrarca Nel Repertorio Musicale Del QuattrocentoDocumento14 pagineLococo, Giusepina - I Testi Del Petrarca Nel Repertorio Musicale Del QuattrocentoMau AlvaradoNessuna valutazione finora
- Ram 0401Documento38 pagineRam 0401ddNessuna valutazione finora
- Recercare CesiDocumento26 pagineRecercare CesiPierluigi FerrariNessuna valutazione finora
- Dizionario storico-critico degli scrittori di musica e de' più celebri artisti, vol. 3 (of 4) Di tutte le nazioni sì antiche che moderneDa EverandDizionario storico-critico degli scrittori di musica e de' più celebri artisti, vol. 3 (of 4) Di tutte le nazioni sì antiche che moderneNessuna valutazione finora
- Claudio Monteverdi e Ecco Mormorar L'ondeDocumento6 pagineClaudio Monteverdi e Ecco Mormorar L'ondeLuca Bellogi0% (1)
- Prattica Della Musica Scuole Napoletane PDFDocumento47 paginePrattica Della Musica Scuole Napoletane PDFstzenni100% (1)
- Max Chop - L'ANELLO DEL NIBELUNGO di RICHARD WAGNERDa EverandMax Chop - L'ANELLO DEL NIBELUNGO di RICHARD WAGNERNessuna valutazione finora
- Conversando con... Elsa Respighi: La moglie del grande compositore Ottorino Respighi racconta aspetti inediti della carriera e dei trionfi del maritoDa EverandConversando con... Elsa Respighi: La moglie del grande compositore Ottorino Respighi racconta aspetti inediti della carriera e dei trionfi del maritoNessuna valutazione finora
- Diapositive - Il Gioco Musicale Nel 400 e 500Documento72 pagineDiapositive - Il Gioco Musicale Nel 400 e 500Marco SuraceNessuna valutazione finora
- Lezioni private - Il pianoforte: Guida all'ascolto del repertorio da concertoDa EverandLezioni private - Il pianoforte: Guida all'ascolto del repertorio da concertoNessuna valutazione finora
- Non tocchiamo questo tasto: Musica classica e mondo queerDa EverandNon tocchiamo questo tasto: Musica classica e mondo queerNessuna valutazione finora
- Dizionario storico-critico degli scrittori di musica e de' più celebri artisti, vol. 2 (of 4) Di tutte le nazioni sì antiche che moderneDa EverandDizionario storico-critico degli scrittori di musica e de' più celebri artisti, vol. 2 (of 4) Di tutte le nazioni sì antiche che moderneNessuna valutazione finora
- Gustav Mahler e l'incontro mistico di poesia e musica: Morte, risurrezione, dolore, amore, estasiDa EverandGustav Mahler e l'incontro mistico di poesia e musica: Morte, risurrezione, dolore, amore, estasiNessuna valutazione finora
- VITTORIO GELMETTI (Revisione Di Rino Rossi)Documento4 pagineVITTORIO GELMETTI (Revisione Di Rino Rossi)Valerio SebastianiNessuna valutazione finora
- Illustrazione delle medaglie dei dogi di Venezia denominate Oselle Edizione seconda con correzioni ed aggiunteDa EverandIllustrazione delle medaglie dei dogi di Venezia denominate Oselle Edizione seconda con correzioni ed aggiunteNessuna valutazione finora
- Cipollone, Barbara - La Tradizione Musicale Del Sonetto or Che'l Ciel Et La Terra. Arcadelt, Rore, MonteDocumento15 pagineCipollone, Barbara - La Tradizione Musicale Del Sonetto or Che'l Ciel Et La Terra. Arcadelt, Rore, MonteMau AlvaradoNessuna valutazione finora
- Rocconi Ed, La Musica Nel'impero Romano PDFDocumento180 pagineRocconi Ed, La Musica Nel'impero Romano PDFFotis AnagnostopoulosNessuna valutazione finora
- La voce di Mignon. Viaggi nel canto tra Goethe e SchubertDa EverandLa voce di Mignon. Viaggi nel canto tra Goethe e SchubertNessuna valutazione finora
- Sonata 1924 e pianismo modernistico di Igor Stravinsky: tra citazione neoclassica e personalizzazione espressivaDa EverandSonata 1924 e pianismo modernistico di Igor Stravinsky: tra citazione neoclassica e personalizzazione espressivaNessuna valutazione finora
- DOMENICO ZIPOLI: “AMO, DUNQUE SUONO”. La scelta radicale di una vita, dalla musica in Europa alle missioni gesuitiche in America LatinaDa EverandDOMENICO ZIPOLI: “AMO, DUNQUE SUONO”. La scelta radicale di una vita, dalla musica in Europa alle missioni gesuitiche in America LatinaNessuna valutazione finora
- La Seconda PratticaDocumento17 pagineLa Seconda PratticaShirley Fideles FigueiredoNessuna valutazione finora
- PURA MUSICA PURA VIOSIONE. Ennio Morricone & Giuseppe Tornatore. Da Nuovo Cinema Paradiso a La Migliore OffertaDa EverandPURA MUSICA PURA VIOSIONE. Ennio Morricone & Giuseppe Tornatore. Da Nuovo Cinema Paradiso a La Migliore OffertaValutazione: 3.5 su 5 stelle3.5/5 (2)
- Metrica1 2 3 NBDocumento70 pagineMetrica1 2 3 NBAlberto BorinoNessuna valutazione finora
- La danza e l'agitprop: I teatri-non-teatrali nella cultura tedesca del primo NovecentoDa EverandLa danza e l'agitprop: I teatri-non-teatrali nella cultura tedesca del primo NovecentoNessuna valutazione finora
- Il melomane domestico: Maria Callas e altri scritti sull'operaDa EverandIl melomane domestico: Maria Callas e altri scritti sull'operaNessuna valutazione finora
- Alle radici dell’infamante Seconda Repubblica: il biennio 1992-1993Da EverandAlle radici dell’infamante Seconda Repubblica: il biennio 1992-1993Nessuna valutazione finora
- Segnali di luce dalla periferia elettrica: l'utopia sonora di Fausto RomitelliDa EverandSegnali di luce dalla periferia elettrica: l'utopia sonora di Fausto RomitelliNessuna valutazione finora
- Ci chiedevano parole di canto: La crisi della musica liturgicaDa EverandCi chiedevano parole di canto: La crisi della musica liturgicaNessuna valutazione finora
- 8.570577-78 Sungtext ItDocumento21 pagine8.570577-78 Sungtext ItjottosNessuna valutazione finora
- 7726 Storia Della Musica Il MedioevoDocumento1 pagina7726 Storia Della Musica Il Medioevoangelica367Nessuna valutazione finora
- Bartolomeo Barbarino, Il Secondo Libro Delli Motetti A Voce Sola, Venezia 1614Documento10 pagineBartolomeo Barbarino, Il Secondo Libro Delli Motetti A Voce Sola, Venezia 1614Vania Dal MasoNessuna valutazione finora
- APEL IntroduzioneDocumento7 pagineAPEL IntroduzioneFrancesco ZitoNessuna valutazione finora
- Meucci - FondamentiDocumento17 pagineMeucci - FondamentiSerena CanevaNessuna valutazione finora
- Relazioni Musicali Tra Italia e Spagna PDFDocumento20 pagineRelazioni Musicali Tra Italia e Spagna PDFGaetano PreviteraNessuna valutazione finora
- Opere e Grandi Musicisti in pilloleDa EverandOpere e Grandi Musicisti in pilloleNessuna valutazione finora
- Il Medioevo (secoli XI-XII) - Musica (31): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 31Da EverandIl Medioevo (secoli XI-XII) - Musica (31): Storia della Civiltà Europea a cura di Umberto Eco - 31Nessuna valutazione finora
- Maestro di te stesso. PNL per musicisti: Guida pratica alla realizzazione artistica e personale con le strategie della Programmazione Neuro LinguisticaDa EverandMaestro di te stesso. PNL per musicisti: Guida pratica alla realizzazione artistica e personale con le strategie della Programmazione Neuro LinguisticaNessuna valutazione finora
- Nel mondo della musica. Vol. 3 - Tomo II. L’epopea della polifonia (dal Trecento al Seicento)Da EverandNel mondo della musica. Vol. 3 - Tomo II. L’epopea della polifonia (dal Trecento al Seicento)Nessuna valutazione finora
- Lezione 5, Gregoriano 2, ScritturaDocumento16 pagineLezione 5, Gregoriano 2, ScritturaFilippo MusengaNessuna valutazione finora
- StravinskijDocumento12 pagineStravinskijLuigi BarbettaNessuna valutazione finora
- Musica e Mecenatismo A Roma Nel Primo Se PDFDocumento37 pagineMusica e Mecenatismo A Roma Nel Primo Se PDFLelio ColistaNessuna valutazione finora
- 05.origini Della Notazione MensuraleDocumento2 pagine05.origini Della Notazione MensuraleMarco CalzaduccaNessuna valutazione finora
- Le Nuove Specie Infestanti Delle Colture Ciclo Autunno-Vernino e Le Modalita Per Il Loro ControlloDocumento0 pagineLe Nuove Specie Infestanti Delle Colture Ciclo Autunno-Vernino e Le Modalita Per Il Loro Controllobrkica2011Nessuna valutazione finora
- Cicerone e Aulo Gellio Sui Rhetores LatiniDocumento2 pagineCicerone e Aulo Gellio Sui Rhetores Latinimatteo libertiNessuna valutazione finora
- Esame Clinico e Diagnosi Biotipologica in MTCDocumento33 pagineEsame Clinico e Diagnosi Biotipologica in MTCRenato NoPonte100% (4)
- Cap Mammella X27592allp1Documento10 pagineCap Mammella X27592allp1Raluca BordeianuNessuna valutazione finora
- Fragola 01 01Documento11 pagineFragola 01 01TransmontesoNessuna valutazione finora
- TUTORIAL Maschera CoccodrilloDocumento14 pagineTUTORIAL Maschera CoccodrilloFabio PirasNessuna valutazione finora
- Gasparini Se 8 1955Documento6 pagineGasparini Se 8 1955MissKitchenNessuna valutazione finora
- 2020 33 3223 S1 1 PDFDocumento3 pagine2020 33 3223 S1 1 PDFtgauliaNessuna valutazione finora
- Esercizi Per Le Algie Vertebrali Con L'utilizzo Della Palla BobathDocumento5 pagineEsercizi Per Le Algie Vertebrali Con L'utilizzo Della Palla BobathMarco CurottiNessuna valutazione finora
- Apparato RespiratorioDocumento15 pagineApparato RespiratoriosteNessuna valutazione finora
- Tiziano Sclavi PDFDocumento9 pagineTiziano Sclavi PDFGiorgio MattaNessuna valutazione finora
- CisticercosiDocumento19 pagineCisticercosipljublovedskijNessuna valutazione finora
- VenesiaDocumento193 pagineVenesiaandreatisot100% (1)
- GuidaTreGocceOro 2012 INTDocumento48 pagineGuidaTreGocceOro 2012 INTzamacorsNessuna valutazione finora
- Libro Intitulato Il Perché Di Girolamo Manfredi 1588 Con Mostrar Le Cagioni D'infinite Cose, Appartenenti Alla Sanitá: Con La Dichiarazione Delle Virtú D'alcune ErbeDocumento357 pagineLibro Intitulato Il Perché Di Girolamo Manfredi 1588 Con Mostrar Le Cagioni D'infinite Cose, Appartenenti Alla Sanitá: Con La Dichiarazione Delle Virtú D'alcune ErbeCraccoDrappoTafferoNessuna valutazione finora
- Dizionario CataniaDocumento6 pagineDizionario CataniafabioriaNessuna valutazione finora
- Neuroanatomia SchemiDocumento8 pagineNeuroanatomia SchemiHeroInLifeNessuna valutazione finora