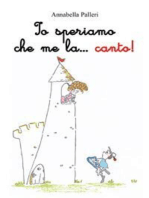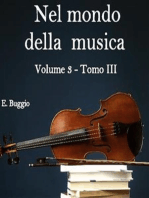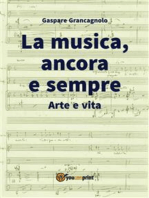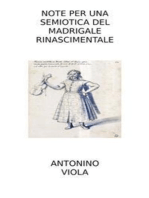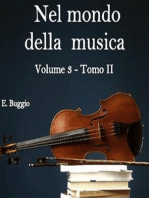Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
01 - STEFFAN - Pierino e Il Lupo
Caricato da
Carlida SteffanTitolo originale
Copyright
Formati disponibili
Condividi questo documento
Condividi o incorpora il documento
Hai trovato utile questo documento?
Questo contenuto è inappropriato?
Segnala questo documentoCopyright:
Formati disponibili
01 - STEFFAN - Pierino e Il Lupo
Caricato da
Carlida SteffanCopyright:
Formati disponibili
“Nuova Secondaria” 3/2014
PERCORSI DIDATTICI
Un ascolto della favola Pierino
e il lupo di Sergej Prokof’ev
Carlida Steffan
SI PROPONE UNA DETTAGLIATA GUIDA ALL’ASCOLTO DELLA FIABA MUSICALE CON UNA STORIA
DELLA GENESI DELL’OPERA NEL SUO CONTESTO STORICO-CULTURALE*.
el 1932 Prokof’ev rientrò definitivamente in nica», o – come recita il frontespizio della partitura – del
N Unione Sovietica dopo un lungo soggiorno euro-
peo e aderì con entusiasmo all’ideologia del so-
cialismo che propugnava l’idea di un impegno politico
«racconto musicale per narratore e orchestra».
La prima esecuzione arrivò il 2 maggio 1936 e Natalija
Sats ebbe il ruolo di narratore. Dati i presupposti didattici
anche nella comunicazione artistica. Prokof’ev scrisse della performance, prima dell’esecuzione furono esposti
musica per film, musica di scena, composizioni celebra- i profili melodici attribuiti da Prokof’ev ai singoli perso-
tive e anche musica didattica come i Dodici pezzi infan- naggi, evidenziati dalle differenze timbriche. E la cosa
tili, op. 65 per pianoforte e la favola sinfonica Pierino e funzionò. Molti piccoli ascoltatori inviarono lettere en-
il lupo, op. 67, di cui scrisse anche il testo. tusiaste al teatro. Volodya, un bimbo di dieci anni, così
Il lavoro fu commissionato nel 1936 da Natalija Sats, fi- raccontò l’esperienza di ascolto musicale:
glia del compositore Ilya e di una cantante, che dalla ri-
voluzione d’ottobre dirigeva il Teatro per l’Infanzia di Mi è piaciuta la musica di Pierino, dell’uccellino e del lupo.
Mosca. Per l’inaugurazione della nuova sede la Sats Come li ho sentiti, li ho subito riconosciuti. Il gatto era bellis-
simo e si muoveva in punta di piedi per non farsi sentire. L’ana-
aveva previsto una serie di commissioni musicali, di bal- tra si muoveva ondeggiando ed era stupida. Mi è dispiaciuto
letto e teatrali, tra cui La piccola chiave d’oro di Tolstoj, molto quando è stata mangiata dal lupo. E sono stato molto con-
rifacimento “sovietico” del Pinocchio di Collodi. A Pro- tento quando in seguito ho sentito ancora la sua voce. Ciò che
kof’ev fu chiesto di scrivere un lavoro sinfonico, la cui ar- mi è piaciuto di più è come Pierino ha sconfitto il lupo e il modo
chitettura formale fosse collegata alla narrazione di una in cui tutti gli strumenti suonano quando il lupo viene condotto
favola. Natalija e Sergej convennero subito sulla storia allo zoo. […] Scrivete se fate un altro concerto!!!
del boy scout Pierino che cattura il lupo, per le efficaci
associazioni che potevano essere fatte tra i personaggi e Novecento e oltre
i suoni degli strumenti musicali. Il successo del lavoro didattico di Prokof’ev ha attraver-
«La prima idea che mi passò in mente – annotò più tardi sato tutto il Novecento, e la favola sinfonica continua a
Natalija – era l’associazione tra il flauto e l’uccellino»1. essere considerata come il più “facile” dei pezzi da pro-
La direttrice del teatro moscovita era convinta si trattasse porre in concerti rivolti a giovani e giovanissimi spetta-
di una corrispondenza scontata e che Prokof’ev l’avrebbe tori, in primis giocando sulle abilità istrioniche del
etichettata come qualcosa di assolutamente kitsch. Per il narratore e focalizzando l’attenzione degli ascoltatori so-
compositore invece «la cosa più importante era proprio prattutto sull’identificazione tra personaggio e strumento
trovare un linguaggio comune», ovvero far in modo che dell’orchestra. E questo attingendo dalla prefazione alla
tratti melodici, costruzioni sintattiche e formali delle partitura stesa dallo stesso Prokof’ev:
varie sezioni musicali potessero costruire una narrazione
Ciascun personaggio di questo racconto è rappresentato da uno
comprensibile per gli ascoltatori – i piccoli soprattutto. strumento. Prima dell’esecuzione orchestrale è preferibile mo-
I primi abbozzi della favola sinfonica portavano un titolo strare tali strumenti ai ragazzi e suonare i vari temi conduttori.
diverso (Come Pierino sconfisse il lupo) e impiegavano
come testo narrativo delle strofe ritmiche. In seguito Pro-
kof’ev scartò l’idea, ritenendo che una tal struttura * Gli articoli dedicati a temi d’intersezione fra letteratura e musica sono a cura
di Giuseppina La Face e Nicola Badolato.
avrebbe potuto distogliere l’attenzione dalla musica. 1. Per questa e la successiva citazione, vedi S. Prokofiev, Peter and the Wolf, Eu-
Scrisse dunque egli stesso il testo della «favola sinfo- lenburg, Londra 1985, p. VI.
Nuova Secondaria - n. 3 2014 - Anno XXXII 63
PERCORSI DIDATTICI
In tal modo, durante l’esecuzione essi impareranno a ricono- quali meccanismi la musica di Prokof’ev “traduce” ciò
scere a uno a uno tutti gli strumenti d’orchestra2. che comprendiamo attraverso il testo narrato.
Per questo, nel curricolo di educazione alla musica,
Senza nulla togliere al valore di questa forma di pre- l’ascolto della fiaba di Pierino e il lupo può costituire un
sentazione, vorrei porre due osservazioni. La prima: va momento di approccio “intuitivo” alla decodificazione
da sé che il racconto verbale è portatore di un codice co- del linguaggio musicale e si presta a essere impiegato già
municativo più immediato, peraltro garantito da una sto- con bambini molto piccoli (scuola materna ed elemen-
ria lineare e coniata in funzione della composizione tare). Peraltro la partitura si offre a un esercizio analitico
musicale. ed ermeneutico propizio anche al curriculum della scuola
Sono molte le contestualizzazioni che hanno interessato secondaria di primo grado.
il testo narrato: sottolineature istrioniche, adattamenti “re- Nel primo àmbito la si può combinare a una ricognizione
gionalistici” (c’è anche una versione in romagnolo, che d’altre forme di sonorizzazione (cartoons, film d’anima-
suona Pirèta e è lòpp, di Ivano Marescotti), oppure gio- zione, video games, ecc.), così da fornire competenze per
chi di riscrittura à la Roberto Benigni. Ma il testo è in eventuali attività musicali produttive che comprendano
questo caso un (pre)testo, un elemento di sutura impor- l’animazione sonoro-musicale di fiabe e racconti. Nel se-
tante che ha la funzione principale di avvicinare i piccoli condo, invece, questa partitura può considerarsi un’ot-
(e i grandi) alla comprensione del linguaggio musicale, o tima palestra per inventariare le funzioni affettive,
per meglio dire alle tecniche narrative del linguaggio mu- denotative o narrative del linguaggio musicale: esse co-
sicale (Prokof’ev ricordava a tal proposito: «Il testo ve- stituiscono peraltro un’esperienza propedeutica per la
niva letto tra un brano e l’altro della musica, che era comprensione del melodramma.
sproporzionatamente più lunga del testo stesso, ma per
me la storia era importante solo come mezzo per indurre Per un ascolto della fiaba sinfonica
i bambini ad ascoltare la musica»). La straordinaria importanza didattica di Pierino e il lupo
La seconda osservazione va di seguito. La presentazione parte dunque dalla descrizione dei «temi conduttori»,
degli strumenti musicali non è finalizzata a un mero ri- che corrisponde a quanto può fare un narratore, nel mo-
conoscimento delle potenzialità timbriche (per questo ci mento in cui offre in apertura una descrizione dei per-
sarebbero ben altre pagine nel repertorio della musica sonaggi3. Nell’economia del linguaggio musicale ci
d’arte occidentale), ma punta a focalizzare e memoriz- sono diversi parametri importanti per tratteggiare un per-
zare i «temi conduttori» attraverso i quali Prokof’ev può sonaggio: il disegno melodico, il tratto ritmico, la tinta
raccontare la «fiaba sinfonica». timbrica. Attraverso le trasformazioni di questi parame-
Negli ultimi decenni diversi studi musicologici hanno tri e la loro combinazione, gli ascoltatori – condotti
prestato attenzione ai processi attraverso i quali si rea- passo passo attraverso l’ascolto del testo verbale – pos-
lizza la narratività musicale, ovvero quali mezzi impiega sono imparare a seguire una vera e propria narrazione
un compositore per raccontare lo svolgersi attraverso il musicale. Ci sono altri titoli ben noti di composizioni
tempo di un’azione, di un incontro o scontro tra perso- concepite con la stessa modalità (L’Histoire du Babar
naggi, ecc. L’ambito degli studi è vasto; molto si è detto del francese Francis Poulenc, per fare solo un esempio),
attorno al teatro in musica (dove ci sono effettivamente ma nessuna partitura vanta una così rilevante potenzia-
personaggi che agiscono in scena e si esprimono attra- lità semantica, indispensabile per esperire condotte
verso un codice musicale), ma alcune proposte si sono d’ascolto che educhino a una fruizione cosciente degli
estese anche alla musica strumentale, tradizionalmente artefatti musicali.
considerata come linguaggio autoreferente. Prendiamo brevemente in considerazione i personaggi,
La struttura dell’op. 67 di Prokof’ev è un terreno straor- nell’ordine di presentazione della partitura, considerando
dinariamente fertile per verificare alcune delle possibi- la diversità di partenza del loro profilo musicale e come
lità narrative della musica, dal momento che ci troviamo
in una condizione ideale di comparazione tra due lin-
guaggi (parola e musica): ogni singola sezione della par-
titura è preceduta da una breve narrazione che anticipa 2. Prokofiev, Peter and the Wolf, cit., pp. VI e X (per questa e la successiva cita-
zione).
ciò che a sua volta la sezione successiva racconta, oppure 3. Lo si ascolti in bella registrazione del 1966, Orchestra Nazionale di Parigi di-
la narrazione si inserisce direttamente nella scrittura mu- retta da Lorin Maazel, Eduardo De Filippo narratore, in <https://www.you-
tube.com/watch?v=hNR0N4KybJA> (parte I) e in <https://www.youtube.com/
sicale e permette di seguire passo passo ciò che avviene watch?v=uIuoygUmdWA> (parte II). Altre edizioni discografiche si possono
in musica. È pertanto stimolante verificare attraverso ascoltare in streaming sul sito <https://www.spotify.com/it/>.
64 Nuova Secondaria - n. 3 2014 - Anno XXXII
PERCORSI DIDATTICI
Partitura 1
questo venga modificato per far sì che l’ascoltatore av- Più complessa è la scelta che il compositore fa per il per-
verta il cambio di situazione, spazialità, movimento, sonaggio-anatra, importante nell’economia dell’esile
azione, cui dovrà adeguarsi4. trama della fiaba. L’identificazione iconica è assicurata
Nella lunga tradizione della musica d’arte occidentale il dall’acciaccatura iniziale affidata al timbro nasalisé del-
suono del flauto rimanda inevitabilmente al canto degli l’oboe, combinato con quello del clarinetto e del fagotto.
uccelli (un esempio: il Concerto RV 428 per flauto e archi Ma melodicamente c’è qualcosa in più (batt. 59 ss.): dopo
di Antonio Vivaldi, intitolato “Il Cardellino”). In questo l’acciaccatura iniziale che conferisce la tinta del perso-
caso abbiamo un’identificazione iconica: la musica tende naggio, esso si scioglie in un andamento quasi circolare –
a riprodurre una caratteristica del soggetto che essa vuol forse non a caso Volodya scrisse nella lettera «ondeg-
denotare. Prokof’ev qui va oltre: non si limita a ripro- giante» – che l’ascoltatore percepisce grazie ad alcuni
durre il verso dell’animaletto, ma ne considera anche il espedienti della scrittura musicale, ad esempio la nota
movimento. Se, infatti, entriamo nella favola e prestiamo lunga iniziale e a seguire un movimento cromatico circo-
attenzione alla più complessa presentazione del perso- lare e gravitante sulla nota stessa (batt. 59-60) [Partitura
naggio-uccellino (batt. 22 e ss.), ci rendiamo subito conto 2]. Nell’economia del racconto il personaggio-anatra è
come il personaggio non solo “canti” (batt. 23-26) ma
anche voli, come ben evidenzia il movimento oscillante
delle quartine di semicrome che seguono a partire da batt.
27 [Partitura 1]. La combinazione di questi due fattori, 4. Sui processi di associazione simbolica si veda M. Della Casa, La ricerca in
semiologia. Educazione ai linguaggi oltre la parola, La Scuola, Brescia 1980,
come vedremo, permetterà a Prokof’ev di portare avanti passim; C. Cano, La musica nel cinema, Gremese, Roma 2002 (cap. II: “Il fun-
il racconto, di far muovere e parlare il suo personaggio. zionamento pragmatico della musica”).
Nuova Secondaria - n. 3 2014 - Anno XXXII 65
PERCORSI DIDATTICI
bro e il personaggio; tuttavia, tra la paletta degli strumenti
a fiato (legni), il clarinetto è certamente quello che ha
l’estensione più ampia e funzionale alla descrizione del
movimento: il passo felpato e insieme flemmatico è reso
attraverso un profilo a note staccate. La testa del tema
(batt. 126 ss.) sfrutta l’estensione più grave dello stru-
mento e sfoggia una struttura sintattica convenzionale del
linguaggio musicale, ovvero una frase regolare di quattro
battute, subito reiterata con una variante finale. Il registro
grave con cui attacca il tema è funzionale alla descrizione
del movimento del personaggio-gatto, come ben si coglie
a battuta 136, quando il profilo melodico è riproposto
quasi identico, ma all’ottava superiore. La ripetizione del
medesimo profilo melodico a differente altezza determina
nella nostra percezione la rappresentazione dello sposta-
mento spaziale [Partitura 3 e 4].
Rappresentazione simbolica anche per il personaggio del
nonno. È affidato al fagotto, strumento dalla tessitura de-
cisamente grave, che rimanda all’immaginario dell’uomo
anziano (nelle convenzioni del melodramma, ad esempio,
il grande sacerdote ha sempre una voce di basso; ma la
stessa osservazione si può estendere anche ai personaggi
maschili di film e cartoni animati). Il profilo melodico è
caratterizzato da un pattern ritmico costante, croma pun-
tata e semicroma, che suscita nell’ascoltatore una possi-
bile associazione con un andamento lento e claudicante
(una raffigurazione dell’anziano certo vicina alle favole e
all’immaginario degli anni Trenta del secolo passato).
Partitura 2 Il lupo è antagonista della favola. In una favola è naturale
trovare la descrizione dell’ambiente e dunque ricomporre
Le partiture citate possono essere visionate on line visivamente lo sfondo sul quale si muovono i personaggi;
nella sezione “Discipline umanistiche” e anche qui il narratore descrive così l’arrivo del lupo:
dei materiali didattici per abbonati. «Non fecero in tempo [Pierino e il nonno] a entrare in
casa che un grosso lupo grigio uscì dalla foresta». Se nar-
rativamente tutto procede bene, musicalmente ci troviamo
presentato dapprima immerso felice a sguazzare nello sta- di fronte a un problema non indifferente: come fa un lupo
gno: questo corrisponde al profilo morbido e sereno che a uscire dal folto del bosco nell’economia di una favola
abbiamo visto; poi, più avanti (batt. 110 ss.), il medesimo sinfonica? Prestiamo attenzione all’inizio dell’Andante
personaggio cambia stato d’animo e si trova impegnato in molto (batt. 216 ss.): in una sola battuta sentiamo il fru-
una discussione col personaggio-uccellino. Per mostrare le sciare dell’orchestra (tecnicamente: fruscio di viole, celli
due diverse situazioni emotive dell’anatra Prokof’ev usa e contrabbassi e rullo sui piatti), una sola battuta – si noti
la medesima nota-personaggio (Mi!3) e la varia nel se- – ma sufficiente a creare un plafond sonoro che determina
guente modo: non più una nota lunga di ¾ seguita da un tensione, attesa, e prepara efficacemente l’evento musi-
gioco cromatico, ma una nota “spezzata” in tre semimi- cale successivo: in altre parole, lo sfondo dal quale far
nime, resa “isterica” nelle battute seguenti grazie ai mu- muovere il personaggio-lupo. L’impiego di una sonorità
tamenti del pattern ritmico (batt. 111-112) e ai salti rarefatta, priva di una sagoma melodica precisa, crea
d’ottava (Mi!3- Mi!4) [Partitura 3]. Tornerò più avanti anche l’effetto della lontananza: come dice il narratore,
a seguire le trasformazioni motiviche adottate dal com- la foresta è lontana dalla casa del nostro protagonista, e da
positore per proseguire la narrazione. lì esce il lupo. Un lupo che non ha un profilo netto, mar-
Il terzo personaggio presentato è il gatto, e Prokof’ev usa cato da un assolo strumentale come abbiamo visto per i
il clarinetto. Non c’è alcun rapporto iconico, qui, tra il tim- personaggi precedenti. Prokof’ev in questo passo ricorre
66 Nuova Secondaria - n. 3 2014 - Anno XXXII
PERCORSI DIDATTICI
al corno perché è lo strumento tradizionalmente impie- [Partitura 6] E – si noti bene – il narratore non inter-
gato per il richiamo della caccia, per creare l’effetto en viene subito dopo. Qui è la musica che anticipa la narra-
plein air; ma fa di più, rafforza la funzione simbolica del zione; lo fa in un paio di battute, che usano un materiale
personaggio-lupo con l’impiego di ben tre corni che muo- musicale del tutto diverso da quanto ascoltato per la de-
vono triadi in stato di rivolto e per gradi congiunti. Il scrizione dei due personaggi. Ne deriva un effetto da ri-
suono compatto e greve dei tre strumenti costruisce un presa cinematografica, come se la macchina da presa si
profilo musicale dalle sonorità più forti, più potenti, più allontanasse dal primo dei due personaggi. Infatti, a par-
cupe rispetto agli altri personaggi, e tali da generare nel- tire da batt. 42, ritroviamo combinati nella pagina musi-
l’ascoltatore un senso di paura [Partitura 5]. cale i loro motivi conduttori, così da percepirne la
Fisionomia iconica, invece, per gli spari dei cacciatori, simultanea presenza sulla scena del prato antistante il
realizzati con timpani e gran cassa, per imitare l’effetto giardino della casa di Pierino. Il medesimo procedimento
naturalistico di una detonazione. di sovrapposizione degli elementi tematici scorre da batt.
E per Pierino? Il boy scout Pétja (questo il nome origi- 94, laddove il narratore informa che anatra e uccellino si
nale) è presentato da un’orchestra di archi (facile così la abbandonano a un battibecco, una dentro l’acqua e l’al-
contrapposizione rispetto agli altri personaggi, che usano tro che svolazza poco sopra [Partitura 7].
i timbri dei fiati): la sua giovinezza, la sua temerarietà è L’arrivo del gatto sposta l’attenzione: l’animale è inten-
resa attraverso un tema saltellante, nella tonalità di Do zionato a fare un boccone dell’uccellino, e Pierino “urla”
maggiore. Tema che a batt. 10 viene impreziosito da un per avvertire il suo amico pennuto. L’orchestra realizza
movimento puntellato di Sol acuti in controtempo, che l’urlo con un espediente iconico, ovvero un accordo for-
suggeriscono un andamento gioioso, quasi balzellante. tissimo realizzato da tutta la compagine strumentale. A
[Partitura 1]. La musica – lo sappiamo – non è apporta- sua volta il nonno mette in guardia Pierino e lo riconduce
trice di significati univoci alla maniera del linguaggio a casa – medesimo procedimento di appaiamento dei temi
verbale; a eccezione di alcune soluzioni iconiche che in conduttori – «chiudendo a chiave la porta»: l’orchestra
parte abbiamo sopra indicato, la musica è soprattutto una sottolinea questa chiusura riutilizzando il modulo della
forma simbolica, vale a dire un qualcosa che riconduce cadenza perfetta sopra descritta.
chi la crea (in questo caso Prokof’ev) e chi la percepisce Ma spetta al lupo mettere per davvero a soqquadro la
(l’ascoltatore) a svariati aspetti della realtà affettiva, con- scena. Possiamo ulteriormente analizzare i meccanismi
creta ed emotiva5. musicali, dal momento che all’arrivo del lupo i perso-
naggi scappano, prendono paura, il che si “traduce” in
Meccanismi della narrazione una trasformazione dei loro temi. Il gatto scappa in cima
Passiamo dunque a vedere altri meccanismi della narra- all’albero: a batt. 229 risentiamo tre battute del tema del
zione musicale, laddove i personaggi che ora abbiamo gatto, ma già dalla quarta il profilo si inceppa, compa-
descritto vengono presentati in un contesto, in un am- iono nuove figurazioni melodiche precedute da una pausa
biente, ed entrano in dialogo o in contrasto tra loro. Ab- breve (croma) e si crea l’effetto di rincorsa. Ma il gatto
biamo già visto come si costruisce musicalmente il avverte sul collo il fiato del lupo e deve correre sempre
contrasto verbale tra l’anatra e l’uccellino. Ma torniamo più veloce: il clarinetto “accelera” e cambia ancora figu-
all’inizio. Dopo la presentazione di Pierino, la sezione si razione, dapprima con terzine e poi con notine velocis-
chiude con una scala cromatica ascendente e una cadenza sime (abbellimenti) che fissano iconicamente l’arrampi-
perfetta (accordo di settima di dominante → tonica), cioè cata del gatto sull’albero: raggiunta la nota più acuta, tutta
il più collaudato tra i meccanismi del linguaggio musi- l’agitazione si placa, e ancora una volta un profilo cro-
cale tonale (a partire dal Seicento) ma che ancor oggi re- matico suggerisce all’ascolto l’immagine del gatto che si
gola la composizione della popular music, e ancora della ferma, rassicurato, raggomitola con calma la coda e si ac-
musica per film, televisione, video games, ecc.), che cor- quatta bel bello sul ramo più alto dell’albero [Partitura
5 e 8].
risponde nella percezione musicale alla funzione svolta
In basso, sul prato, le cose non vanno invece così bene. Il
dal punto a fine capitolo nel contesto della scrittura nar-
narratore ci avverte che alla vista del lupo l’anatra uscita
rativa [Partitura 1]. Subito dopo il narratore presenta il
personaggio-uccellino, e il suono del flauto lo descrive,
come abbiamo detto, sia con modalità iconiche (cinguet-
tio), sia con modalità simboliche (svolazzamento). Ma la
5. Si veda J.-J. Nattiez, Musica e significato, in Enciclopedia della musica, a cura
descrizione di questo personaggio non si chiude con una di J.-J. Nattiez, M. Baroni, M. Bent e R. Dalmonte, Einaudi, Torino 2002, vol.
cesura forte come quella che avvertiamo per Pierino. II, pp. 206-240.
Nuova Secondaria - n. 3 2014 - Anno XXXII 67
PERCORSI DIDATTICI
dall’acqua prova a scappare; poi segue via via la vicenda, Subito dopo si prepara la scena della cattura del lupo. Pie-
mentre l’orchestra la realizza musicalmente. Questa è una rino dapprima guarda da dietro il cancello; qui è al sicuro,
pagina davvero molto interessante per verificare quali e dunque l’orchestra sfoggia quattro battute del suo tema,
mezzi usa la musica per raccontare la corsa affannosa del- intatto. Poi Pierino si mette a cercare la corda, e tutta que-
l’anatra. Abbiamo già visto che l’animale aveva mutato sta azione è invisibile per noi, è dentro la casa: per una
profilo melodico e fraseologia nel discutere con l’uccel- decina di battute l’orchestra abbandona il materiale iden-
lino; qui Prokof’ev gioca con gli stessi parametri: «l’ana- tificativo dei personaggi, costruendo un plafond di pas-
tra si precipitò fuori dello stagno starnazzando» saggio alla descrizione successiva. Che si apre quando il
corrisponde a un ribattutto isterico della nota iniziale (an- boy scout si arrampica sul muro e raggiunge il ramo del-
cora Mi!3); poi, per ricreare nella percezione dell’ascol- l’albero: l’orchestra segnala iconicamente con terzine
tatore l’effetto della corsa dell’anatra (che non ha l’agilità sbalzate verso l’alto il movimento del protagonista e poi
del gatto), usa ancora uno spostamento del profilo melo- gioca a far rimbalzare un breve ma ben riconoscibile
dico all’ottava superiore (un’anatra da stagno non vola frammento del tema di Pierino prima al clarinetto e poi al
alto, si sa, volicchia a filo dell’erba). In corrispondenza flauto, quasi a indicare la convergenza di emozioni tra il
delle parole del narratore, «anche se l’anatra si sforzava», protagonista e gli altri personaggi (gatto e uccellino), en-
Prokof’ev zittisce l’oboe e lo sostituisce col flauto (che trambi angosciati dalla presenza del lupo. Ancora più in-
noi abbiamo conosciuto come strumento identificatore teressante è la costruzione musicale della sezione se-
dell’uccellino) per rendere palese all’ascolto i conati di guente, quando Pierino chiede all’uccellino di fare una
volo dello sfortunato animale. Sforzi inutili, perché «il manovra di disturbo, svolazzando attorno alla testa del
lupo era più veloce», dice il narratore, e tutta l’orchestra lupo. Il tema identificatore del pennuto si avverte solo
è messa a soqquadro, spostati i timbri, alterate le fisio- nella coda, mentre l’episodio è caratterizzato dall’elabo-
nomie melodiche dei personaggi: «ecco s’avvicina, s’av- razione del tema di Pierino, trasfigurato nel timbro del
vicina sempre più, ecco la raggiunge. L’acchiappa e la flauto e arricchito sul piano timbrico da altri strumenti,
inghiotte in un boccone!!!». È il momento clou, il paros- incluse le percussioni (tamburo militare e triangolo). L’in-
sismo orchestrale raggiunge la sua climax: il narratore quadratura musicale si sposta poi sul lupo: anche in que-
tace [Partitura 9]. Anche a questo punto – siamo a batt. sto caso si riconosce la parte iniziale del suo tema,
273 – è la musica a rivelare ciò che sulla scena non si combinata con effetti iconici che suggeriscono all’ascol-
vede, ovvero che l’anatra è viva dentro la pancia del lupo: tatore il tentativo da parte del lupo di saltare e acciuffare
sentiamo infatti di nuovo il suono dell’oboe, ma stavolta l’uccellino.
in pp con tono «doloroso ed espressivo»; è esattamente il La descrizione dell’impresa del protagonista – far calare
medesimo profilo tematico della presentazione, ma ora un nodo scorsoio dall’alto e catturare il lupo – dà spazio
tutto intonato all’ottava superiore, creando un effetto di a una delle sonorizzazioni musicali più collaudate nei car-
lontananza, di suono nascosto. toni animati di tutti i tempi, realizzata mediante un mo-
Il narratore ricompare dopo questa breve ma intensissima vimento cromatico discendente che nella nostra
pagina per decrivere la situazione dei personaggi: gatto e percezione materializza il movimento evocato dal narra-
uccellino sono sul medesimo albero, ma a rispettosa di- tore [Partitura 11]. Il lupo è intrappolato, e Pierino tira
stanza. Infatti l’orchestra prontamente fa sentire il tema con forza la corda: l’orchestra appesantisce il timbro per
del gatto, ora ricomposto come nel profilo iniziale; e, a descrivere la veemenza con cui l’animale intrappolato si
debita distanza di qualche pausa, qualche frammento nel divincola e i salti che inevitabilmente finiscono però per
pentagramma del flauto ci fa sentire la presenza dell’uc- stringere sempre più il cappio.
cellino. L’attenzione si sposta sul lupo, che gironzola La scena cambia con l’arrivo dei cacciatori, presentati
«sotto l’albero guardando le bestiole con occhio avido»: musicalmente attraverso un profilo tematico che focalizza
qui l’orchestra fa sentire le prime quattro battute del tema l’effetto dell’avvicinamento (dalla foresta verso la casa
del lupo, poi s’interrompe e, con tecnica cinematografica, di Pierino) e lascia spazio a brevi ma violenti flash ico-
sposta l’attenzione in cima all’albero dove stanno l’uc- nici, affidati alle risorse timbriche delle percussioni, rim-
cellino e il gatto. Stavolta si sentono quattro battute deri- polpate dagli ottoni.
vate dal tema del felino; cioè: si riconosce la presenza del Pierino stoppa i cacciatori e suggerisce di portare il lupo
gatto, ma il suo stato d’animo non è dei più tranquilli, dal al giardino zoologico; gli archi impiegano un tema del
momento che il lupo punta lo sguardo verso l’alto. Al- tutto nuovo, quasi di gusto neoclassico (batt. 459), che si
trettanto scardinato risulta anche il seguente tema identi- combina con un passo flautistico: la musica conferma at-
ficatore dell’uccellino (batt. 313-316) [Partitura 10]. traverso il suo linguaggio la centralità che nella storia
68 Nuova Secondaria - n. 3 2014 - Anno XXXII
PERCORSI DIDATTICI
hanno assunto Pierino e l’uccellino («abbiamo già cattu- E l’uccellino? l’altro eroe nella cattura del lupo? «svo-
rato il lupo, sì, l’uccellino e io») [Partitura 12]. lazzava sul corteo dicendo: “Visto cosa abbiamo fatto io
Non resta che organizzare la parata finale, che musical- e Pierino?”»: Prokof’ev affida al flauto una pagina di au-
mente si traduce in un’ampia pagina dove di nuovo tro- tentico virtuosismo strumentale, che rende in maniera
vano spazio i «temi conduttori» dei vari personaggi, ma evidente sia lo stato d’animo felice del pennuto sia la con-
con interessanti trasformazioni sonore e ritmiche. In aper- sapevolezza dell’abilità giocata nella partita.
tura, ad esempio, il profilo tematico di Pierino si presenta La musica scema verso il pianissimo a batt. 598; ma la
con un ritmo diverso per aumentazione e soprattutto af- storia non è conclusa; è il momento di conoscere anche
fidato ai corni che avevano identificato il lupo (e così si attraverso la voce del narratore ciò che l’orchestra ci
allude simbolicamente alla cattura del lupo da parte del aveva già fatto sapere a batt. 273 e ss. [Partitura 13]:
boy scout); poi sfilano gli altri personaggi; il nonno e il nella fretta il lupo aveva ingoiato l’anatra in un sol boc-
gatto stanno in coda alla parata, e i loro temi vengono cone, e la voce della malcapitata si sente ancora dentro la
combinati insieme, prima di far risentire il tema del pro- pancia del quadrupede. Il tempo per un breve flash, e la
tagonista, ancora con la sonorità piena dei corni. (Questa partitura si chiude con un consueto modulo di accumula-
pagina offre un terreno ideale d’ascolto per considerare i zione finale – necessario per trascinare l’applauso.
vari parametri della scrittura musicale – melodia, ritmo, Oltre alla fruizione integrale della favola sinfonica, la
timbro – e come le loro differenti combinazioni abbiano partitura di Prokof’ev può diventare uno straordinario
significative ricadute sulla nostra percezione e sulla con- strumento didattico, proprio lavorando sulle elaborazioni
seguente capacità di conferire un significato all’ascolto.) motiviche e sintattiche a cui ciascun «tema conduttore» è
sottoposto. L’uso di strumenti multimediali oggi di facile
accesso (penso ad esempio alle applicazioni che, come
GarageBand per Mac, consentono di manipolare i files
audio) permette di ritagliare la storia musicale di ogni sin-
golo personaggio, così da prendere confidenza con i tratti
BIBLIOGRAFIA di partenza del tema e i successivi cambiamenti della
scrittura, costatandone le eventuali ricadute nella defini-
C. Cano, Semiologia e pedagogia della musica. Prospettive nel
dibattito pedagogico italiano, in «Rivista italiana di
zione di significato ai fini della narrazione.
Musicologia», 25, 1990, pp. 353-387. Certo, un’esperienza di questo tipo è molto più facile del-
Ead., La musica nel cinema, Gremese, Roma 2002. l’ascolto di una composizione strumentale che sia magari
A. Carone (ed.), La narratologia musicale. Applicazioni e priva anche di un semplice titolo evocativo6. Ma penso
prospettive, Trauben, Torino 2006. che valga la pena di lavorare molto e a fondo su partiture
M. Della Casa, La ricerca in semiologia. Educazione ai
di questo tipo – e in genere su tutto il repertorio che ri-
linguaggi oltre la parola, La Scuola, Brescia 1983.
Id., Educazione musicale e curriculum, Zanichelli, Bologna manda a significati extramusicali – come palestra di eser-
1985. cizio all’ascolto. Saccheggiando quanto scrisse Mahler
G. La Face, L’incontro con la musica, in «I diritti della scuola», nel 1896 a proposito della sua Prima Sinfonia (per la
1, 2004, pp. 37-38. quale aveva dapprima indicato una serie di suggestioni
Ead., Le pedate di Pierrot. Comprensione musicale e didattica
letterarie ridotte poi a semplici titoletti), possiamo anche
dell’ascolto, in F. Comploi (ed.), Musikerziehung. Erfahrungen
und Reflexionen, Weger, Bressanone 2005, pp. 40-60 noi convenire che «è bene a ogni modo che per i primi
(<http://wwcat.saggiatoremusicale.it/saggem/ricerca/bibliografia/ tempi […] l’ascoltatore venga provvisto per il viaggio di
pedate.pdf>). alcuni cartelli stradali programmatici e di alcune pietre
«Musica e Storia», 14(3), 2006, pp. 489-731 miliari…»7.
(<http://www.rivisteweb.it/issn/1127-0063/issue/179>) (l’intero
fascicolo è dedicato alla didattica dell’ascolto). Carlida Steffan
C. Sintoni, Quando il gioco diventa gesto. Un laboratorio su ISSM “Vecchi-Tonelli”, Modena
«Pierino e il lupo» di Sergej Prokof’ev, Aracne, Roma 2009.
P. Somigli, From the Onomatopoeias to Musical Form:
Resources of Circularity of Listening and Performance, in Meryc
2009
(<http://wwcat.saggiatoremusicale.it/saggem/ricerca/atti/meryc20
09/Somigli%20MERYC%20per%20SagGEM.pdf>). 6. G. La Face, Le pedate di Pierrot. Comprensione musicale e didattica del-
F. Tammaro, Le funzioni della musica nel teatro d’opera, in l’ascolto, in Musikerziehung. Erfahrungen und Reflexionen, a cura di F. Com-
«Musica Docta», 1, 2011, pp. 49-57 ploi, Weger, Bressanone 2005, pp. 40-60.
(<http://musicadocta.unibo.it/article/view/2145/1527>). 7. La citazione è riportata in C. Dahlhaus, La musica dell’Ottocento, La Nuova
Italia, Firenze 1990, p. 389.
Nuova Secondaria - n. 3 2014 - Anno XXXII 69
Potrebbero piacerti anche
- Luciano Berio Thema Omaggio A Joyce 1958Documento10 pagineLuciano Berio Thema Omaggio A Joyce 1958simonNessuna valutazione finora
- Riassunto NovecentoDocumento4 pagineRiassunto NovecentoGigino GigiNessuna valutazione finora
- Nel mondo della musica. Vol. 3 - Tomo I. Da sant’Agostino ai TrovatoriDa EverandNel mondo della musica. Vol. 3 - Tomo I. Da sant’Agostino ai TrovatoriNessuna valutazione finora
- Nel mondo della musica. Vol.3 - Tomo III. Opera e musica strumentale tra Sei e SettecentoDa EverandNel mondo della musica. Vol.3 - Tomo III. Opera e musica strumentale tra Sei e SettecentoNessuna valutazione finora
- Filologia MusicaleDocumento4 pagineFilologia MusicaleCristina CondeNessuna valutazione finora
- I Suoni Del TeatroDocumento35 pagineI Suoni Del TeatroFabrizio CastiNessuna valutazione finora
- 5-Luciano Berio - Poesia e MusicaDocumento10 pagine5-Luciano Berio - Poesia e MusicaMNessuna valutazione finora
- Magnificat DuranteDocumento68 pagineMagnificat DuranteSebastianIbarra100% (1)
- Elaborazione Trascrizione ArrangiamentoDocumento26 pagineElaborazione Trascrizione ArrangiamentoLuca ScontrinoNessuna valutazione finora
- 6 PucciniDocumento30 pagine6 PuccinilucaspunkyNessuna valutazione finora
- Gesto Comprensione MusicaleDocumento17 pagineGesto Comprensione MusicaleSquawNessuna valutazione finora
- Delalande - Condotte Musicali, Cos'è La MusicaDocumento9 pagineDelalande - Condotte Musicali, Cos'è La MusicaIgor Legari100% (1)
- Mi si scusi il paragone: Canzone d'autore e letteratura da Guccini a CaparezzaDa EverandMi si scusi il paragone: Canzone d'autore e letteratura da Guccini a CaparezzaNessuna valutazione finora
- Musica Greca 2AMUDocumento12 pagineMusica Greca 2AMURaffaello PrandoNessuna valutazione finora
- Musica Nell'antica GreciaDocumento10 pagineMusica Nell'antica GreciaSilvia ForesiNessuna valutazione finora
- Storia Della Musica Moderna e ContemporaneaDocumento21 pagineStoria Della Musica Moderna e ContemporaneaMauro Bruce AbbatesciannaNessuna valutazione finora
- Madrigal eDocumento3 pagineMadrigal eBetelgeuse BT OrionisNessuna valutazione finora
- Maderna e Berio (Iovino)Documento5 pagineMaderna e Berio (Iovino)Gianluca SalcuniNessuna valutazione finora
- Lezioni private - Il pianoforte: Guida all'ascolto del repertorio da concertoDa EverandLezioni private - Il pianoforte: Guida all'ascolto del repertorio da concertoNessuna valutazione finora
- 13.0 L'opera Di CorteDocumento5 pagine13.0 L'opera Di CorteMarco PorcelluzziNessuna valutazione finora
- MartucciDocumento193 pagineMartucciGiordana SalamiNessuna valutazione finora
- Carone Schubert D946Documento21 pagineCarone Schubert D946HucbaldNessuna valutazione finora
- Perfidia ItalianoDocumento16 paginePerfidia ItalianoJuana Victoria Torres VarelaNessuna valutazione finora
- Introd Uzi OneDocumento13 pagineIntrod Uzi Oneliszt_brNessuna valutazione finora
- Pierino e Il LupoDocumento8 paginePierino e Il LupoOrazio FitoluaccoNessuna valutazione finora
- 4 StagionivivaldiDocumento46 pagine4 StagionivivaldiMaria Carmela VitielloNessuna valutazione finora
- Note per una Semiotica del Madrigale RinascimentaleDa EverandNote per una Semiotica del Madrigale RinascimentaleNessuna valutazione finora
- Tesi CiacconaDocumento108 pagineTesi CiacconaAlessandro Vaccari100% (1)
- Nel mondo della musica. Vol. 3 - Tomo II. L’epopea della polifonia (dal Trecento al Seicento)Da EverandNel mondo della musica. Vol. 3 - Tomo II. L’epopea della polifonia (dal Trecento al Seicento)Nessuna valutazione finora
- Filosofia Ed Estetica MusicaleDocumento104 pagineFilosofia Ed Estetica MusicaleGiuliana ZaccariniNessuna valutazione finora
- 05 Teatro MusicaleDocumento16 pagine05 Teatro MusicaleHermann90Nessuna valutazione finora
- Caruso - Marafioti Sintesi Del TrattatoDocumento25 pagineCaruso - Marafioti Sintesi Del TrattatoGianmarco LatiniNessuna valutazione finora
- Careri 1984Documento9 pagineCareri 1984Sara MizzanuNessuna valutazione finora
- Commento A Il Notturno N. 2 Op. 9 Di F.chopinDocumento2 pagineCommento A Il Notturno N. 2 Op. 9 Di F.chopinFrank BozNessuna valutazione finora
- Spartito PresoDocumento162 pagineSpartito PresoMarinaBoselli100% (2)
- Le Arti Del Suono PDFDocumento196 pagineLe Arti Del Suono PDFKent Villanueva Palomino100% (1)
- Relazione Tra Linguaggio e MusicaDocumento25 pagineRelazione Tra Linguaggio e MusicaRoberto PalazzoloNessuna valutazione finora
- Lezione 5, Gregoriano 2, ScritturaDocumento16 pagineLezione 5, Gregoriano 2, ScritturaFilippo MusengaNessuna valutazione finora
- 1 MonodiaDocumento15 pagine1 MonodiaFrancesco RonzioNessuna valutazione finora
- AronneDocumento2 pagineAronnefedoerigoNessuna valutazione finora
- Didattica Della Musica Del NovecentoDocumento11 pagineDidattica Della Musica Del Novecentojoffo89Nessuna valutazione finora
- Appunti Civiltà Musicale Greca e RomanaDocumento32 pagineAppunti Civiltà Musicale Greca e RomanaManu KoloredNessuna valutazione finora
- L’aura ritrovata: Il teatro di Sylvano Bussotti dalla Passion selon Sade a LorenzaccioDa EverandL’aura ritrovata: Il teatro di Sylvano Bussotti dalla Passion selon Sade a LorenzaccioNessuna valutazione finora
- Percorso Di Storia Della MusicaDocumento22 paginePercorso Di Storia Della MusicaMauro Vergimigli100% (1)
- Breve Storia Opera LiricaDocumento6 pagineBreve Storia Opera LiricabesciamellaNessuna valutazione finora
- Max Chop - L'ANELLO DEL NIBELUNGO di RICHARD WAGNERDa EverandMax Chop - L'ANELLO DEL NIBELUNGO di RICHARD WAGNERNessuna valutazione finora
- Biscione-Messiaen e Il QuatuorDocumento13 pagineBiscione-Messiaen e Il QuatuorAnonymous 4rSnecP100% (2)
- La Lira Da Braccio e La Resurrezione Di OrfeoDocumento8 pagineLa Lira Da Braccio e La Resurrezione Di OrfeoStefano A E LeoniNessuna valutazione finora
- Musica e Performance Nella Commedia Di P PDFDocumento163 pagineMusica e Performance Nella Commedia Di P PDFRoberto GuardiNessuna valutazione finora
- ConclusioniDocumento17 pagineConclusionioggokNessuna valutazione finora
- Canzone Napoletana e Musica Di Tradizion PDFDocumento23 pagineCanzone Napoletana e Musica Di Tradizion PDFEnzo De RosaNessuna valutazione finora
- StravinskijDocumento12 pagineStravinskijGiulia PaganoNessuna valutazione finora
- Casa Editrice Leo S. Olschki S.R.L. Il Saggiatore MusicaleDocumento4 pagineCasa Editrice Leo S. Olschki S.R.L. Il Saggiatore MusicaleMarco CosciNessuna valutazione finora
- Chopin Notturno TesDocumento57 pagineChopin Notturno TesFacchini Coe MatteoNessuna valutazione finora
- La Ricerca Del Pensiero QSF 2Documento97 pagineLa Ricerca Del Pensiero QSF 2Michele Ruzzi100% (2)
- Manuale Utente - KalliopeCTI 4.5.18Documento48 pagineManuale Utente - KalliopeCTI 4.5.18MarcoNessuna valutazione finora
- ArticoliDocumento1 paginaArticolitoritori88Nessuna valutazione finora
- Filosofia-Socrate e PlatoneDocumento14 pagineFilosofia-Socrate e PlatonePillimoGarauNessuna valutazione finora
- Storia Della MusicaDocumento128 pagineStoria Della MusicaAlfonso BelfioreNessuna valutazione finora
- Metodologie DidatticheDocumento8 pagineMetodologie DidatticheMike HarperNessuna valutazione finora
- Dante OpereDocumento21 pagineDante OpereDino FrancoNessuna valutazione finora
- Noi Verbo FareDocumento50 pagineNoi Verbo FareAkira LiNessuna valutazione finora
- Risposte Cisco Cap 1-3Documento6 pagineRisposte Cisco Cap 1-3maNessuna valutazione finora
- Cap2 - Modelli Di OttimizzazioneDocumento12 pagineCap2 - Modelli Di OttimizzazioneAlessio PaniniNessuna valutazione finora
- Pregh Corona Davvento e NovenaDocumento2 paginePregh Corona Davvento e Novenaapi-421393782Nessuna valutazione finora